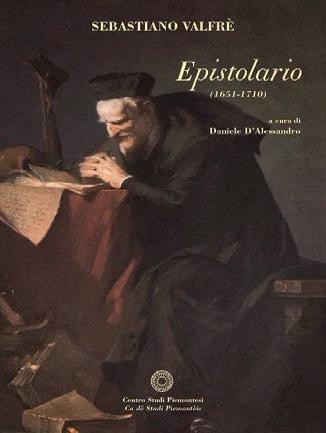4 minute read
El Greco. Una pittura fuori dal tempo di Michela Gianfranceschi
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale
Finalmente, durante lo scorso inverno, una mostra monografica ha voluto ricordare il fondamentale contributo artistico dato dal grande pittore Domenikos Theotokópoulos detto El Greco (Candia 1541-Toledo 1614) alla cultura visiva a cavallo tra Cinque e Seicento, in un momento storico tra i più incisivi della nostra storia europea.
L’esposizione allestita tra lo scorso ottobre e febbraio nelle sale del Grand Palais parigino, per la cura di Guillaume Kientz, è stata l’occasione per riflettere su alcuni temi riguardanti i modi del linguaggio artistico e i significati dell’arte moderna. Dalle influenze visive bizantine delle sue origini greche alla visione pittorica unica e ancora oggi di grande modernità, la mostra parigina ha esaltato le qualità coloristiche dell’artista, la sua incredibile originalità interpretativa, oltre alla forte componente mistica della sua poetica.
Le sue opere, in effetti, sembrano galleggiare in un universo spaziotemporale a sé stante, rispetto a ciò che veniva prodotto alla fine del Cinquecento, eppure, osservando più in profondità si intravedono e si riconoscono i rimandi alla cultura pittorica italiana del tempo, soprattutto veneta, i riferimenti all’antico, al manierismo di chiave romana e soprattutto la componente devozionale legata al momento storico, cioè poco dopo la chiusura del Concilio Tridentino (1563).
Un pittore apolide
Nato a Creta nel 1541, poi passato nella penisola italiana, tra Venezia, Parma, Firenze e Roma, infine giunto alla corte spagnola, dove fu attirato dal grande cantiere dell’Escorial, El Greco incarnò, anzitempo, la figura del pittore apolide o, forse, potremmo dire europeo. Egli attraversò le influenze formali del tempo, ottenendo un linguaggio nuovissimo, che tuttavia traeva linfa proprio dagli stilemi della tradizione manierista della fine del Cinquecento.
La sua visione, fatta di linee sinuose e spezzate, di forme e colori che si allungano all’inverosimile, per poi mescolarsi tra loro e
El Greco, Cristo in croce, circa 1597, Madrid, Museo del Prado.
El Greco, Salvator mundi, circa 1600, Edimburgo, National Gallery of Scotland. snodarsi verso nuove espressioni della figurazione, sembra parlare direttamente ad un’epoca successiva alla sua. Eppure, a ben guardare, le sue linee di contorno sono una estremizzazione del manierismo cinquecentesco, i suoi squarci di colore taglienti e acidi derivano dalla sua osservazione della pittura dei grandi artisti veneziani del tempo, in particolare di Tiziano e di Tintoretto, che già mostravano definizioni coloristiche di grande impatto visivo ed emozionale. Dunque la grandezza del Greco, potremmo dire, sta nella sua capacità di prendere dalla cultura del presente, rielaborando magistralmente tutto, seguendo un’urgenza narrativa e comunicativa, fino a trovare una chiave stilistica e compositiva personale. Tale declinazione pittorica rafforza il racconto sacro, ottenendo ciò che più era richiesto dalla cultura controriformata dell’epoca: la capacità di muovere gli animi e di coinvolgere il fedele, attraverso immagini chiare ed efficaci. Negli anni Settanta realizzò numerose opere di formato ridotto, idonee alla devozione privata, mentre al decennio successivo sono ascrivibili le sue iconografie sacre più riconoscibili, quasi un marchio di fabbrica del suo pennello e della sua ormai fiorente bottega spagnola: si tratta delle penitenti immagini di Maddalena, san Francesco, san Domenico, raccolti in meditazione, delle Sacre Famiglie dolcissime e del Crocifisso, fluttuanti in atmosfere apocalittiche.
La cappella di Toledo
Uno dei più significativi esempi della visione artistica del Greco applicata ad un luogo

sacro è la meravigliosa cappella sita nella chiesa di San Tomé a Toledo. Nell’ultima parte della sua vita, El Greco spinse la propria ricerca fino a toccare le profondità della sua anima e ne trasse ciò che rimane per noi un’eccezionale confessione in punta di pennello. La pala d’altare, vivida di colori, di squarci luminosi e del movimento vorticoso delle forme che si assembrano, raffigura l’Entierro del conte de Orgáz ossia il miracolo della deposizione nel 1323 delle membra di Gonzalo Ruiz nel sepolcro di San Tomé ad opera di santo Stefano e sant’Agostino.
Il parroco della chiesa toledana nel 1586 volle che il pittore descrivesse l’evento miracoloso in una grande pala d’altare per ricordare il miracolo e il generoso benefattore Ruiz. Il Greco, ispirandosi alle elaborazioni compositive di Perugino e di Raffaello, organizzò uno spazio suddiviso tra il mondo degli uomini in basso e l’empireo divino in alto; coltri di nuvole segnano la divaricazione tra i due mondi, seppure la preghiera collettiva


e il rito dell’inumazione, costruiscano l’invisibile ponte per i fedeli tra le due realtà. Così come nel gruppo degli uomini, raffigurato nella parte bassa della tela, sono stati individuati i ritratti puntuali di numerose personalità dell’aristocrazia toledana del tempo, allo stesso modo tra le nuvole, oltre alla figure di Gesù, Maria e san Giovanni Battista, anche i ritratti dei santi e dei beati convenuti acquisisiscono verità e pienezza, significando con forza la Verità celeste accanto a quella terrena.
Sopra, El Greco, San Pietro penitente, 1580, County Durham, Barnard Castle, Bowes Museum. A sinistra, Mater Dolorosa, circa 15 871590, Berlino, Gemaldegalerie.