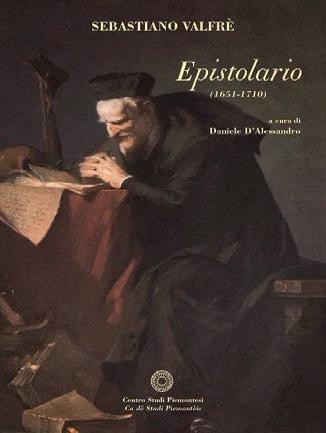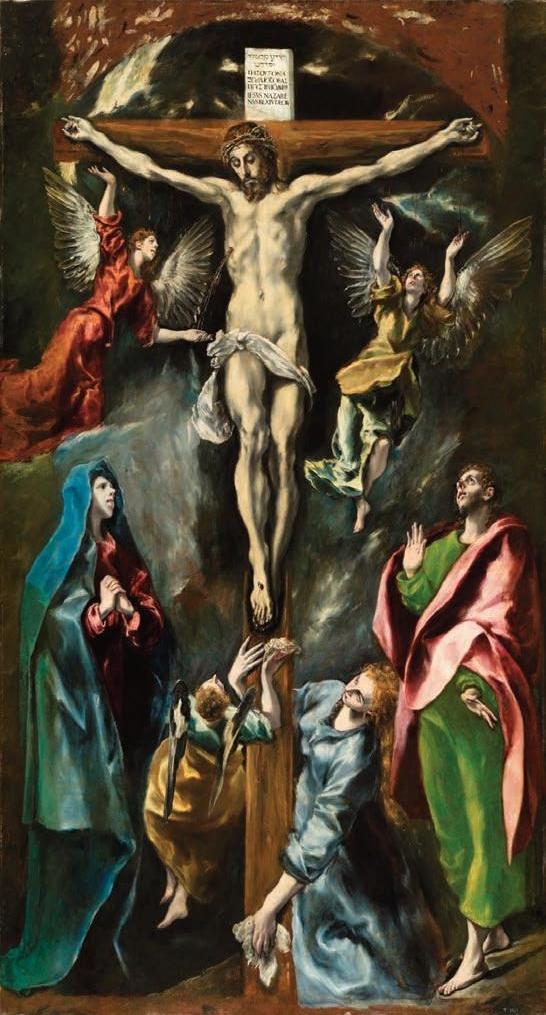7 minute read
Il marchesato di Saluzzo di Dario Pasero
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale
Il marchesato di Saluzzo

Il marchesato di Saluzzo occupava territori delle attuali province di Cuneo e di Torino, arrivando a possedere anche zone oggi sotto controllo francese. I principali centri erano Saluzzo, la capitale, Carmagnola (nella foto su licenza Creative Commons, il castello), La Manta, Revello e Racconigi. La posizione strategica del marchesato di Saluzzo fu, ad un tempo, causa della sua fortuna e della sua rovina, specie tenendo conto dei suoi vicini, volitivi e desiderosi di far proprie quelle terre, ovvero i Savoia da una parte ed il Regno di Francia dall’altra. I secondi, alla fine, riuscirono ad annetterselo, salvo poi cederne parte ai primi. Saluzzo fu anche terra di profonda fede, probabilmente sin dall’età romana, come testimoniano le numerose tracce artistiche ed architettoniche giunteci sino ad oggi.
di Dario Pasero

Il marchesato di Saluzzo occupava, nel sud-ovest del Piemonte, territori delle attuali province di Cuneo e di Torino, arrivando a possedere anche zone oggi sotto controllo francese. Era costituito da terre comprese tra i fiumi Stura di Demonte, a meridione e ad oriente, il Po a settentrione, e le Alpi ad occidente. I principali centri erano Saluzzo, la capitale, Carmagnola, enclave nei territori sabaudi e sede della Zecca, La Manta, Revello e Racconigi.
Le origini
Le prime origini del marchesato vanno ricercate negli anni immediatamente successivi al crollo del regno carolingio, col conseguente aumento dell’autonomia dei singoli territori.
Esso divenne, tra i secoli IX e X, sede di una curtis regia sotto Berengario I (850 d.C. circa 924). Fu poi possedimento degli Arduinici, finché entrò in possesso della famiglia marchionale dei Del Vasto, antica e nobile dinastia di stirpe aleramica, che controllava in origine vari territori in Liguria e nel Piemonte meridionale.
Tale famiglia regnò sulla città da quando Bonifacio I (ca. 1055 - ca. 1125) l’ottenne in
Saluzzo divenne, tra i secoli IX e X, sede di una curtis regia sotto Berengario I. Fu poi possedimento degli Arduinici, finché entrò in possesso della famiglia marchionale dei Del Vasto (nella foto, lo stemma del Casato).

Fu Tommaso II a far erigere il castello di Saluzzo, noto ancora oggi come La Castiglia (nella foto). feudo da Olderico Manfredi II, marchese di Torino e di Susa. Nel 1142, in seguito alla morte di Bonifacio, la regione di Saluzzo passò in eredità al figlio primogenito Manfredo I (†1175) e, da quella data, Saluzzo ed il suo territorio divennero un marchesato, trasmesso per via dinastica, come una vera e propria signoria feudale.
Manfredo II (†1215), cercando di estendere i suoi domini verso nord, si spinse fino a Racconigi e a Carmagnola, trovandosi così a combattere contro i Savoia, suoi confinanti. Il marchese fu sconfitto ed, alla sua morte, la vedova Alasia dovette accettare una serie di tributi annui: da questa condizione di vassallaggio, i Savoia accamparono le pretese sul loro presunto diritto di proprietà sul marchesato, da cui nacquero vari scontri armati. Inoltre la sua collocazione geografica, strategica per i rapporti tra Regno di Francia e Ducato di Savoia, lo fece oggetto di continue pressioni da parte dei più potenti Stati confinanti, il cui obiettivo era, per entrambi, l’annessione.
Proprio le mire espansionistiche dei Savoia ed in seguito quelle della Francia non permisero al marchesato di espandere i propri confini in altre regioni del Piemonte, né di mantenere a lungo la propria autonomia. Dopo Manfredo II possiamo ancora ricordare Manfredo III (1215-1244), Tommaso I (1244-1296), che dovette affrontare Carlo I d’Angiò, Tommaso II, costruttore del castello a Saluzzo (detto ancora oggi La Castiglia), Manfredo IV (12961340), che divenne vassallo di Amedeo di Savoia, Tommaso II (1340-1351), che dovette sostenere una guerra civile col fratellastro del padre, appoggiato dagli Angioini, Federico II (1357-1396) e Tommaso III (1396-1416), autore del poema cavalleresco in oïl Le chevalier errant, da cui prendono spunto i famosi affreschi del castello della Manta.

Alleanze complicate
In conseguenza della situazione geo-politica
del loro Stato, i marchesi adottarono una politica di alleanze poco trasparente, barcamenandosi tra i due vicini a seconda degli interessi del momento, causando in tal modo situazioni spesso difficili. I Savoia assediarono la città per ben tre volte: nel 1363, nel 1415 e nel 1487. I marchesi riuscirono comunque, nonostante una situazione economica negativa e la sfiducia dei propri sudditi, a conservare l’indipendenza fino a tutto il secolo XV, anche se, dopo il 1494, la Francia trattò il marchesato come una sorta di protettorato vassallo, invece che da alleato come sarebbe dovuto essere, per poi annetterselo nel 1549.
Il periodo di maggior splendore per il marchesato fu sotto il governo di Ludovico I (1405-1475) e poi di Ludovico II (14381504). Il primo, con una politica neutrale all’interno della situazione dell’Italia del tempo, seppe collocarsi come mediatore, ottenendo la stima sia dell’Imperatore che del Re di Francia; al contrario il secondo, cercando la gloria sui campi di battaglia, venne ripetutamente sconfitto, portando così il suo Stato al principio del suo declino.
Sempre Ludovico II si impegnò a sviluppare i commerci costruendo il primo traforo alpino, il cosiddetto «buco di Viso», tuttora esistente e praticabile, che collegava con una via sicura Saluzzo al Delfinato ed alla Provenza e quindi al mare. Favorì inoltre lo sviluppo urbano ed artistico della capitale con la costruzione di importanti edifici, tra cui la chiesa di San Giovanni, dove fu poi sepolto. La città assunse così un aspetto nobile ed artistico, che conserva tutt’ora nella sua parte collinare antica, guadagnandosi il titolo di «piccola Firenze del Piemonte». I marchesi ed i loro familiari risiedevano principalmente nel castello di Saluzzo, ma alloggiavano anche in quello di Revello, dove si trova la cappella marchionale, nel castello della Manta e nella rocca di Castellar.
La morte di Ludovico II determinò un lungo periodo di reggenza e di potere della vedova, Margherita di Foix (1473-1536), donna di carattere volitivo, schierata, anche per le sue origini, con la Francia. Questa sua scelta politica determinò una serie di controversie con i figli ed affrettò la decadenza dello Stato.
L’annessione alla Francia
Gli ultimi marchesi si contesero aspramente il trono, prosciugando così le finanze dello Stato: quando si riuscì a ristabilire l’ordine, però, il re di Francia Enrico II di Valois aveva puntato il proprio interesse, come già suo padre Francesco I, sul marchesato. Fu dunque poco più di una formalità, dopo la
Ludovico II favorì lo sviluppo urbano ed artistico di Saluzzo con la costruzione di importanti edifici, tra cui la chiesa di San Giovanni (nella foto su licenza Creative Commons), dove fu poi sepolto.

Il Cristianesimo nel marchesato di Saluzzo è attestato con certezza a partire dai secoli dell’alto Medioevo, anche se si può ragionevolmente pensare che esso già fosse presente in età tardo-antica, portatovi, secondo la tradizione, dasan Dalmazzo martire (nella foto, su licenza Creative Commons, la statua presso Pornassio, in Liguria).

deposizione, nel febbraio 1548, dell’ultimo marchese Gabriele, che morirà pochi mesi dopo, annettere il territorio alla corona francese nel 1549.
Pertanto Saluzzo divenne parte integrante della Francia per poco più di mezzo secolo, vale a dire fino a quando il duca Carlo Emanuele I di Savoia, con il trattato di Lione del 1601, ne ottenne il possesso definitivo, cedendo in cambio al sovrano vittorioso, Enrico IV, alcuni suoi territori d’Oltralpe.
Un’antica tradizione cristiana
Il Cristianesimo nelle terre che costituivano il marchesato di Saluzzo è attestato con certezza a partire dai secoli dell’alto Medioevo (VIII-X sec.), anche se si può ragionevolmente pensare che esso già fosse presente in età tardo-antica, portatovi, secondo la tradizione, da san Dalmazzo martire (254 d.C.), vista l’esistenza di numerose città e villaggi fondati o colonizzati dai Romani (Forum Vibii, Forum Germanorum, Pedona, Auriate…), in cui sicuramente i cristiani dovettero essere parte significativa, almeno a partire dai tempi di Costantino.
Tra le più antiche testimonianze artisticoarchitettoniche cristiane possiamo ricordare la chiesa di Santa Maria del Monastero alla Manta, risalente ai secoli X/XI, come chiesa del Priorato benedettino di Santa Maria, dipendente dal monastero di Pedona. La chiesa abbaziale di San Costanzo al Monte, a Villar San Costanzo, nella bassa valle Maira, il cui documento più antico risale alla fine del secolo XII, ma che dovrebbe essere stata eretta addirittura nell’VIII; essa sorge nel luogo in cui, secondo la tradizione, avrebbe affrontato il martirio san Costanzo, protettore della Diocesi.
Tra i monumenti civili degni di interesse, oltre ai due castelli più famosi (la Castiglia a Saluzzo e quello della Manta, ma altri minori sono disseminati in molte altre località), è necessario citare a Saluzzo la Torre e l’antico palazzo civico del secolo XV, la casa natale di Silvio Pellico e Casa Cavassa, già residenza, tra gli altri membri di questa nobile famiglia, di Galeazzo, vicario del marchese Ludovico II a metà del secolo XV. Essa ora, trasformata in museo civico, costituisce una splendida testimonianza di come dovesse presentarsi una casa signorile dei secoli XV/XVI coi suoi mobili, dipinti (tra cui opere di Jacobino Longo di Alba e di Hans Clemer) ed arredi del tempo.
I due castelli più famosi del marchesato di Saluzzo sono La Castiglia e quello della Manta (nella foto su licenza Creative Commons), ma altri minori sono disseminati in molte altre località.