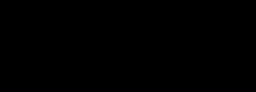9 minute read
INCHIESTA
Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare
Il tempo del dubbio pare finito
Il cambiamento climatico indotto dall’aumento delle emissioni di gas effetto serra dovuto alle attività antropiche è in atto. L’impatto probabilmente non è ancora stato del tutto quantificato, ma coinvolgerà diverse aree importanti per lo sviluppo e il mantenimento degli equilibri vitali di tutti gli abitanti: dalla disponibilità di beni di prima necessità come acqua dolce, cibo ed energia, alle politiche di sviluppo locale e globale per cambiare o mitigare i modelli di crescita e di progresso. I legami tra cambiamento climatico e sviluppo sostenibile sono forti, dice la WHO. Si prevede infatti che il fenomeno interesserà tutti anche se i paesi poveri e in via di sviluppo saranno tra quelli più colpiti e meno in grado di far fronte agli shock.
Un problema di food safety e food security Una delle conseguenze di cui più spesso si parla riguarda la compromissione della disponibilità di cibo (food security) per tutti. Si parla meno di food safety invece. Eppure i cambiamenti a lungo termine di temperatura, umidità, precipitazioni e frequenza degli eventi meteorologici estremi stanno già influenzando le pratiche e la produzione agricola e la qualità nutritiva delle colture alimentari. Inoltre, le modifiche nel metabolismo dei microrganismi potenzialmente tossici o nocivi potrebbero influenzare l’intensità e la comparsa di alcune malattie trasmesse da alimenti. Tutti gli ambienti naturali sono interessati. Come stiamo affrontando tutto ciò? Oltre alla riduzione delle emissioni, è necessario ormai valutare misure di mitigazione, anche in ambito di sicurezza alimentare. L’Europa attraverso i suoi organismi deputati sta già lavorando. Efsa, come si può leggere dalla documentazione messa a disposizione sul sito web, ha inaugurato nel 2018 il progetto CLEFSA, che ha lo scopo di sviluppare metodi e strumenti per individuare e definire i rischi emergenti per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute delle piante e degli animali, i rischi biologici, i contaminanti e la qualità nutrizionale connessa ai cambiamenti climatici. In tema di contaminanti, molti fenomeni osservati annoverano fra le possibili cause il cambiamento climatico. Temperatura e umidità sono i principali indiziati

per quanto riguarda la crescita fungina, l’infezione delle colture e la tossicità delle tossine eventualmente prodotte, che possono entrare nella catena alimentare attraverso colture e mangimi (cereali, legumi, frutta a guscio). Un pericolo emergente è poi legato alle miscele di micotossine per cui si stanno iniziando a valutare gli effetti sull’uomo e sugli animali (vedi intervista a Paola Battilani). L’ambiente marino è interessato per la disponibilità di fitoplancton, microalghe indispensabili al nutrimento di pesci e al tre forme marine. Alcune di queste alghe però sono tossiche e mettono a rischio la sicurezza dei frutti di mare, come ricorda l’episodio legato alla ciguatera avvenuto nel 2008. L’alga è tipicamente tropicale ma la sua proliferazione ha provocato fo colai di avvelenamento di frutti di mare in Spagna e Portogallo. Efsa sta studiando i fattori ambientali che ne influenzano la tossicità (aumento della temperatura e della salinità) e sviluppando modelli per prevederne la fioritura, l’accumulo nei pesci e i futuri focolai utilizzando diversi scenari climatici. Anche l’aumento di bat teri marini indigeni come il Vibrio che può produrre tossine nei molluschi, può esse re spiegato con l’aumento dei livelli delle acque di mare e delle temperature. Infine, i cianobatteri di origine naturale, d’acqua dolce e marina, che possono avere anche proprietà tossiche, «il cui aumento è pre visto a causa del riscaldamento globale e di altri fattori ambientali come la dispo nibilità di nutrienti» spiega Efsa, che su tutte queste tematiche ha aperto aree di studio e intervento per aiutare la defini zione di politiche di intervento.
I cambiamenti a lungo termine di temperatura, umidità e precipitazioni stanno già influenzando la qualità nutrizionale delle colture
Le conseguenze Rimane comunque difficile valutare le perdite delle colture a livello globale. Uno studio del 2019, pubblicato su Nature Ecology & Evolution (The global burden of pathogens and pests on major food crops. S. Savary et al.) ha fornito stime sulle perdite di rendimento per cinque principali colture a livello globale. Le perdite associate a 137 agenti patogeni e parassiti riguardano grano (10.1-28.1%), riso (24.6-40.9%), mais (19.5-41.1%), patate (8.1-21.0%) e soia (11.0-32.4%); le più elevate si rilevano nelle regioni a deficit alimentare con popolazioni in rapida crescita e spesso a emergenti. Ma non finisce qui, perché il cambiamento climatico si inserisce in un quadro più ampio di cambiamento globale al quale contribuiscono fenomeni su scala pla netaria causati da cambiamenti sociali quali l’intensificazione del commercio globale, modifiche nei sistemi di produ zione agricola e cambiamenti nelle tendenze dei consumatori. Oggi abbiamo un movimento enorme di merci e persone che favoriscono l’introduzione casuale di microrganismi o insetti da zone diverse dalla nostre. «Il cambiamento climatico potrebbe semplificare l’adattamento», dice Battilani. Questo è uno dei temi che affronta Efsa nella valutazione del rischio per i patogeni da quarantena. L’11 ottobre scorso la Commissione ha pubblicato un elenco di 20 organismi nocivi da quarantena regolamentati, considerati prioritari che hanno il più grave impatto sul territorio dell’UE (Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1702 of 1 August 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council by establishing the list of priority pests).
20 Gli Stati membri dovranno avviare campagne di informazione ma anche predisporre piani di emergenza, simulazioni e piani d’azione per l’eradicazione di tali organismi nocivi. Per il commissario Tibor Navracsics, anche responsabile per il Centro comune di ricerca (JRC), che ha lavorato all’individuazione degli organismi nocivi, «dobbiamo innanzitutto arrestare l’impatto negativo sull’economia, sull’ambiente e sulla società». Spiega Emilio Rodriguez Cerezo, coautore dello studio: «La metodologia permette di stimare il potenziale impatto dei parassiti della quarantena sui settori economico, sociale e ambientale. Integra in un unico indicatore le stime delle perdite di produzione, degli impatti sul commercio e sull’occupazione e su altri indicatori socioeconomici». Sono stati 38 gli organi

smi più pericolosi individuati per l’Unione - ma la Commissione ne ha segnalati 20 - selezionati sulla base della probabilità di diffusione, di insediamento e delle conseguenze. Oltre agli effetti diretti sulla produzione, sono responsabili di effetti indiretti significativi su numerosi settori economici a monte o a valle. Ad esempio, se il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) dovesse diffondersi in tutta l’UE, si registrerebbe una perdita diretta di oltre il 5% delle scorte complessive di legname e l’impatto economico sul settore forestale a monte potrebbe raggiungere i 50 miliardi di euro. L’UE e gli Stati membri si stanno impegnando a trasformare l’Europa in un’economia a basso consumo energetico e a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Il quadro di azione per il clima nell’UE include inoltre strategie per la sicurezza di alimenti e mangimi. Non è più solo una questione di prospettiva ma è un problema ormai entrato nell’agenda quotidiana degli operatori di tutte le filiere agroalimentari. Il tempo del dubbio sembra proprio finito.
Abbiamo chiesto a Paola Battilani, docente di patologia vegetale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, di spiegare gli effetti del cambiamento climatico sulle patologie delle piante di interesse alimentare (e zootecnico) e i mezzi per affrontarle.
Partiamo parlando di micotossine, come agisce il cambiamento climatico sulla produzione di queste tossine? L’effetto del cambiamento climatico non si può dare per scontato, perché la relazione fra le variabili coinvolte è molto complessa. Può accadere che si modifichino gli equilibri fra i diversi funghi o fra funghi e insetti in un modo difficile da prevedere. In merito alle aflatossine, c’è una ragionevole certezza che si vada verso un peggioramento della situazione. Sono prodotte da un fungo che più si avvantaggia di altri delle elevate temperature e delle condizioni di siccità. Poiché andiamo verso un innalzamento delle temperature è evidente che sarà favorito perché tutti gli altri funghi, in simili condizioni, diventano meno competitivi.
È un fenomeno limitato ad alcune aree geografiche? Da un punto di vista generale si parla di un incremento delle tossine, favorito da un aumento della temperatura di +2/+3 °C, che è la situazione che oggi appare confermata. Di certezze ne abbiamo poche. Se non che andiamo verso un aumento della CO2 e della temperatura e verso eventi estremi (piogge forti o siccità). Questo ha certamente un impatto a livello di macro-aree, ma la stessa variabilità la si osserva anche su piccola scala: nell’ambito della stessa regione o fra località poco distanti fra loro. Nel 2003 si è avuto effettivamente su tutto il territorio del nord Italia un solo tipo di tossina dominante ma da allora è successo che in località anche vicine si sono avute più tossine presenti e la tossina dominante in un luogo era diversa da quella dominante in un altro. Il fenomeno si spiega appunto con l’interazione pianta-patogeno-ambiente su cui le condizioni meteorologiche e la loro variabilità hanno un impatto, differente fra gli anni ma anche nello stesso anno fra località.
Da qui si arriva alla tematica emergente della copresenza e del rischio tossicologico connesso... Abbiamo appena concluso un progetto finanziato da EFSA sul risk assessment riguardante la copresenza di micotossine nei prodotti ad uso alimentare. Ad oggi i dati sull’impatto tossicologico su animali e su uomo delle diverse combinazioni di copresenza delle micotossine sono scarsissimi e non consentono di eseguire un risk assessment. Abbiamo però conferma, ottenuta grazie alle analisi eseguite sui biomarcatori, ovvero i fluidi biologici, che siamo effettivamente esposti a un pool di micotossine.
Cosa si sta facendo da un punto di vista di pratiche agricole? Due sono stati gli approcci principali: cercare di migliorare la gestione delle colture per renderle più resilienti, ovvero meno suscettibili allo stress, dal momento che si sa che i funghi micotossigeni sono parti colarmente favoriti da condizioni estreme e di stress, e agire direttamente sui funghi tossigeni, nel rispetto dell’ambiente. Si è lavorato molto per redigere linee guida che supportassero gli agricoltori nella migliore gestione delle colture, con un’attenzione particolare ai costi, come pure nella fase di raccolta e post raccolta, un momento importante soprattutto per i cereali. In particolare, si è cercato di giustificare i suggerimenti operativi con spiegazioni, per aumentare la consapevolezza degli operatori e quindi la loro disponibilità a tenerne conto. Se, per esempio, lasciamo il mais in campo perché perda umidità per avere un costo di essicazione più basso, stiamo in realtà lasciando più tempo al fungo per produrre aflatossine. Abbiamo lavorato dal 2003 anche sul biocontrollo di Aspergillus flavus, il fungo produttore delle aflatossine, ottenendo un prodotto con autorizzazione temporanea di impiego che dal 2016 è disponibile per gli agricoltori con ottimi risultati.
Cosa si può dire sui modelli previsionali? Usano i dati dell’andamento meteorologico come input e come output, restituiscono il livello di rischio di avere colture contaminate al di sopra dei limiti di legge. Permettono all’agricoltore di ottimizzare le tecniche da implementare per ridurre il rischio. Possono anche essere usati per fare mappe di rischio del territorio (usando dati storici) oppure per avere previsioni future sulla tendenza di un certo fungo o tossina.
Oltre alle micotossine quali altre patologie dobbiamo aspettarci? Non ci sono, per ora, altre patologie così impattanti come quelle relative alle micotossine, almeno se ci riferiamo all’effetto diretto sulla salute del consumatore. Tutte le malattie però risentono del cambiamento climatico e la variabilità ha un importante impatto. Anche su piccola scala, e da un anno all’altro, si vedono grosse variazioni. Sono stati fatti alcuni studi per prevedere come cambierà l’importanza delle diverse malattie nelle colture, ad esempio sulla vite. Anche in questo caso è difficile fare una previsione, ma non possiamo escludere che l’andamento climatico possa di anno in anno dare spazio a patogeni diversi.