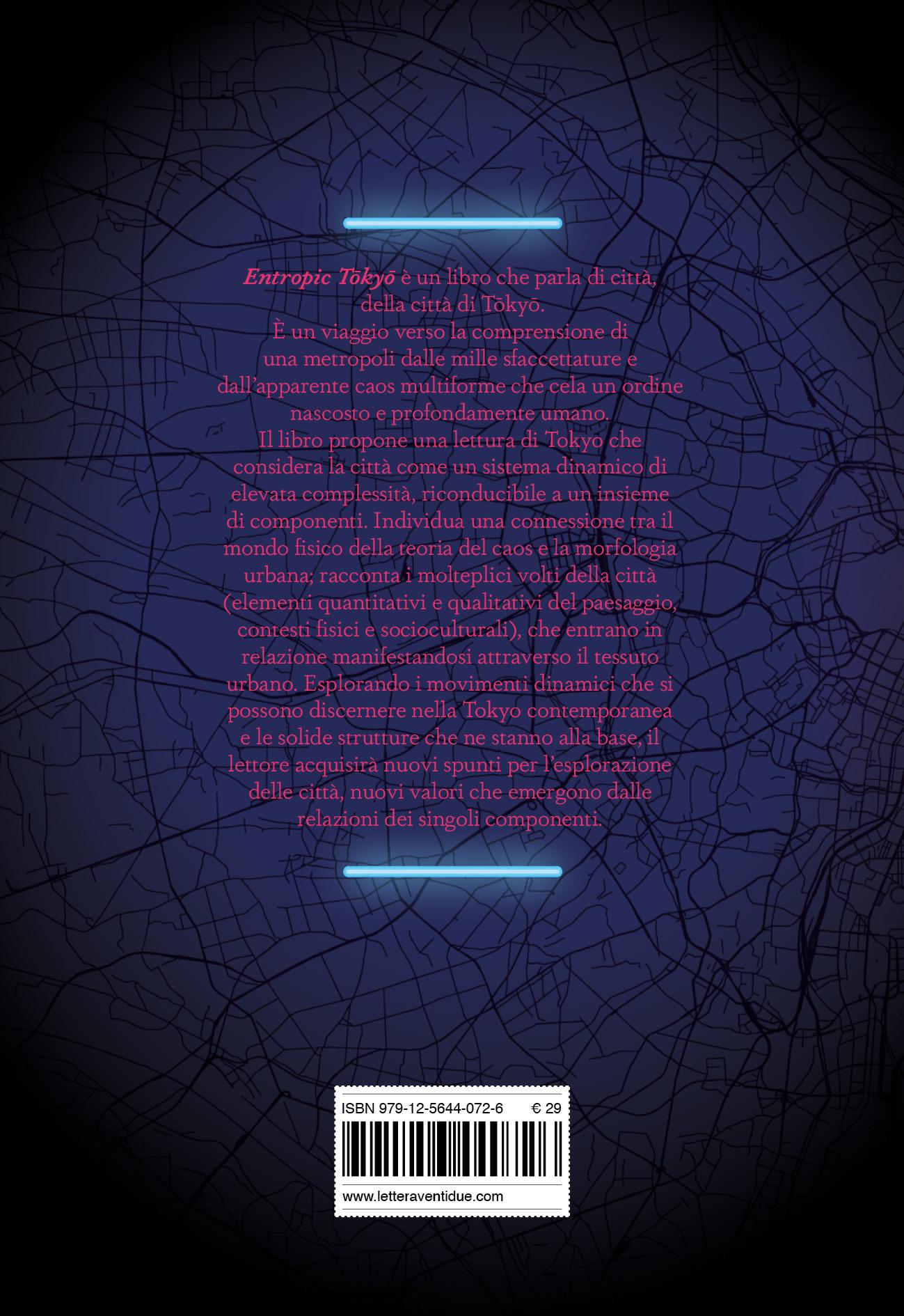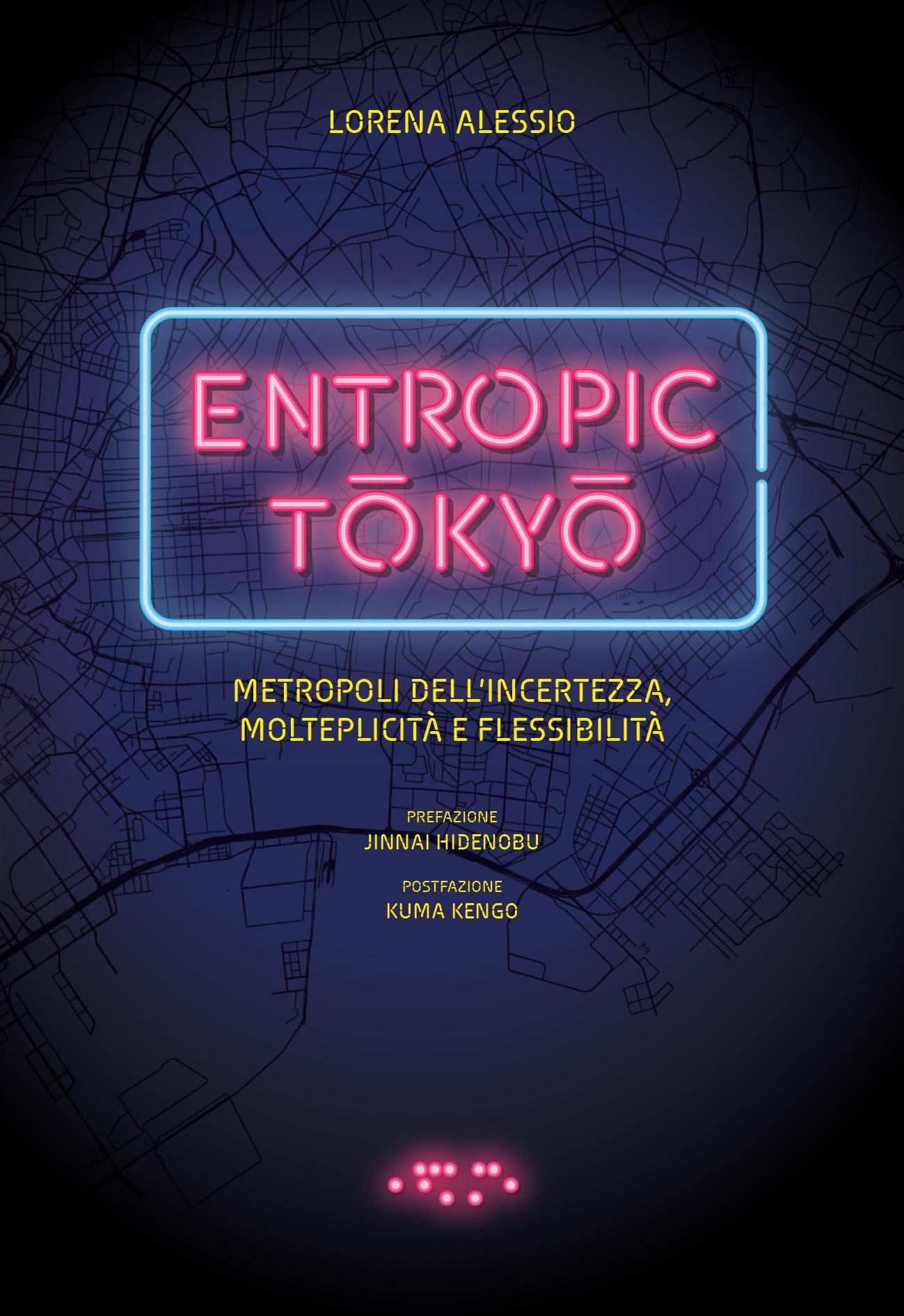




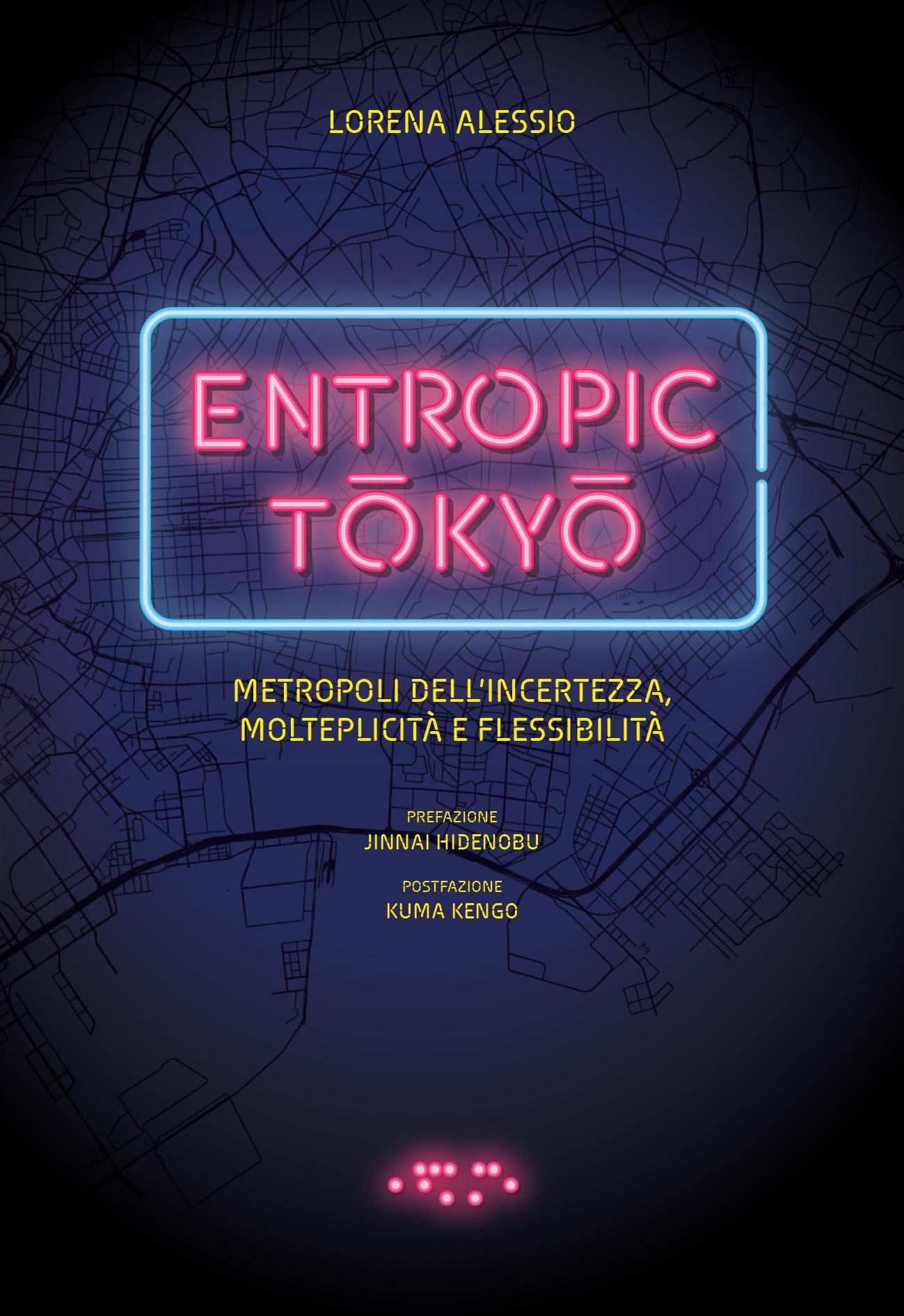



陣内秀信
法政大学江戸東京研究センター初代センター長
Professore alla Facoltà di Ingegneria e Design, Hosei University
Primo Direttore del Centro di Ricerca e Studi Edo-Tokyo, Hosei University
本書は、イタリアのトリノを拠点に建築と都市の研究及 び設計の実務に活躍する女性建築家、ロレーナ·アレッシオ (Lorena Alessio) 氏による、都市東京の特質を解明する目的 で書かれた野心的な著作である。世界のなかでも特異な存 在で、複雑な様相を示すこの巨大な都市の実像をヴィヴィッ ドに描き出し、その魅力の源泉をも解き明かす。
日本に留学し、PhD 論文の作成に取り組んでいた頃から 彼女の研究の理論的なアプローチに関心をもち、その後の 大きな進展を見続けてきた私にとって、アレッシオ氏の長年 の研究成果が、このような素晴らしい本の出版に結実したこ とは、大変嬉しいことである。そして今、こうしてこの本の推薦 文を書く機会を得たことを光栄に思う。
アレッシオ氏もまた、多くの外国人の建築家、都市計画家 と同じように、東京に初めて来た時に、この都市が西洋都市 とはまったく異なる様態を示し、自分の身につけていた認識 方法ではまったく理解できないことに大きなショックを受け た。この都市は何者なのか?その謎を解き明かそうと考えた のが東京研究の発端だったという。
一見、カオティックで秩序不在に見える都市という東京の イメージは多くの外国人が抱く共通の印象だった。それをど う捉え、評価するかは、実は、時代とともに変化してきたと言 える。我々日本人自身も、変化が激しく、建物がバラバラに並 び、西欧都市のような整った空間の美からは程遠い東京の都 市をネガティブに捉える傾向が1970年代のある段階まで 続いた。パリを筆頭とする美しい景観をもつ西欧都市への憧 れも強かった。
だが、日本が経済成長を遂げ、社会に余裕が生まれた70 年代後半から80年代前半にかけて、そのトラウマから抜け 出し、東京に独自のアイデンティティを捉え直そうという動き が急速に進んだ。常に変化し、安定した統一美とはかけ離れ ていても、西欧の都市にない小さいスケールを大切にし、多
Entropic Tōkyō è un libro che parla di città, della città di Tōkyō.
È un viaggio verso la comprensione di una metropoli dalle mille sfaccettature e dall’apparente caos multiforme che cela un ordine nascosto e profondamente umano. Generalmente la nostra comune comprensione dello spazio urbano è spesso dominata dalla volontà di riconoscere un ordine visivo tra le cose. Tale tendenza spinge l’uomo verso una semplificazione della realtà che azzera i significati più profondi e ne riduce l’effetto. Per molto tempo mi sono dedicata allo studio delle configurazioni urbane e del modo in cui esse si sviluppano nel tempo entrando in relazione con il contesto. Tuttavia quando andai a Tōkyō per la prima volta rimasi profondamente colpita dal suo carattere eterogeneo e dall’apparente mancanza di bellezza che rendevano questa realtà così diversa rispetto ai modelli occidentali, soprattutto italiani.
Era il 1994 e il Giappone stava soffrendo per la fine della Bubble Economy, lavorando alla costante ricerca di nuove strategie di crescita e sviluppo. In quegli anni scoprii di essere affascinata dalla capacità della città di permanere in uno stato di continuo divenire, aperto ai modelli innovativi esterni, ma attenta a preservare i suoi caratteri identitari. Profondamente danneggiata dal Grande Terremoto del Kanto del 1923, e successivamente colpita dai bombardamenti durante la Seconda Guerra mondiale, Tōkyō ha imparato a ricostruirsi e rinascere in forma nuova. Gli occhi di un visitatore che osservano periodicamente la città in alcune sue parti potrebbero sentirsi disorientati dalla mutevolezza e dagli innumerevoli interventi di riqualificazione urbana che aprono alla vista uno scenario sempre diverso. In effetti a partire dagli anni Novanta, Tōkyō ha cambiato
profondamente il suo aspetto in seguito ad un consistente cambiamento delle politiche urbane. Qualcosa del vecchio mondo si perse, ma qualcosa di nuovo arrivò. Entropic Tōkyō parla di questo.
Oggigiorno la maggior parte delle città si trova a dover affrontare problemi legati all’avanzare del mondo globalizzato e, contemporaneamente, alla volontà di tutela dei propri caratteri identitari. Ciò che oggi vediamo della città è il frutto di continue evoluzioni del sistema, che si manifestano in uno spazio e un tempo indefiniti.
L’architettura giapponese, così come la struttura delle città, esprime la vitalità della cultura. La città possiede una distintiva libertà caratterizzata non da rigide impostazioni planimetriche, ma dalla fluidità della comunità che la vive. Comprendere l’essenza della città giapponese vuol dire cogliere l’ordine all’interno del disordine.
Verrà qui proposta una lettura di Tōkyō basata sul racconto dei molteplici volti della città – elementi quantitativi e qualitativi del paesaggio, concetti fisici e socio-culturali – che entrano in relazione manifestandosi attraverso il tessuto urbano.
A partire dai miei studi durante il dottorato in Giappone e in seguito alle successive attività di ricerca svolte nel corso degli anni sono giunta all’individuazione di una connessione tra il mondo fisico della teoria del caos e l’approccio urbanistico proprio dell’architettura, che mi ha offerto un nuovo linguaggio di descrizione applicabile agli studi sulle città.
Lo scopo di questa ricerca è, quindi, quello di sviluppare e fornire nuovi punti di vista per l’esplorazione dell’ambiente urbano di Tōkyō, che nascono dall’indagine e dalla relazione tra le sue componenti. L’approccio adottato non considererà la città come un oggetto bensì come un organismo, un sistema dinamico ad elevata complessità. Tale definizione implica che la città sia riconducibile ad un insieme di componenti e che le relazioni e i processi che scaturiscono da esse non siano gestibili con strumenti deterministici.
La morfologia urbana deve essere intesa in termini di forma e processo. Per fare ciò, è necessario approcciarsi allo studio della sua forma attraverso una nuova visione che vede il caos come indice di elevata entropia, e di conseguenza di elevata incertezza, di maggiore dispersione di energia. Dalle ricerche effettuate deriva che se un sistema presenta più incertezze, allora tenderà ad essere disordinato e di conseguenza avrà bisogno di maggiori informazioni per essere descritto. Nei sistemi ordinati, invece, l’entropia e il disordine saranno minori con meno incertezze.
itneveideterenidrosideenidroaiportneesoacemozionalità
oku(奥) ma(間) michikusa (道 草)
fudosei (風土性) shinsui shinsui
(しんすいしんすい) libertàspaziale esterni
s izap o r a p p o r to con la natura infrastrutture
silenzio sensibilità stimoli temporaneitàe morfologiaterritorialevivibilitàallascalaumanainterconnessione tutela approccio bottomup
ÀTTICALLEDIVITATILAUQ
onabruotusset otattegorpoizaps ipecrep t o p e r c e z ione de l lo spazio sistemadinamico
tnemmariza
itoacàtic e fitlum àtimro àtilibisselfgrattacielistruttureadusomistomorfologiaurbanatempliesantuari sento syamanote hitamachi piazze incroci stradali parchi urbani pops viali pedonali elementidiconnessione roji waterfronts porti stazioni rete ferroviaria
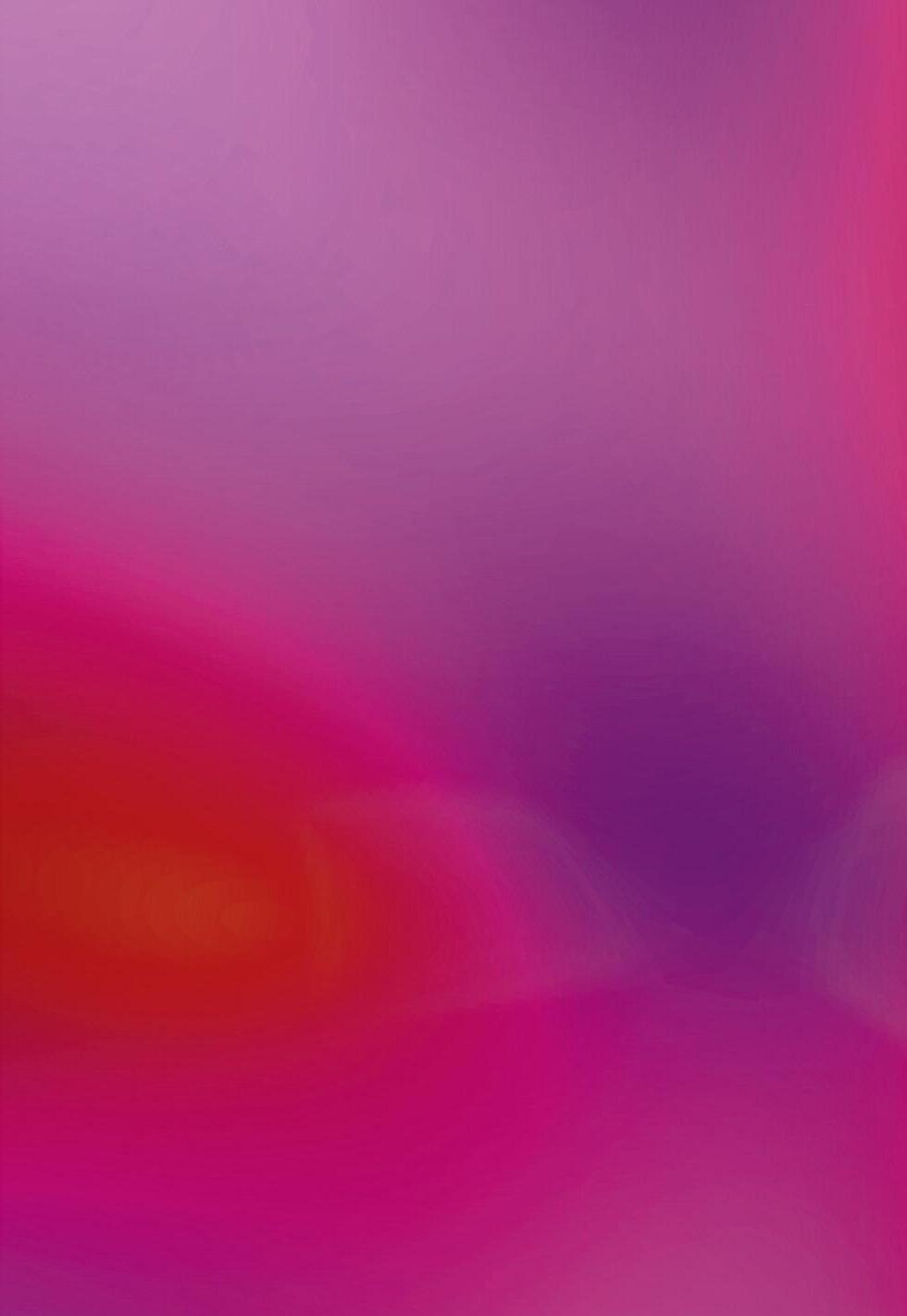
Interrelazioni di Entropic Tokyo

La città è ovunque e in ogni cosa (Amin e Thrift 2002).
Da alcuni anni le ricerche scientifiche in campo urbanistico concordano nel considerare la città come un sistema definito da elementi funzionali e dalle interazioni tra le sue componenti, che producono molteplici effetti sul contesto. Le città devono essere considerate come un sistema complesso, con qualità spaziali caratterizzate da una straordinaria varietà, e trattate come problemi di complessità organizzata (Jacobs 1961, 434). È difficile arrivare ad una comprensione esaustiva del contesto urbano: il primo passo risiede in un cambiamento rispetto all’approccio meccanicistico che manifesta una tendenza alla semplificazione del modello urbano. Il cambiamento ci avvicina alla visione delle città come organismi complessi che mai si arrestano, ma evolvono in una molteplicità di spazi e tempi.
Molti studiosi si sono dedicati alla comprensione delle molteplici dimensioni della vita quotidiana della città. Henri Lefebvre (1966) definisce il quotidiano come condizione esistenziale o fenomenologica; e intende la quotidianità come una forza vitale immanente che attraversa il tutto. Batty (1994) si concentra sulle interazioni, piuttosto che sui luoghi, sulle reti e sui flussi e sulla capacità di comprendere le reti, puntando alla definizione di una nuova scienza per le città.
Altri studiosi hanno, invece, recuperato la flânerie, le peregrinazioni di Walter Benjamin, come tecnica di ricerca
nell’ambito della sociologia applicata al contesto urbano. L’idea di studiare la metropoli, vagando senza una meta stabilita, setacciandone gli angoli, presuppone una profonda trasformazione concettuale e metodologica degli studi sul territorio. La lettura intima della città pone l’attenzione sulle dinamiche urbane quotidiane e sul bisogno di esplorare un contesto al di là dei poteri della cognizione. Alla base di questa politica del quotidiano risiede l’importanza di cogliere la quotidianità percepita come forza immanente, “un eccesso che non deriva né da un corpo né da un mondo isolato, ma dai movimenti banali del processo puro” (Seigworth 2000, 240). Pertanto le recenti tendenze riconsiderano l’approccio situazionista come metodo di comprensione delle qualità urbane. Ma la comprensione attraverso i sensi resta difficile da analizzare e da inserire in uno studio metodologico sulla città.
Il filosofo Watsuji Tetsuro (1935) ha creato il neologismo fudosei (風土性) per indicare il legame tra una società e il suo ambiente: in questo legame risiede lo spazio della soggettività umana ed è qui che vorrei considerare il paesaggio urbano. Ma quali sono i temi necessari per comprendere l’agglomerato urbano? In che modo urbanisti e architetti possono parlare della città includendo tutti gli elementi del sistema?
Il presente libro non intende fornire una risposta a questi ambiziosi interrogativi, ma vuole suggerire nuove prospettive di osservazione della città.



«La mia prima visione della Nakagin Capsule Tower avviene attraverso le fessure delle mura di recinzione del Giardino di Hama-Rikyu. La discesa del fiume Sumida mi conduce nello splendido e secolare giardino, ora attorniato, oltre che da uno strato d’acqua, dai grattacieli.
Intravedo la Capsule Tower dell’architetto Kurokawa Kisho, icona del Metabolismo. Un mosaico di 144 capsule abitative prefabbricate in cemento e acciaio, per la cui tutela il Japan Institute of Architect di Tōkyō si spese attivamente.
Situato vicino al quartiere della vita notturna di Ginza, la Nakagin Capsule Tower offriva, quando progettata, alle persone di ceto medio, la possibilità di non rinunciare ad una vita in centro.
Nel 1972, all’epoca della sua costruzione, la torre era simbolo del progresso tecnologico e culturale del Giappone: le unità abitative annunciavano l’era dell’architettura in movimento, distaccata dal suolo, modificabile per parti. Le capsule, pensate per preservare le libertà individuali degli inquilini, incarnavano l’emancipazione dell’uomo che corre al riparo dal sovraccarico di informazioni. Un tema affrontato cinquant’anni fa, oggi attuale più che mai.
Tuttavia, nel giro di trent’anni, nessuna capsula era stata sostituita. Provato dai segni del tempo e in evidente stato di usura, molti inquilini si mostrarono favorevoli all’abbattimento dell’edificio in favore della costruzione di una struttura più grande.
Le iniziative di Kurokawa, di architetti e di altri attivisti per la conservazione convinsero il Governo di Tōkyō ad intervenire in difesa della torre. Ricordo, nel periodo tra il 2008 e il 2011, alcuni cari amici architetti, impegnati a distribuire brochure informative per sostenere la tutela della Nakagin Capsule Tower. Nel 2013 circa 40 delle 140 capsule risultavano ancora occupate. Nel 2014 Masato Abe, il proprietario di una capsula ed ex-residente fondò il Comitato “Save Nagakin Tower”. La definitiva demolizione avvenne il 12 aprile 2022, in soli due giorni. Alcune delle capsule abitative furono vendute a collezionisti oppure donate a musei d’arte contemporanea, evitandone così la demolizione.
Tōkyō ha sempre avuto molte identità. La sua natura multifrattale e plurinodale rivela micro realtà che aprono alla vista scenari differenti. Sebbene le differenze tra alcuni nodi tendano a scomparire determinando la perdita dei propri elementi caratteristici, la città si sta impegnando a creare nuove identità con l’obiettivo di aprirsi al mondo. Il TMG è sempre alla ricerca di nuove visioni che possano portare Tōkyō a diventare un modello mondiale. Negli ultimi decenni gli approcci top-down hanno trovato ispirazione dalle realtà occidentali andando a definire nuovi scenari urbani, prima sconosciuti, e sostituendo le precedenti identità locali, frammentate e meno organizzate, con nuove identità più omogenee, pre-organizzate e controllate.
Indotta dalle forze esterne delle metropoli occidentali, Tōkyō si è ormai avviata verso una forte spinta rivoluzionaria di rivitalizzazione del tessuto urbano. Lo skyline sta mutando: la città, prima composta principalmente da edifici di pochi piani, si sta trasformando progressivamente in una metropoli verticale. Come meteoriti che entrano in collisione con la terra determinando effetti permanenti, i nuovi interventi urbani, soggetti agli stimoli delle città occidentali e alle nuove tendenze sociali, sono giunti nel centro di Tōkyō in modo irruento, sconvolgendo i vecchi equilibri e generandone altri. Finora gli approcci top down di Tōkyō hanno definito nuove visioni per la città e nuovi modi di vivere. I grandi stakeholders, in accordo con il settore pubblico, hanno sviluppato grandi aree con grattacieli che offrono sul mercato nuovi tipi di strutture ad uso misto con grandi spazi per uffici, aree commerciali e appartamenti nel centro città. Questi nuovi sviluppi hanno riportato la gente in centro per vivere. La vita negli appartamenti, prima assente a Tōkyō, è stata valorizzata come Mappa dei casi studio


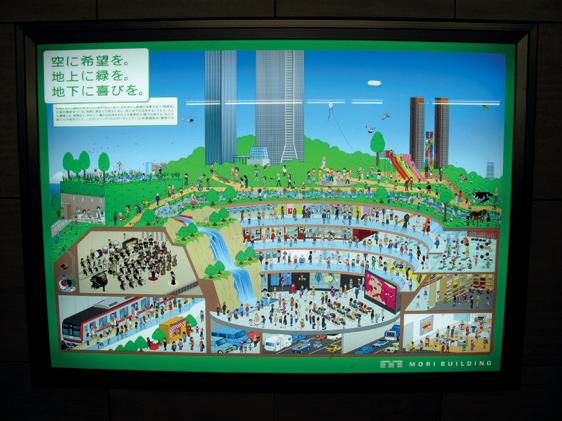



Hagiso venne inaugurato nel 2012 e tre anni dopo Hanare, una struttura con 5 stanze, su un’area di 99,2 mq.
Il complesso di Hanare, che comprende entrambe le strutture, funziona oggi come hotel, ma anche come importante punto di riferimento del quartiere in quanto offre una panoramica delle possibili attività da svolgere e include una serie di servizi esclusivi tra cui: creare e suonare un flauto in bambù, vivere l’esperienza di un bagno nei sento (antichi bagni pubblici del quartiere), fare un tour guidato indossando un kimono tradizionale, affittare una bicicletta o conoscere persone del luogo.
I costi del progetto sono stati sostenuti per 2/3 dai proprietari degli immobili e per 1/3 dall’architetto, un accordo che avrebbe comportato la condivisione del rischio.
L’elemento di innovazione del progetto e il suo valore aggiunto risiedono nella valorizzazione dei luoghi attraverso la
strutturazione di una rete tra le risorse territoriali, che offrono alle persone modi alternativi di vivere il quartiere.
D’altra parte le strutture dell’hotel, che sorgono entrambe all’angolo di un isolato e quindi occupano una posizione ben visibile che avrebbe potuto alterare gli equilibri e la tranquillità del quartiere, sono riusciti ad entrare in relazione con l’area circostante ponendo attenzione alla qualità e al valore morale delle esperienze offerte.
L’esperienza dell’hotel Hanare ci insegna che la flessibilità è una caratteristica imprescindibile dell’approccio innovativo, e che la vera innovazione risiede nel processo, e non in un oggetto iconico. Yanesen ha sostenuto un processo d’innovazione che ha colto i punti di forza del luogo andando incontro ai cambiamenti del tempo. Un connubio tra passato e presente in grado di creare un’offerta diversificata ed esclusiva.