
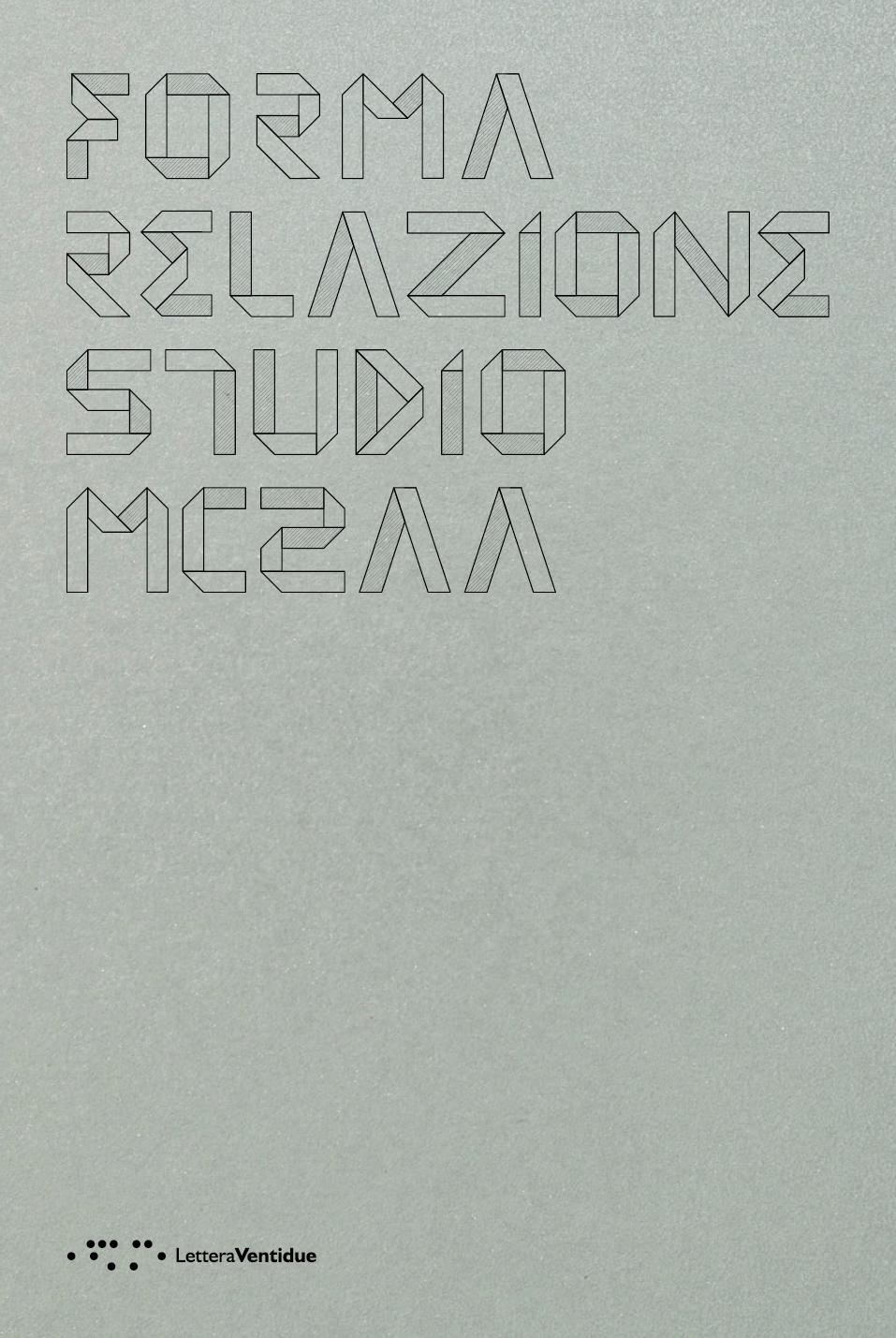
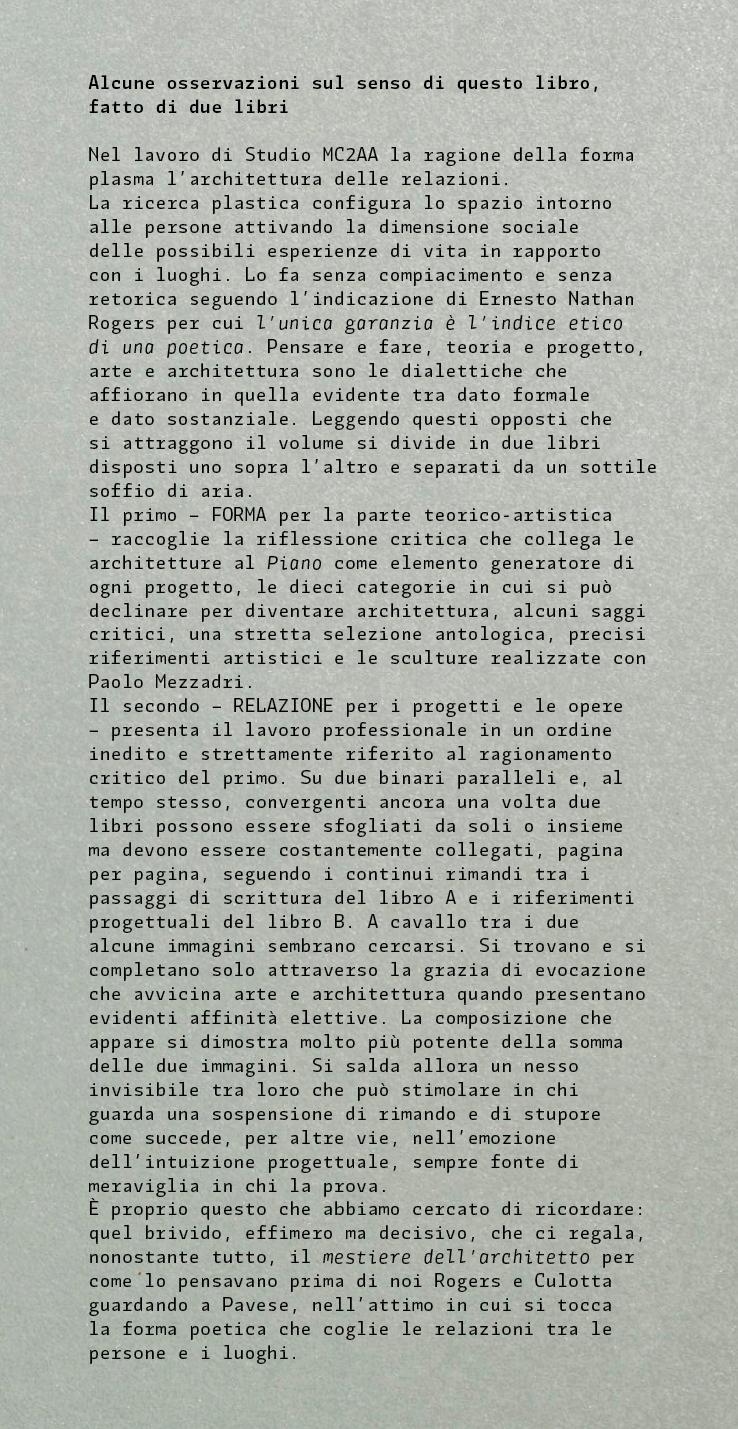


Il doppio sguardo di MC2AA
Antonino Saggio
Se volessimo tracciare una linea di demarcazione netta, potremmo dire che la ricerca architettonica si divide in due grandi campi: da una parte i formalisti, dall’altra gli architetti dei contenuti. I primi pongono al centro l’elaborazione della forma, la costruzione di un linguaggio personale e riconoscibile; i secondi lasciano prevalere, di volta in volta, le ragioni del programma, del contesto, del sito e del budget. Naturalmente questa suddivisione è arbitraria: tra un estremo — penso
al mio maestro Carlo Melograni — e l’altro — penso al mio mentore Peter Eisenman — si dispiegano mille sfumature di grigio. Impostata così la questione, è interessante osservare il lavoro di Dario Costi e Simona Melli, riuniti sotto la sigla MC2AA, protagonisti di una recente e importante mostra presso la Galleria dell’Architettura a Valle Giulia a Roma e di questo volume di Gaetano De Francesco.
Da buoni emiliani, Costi e Melli mostrano un’attenzione al dato concreto del progetto molto spiccata: la loro pratica si distingue per numerose realizzazioni e collaborazioni con clienti, associazioni e soprattutto con molti Comuni della loro regione.
I loro progetti rispettano il budget, arricchiscono la

funzionalità sociale e urbana e rappresentano quasi sempre un dono per il committente. Eppure, al tempo stesso, la loro architettura rivela una forte vocazione formale. La pubblicazione e la mostra lo mettono in piena evidenza: dal dialogo serrato tra Costi e De Francesco è nata un’autentica organizzazione di principi — Orografia, Soglia, Risvolto, Piega, Curva, Nastro, Taglio, Sospensione, Sequenza, Incisione.
Ciascuno di essi è racchiuso in una parola-chiave, ma in realtà attraversa l’opera in tutta la sua profondità, dal piano formale a quello pragmatico. Il dato formale diventa così lo strumento per affrontare con efficacia quello pragmatico, e il dato pragmatico,
a sua volta, si rivela fondamento del formale. Ne nasce un atteggiamento progettuale che vive insieme nella teoria e nella pratica, e che spesso entra in risonanza con la scultura e l’arte.
Non è forse proprio questo ciò che cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti? E non è in questa direzione che la mostra assume anche una straordinaria utilità didattica? Il doppio sguardo — pragmatico e formale — si rispecchia in un’attenzione relazionale che contraddistingue il lavoro di questo studio italiano. Ancora giovani, per la misura dei tempi dell’architettura, siamo certi che questa mostra e questo volume offriranno l’occasione per conoscere e apprezzare ancora meglio il valore della loro ricerca.



Forme di relazione
Gaetano De Francesco
PREMESSA
Ho conosciuto il lavoro dello studio parmigiano MC2AA alcuni anni fa, con l’uscita delle pubblicazioni Architettura delle relazioni.
Note. Le forme della vita e le sponde di filosofia, sociologia, neuroscienze e arte (Costi 2023) e Opere e progetti (Costi 2023a), il volume nel volume che raccoglie le riflessioni teoriche che alimentano il lavoro degli architetti Dario
Costi e Simona Melli, fondatori dello studio, e ne documenta le principali opere.
Da allora ho avuto modo di approfondire il senso della loro ricerca, comprenderne lo spessore teorico, apprezzarne la coerenza di senso tra pensiero, progetto, architettura e il rigore metodologico. Questo saggio propone una lettura critica dell’opera di MC2AA attraverso un esercizio di concettualizzazione della forma e di comprensione delle relazioni da cui essa trae origine. Racconta le opere di MC2AA attraverso l’esplicitazione della loro grammatica compositiva, al fine di rendere manifesto il processo di ricerca formale e i suoi strumenti. È una riflessione critica sull’architettura nata da un dialogo con Dario Costi e Simona Melli. Un percorso condiviso con lo Studio MC2AA che ha assunto il valore di un momento di verifica e bilancio
anche per gli stessi progettisti, a coronamento di un’esperienza professionale ormai più che ventennale. Il testo restituisce dunque non solo una nuova chiave di lettura dell’opera di MC2AA, ma anche una consapevolezza maturata insieme, nel confronto tra chi osserva e chi progetta.
FORMA COME PROCESSO
L’architettura è uno scavo profondo nella dimensione spaziale che ha come risultato la forma. Ludwig Mies van der Rohe, il maestro di Aachen, affermava: «La forma non è il fine, bensì il risultato del nostro lavoro. Non esiste alcuna forma in sé. La vera pienezza di forma è condizionata e strettamente legata ai propri compiti: sì, è l’espressione più elementare della
loro soluzione. La forma come fine è formalismo; e noi lo rifiutiamo» (Mies van der Rohe 1923, L).
In una lettera al Dr. Riezler, direttore della rivista Die Form scriveva: «La forma è effettivamente uno scopo? Non è piuttosto il risultato di un processo di formazione? Non è il processo l’essenziale? Un piccolo cambiamento delle sue condizioni non ha come conseguenza un risultato diverso?
Un’altra forma?» (Neumeyer 1997, 271). Queste menzioni sono passaggi essenziali nel dialogo tra Mies van der Rohe e Paul Klee, ricostruito da Dario Costi nel libro Mies e Klee.
L’arte moderna di costruire tra le cose e l’attesa dell’apparizione (Costi 2025). Non è un caso che MC2AA assuma come principale fra i suoi maestri il pittore svizzero.
Nel prologo del libro, in pochi cenni introduttivi, Costi racconta come da ragazzo si sia avvicinato all’arte e all’architettura attraverso i diari di Klee (Klee 1960) e come il lavoro del maestro di Münchenbuchsee sia centrale per l’architettura moderna, non solo per la forza evocativa degli esiti di quel processo di riduzione al carattere delle cose, ma anche per la ricerca generativa della
Gestaltung elaborata nella teoria della forma e della figurazione (Spiller 1959) che porta a un declinarsi delle forme di natura processuale in cui l’atto generativo è il centro dell’attenzione come sequenza di passaggi che conducono alla configurazione finale (Costi 2025, 39). Per MC2AA la forma è esito atteso, è risultato del
processo progettuale e riflette in un certo qual modo una sensibilità volta a mettere continuamente in discussione il linguaggio –se per linguaggio si intende un a-priori cui bisogna aderire –, è risultato di un attento processo progettuale in cui tema e luogo sono le condizioni di partenza. Lo testimoniano anche i taccuini di Costi che vanno intesi come strumenti di lavoro intellettuale, spazi di una dialettica continua tra teoria e progetto, in cui si sedimentano appunti, prove e continue reiterazioni, intuizioni: un terreno vivo in cui si cerca, tra rigore ed esaltazione culturale, la forma architettonica. La forma è dunque strettamente legata ai propri compiti – per usare le parole di Mies – compiti che non

Casa nei tre paesaggi
Numana, 2011 - 2015
[A 19; A 36; A 55; A 95]



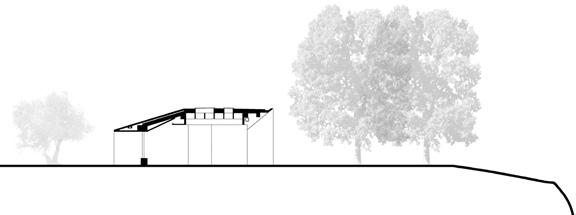




Borgotaro, 2010 - 2018
[A 20; A 40; A 55; A 95]







