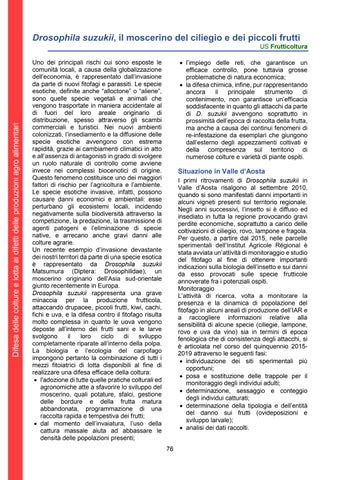Drosophila suzukii, il moscerino del ciliegio e dei piccoli frutti
Difesa delle colture e lotta ai difetti delle produzioni agro alimentari
US Frutticoltura l’impiego delle reti, che garantisce un efficace controllo, pone tuttavia grosse problematiche di natura economica; la difesa chimica, infine, pur rappresentando ancora il principale strumento di contenimento, non garantisce un’efficacia soddisfacente in quanto gli attacchi da parte di D. suzukii avvengono soprattutto in prossimità dell’epoca di raccolta della frutta, ma anche a causa dei continui fenomeni di re-infestazione da esemplari che giungono dall’esterno degli appezzamenti coltivati e della compresenza sul territorio di numerose colture e varietà di piante ospiti.
Uno dei principali rischi cui sono esposte le comunità locali, a causa della globalizzazione dell’economia, è rappresentato dall’invasione da parte di nuovi fitofagi e parassiti. Le specie esotiche, definite anche “alloctone” o “aliene”, sono quelle specie vegetali e animali che vengono trasportate in maniera accidentale al di fuori del loro areale originario di distribuzione, spesso attraverso gli scambi commerciali e turistici. Nei nuovi ambienti colonizzati, l’insediamento e la diffusione delle specie esotiche avvengono con estrema rapidità, grazie ai cambiamenti climatici in atto e all’assenza di antagonisti in grado di svolgere un ruolo naturale di controllo come avviene invece nei complessi biocenotici di origine. Questo fenomeno costituisce uno dei maggiori fattori di rischio per l’agricoltura e l’ambiente. Le specie esotiche invasive, infatti, possono causare danni economici e ambientali: esse perturbano gli ecosistemi locali, incidendo negativamente sulla biodiversità attraverso la competizione, la predazione, la trasmissione di agenti patogeni e l’eliminazione di specie native, e arrecano anche gravi danni alle colture agrarie. Un recente esempio d’invasione devastante dei nostri territori da parte di una specie esotica è rappresentato da Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), un moscerino originario dell’Asia sud-orientale giunto recentemente in Europa. Drosophila suzukii rappresenta una grave minaccia per la produzione frutticola, attaccando drupacee, piccoli frutti, kiwi, cachi, fichi e uva, e la difesa contro il fitofago risulta molto complessa in quanto le uova vengono deposte all’interno dei frutti sani e le larve svolgono il loro ciclo di sviluppo completamente riparate all’interno della polpa. La biologia e l’ecologia del carpofago impongono pertanto la combinazione di tutti i mezzi fitoiatrici di lotta disponibili al fine di realizzare una difesa efficace della coltura: l'adozione di tutte quelle pratiche colturali ed agronomiche atte a sfavorire lo sviluppo del moscerino, quali potature, sfalci, gestione delle bordure e della frutta matura abbandonata, programmazione di una raccolta rapida e tempestiva dei frutti; dal momento dell’invaiatura, l’uso della cattura massale aiuta ad abbassare le densità delle popolazioni presenti;
Situazione in Valle d’Aosta I primi ritrovamenti di Drosophila suzukii in Valle d’Aosta risalgono al settembre 2010, quando si sono manifestati danni importanti in alcuni vigneti presenti sul territorio regionale. Negli anni successivi, l’insetto si è diffuso ed insediato in tutta la regione provocando gravi perdite economiche, soprattutto a carico delle coltivazioni di ciliegio, rovo, lampone e fragola. Per questo, a partire dal 2015, nelle parcelle sperimentali dell’Institut Agricole Régional è stata avviata un’attività di monitoraggio e studio del fitofago al fine di ottenere importanti indicazioni sulla biologia dell’insetto e sui danni da esso provocati sulle specie frutticole annoverate fra i potenziali ospiti. Monitoraggio L’attività di ricerca, volta a monitorare la presenza e la dinamica di popolazione del fitofago in alcuni areali di produzione dell’IAR e a raccogliere informazioni relative alla sensibilità di alcune specie (ciliegie, lampone, rovo e uva da vino) sia in termini di epoca fenologica che di consistenza degli attacchi, si è articolata nel corso del quinquennio 20152019 attraverso le seguenti fasi: individuazione dei siti sperimentali più opportuni; posa e sostituzione delle trappole per il monitoraggio degli individui adulti; determinazione, sessaggio e conteggio degli individui catturati; determinazione della tipologia e dell’entità del danno sui frutti (ovideposizioni e sviluppo larvale); analisi dei dati raccolti. 76