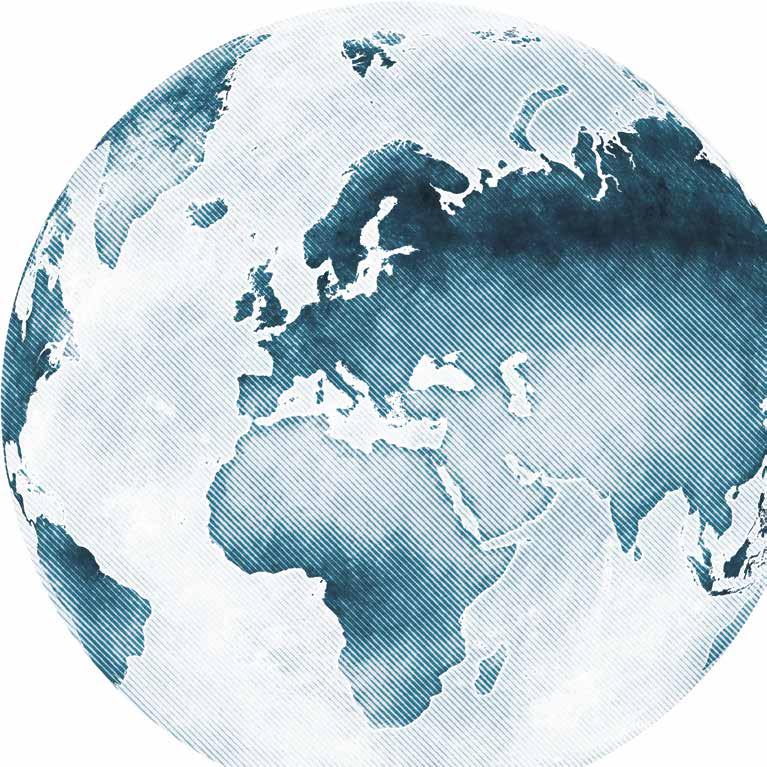
3 minute read
Per i petrolieri meglio le tasse delle rinnovabili
by Economy
British Pretoleum ha rifiutato la proposta di Rishi Sunak di dirottare parte delle plusvalenze in investimenti green in cambio di un alleggerimento fiscale. Una visione condivisa che ben spiega i paradossi moderni
di Giuseppe Corsentino
Advertisement
Contraddizioni (e paradossi) del mondo globale. È meglio pagare più tasse sui maxiprofitti generati dal boom dei prezzi petroliferi (greggio e gas) oppure è meglio indirizzare queste risorse (più di 200 miliardi di euro solo in Europa) agli investimenti green, alle energie rinnovabili contribuendo così a salvare il pianeta (e, in futuro, anche i bilanci)?

I colossi petroliferi hanno dimostrato finora (ma vedremo per quanto tempo ancora) di preferire la prima opzione (più tasse) come ha fatto qualche mese fa la BP, British Petroleum, che non ha accettato la proposta dell’allora ministro del Tesoro Rishi Sunak (oggi premier) di dirottare parte delle plusvalenze create dall’aumento dei corsi delle materie prime investendo nel settore delle rinnovabili (eolico e fotovoltaico) in cambio di un alleggerimento fiscale e ha scelto, al contrario, di destinare questi superprofitti a un piano di acquisto di azioni proprie che ha fatto felici gli azionisti anche a costo di una “mazzata” fiscale mai vista (perché il ministro Sunak ha immediatamente risposto con una imposta eccezionale). Ma tant’è. I vecchi giganti delle energie fossili come la britannica BP, come la francese Total (che ha fatto lo sforzo di aggiungere la parolina “Energies” al vecchio nome tanto per ripulirsi la coscienza) e tanti altri (compresa l’Eni di De Scalzi ben supportato dal governo Meloni), da quel che si capisce dalle dichiarazioni dei loro amministratori delegati e dalle relazioni ai ricchissimi bilanci 2022 appena presentati in queste settimane di assemblee generali, tra aprile e maggio, non hanno nessuna intenzione di dirottare una parte dei giganteschi profitti realizzati nell’anno della guerra in Ucraina – più di 200 miliardi di euro come si diceva prima contando solo le revenus delle compagnie petrolifere europee – nel settore delle energie rinnovabili come chiedono i governi e gli azionisti più sensibili ai problemi del pianeta (si tratta, in genere, di associazioni e di fondi specializzati che in questo momento si stanno battendo anche per affermare il diritto del cosiddetto “say on climate”, vale a dire il diritto delle assemblee di spingere, con il proprio voto, il management a mettere una percentuale dei profitti non nei portafogli degli azionisti ma sul mercato, appunto, delle rinnovabili).
Uno scandalo da voracità finanziaria o gestione prudente dei bilanci come proverò a spiegare più avanti? Si è scandalizzato perfino il presidente americano Joe Biden che nel discorso sullo stato dell’Unione dell’8 febbraio scorso ha avuto parole pesanti contro i big del petrolio e ha minacciato di quadruplicare l’imposta sull’acquisto di azioni proprie con l’obiettivo di spingere le compagnie a investire a lungo termine sulle rinnovabili (sostenuto, in questo, dall’ex capo economista del Fondo monetario internazionale, il francese Olivier Blanchard, docente al Mit e ad Harvard, secondo cui non c’è “rien de mal à taxer ces profits exceptionnels” in caso contrario).
Ma al di là dell’indignazione (delle opinioni pubbliche e della politica), le compagnie petrolifere hanno comunque qualche buona ragione a preferire le tasse all’investimento nelle rinnovabili. I loro azionisti, infatti, da tempo sono (ben) abituati ad alti rendimenti, obiettivo al momento impossibile con gli investimenti “green”. È per questo motivo che le compagnie europee, come Bp o Total o Eni, sono meno valorizzate in Borsa rispetto alle loro omologhe americane con le quali debbono competere sui mercati globali. Inoltre, c’è anche una ragione microeconomica che complica la vita ai colossi del petrolio e del gas. Perché una grande compagnia petrolifera sa trattare con gli Stati per i grandi “deal” energetici (è il suo Dna), ma non è detto che sappia trattare allo stesso modo con quel sistema di autorità pubbliche (enti locali, agenzie, etc.) che rappresentano il “sottostante” del mercato delle rinnovabili. In altre parole, i petrolieri non si trovano a loro agio a trattare con le reti e questo avrebbe di certo effetti negativi sulla redditività degli eventuali investimenti “verdi”.
A questo punto non resterebbe che la leva fiscale: per esempio la famosa “tax carbone” tentata (malamente) dalla presidenza Macron in Francia che ha scatenato la mezza rivolta dei gilet gialli, ma gli economisti fanno notare che un’imposta di questo tipo dovrebbe essere universale, cioè applicata a tutti gli stati (almeno in Europa). Forse un ruolo potrebbero giocarlo le istituzioni internazionali, vere sentinelle della globalizzazione, come la Banca Mondiale (dove, tra l’altro, è appena arrivato – il 23 febbraio scorso - un nuovo presidente sensibile ai problemi dell’ambiente, a differenza del suo predecessore climatoscettico, come Ajay Banga, indiano, candidato da Biden) e come la Banca europea degli investimenti guidata dal tedesco Werner Hoyer, quello che nel 2019 ha lanciato il programma “1 trilion for 1,5°”, mille miliardi per riuscire ad abbassare di un grado e mezzo il riscaldamento globale: un buon viatico, senza dubbio, ammesso che le compagnie petrolifere vogliano uscire dal vecchio mondo delle energie fossili e dalle sue contraddizioni.








