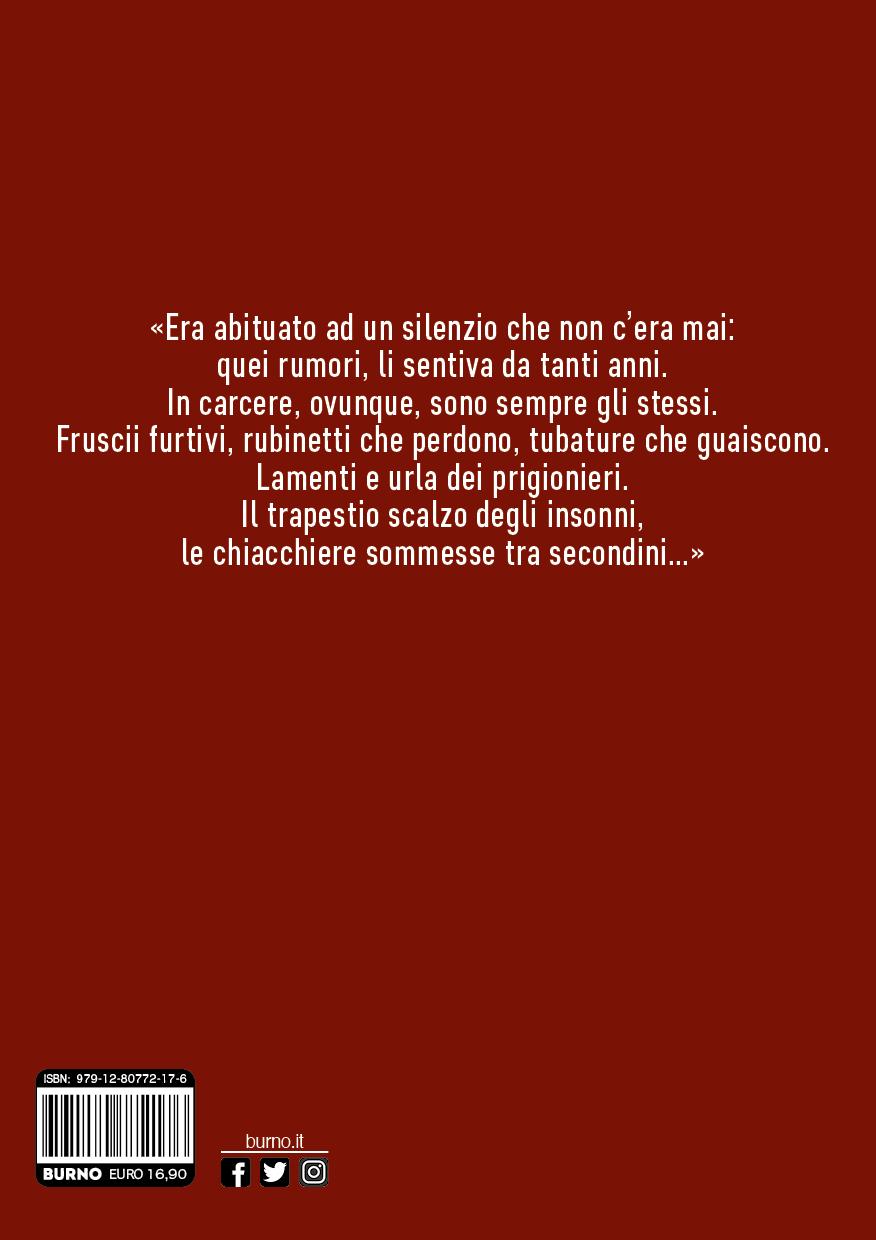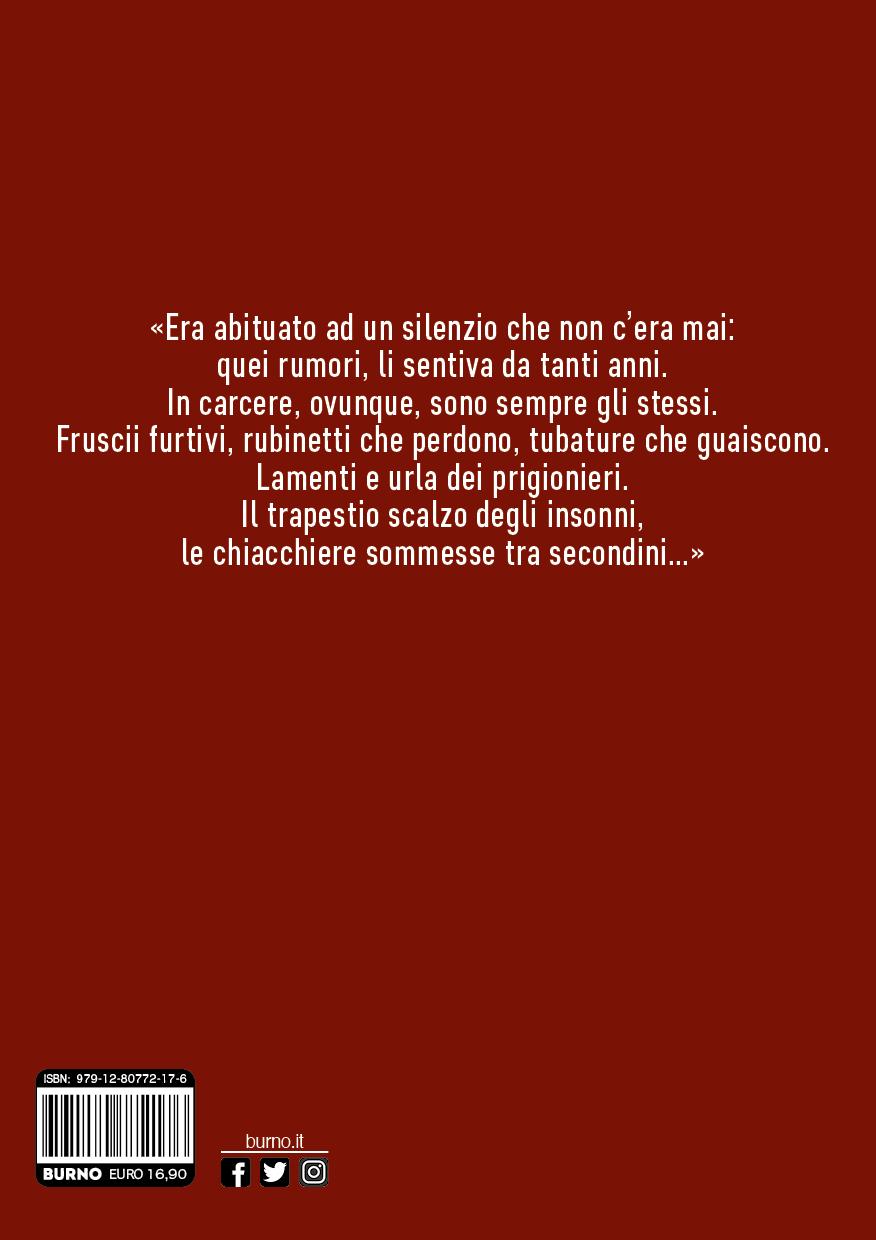IL CONTRARIO DI BENNY

MARCO NICOLINI
Dedicato a mia fglia Amalia, che anch’io ho conosciuto prima che nascesse.
2018
E –Era abituato ad un silenzio che non c’era mai: quei rumori, li sentiva da tanti anni. In carcere, ovunque, sono sempre gli stessi.
Fruscii furtivi, rubinetti che perdono, tubature che guaiscono. Lamenti e urla dei prigionieri. Il trapestio scalzo degli insonni, le chiacchiere sommesse tra secondini.
Il carcere di Punta Sottile, però, era diverso da ogni altra prigione: aveva rumori tutti suoi.
Nei tanti anni in cui aveva scontato la propria condanna, quello era il posto peggiore in cui era stato recluso.
Lo stabile che conteneva il carcere era un’antica fortezza, scavata nella roccia, che gli Asburgo avevano tramutato in un carcere di massima sicurezza; in due secoli nulla era cambiato. Le celle si trovavano dodici metri sotto il livello del mare e, giocoforza, non avevano fnestre.
L’aria era irrespirabile, sia nell’umido che penetrava le ossa d’inverno, sia nel caldo opprimente dell’estate.
Nelle serate di tempesta, il clamore del mare faceva tremare i muri, l’acqua fltrava ovunque, i topi si aggiravano in marmaglie irrequiete e il terrore per la peggiore delle
7
morti mordeva l’animo di uomini rotti a tutto. Le pareti parevano di carta, frapposte agli umori isterici del mar Adriatico invernale.
I reclusi ospitati dalla prigione erano solo trenta ed erano tutti ergastolani che avevano già scontato altrove alcuni anni della loro pena. Tutti avevano un passato di difcile vita detentiva: evasioni, episodi violenti, aggressioni ai secondini.
A Punta Sottile vigeva il peggior regime carcerario che Benny avesse mai provato in ventiquattro anni, tre mesi e quattro giorni di detenzione.
La macchina carceraria italiana considerava questa vecchia prigione come l’ultimo dei rifugi per i detenuti diventati reietti, indipendentemente dal loro reato originario ma solo alla luce della carriera sviluppata in reclusione.
Le testimonianze di fne pena degli ex prigionieri non avevano mosso grandi folle a salvaguardia dei diritti umani, ma un deputato tedesco del Consiglio d’Europa, dopo aver ricevuto un rapporto da parte del Comitato di Prevenzione delle Torture, aveva fatto il diavolo a quattro durante una riunione della plenaria di Strasburgo, ottenendo altre ispezioni che, in realtà, si stavano trascinando da anni senza aver prodotto alcun cambiamento.
Le zone destinate all’ora d’aria dei detenuti erano sei chiostri di forma perfettamente quadrata, con ciascun lato di cinque metri di lunghezza. Il prigioniero vi entrava, nolente o volente, annusava l’aria aperta che cadeva dalle quattro, alte murate, fssava la piccola porzione di cielo che gli stava sopra, se era fortunato vedeva e sentiva sul corpo la pioggia
8
cadere o, meno frequentemente per quel lembo d’Istria a picco sul mare, la neve degli inverni più rigidi.
In ogni cella c’era una tazza del water in acciaio, ben rivettata per aderire al suolo, con un rubinetto forgiato in un pezzo unico per lo scarico.
La popolazione carceraria era composta da tre nigeriani, un ghanese, un algerino, due tunisini, quattro marocchini, un francese, due romeni e sedici italiani.
Le celle erano disposte su cinque fle nel medesimo piano interrato. Ognuna di esse aveva davanti un corridoio largo un metro e mezzo, delimitato da un muro molto spesso che costituiva la parete posteriore delle celle della fla successiva.
Nessun detenuto ne incontrava mai un altro, poiché i contatti tra i prigionieri, nell’ultimo girone umano d’Europa, erano fermamente vietati.
Vi erano particolari accorgimenti che i secondini erano costretti a rispettare: gli africani subsahariani andavano generalmente d’accordo tra loro, ma disprezzavano i magrebini. Le celle di due, tra i nigeriani, dovevano trovarsi il più distante possibile da quelle del connazionale restante, perché tutti loro alimentavano d’odio una faida tribale che durava dalla notte dei tempi.
La doccia, unica per tutti i trenta ospiti, si faceva a turni di sei minuti il lunedì, il mercoledì e il venerdì ed era l’unico posto in cui i reclusi rischiavano d’incontrarsi.
Un rischio che, quel giorno, si tramutò in realtà.
Per la distrazione del giovane secondino scelto per scortarlo o per mancanza di comunicazione tra il personale del
9
carcere, Benny era giunto alla sala della doccia con qualche minuto di anticipo.
Al centro del pavimento piastrellato, nudo come un verme, un uomo alto circa due metri, magrissimo, nerboruto e con il corpo ricoperto quasi interamente da tagli e ferite, aveva alzato la testa per guardarlo. Il volto era scheletrico e dava l’impressione di essere consumato dalla follia.
Benny non lo aveva potuto riconoscere perché mai lo aveva incontrato, ma dai connotati fsici sapeva benissimo chi aveva di fronte.
Dietro quello sguardo alienato c’era Rami Renaud, conosciuto come l’Arabo per una lontana parentela algerina di sua madre. Era l’uomo che aveva difuso il panico per l’Italia del nord nei primi anni duemila.
F –
Francese di Lione, Rami era cresciuto ai margini della banlieue cittadina senza proferire parola fno all’età di sette anni, secondo quanto detto ai giornalisti dai genitori i quali – ad ogni buon conto – erano tossicodipendenti dello stadio più avanzato quando lo avevano messo al mondo.
Di passaggio per gli angoli bui delle grandi città europee, Rami aveva presto dimostrato un’autentica vocazione alla violenza nella più sadica delle sue accezioni.
Nel 2002, venticinquenne randagio di strada, aveva violentato e ucciso una giovane immigrata cinese in un 10
quartiere di Torino. Era stato il suo primo omicidio, anche se non certo il suo primo reato violento.
Fuggito e braccato lungo i binari ferroviari, aveva ucciso un anziano vigilante a Fidenza, impossessandosi della sua pistola e sparandogli in mezzo agli occhi per testarne le qualità.
In un’orgia di sangue e follia, accompagnati da scaltrezza e furbizia, l’Arabo Renaud aveva gettato l’Italia in un autentico terrore: gli avvistamenti si erano moltiplicati di pari passo con l’autosuggestione e l’isteria delle persone che credevano di incontrarlo ovunque.
Tra mille altri luoghi, era stato segnalato mentre si imbarcava sul traghetto per Capri, prendeva la tintarella in un cafè di Trieste in compagnia di militari jugoslavi, saliva su un autobus a Bari spaventando la gente col proprio ghigno, giocava a calcio con una rumorosa compagnia di punkabbestia in un parco di Padova.
L’alto numero di errate segnalazioni aveva impedito di riconoscere quest’ultima segnalazione come reale.
Terminato di giocare il calcio disordinato dei giocatori tossici, Rami aveva abilmente isolato una ragazza del gruppo, guidandola al riparo di un paio di alti alberi, senza che lei nemmeno se ne accorgesse.
Sotto i tanti piercing cosparsi per il volto, la giovane aveva un’espressione insicura e dolce. Quella vulnerabilità che Rami cercava e predava.
La ragazza parlava al gigantesco francese di come stesse pensando di tornare a casa, in un minuscolo paesino non lontano da Ginevra, dove la vita scorreva lenta e, accortasi di 11
non vedere più gli altri, si era girata allarmata incrociando gli occhi del suo conversatore, leggendone solo allora la pericolosità e capendo che, purtroppo, non avrebbe visto più i suoi anziani genitori, né il suo vecchio cane che la attendeva davanti al fuoco, né il ragazzo a cui aveva dato il primo bacio e di cui, segretamente, era ancora innamorata.
Rami l’aveva tramortita con un pugno alla tempia e violentata mentre era ancora svenuta. Poi l’aveva depredata di ogni avere e, prima di andarsene, per guadagnare pochi minuti, le aveva sparato al cuore appoggiandole la canna sul seno nudo. Era quindi scappato via, uscendo dal parco e confondendosi abilmente tra la folla dell’ora di punta.
A circa un anno dall’omicidio della povera ragazza cinese, Rami Renaud aveva fnito con l’essere braccato mentre fuggiva a piedi lungo le vie d’acqua che da Padova puntavano al mare. L’abitudine al comportamento animale e la capacità di fermarsi in luoghi poco accessibili per lungo tempo ne salvaguardarono la fuga per alcuni giorni.
Spossato e afamato, l’Arabo aveva commesso l’imprudenza di cercar di rubare su una barca ormeggiata nella conca di Moranzani, poco a monte della foce della Brenta Vecchia.
Scorto dagli occhi allenati ai movimenti lontani di un pescatore, era stato subito segnalato alla vicina caserma di Carabinieri dai cui militi, però, credendo di avere a che fare con un semplice ladruncolo, la minaccia era stata sottovalutata: sul luogo fu mandata una pattuglia impreparata.
Un giovane appuntato era sceso dall’automobile e si era avvicinato in tutta fducia all’imbarcazione dove il gigantesco
12
“senzatetto” stava ancora armeggiando con un lucchetto. Lo avrebbe rimproverato e mandato via, dato che i danni da effrazione parevano essere irrisori, almeno secondo il rapido esame della coperta della barca.
Remi Renaud, però, che aveva visto la macchina e sentito i passi del carabiniere, aveva atteso fno all’ultimo per avere un tiro facile e preciso. Si era girato in un lampo quando il carabiniere gli aveva battuto sulla spalla, centrandolo alla gola con l’ultimo colpo rimasto nella pistola.
Erano arrivati altri carabinieri che lo avevano inseguito con rabbia e determinazione. Entrato nel grande parcheggio all’imbarco delle navi, ultima sosta per le autovetture sulla terraferma, Rami si era trovato inaspettatamente all’aperto ed aveva sentito il sibilo di una pallottola, per la prima volta in vita sua.
Si era gettato piangente a terra, perché era l’unica speranza di sopravvivere alla ferocia dei carabinieri a cui lui aveva assassinato il giovane collega.
Rideva, invece, mentre dal cellulare blindato era accompagnato alla sala bunker del tribunale di Venezia e sghignazzava in faccia ai parenti delle vittime mentre il Presidente del Tribunale, giunto a fne processo sconvolto dalla brutalità dei delitti del francese, gli stava comminando vari ergastoli.
Dopo due anni, passati in isolamento al carcere Due Palazzi di Padova, dove era riuscito nell’intento di accoltellare un altro detenuto con un orpello fabbricatosi con della latta, era stato spostato al carcere di massima sicurezza di Sennariolo, in Sardegna, per boss mafosi e criminali
13
internazionali. L’improvviso arresto di un capo foggiano della Sacra Corona Unita aveva costretto il direttore del carcere a cedere la cella del francese per questioni di contingenza e opportunità.
Rami Renaud era così giunto al famigerato carcere di Punta Sottile nell’aprile del 2006.
In dodici anni aveva avuto tutto il tempo per imparare le regole di totale isolamento del luogo, montando dentro sé una rabbia oscura e silente che non strideva troppo col suo eterno, antipatico sorriso.
I centonovantasette centimetri di ossa e nervi bramavano l’assassinio di qualcuno. Non di una delle guardie, le quali erano sempre armate, difese da un particolare uniforme corazzata e ormai spersonalizzate nella sua malata visione: Rami avrebbe preferito strappare la vita a un altro recluso. Voleva ancora veder la vita spegnersi negli occhi di qualcuno.
Q –
Quella sera, Benny era entrato nella sala docce inaspettato e per Rami fu come il regalo di un compleanno che non si festeggia più da tempo. Si erano guardati negli occhi, il francese di due metri e l’italiano non più giovane, eppure ancora asciutto e muscoloso.
Rami Renaud non aveva dato il tempo alle guardie d’abbozzare una minima reazione: si era scagliato contro l’altro ergastolano con ferocia animale, ma con rabbia tutta umana.
14
Mirò alla testa con le armi che gli uomini solitamente non usano, ma che sono anche le più efcaci: i denti e le unghie.
Benny aveva passato vent’anni sui ring di pugilato di tutt’Italia, prima da atleta dilettante, poi da prima serie di interesse olimpico, infne da uomo d’angolo e allenatore. Aveva nell’istinto i movimenti laterali, la copertura con gli arti e la capacità di leggere i movimenti. L’età era però piuttosto matura, sofriva di una patologia al cuore e da ventiquattro anni girava per le più dure carceri del paese; i rifessi erano quindi arrugginiti dal continuo muoversi in piccoli ambienti.
Fece un balzo indietro, incassando il mento nel collo nella convinzione di entrare in un tradizionale combattimento. Ma non ci sarebbe stato nulla di tradizionale in questa lotta; e nemmeno di umano.
Abituato nella sua precedente vita a schivare o incassare pugni, Benny si ascoltò gridare più per la sorpresa che per il dolore, che comunque giunse forte e lancinante.
L’assassino seriale francese aveva afondato i propri denti alla base del collo del recluso italiano, con tutta la forza che arrivava dalla sua natura ispida e rabbiosa.
Le due guardie presenti reagirono con lentezza dettata dall’orrore nel vedere l’Arabo all’opera e per l’impiccio delle uniformi imbottite per difendersi dalle pugnalate degli ergastolani. Il più esperto dei due secondini scaricò un deciso colpo del manganello a molla sul coccige del francese, rallentandogli appena la furia del morso, mentre la seconda guardia mirò alla testa con una gragnuola di manganellate che, però, fnirono per colpire sia il francese, sia l’italiano.
15
Renaud aprì la bocca ormai riempita di sangue tanto da impedire la respirazione e Benny riuscì a colpirlo con un corto gancio alla tempia. Non riuscendo più a muovere il braccio destro per i danni fatti dal morso, però, non poté doppiare il colpo e il secondino maldestro, che manganellava a casaccio, fece il resto colpendolo più volte alla testa.
Remi Renaud, noncurante delle randellate delle guardie e del pugno sinistro di Benny che gli bersagliava la nuca, spalancò le fauci e morse selvaggiamente l’italiano con l’arcata superiore poggiata all’occipite e quella inferiore allo zigomo; tra i due fronti, l’occhio correva il rischio di fnire nella morsa dei denti del francese.
Quando la pressione della mascella fece scivolare i denti superiori, Benny vi inflò la mano per salvarsi l’occhio, ma subito sentì le falangi schioccare e fratturarsi. Il dolore aveva ormai passato la soglia della sensibilità.
Con dei caricati colpi di tallone, Benny cercava disperatamente di colpire la spina dorsale del gigante francese, mentre le guardie colpivano inefcacemente Remi, senza tentare di strapparlo dal corpo di Benny per la paura di essere morsi a loro volta.
Quando erano passati ormai due minuti dal principio di quella feroce aggressione, tre secondini in assetto antisommossa fecero irruzione nelle docce richiamate dall’allarme muto attivato dalle guardie. Afondando gli scarponi nel sangue di Benny, due di loro presero il francese per i capelli, mentre il terzo scaricò la folgore elettrica del Taser nel corpo del francese, che perse immediatamente i sensi.
16
Renaud fu sollevato, imbrigliato in una camicia di forza e gettato in un angolo a smaltire la scossa.
Nudo come un verme, con ferite che perdevano copiosamente sangue al collo e al lato destro del volto e privo di un lembo di pelle sulla tempia, Benny sofriva per le ferite, ma sopportava nel silenzio imposto agli ergastolani dalla poco indulgente struttura carceraria.
Fu caricato, senza tante premure, su una lettiga giunta dall’infermeria. Prima di esser stabilizzato, gli fu somministrato un potente sedativo.
La lettiga fu spinta lungo il corridoio.
Nell’attimo di calma precedente al perdere conoscenza, Benny fece l’amaro conto di quel che gli rimaneva della propria esistenza.
Alberto Mureschi, da sempre conosciuto come Benny, aveva cinquantotto anni. Aveva varcato la porta del carcere, senza più uscirne, quando ne aveva trentaquattro.
Da quel giorno non aveva più visto sua moglie e sua fglia. I suoi genitori erano morti dopo averlo rinnegato, al pari di suo fratello e di sua cognata, dei quali non aveva più alcuna notizia. Nessuno dei suoi tanti amici si era mai presentato ai colloqui. Nulla della sua vita di un tempo si era mai riproposto in alcuna forma.
Si trovava su un’ambulanza, probabilmente diretta al più vicino ospedale militare, col nervo soprascapolare danneggiato, le dita della mano sinistra doloranti e la pelle del volto rivoltata.
Non era nemmeno tanto sorpreso di aver subito l’insensato attacco da parte del famigerato serial killer Rami Renaud: il
17
francese era un maledetto sadico e comunque, a ben vedere, tutto in quel carcere era follia e violenza.
Aveva già tre cicatrici a testimoniare altrettante ferite rimediate in scontri occorsi nelle carceri di tutta Italia e inferte con pugnali improvvisati ricavati da specchi, plastiche, ferraglie. A pagare col trasferimento in celle più isolate era sempre stato lui, anche se si era sempre e solo difeso. Anche se mai aveva provocato o insultato.
Non erano, però, i combattimenti così orribili e privi di regole della prigione a preoccuparlo: non gli interessava di sentire dolore e non aveva paura di combattere, nemmeno ora che si avvicinava ai sessant’anni.
Era una cosa molto peggiore a segnarlo profondamente, a togliergli il sonno ormai da decenni, che lo torturava ogni secondo in cui la sua mente tornava a vagare libera ai lontani anni in cui era stato felice.
Il fatto che il suo fosse uno dei peggiori destini di cui mai possa essere vittima un uomo: quello di vivere da rinnegato dalla propria famiglia, dagli amici e dalla società a causa della sgradevolezza del crimine per cui era stato condannato. Di aver perso il lavoro, la rispettabilità. La libertà. Di non aver avuto più una sola notizia della donna di ventinove anni che per lui era ancora la bimba di cinque anni che aveva visto nascere e che aveva poi cresciuto come unico senso e signifcato della propria vita.
Di aver sopportato le prove peggiori per una persona.
A causa di un crimine che non aveva commesso. 18
1994
S –Sul ring le forze non erano pari. Spesso accade tra pugili esordienti dato che il valore in combattimento necessita della prova del quadrato.
L’atleta della polisportiva Condor, la società di via Padova, a Milano, aveva leve corte ed era poco mobile. Era mancino, ma lo era pure il suo avversario.
Alberto Mureschi, per tutti Benny, dall’angolo gli dava indicazioni. Non era più un pugile in attività agonista da ormai sei anni, dopo esser stato un discreto prima serie, ossia il punto più alto del dilettantismo. Nel 1986 aveva accarezzato il sogno di partecipare ai mondiali di Reno, a causa di una contingente penuria di pesi mediomassimi, ma si era dovuto arrendere all’evidenza dell’essere un pugile combattivo e dalla mascella forte, però piuttosto lento e poco e f cace nel combattere fuori dalla guardia dell’avversario.
Da allenatore aveva potuto ritrovare il pugilato che più gli piaceva, quello fatto di miglioramenti evidenti, di sana passione, di birre e pizze insieme a quelli con cui ci si era tirati pugni in faccia fno ad un’ora prima.
19
Non sarebbe stato, comunque, in grado di allenare uno di quei professionisti che necessitano di perfezionamenti e di perfezionismi.
I ragazzi avevano allargato la sua famiglia.
Ad allenarsi da lui arrivavano i meno ambiti dalle palestre meneghine o lombarde più prestigiose: la Polisportiva Condor, che proponeva solo sport individuali era da sempre, infatti, una palestra di frontiera. Fondata da un prete missionario che aveva speso metà della propria esistenza nel Brasile equatoriale, prima di dare le spalle alla propria vocazione sposando un’ex–prostituta di Maceió, aveva sempre accolto atleti poco dotati, persone emarginate, alle volte anche ex galeotti.
Il ragazzo ventitreenne che Benny allenava da un anno e che esordiva in quella che era stata proprio la sua categoria di peso, quella al limite dei mediomassimi, pareva essere l’archetipo della polisportiva: era tozzo e sgraziato, abbandonato da neonato in ospedale, cresciuto in un istituto, rimbalzato tra mille case-famiglia per numerosi problemi comportamentali.
Il suo avversario aveva diciannove anni appena compiuti, aveva fatto tutta la trafla da cadetto a junior – con risultati ottimi – e quella sera esordiva nei senior con le intenzioni di arrivare presto agli incontri di prima serie.
Era elegante, alto e bello da veder boxare. Aveva velocità, colpo d’occhio e misura. Per due riprese aveva bersagliato il pugile allenato da Benny con diretti fulminei, prontamente doppiati con precisione.
Pareva non avere punti deboli e Benny era spiaciuto nel vedere un ragazzo meritevole come Kali brancolare nel buio
20
Altri volumi pubblicati:
I nobili piaceri del gentiluomo – isbn: 979-12-80772-00-8
Limiti – isbn: 979-12-80772-02-2
Mille pugili – isbn: 979-12-80772-01-5
I Fiori del Bene – isbn: 979-12-80772-04-6
Le cose come stanno – isbn: 979-12-80772-11-4
Il giro del mondo in ottant’anni - L’autobiografa di Bud Spencer – isbn:
979-12-80772-03-9
Il fato di Edith – isbn: 979-12-80772-15-2
Storie feline di gatti famosi – isbn: 979-12-80772-13-8