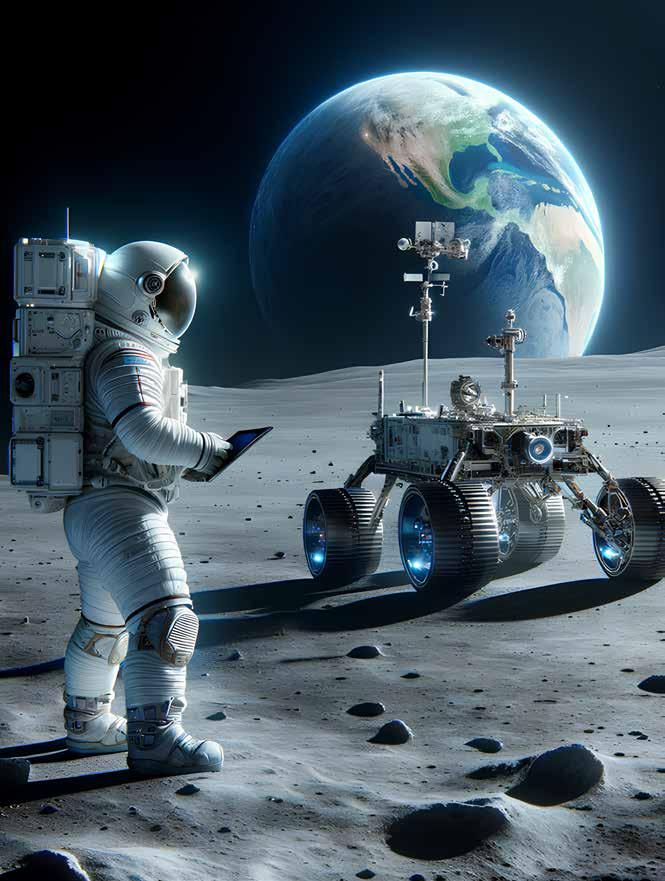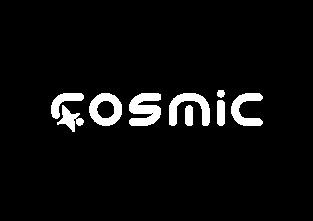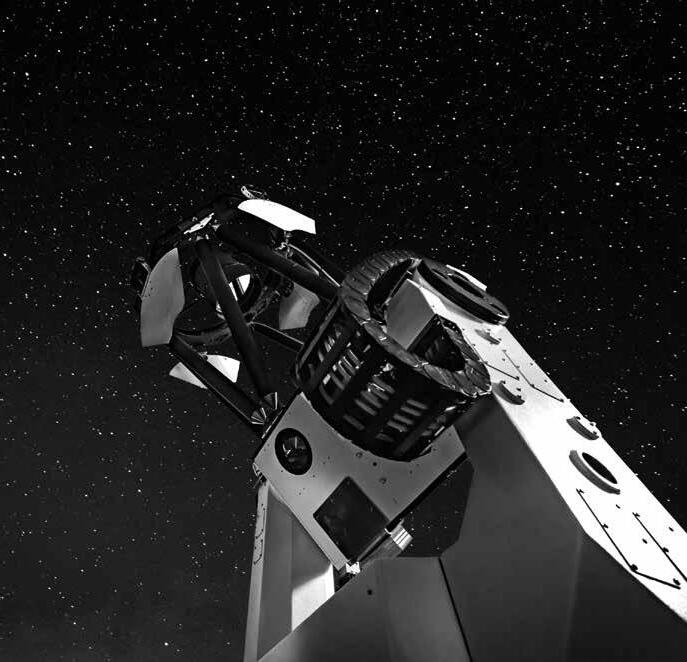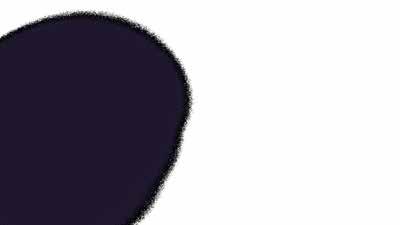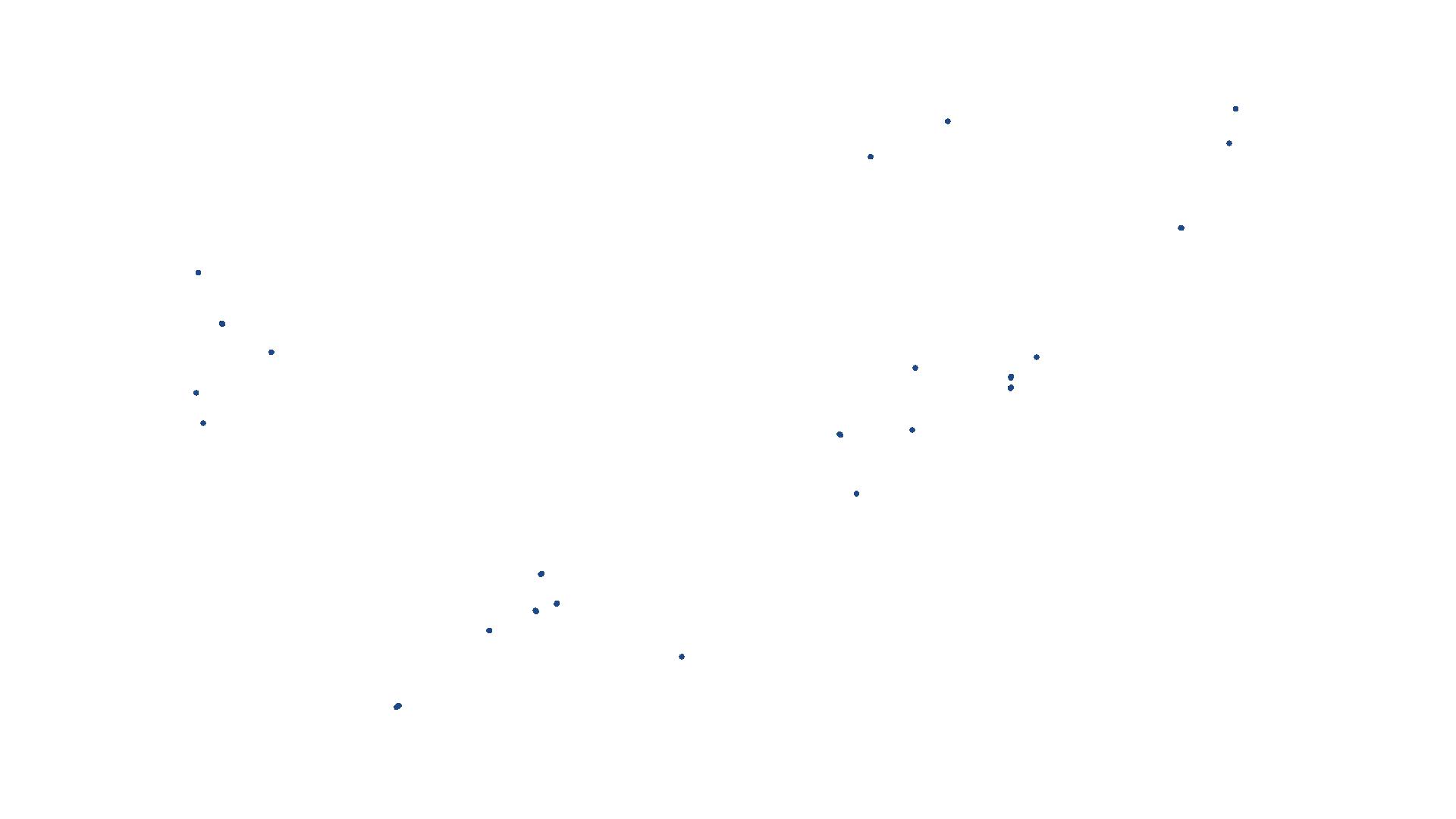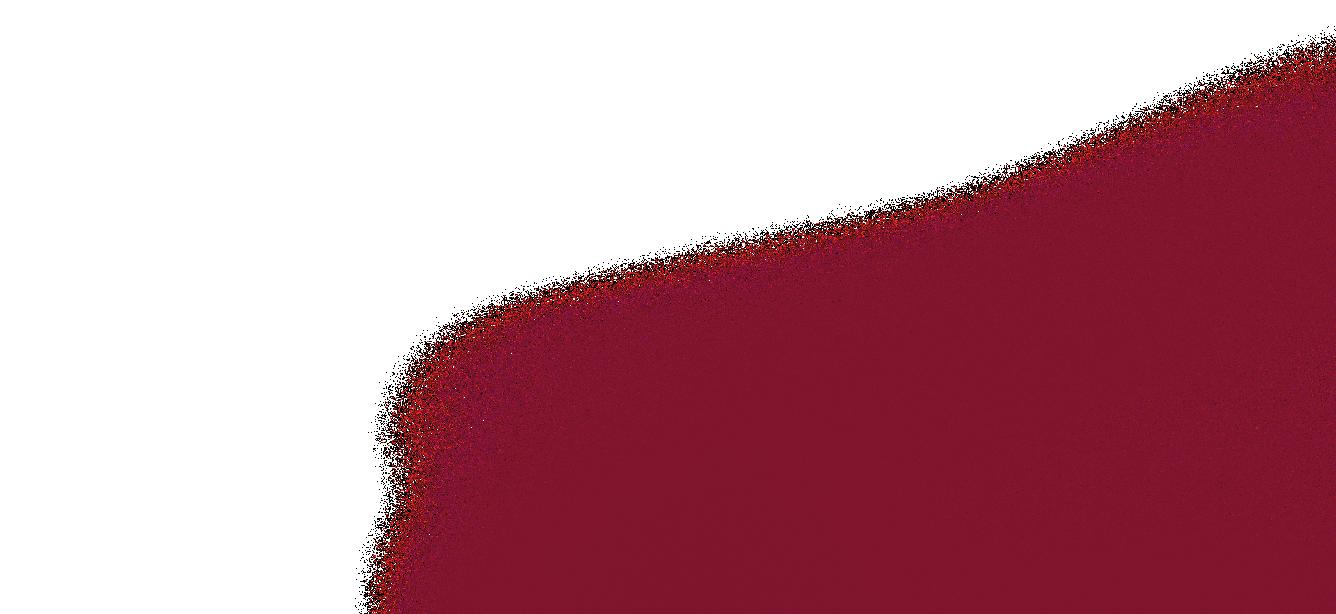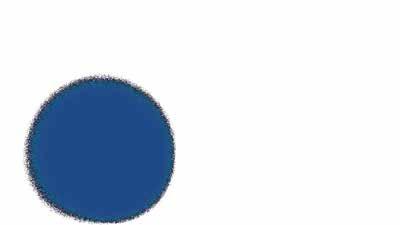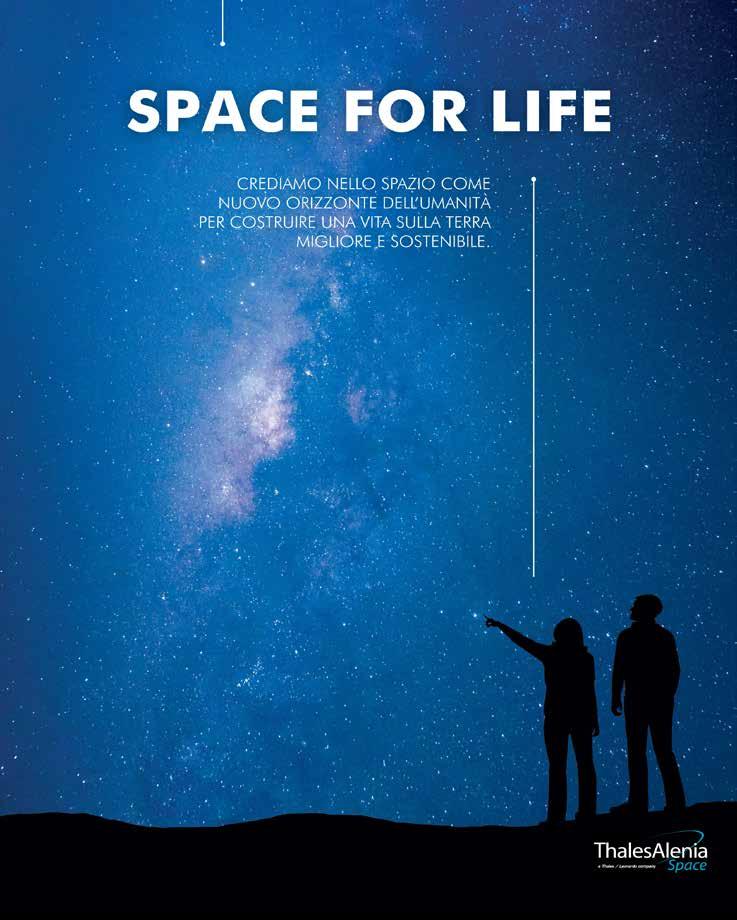In questo numero la neonata casa editrice Faros
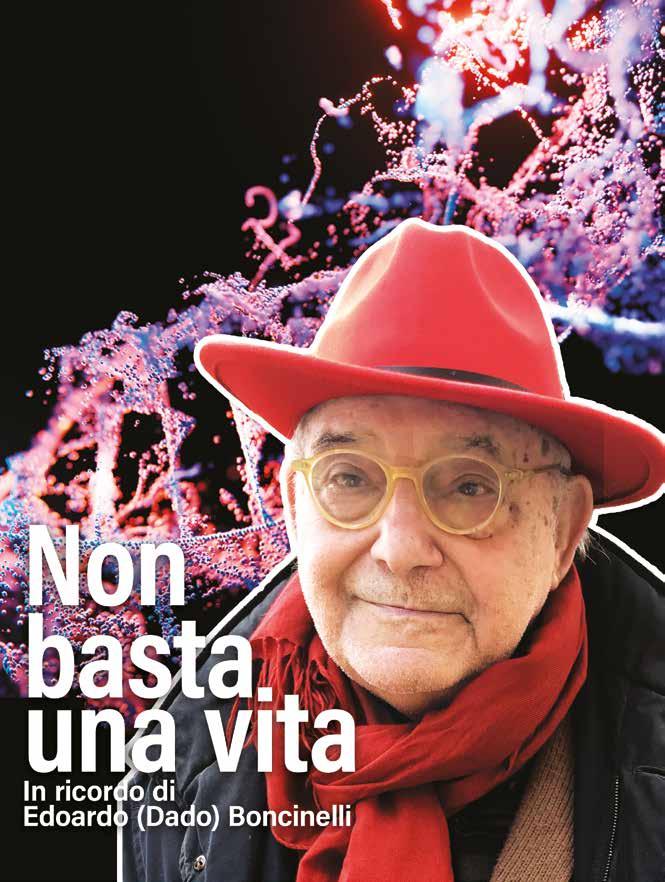
I progetti di EIE GROUP per l'esplorazione del cosmo

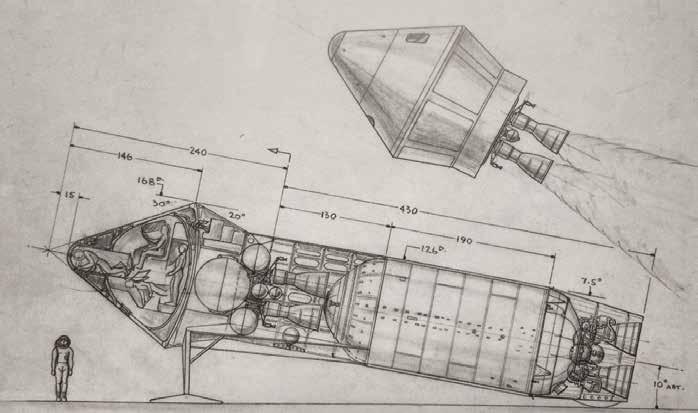
EIE GROUP & THE COSMOS EXPLORATION... ...ALWAYS PIONEERS & INNOVATORS
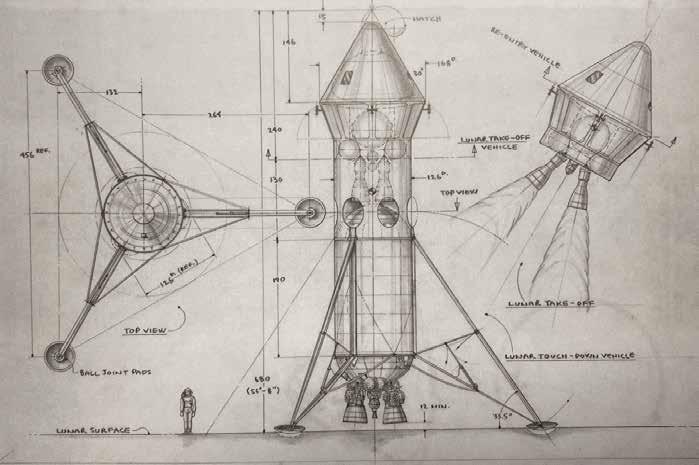
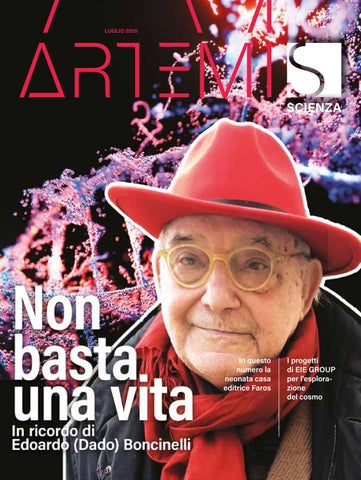
In questo numero la neonata casa editrice Faros
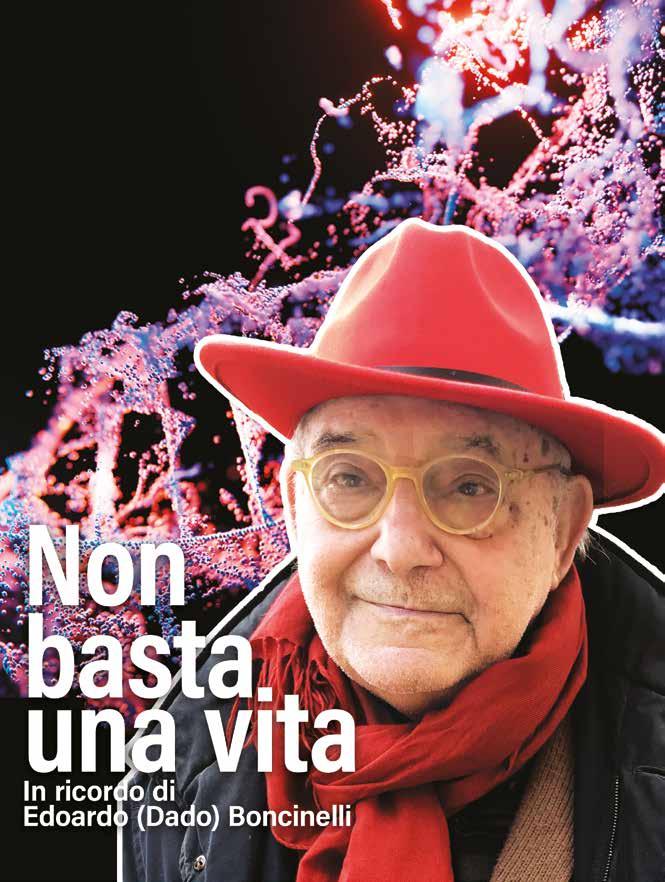
I progetti di EIE GROUP per l'esplorazione del cosmo

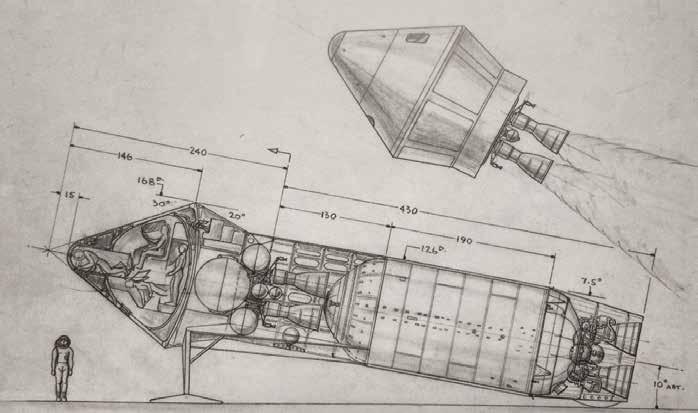
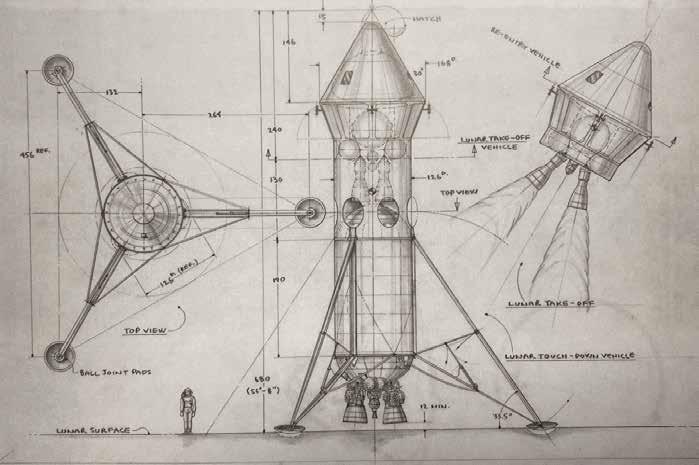
Edoardo Boncinelli è stato professore di Biologia e Genetica presso l'Università Vita-Salute di Milano. È stato inoltre Direttore della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, dopo essere stato Capo del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo presso il Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Fisico di formazione, si è dedicato allo studio della genetica e della biologia molecolare degli animali superiori e dell'uomo prima a Napoli, presso l'Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica (IGB) del CNR, dove ha percorso le tappe fondamentali della sua carriera scientifica, e poi a Milano. É membro dell'Academia Europaea e dell'EMBO, l'Organizzazione Europea per la Biologia Molecolare, ed è stato Presidente della Società Italiana di Biofisica e Biologia Molecolare. Nel 2005 ha ricevuto l'EMBO Award for Communication in the Life Sciences. Collabora a Le Scienze e al Corriere della Sera.
I suoi contributi sperimentali sono stati fondamentali per la comprensione dei meccanismi biologici dello sviluppo embrionale degli animali superiori e dell’uomo. É stato fra i primi, nel 1985, a comprendere il significato delle nuove scoperte sul controllo genetico dello sviluppo della drosofila e ad estenderle allo studio degli esseri umani. Con il suo gruppo di lavoro ha individuato e caratterizzato una famiglia di geni, detti omeogèni, che controllano il corretto sviluppo del corpo, dalla testa al coccige. Queste scoperte sono riconosciute come una pietra miliare della biologia di questo secolo, se non della biologia di tutti i tempi. A partire dal 1991 si è poi dedicato alla studio del cervello e della corteccia cerebrale individuando altre due famiglie geniche che giocano un ruolo cruciale in questi processi. Ha mostrato inoltre come tutto questo possa avere delle applicazioni mediche, immediate e a più lunga scadenza.
Quanto scritto sopra è quanto riportava di sé stesso il suo sito. Quello che aveva fatto nella sua vita di scienziato. Non poca roba. Ma c’è stato molto di più: e ne sono un parziale esempio i 77 libri che ha scritto, prevalentemente divulgativi, perché aveva una grande capacità di avvicinare ed interessare un pubblico privo delle basi per comprendere, non perché fosse stupido ma semplicemente perché l’evoluzione umana da un punto di vista di un genetista non è di immediata comprensione.
Boncinelli su quanto ha rilevato dell’uomo, ci ha riflettuto, gli ha dato un peso filosofico non solo biologico. Questo lo ha reso una delle menti più brillanti del secolo scorso e di un quarto di questo secolo.
fa presto a chiamarlo Frascati
Il libro della giornalista e sommelier Antonella Amodio
vino Lugana alla conquista della Capitale
è il caso, la vita secondo Edipi
Direttore responsabile
Paola Nardella pinar2019@gmail.com
Hanno collaborato a questo numero
Paola Nardella
Fabrizio Beria
Gruppo EIE
Faros Edizioni
Succede Oggi Editore
Progetto grafico
Davide Coero Borga
Realizzazione grafica
Maria Carlotta Spina
Web editor
Fabrizio Beria
Concessionaria pubblicitaria
Pinar Marketing & Comunicazione
Contatti 0683425014 www.artemiscience.news
Editore
Pinar Marketing & Comunicazione

Crediti immagini
Esa, Nasa, Pexels, Unsplash, Gemini, EIE GROUP, ESO, Enrico Sacchetti, Wikimedia Commons, Wikipedia, Faros Edizioni, Adobe Stock, Succedeoggi, Archivio Mario Giacomelli, Antonella Amodio

Non sono due supereroi ma sono i sistemi antagonisti per la produzione di energia da fusione nucleare. Se i tokamak sono più facili da progettare, risultano molto più difficili da gestire mentre lo stellarator è l’opposto: difficile da disegnare, ma più stabile e continuo. Che facciamo? Buttiamo a mare i Tokamak? Assolutamente no. I reattori a fusione nucleare si stanno moltiplicando nel mondo e non passa mese che qualcuno di questi non raggiunga un nuovo record di stabilità nel contenere il plasma prodotto.
E che la fusione nucleare rappresenti il futuro della produzione energetica globale, e come tale senza scorie e con effetti devastanti sull’equilibrio del pianeta,
lo dimostrano non già gli ingenti investimenti delle aziende pubbliche, come ENI nel progetto ITER e non solo, ma soprattutto dei privati, come Bezos, Musk o Bill Gates.
In questa sfida è entrata prepotentemente anche la Cina che dopo aver prodotto la propria ricchezza e potenza sui fossili, oggi è forse il primo paese al mondo per investimento nelle energie rinnovabili, che siano da fusione nucleare o di altro genere. Il problema è che il traguardo non è vicino… anzi si allontana.
Se inizialmente si pensava, ottimisticamente, che i primi impianti potessero entrare in funzione nei prossimi anni ’30, la strada si è mostrata assai più impervia e chi
guarda positivamente al futuro pensa ai prossimi anni ’50.
Ad oggi ogni volta che si accende un reattore a fusione nucleare si consuma più energia di quanto se ne produca, anche se gli ultimi risultati dello stellarator tedesco, V7-X , fanno ben sperare.
Se il traguardo è così lontano è necessario ampliare la produzione di energia pulita se vogliamo che la nostra specie ritrovi un futuro a lungo termine. E le vie sono sostanzialmente due, vediamo quali.


riunito a Lussemburgo.
Secondo il ministro Pichetto Fratin si tratta di una decisione in linea con le scelte di politica energetica del governo italiano «che promuove con convinzione il principio della neutralità tecnologica, per seguire una transizione energetica soste nibile, che garantisca la sicurezza e la resilienza del sistema energetico e favorisca imprese e famiglie. L’I talia sta infatti seguendo una stra tegia nazionale che in maniera tra sparente e graduale, promuove una rivalutazione pragmatica del ruolo dell’energia nucleare come fonte decarbonizzata, sicura, affidabile e programmabile».
L’alleanza UE sul nucleare è un'i niziativa lanciata nel 2023 dalla Francia, leader in Europa nella produzione di energia nucleare con un totale di 57 reattori nucleari, in grado di soddisfare circa il 70% del fabbisogno nazionale di ener gia elettrica. L’Alleanza Nucleare Europea rappresenta quindi una coalizione di Paesi membri dell’UE


duati per agevolare il pieno utilizzo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nel contesto del quadro energetico nazionale: attuare semplificazioni per le procedure burocratiche, potenziare l’infrastruttura di rete e la capacità di accumulo degli impianti già installati, modificare il quadro regolatorio per sbloccare gli investimenti e garantire una tutela degli impianti. Queste le direttive individuate dallo Studio “Lo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia: quali leve strategiche per accelerarne il dispiegamento nel paese” realizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA Group).
Il Rapporto Annuale è stato presentato in occasione della terza edizione del Forum delle Energie Rinnovabili “Renewable Thinking”, ideato da CVA – Compagnia Valdostana delle Acque -, in collaborazione con TEHA Group con il patrocinio di Elettricità Futura.
L’analisi ha innanzitutto delineato lo scenario mondiale di sviluppo delle FER: nonostante i consumi energetici siano cresciuti (+19% nel 2023 vs. 2010) si è registrata una riduzione dell’intensità energetica e carbonica (-18% e -4%), possibile
ne delle FER. Le differenze tra le varie parti del mondo, però, restano significative: se in Cina e altre economie emergenti vi è una forte accelerazione per quanto riguarda le installazioni rinnovabili, il caso degli USA rappresenta una possibile minaccia alla corsa dell’energia pulita. In Europa le FER costituiscono circa il 47% della produzione totale di energia elettrica (dato al 2024), in Italia la quota è del 41%. Tuttavia, la crescita della capacità installata FER rispetto al PIL Europeo e nazionale sta subendo un rallentamento, in particolare se confrontato rispetto ad altri Paesi, Cina in primis.
In questo contesto in evoluzione, la decarbonizzazione continua a rimanere una priorità strategica e le FER uno strumento chiave per rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da combustibili fossili e aumentare la competitività del sistema. A livello europeo, infatti, continua ad esserci una forte dipendenza dai combustibili fossili come fonte di energia per il consumo finale. La dipendenza energetica è poi un altro tema da attenzionare, considerando che, nel 2023, l’Europa ha importato il
getico, quota che sale al 74,8% in Italia.
Nonostante ciò, il caso italiano è la dimostrazione puntuale di come lo sviluppo delle rinnovabili determini una riduzione della dipendenza energetica, in flessione del 9,66% dal 2008, a fronte di una crescita a tripla cifra della produzione rinnovabile (da 23,9 GW nel 2008 a 66,7 GW nel 2023, + 179%). A ciò si aggiunge un altro elemento: in Italia il prezzo dell’energia elettrica è di gran lunga superiore rispetto ad altre economie europee: ad aprile 2025, si toccavano i 99,85 €/MWh, prezzo quattro volte superiore rispetto a quello della Spagna (26,81 €/MWh) e più che doppio rispetto al valore francese (42,21 €/MWh).
Tale dato è determinato per il 90% delle volte dal prezzo di riferimento del gas, secondo il meccanismo del prezzo marginale: potenziando le FER, tale prezzo sarebbe più basso. Rivolgendo lo sguardo al futuro, l’Italia è ancora lontana dal raggiungere gli obiettivi al 2030 del PNIEC - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - per quanto riguarda l’installazione di FER: i 7.5 GW nel 2024 installati nel 2024
(+33% vs. 2023) sono comunque inferiori agli 11 GW attesi. Lo scenario potrebbe poi complicarsi ulteriormente nel 2025, con il rischio di una contrazione di circa 1 GW rispetto al 2024: si tratterebbe della decrescita più significativa dell’ultimo decennio.
È importante sottolineare come l’Italia presenti ancora importanti margini di sviluppo delle FER, con oltre il 40% del proprio potenziale ancora da valorizzare: è quanto emerge dal Renewable Thinking Indicator elaborato da TEHA. Restringendo il campo agli ambiti del solare e dell’eolico, che sono le fonti per le quali il PNIEC preve-
de una crescita più significativa, il potenziale di sviluppo di tali FER al 2030 sale al 50%. In questo contesto, le Regioni della Sicilia, Sardegna e Emilia-Romagna potranno contribuire in modo significativo al raggiungimento dei target FER nazionali al 2030.
Per favorire il pieno sviluppo delle FER, lo Studio ha individuato alcuni ambiti prioritari di intervento, andando ad agire su alcune situazioni che hanno determinato dei colli di bottiglia, ovvero: ritardi nei principali Decreti sull’Energia (Decreto Aree Idonee, DL Agricoltura), disallineamento generale tra Stato e Regioni – ad esempio sul tema

delle concessioni idroelettriche – e complessità degli iter burocratici e autorizzativi per gli impianti FER.
A ciò si aggiungono ulteriori fattori abilitanti, tra cui spicca la necessità di sviluppare adeguate capacità di accumulo e infrastrutture di rete: elementi essenziali per raggiungere il target del 63,4% di FER nel mix di generazione elettrica al 2030, secondo il PNIEC.
Per rispondere a questa sfida e rendere l’Italia protagonista della transizione energetica il Think Tank Renewable Thinking ha individuato 3 ambiti prioritari di policy: la semplificazione delle procedure burocratiche, l’incremento della produttività degli impianti FER e il rafforzamento del quadro regolatorio: solo così l’Italia potrà raggiungere i target al 2030 e rappresentare una best case di sviluppo positivo su scala internazionale.
Fonte CVA - TEHA Group
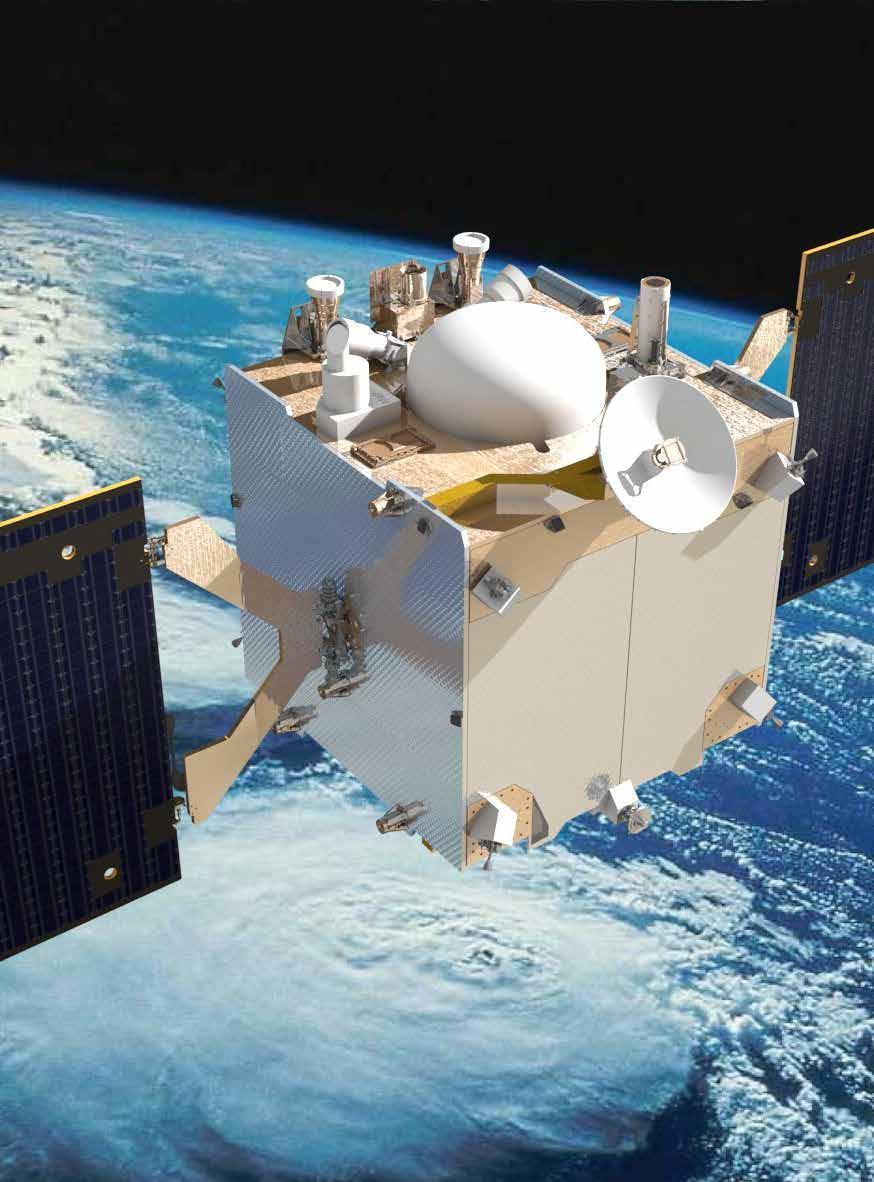

Era il dicembre 2004 quando l’asteroide 99942 Apophis divenne un osservato speciale delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Nel 2029 99942 Apophis era destinato a colpire la Terra con una percentuale del 2,7%, una percentuale piuttosto importante, a valore 1 sulla scala di Torino dedicata al rischio di impatto di asteroidi sul nostro pianeta.
D’altronde impatti del genere rientrano nella normalità della vita del nostro sistema solare; la differenza la fa la frequenza degli impatti e soprattutto le dimensioni e la composizione dell’asteroide. Fino a che il pianeta Giove, modificando la sua orbita non si è spostato sull'orbita attuale, la Terra fu oggetto di un “Heavy Bombardment” che, probabilmente, alla fine si è rilevato produttivo portando sul nostro pianeta tutti gli elementi, acqua compresa, che l'hanno reso il “pianeta azzurro”.
Considerate le dimensioni, anche se non ne è chiara ancora la
composizione, l’asteroide 99942 Apophis non avrebbe provocato un effetto come per l’estinzione dei Dinosauri, ma avrebbe prodotto inevitabilmente danni ingenti, equivalendo, con le attuali stime, ad una bomba da 870 Megatoni, circa 65500 volte la bomba di Hiroshima.
Nel 2013, circa dieci dopo, le stime hanno stabilito che tale asteroide non avrebbe colpito il nostro pianeta, ma lo avrebbe sfiorato ad appena 32.000km di distanza. Per capirci un satellite geostazionario, come quelli per le telecomunicazioni, ha un’orbita di 37.000km dalla Terra.
A questo punto perché perdere l’occasione? Dopo l’esperienza Dart della NASA, con Licia Cube dell’ASI a testimoniare l’impatto con l’asteroide Dymorphos, quale migliore occasione per capire come sono fatti questi oggetti cosmici potenzialmente catastrofici, che puntare ad osservarlo mentre ci è vicinissimo?
Nasce così la missione Ramses dell’Agenzia Spaziale Europea. Intesa come una prossima missione di difesa planetaria - la Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) - incontrerà l'asteroide 99942 Apophis e lo accompagnerà attraverso un sorvolo sicuro, anche se eccezionalmente ravvicinato, della Terra nel 2029. I ricercatori studieranno l'asteroide mentre la gravità terrestre altererà le sue caratteristiche fisiche. Le scoperte che ne deriveranno miglioreranno la nostra capacità di difendere il nostro pianeta da un oggetto simile in rotta di collisione.
Ramses dovrà essere lanciato nell'aprile 2028 per consentire un arrivo ad Apophis nel febbraio 2029, due mesi prima del contatto ravvicinato. Per rispettare questa scadenza, l'ESA ha chiesto il permesso di iniziare i lavori preparatori della missione il prima possibile utilizzando le risorse esistenti. Questo permesso è stato concesso dal comitato del programma Space Safety. La decisione di impegnarsi pienamente nella missione o meno avverrà durante la riunione della ministeriale ESA prevista a Parigi nel novembre 2025.
La sonda madre verrà realizzata da OHB Italia, come annunciato lo scorso ottobre durante l’International Astronautical Congress te-
nutosi a Milano, mentre il contratto del primo CubeSat è stato assegnato lo scorso marzo a favore dell’azienda torinese Tyvak International che ebbe a realizzare il piccolo satellite Milani per la missione Hera.
Recentemente l’azienda spagnola Emxys è stata scelta per la realizzazione del secondo CubeSat che, dopo un periodo di osservazione dell'asteroide, tenterà l’atterraggio controllato sulla superficie per raccogliere dati sull’attività sismica.
Come per OHB Italia e Tyvak International, anche Emxys ha contribuito alla missione Hera partecipando alla realizzazione del satellite Juventas.
Un payload destinato allo studio della composizione dell’asteroide è stato presentato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Si tratta di Hamlet (HyperScoutforApophisMultispectraLExplorationandTaxonomy), che potrebbe fornire immagini spettrali di Apophis nella gamma di lunghezze d'onda del visibile-vicino all'infrarosso utili ad identificare la classe spettrale degli asteroidi, limitando la struttura superficiale e la mobilità della regolite e per misurare gli effetti di meteorologia spaziale e gli eventuali cambiamenti di forma e superficie di Apophis dovuti all'incontro ravvicinato con la Terra.



STAM è leader nella consulenza ingegneristica e nei servizi per l’innovazione con oltre 25 anni di esperienza nel settore spaziale. Competenze multidisciplinari e intersettoriali, un team di 100 ingegneri, laboratori interni per supportare proof-of-concept e partnership con più di 1500 stakeholders (imprese, start-up ed enti di ricerca) in tutta Europa sono i nostri punti di forza.


STAM agisce come ESA Technology Broker per l’Italia e gestisce in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana il Fondo ESA Spark Funding.
www.stamtech.com
A cura di Paola Nardella

Qual è la relazione tra le biomasse e il clima terrestre? E quanto il loro studio può essere utilizzato per combattere i cambiamenti climatici in atto? Possono sembrare quesiti banali e in parte lo sono, ma sono premesse di conoscenza fondamentali per comprendere quanto il fattore umano, per dirla alla Virzì, incida in maniera importante in processi climatici che fanno parte della normalità in un pianeta come il nostro, ma che l’accelerazione imposta dall’uomo non permette all’uomo stesso di adeguarsi al nuovo clima del pianeta. Per essere sintetici, ci stiamo suicidando. Ci metteremo un po’ certo, ma se, come ricorda nel suo volume Su un altro pianeta l’astrofisico Amedeo Balbi, ogni specie è destinata prima o poi ad estinguersi, l’accelerazione in atto rischia però di rendere assai più vicino quel momento.
E se da una parte le biomasse rappresentano una validissima alternativa ai fossili per la produzione di energia, dall’altra parte la loro presenza sul pianeta ad una percentuale importante dell’anidride carbonica prodotta sul pianeta finisce nell’atmosfera creando quell’effetto serra che riscalda il pianeta stesso producendo un cambiamento climatico che, come una spirale, si avvita in sé stesso.
Ed è per tale motivo che l’Agen-
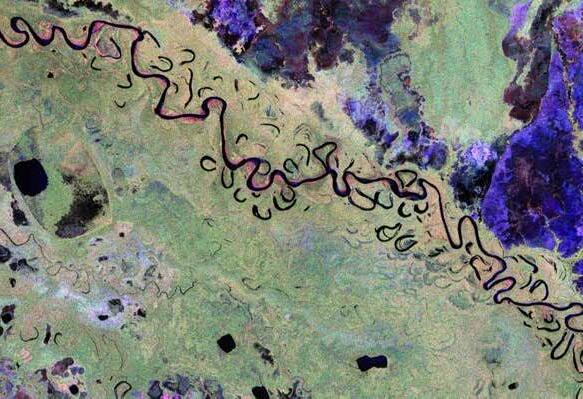
zia Spaziale Europea ha deciso di realizzare la missione BIOMASS, lanciata lo scorso 29 aprile e di cui recentemente sono state rilasciate le prime immagini. Il satellite, è il primo satellite dotato di un radar ad apertura sintetica in banda P, in grado di penetrare le canopie delle foreste per misurare la biomassa legnosa – tronchi, rami e steli –dove viene immagazzinata la maggior parte del carbonio forestale. Queste misurazioni fungono da proxy per lo stoccaggio del carbonio, la cui valutazione è l'obiettivo principale della missione.
Ancora in fase di commissioning (di validazione che tutto funzioni correttamente) il satellite ESA fornirà informazioni cruciali sullo stato delle nostre foreste e su come stanno cambiando, permettendoci così di approfondire la nostra conoscenza del ruolo svolto dalle foreste nel ciclo del carbonio.
Le foreste svolgono, infatti, un ruolo vitale nel ciclo del carbonio della Terra assorbendo e immagazzinando grandi quantità di anidride carbonica, contribuendo così a regolare la temperatura del
pianeta. Spesso chiamati 'polmoni verdi della Terra', assorbono circa 8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Tuttavia, la deforestazione e il degrado – specialmente nelle regioni tropicali – stanno rilasciando carbonio immagazzinato nell'atmosfera, peggiorando i cambiamenti climatici. Una sfida importante non solo per
gli scienziati ma soprattutto per una parte della politica, che ha giustificato il suo scetticismo sulla presunta mancanza di dati accurati su quanto immagazzinano le foreste di carbonio, nonostante l'aumento delle temperature, l'aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera e i cambiamenti nell'uso del suolo guidati dall'uomo, ci mettano giornalmente, soprattutto d’estate, di fronte a situazioni che non si possono più definire eccezionali.


Sette satelliti sono stati lanciati per la missione italiana di osservazione della Terra IRIDE. I satelliti fanno parte della costellazione Hawk for Earth Observation (HEO), che trasporta strumenti ottici multispettrali.
La costellazione fornirà dati per
In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione dell'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato una cerimonia celebrativa dal titolo 'Stelle d’estate', presso la sua sede di Roma.
L'evento, condotto dalla giornalista Safiria Leccese, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, vertici dell'ESA e dell'ASI e astronaute e astronauti, offrendo al pubblico un articolato programma artistico e divulgativo.
Nel corso della serata sono intervenuti il presidente dell'ASI, Teodoro Valente, il Direttore
prodotti e servizi che aiuteranno le pubbliche autorità a prendere decisioni basate su dati scientifici provenienti dallo spazio. Il programma IRIDE fornirà informazioni per una vasta gamma di servizi ambientali, di emergenza e di sicurezza per l'Italia.
I sette satelliti HEO sono stati sviluppati da Argotec per il programma IRIDE. Si uniscono a HEO Pathfinder, il primo satellite IRIDE in orbita, lanciato a gennaio 2025. Pathfinder ha catturato la prima immagine del programma – una vista di Roma e dell'Italia centrale in alta risoluzione – che è stata presentata presso il Centro ESA in Italia, ESRIN, all'inizio di quest'anno.
Generale dell'ESA, Josef Aschbacher, il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra e Responsabile dell'ESRIN, Simonetta Cheli, e il Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Federico Eichberg, che ha rappresentato gli auspici del Ministro Adolfo Urso per la crescente rilevanza dello spazio in Italia e in Europa, quale chiave per la competitività non solo del settore, ma dell'intera economia continentale. Erano inoltre presenti il Direttore Generale dell'ASI, Luca Vincenzo Maria Salamone, la Vicepresidente Elda Turco Bulgherini, esponenti degli Organi dell'Agenzia, Dirigenti e alti esponenti dell'ESA.
Samantha Cristoforetti e Luca Par-
Il lancio da parte di SpaceX è avvenuto alle 23:25 CEST di lunedì 23 giugno, su un razzo Falcon 9, dalla base spaziale Vandenberg Space Force Base in California. L'acquisizione del segnale è stata confermata al controllo missione di Argotec circa quattro ore dopo il lancio. Coordinato dall'ESA con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il programma IRIDE prevede il dispiegamento di sei costellazioni di satelliti. Si tratta di un'ambiziosa iniziativa spaziale del governo italiano con finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
mitano, del corpo degli astronauti dell'ESA di nazionalità italiana, intervenuti insieme ad Anthea Comellini e Andrea Patassa, membri della riserva delle astronaute e degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno condiviso con i presenti riflessioni sulle loro esperienze in missione, sulle prospettive future dell'esplorazione spaziale e sull'importanza della crescente rappresentanza italiana all'interno del corpo astronautico europeo.
Ad accompagnare l'evento, l'esibizione dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale F.P. Tosti di Ortona, diretta dal maestro Paolo Angelucci, che ha proposto un repertorio di celebri colonne sonore ispirate ai temi dello spazio.
La collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) ha annunciato la rilevazione della fusione dei buchi neri più massicci mai osservati con le onde gravitazionali, che mettono in crisi i modelli astrofisici dell’evoluzione delle stelle. La fusione ha prodotto un buco nero finale di massa più di 225 volte superiore a quella del nostro Sole. Il segnale, denominato GW231123, è stato osservato durante il quarto periodo di osservazione (O4) della rete LVK il 23 novembre 2023.
I due buchi neri che si sono fusi avevano una massa pari a circa 103 e 137 volte quella del Sole. Oltre alle loro masse elevate, sono anche in rapida rotazio-
ne, il che rende questo segnale unico e difficile da interpretare e suggerisce la possibilità di una storia di formazione complessa.
I rivelatori di onde gravitazionali come LIGO negli Stati Uniti, Virgo in Italia e KAGRA in Giappone sono progettati per misurare le minime deformazioni dello spazio-tempo causate da eventi cosmici violenti come le fusioni di buchi neri. Il quarto ciclo di osservazioni è iniziato nel maggio 2023 e i risultati della prima metà del ciclo (fino a gennaio 2024) saranno pubblicati nel corso dell'estate.
La sonda Parker della Nasa ha ripreso le immagini del Sole più ravvicinate di sempre, da una distanza di appena 6,2 milioni di chilometri dalla superficie solare: i dati raccolti forniscono preziose informazioni sul vento solare, il flusso di particelle elettricamente cariche che si propaga nel Sistema solare condizionando il meteo spaziale con eventi che influiscono anche sulla Terra.
La sonda Parker ha iniziato il suo passaggio più ravvicinato al Sole il
24 dicembre 2024, volando a soli 6,1 milioni di chilometri dalla superficie solare. Mentre sfiorava l'atmosfera esterna della stella, la cosiddetta corona solare, ha raccolto dati con i suoi strumenti scientifici di bordo. In particolare, le nuove immagini catturate dallo strumento Wispr (Wide-Field Imager for Solar Probe) mostrano la corona e il vento solare, cioè il flusso costante di particelle elettricamente cariche provenienti dal Sole che si diffonde in tutto il Sistema solare con effetti di vasta portata che colpiscono
anche la Terra, generando aurore e pericolose interferenze con le reti elettriche, le comunicazioni radio e i satelliti.
Le immagini di Wispr offrono uno sguardo più approfondito su ciò che accade al vento solare subito dopo il suo rilascio dalla corona: nello specifico, mostrano l'importante confine dove la direzione del campo magnetico solare cambia da nord a sud. Inoltre, per la prima volta catturano in alta risoluzione la collisione di molteplici espulsioni di massa coronale (Cme), grandi esplosioni di particelle cariche che rappresentano un fattore chiave del meteo spaziale. Quando le Cme si scontrano, la loro traiettoria può cambiare, rendendo più difficile prevedere dove finiranno. La loro fusione può anche accelerare particelle cariche e mescolare i campi magnetici, il che rende gli effetti delle Cme potenzialmente più pericolosi per gli astronauti e i satelliti nello spazio e per la tecnologia sulla Terra.

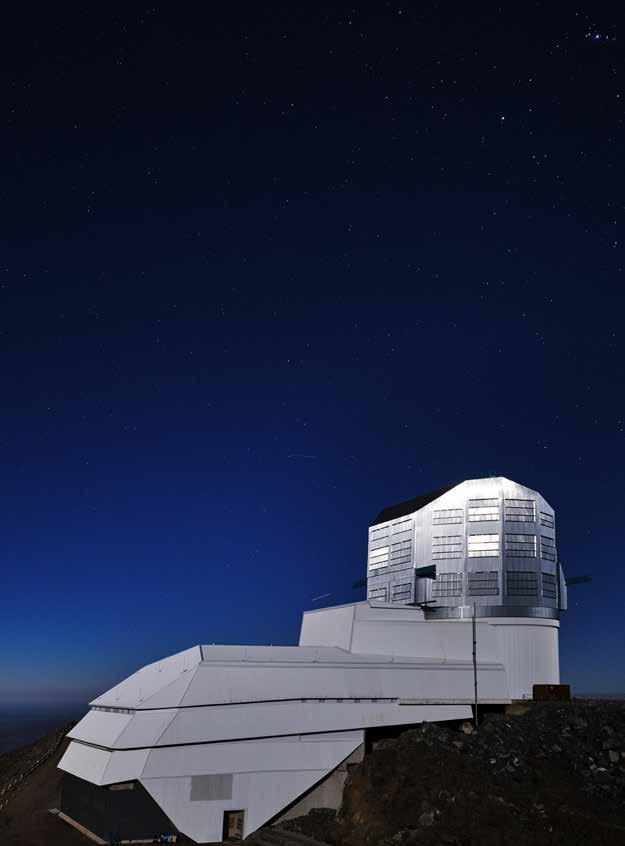
A cura di EIE GROUP
First Light - Un traguardo fantastico, quello raggiunto da EIE GROUP, il 23 giugno scorso. In collegamento internazionale la NSF ha voluto celebrare la “prima luce” del nuovissimo e potentissimo telescopio del Vera Rubin Observatory sito sul Cerro Pachón in Cile. Un Survey Telescope con uno specchio primario monolitico della classe 8.4m di diametro. Nell’occasione sono state pubblicate le prime spettacolari immagini ottenute dall’osservatorio, intitolato all’astronoma Vera C. Rubin, La prima luce tecnica, ovvero la prima cattura di fotoni dallo strumento, era avvenuta già il 24 ottobre 2024, ma la “prima luce” vera e propria, con la camera scientifica definitiva e le immagini destinate alla ricerca, è stata annunciata a metà 2025.
Il Vera C. Rubin Observatory è stato progettato per una campagna di osservazione decennale, nota come Legacy Survey of Space and Time (LSST), che mapperà il cielo australe con altissima risoluzione e frequenza, rivoluzionando l’osservazione del cosmo. Le immagini della prima luce mostrano milioni di galassie, stelle, asteroidi e dettagli di nebulose con una tecnologia di punta, comprendente una fotocamera digitale da 3.2 gigapixel, la più grande mai costrui-
ta per la ricerca astronomica.
Una rivoluzione scientifica - il progetto LSST, originariamente Large Synoptic Survey Telescope, rappresenta per EIE GROUP una tappa dai contenuti tecnologici avveniristici, dove la maturità industriale ha saputo creare, con gli scienziati americani del NOIRLab (National Optical Infrared Research) un equilibrato ecosistema nel quale, ogni singolo requisito di progetto dell’edificio rotante, è stato sapientemente fuso mutuando sostenibilità ambientale, ridotti consumi, ridotti costi di gestione, funzionalità operativa e di manutenzione, durata nel tempo, sicurezza intrinseca con peculiari ed ambiziosi obiettivi scientifici che rivoluzioneranno l’approccio osservativo: una scansione continua e ad alta frequenza del cielo australe, creando una vera e propria “astro-cinematografia”.
Questo significa che invece di osservare singoli oggetti celesti isolati come fanno i telescopi tradizionali, il Vera Rubin osserva ampie porzioni di cielo ripetutamente ogni tre giorni, mappandolo con dettagli spaziali e temporali. La survey intende non solo monitorare la posizione e caratteristiche di stelle, galassie e oggetti del Sistema Solare, ma anche registrare i cambiamenti nel tempo, permettendo di studia-
re fenomeni variabili e transienti come supernove, stelle variabili e il passaggio di asteroidi. Questo approccio innovativo è definito come un salto di paradigma, da un’astronomia basata su semplici “istantanee” di singoli oggetti, verso un’osservazione dinamica e sistematica dell’intero cielo che genera una “narrazione visiva” continua e dettagliata del cosmo, con applicazioni importanti nello studio della materia oscura, energia oscura, popolazioni di galassie, oggetti del Sistema Solare e fenomeni variabili
L’osservatorio astronomico
- L'Osservatorio Vera Rubin si trova nel Cile centro-settentrionale, sulla cresta del Cerro Pachón ai piedi delle Ande, ad una altitudine di circa 2.600m sul livello del mare, un luogo senza inquinamento luminoso nelle vicinanze, dove i cieli notturni brillano di magici colori. L'intera area di Cerro Pachón, comprende il sito dell'Osservatorio Rubin e i telescopi Gemini-South e SOAR, si trova su un tratto di terra di proprietà dell'Associazione delle Università per la Ricerca in Astronomia (AURA), Inc. Cerro Pachón si trova nell'entroterra, a circa 100 chilometri dalla città di supporto di La Serena, dove si trova anche la sede operativa dell'Osservatorio Rubin.
La cupola rotante del Rubin Observatory è una struttura apposi-
tamente progettata da EIE GROUP per ospitare e proteggere il grande telescopio da 8,4 metri. È un edificio a forma poligonale irregolare, che ruota per consentire al telescopio di puntare qualsiasi parte del cielo australe visibile, minimizzando l’impatto sulle immagini dovuto a turbolenze atmosferiche e condizioni ambientali.
Caratteristiche principali dell’edificio rotante:
• ha un diametro di circa 30m ed è una struttura a più piani che contiene il telescopio e il suo supporto, dall’imponente base fino alla camera e strumentazione.
• l’edificio rotante è progettato per ridurre le turbolenze d’aria attorno al telescopio, mantenendo condizioni stabili durante le osservazioni. Ruota sincronizzato con il telescopio, consentendo movimenti fluidi e rapidi per coprire il campo di vista molto ampio del telescopio, con puntamento disponibile entro pochi secondi.
• La base in calcestruzzo sulla quale è montato l’edificio permette un movimento preciso, mentre il pilastro del telescopio è isolato per ridurre
vibrazioni e assicurare stabilità. Questo edificio rotante è parte vitale dell’osservatorio, garantendo protezione, isolamento da vibrazioni, e la capacità di svolgere le osservazioni ad alta precisione e velocità tipiche del Vera Rubin Observatory.
Una caratteristica importante che rende unica la struttura dell'Osservatorio Rubin è il lungo e basso edificio attaccato al pilastro che sostiene la cupola rotante. Questo edificio di 2500 mq ospita tutti i tipi di servizi ausiliari complessi (ad esempio, elettrico, riscaldamento e raffreddamento) necessari per il funzionamento e la manutenzione del telescopio e della telecamera. C'è anche un piano di servizio dedicato, dove vengono immagazzinate le attrezzature speciali e dove possono essere eseguite attività di manutenzione ordinaria. Nell'edificio ausiliario sono installate anche la camera di lavaggio e di alluminatura dello specchio. Le camere sono già state utilizzate per pulire e rivestire gli specchi del telescopio con un sottile strato di materiale riflettente prima che fossero installati. Tale trattamento superficiale verrà ripetutamente rifatto negli anni per mantenere una elevata riflessività dello specchio.
L'edificio di servizio è dotato anche
di una camera bianca dedicata agli interventi sulla fotocamera i cui componenti sono così sensibili che devono essere protetti anche dalle particelle di polvere più fini nell'aria.
È dal 1986 che EIE GROUP opera in Cile, per la realizzazione dei più potenti ed innovativi osservatori astronomici, per conto delle più importanti comunità scientifiche internazionali. Una lunga storia di successi, caratterizzata dalla realizzazione dei sempre più potenti e grandi telescopi del mondo. È proprio vicino a La Serena, meta turistica amata dai cileni per le sue sterminate spiagge di sabbia dorata, dove la ESO (European Southern Observatory) con sede a Garching, vicino a Monaco di Baviera, ha collocato il suo primo sito astronomico di La Silla, un’area osservativa con numerosi telescopi astronomici. È qui che EIE è stata chiamata a realizzare quello che si chiama progetto NTT, il New Technology Telescope che costituisce il primo esempio di “osservatorio sistemico” dove ogni elemento che lo costituisce rappresenta un tassello funzionale del mosaico prestazionale che garantisce al telescopio la sua massima efficienza, la sua capacità di puntare ai confini dell’Universo. Ed è da qui che inizia e si
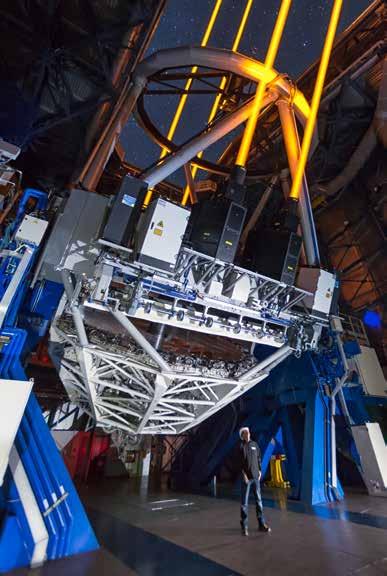
sviluppa questa lunga storia di EIE in campo astronomico, a rincorrere la realizzazione di telescopi sempre più grandi.
L’Osservatorio Vera Rubin, progettato per studiare specificatamente la materia oscura, che costituisce l'85% del nostro universo ed ancora sconosciuta agli scienziati, rappresenta per EIE l’ultimo osservatorio realizzato in Cile, dal 2014 e che si
Le stelle guida laser al Very Large Telescope n°4
• i quattro telescopi e i quattro edifici del progetto VLT (Very Large Telescope) installati al Paranal, sempre nel deserto di Atacama, in Cile. Si tratta di un array di 4 telescopi con specchi da 8.2m di diametro ciascuno, che possono operare singolarmente o combinati in modo interferometrico, ottenendo così un’altissima risoluzione e una capacità di ESO
concluderà il prossimo anno. Sono opere realizzate da EIE GROUP, e dai suoi partner:

raccolta fotografica superiore, fino a quattro volte quella di un singolo telescopio. I telescopi sono stati inaugurati nel 1999 e ciascuno ha un nome in lingua mapuche: Antu (il Sole), Kueyen (la Luna), Melipal (la Croce del Sud) e Yepun (Venere). Questa infrastruttura è tra i telescopi ottici più avanzati e potenti al mondo, con capacità che superano persino il telescopio spaziale Hubble in qualità delle immagini. Il progetto VLT ha avuto un costo di circa 500 milioni di dollari ed è gestito dall’ESO (European Southern Observatory), la principale organizzazione astronomica europea. Il sistema serve per una vasta gamma di osservazioni astronomiche, come lo studio delle galassie lontane, la formazione stellare, l’osservazione di esopianeti, e il monitoraggio di fenomeni estremi come bu-
chi neri e lampi gamma. Una recente evoluzione del progetto include l’uso combinato della luce di tutti e quattro i telescopi principali attraverso uno spettrografo chiamato ESPRESSO, che rende il più grande telescopio ottico funzionante per area di raccolta. Questa modalità permette osservazioni molto più dettagliate e precise.
EIE GROUP è stata chiamata sin dal 2007 a studiare per conto dell’organizzazione scientifica ESO la possibilità di realizzare telescopi giganti della classe 40-50m di diametro di specchio primario. Dopo 5 lunghi anni di studi, simulazioni, analisi si è giunti ad una configurazione possibile con uno specchio primario di 39m. È iniziata così la storia di que-
sto enorme telescopio l’Extremely Large Telescope (ELT) il progetto per la costruzione del più grande telescopio ottico al mondo, con uno specchio primario, composto da 798 segmenti esagonali, ora in fase di installazione a Cerro Armazones, nel deserto di Atacama, Cile, a circa 3000 metri di altitudine, una posizione scelta per la sua eccezionale limpidezza atmosferica e assenza di inquinamento luminoso.
EIE ha avuto l’onore di progettare sia il telescopio che il relativo osservatorio. L’ELT utilizza un design innovativo a cinque specchi con ottiche adattive per correggere le distorsioni dell’atmosfera terrestre, garantendo immagini estremamente nitide. Questo telescopio potrà raccogliere fino a 13 volte più luce rispetto agli attuali grandi telescopi e fornire immagini 16 volte più nitide rispetto al telescopio spaziale Hubble.
Il progetto ELT è tecnicamente
complesso e sta procedendo con la costruzione della struttura, compresa la grande cupola rotante che ospiterà il telescopio. Dopo diversi anni di sviluppo, il completamento dell’installazione degli specchi e l’entrata in funzione completa, è prevista per il 2029-2031. L’ELT permetterà di esplorare temi di grande attualità astronomica come lo studio di esopianeti, buchi neri, materia oscura e le origini dell’universo.
Un’altra opera gigantesca, realizzata anche da EIE GROUP è quella del progetto del radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array) che è il più grande interferometro astronomico situato nel deserto di Atacama, in Cile, a circa 5.000 metri di altitudine. È costituito da un array di 66 radiotelescopi di precisione, di cui 50 antenne principali da 12 metri di diametro e 16 antenne più piccole (4 da 12 metri e 12 da 7 metri) che formano un array compatto chiamato Atacama Compact Array (ACA). EIE GROUP ha avuto l’opportunità di inventare, progettare e realizzare una delle sue più belle opere in campo astronomico realizzando il primo prototipo di radio antenna e la serie delle 25 europee, per conto di ESO, in partnership con altre due realtà industriali francesi e tedesche.
ALMA osserva le onde elettromagnetiche nelle lunghezze d’onda millimetriche e sub-millimetriche, permettendo di studiare fenomeni come la nascita delle stelle nell’universo primordiale e la formazione di stelle e pianeti nel nostro universo locale. Le antenne possono essere spostate su distanze variabili da 150 metri fino a 16 km per ottenere varie risoluzioni spaziali, con uno “zoom” potente simile a quello del Very Large Array negli Stati Uniti.
È il progetto astronomico a terra più costoso e sofisticato mai realizzato (circa 1,4 miliardi di dollari), frutto di una collaborazione internazionale tra Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Cile. Inaugurato ufficialmente nel 2013, ALMA è oggi uno degli strumenti più sensibili al mondo per l’osservazione a queste lunghezze d’onda, con risoluzione angolare di 10 milliarcosecondi e capacità di imaging molto superiori rispetto a radiotelescopi precedenti.
Le applicazioni scientifiche di ALMA includono l’osservazione dettagliata di dischi protoplanetari, studi sulle comete, la formazione stellare, e la struttura delle galassie vicine e lontane.
EIE GROUP si è cimentata anche
nella astronomia gamma realizzando sia il primo prototipo che il primo esemplare serie dei telescopi per il progetto ASTRI (Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana). Un progetto bandiera italiano finanziato dal MIUR e guidato dall’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) nell’ambito del programma internazionale CTA (Cherenkov Telescope Array), finalizzato alla costruzione di un osservatorio per l’astronomia dei raggi gamma da terra. ASTRI si concentra sulla progettazione e costruzione di telescopi di piccola taglia (SST - Small Size Telescope) per l’osservatorio CTA. Il primo risultato è stato il telescopio prototipale ASTRI SST-2M, installato a Serra La Nave (Catania), che ha adottato una configurazione ottica innovativa Schwarzschild-Couder, con doppio specchio, che consente immagini più compatte e l’utilizzo di rivelatori più piccoli e leggeri. Questo telescopio prototipale è stato validato con osservazioni di sorgenti gamma astrofisiche. Attualmente, INAF è impegnata nella realizzazione di una serie di 9 telescopi precursori (“pathfinder”) basati sull’ottimizzazione del prototipo ASTRI, destinati a test e implementazione nell’emisfero sud, parte integrante della rete CTA. EIE GROUP, come partner tecnologico, ha contribuito alla progettazione e realizzazione del primo telescopio e della prima
Camera Cherenkov dell’Array di telescopi ASTRI, assicurando il successo di questa importante opera scientifica.
Recentemente EIE GROUP ha deciso di investire anche nei settori dello Spazio e della Difesa creando al suo interno una nuova Divisione per le attività spaziali per il supporto e l’ingegneria a servizio dei seguenti principali Programmi Spaziali. EIE fornisce soluzioni di ingegneria avanzata, progettazione e realizzazione di:
• Equipaggiamenti di supporto a terra (Ground Support Equipment, GSE) ottici, meccanici e termici per testare prototipi e hardware destinati allo spazio.
• Sistemi opto-meccanici per l’esplorazione del Sistema Solare e l’osservazione della Terra.
• Servizi ingegneristici che spaziano dalla modellazione ottica e meccanica alla simulazione numerica di processi fisici complessi e alla prototipazione di strumentazione avanzata per missioni spaziali.

Sono esempi di programmi: sviluppo di strumenti GSE per le missioni BepiColombo (ESA) e Solar Orbiter (ESA/NASA).
Con il boom della cosiddetta Space Economy, EIE ha ulteriormente ampliato le sue attività nei seguenti ambiti: progettazione e realizzazione di infrastrutture per l’osservazione terrestre e per i sistemi innovativi per il monitoraggio di detriti orbitali e piattaforme di lancio dei futuri spazioporti europei. EIE partecipa allo sviluppo di habitat lunari e marziani, con particolare attenzione all’uso di materiali innovativi e di strutture modulari
CTA/ASTRI - il primo prototipo di telescopio per raggi gamma
sostenibili, guardando alla futura colonizzazione dello spazio.
EIE è membro attivo di alleanze e associazioni internazionali come la Global Spaceport Alliance e l’AIPAS (Association of Enterprises for Space Activities).
EIE GROUP collabora con l’ESA (European Space Agency) per progetti come Flyeye, un sistema di telescopi per lo Space Surveillance & Tracking, ovvero la sorveglianza spaziale e il tracciamento degli oggetti in orbita. La cupola è stata
studiata per ospitare un telescopio di medie dimensioni, dotato di una montatura equatoriale di rapido puntamento, caratteristica indispensabile per le operazioni di “sky survey” rapido e automatizzato. L’osservatorio comprenderebbe servizi operativi a supporto, vie di accesso e sistemi tecnici per il controllo remoto e la raccolta dei dati, così da limitare la presenza umana continua sulla cima della montagna che ospiterà il telescopio. In attesa dell’osservatorio montano, EIE ha realizzato presso la sede dell’ASI di Matera una struttura provvisoria per alloggiare il telescopio.
Tra le attività in ambito spaziale sulle quali EIE GROUP sta ponendo particolare interesse vi sono le applicazioni per il vivere extra-terrestre. I nuovi habitat lunari e marziani sono progettati per ospitare e supportare la vita umana in ambienti estremi e ostili, come la superficie della Luna e di Marte. Di seguito una serie di esempi attraverso i quali i nostri tecnici, ingegneri e fisici stanno verificando l’attivazione di progetti autonomi: Habitat lunari:
• Il Multi-Purpose Habitation
Module (MPH) è un modulo abitativo multifunzionale permanente sulla superficie lunare, sviluppato da Thales Alenia Space in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nell’ambito del programma Artemis della NASA. È progettato per essere lanciato nel 2033 e sarà il primo habitat umano permanente sulla Luna. Le sue dimensioni sono circa 3 metri di diametro per 6 di lunghezza, simile a un container, e potrà ospitare due astronauti per missioni di durata da 7 a 30 giorni, con la possibilità di operare anche in modalità automatica senza equipaggio umano a bordo. Il modulo offrirà un ambiente sicuro, confortevole e multifunzionale, con spazi simili a quelli terrestri (con pavimento e possibilità di camminare, sedersi e dormire in posizione orizzontale), comprensivi di un bagno e aree per esperimenti scientifici e manutenzione. Sarà inoltre capace di spostarsi autonomamente sulla superficie lunare e sarà operativo per circa dieci anni, supportando sia le missioni con equipaggio che quelle robotiche. L’MPH rappresenta una svolta per la
presenza umana sostenibile sulla Luna e un passo intermedio verso l’esplorazione umana di Marte.
• Altre proposte di habitat lunari includono il progetto Lunar Lantern statunitense, che prevede l’uso di materiali locali (regolite lunare) e tecnologie di stampa 3D robotizzata per costruire strutture protettive, con doppi gusci e sistemi di schermatura contro temperature estreme e radiazioni. Esiste anche il progetto europeo Moon Village, un habitat semi-gonfiabile e completamente operativo, che evidenzia la crescente integrazione tra architettura spaziale e tecnologia di costruzione automatizzata.
Habitat marziani:
• Per Marte, le sfide sono simili ma amplificate dalla maggiore distanza e condizioni ambientali più severe. Si prevede l’uso intensivo della regolite marziana (il suolo locale) per costruire habitat tramite stampanti 3D, creando strutture resistenti in situ, riducendo la necessità di trasportare materiali dalla Terra. Questi
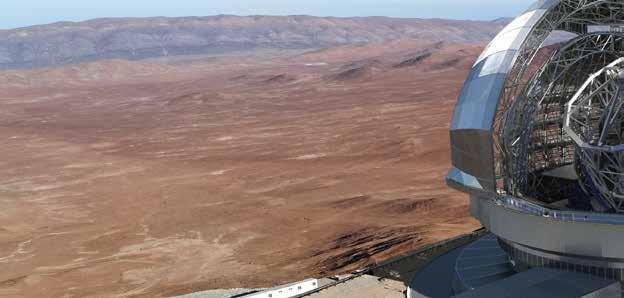
habitat dovranno assicurare un sistema di supporto vitale a circuito chiuso, inclusa la coltivazione di piante che trasformino CO2 in ossigeno e cibo tramite fotosintesi, ispirandosi a progetti ESA come MELiSSA. Gli habitat marziani saranno quindi fortemente tecnologici e autosufficienti, concepiti come vere e proprie biosfere capaci di sostenere la vita umana per lunghi periodi.
Sono in corso anche studi per la mobilità sui pianeti extraterrestri quali rover, piccoli velivoli/elicotteri.
EIE GROUP, nell'ambito di un consorzio composto da INAF in primis, e da altre aziende italiane, è impegnata nella realizzazione delle parti più critiche del progetto impiantistico VERT-X per la missione ATHENA.
ATHENA sarà un potente osservatorio a raggi X per tutti i campi dell'astrofisica. L'ambizione della missione sarà quella di studiare i componenti barionici caldi dell'U-
niverso, dai buchi neri supermassicci (SMBH) nell'Universo primordiale agli ammassi di galassie e alle loro grandi strutture. Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso il più grande specchio a raggi X mai costruito che focalizzerà fotoni 0,2-12,0 keV su due strumenti all'avanguardia per la spettroscopia ad alta risoluzione spazialmente risolta (X-Ray Integral Field Unit, X-IFU) e per l'imaging a largo campo e la spettroscopia a bassa risoluzione (Wide Field Imager, X-IFU) e l'imaging a largo campo e la spettroscopia a bassa risoluzione (Wide Field Imager, X-Field Imager, Campo a raggi X, WFI).
Lo specchio sarà costruito utilizzando la tecnologia ESA Silicon Pore Optics (SPO) che fornisce un'ampia area effettiva con un'eccellente risoluzione angolare. Le procedure di test e integrazione dei moduli a specchio singolo (MM) sono già ben consolidate. Le misurazioni a raggi X saranno effettuate utilizzando fasci di matita monocromatici al sincrotrone BESSY e, quindi, in modalità di piena illuminazione, utilizzando la struttura di prova BEATRIX. L'integrazione MM nel gruppo specchio (MA) sarà effettuata utilizzando un grande fascio UV collimato, con una struttu-
ra verticale da implementare.
La verifica e la taratura dell'intera AIC è particolarmente impegnativa e sono allo studio diverse opzioni. Infatti, la raccomandazione dell'ATHENA Telescope Working Group (TWG) è che la fonte per la verifica e la calibrazione della malattia di Alzheimer dovrebbe essere situata a una distanza minima di 300 m con un obiettivo di 800 m. Poiché il tubo più lungo d'Europa è l'MPE Panter Lab, questo può essere realizzato solo in una nuova struttura a raggi X a lungo raggio o con un aggiornamento significativo della struttura a raggi X e criogenica (XRCF) della NASA.
Per ovviare a questo problema, abbiamo proposto all'ESA il concetto di una struttura innovativa. Questo concetto si basa su un fascio parallelo di raggi X prodotto da una sorgente puntiforme, situata nel fuoco di un collimatore di raggi X privo di errori. Questo concetto non è nuovo ed è già in fase di costruzione per BEATRIX. Poiché, per ovvie ragioni costruttive, la larghezza del fascio deve essere molto più piccola di quella dello specchio ATHENA, si pensa che il sistema sorgente-collimatore, che produce il fascio, sia mosso da un meccanismo di scan-

sione raster che copre tutte le ottiche da calibrare. Ciò si traduce nella progettazione di un sistema di calibrazione molto più piccolo del tradizionale tubo lungo.
Oltre alla ridotta quantità di risorse in gioco, ci sono anche altri evidenti benefici generati dalla compattezza di questo concetto. In primo luogo, consente una geometria verticale che semplifica notevolmente il supporto dello specchio e riduce a zero il degrado delle PSF dovuto alla gravità laterale (perpendicolare all'asse ottico). Ciò consentirebbe anche di ospitare l'AG integrato con la SIM per eseguire la campagna di calibrazione end-to-end, anche se, al momento, ciò non è previsto nel programma di sviluppo del progetto ATHENA. Pertanto, grazie al design compatto, la posizione della struttura può essere scelta in modo flessibile e in base alle esigenze del progetto. Inoltre, mentre il meccanismo di scansione raster introduce una scala temporale per le operazioni di calibrazione (~1 ora), consente di caratterizzare il contributo dei singoli moduli alle prestazioni complessive dello specchio. Il progetto della struttura del VERT-X si compone di diverse parti: la sorgente, il collimatore, il meccanismo di scansione raster, la
metrologia, il supporto dello specchio ATHENA, il rivelatore con il suo sistema di posizionamento, il tutto racchiuso in una camera a vuoto.
EIE GROUP, forte della sua importante esperienza nelle infrastrutture a servizio dei telescopi, sta ora specializzandosi nella progettazione e realizzazione degli spazioporti, un orizzonte prossimo nel dominio dello spazio.
Si tratta di infrastrutture specializzate, simili ad aeroporti, ma destinate a supportare il lancio, il rientro e le operazioni a terra di veicoli spaziali suborbitali, come navette e spazioplani. Questi siti dispongono di edifici, installazioni, impianti e apparati specifici per gestire tutte le fasi operative di un volo suborbitale, inclusi controlli di sicurezza, preparazione del veicolo, monitoraggio e comunicazioni in volo. Attualmente è impegnata nella progettazione e realizzazione di piattaforme di lancio dedicate ai decolli dei razzi o veicoli spaziali e che sono parte integrante degli spazioporti. La loro costruzione prevede componenti chiave come:
• Una struttura di servizio che permette l’accesso al veicolo per ispezioni e ingresso dell’equipaggio.
• Una struttura di aggancio che collega il veicolo ai sistemi di rifornimento di propellente, gas, energia e comunicazioni.
• Sistemi per deviare le fiamme e il calore intense generate dai motori al lancio.
• In alcune rampe, sistemi di soppressione acustica per proteggere i veicoli dalle onde sonore forti durante il decollo.
• Supporti stabili con bulloni esplosivi che tengono il razzo fermo durante l’accensione motori e si staccano al momento del lancio.
Queste infrastrutture richiedono ingenti investimenti e complessa ingegneria per garantire affidabilità e sicurezza nei lanci.

attività illecite e dannose.
Di Fabrizio Beria
L’intelligenza artificiale (IA) ha vissuto un’evoluzione rapida e articolata negli ultimi anni, progressivamente arricchendo ambiti applicativi e consolidando metodologie che, fino a qualche anno fa, erano confinate alla ricerca accademica. Dall’apprendimento supervisionato e non supervisionato fino alle architetture di deep learning, l’IA ha dimostrato la propria efficacia nel riconoscimento di pattern, nell’analisi predittiva e nella generazione di contenuti.
Tuttavia, l’estrema potenza di queste tecnologie porta con sé rischi significativi: in mani malevole, hacker e produttori di deepfake possono sfruttare sistemi di IA per
È pertanto cruciale fare il punto sullo stato dell’arte odierno, riconoscere le principali minacce e identificare le contromisure tecnologiche, organizzative e normative necessarie.
Come spesso abbiamo fatto in questa rubrica, abbiamo chiesto un’analisi direttamente alla nostra AI di riferimento, ChatGPT che ci ha risposto utilizzando la versione OpenAI o4-mini.
1.1 Evoluzione degli algoritmi
Negli ultimi cinque anni, l’IA si è spostata da modelli relativamente leggeri a reti neurali profonde con miliardi di parametri. Architetture come Transformer, introdotte nel 2017, hanno rivoluzionato l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) grazie a meccanismi di self-attention che consentono di cogliere relazioni a lungo raggio tra paro-
le. Modelli come GPT-4, PaLM e BERT hanno stabilito nuovi record in compiti di traduzione, estrazione di informazioni e generazione testuale intelligibile a livello umano.
1.2 Applicazioni principali
• NLP e chatbot: assistenti virtuali capaci di gestire dialoghi complessi in linguaggio naturale.
• Visione artificiale: riconoscimento facciale, analisi di immagini mediche e sorveglianza.
• Analisi predittiva: modelli di forecasting per finanza, manutenzione predittiva in ambito industriale.
• Generazione di contenuti: sistemi di image-to-text, video synthesis e musical AI.
1.3 Infrastrutture e democratizzazione
L’accesso a potenti GPU e TPU, unito a piattaforme cloud (AWS, GCP, Azure), ha reso possibile l’addestramento di grandi modelli anche per PMI e startup. Framework open source come TensorFlow e PyTorch hanno abbassato barriere di ingresso, alimentando un ecosistema vivace di librerie e tool.
Pericoli dell’uso distorto dell’IA
2.1 Deepfake e disinformazione
I deepfake rappresentano la minaccia più percepita dal grande pubblico. Attraverso GAN (Generative Adversarial Networks), è possibile generare video e audio falsi estremamente realistici. Tali contenuti possono essere utilizzati per:
• Campagne di disinformazione politica.
• Ricatti e frodi tramite scenari simulati di personalità note.
• Manipolazione dell’opinione pubblica sui social media.
2.2 Hackeraggio basato su IA
Gli hacker utilizzano tecniche di IA per automatizzare attacchi avanzati:
• Phishing generativo: email e messaggi altamente personalizzati basati su profili social.
• Fuzzing intelligenti: ricerca automatica di vulnerabilità nei software.
• Brute-force ottimizzato: utilizzo di modelli predittivi per restringere lo spazio di password.
2.3 Minacce alla privacy e all’identità
Il riconoscimento facciale e il tracciamento comportamentale, se combinati con database pubblici e privati, permettono profilazioni dettagliate, mettendo a rischio anonimato e diritti fondamentali.
3 Contromisure tecnologiche
3.1 Rilevazione dei deepfake
• Watermarking intenzionale: inserire segnature digitali nei contenuti generati.
• Modelli di rilevazione forense: Reti neurali addestrate a distinguere artefatti tipici dei deepfake.
3.2 Difese contro attacchi basati su IA
• Sistemi di Intrusion Detection (IDS) con modelli di anomaly detection per identificare comportamenti anomali.
• Robust training e adversarial training: addestrare i modelli a resistere a perturbazioni avversariali.
• Autenticazione multifattoriale e basata su
hardware (TPM, Secure Enclave).
3.3 Privacy e sicurezza dei dati
• Differential privacy: aggiungere rumore calibrato ai dataset per proteggere i dati sensibili.
• Federated learning: addestramento distribuito che mantiene i dati sul dispositivo dell’utente.
• Contromisure organizzative e normative
4 Contromisure organizzative e normative
4.1 Policy aziendali e governance dell’IA
• Creazione di comitati etici interni per la valutazione dei progetti IA.
• Standard ISO e linee guida (ad esempio ISO/IEC JTC 1/SC 42) per gestione e valutazione del rischio.
4.2 Normative in evoluzione
• Regolamento UE sull’IA: classificazione dei sistemi IA in base al rischio (alto, medio, basso) e requisiti di trasparenza.
• Leggi su deepfake: proposte di legge per sanzionare la

produzione e diffusione di contenuti contraffatti.
Tutto interessante e chiaro ma si sente ancora la mancanza di un ulteriore spunto di riflessione sia per descrivere lo stato dell’arte in tema di AI e potenziali pericoli: la possibilità ormai alla portata di tutti, di poter installare un sistema di AI in locale sul proprio computer a poter poi agire in modo “totalmente” anonimo e senza filtri (almeno per i più smanettoni).
Abbiamo quindi chiesto a ChatGPT di analizzare questa tipologia di utilizzo e descriverne le insidie.
Utilizzare un sistema di Ai in locale sul proprio computer
1. Proprietà e controllo dei dati sensibili
Installare e gestire internamente un modello IA significa disporre di capacità avanzate di elaborazione sui dati, ma anche di responsabilità critica. Un utente malintenzionato può sfruttare il modello per:
• Estrazione di informazioni riservate: attraverso tecniche di “prompt injection” o di reverse engineering del modello, si possono carpire dati
sensibili presenti nei prompt o nel training set locale.
• Esfiltrazione automatizzata: script malevoli possono orchestrare volumi massivi di query per sondare il comportamento del modello e raccogliere in output informazioni aziendali o personali.
2. Creazione e diffusione di deepfake
I modelli di generazione audio/ video open source (ad esempio, Stable Diffusion o modelli TTS avanzati) consentono di produrre video realistici o voci sintetiche di personaggi pubblici e privati, aumentando il rischio di:
• Disinformazione mirata: video falsi veicolati sui social media possono manipolare opinioni pubbliche o influenzare processi elettorali.
• Estorsione e ricatti: deepfake espliciti utilizzati per minacciare vittime o diffondere contenuti compromettenti.
3. Automazione di attacchi informatici
Un AI locale potente e personalizzabile dà a un hacker la possibilità di:
• Phishing su larga scala: generazione di e-mail o messaggi estremamente credibili, ottimizzati per target specifici, con linguaggio naturale e toni personalizzati.
• Analisi di vulnerabilità automatica: integrazione con tool di scansione per produrre report più rapidi e suggerimenti di exploit, riducendo i tempi di scoperta delle falle.
4. Evasione dei controlli di sicurezza
Le implementazioni open source spesso mancano dei rigidi “safeguard” presenti nei servizi cloud proprietari:
• Filtri di contenuto aggirabili: senza meccanismi centralizzati di aggiornamento, un aggressore può modificare direttamente il codice per rimuovere vincoli etici o di policy.
• Assenza di monitoraggio e logging centralizzato: rende più difficile rilevare attività sospette, soprattutto in ambienti distribuiti o
offline.
5. Proliferazione e diffusione non autorizzata
Il rilascio su GitHub o altre piattaforme di codice aperto favorisce la replicazione e la modifica dei modelli:
• Fork incontrollati: ogni clone può evolvere con nuove funzionalità malevole, moltiplicando le varianti di minaccia.
• Distribuzione via peerto-peer: strumenti di condivisione decentralizzata permettono di scambiare rapidamente intere reti neurali e set di dati addestrati per fini illeciti.
Senza entrare adesso nel dettaglio di come poter installare un sistema di AI sul proprio computer domestico o di lavoro, magari ne tratteremo in dettaglio prossimamente, quello che segue è un elenco di tecnologia hardware e software necessari allo scopo per darvi l’idea di quando sia accessibile già oggi crearsi AI personal System (sia online che offline).
Hardware
• Processore (CPU):
• Minimo: quad-core moder-
no (es. Intel i5/Ryzen 5)
• Consigliato: 6–8 core per prestazioni migliori
• Scheda video (GPU):
• Necessaria per modelli di grandi dimensioni
• NVIDIA con supporto CUDA (VRAM ≥ 8 GB; ideale ≥ 12 GB)
• Memoria RAM:
• Minimo: 8 GB
• Consigliato: ≥ 16 GB
• Spazio su disco:
• 10–20 GB per pesi modelli e dipendenze (SSD preferibile)
• Sistema di raffreddamento:
• Ventole o dissipatori adeguati per carichi prolungati
Software
• Sistema operativo:
• Linux (Ubuntu, Fedora) o Windows 10/11
• Ambiente Python:
• Python 3.8+
• Virtualenv/venv o Conda per isolare le dipendenze
• Librerie ML/DL:
• PyTorch (con supporto CUDA, se GPU)
• Transformers (Hugging Face)
• (Opzionale) TensorFlow, bitsandbytes per quantizzazione
• Driver e tool GPU (se applicabile):
• NVIDIA Driver + CUDA Toolkit (versione compatibile con PyTorch)
• cuDNN
• Strumenti aggiuntivi:
• Git (per clonare repository)
• Docker (per containerizzazione e isolamento)
• wget/curl (per scaricare modelli e dati)
Non scoraggiatevi se leggendo questa lista finale non riuscite a comprendere alcuni nome di tecnologia HW e SW, sappiate sempre che man mano che andremo avanti, con balzi da leone, questi metodi e possibilità saranno sempre più alla portata di tutti e integrati per default nei device personali quotidiani.
Colloquio avvenuto il 06 luglio 2025

Da oltre 40 anni crediamo nell’intelligenza. E negli ultimi 15 anni abbiamo investito nella progettazione di piattaforme di interpretazione di flussi di dati sempre più complessi da cui trarre stimoli e segnali per cercare di comprendere il presente e anticipare il futuro per i nostri clienti.
Ma abbiamo continuato a ritenere fondamentale l’istinto, il pensiero laterale e qualche volta la visionarietà dell’umano intelletto.
Per questo crediamo fermamente nella IA. L’Intelligenza Animale.
grupporoncaglia.it
L’agricoltura è una impresa circolare e autarchica
Nei pressi di Castel del Monte, alle pendici dell’Altopiano delle Murge, sorge l’azienda agricola di Giancarlo Ceci. Nel 1988, Giancarlo Ceci, memore della tradizione agronomica dei suoi avi, sotto il marchio Agrinatura, converte l’intera attività produttiva al metodo di coltivazione dapprima biologico e, successivamente biodinamico. Il fine ultimo è quello di rispettare e rappresentare la natura, in modo tale da garantire la massima qualità dei prodotti agricoli, a partire dal vino. Lo abbiamo incontrato.
Cosa l’ha spinta a questa scelta?
Avvenne nell’anno in cui mi sono laureato come enologo all’Università di Bologna, una volta tornato a casa, all’azienda di mio padre, un’azienda che allora era in uno stato di semi abbandono, perché non aveva intenzione di fare miglioramenti fondiari negli anni 80.
Era sfiduciato dall'aumento dei costi, dall'arrivo della globalizzazione e quindi aveva fermato tutte le attività. Fu molto contento che io, al contrario, fossi molto stimolato, amavo ed amo la natura, fin da piccoli e viverla quotidiamente, come avevo vissuto sempre l’azienda. Il paradosso è stato aver intrapreso la strada del biologico pur avendo imparato esattamente il contrario. Perché all'università ho imparato chiaramente a spingere le produzioni

in tutti i modi possibili. Il perché della scelta sta proprio in quell'infanzia vissuta in azienda che mi ha formato in un legame con la natura particolarissimo, che mi porta avanti per tutta la vita.
Qui abbiamo un bosco di 100 ettari in azienda, proprio nella casa familiare che confina con tutta l'attività produttiva. E io lì dentro mi perdevo, era il mio parco giochi, diciamo. Ho vissuto delle esperienze molto forti che mi hanno fatto scegliere la strada del biologico perché quella per me era la strada di una ricerca, di un lavoro in armonia con la natura che potesse portare fuori al massimo la qualità del prodotto, piuttosto che l’azienda.
L'azienda di suo padre già produceva
le diversità di prodotti che attualmente produce lei, cioè dal pomodoro al vino, o lei ha introdotto alcuni elementi?
No, mio padre produceva, come anche i suoi predecessori, olive che trasformavano anche in olio avendo degli stabilimenti di trasformazione. Ma non hanno mai messo in bottiglia il prodotto. Hanno sempre venduto, lo stesso dicasi per il vino. E poi sono venuti i cereali.
Gli ortaggi sono stati una mia iniziativa, come il pomodoro, anche gli ortaggi invernali. Mi piace molto coltivare gli ortaggi in virtù del fatto che hanno una loro dinamicità completamente diversa da quella del vino o dell'olio. Non sono paragonabili ovviamente, sono due cose completamente diverse, sono due modi diversi di vivere la natura, mi affascinano tutte e due e le ho percorsi tutte e due. Io ho voluto un’azienda che fosse equilibrata anche dal punto di vista delle quantità delle varie produzioni, perché sinergiche tra loro e chiudere il ciclo all'interno dell'azienda stessa. Ne è motivo l’allevamento di bestiame, perché anch’esso interviene nella circolarità produttiva
. Lei ha costruito un sistema di circolarità che è tra gli aspetti che mi ha colpito di più: si parla sia di economia circolare ma anche di processi biologici e naturali circolari, le hanno riconosciuto la carbon neutrality, che è il fatto di riuscire a compensare la produzione di CO2 che l’azienda im-

mette nell'ambiente durante la produzione. Ha voluto un impianto fotovoltaico che le permettesse di ridurre il consumo di energia assicurandosi il più possibile che fosse rinnovabile. Considera tutto questo più biologico o biodinamico?
Fa parte dell'idea di circolarità del biodinamico più che del biologico perché si riferisce ad una filosofia di produzione che prevede l'utilizzo di tutte le risorse aziendali all'interno dell'azienda stessa. I nostri impianti alimentano tutti gli usi energetici dell'azienda.
Adesso poi con la nuova tecnologia dello stoccaggio dell'energia riusciremo a essere completamente, entro i prossimi due anni, autonomi. Eviteremo prelevare energia durante la notte dalla rete esterna, perché potremmo usare le batterie, accumulando durante il giorno l’energia prodotta in eccesso e questo sarà un ulteriore grande risultato.
Sarete totalmente autosufficienti a quel punto?
Sì, anche nell'irrigazione, che è peraltro cosa molto equilibrata. Anche le sostanze organiche di scarto della nostra azienda vengono tutte riutilizzate e valorizzate all'interno dell'azienda stessa.
E questa è una parte della filosofia biodinamica?
Esatto, sì. Faccio un esempio. Produ-
ciamo un gran quantitativo di verdure che vengono lavorate e preparate per il consumatore finale, quindi in unità da un chilo, o mezzo chilo all'interno delle casse. Tutti gli scarti vegetali, che sono il 30 al 40% del peso della verdura raccolta, sono impiegati per alimentazione degli animali stessi. L'eccesso, perché sono di più ovviamente, viene utilizzato per fare concime con in aggiunta le vinacce dell'uva, i raspi dell'uva o anche i pomodori di scarto durante la lavorazione del pomodoro. Viene tutto aggiunto a una base importante che è il letame del bovino e dato che non è sufficiente il letame delle nostre vacche, abbiamo un accordo con un altro allevamento bio da cui prendiamo altro letame. Ad oggi siamo quasi autosufficienti dal punto di vista del concime e della concimazione, arriviamo all'80% del nostro fabbisogno fatto in azienda. Questo fa parte del concetto di circolarità dell'azienda.
Dei vostri vini ho assaggiato sia la linea “standard” che la linea biodinamica, che niente ha a che fare con una cultura biodinamica per la quale il vino si fa da se. Ho avuto l'impressione che la frase “si fa presto a dire biodinamico” sia ben collegabile alla sua filosofia, perché lei ha la filosofia di fondo, ma poi fa un lavoro che prevede investimenti importanti. Perché i prodotti non hanno niente a che fare con “fare tutto da solo”.
No, no, gli investimenti sono importantissimi perché io ho sempre avuto
l'idea di fare tutto ciò che è in armonia con la natura e seguire la natura in assoluto, perché sono convinto che la qualità del prodotto sta proprio così com'è nel campo. So bene che la qualità sta lì e non sta nei processi di trasformazione e di manipolazione del prodotto. Per fare la qualità bisogna preservare tutte le qualità durante la trasformazione e per fare questo servono delle attrezzature molto importanti e serve anche una conoscenza di dove sta il pericolo di perdere la qualità della materia prima. Nel caso del vino, il freddo, le contaminazioni con l'ossigeno, e quindi tutte le attrezzature che ho impostato sono state volte a preservare questa materia prima. Ma nel caso del vino è stato fondamentale per me, grazie a Luca Maroni, l'incontro con Lorenzo Nandi alla fine degli anni 90, quando ebbi l'idea di aggiungere, all'olio e agli ortaggi, anche il vino. Luca Maroni si disse interessato dal mio progetto perché chiaramente gli parlavo di naturale, di biologico e biodinamico.
E lui mi disse che dovevo conoscere un enologo che avesse la mia stessa filosofia e mi presentò Lorenzo Nandi. E lì fu una grandissima fortuna per me, perché se non avessi incontrato lui non sarebbe stato possibile impostare, fino dall'inizio, una cantina che è ancora pienamente operativa, che è una cantina moderna, controllata nelle sue temperature in automatico da un computer, che ha una serie di serbatoi tantissimi, piccoli, bassi e larghi, che ci consentono di dividere le varie partite, ma ci consentono

di controllare in maniera perfetta le temperature, non solo, ma anche le saturazioni e tutto ciò che serve per arrivare a fare un prodotto di qualità, che non abbia difetti, e questo per me è fondamentale in tutte le filiere di produzione che io porto avanti, e per questo servono molti investimenti. E questa è una grande qualità.
Sono un amante del pomodoro, voi fate il pomodoro, dalla coltivazione al prodotto finale?
Se lei adesso viene in azienda, troverà circa 40 ettari di oliveti consociati con il pomodoro. Sono filari larghissimi, 12 metri fra un albero e l'altro, all'interno dei quali abbiamo tre filari di pomodoro. C’è poi il magazzino di trasformazione all'interno dell'azienda, dove c'è la cantina, dove c'è l'oleificio e quindi tutta la trasformazione avviene a brevissima distanza: raccolto e trasformato velocemente. Anche qui non aggiungiamo nulla. L’acido citrico per esempio non è aggiunto alle nostre salse, ai nostri sughi. La lavorazione va da fine luglio fino più o meno a ottobre. È stato un investimento importante perché sono catene di lavorazione che hanno una tecnologia di uso di basse temperature: la nostra passata di pomodoro la produciamo in pentole che abbassano la pressione atmosferica, in pressione negativa, quindi abbassano il punto di ebollizione dell'acqua. Da 100 gradi lo abbassiamo a 60 gradi, quindi la concentrazione, l'evaporazione dell'acqua del pomodoro avviene a bassa temperatura e questo consente

di mantenere tutte le qualità organolettiche del pomodoro e la qualità anche del contenuto di antiossidanti all'interno del pomodoro. In sostanza è come se noi mettessimo in bottiglia un pomodoro fresco che però ha subito tutti i trattamenti termici di trasformazione per la conservazione. Sul nostro processo di trasformazione è stato anche avviato e concluso un processo di brevetto in collaborazione con l'Università di Foggia, che ha studiato i contenuti di questo processo rispetto ad'altri, ed è stato ottenuto un brevetto nazionale ed europeo.
Dovrò sicuramente provarla, è una domanda. Visti gli investimenti che lei ha fatto in azienda, i conti tengono?
I conti tengono. Per quanto riguarda il vino, i nostri clienti sono per l'80% sempre esteri, svizzeri e tedeschi soprattutto, ma anche austriaci, olandesi, inglesi, che valorizzano bene questa produzione, nel senso che consentono di vendere il prodotto a un prezzo remunerativo, anche se la globalizzazione si sente anche in quella nicchia di mercato che noi andiamo a coprire. La crisi si sente, però devo dire che possiamo dirci soddi-

sfatti, il nostro concetto è sempre stato quello un po' slow food, anche per quanto riguarda il vino. Infatti in slow wine siamo molto riconosciuti, anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Ce ne sono tanti di vini molto costosi, che però secondo me non hanno una giustificazione intrinseca del prodotto del costo, sono costi relativi al marketing, questo accade anche nella moda, e certe volte un pezzo di stoffa costa 1000 euro e ne vale 10.
Mi auguro sempre che si diffonda sempre più la cultura del sapere, del conoscere, di tutto ciò che noi mangiamo in generale, perché questo porterà sicuramente il consumatore a scegliere bene. Questo è un tema molto importante in quella frenesia esistenziale che non ci fa fermare a riflettere. Auguro che questo migliori nel tempo.
Non hai tempo per leggerlo?
Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza

Tra Nettuno e Anzio c’è di mezzo il Cacchione. Può sembrare una battuta ma è una realtà. Il Cacchione è un vitigno biotipo del Bellone, che troviamo diffuso in tutto il territorio laziale e in particolare nella zona dei Castelli Romani. Ma il Cacchione ha un elemento che lo contraddistingue e lo riconduce ad una zona circoscritta della Regione Lazio, il litorale tra Nettuno e Anzio.
Il Cacchione infatti, come spiega Roberto De Saverio, sommelier FISAR, che ci sta facendo da cicerone in questo excursus nel litorale sud della regione, rappresenta un vitigno storico, già citato da Plinio il Vecchio su Naturalis Historia e che grazie al territorio dove è stato
coltivato ha potuto resistere all’aggressione della filossera e quindi potersi fregiare del “titolo” a “piede franco”, senza cioè l’innesto sulla talea di una vite americana.
L’importanza di questa qualità qualche anno addietro aveva mosso la Cantina Bacco e la cantina Divina Provvidenza a promuovere la DOVI, la Denominazione di Origine Vitigni Italici, che fu presentata nel 2022 al Nettuno Wine Festival e che ricomprendeva diversi vitigni sparsi in tutta Italia che potevano pregiarsi di quella peculiarità, il piede franco. Dalla valle d’Aosta alla Sicilia. E se il Bellone trova la sua esistenza e vigoria nella grande caldara rappresentata dal lago di Albano e da

tutta l’area dei Castelli Romani, il Cacchione gode del terreno sabbioso del litorale di Anzio e Nettuno e di un clima che vede brezza marina e scarsa escursione termica.
E che Anzio rappresenti un territorio importante per le sue peculiarità in vigna lo dimostra la scelta di una cantina come casale del Giglio che ha fatto del rilancio della viticoltura del basso Lazio un elemento qualificante del suo percorso imprenditoriale. Casale del Giglio a questa realtà ha dedicato un vino che si chiama Anthium che è coltivato proprio a due passi dalle cantine sopra citate.
E quando si arriva alla Cantina Bacco è il termine Cacchione che prevale, accanto a scelte di vitigni internazionali, scelte che caratterizzano tutta la regione. Il loro prodotto di punta l’hanno chiamato Pantastico, un Nettuno Doc realizzato con questo storico vitigno in purezza.
Una passeggiata al mare e una visita in cantina…

Giornata dedicata alle bollicine metodo classico quella organizzata dal Consorzio dell’Alta Langa nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma. Una B2B destinata agli operatori e alla stampa di settore, per una bollicina che ha un grande passato e un’importante espansione.
Il territorio dell’Alta Langa si trova in realtà nel sud del Piemonte, al confine con la Lombardia, la Liguria e l’Emilia Romagna. È abbracciato dalle colline di Alessandria, Asti e Cuneo, dove Chardonnay e Pinot Nero hanno trovato, fin dall’800 un habitat ideale, tra pascoli, frutteti e filari di viti.
Una tradizione raccolta dai francesi, quella del metodo classico, resa importante inizialmente con il Moscato, vitigno caratteristico del territorio di Asti, per poi raffinarsi nei vitigni sopracitati, Pinot Nero e Chardonnay, i vitigni base dello champagne.
Ma se conosciamo diffusamente realtà come l’Asti spumante, è nell’ultimo decennio che l’Alta Langa si è caratterizzata per una produzione di metodo classico innovativa e di grandissima qualità, così da divenire concorrenziale al Franciacorta o al Trento Doc.
Hanno contribuito alcune scelte di sistema, come per esempio prevedere nel proprio disciplinare la
sola versione millesimata, ovvero con vendemmie della stessa annata, come avviene per i vini fermi, mentre è opzionale negli champagne e nei metodi classici. Lo champagne infatti nasce come cuvée di diverse annate e diversi vitigni, ed è frutto di un sapiente dosaggio, la ricetta segreta che lo rende unico. Ma le ricette possono essere tante e caratterizzate da elementi diversi: il territorio, l’enologo, la passione del viticoltore, oltre l’uva, sono elementi fondamentali di una ricetta che punta alla perfezione. Nel nostro viaggiare tra i banchi d’assaggio ci siamo “incontrati” con

aziende che sono realtà storiche nell’ambito della produzione di vino in Piemonte, la regione che ha più Docg in Italia, bel 19, con 6 di queste che riguardano solo il Nebbiolo, e che tra Barolo e Barbera, Roero e Erbaluce, hanno scelto di dedicare un po’ di attenzione a quei vitigni, Pinot Nero e Chardonnay, propri della Champagne e della Borgogna, che però in quel territorio hanno trovato una nuova patria.
Tra queste Terre di Barolo https:// terredelbarolo.com/, una cooperativa nata nel 1958 che rappresenta le trecento aziende che si dividono un territorio estremamente ridotto e che comprende appena 11 comuni. Hanno due versioni, anzi tre con la riserva: una chardonnay in purezza (che poi diviene riserva) e un blanc de noir all’85% Pinot Nero.
Mi ha colpito Tenuta Langasco d’altronde se guardate la foto potrete capire perché. L’azienda non è giovane, è nata nel 1979, loro sono giovani, lui enologo lei laureata in economia aziendale sta per specializzarsi in marketing per poi dedicarsi allo sviluppo dell’azienda. Dal punto di vista delle bollicine anche come azienda sono giovani, pochi ettari per poche bottiglie, mettendo in questa lavorazione tutta l’esperienza di tanti anni di vino fermo.
Chiudo con Agricola_TT, azienda nuovissima, appena 2019. Una storia che sa di sfida. Proprietari di vigneti li davano in affitto ad altri produttori. Nel frattempo avevano realizzato un agriturismo con obiettivi molto concreti e per questo limitati. E alla fine però è andata bene e si sono chiesti se aveva senso vendere bollicine altrui quando avevano i vigneti per produrlo autonomamente. Oggi si appoggiano, per la vinificazione e i successivi processi, alle cantine che un tempo affittavano i loro terreni, nel frattempo è in costruzione la loro cantina.
Non potevo parlare di tutti, perché tutte le cantine del consorzio meritano, poi possono piacere più o meno, dipende dal gusto: ma produrre vino, produrre spumante, non è realizzare una mera bevanda, ma un’opera complessa fatta di cultura, passione, appartenenza … e che deve il più possibile messa nella disponibilità di essere conosciuta da tutti.


Che la religione cristiana abbia da sempre avuto a che fare con il vino è cosa risaputa: dalle Nozze di Cana all’Ultima Cena, il vino ha sempre avuto un ruolo importante, tanto da diventare un elemento portante della liturgia cattolica. Ma cosa leghi il Papa al vino è meno risaputo. Papa Bergoglio ha sempre sottolineato il valore del lavoro della terra e dei suoi frutti e, come ricorda il quotidiano La Repubblica, dal nome della sua enciclica più importante, Laudato Sì, è nato il progetto Borgo

Laudato Sì: sulle sponde del lago di Albano, non lontano da Castel Gandolfo, un pool internazionale sta creando una fattoria moderna di 55 ettari, 35 di giardino e 20 di vigna. Per quest’ultima la prima vendemmia è prevista nel 2027.
E d’altronde i Castelli Romani han-
no sempre garantito la fornitura del vino ai Papi che dimoravano a Roma. Non è quindi un caso che fin dal XIII secolo alla corte del Papa esisteva la figura del Bottigliere, che selezionava i vini da mettere sulla tavola del Papa e dei suoi collaboratori, e di una Cappellania che distribuiva alimenti ai poveri e ai pellegrini bisognosi. Sia la Bottiglieria che la Cappellania avevano bisogno di vino in grandi quantità, ma la differenza di qualità era ovviamente enorme.
Tra i bottiglieri più importanti il precursore del mestiere di sommelier, Sante Lancerio, che nel XVI secolo prestò il suo operato per Paolo III, al quale si deve una delle guide ai migliori vini d’Italia più antiche della storia: in questa opera Sante Lancerio ricorda la passione del Papa per la vernaccia di San Gimignano, per il rosso umbro Sucato, per il rosso di Canale Monterano nel Lazio, come anche per l’Orvieto.
Quelle appena citate non sono le sole testimonianze della buona considerazione che avevano i Papi per il vino, considerato fino ai nostri giorni più un cibo che una bevanda. Di Bonifacio VIII si narra che, essendo di Anagni, amasse il Cesanese del Piglio, e fu alla sua morte che il papato si trasferì ad Avignone, dando vita, nei 100 anni di presenza in quella zona della Francia, ad una
svolta per quella parte di territorio. Grazie all’impegno dei Papi e al loro investimento finanziario e culturale per promuoverne la viticoltura, la zona di Chateneuf-Du-Pape, il castello nuovo del papa, e la denominazione eponima, è oggi conosciuta e apprezzata nel mondo sia in rosso che in bianco.
Come detto, di aneddoti nella storia dei Papi legati al vino ve ne sono molti, ma tornando a Papa Bergoglio è necessario anche ricordare le origini dei suoi nonni, tra l’alta Liguria e il basso Piemonte, la zona di Alessandria, nel Monferrato, per capire, ad esempio, cosa ha spinto tre giornalisti, Giacomo Fasola, Ilario Lombardo e Francesco Moscatelli a scrivere un romanzo con protagonista la famiglia di Papa Francesco e il Ruché di Castagnole di Monferrato, di cui abbiamo scritto recentemente: uscito nel 2015, a poca distanza temporale dall’elezione al Soglio Pontificio di Jorge Mario Bergoglio, il romanzo si intitola Il vino del papa. L'avventurosa storia del Ruché e il mistero della bottiglia scomparsa, Compagnia Editoriale Aliberti.

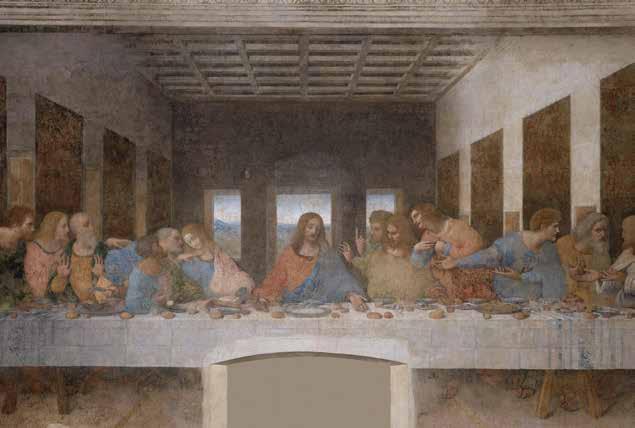

Frascati città del vino 2025. A conferire tale titolo al capoluogo dei Castelli Romani, dodici realtà che sorgono sulla grande caldara della zona di Albano, vulcano quiescente ma ancora attivo, che conferisce il terroir ideale per la viticoltura, l’Associazione Nazionale Città del Vino, istituita a Siena nel 1987.
In tale occasione la rivista il Gambero Rosso ha auspicato che tale riconoscimento sia una buona occasione perché i produttori del vino laziale riescano finalmente a sconfiggere quella nomea che il vino “de li castelli” ha da decenni, il vino da “fraschetta”.
In effetti per anni, soprattutto nel secondo dopoguerra, la grande capacità produttiva dei vigneti dei Castelli è stata improntata sulla quantità più che sulla qualità. Una realtà comune a quasi tutte le regioni. Il vino è sempre stato considerato un alimento più che una bevanda e tutt’oggi definirlo una bevanda tout-court risulta improprio se non limitante.
La realtà è che negli anni ’70 e ’80 alcune regioni compresero l’importanza di una produzione di qualità, non elitaria, ma distinguibile. Non è un caso che il Piemonte abbia 19 Docg, il Veneto 14, la Toscana 11. Il Lazio ne ha solo 3. Tante Doc ma
solo 3 Docg. Due dei Castelli: il Frascati Superiore Docg e il Cannellino di Frascati, un vino dolce.
Rappresenta quasi un paradosso se pensiamo quanto i Romani antichi abbiano influito nella conoscenza del vino e del suo affinamento. La coltivazione della vite ha origini in oriente e nella nostra penisola furono i greci ad introdurre la produzione di vino, gli etruschi furono i primi ad affinarla, ma si deve ai Romani la produzione di vino in Europa, furono loro a portare le viti a Bordeaux, sulla Loira, in Borgogna, come ci ricorda l’autore dell’Atlante del Vino, Hugh Johnson. E sempre ai romani va attribuito l’uso della botte di legno. E il vino sapeva invecchiare: Hugh Johnson ci ricorda di come il «pregiatissimo Opimiano (dall’anno del consolato di Lucius Opimius, 121 A.C.) si bevesse ancora dopo 125 anni di invecchiamento».
E in effetti Roma è caratterizzata nella sua storia dalle vigne. Basta guardare la mappa della Capitale: Vigna Clara, Vigna Murata, Via delle Vigne etc… La vite veniva coltivata anche dove erano i palazzi del potere dell’antica Roma, il Palatino. Quel vigneto è tornato produttivo e affidato alle cure del consorzio di Cori su volontà del Parco Archeologico, ovviamente non a fini commerciali.
E non c’è soluzione di continuità tra Roma e i Castelli. Ovviamente la produzione si è spostata fuori dalla città, ma a cominciare dal Parco dell’Appia Antica.
Oggi la realtà del vino del Lazio si è modificata. Per il contributo delle nuove generazioni, ma anche e soprattutto per il contributo di molte donne imprenditrici. E il “Frascati” di pronta beva, quello che ci aspettiamo culturalmente, si accompagna oggi a Frascati invecchiati, da apprezzarsi dopo oltre un decennio di affinamento. “Frascati Città del Vino 2025” e le diverse iniziative che caratterizzeranno i Castelli Romani e non solo, durante questo anno, saranno l’occasione per prenderne coscienza.
Non hai tempo per leggerlo? Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza
Lo spunto ce lo dà un volume dedicato all’abbinamento tra pizza e vino, Calici&Spicchi ad opera della giornalista e sommelier Antonella Amodio, edito da Malvarosa, pubblicato la prima volta lo scorso anno e ora in uscita con una nuova edizione più ampia che riguarderà anche delle realtà all’estero.
Il volume, che sicuramente offre spunti per abbinamenti decisamente interessanti, permette di

affrontare un tema, quello dell’accoppiata pizza e birra che diamo assolutamente per scontato, come se esistesse da sempre.
È vero che secondo alcuni studi gli egiziani antichi usavano una be-

vanda fermentata che poteva essere all’origine della birra e che il pane ha sicuramente trovato la sua prima dimensione sempre in oriente circa 30.000 anni fa, ma spesso associamo comportamenti sociali e gastronomici ai primordi della civiltà umana, quando invece sono realtà assai più recenti.
Abbiamo detto della carbonara, come questa sia nata alla fine della guerra, dalla fantasia di unire quel poco che si aveva per creare nuovi piatti con cui sfamarsi.
L’abbinamento birra e pizza è addirittura un poco più giovane. Risale al boom economico quando i piccoli pizzaioli ottennero in massa la licenza per vendere alcolici di bassa gradazione, come è appunto la birra, supportati dalle aziende produttrici, all’epoca prevalentemente se non esclusivamente italiane, che videro in quella novità un elemento fondamentale per espandere il mercato della birra, fino a quel momento non così diffuso.
E così in pizzeria troviamo normale avere qualche alternativa nella scelta della birra e una carta dei vini piuttosto ridotta e poco attinente al prodotto. Ci sono le eccezioni ovviamente. Il paradosso è che mangiare pizza bevendo birra ha effetti sul nostro fisico da non sottovalutare. L’accoppiata, infatti, di questi due prodotti da cereali comporta un aumento degli zuccheri e del picco glicemico che a lunga andare può essere dannoso. Sia chiaro, birra e pizza legano tra loro come gusto, ma non vuol dire che un bicchiere di vino non possa portare ad un risultato uguale. Di sicuro è un costume recente che ha nel marketing, come spesso succede, il suo principale fautore.
Come la pinsa romana. Sembra che ci conviviamo da sempre, eppure è apparsa sulle nostre tavole solo a partire dagli anni ’90, ad opera di un ristoratore che ha messo insieme diverse farine, alcune non glutiniche, e il verbo latino “pinsere”,
pigiare, ha fatto il resto.
Rimanendo nel settore della panificazione un altro aspetto che negli ultimi anni caratterizza gli scaffali della grande distribuzione sono i cosiddetti grani antichi, rigorosamente macinati in pietra, a partire dalla pasta “Senatore Cappelli”. Ottima pasta, viene solo da chiedersi cosa intendiamo per antico. Il grano attribuito al Senatore Cappelli non ha nulla a che fare con lui. Ha origine da un grano duro di origine algerina, "Jeanh Rhetifah", che l’agronomo e genetista e senatore del regno d’Italia Nazzareno Strampelli incrociò con altri grani con l’obiettivo di aumentarne la produzione e che dedicò al collega Senatore Cappelli che gli aveva messo a disposizione per i suoi studi la sua tenuta di Foggia.
Questo grano fu esportato in varie parti del mondo e in Italia fu prodotto fino al 1975, produzione poi ripresa a partire dagli anni ’90. E non ha un singolo produttore, è un tipo di grano. Dalla grande capacità riproduttiva.
L’unica cosa antica che possiamo essere sicuri esista nel mondo della panificazione è la panificazione stessa ed è lecito presumere che il primo processo di lievitazione sia nato per caso, quando qualche “antico”, migliaia di anni fa, dimenticò di mettere a cuocere l’impasto appena fatto per accorgersi il giorno
dopo che veniva più morbido. Antico è sicuramente il sostantivo “farina” che viene dal latino farina, da far, farro. E alla farina, al processo per ottenerla, è anche legata la simbologia del nome dell’Accademia della Crusca.


Il vino Lugana alla conquista della Capitale. Terza edizione della manifestazione dedicata al Turbiana, il Trebbiano di Lugana dall’omonima località in provincia di Brescia, e alle cantine sul Lago di Garda che danno vita a questo vino dalla notevole generosità in degustazione. Manifestazione organizzata dal Consorzio Lugana Doc
Nella splendida cornice del giardino di Palazzo Brancaccio, nel cuore della Capitale, si è svolta la terza edizione della manifestazione enologica dedicata al vitigno Turbiana, il trebbiano di Lugana che grazie al Lago di Garda e al suo microclima, ha guadagnato una doc dedicata divisa tra la Lombardia e il Veneto, al pari del Lago che ne rappresenta il territorio di appartenenza.
All’evento, che ha fatto il pieno di visitatori, hanno preso parte oltre 40 cantine e oltre 100 etichette, dalle più rinomate e blasonate, alle giovani realtà emergenti.
«Portare il Lugana a Roma, nella cornice suggestiva di Palazzo Brancaccio, indica molto più che presentare un vino: significa raccontare un territorio che ha saputo fare della qualità, della sostenibilità e dell’accoglienza i suoi valori fondanti. ‘Armonie senza tempo’
è un invito a scoprire non solo la bellezza del Garda e la ricchezza della nostra denominazione, ma anche un modo di vivere che mette al centro l’essenza del tempo, il piacere dell’incontro, la cultura del benessere. Il Lugana è questo: un ponte tra luoghi, persone e storie» ha commentato Fabio Zenato, Presidente del Consorzio Lugana.
Anche se il disciplinare di produzione prevede la presenza di vitigni complementari a bacca bianca, purché non aromatici, per una quota del 10%, oggi i produttori della zona tendono a fare i loro Lugana esclusivamente con uva Turbiana in purezza, declinandolo in ben cinque diverse tipologie: il Lugana base, il Superiore, la Riserva, la Vendemmia Tardiva e lo Spumante.
Un vino che accompagna ai sentori di agrumi, a seconda della tipologia, mineralità ed acidità ma anche mandorla e pietra focaia. Ma oltre i sentori, la gradevolezza di questo vino, in tutte le sue tipologie, è il territorio rappresentato che si dispone per essere uno dei percorsi dedicati al vino più apprezzabili, come possono essere solo le coste del Lago di Garda e i paesaggi che lo contraddistinguono. Una manifestazione che andava vissuta, ma che non si perde nelle vie di Roma,
perché permane in quelle di Peschiera del Garda, di Desenzano sul Garda e ovviamente di Lugana.







SONO DISPOSITIVI MEDICI 0373
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 06/08/2024


Fondare una casa editrice nel 2025? Ma siete matti? Non sapete che il libro sta morendo, che i giovani non leggono più, che rimanere concentrati per più di 6 secondi è sempre più raro in generale? Nella lettura, poi...
Questo è quanto chi ha fondato Faros edizioni spesso ha letto nei pensieri di quanti venivano a conoscenza della nascita di una nuova casa editrice, e soprattutto della sua linea editoriale.
Ma Flavio Sorrentino e Marina Guglielmi rimangono convinti del fatto che il libro, come oggetto tecnologico capace di trasportare informazioni complesse nello spazio e nel tempo e di farle arrivare al fruitore efficacemente, sia lontano dall'esalare l'ultimo respiro.
E sono convinti anche che un certo tipo di complessità viva meglio nell'oggetto libro, che favorisce la concentrazione, l'isolamento quando serve, ma anche la condivisione delle emozioni e dei pensieri suscitati dall’immersione nelle pagine (si pensi al successo dei gruppi di lettura).
Faros è nata da Flavio Sorrentino, che ha lavorato per 10 anni nel campo della saggistica e poi per 15 anni nel campo della produzione editoriale ad Alta Leggibilità per bambini e ragazzi con difficoltà di lettura, e da Marina Guglielmi, docente di Letteratura comparata e di Editoria all'Università di Cagliari.
“Il nome Faros non vuole richiamare l'immagine – pretenziosa – del faro che illumina e guida” dicono, “ma è il nome di un piccolo porto greco di pescatori che si trova a Sud di un'isola delle Cicladi, Sifnos – Sifanto, quando era occupata dai veneziani. È un porto sicuro dalle raffiche del Meltemi che lì soffia forte. Abbiamo pensato a Faros, nelle tempeste che a volte ci sorprendono, in mare e a terra, come il luogo sicuro in cui trovare – e fermarsi a leggere – quel buon libro che cercavamo. Fino alla prossima partenza”.
Il progetto editoriale prevede al momento due collane: Sandbox, dedicata a saggi informati e godibili sui videogiochi, su quel fermento di mondi possibili che sono al tempo stesso gioco, cultura e professionalità e Teen Spirit, che propone romanzi di qualità per adolescenti e giovani adulti che affrontano la sessualità, il desiderio e le fantasie senza falsi pudori o moralismi, e vuole essere un'alternativa ai dark romance.
In un mondo di giganti che tendono a occupare tutto lo spazio disponibile, una piccola casa editrice come Faros può solo percorrere strade nuove, finora inesplorate. È vero che i libri sui videogiochi non mancano, ma una collana interamente dedicata ai videogiochi come Sandbox - con una direzione editoriale di esperti e un comitato scientifico
- invece manca. L'università italiana, diversamente da quelle nordeuropee e americane, è in ritardo, mancano i corsi dedicati ai videogiochi (e i ragazzi e le ragazze che vogliono studiarli si devono affidare a realtà private). Ma Faros è convinta che tra poco arriveranno anche in Italia, e che pubblicazioni scientifiche e divulgative tradotte dalle collane più prestigiose americane o inglesi, come Playful Thinking dell'MIT, diretta da nomi noti quali Jesper Juul, Geoffrey Long, William Uricchio e Mia Consalvo saranno d'aiuto sia a chi insegna che a chi impara.
Anche l'altra collana, di narrativa, vuole percorrere una strada inesplorata. Finora, infatti, la letteratura per ragazzi ha tenuto fuori la sfera della sessualità, come se ragazze e ragazzi dovessero diventare almeno young adult per accedervi. Teen Spirit, invece, mette il piede nella pozzanghera e sceglie testi che raccontano – lontano dagli stereotipi – scoperte del corpo, contatti, prime volte, molestie, e parlano liberamente di sessualità, di desiderio e di fantasie.
Flavio Sorrentino ha lavorato per anni in case editrici romane, prima nella saggistica, poi nella letteratura per ragazzi. In Faros unisce le sue due anime e competenze.
Marina Guglielmi ha lavorato in alcune case editrici a Roma, oggi fra le materie che insegna all’università di Cagliari l’editoria è la sua preferita.
Leonardo Sorrentino insegna e fa ricerca in Game Design all’università di Tallinn. Realizza videogiochi con il gruppo Scale Issue.
Chiara Medinas ha studiato Produzione multimediale all’università di Cagliari e si occupa di social media.
Marco Gasperetti insegna Animazione e Stop-motion nella Scuola internazionale di Comics di Napoli. Ha scritto un manuale sull’animazione, Flashtoons, per l’editore FAG e il saggio Hanna & Barbera per NPE.

Nel lessico dei videogiochi il termine "sandbox" si riferisce a un genere o a una modalità di gioco che offre ai giocatori un elevato grado di libertà e creatività all'interno di un ambiente aperto. A differenza dei giochi lineari con obiettivi predeterminati, i sandbox permettono agli utenti di esplorare, interagire e spesso modificare il mondo di gioco a loro piacimento, senza vincoli rigidi o una trama fissa da seguire.
Lo stesso grado di libertà vogliono mantenere i saggi pubblicati da Faros, esplorando un mondo complesso e ormai imponente come quello dei videogiochi, prendendolo sul serio e analizzandolo come fenomeno della contemporaneità. Si tratta di saggi leggibili, a volte polemici, scritti facendo interagire le competenze sui giochi e videogiochi con quelle su altre discipline, nell’obiettivo di costruire ponti
I volumi sono concisi e coinvolgenti ed esplorano i più vari temi legati ai giochi. Scritti da accademici ed esperti del settore, si propongono di analizzare aspetti spesso tra-
scurati del mondo ludico, offrendo nuove prospettive su come i giochi influenzino e riflettano la società. Ogni libro è pensato per essere accessibile e stimolante, combinando visioni originali con panoramiche degli studi sui giochi e di altri campi. L'obiettivo è stimolare una riflessione più profonda sul concetto di gioco e sul suo impatto
La collana mira ad avere come lettori un pubblico variegato, accomunato da una profonda curiosità e un interesse critico per i giochi. Gli autori, accademici o designer, inviteranno a riflettere in modo nuovo sul significato e sul ruolo del gioco nel mondo contemporaneo.
La direzione della collana è affidata a Ivan Girina e Aleena Chia, docenti della Brunel University, London, e a Riccardo Fassone dell’Università di Torino. Del comitato scientifico fanno parte Diego Cavallotti, Emiliano Ilardi e Marco Benoît Carbone dell’Università di Cagliari, e Riccardo Finocchi, dell’Università di Cassino.



Jaroslav Švelch, Giocatore contro mostro. Creare e distruggere mostri nei videogiochi.
Il saggio analizza l'evoluzione e il significato dei mostri nei videogiochi, dal loro ruolo di semplici ostacoli a complesse rappresentazioni delle nostre paure e ideologie.
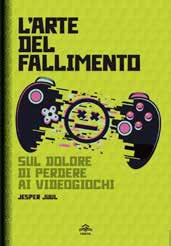
Jesper Juul, L’arte del fallimento. Sul dolore di perdere ai videogiochi
Il saggio di Juul affronta il "paradosso del fallimento", ovvero la contraddizione per cui i giocatori vanno in cerca di attività (i videogiochi) che li portano a
Il libro ripercorre mezzo secolo di storia dei videogiochi, mostrando come draghi, alieni e mutanti siano stati creati per riflettere le ansie di ogni epoca, spesso riducendo il "nemico" a una figura semplice da sconfiggere, eco della mentalità da Guerra Fredda.
Švelch esamina vari tipi di mostri e la loro funzione: non solo ostacoli di gioco, ma anche simboli che rafforzano determinate visioni del mondo. Distruggere il mostro non è solo un atto ludico, ma anche un modo per consolidare concetti di "noi contro loro".
Il saggio invita a una riflessione critica: la costante eliminazione di
nemici predefiniti può influenzare la nostra percezione della violenza e del conflitto? L'autore suggerisce che il mostro nei videogiochi, pur variando di forma, serva principalmente come bersaglio, perpetuando un ciclo di creazione e distruzione che merita un'analisi più profonda.
In sintesi, Giocatore contro mostro offre un'analisi culturale e funzionale di come i mostri siano stati usati nei videogiochi, collegandoli alle dinamiche sociali e politiche del mondo reale.
ISBN: 9791281836037 - 192 pp.19,00 €
sperimentare fallimento e sentimenti di inadeguatezza, nonostante nella vita quotidiana cerchino di evitarle. Juul non si limita a notare questo paradosso, ma lo sviscera, confrontandolo con il paradosso della tragedia nell'arte e sottolineando come i giochi, a differenza delle tragedie, non si limitino a purificare emozioni spiacevoli, ma le producano attivamente.
Juul introduce anche l’idea di "promessa di riscatto" insita nei giochi. Mentre il mondo reale non garantisce un'equa possibilità di superare i fallimenti, i giochi sono progettati per offrire tale possibilità. Questo rende il fallimento nel gaming diverso e, in un certo senso, più accettabile rispetto a quello speri-
mentato nella vita, trasformandolo da evento frustrante a catalizzatore per il miglioramento e la gratificazione.
Infine, riflette sulla doppia natura del fallimento nei videogiochi – come esperienza reale per il giocatore e come elemento fittizio per il protagonista – in maniera particolarmente acuta. Questa dualità permette ai giochi di esplorare contenuti tragici in modi nuovi, rendendo il giocatore "complice" di eventi spiacevoli nella finzione, offrendo una profondità emotiva che altre forme d'arte difficilmente possono eguagliare.
ISBN: 9791281836006 - 160 pp.16,00 €
Il libro Giocatore contro mostro distingue tra due forme di mostruosità nei videogiochi: la mostruosità sublime e la mostruosità controllata.
La mostruosità sublime si riferisce a nemici che evocano sentimenti di timore reverenziale, grandezza, orrore e meraviglia, spesso a causa della loro scala, della potenza o della loro natura inspiegabile e terrificante. Questi mostri sono al di là della piena comprensione o del controllo del giocatore, incarnando una minaccia che trascende la semplice sfida ludica e si avvicina all'esperienza estetica del sublime, dove la paura si mescola all'ammirazione. Sono figure che, pur essendo pericolose, possono affascinare e al tempo stesso generare un senso di impotenza nel giocatore.
Al contrario, la mostruosità controllata designa quei nemici che,
per quanto potenti o minacciosi, sono concepiti all'interno di regole e parametri di gioco ben definiti. La loro forza, i loro schemi di attacco e le loro debolezze sono prevedibili e possono essere appresi e sfruttati dal giocatore. L'esperienza di gioco con questi mostri è meno incentrata sull'orrore puro o sul disorientamento, e più sulla sfida strategica e sul perfezionamento delle abilità. Il loro scopo è testare le capacità del giocatore, offrendo un ostacolo superabile che garantisce un senso di progressione e di maestria una volta sconfitti. Spesso, questi mostri sono parte di un sistema bilanciato di difficoltà, progettati per essere divertenti e "giusti" nella loro sfida, piuttosto che puramente terrificanti.
Brano estratto da pp. 35-39
Nel XIX e XX secolo i tentativi di irreggimentare la mostruosità sono stati sostenuti dalla diffusione di dati scientifici, della burocrazia nell’amministrazione e dell’informatica. La quantificazione, il calcolo e l’elaborazione dei dati divennero il modo preferito di gestire le sfide che sia gli individui che le società dovevano affrontare. Il sociologo Ulrich Beck ha descritto questo sviluppo come uno spostamento verso una società del rischio. A suo avviso, le società premoderne tendevano a concettualizzare le avversità come minacce incerte, inaspettate e mandate dal cielo. Le società moderne, invece, le concepiscono in termini di rischi che possono essere calcolati statisticamente e su cui si può ragionare (Beck 2009). La storia del calcolo del rischio può essere fatta risalire alle polizze di assicurazione marittima. In uno dei primi contratti di assicurazione conservati, siglato nel 1350, un mercante assicurava un carico di grano dalla Sicilia a Tunisi, “assumendo tutti i rischi, i pericoli e i destini ... da atti di Dio dell’uomo o del mare” (Franklin 2015, 274). Le tariffe assicurative sarebbero variate in base alle condizioni meteorologiche e ad altri fattori di rischio, rendendo


più prevedibile l’avventurosa attività di navigazione.
L’esigenza di ridurre l’incertezza e di prevedere gli eventi futuri è stata particolarmente forte in ambito militare. Un modo per farlo è il wargame, nato tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, quando gli ufficiali dell’esercito prussiano iniziarono a progettare (e a giocare) finte battaglie da tavolo sia per addestramento che per divertimento. Per creare modelli funzionali di battaglia, dovettero assegnare valori ai vari tipi di eserciti e di terreni, creando così le prime simulazioni militari. Già negli anni Venti del XIX secolo, i wargame prussiani utilizzavano i dadi per simulare l’incertezza e i punti numerici (che sono diventati poi i punti ferita) per rappresentare la capacità delle unità di resistere ai danni (Peterson 2013, 229). Come vedremo nel prossimo capitolo, il wargame ha poi influenzato direttamente i giochi di ruolo da tavolo e i videogiochi.
Un altro elemento che ha influenzato i videogiochi proviene dai progetti militari dell’epoca della Guerra Fredda e dalla cibernetica, che era alla base del paradigma intellettuale dominante di quei progetti militari. I progressi tecnologici alla base dei videogiochi – computer polivalenti, interfacce interattive in tempo reale e display grafici – sono stati in gran parte finanziati dall’esercito statuni-
tense. Secondo lo studioso di tecnocultura Patrick Crogan, i videogiochi hanno assimilato molto dall'eredità tecnoscientifica militare”. Non tutti i videogiochi sono pura propaganda militare (solo alcuni lo sono), ma molti hanno adottato elementi concettuali della dottrina della Guerra Fredda, tra cui quello che Crogan descrive come “l’impulso a creare modelli dei fenomeni estendendone ed estrapolandone ipoteticamente il futuro per vedere come questo possa essere previsto, modificato e controllato” (Crogan 2011).
L’eredità è duplice: mentre la scienza e l’ingegneria della Guerra Fredda hanno prodotto tecnologie progettate per controllare e simulare situazioni di conflitto, l’ideologia militare della Guerra Fredda ha visto il mondo intero attraverso la lente del conflitto. Lo studioso di storia e tecnologie dell’informazione Paul N. Edwards ha osservato che il principio strategico e ideologico che guidava gli sforzi militari statunitensi dell’epoca della Guerra Fredda era la nozione di mondo chiuso: “una scena di conflitto radicalmente delimitata, uno spazio inevitabilmente autoreferenziale in cui ogni pensiero, parola e azione sono in ultima analisi diretti verso una lotta principale” (Edwards 1997, 12). Questa mentalità può essere fatta risalire agli inizi della cibernetica, disciplina emersa dagli studi di Norbert Wiener duran-
te la Seconda Guerra Mondiale sul predittore antiaereo, una macchina che avrebbe anticipato dinamicamente le azioni di un bombardiere nemico. Lo storico Peter Galison sostiene che “l’immagine che Wiener ha del mondo umano e naturale è ... un’estensione globalizzata, persino metafisica, della lotta epocale tra l’implacabile nemico dal cielo e il calcolatore [antiaereo] degli Alleati che combatteva da terra” (Galison 1994, 265). Di conseguenza, ogni altro essere che entra nel raggio d’azione del predittore viene considerato un nemico spietato ma calcolabile. Questo approccio all’alterità, che Galison ha chiamato ontologia del nemico, è comune anche nei videogiochi, in cui l’antagonismo è la caratteristica che definisce l’esistenza di molte, se non della maggior parte, delle entità simulate.
La tecnologia informatica ha permesso la costruzione di mondi chiusi miniaturizzati popolati da nemici simulati. Un esempio è Star Trek del 1972, uno dei primi programmi di successo per mainframe e minicomputer a diffondersi nelle università e nei laboratori di ricerca di tutto il mondo (Ahl e Leedom 1976; Smith 2020). In questo gioco tattico a turni, basato solo sul testo, il giocatore controlla l’astronave Enterprise, che si muove su una mappa spaziale a griglia e combatte l’invasione delle navi da guerra
Klingon con i phaser o i siluri fotonici. La specie umanoide ma mostruosa dei Klingon rappresentava un’alterità ostile che poteva essere letta come una controfigura dei nemici sovietici dell’America durante la Guerra Fredda.
I modelli militari e le simulazioni della realtà in generale sono stati progettati per ottenere “il controllo totale su un mondo ridotto a operazioni calcolabili e meccaniche” (Levidow e Robins, 1989). Tali simulazioni richiedono che al loro interno tutto aderisca a una logica computazionale unificante. Per essere operative, le qualità delle entità simulate devono essere tradotte in numeri o algoritmi. Come ha sottolineato McKenzie Wark, “la vera violenza dello spazio dei giochi è il suo ridurre tutto ciò che è analogico in digitale, riducendo il continuum in bit”. Tale violenza, sostiene Wark, “non ha nulla a che fare con esplosioni dai colori vivaci o con un numero crescente di morti, ma dipende dalla decisione presa tramite un decreto digitale che specifica da dove essa proviene e come viene classificata” (Wark 2007). La tecnologia digitale ha potenziato gli sforzi per costruire database, dissipare misteri e documentare ciò che non era documentato. Questo vale anche per i mostri dei videogiochi. L’onnipresenza del conflitto nei discorsi e nella cultura
popolare dell’epoca della Guerra Fredda ha creato una domanda di antagonisti, anche mostruosi. Allo stesso tempo, l’imperativo della simulazione è stato applicato anche agli esseri fantastici.
È significativo che lo studioso di videogiochi Espen Aarseth, quando ha voluto illustrare la differenza tra la narrativa letteraria e i videogiochi, abbia scelto l’esempio del drago, una classica creatura mostruosa. Più precisamente, mette a confronto un esemplare letterario, Smaug de Lo Hobbit di Tolkien, con quello che si incontra nel gioco di ruolo online multigiocatore (MMORPG) EverQuest:
Un drago è chiaramente immaginario, mentre l’altro è simulato. Uno è lì per essere letto o guardato sullo schermo di un televisore o di un film, l’altro è lì per essere giocato. Uno è fatto solo di segni, l’altro di segni e di un modello dinamico che ne determina il comportamento e risponde ai nostri input. È questo comportamento del modello che lo rende diverso da una finzione, perché possiamo conoscere ... la simulazione molto più intimamente di quanto non facciamo con la finzione. Le simulazioni ci permettono di testare i loro limiti, comprendere le causalità, stabilire strategie ed
effettuare cambiamenti, in modi che le finzioni non ci permettono, ma comunque molto simili alla realtà. Non possiamo fare a modo nostro con le finzioni, ma con i giochi sì (Aarseth 2007, 37).
Affinché un mostro sia interattivo e funzioni correttamente in un mondo videoludico, i suoi comportamenti, le sue proprietà e le sue interdipendenze con gli altri oggetti devono essere specificati senza ambiguità. In diretta opposizione con l’articolazione della mostruosità sublime di Kristeva, che resiste a diventare un oggetto, il drago è diventato un obiettivo della nostra agency: è qui perché lo si possa studiare e ci si possa giocare. Non appena riusciamo a comprendere il suo comportamento, possiamo prevedere le sue azioni future, elaborare una strategia e infine sconfiggerlo. Simulando la mostruosità, la stiamo anche controllando.
Tradizionalmente concepiti come entità viventi, spesso zoomorfe o antropomorfe, i "mostri" hanno ampliato il loro spettro semantico fino a includere l'ambiente stesso. Questo capitolo illustra come il concetto di avversario si sia trasformato da una figura concreta e attaccabile a una minaccia diffusa e sistemica.
In tal senso, i mostri non sono più esclusivamente le creature che il giocatore combatte direttamente, ma si manifestano anche nelle condizioni avverse dell'ambiente: un deserto inospitale, un labirinto claustrofobico, una tempesta imperversante, o persino la carenza di risorse vitali. Questi "mostri ambientali" incarnano una forma di ostilità più astratta ma ugualmente pervasiva, che sfida non solo le capacità di combattimento del giocatore, ma anche le sue abilità di pianificazione, sopravvivenza e adattamento.
Questo mutamento riflette una sofisticazione nel game design, dove la tensione e la difficoltà non derivano unicamente dallo scontro fisico, ma dall'interazione complessa con un mondo che è intrinsecamente ostile o indifferente. I mostri, dunque, si sono evoluti da entità da annientare a forze della natura o sistemi da decifrare e superare, ampliando la definizione di "nemico" nel panorama ludico.
estratto da p. 125-128
Un modo per mettere in discussione le tradizionali narrazioni di mostri è quello di mettere in dubbio l’eroismo del killer di mostri. Nella tradizione occidentale, questa linea di pensiero precede di gran lunga l’Antropocene e può essere individuata già nel primo cristianesimo. Una delle sue formulazioni più famose è apparsa nel saggio Beowulf: mostri e critici di J. R. R. Tolkien. Tolkien sostiene che i mostri sono fondamentali per comprendere le qualità poetiche del poema. A suo avviso essi forniscono una prospettiva che “supera i dati e i limiti del suo periodo storico”; in altre parole, evocano un sentimento di sublime (Tolkien 2000, 68). Allo stesso tempo, chiarisce che l’uccisione dei mostri non deve essere intesa come intrinsecamente virtuosa. Si schiera con il poeta di Beowulf nel rifiutare la nozione di “eroismo marziale fine a sé stesso” (Tolkien 2000, 57). Nonostante le sue imprese sempre più difficili, l’orgoglioso guerriero Beowulf affronta la “tragedia fatta di inevitabile rovina” che nessuna fama o fortuna terrena può evitare. Pur uccidendo il drago – il “boss” finale del poema – viene ferito a morte e muore poco dopo. L’approccio di Tolkien all’eroismo di Beowulf deriva dalla sua fede cattolica, che
ha informato sia il suo lavoro accademico che quello narrativo. Come spiega Asma, Tolkien adotta la visione paleocristiana secondo cui “senza il cristianesimo, gli assassini di mostri o sono eroi esistenziali senza speranza, che cercano con patetici sforzi umani di liberare il mondo dal male, o sono essi stessi giganti mostruosi in mezzo a un gregge di giusti e miti devoti” (Asma 2012, 99). Di conseguenza, Tolkien legge Beowulf come un eroe tragico, concludendo che il poema è un’elegia piuttosto che un’epopea (Tolkien 2000, 65).
Non sono rari i casi di mostri assassini ritratti in modo tragico. Come sottolineato da Tanya Krzywinska, il tema del “falso eroe”, tramandato dalla letteratura e dal cinema gotico, è tipico dei videogiochi horror e fantasy (Krzywinska 2015). Il tono cupo ed elegiaco permea molti titoli che impiegano il modello Giocatore contro Ambiente mettendolo però contemporaneamente in discussione. Un primo esempio di questo tipo di gioco è Shadow of the Colossus, ampiamente riconosciuto come una pietra miliare nel design dei nemici e nel mondo del gioco etico (Fortugno 2009; Sicart 2009). La storia segue un giovane uomo di nome Wander che viaggia in una terra proibita per riportare in vita la sua amante morta. Un’entità misteriosa e invisibile dice a Wander che in cambio deve uccidere sedici
colossi, creature gigantesche che popolano vari angoli del territorio (figura 4.2).
Per sconfiggerli, Wander deve individuare e raggiungere uno o più dei loro punti deboli (o “vitali”).

Non sorprende che, per un gioco d’azione e avventura, ogni colosso ponga un enigma unico, ispirato ai boss della serie Legend of Zelda. Shadow of the Colossus, tuttavia, si discosta dalla formula per almeno tre aspetti.
Innanzitutto, non ci sono mob (nemici controllati dal computer) nel gioco. Il motivo alla base di questa decisione è sia pratico che artistico. Come ha dichiarato il produttore del gioco Kenji Kaido in un’intervista, hanno fatto così “per concentrare le risorse del team sui [colossi]”, ma anche per sottolineare il “contrasto tra la tranquillità del viaggio e i combattimenti” (Reed
2005). Di conseguenza, il gioco non offre la facile soddisfazione di colpire e uccidere avversari più deboli. In secondo luogo, Wander può – e spesso deve – montare sui mostri, restare in equilibrio e aggrapparvisi, spesso afferrandosi alla loro pelliccia. Come ha sottolineato Kaido, “sono in parte edifici e in parte creature viventi” (Kikizo Staff 2005). Un colosso non è semplicemente un avversario che il protagonista combatte, ma è anche il terreno su cui si regge. Quando i colossi cercano di scrollarselo di dosso, Wander diventa letteralmente un soggetto instabile: trascorre lunghi minuti premuto contro i mostri, fondendosi temporaneamente con la loro massa corporea prima di trafiggerli con la sua spada magica (figura 4.3). Infine, la distruzione dei colossi è considerata eticamente discutibile. In un’intervista retrospettiva, il

direttore del gioco Fumito Ueda ha ricordato che durante la produzione del gioco “ha iniziato a nutrire dubbi sul fatto di sentirsi bene e di provare un senso di realizzazione battendo i mostri” (Taylor 2019). I colossi sono in gran parte pacifici finché Wander non li attacca. Sebbene il giocatore possa provare un senso di trionfo quando li sconfigge (e, nel remake del 2018, raccogliere i trofei PlayStation per ciascuno di essi), il design audiovisivo del gioco suggerisce l’esatto contrario. Quando vengono trafitti dalla spada di Wander, ruggiscono e si contorcono dal dolore mentre il sangue nero schizza dalle loro ferite, e la loro fine è accompagnata da una musica malinconica (Cole 2015). Per illustrare quanto fosse inusuale all’epoca, Ueda ha raccontato che quando fece sentire per la prima volta la musica ai suoi collaboratori, “pensarono che fosse uno scherzo e si misero a ridere perché erano abituati ai giochi che suonavano una fanfara dopo aver sconfitto un mostro” (Taylor 2019).
“L’idea di intervenire è arrivata una notte. Vedevamo in classe e a casa ragazze e ragazzi sempre alle prese con un nuovo compagno d’avventure che li seguiva ovunque: il pensiero del sesso.
Gruppi di amiche e amici si chiudevano ore e ore a interrogarsi, cercare risposte. Dalla scuola, medie e superiori, non ne arrivava nessuna. E da noi non volevano interferenze.
Poi, quella notte, è arrivata una brutta notizia, alcune studentesse alle prese con il dramma delle molestie.
A quel punto abbiamo capito che, da genitori, insegnanti, editori, volevamo fare qualcosa. Volevamo dare alle ragazze e ai ragazzi degli strumenti per capire. Capire che cosa? Prima di tutto che cosa è una relazione affettiva sana, poi che cosa sono il piacere, il rispetto, il corpo, il sesso. Senza paure e senza falsi moralismi. Non servivano i manuali, non i romanzi in cui il sesso è invadente, stereotipato, falso, non i siti porno. Servivano storie di qualità su quella scoperta di sé che ognuno fa con i propri tempi, storie in cui la relazione affettiva sia il centro dell’esperienza.
Servivano personaggi che si facessero le loro stesse domande, che provassero il timore e la gioia della scoperta del corpo e della sessualità. Che imparassero a distinguere una molestia e a difendersene, a tenersene lontani e lontane.
Quella notte abbiamo inventato Teen Spirit (ricordate i Nirvana? Smells Like Teen Spirit?). Una collana di romanzi teen di alto livello pensati per loro. Solo per vederli crescere sani.”
Volumi in libreria e sugli store online

Toccami di Susie Morgenstern
Toccami è una commedia sentimentale, divertente, maliziosa, a suo modo pudica, piena di risate e lacrime raccontate con lo stile unico, leggero, ma anche denso e profondo di Susie Morgenstern che relativizza le difficoltà della vita e che per la prima volta affronta i temi della sessualità, delle fantasie e del desiderio degli e delle adolescenti.
ISBN: 9791281836020 - 14,5x21 cm - 176 pp. - 18,00 € - ETÀ: 13+
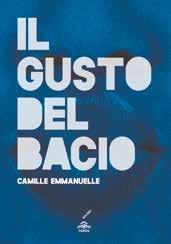
Il gusto del bacio di Camille Emmanuelle
Camille Emmanuelle racconta, con uno stile che rimane lontano dagli stereotipi, le prime esperienze di Aurore, la conquista di una sessualità prima difficile, poi serena, i rapporti con la famiglia e con gli amici. L’autrice riesce a descrivere bene la complessità del rapporto che hanno i giovani e le giovani con il proprio corpo ancora da scoprire.
ISBN: 9791281836013 - 14,5x21 cm - 176 pp. - 18,00 € - ETÀ: 15+
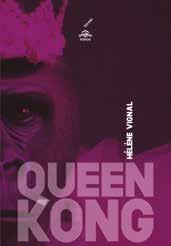
Queen Kong di Hélène Vignal
Hélène Vignal è una voce importante della letteratura per ragazzi francese. Nel 2021 questo romanzo ha vinto la “Pépite d’or”, il più importante premio della letteratura per ragazzi raccontando la storia di una ragazza che vuole essere soltanto libera di scegliere come essere e cosa fare.
ISBN: 9791281836051 - 14,5x21 cm - 112 pp. - 13,00 € - ETÀ: 15+
Limone di Mélody Gornet
Mélody Gornet è una delle nuove voci della letteratura francese per ragazzi, propone nel suo romanzo un’attitudine sex positive e un mondo in cui il maschio alfa non è l’unico modello e in cui le persone queer non sono necessariamente “diverse”.
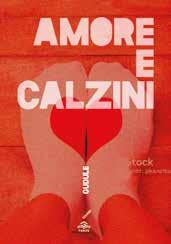
ISBN: 9791281836044 - 14,5x21 cm - 192 pp. - 18,00 € - ETÀ: 15+ Amore e calzini di Gudule
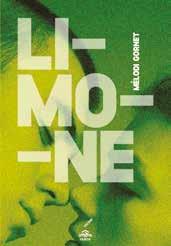
Gudule è nota soprattutto per la capacità di trattare con leggerezza e ironia temi difficili. Qui Delphine inizia il suo diario raccontando del professore che apre la lezione in classe distribuendo dei preservativi alle ragazze e ai ragazzi e mostrando come si usano. Da qui parte una commedia degli equivoci ben gestita dall’autrice fino al finale a sorpresa.
ISBN: 9791281836068 - 14,5x21 cm - 128 pp. - 13,00 € - ETÀ: 13+
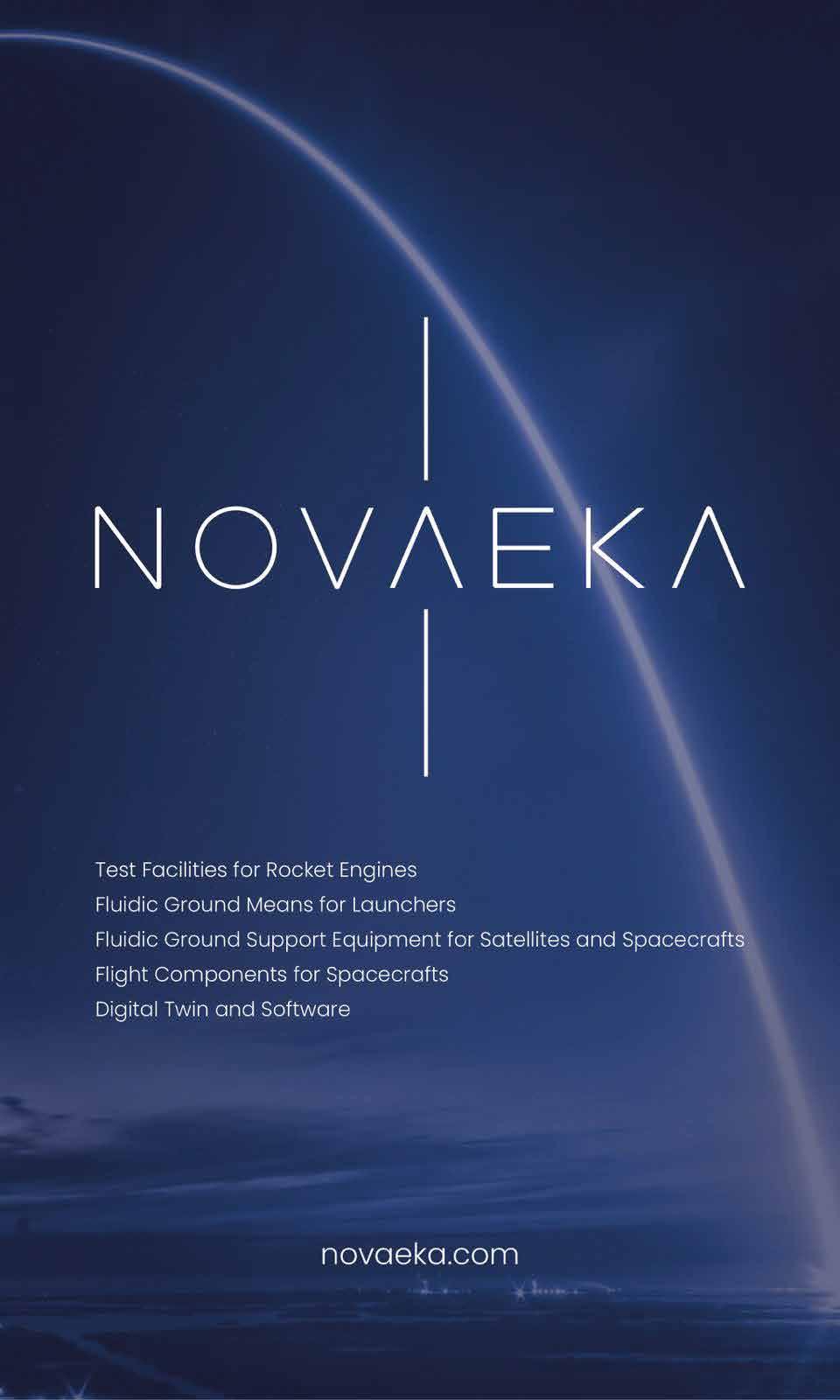
Quanti Edipo accompagnano la vita di ciascuno di noi?
A cura della casa editrice Succedeoggi
C’è l’Edipo bambino, rifiutato dai genitori e costretto a portare questo suo doloroso destino fin nel nome perché qualcuno, per liberarsene, gli ha rotto i piedi. C’è l’Edipo bullizzato, il ragazzo che comincia a intuire il proprio destino solo quando un amico ubriaco, a un happy hour, lo chiama “bastardo”. C’è l’Edipo che non controlla i suoi istinti: va in crisi quando lo insultano e, per una banale lite di precedenze stradali, uccide un vecchio. C’è l’Edipo che vuole vivere lontano dal padre e perciò mette in campo una strategia per essere sé stesso. C’è l’Edipo intelligente ma un po’ gradasso che risolve l’enigma della sfinge. C’è l’Edipo che crede di poter sfuggire il proprio destino; peggio, che crede di poter costruire la sua vita a dispetto del Caso. C’è l’Edipo che scopre di aver vissuto la vita di un altro da sé. C’è l’Edipo che si avvia alla morte (in pace) solo nel momento in cui ammette le proprie responsabilità nell’avventurosa parabola della sua vita e accetta di aver consumato un’esistenza diversa da quella che si aspettava da sé. C’è l’Edipo che ammette i suoi errori perché li ha commessi, anche se non ne era consapevole. C’è l’Edipo le cui colpe ricadono sui figli, da Eteocle e Polinice a Antigone e Ismene: una genìa di figli che affogano nel dolore perché marchiati dagli orrori del padre.
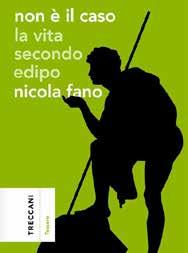
E poi ci sono l’Edipo di Freud, quello di Stravinskij, quello di Pasolini e quello di Francis Bacon.
Più che un personaggio, Edipo è un caleidoscopio di vite possibili. Da ciascuna abbiamo qualcosa da imparare. E si tratta di una lezione – come dire? – composita, continuativa, che riguarda tutte le nostre età. Nel senso che Edipo può suggerire problemi e soluzioni a giovani, adulti, vecchi: il mito, dalla Grecia classica a oggi, lo ha inseguito in tutte le stazioni della sua vita, al punto che la sua parabola umana può legittimamente riverberare le esistenze di tutti. Di più: il sortilegio di Edipo sta anche nel fatto che un grande scrittore, Sofocle, ha

ritratto le sue angustie in ogni sua età. E le ha descritte non una volta per tutte, come un qualunque autore che un giorno si metta seduto alla scrivania a comporre il romanzo della vita, magari la parabola di un secolo di illusioni e solitudini. No, Sofocle ha raccontato la memoria di Edipo giovane quando egli stesso era giovane. Poi ha messo in scena la delusione dell’uomo maturo chiamato a fare i conti con il proprio passato quando egli stesso aveva iniziato a tracciare il bilancio della propria vita. E infine ha composto l’elegia del vecchio Edipo, prossimo alla morte, quando egli stesso – Sofocle – era prossimo alla morte. È un caso unico ed eccezionale: un grande autore che racconta il suo personaggio come un alter ego nel corso di una lunghissima vita intera (Sofocle ha vissuto novant’anni), volta a volta soffermandosi sulle stagioni essenziali della sua avventura terrena e di quella di chiunque.
Ecco perché c’è un Edipo diverso in ciascuno di noi, uno per ognuno di noi. Lo possiamo sentire amico da adolescenti, da adulti e da vecchi: ogni volta lui se ne sta lì, con il suo cipiglio iroso, a svolgere la sua esperienza specifica per fornirci indicazioni. O consigli veri e propri. Questo facevano i greci, con il teatro: elargivano consigli, suggerimenti di vita concreta. E, dun-
que, seguendo la traccia del mito di Edipo si può costruire il paradigma di noi stessi in ogni età. È quel che cercheremo di fare nelle pagine che seguono. Partendo, naturalmente, dall’inizio, dalla fanciullezza dell’umanità: dai greci.
Treccani, 112 pagine, 14 Euro.


Di Danilo Maestosi
Il Palazzo delle Esposizioni di Roma "nasconde" alcune belle mostre - soprattutto quella dedicata al fotografo Mario Giacomelli - dietro alla passerella di Dolce&Gabbana che confonde il consumo con l'arte
Uno scivolone di percorso. Non trovo altro modo per spiegare la mostra degli stilisti Dolce e Gabbana che il palazzo delle Esposizioni di Roma ha accolto fino al 13 agosto nelle sue sale.
D'accordo, c'è il mito e il culto dilagante del made in Italy, ormai diventato una sorta di religione di Stato che non tollera abiura: e il duo di stilisti occupa da tempo in quel Pantheon un posto di sicuro rilievo. D'accordo, divulgare cultura è mescolare alto e basso e accettarne la convivenza. D'accordo, tener
conto che oggi gli steccati che per secoli hanno separato arte e creatività sono crollati e nessuno più si chiede se è un male o un bene sprofondare in questa deriva. Ma era proprio necessario fare di questa passerella di divi dell'abbigliamento il cuore della programmazione estiva del padiglione di via Nazionale? Destinargli le sale più spettacolari del piano terra, sbandierarne il titolo “Dal cuore alle mani”, con uno stendardo tra le arcate centrali d'ingresso, che sovrasta il richiamo degli altri titoli in cartellone?
Ma l'obiezione decisiva è un'altra: può uno spazio pubblico e il Comune che lo gestisce trasformarsi in affittacamere e non governare quest'offerta, probabilmente venduta a buon prezzo? Consentire a chi l'ha ideata e organizzata di farne un corpo estraneo? Separato da un diverso biglietto – 15 euro in più – e un diverso ufficio di promozione ma ancor più da una serie di barriere che nascondono alla vista questa mostra e ne marcano la distanza da altri eventi in corso nella stessa sede?
Ai visitatori solo un fuggevole scorcio della rotonda centrale, dominata da una sorta di piramide di abiti di gran gala, un tripudio di trine e svolazzi eretto su un fondale di quadri e immagini di colori rutilanti e barocchi. A me – da spet-

tatore privilegiato che non fa testo – quel tuffo in un kitsch calibrato a far colpo è bastato per toglier la voglia; in altri, sono sicuro, avrà acceso desideri e curiosità. Ma comunque un interesse tenuto a bada da un muro. Fastidioso come un rifiuto al dialogo con una platea e un contesto meno complici, finalizzato solo alla sicurezza e alle chimere del brand: i capricci dell'alta moda sono già in sé una selezione di stato o illusioni di salto sociale, pretendono e promettono il fascino dell'esclusività. Una fiera della vanità che trasforma in traguardi, voglia di seduzione, soldi e successo. Nessuna di queste motivazioni è in sé peccato. Ma peccato, abbaglio insidioso lo diventa nell'universo delle comunicazioni di massa, se si fa spinta a chiudere gli occhi rinunciando a vedere al di fuori e al dentro di se, a bandire le differenze che parlano il linguaggio dell'altro e dell'altrove. A sprofondare nella voragine delle paure e della rassegnazione. Ad accecare gli occhi non solo al rifiuto dell'invisibile, porto privilegiato dell'arte, della coscienza critica e del cambiamento, ma alla cruda e nuda disumana realtà che ci punisce e ci incalza, abbandonandoci alla tirannia delle merci, delle guerre e di nuovi despoti.
Non so quale fossero i calcoli della premiata ditta Dolce&Gabbana, Ma perché far tanto sfoggio di mera-
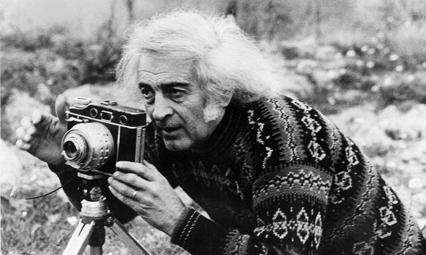
viglie e stereotipi di bellezza e poi chiudere lo spettacolo nel guscio di una sofisticata, respingente apartheid? E qual è il vantaggio che il Palaexpo ne ha ricavato, accettando di farsi escludere dalla cabina di regia? Credo che Marco Delogu, presidente e padrone di casa di questo contenitore si sia accorto del rischio e abbia cercato di tamponarlo cucendo attorno a questo evento di lustrini e disimpegno mondano una dosata cintura di appuntamenti-anticorpi. Come? Facendo ricorso ai ferri del suo vero mestiere, la fotografia, l'unica tra le tante discipline visive ancorata, almeno in partenza, alla presa di realtà dello sguardo. Un bagno di realtà salutare ad esorcizzare quel corpo estraneo da favola per élite. Una sorta di riproposizione in formato concentrato e ridotto di quel festival della fotografia, che Delogu
ha inventato e poi visto morire nel disamore della politica culturale capitolina.
Già basterebbero a riportare con i piedi a terra il pubblico del Palaexpo le immagini messe in fila nella galleria del secondo piano dalla nuova edizione del premio World press photo, un'antologia dei migliori reportage fotografici sulle zone di conflitto e di guerra di tutto il mondo e sulle esperienze di solidarietà a sostegno dei più fragili e degli ultimi della terra. Tra tutte campeggia la foto premiata. Non è la più bella. La bellezza è spesso una benda sugli occhi, un alibi che giustifica la fuga dalle responsabilità. Ma sicuramente la più intensa. L'ha scattata un reporter palestinese a Gaza. Ritrae un adolescente, la manica della maglietta che galleggia nel vuoto di un braccio amputa-
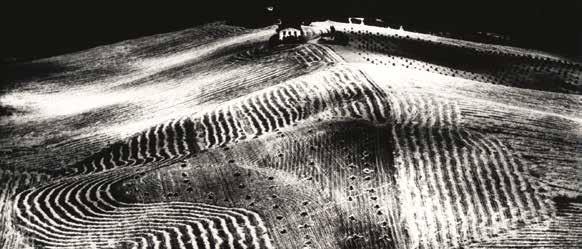
to. Il volto non grida dolore e voglia di vendetta. Si limita a sussurrare la pena di un'innocenza violata. Il tragico futuro di un popolo condannato al massacro delle bombe, della fame, nel nome usurpato e tradotto in bestemmia di un Dio delle armi e della pulizia etnica. Complice la nostra smemoratezza. Ogni volta che dimentichiamo di chiederci, come ci ha insegnato Primo Levi, un ebreo scampato al genocidio nazista, Se questo è un uomo. Non solo che stiamo diventando, ma chi siamo. E che cos'è e cosa possiamo imparare dal mondo, dalla Natura che ci circonda.
Dubito che la mostra di Dolce e Gabbana possa sostenerci in questo percorso, quella passerella di abiti e bagliori d'ispirazione rubati come credenziali alle fantasie trasgressive del barocco può al massimo offrirci una maschera per nascondere al nostro io narciso le rughe del tempo, rimuovere dal nostro scenario quotidiano lo spettro e lo scandalo della morte.
Ma è nella morte che bisogna immergersi, e guardarla negli occhi, per dar senso alla vita e raccontarla per quello che è. Un mistero che sfugge ai doveri e ai piaceri del design e della sartoria. E a cui solo il salto nell'invisibile dell'arte può avvicinarsi, non importa con quale linguaggio, pittura, poesia, fotogra-
fia. Tre risorse d'immaginario alle quali ha attinto con caparbia concentrazione e modestia operaia Mario Giacomelli. La mostra con cui il Palazzo delle Esposizione ne rivisita la produzione è il grande gioiello che il suo cartellone estivo ci regala. È una celebrazione di centenario, sdoppiata in simultanea tra Roma e Milano. Un secolo di vita da cui Mario Giacomelli riemerge come un maestro di assoluta originalità nel panorama mondiale. A darle ancora più risalto un colpo d'ala dei curatori Bartolomeo Pietromarchi e Katiuscia Giacomelli: mettere a confronto le sue stampe in bianco e nero con un piccolo campionario di opere di grandi pittori con cui Giacomelli qualche prova di pittore di buon talento anche lui, ha collaborato o intrattenuto rapporti di amicizia: Burri, Afro Kounellis, Cucchi, Roger Ballen. Più facile così comprendere l'anima astratta che rivendicava per le sue fotografie, il bianco e nero già come un codice di segni ed emozioni. Un inchiostro distillato dalla continua presenza della morte e del suo passaggio. Che ruba e da senso agli istanti e agli slanci di vita. Un’ombra di dolore e di privazione che Giacomelli si trascinava appresso dall'infanzia. Il padre morto quand'era bambino, una madre che imprigionava carezze e sentimenti per riversare ogni energia nel tirar sù lui e il resto della famiglia. Vuoti che Giacomelli non ha mai tentato
di cancellare, confinandosi lui stesso in quell'entroterra marchigiano di Senigallia dov'era nato, in quella terra contadina da cui non si è mai allontanato, sacerdote della memoria e testimone del tempo che passa. Un lavoro da tipografo che lo ha addestrato alle magie della stampa e della camera oscura e alla fatica che c'è dietro ogni scatto per penetrare oltre la pelle delle figure.
Perché a Giacomelli non bastava lo sguardo, dei suoi occhi e della sua macchina fotografica, una meccanica che continuava a riadattare, Doveva studiare prima ogni soggetto, osservarlo e farlo parlare fino a tirar fuori la linfa delle emozioni tenute nascoste, le prove della battaglia che ogni uomo combatte col proprio corpo e le proprie esigenze di tregua. E poi passare al dopo, modellare con la stampa e l'artificio di infiniti, pignoli ritocchi la chiave d'ingresso per abitare le sue visioni.
Nasce da questa ricerca insaziabile di verità, il capolavoro più noto, il ciclo dei pretini, che gli consegna premi e porte di luminosa carriera. Che meraviglia quella danza di tonache nere su un prato innevato, reso ancora più bianco in camera oscura. Un'icona senza tempo che ha fatto il giro del mondo. Eppure a contarli ci sono voluti quasi tre anni, per arrivare a quel clic. Tre anni per frequentare quei giovani semina-

risti, raccogliere le loro storie. Per liberarsi- come confessa lui stesso- delle false domande con cui si era accinto all'impresa, scettico su quella scelta di vita che imponeva la rinuncia alle pulsioni del corpo. A metterlo sulla strada giusta, una prima frase di padre Turoldo, un teologo che frequentava il convento, «finalmente ho disturbato la quiete di questo convento». E poi una seconda con cui Giacomelli sceglierà di battezzare l'intera serie: «Io non ho mani che mi accarezzino il volto». Giacomelli, un fotografo-poeta che si lascia guidare dalla poesia, come farà con le opere di pittura a cui ruba anima e dettagli. E misura a cicli il tempo della sua ispirazione, una luce che si accende e si spegne per decenni, la spina innestata in esperienze in presa diretta.
È così che nasce e prosegue il ciclo sugli ospizi per vecchi. Luoghi che ha frequentato insieme alla madre che vi prestava assistenza, e torna a visitare con i versi di una poesia di Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi scolpiti nella mente. Con discrezione e pudore. E a volte con rabbiosa impotenza di fronte a quelle anticamere della morte, così male attrezzate per accogliere testamenti di rughe, abbracci e pochi sprazzi di quiete e sorrisi.
E poi la Natura. Altro tema ricorrente, cui continuerà ad aggiungere immagini. I paesaggi dei campi e
delle colline disegnati, come corpi tatuati, dal lavoro dei contadini. Il mistero della natura, che certo conosce la morte ma anche lo stupore della rinascita, come una tela di incredibili ricami: I solchi degli aratri come cicatrici e inni alla vita scolpiti in terra, che già fanno quadro, racchiudono palpiti di inarrivabile astrazione. Ma che lui non esita a modificare, trasformandosi in regista della scena Mettendosi alla guida del trattore col consenso dei contadini suoi amici, per deviare la rotta di quei segni, piegarli in direzioni impreviste, che moltiplicano la sorpresa. Oppure aggiungendo pennellate nere al fondale. Tele e collage di segni ed emozioni e manipolazioni d'autore. Ma che importano i trucchi se colgono l'essenza di una visione, suscitano domande mai scontate. Insegnano a vivere senza dimenticare e camuffare la disperazione dietro maschere di rassegnazione e di compromesso. Passaggi a vuoto che accompagnano spesso anche fotografi di talento e successo come Albert Watson, 83 anni, scozzese trapiantato a New York, al quale il Palaexpo rende omaggio con un'antologica allestita – penso non a caso – nelle sale del pianoterra. Alle spalle del palcoscenico separato di Dolce&Gabbana con il quale in qualche modo dialoga, senza calcare troppo le distanze tra arte e creatività. Confini
scavalcati dalla sua stessa biografia: per anni ha fatto soldi e carriera con la pubblicità. Pagando visibilmente dazio al dio delle merci e della superficie. Quanti eccessi di colori, sottolineature narrative, in molte di quelle immagini esposte in rassegna, accomunate dall'intento di raccontare la bellezza sfuggente e gradassa di Roma. E che spreco di ingegno e talento rivelano invece altre foto davvero parlanti, per concisione di inquadrature e scavo psicologico. Un’alternanza comunque intrigante tra vocazione e mestiere.
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi. it/2025/06/mario-giacomelli-la-realta-e-il-kitsch/
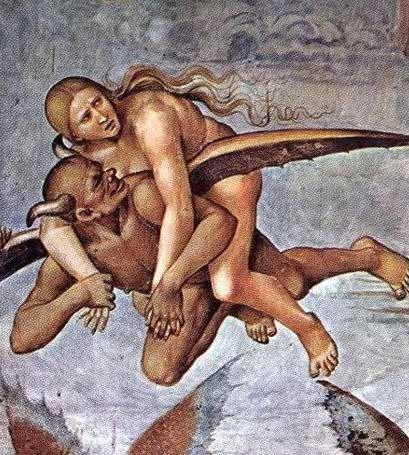
Di Giovanna Di Marco
La studiosa Laura Pasquini analizza l'iconografia diabolica. Così, attraverso i secoli, l'immagine del male ha cambiato segno e connotati, fino agli orrori del potere del Novecento
Da un mosaico dal IV secolo d.C. alla faccina maligna e cornuta delle emoji della messaggistica Whatsapp. Se non fosse troppo semplicistico e banalizzante, potrebbe essere un ulteriore sottotitolo, questo, dell’ampio e corposo saggio Il diavolo. Storia iconografica del male (Carocci, pp.362 euro 39,00), che la studiosa Laura Pasquini ha recentemente congedato. Un sottotitolo per non addetti ai lavori, certamente, poiché il volume richiede una conoscenza specifica di stratificati eventi delle arti plastiche nell’arco della storia. Il suddetto mosaico, che si trova sulla pavimentazione
della chiesa di Santa Maria Assunta ad Aquileia, è il primo esempio iconografico che propone l’immagine del Male in questo testo, e lo fa in brevi e decise linee scure, che rappresentano un volto di profilo che tira fuori dalla bocca una lingua irriverente, il tutto su uno sfondo aniconico. Pasquini ripercorre dunque l’immagine del Male nell’arco della storia occidentale. Un volume interessante per gli addetti ai lavori, dicevo, quindi per gli storici dell’arte, per intenderci, ma anche per gli storici. In che modo, mi sono chiesta, un testo di questo tipo può parlare anche a chi non è un esperto di iconografia? Cosa può lasciargli? La studiosa propone il tema, focalizzato nel suo fluire storico. Così scrive: “L’unica via praticabile per raccontarne le forme rimane quella diacronica, dalle origini a oggi, superando necessariamente i limiti del Medioevo […] che viene in più casi ripreso, rielaborandolo e interpretandolo attraverso nuovi rimandi e associazioni”.
Non si parte però dalle origini delle forme in ambito cristiano, ché le origini stanno più lontano, nella radice culturale greco-romana, dove gli attributi demoniaci erano già di quelle divinità umane troppo umane, sia che fossero olimpiche che ctonie. Da lì il Cristianesimo attinse per recuperare figure da vituperare. Quelle ctonie, appunto, e

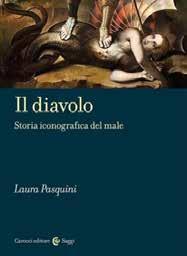
quelle bacchiche, come satiri, sileni e l’immancabile Pan. In ritardo, tuttavia, rispetto alle discettazioni dei filosofi cristiani, dei Padri della Chiesa arrivano le immagini. Iniziano a presentarsi più numerose e incalzanti in epoca carolingia, per esecrare i Longobardi. Prima avvisaglia, dunque, di demonizzazione del nemico. Poi, è con il Romanico e il Gotico che le cattedrali si popolano di figure demoniache. Satana si trasforma nei secoli. Diventa di colore livido, può avere le classiche corna o le ali di pipistrello; giganteggia in Giudizi universali, prima della nascita di Dante, influenzando il Sommo Poeta, poi per essere influenzato da lui. Si tratta di un mostro, a volte a tre teste, contor-
nato da bestie, che mangia peccatori, che li elimina come feci, ogni tanto. Poi, con l’Umanesimo e il Rinascimento prende forme umane, come avviene negli esempi di Luca Signorelli o del Michelangelo della Sistina. Al Maligno si addice la seduzione, che può essere della carne, ma anche dell’intelletto. Pasquini fa in tempo a inserire, a ragione, due capitoli sulla cultura coeva nordica, dove, in un’ottica pessimista, che si avvicina già inconsapevolmente

all’adesione all’imminente Riforma, c’è una sostituzione del Maligno gigantesco e quasi eroico con delle piccole figure di demoni che
confondono, che si moltiplicano, che si insinuano nella vita quotidiana, come a mostrarci quanto il Male non sia esterno alla realtà, ma sgusciante tra piccoli oggetti, serpeggiante e deforme, perché: “Il demoniaco e il grottesco fanno parte della realtà cui nessuno può sfuggire, sono anzi la realtà medesima, sono l’incubo che si invera”. Il mondo del sole mediterraneo opposto alla tenebre nordiche di una Natura avversa e ostile preconizza due principî dello spirito, il classico e il romantico.
E la Riforma è dietro l’angolo e, di

seguito, la Controriforma con tutto quello che ha comportato come censura, sospetto, delazione. Il Settecento tace, in nome della Dea Ragione, che, come intuì Goya alla fine di quel secolo, generò dei mostri. Quanta mostruosità innestò l’omissione delle figure del Male applicata alla storia? Pensiamo al periodo del Terrore della Rivoluzione francese!
Il Male dunque ritorna, quasi eroicamente in epoca romantica e decadente. Affascina, seduce, conduce in un Altrove di pulsioni inconsce e visioni oniriche. E l’autrice correda l’analisi dei manufatti delle arti plastiche con una testualità precisa, che si focalizza su autori come il Goethe di Faust o Baudelaire.
Fino ad arrivare al secolo breve, ai disastri delle due guerre mondiali e dei totalitarismi, dove non c’è più soltanto l’aspetto religioso a circoscrivere il Male, ma dove l’iconografia religiosa serve a identificarlo, quando “l’inferno sono gli altri”, come scrisse Sartre; dove il male è empio e travalica i limiti del fas divenendo nefas. Quando vengono violati i principî dell’umanità e l’altro da sé è da prevaricare iniquamente. Quando il male è essenzialmente il potere in ogni sua forma! Arriviamo dunque all’emoji citata all’inizio: dopo tanto scorrere attraverso capolavori dell’arte, giun-
giamo al nostro linguaggio visivo risicato, ideografico, perché le parole si sono perse e si fa ricorso alla messaggistica istantanea. Quando l’educazione alla complessità anche nella cultura visiva è stata obliata, il demoniaco si insinua nei nostri cellulari attraverso i social, ma, ahinoi, anche nella sfera della violenza di giochi virtuali e di serie televisive. Il tutto è ormai fruito sin dalla giovane età, creando suggestioni e non solo nei più giovani, che a volte conducono a efferati delitti. Ecco, il saggio di Pasquini va certamente letto per veder mutare le forme del Male nell’arco della storia, per verificare quale fosse (e qual è?), a mano a mano, il Nemico della cultura, contro il quale combattere. Ma anche per avere una visione della controcultura visiva. E, soprattutto - ed è questo il fulcro di tutta l’opera - l’immagine del Maligno si fa viva per assumere continuamente un’altra effigie. Pasquini infatti afferma che il Maligno è “capace sempre di adeguarsi ai cambiamenti della storia, per insinuarsi agevolmente nei suoi anfratti; capace di leggere acutamente le mutazioni del pensiero e delle dinamiche sociali, per agire con armi adeguate sui potenti come sugli oppressi, e sempre al passo coi tempi, sensibile al mutare del gusto, all'evolversi dell’arte, strumento fondamentale della sua visibilità”.
Ma, come per esorcizzare istintiva-
mente il mostruoso e il bestiale, due figure ricorrenti proposte attraverso le opere di diversi autori, due figure di santi, luminose, che vinsero il Maligno mi hanno accompagnata nella galleria di immagini che guida il limpido saggio di Pasquini: Sant’Antonio Abate e San Michele Arcangelo. Perché è istintivo - prima che razionale e influenzato da una visione critica - a fronte di una lettura su secoli di immagini fosche e terribili, cercare il nitore, la salvezza e, con essi, la sconfitta del Male.
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi. it/2025/06/laura-pasquini-faccia-da-diavolo/


Di Michela Leonardi
Uno studio appena pubblicato dalla prestigiosa rivista analizza e spiega come ha fatto l'Homo sapiens a diffondersi dall'Africa in tutto il mondo
Dove andiamo? Da dove veniamo? Come siamo arrivati fino a qui? In questo momento di incertezza su vari fronti, la risposta alla prima di queste domande è sicuramente difficile da trovare. La scienza, però, ci aiuta a rispondere alle altre due. Per quanto riguarda la seconda, già negli anni ‘70 dell’800 Charles Darwin ipotizzava che la specie umana, la nostra, fosse nata nel continente Africano. Da allora, innumerevoli studi di varie discipline hanno confermato questa sua intuizione, e ora possiamo dire con certezza che tutti noi esseri umani veniamo originariamente dall’Africa.
Come ci ricorda il genetista Guido Barbujani nel suo omonimo libro, Gli Africani siamo noi (un dettaglio fra i tanti che dovremmo considerare quando proviamo a decidere, se non dove andremo, almeno dove vorremmo andare).
E come siamo arrivati fino qui? È una storia lunga e travagliata. Homo sapiens, la nostra specie, è nata in Africa fra i 300 mila e i 250 mila anni fa. I nostri antenati, cacciatori-raccoglitori nomadi, sono usciti dall’Africa diverse volte; e in periodi diversi troviamo i loro resti nella penisola arabica, nel Medio Oriente, in Grecia, e persino in Cina. Ma, da quanto ne sappiamo, non sono sopravvissuti a lungo in questi territori.
All’epoca, l’Europa e l’Asia erano occupate da altre specie umane (gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati i Neandertaliani e i Denisoviani). Anche i loro antenati erano arrivati dall’Africa, ma quasi due milioni di anni fa. Nel frattempo, si erano diffusi ovunque, adattandosi alla grande variabilità di climi e ambienti che incontravano. Avevano ossa leggermente diverse dalle nostre, vivevano di caccia e raccolta anche loro, e possedevano un livello tecnologico equivalente a quello dei sapiens contemporanei.
E così le piccole popolazioni di sapiens che arrivavano in Eurasia dall’Africa dovevano competere per lo spazio e le risorse con questi pa-

renti alla lontana attrezzati decisamente meglio di loro; e non hanno avuto modo di diffondersi più di tanto.
Fino a che, intorno a 50.000 anni fa, qualcosa è cambiato. I sapiens che sono usciti dall’Africa in questo periodo non solo sono sopravvissuti. Si sono diffusi, hanno incontrato i loro “cugini” nordici, ci hanno vissuto fianco a fianco e a volte ci hanno anche fatto dei figli. Nel frattempo, il clima è cambiato, le altre specie eurasiatiche si sono estinte e quel piccolo gruppo di sapiens africani ha dato origine alla popolazione umana attuale (Africa esclusa). Ma cosa è cambiato rispetto alle migrazioni precedenti? Sulla rivista Nature, è appena uscito uno studio (tra i cui autori c’è anche chi scrive qui) che ce lo racconta. Un gruppo internazionale di scienziati e scienziate ha raccolto informazioni su tutti i siti archeologici africani di Homo sapiens datati fra 120.000 e 15.000 anni fa. Li hanno poi usati per capire in quali ambienti gli esseri umani riuscivano a vivere nel corso del tempo. Così facendo, si sono accorti che intorno a 70.000 anni fa, le popolazioni africane di sapiens sono diventate più flessibili dal punto di vista ecologico. In pratica, hanno iniziato ad occupare all’interno dell’Africa zone con condizioni ambientali più estreme, dove prima non riuscivano a stare.
Come hanno fatto? Dato che gli ambienti in cui hanno iniziato a vivere sono tanti e diversi, è improbabile che questo cambiamento sia il risultato di una singola scoperta tecnologica o invenzione (per esempio dei contenitori per trasportare l’acqua su lunghe distanze). Inoltre, in questo periodo, le popolazioni diverse di sapiens iniziano ad assomigliarsi sempre di più in tutto il continente, il che fa pensare a scambi e contatti più frequenti. Questi avrebbero facilitato lo scambio di informazioni e le innovazioni tecnologiche, che a loro volta hanno permesso agli esseri umani di diventare in grado di affrontare sfide e ambienti completamente nuovi (persino quelli dell’Europa e dell’Asia che non avevano mai incontrato prima). A questo punto proviamo a tornare alle nostre tre domande iniziali. Se veniamo dall’Africa e già da 70.000 anni fa siamo riusciti a superare le difficoltà legate a nuove sfide sociali e ambientali grazie allo scambio, la cooperazione e l’integrazione di conoscenze e punti di vista diversi… Dove vogliamo andare?
Lo studio è stato diretto da Emily Hallett (Loyola University, Chicago) e Michela Leonardi (Museo di Storia Naturale di Londra, autrice di questo articolo), sotto la supervisione di Eleanor Scerri (Max Planck Institute for Geoanthropology,
Jena) e Andrea Manica (Università di Cambridge) grazie a fondi della Max Planck Society, dell’European Research Council e del Leverhulme Trust.
Fonte: Emily Y. Hallett, Michela Leonardi, Jacopo Niccolò Cerasoni, Manuel Will, Robert Beyer, Mario Krapp, Andrew W. Kandel, Andrea Manica, Eleanor M.L. Scerri. Major expansion in the human niche preceded out of Africa dispersal. Nature, DOI: 10.1038/ s41586-025-09154-0 https://www.nature.com/articles/s41586025-09154-0
Il libro di Guido Barbujani citato nel testo, che racconta la storia della nostra specie, è questo: https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858125205
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi. it/2025/06/homo-sapien-lunione-fa-la-forza/
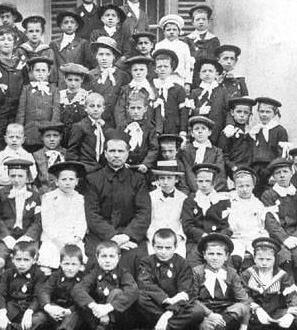
A proposito di "Autobiografia della scuola"
Di Paolo Puppa
Lo storico Mario Isnenghi ricostruisce la (ricca e prestigiosa) parabola della scuola italiana dall'Unità a Don Milani. Un saggio essenziale per capire la decadenza di oggi
Oggi, a scuola, ogni tanto gli studenti picchiano un insegnante. Capita anche ai medici, aggrediti da pazienti, esasperati da un sistema sanitario disastrato. A scuola, lo fanno pure i genitori degli alunni. Guai ad essere severi. Ti bucano le gomme dell’auto, se usi la macchina. I docenti hanno perso ogni residuo di carisma professionale. Un tempo era diverso. Mario Isnenghi (Autobiografia della scuola. Da De Sanctis a don Milani, Il Mulino, 368 pagine, 26 euro) prova a documentarci in tal senso. Il paese si confessa così in un grande itinerario collettivo per oltre un secolo e mezzo.
Oggetto, le interne migrazioni degli insegnanti, dalla elementare all’università, dall’Italia appena unita sino al fascismo e al secondo dopoguerra. Ricostruisce la carriera di alcune grandi intellettuali, maîtres à penser. Basti pensare ai due citati nel titolo del volume, da Napoli, la città più popolata della penisola da dove fermenta il magistero dell’irpino Francesco De Sanctis, esule svizzero e poi primo ministro della Pubblica Istruzione, alla desolazione di Barbiana in cui viene confinato Lorenzo Milani. Di quest’ultimo, famiglia fiorentina e triestina alto borghese ebraica, ordinato prete nel 1947, Lettera a una professoressa uscito l’anno della sua morte nel 1967, leggendario pamphlet contro la scuola di classe. Lo recensisce esaltandolo Pasolini sul settimanale «Tempo» dell’8 luglio del 1973. I gesti didattici del poeta supplente a Casarsa negli anni ’40 mostrano qualche sorprendente analogia cogli sforzi radicaleggianti del prete di Barbiana.
Nella ricostruzione di Isnenghi che scarta Pasolini risulta davvero sorprendente l’accostamento di Don Milani a Padre Agostino Gemelli, colui che aveva esultato nel suo rigorismo intransigente dopo il positivismo giovanile nel 1824 al delitto Matteotti. Ma la polemica contro le professoresse che bocciano continua l’allergia secolare ai danni delle maestrine di marca conservatrice.

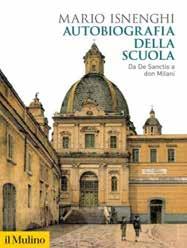
Il libro equipara i faticosi sbalzi geografici del docente attraverso lo stivale a un prolungato servizio di leva. Incessanti nomadismi generatori di scrittura, tra epistolari e diari di bordo. Ecco Pascoli passato da Matera a Massa e a Livorno, prima di approdare all’Ateneo bolognese, nelle vesti di poeta vate dietro il prototipo carducciano. O il grecista romagnolo Manara Valgimigli da Messina a Bosa sarda e al prestigioso liceo D’Azeglio torinese dove mette radici Augusto Monti. Nel frattempo si mettono a fuoco le lobbies di casta, tra tutte quella di Carducci, e poi di Giovanni Gentile, in grado di far nominare allievi e adepti, in una rete di cooptazioni, oggi diremmo baronie, grazie
all’esercizio inesausto della raccomandazione. Nondimeno, tanti i mutamenti ideologici, con date che discriminano, come 1931, giuramento universitario che richiede sudditanza all’aristocrazia della ricerca, non solo ai mediatori del sapere, 1938 legge razziale, (con cui si cacciano 40 mila nemici, assimilati da una vita e ora traumaticamente scoperti diversi) e 1943, caduta della dittatura. Incluso lo spettacolo di camicie nere indossate in fretta
da illuminismo e ventata napoleonica, Restaurazione a Santa Alleanza, conventi trasformati in scuole, e quindi dall’Italia demo-liberale a quella fascista e poi a quella antifascista o post-fascista presto riassorbita dal moderatismo guelfo, la quota più alta del Dna nazionale. Così Guido Negri, il ‘capitano santo’ nato ad Este nel 1888, che sublima in castità e apostolato per morire in guerra nel 1916 e mezzo secolo dopo il padovano Antonio
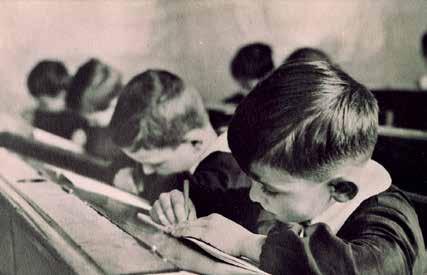
e dismesse con altrettanta rapidità. Da qui, le periodiche epurazioni che svuotano classi e rovinano profili professionali, nel passaggio
Negri operaista, anche lui disceso dalle parrocchie venete, assetato di assoluto. De Sanctis espelle dall’Università partenopea 34 bor-

bonici o disadatti a insegnare, nel sogno di laicizzare il paese togliendo collegi ai frati e educandati alle suore. All’opposto, la rete capillare dell’invasione ecclesiastica, basata su catechismi e codici, invano assorbita dai rituali fascisti che non per nulla preferiranno il compromesso del Concordato nel 1929. Tra i docenti accademici non giura fedeltà al Re e al Duce appena una dozzina nel 1931 a fronte dei mille e duecento ordinari consenzienti. Lo storico si interroga sui funzionari costretti a recitare quali militanti di una presunta ‘ora storica’, e questo nella contrapposizione tra i due termini cari all’autore. E su Piazza Venezia che osanna il Duce: mera finzione o non lo è stata piuttosto la successiva palinodia? Viene in mente allora Il vecchio con gli stivali, racconto di Brancati del 1946, dove Aldo Piscitello, fascista per forza, si divide tra il suo Io pubblico, esposto nelle adunate del Sabato, e quello privato in bagno, intento a pisciare contro le insegne prima esibite in strada.
Spuntano fuori personaggi di carta e di carne, figure amate dallo storico, Garibaldi e Nievo in particolare. Appare pure Benedetto Croce, tollerato ambiguamente dal regime nonostante la sua resilienza (ma col comunista Gramsci il fascismo si comporta più brutalmente) che trova una sponda attivistica nell’al-
tro console dell’idealismo, il siciliano Giovanni Gentile, fondatore della riforma scolastica, in cui il fascismo viene imposto quale autentica religione di stato. Lo uccidono i partigiani nel 1944. Luigi Squarzina si ricollega a questa vicenda di sangue in Tre quarti di luna, varata nel 1953, trattando i cattivi maestri sotto il fascismo. Il copione si contestualizza nel 27 ottobre del ’22, in un liceo della provincia romagnola. Il preside ossessionato dalla riforma gentiliana, creato sull’aitante fisicità di Vittorio Gassman, risulta una complessa figura di figlio dell’idealismo, poi ucciso dal seminarista spretato di Ronconi, a vendicare il compagno suicida.
Nel libro si illustrano episodi nobili, gesti sacrificali. Si veda il suicidio nell’acqua del mulino nel 1886 della povera Italia Donati, maestrina toscana, concupita dal sindaco del paesino in cui insegna e da cui dipende (a quel tempo l’amministrazione comunale si faceva carico della scuola elementare). Costei nel suo gesto estremo pretende che da morta un’autopsia che dimostri la sua innocenza le renda giustizia. Il fantasma della ragazza rivive a suo modo nell’astuto e melodrammatico La maestrina di Dario Niccodemi, affidata nel 1917 alle grazie guittesche di Dina Galli, o nella ricostruzione apologetica nel 2003 della pedagogista Elena Gia-
nini Belotti che ne fa una sorta di “Lucia Mondella acculturata”. Ma il turgore con cui si eleva il ruolo del maestro, non maestrino, e delle sue varianti di genere trova già nella Scuola Normale Femminile di Matilde Serao nel 1885 un contraltare di disincanto e di miseria, tra ispettrici grottesche e penosi canti corali imposti ad inizio della lezione mattutina. Del resto, anche Pirandello, qui assente, docente all’Istituto superiore magistrale romano descrive la proletarizzazione della piccola borghesia insegnante, come ne Il professor Terremoto del 1910. E sulla scena ne ha dipinto i tratti dispettosi e nevrotici nel suo Pensaci, Giacomino!, inaugurato nel 1916. Nella college story, il vecchio docente in scienze naturali, nel suo odio per lo Stato, sposa la giovanissima figlia del portiere, incinta di Giacomino, in un bizzarro ménage a tre che ne consegue, pur di vendicarsi strappando una pensione, pertanto prolungata.
Ma l’idea mobilitante del libro risiede nella “trascinante campagna di acculturazione delle plebi rurali”. Contadini e anche donne, però. A sradicare antichi stereotipi sulla fissazione della donna quale angelo del focolare. A tale proposito, Isnenghi parla di “cantieri cattolici” a segnarne i passaggi controversi e delicati. Occorrono gradualismi e snervanti oscillazioni verso lo spet-

tro dell’emancipazione femminile, come le incertezze del narratore vicentino Antonio Fogazzaro, perseguitato dalla Chiesa per il suo modernismo. Titubanze che gli tolgono però il Nobel nel 1907, finito a Kipling. Splendido il capitolo dedicato all’educazione virilista da caserma autoritaria all’infante Vittorio Emanuele III nelle mani circospette del professor Luigi Morandi italianista. Subito dopo, in dialettico contrasto, il figlio della maestra e del fabbro, Benito Mussolini, sbandato, copia del Franti di Cuore, frequentante il carcere e bordelli, addestrato in collegio salesiano a Faenza e poi nel collegio laico di Forlimpopoli diretto dal fratello di Carducci. Questo, prima della ventennale beatificazione. Escono altresì figure complesse, come De Amicis che dopo i bozzetti de La vita militare, i languori di Cuore o l’epopea del coevo Romanzo di un maestro non teme di schierarsi a favore del socialista Filippo Turati sotto processo. Di contro si manifestano orrori, servilismi e hybris dei vincitori. Norberto Bobbio che scrive una lettera umiliante al Duce per non finire in manette, una volta scoperte le sue connivenze con Giustizia e libertà, rivendicando parenti generali. Ma non tutti possono essere eroi come Leone Ginzburg. Ora lo storico, se mantiene un aplomb verghiano, a volte esplode con aspre interiezio-
ni, specie nel discorso sul ventennio, di fronte alle spedizioni punitive nelle aule contro i professori neutrali o socialisti, o alla ferocia nel 1938 della legge razziale. Quando il giovane fisico Bruno Rossi, genero di Lombroso, esce dall’Università di Padova, salutato e pianto solo dall’umile bidello, esplode in “Brividi. Vergogna”.
Il fatto è che l’occupazione militare delle coscienze avviene proprio nella scuola, dove Isnenghi ripresenta le inaugurazioni solenni, le prolusioni dei presidi, le ritualità celebrate, le antologie preposte allo scopo di selezionare il passato ad uso del presente, il libro unico per la scuola elementare. E insieme si sedimentano miti fondanti, tra balilla e figli della lupa, dall’entrata in guerra all’affermazione di un illegalismo divenuto sacralità del nuovo ordine nazionale. Eccolo ancora definire “oscena” la sparizione del logo Treves dalle pubblicazioni del grande editore triestino, eccolo ergersi indignato verso Farinacci, “energumeno”, allorché lo vede inaugurare nella sua Cremona un Istituto magistrale parlando della donna. Cacciati i professori ebrei, faticano a rientrare dopo la liberazione, mentre quelli che li hanno cacciati possono restare, per amnistie e condoni/perdoni. Insomma, non si sono fatti i conti col ventennio, visto quale parentesi marziana,
e non invece autobiografia del Paese, dunque. Omissione che spiega forse il momento politico che stiamo vivendo oggi.
In Italia ci sono 78 % di analfabeti nel 1861, si lamentava De Sanctis nel suo primo discorso alla Camera, ridotti nel 1991 al 2,1%. Eppure, nell’ultima delle 325 pagine, l’autore si sbarazza bruscamente del lavoro. Appare rassegnato. Si scaglia contro l’anglo-crazia che incombe nei corsi accademici, così come contro l’aziendalizzazione delle scelte ministeriali, per cui la scuola è considerata mera voce economica, non più strumento di educazione. E l’ultimo testo citato suona da triste congedo, le puntate uscite nel 1987 sul «Manifesto» a firma del napoletano Domenico Starnone. Ex cattedra decreta con triste arguzia come insegnare non sia più una missione, ma nemmeno un mestiere.
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi. it/2025/07/mario-isnenghi-la-scuola-e-finita/