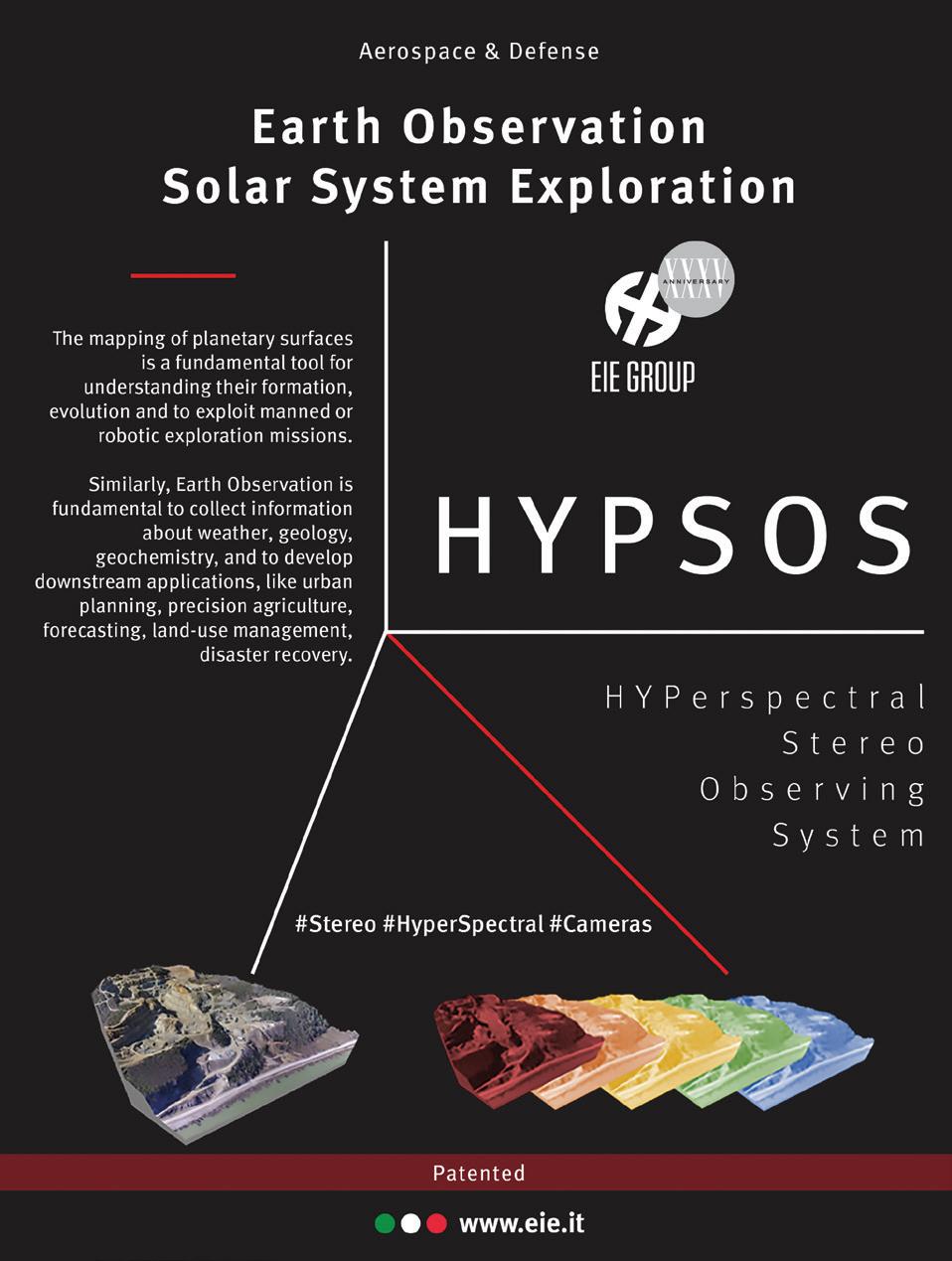60 anni di Spazio Italiano: Broglio e la storia del progetto San Marco
I progetti più iconici di EIE GROUP che festeggia i suoi 35 anni di attività





















60 anni di Spazio Italiano: Broglio e la storia del progetto San Marco
I progetti più iconici di EIE GROUP che festeggia i suoi 35 anni di attività



















La nuova legge sullo spazio, o meglio sull’economia dello spazio è stata varata dal parlamento italiano. Al di là delle inevitabili polemiche politiche tra maggioranza e opposizioni, la nuova legge prende atto in primo luogo che il settore spaziale è ormai una realtà per lo sviluppo economico assai rilevante con potenzialità che saranno sempre più crescenti. E in questo contesto è inevitabile da una parte scrivere le regole per un mercato che in Europa sta avviandosi e che necessita di una regolamentazione, di relative certificazioni, ma anche al contempo vi deve essere un sistema che permetta alle imprese più piccole di poter entrare in questa nuova corsa all’oro. Il tutto condito da una visione che deve necessariamente essere governativa e un domani del governo europeo.

Lo spazio non è più una sola attività di ricerca. Da tempo è una realtà industriale importante, ma basata sull’investimento pubblico. Oggi è una realtà dove il privato è rilevante e può esserlo sempre di più e per questo devono esserci delle norme come anche una visione strategica del paese e del continente. Aspetto questo che è stato manchevole a livello europeo, troppo impegnati, come ci ha ricordato Mario Draghi, a far prevalere il concetto del ritorno alla pari dell’investimento, piuttosto che la crescita nel settore dell’intero



In questo contesto il ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana diventa prevalentemente tecnico e per questo essenziale nel valutare e consigliare l’organismo di governo che dovrà scegliere le strategie migliori per il paese, perdendo quella autonomia che contraddistingueva questo organismo fino al 2018, poco tempo fa. Rimarrà una componente di ricerca e di sviluppo tecnologico che sarà tema prevalente se non esclusivo dell’ASI almeno fino a che questo aspetto non raggiunga quella maturità che ha dato vita alla space economy.
Siamo in una fase di transizione resa ancora più complessa in un quadro geopolitico internazionale terremotato le cui nuove fondamenta sono ancora in fase di costruzione. Per questo dare una regolamentazione ad un mercato magmatico dove la logica della corsa all’oro potrebbe prendere il sopravvento è un passaggio apprezzabile che, ci si augura, possa portare lontano nel rispetto delle esigenze di sicurez-
Spazio e Apsara - Da un'articolo di Riccardo Corrado
La (bella) favola di Pumps&Pipes 20 LuGRE è sulla Luna
Il meglio del 2024 in breve - Flash news dallo spazio 25 Speciale EIE GROUP
- Inserto speciale per festeggiare i 35 anni dalla fondazione
35 anni di EIE GROUP - Editoriale a cura di Gianpietro Marchiori
Guerra tra AI. DeepSeeck Vs ChatGPT - Flash news dallo spazio
La Valle - Estratto dal libro di Paolo di Reda
I progetti più iconici di EIE
Gianpietro Marchiori
La Carbonara dei carbonari di Sante Lancerio e Sommelier Franz
Vent'anni d'Arte Fascista
- Articolo di Toti Scialoja pubblicato sul primo numero di Mercurio
L'eredità di Biden
Apologia della Disubbidienza
Toti Scialoja Sguardi e Battaglia
- La critica d'arte nei saggi di Mercurio
Direttore responsabile
Paola Nardella pinar2019@gmail.com
Hanno collaborato a questo numero
Anilkmar Dave
Fabrizio Beria
Paolo Di Reda
Gruppo EIE
Succede Oggi Editore
Progetto grafico
Davide Coero Borga
Realizzazione grafica
Maria Carlotta Spina
Web editor
Fabrizio Beria
Concessionaria pubblicitaria
Pinar Marketing & Comunicazione
Contatti
0683425014 www.artemiscience.news
Editore
Pinar Marketing & Comunicazione www.artemiscience.news

Crediti immagini
Esa, Nasa, Archivio Fausti, Pexels, Unsplash, Gemini, EIE GROUP, Wikimedia Commons, Succedeoggi, Fondazione Toti Scialoja


Di seguito un estratto dal volume di Giovanni Caprara “Storia Italiana dello Spazio” edito da Bompiani.
Come eredità dell’Anno geofisico internazionale, e secondo gli orientamenti espressi dalla National Academy of Science, c’era particolare interesse a esplorare l’alta atmosfera, un ambiente del tutto sconosciuto per l’impossibilità di raggiungerlo con i mezzi allora a disposizione. Solo i razzi potevano aiutare a salire a quelle quote, come aveva dimostrato l’impiego del gruppo di missili v2 portati negli Stati Uniti dalla Germania come bottino di guerra e lanciati con apparecchiature scientifiche dal poligono di White Sands nel New Mexico (Usa). A ciò si aggiungeva un parallelo interesse della difesa, che aveva bisogno di conoscere l’alta atmosfera perché questa interagiva con il rientro delle testate nucleari lanciate dai missili influenzandone la precisione.
[….]
Seguendo tale indirizzo, l’Italia puntava a una collaborazione con gli USA nel programma scientifico varato dalla Commissione ricerche spaziali per l’esplorazione scientifica dell’alta atmosfera con razzi sonda, che si inseriva in un’attività già svolta dalla Nasa con razzi lanciati dalla base di Wallops Island, in Virginia. Aggiungendo sondaggi da altre zone del pianeta le indagini si rafforzavano e quindi l’interes-
se a collaborare cresceva da ambedue le parti. Tra l’altro, nelle gallerie del vento del Centro ricerche aerospaziali sulla via Salaria a Roma già gli specialisti del professor Broglio si occupavano delle indagini aero-termodinamiche connesse al rientro dallo spazio su contratti garantiti dall’Usaf. Quindi c’era già un’area di studio di interesse comune ben avviata, sul cui filone ora si aggiungevano i rilievi degli strati più elevati effettuati attraverso i razzi. Non fu perciò difficile trovare subito un accordo con la Nasa, siglato nell’aprile 1960.
[….]
… prende forma l’avventura africana del professor Luigi Broglio e quindi la nascita dell’attività spaziale italiana. C’erano un luogo e una data nei quali i programmi e le aspirazioni si con-
cretizzavano: Firenze, 1961. In quel periodo quattro personaggi legati tra loro da inte-ressi comuni animavano in particolar modo la politica italiana e l’economia in un’ottica internazionale: il presidente della repubblica Giovanni Gronchi, Amintore Fanfani, il sindaco di Firenze Giorgio La Pira e il presidente dell’Eni Enrico Mattei.
[….]
Il 1961 registrava per la prima volta un’iniziativa anomala per la politica italiana: in dicembre la Democrazia cristiana, il partito al governo, organizzava un convegno dedicato alla ricerca che, in un certo senso, era conseguenza di un altro convegno, della Confindustria, tenutosi nell’anno precedente, in cui si era lamentata l’arretratezza tecnologica del paese e le inesistenti politiche per miglio-

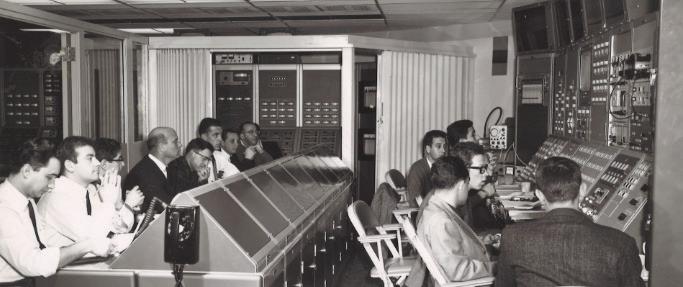
rare la situazione. I progetti spaziali che stavano entrando in scena erano quindi visti con occhi positivi e si aggiungevano al fronte nucleare già avviato. Tra i più stretti amici di Fanfani c’era Giorgio La Pira.
[…]
Per promuovere e consolidare nuove e utili relazioni si cercava e accoglieva ogni opportunità. Così si riusciva a organizzare a Firenze il congresso annuale del Cospar (Committee on Space Research), il comitato internazionale che riuniva gli scienziati impegnati nelle scienze spaziali, allora forzatamente protagonisti, sia pure indirettamente e in chiave civile, delle vicende che animavano il confronto della Guerra fredda. Non era un caso se l’amministrazione comunale si impegnava nell’iniziativa.
[…]
L’occasione, però, era propizia per qualcosa di più importante ed era ideale per sondare i rappresentanti della Nasa sulla disponibilità a collaborare a un progetto che Broglio aveva elaborato come presidente della Commissione per le ricerche spaziali. Tale progetto, battezzato San Marco, veniva approvato dalla Commissione nel gennaio 1961 nell’ambito del piano triennale 1961- 1963.
L’occasione per proporlo si presentava proprio a Firenze, dove era arrivata la delegazione statunitense guidata da Arnold W. Frutkin, direttore dell’ufficio per la cooperazione internazionale della Nasa.
[…]
La proposta fatta a Frutkin era uno dei passi essenziali che Broglio stava compiendo per raggiungere l’obiettivo. Ma prima di avanzare l’idea nella serata conviviale Broglio si era già assicurato il consenso ufficioso del presidente del consiglio Fanfani, con il quale si incontrava sabato 14 gennaio 1961.
[…]
L’agosto 1961 e la riunione a Palazzo Chigi, con l’approvazione ufficiosa del progetto San Marco (quella ufficiale del governo seguirà in ottobre), segnavano dunque l’ingresso della politica italiana in un’attività fino allora limitata a pochi studi universitari, ad alcune sperimentazioni nelle forze armate oppure all’iniziativa privata di qual- che appassionato isolato. Il passaggio era ormai necessario, reso obbligato dalle esigenze interne e internazionali.
[…]
Nel marzo 1962 il progetto preliminare del satellite era pronto e il mese
successivo Broglio tornava a Washington per lavorare all’organizzazione del programma definito in un memorandum tra la Commissione ricerche spaziali e la Nasa, firmato poi a Ginevra da Broglio e Dryden il 31 maggio. Intanto i rispettivi governi precisavano gli aspetti diplomatici e l’accordo conclusivo, con allegato il memorandum di maggio, veniva sottoscritto il 5 settembre 1962 addirittura dal vicepresidente americano Lyndon B. Johnson, presidente anche dello Space Council, giunto appositamente a Roma, e dal ministro degli esteri Attilio Piccioni.
[…]
Il gruppo romano, dopo l’accettazione da parte della Nasa del piano per la costruzione di un satellite scientifico, aveva davanti a sé, in quei mesi del 1961, il problema di trovare un luogo da dove lanciarlo con il razzo Scout.
[…]
La realizzazione della base rischiava di ostacolare l’intero programma. La soluzione arrivò da Carlo Buongiorno, stimolato dalla presentazione in un telegiornale di una piattaforma per l’estrazione petrolifera dell’Eni costruita dalla Nuovo Pignone.
[…]
Nella sua idea, Buongiorno aveva tro-
vato due elementi favorevoli alla realizzazione. La Nuovo Pignone era di Firenze ed era stata salvata da Enrico Mattei grazie all’intervento del sindaco La Pira. Ora, essendo entrambi i personaggi strettamente legati a Fanfani, dopo il satellite potevano diventare di nuovo la chiave per risolvere anche il problema della base.
[…]
La situazione africana intorno al Kenya non era politicamente tranquilla: in Uganda si era verificata una rivolta di due reggimenti e nello stesso Kenya c’erano manifestazioni contrarie al governo. Nascevano quindi delle preoccupazioni nel Dipartimento di stato americano, il quale convocava Broglio a Washington.
Nell’incontro, anche alla presenza del rappresentante della Nasa, per ragioni di sicurezza esasperate dal Dipartimento di stato si ipotizzava l’im-
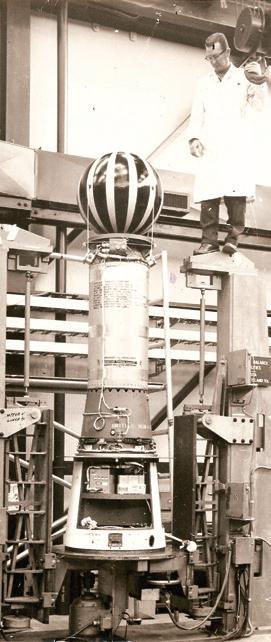
possibilità di avviare il piano stabilito, portando dei razzi sonda in Kenya da far partire dalla piattaforma. In alternativa si proponeva di lanciare il satellite San Marco da Cape Canaveral con un razzo Thor-Delta, più potente. Questo significava abbandonare l’autonomia con l’uso del poligono italiano e ridimensionare l’intero progetto. Broglio rifiutava, con il consenso ufficioso della nasa. […]

Il memorandum firmato da Johnson e Piccioni prevedeva che il progetto San Marco si sviluppasse in tre fasi. Nella prima si precisava che il satellite con la sua strumentazione scientifica doveva essere collaudato con il lancio
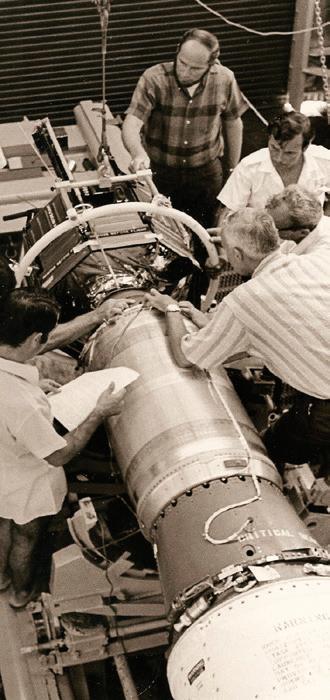
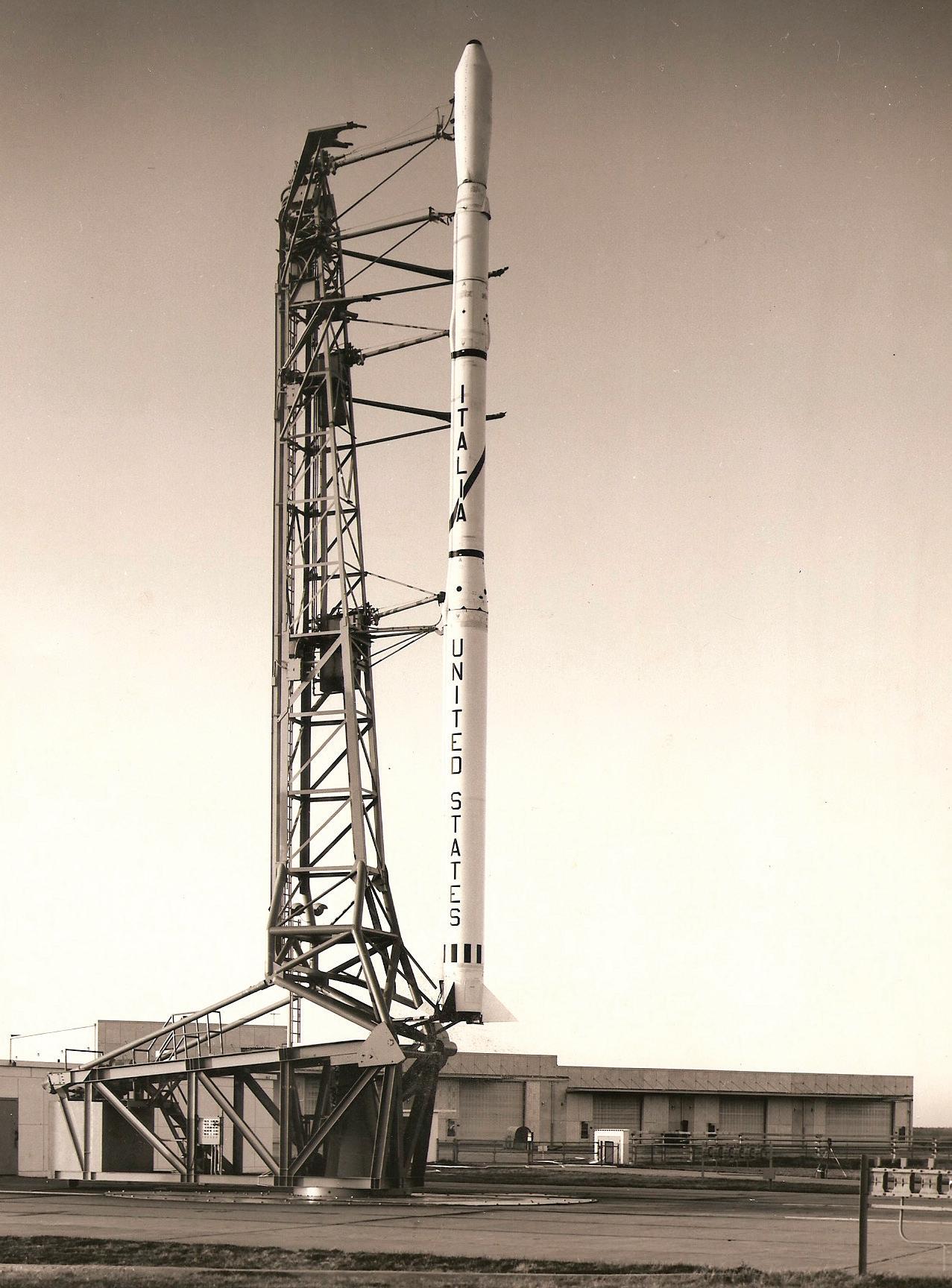

di un razzo sonda compiendo una traiettoria parabolica, senza arrivare nello spazio. Nella seconda il satellite doveva esse- re portato in orbita attorno alla Terra lanciandolo con un razzo Scout dalla base americana di Wallops Island, sulla costa orientale degli Usa. La terza e ultima fase stabiliva che il satellite San Marco venisse lanciato in orbita equatoriale con un razzo Scout dalla piattaforma mobile ancorata davanti alle coste del Kenya. La Nasa forniva gratuitamente i vettori in cambio delle informazioni scientifiche che si sarebbero raccolte e addestrava i tecnici italiani alle operazioni di lancio. […]
Il lancio del San Marco 1 da Wallops Island
Il loro arrivo nella base, che a quel punto era popolata da una massiccia presenza italiana, era una festa carica di tensione. Dopo pochi giorni il primo satellite tricolore sarebbe partito per lo spazio segnando la prima importante tappa di un’impresa che sembrava impossibile.
La tensione era inevitabile, anche perché nei mesi precedenti i nostri tecnici erano stati addestrati per effettuare direttamente loro il lancio, sia pure controllati a vista dai colleghi americani. Si trattava quindi di una doppia prova determinante, da
superare con successo e senza intoppi per consentire l’ambitissimo passo successivo e il coronamento del progetto, cioè il lancio dalla base mobile tutta italiana in Kenya.
Il momento fatidico giungeva il 14 dicembre 1964 e sulla costa atlantica soffiava un vento gelido, non tanto pericoloso però da insidiare le operazioni di lancio. Nel centro di controllo, al di là della vetrata che separava i tecnici, tra gli ospiti sedevano Hugh L. Dryden, vice amministratore della Nasa, e Sergio Fenoaltea, ambasciatore italiano a Washington.
Finalmente il 15 dicembre 1964 alle 20 e 24 minuti (utc) lo Scout, al suo trentacinquesimo volo, si sollevava dalla rampa portando il San Marco 1, una sfera di 66 centimetri di diametro pesante 115 chilogrammi, intorno alla Terra su un’orbita ellittica alta 846 chilometri nel punto più lontano e 198 nel punto più vicino.
Il lancio
del San Marco 1 avvenuto il 15/12/1964


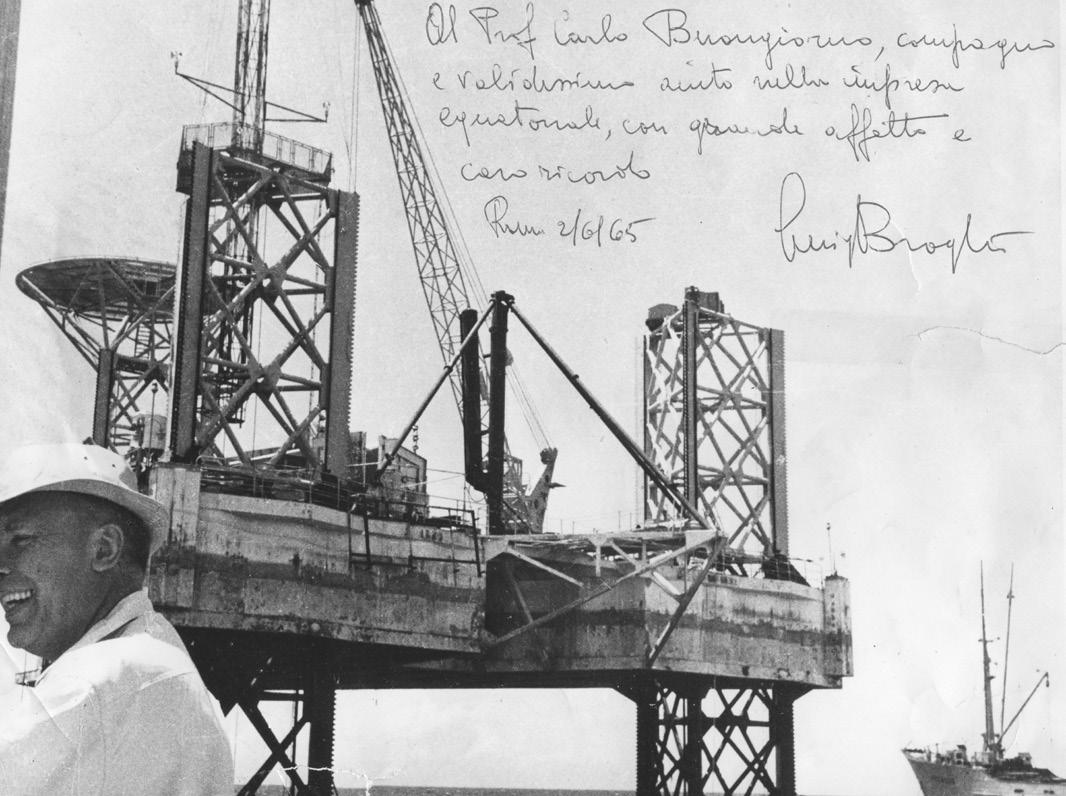
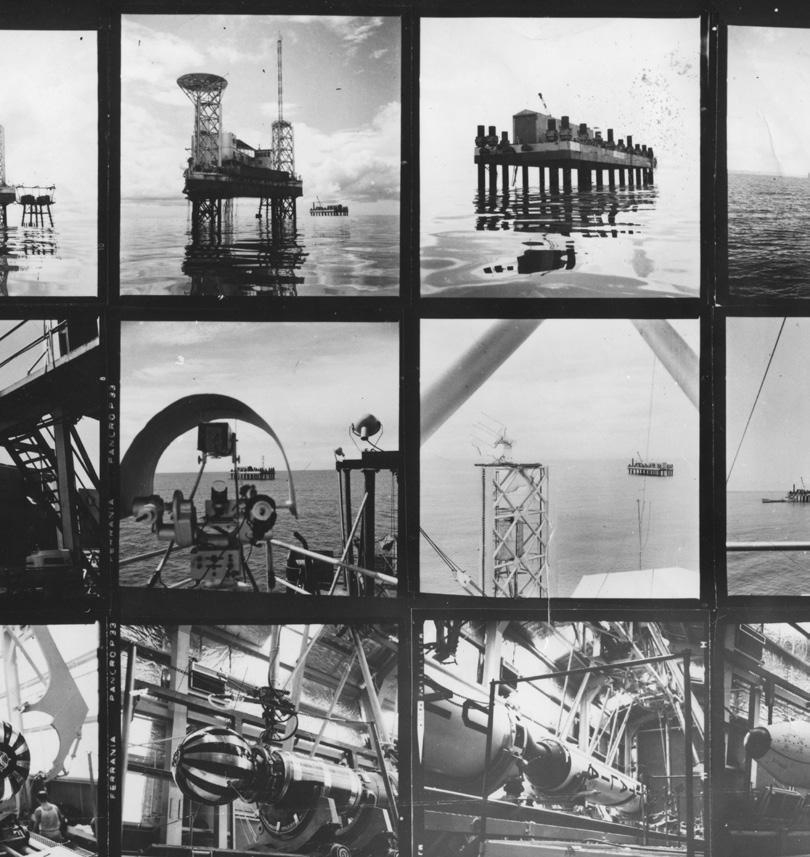





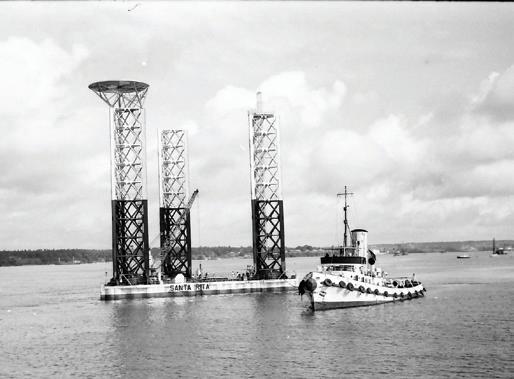




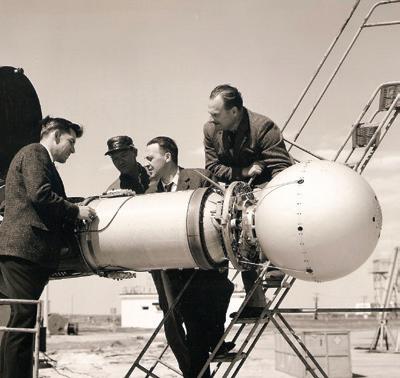

STAM è leader nella consulenza ingegneristica e nei servizi per l’innovazione con oltre 25 anni di esperienza nel settore spaziale. Competenze multidisciplinari e intersettoriali, un team di 100 ingegneri, laboratori interni per supportare proof-of-concept e partnership con più di 1500 stakeholders (imprese, start-up ed enti di ricerca) in tutta Europa sono i nostri punti di forza.


STAM agisce come ESA Technology Broker per l’Italia e gestisce in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana il Fondo ESA Spark Funding.
www.stamtech.com

Di Riccardo Corrado
La Cambogia, spesso trascurata a favore dei suoi due vicini, Thailandia e Vietnam, generalmente più conosciuti in Italia, è un tesoro a volte sottovalutato, che racconta storie, intrecci di divinità, eroi e leggende che trasformano ogni angolo del Paese in un capitolo vivente di un antico poema epico.
La sua capitale Phnom Penh, posizionata dove il Mekong e il fiume Tonle Sap si abbracciano, ha una storia tutta sua, plasmata da un periodo coloniale, poi di indipendenza, e dopo una tragica sofferenza negli anni dei Khmer Rossi, ora in rapidissimo sviluppo. Il suo nome stesso, Phnom Penh, nasconde una storia tra realtà e mito. La storia risale al XIV secolo, quando una donna di nome Daun Penh viveva lungo il fiume Mekong. Un giorno, durante una piena, trovò un grande albero trasportato dal-
la corrente con al suo interno quattro statue del Buddha e una di Vishnu. Interpretando questo evento come un segno sacro, Daun Penh decise di costruire una collina artificiale (phnom) per collocare le statue in un luogo degno di venerazione. Quella collina si trova al centro di Phnom Penh, e al suo apice è posizionato un tempio, oggi conosciuto come Wat Phnom, il tempio sulla collina. Da qui nacque il nome Phnom Penh, ovvero "La Collina di Penh".
Vicino al Wat Phnom, a cinque minuti di strada, si trova la CamEd Business School, rinomata università nel paese per business, finanza e accounting. E ci si potrebbe domandare, cosa c'entra questo con lo spazio e con l’Italia, ma in realtà c’è un collegamento diretto e magari inaspettato.
Probabilmente per i lettori di questa rivista, non sarà una sorpresa il fatto che ogni 16 dicembre si celebra la Giornata Nazionale dello Spazio, evento celebrato sia in Italia che nel mondo. Tale evento celebra l'importanza delle tecnologie spaziali per lo sviluppo sostenibile e la sicurezza del Paese, sensibilizzando il pubblico sull'importanza dell'innovazione spaziale, tramite conferenze, mostre, osservazioni astronomiche e attività educative al fine di ispirare le nuove generazioni a guardare oltre i confini terrestri.
Ebbene, lo scorso dicembre, per la prima volta nel paese, una celebrazione a

tema spaziale è stata condotta, ed è stata tutta italiana. L’evento è stato organizzato dalla ItaCham, capitolo italiano della Camera di Commercio Europea, in collaborazione proprio con quella CamEd Business School che si trova a cinque minuti dal Wat Phnom. L’evento è stato pensato come un’agenda di tre giorni, con evento focale un dialogo che ha visto speaker illustri da ovest (Italia) a est (Cambogia).
Presenti professori dell’Università di Trieste che hanno presentato il Progetto RISE (Resilient Integrated Structural Elements), focalizzato sul semplificare l’assemblaggio di small satellites attraverso una struttura stampata in 3D, e testata sulla International Space Station proprio nello stesso periodo. Presenti anche rappresentanti di aziende italiane quali NPlus, azienda parte del gruppo Riello, specializzata nel monitoraggio della salute strutturale, tramite uso di sensori a terra e rilevamenti satellitari, anche in applicazioni per la preservazione di edifici culturali e storici, come il Duomo di Milano. Oppure MEEO, agenzia d'eccellenza dedicata allo sviluppo e all'implementazione di prodotti e servizi basati sul telerilevamento del sistema Terra-Atmosfera.
Non soltanto Italia, ma anche Cambogia con professori dell’Istituto Tecnologico della Cambogia (ITC) a raccontare e condividere quanto fatto finora in ambito di collaborazioni a livello accademico, una ricercatrice cambogia-

na che lavora nel Singapore-ETH Centre, un centro di alta ricerca creato nel 2010 dal ETH Zurich in collaborazione con il Singapore's National Research Foundation, a discutere dell’utilizzo di immagini satellitari per applicazioni di monitoraggio urbano. O ancora il vice direttore del Satellite Department del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Cambogiano, a illustrare quanto fatto nel recente passato dal Governo Cambogiano, e le priorità e iniziative per il prossimo futuro. E ancora, un rappresentante del Council for the Development of Cambodia (CDC), il massimo livello decisionale del governo per gli investimenti nel settore privato e pubblico in Cambogia che ha condiviso gli schemi e gli incentivi per gli investimenti in ambito tecnologico e spaziale. Il tutto a concludersi con le parole di Anilkumar Dave, esperto della Space Economy, che ha condiviso consigli per poter sviluppare in maniera sostenibile una space economy nel paese, partendo da passi concreti, e perché no, con progetti di collaborazione Italia-Cambogia.
Durante tutti e tre i giorni, uno schermo nella hall dell’università, aperta a tutti gli studenti e gli interessati, ha mostrato i video e le immagini fornite dall’Agenzia Spaziale Italiana sulla storia dell’Italia nello spazio, e sull’eccellenza italiana in tale ambito. Il tutto accompagnato da due corone di danzatrici Khmer, usate nel Royal Ballet Cambogiano.
Il Royal Ballet è una danza tradizionale, eseguita da secoli, che mette in mostra l’eredità culturale del paese, con i suoi movimenti aggraziati, gesti complessi delle mani e costumi elaborati, e che spesso racconta scene della mitologia e della storia cambogiana. L'Apsara, una ninfa celeste, è la figura centrale nel balletto, e simboleggia bellezza, grazia e femminilità divina, e indossa una corona simbolo di regalità e divinità, con disegni intricati che simboleggiano la connessione del ballerino con gli dèi e la corte reale. Questi elementi riflettono l'identità spirituale e culturale della Cambogia, e regalano sensazioni eteree. Assieme alle corone, due dipinti messi a disposizione da una galleria d’arte e fatti appositamente per tale evento da un artista locale. Come dire: spazio, scienza, tecnologia, arte e bellezza sembrano fatte per stare insieme. Alla fine, Axiom e Prada hanno già mostrato che aziende, a prima vista in ambiti completamente diversi, possono dare vita a collaborazioni che fanno sognare. Quando si apre la mente alla creatività e all'innovazione, non ci sono limiti.
Tema delle tre giornate: The Space Apsara. Il legame tra divinità, stelle, mitologia, scienza e tecnologia, tutto a portarci tra le stelle, e poi indietro, per qualcosa di più terrestre: una collaborazione futura tra i due paesi, per educazione, sviluppo tecnologico, investimenti e progetti attorno allo spazio. Tra Italia e Cambogia, guardando lassù, satelliti italiani tra Apsara cambogiane.



attività. Nacque così la prima edizione dell’evento ‘Pumps&Pipes’.
Di Anilkumar Dave
C’erano una volta, un amministratore delegato di una multinazionale del petrolio e il direttore di cardiologia del più grande centro ospedaliero del mondo seduti in business class su un volo New York - Houston. La “leggenda” vuole che dopo le prime 2 ore di disbrighi personali, al fatidico momento del pasto a bordo (ricordiamoci che stiamo parlando di business class), i due cominciano a chiacchierare del più e del meno: di lavoro, di problemi al lavoro, di soddisfazioni al lavoro, di ricerca e sviluppo al lavoro, di nuove prospettive di lavoro. Al termine del lungo volo (sempre in business class) una cosa era a loro chiara: il loro lavoro era fatto di ‘pompe e tubi’.
Questa “scoperta” li porta ad organizzare un primo incontro tra gli ingegneri della grande azienda petrolifera e i chirurghi del grande centro ospedaliero per condividere alcune loro
Houston è la quarta città per dimensione degli Stati Uniti con più di 500 miliardi di dollari di PIL e una popolazione in costante crescita (del 18% ogni anno). La città ha una delle popolazioni più giovani, più in rapida crescita e più diversificate al mondo: uno su quattro dei 7 milioni di residenti della regione è nato all’estero e circa 400000 millennial si sono formati qui finora. Gli stessi millennials che, fortuna o sfortuna loro, non hanno visto la serie DALLAS in televisione, non sanno chi sia JR ma sanno comunque che Houston ed il Texas sono fortemente legati all’estrazione petrolifera.
Houston impiega quasi 250000 addetti, un terzo dei posti di lavoro della nazione in quell’industria ed è sede di oltre 4.700 aziende legate all’energia, rimanendo anche avamposto mondiale per gli investimenti in ricerca nell’energia rinnovabile e nella transizione energetica. La massa critica creata da una concentrazione così elevata di aziende e opinion leader offre opportunità per tutti i settori dell’industria energetica, da quella tradizionale a quelle nate dalla cross-contaminazione con altri ambiti (es Deep Tech, Gaming ecc). C’è un interessantissimo elemento che viene spesso citato anche dalla rappresentanza del territorio (Greater Houston Partnership): Houston è la quarta città degli Stati Uniti per concentrazione di ingegneri.
I millennials di cui sopra, sono però più consapevoli del secondo pilastro

economico della città: le scienze della vita. Il Texas Medical Center (TMC) è il più grande centro medico al mondo con più di 100000 dipendenti, 60 istituzioni presenti, 21 ospedali, 8 centri di ricerca avanzata, 10 centri di formazione specializzata. Ma i numeri più impressionanti sono i 160000 pazienti all’anno ed i 7 milioni di visitatori che frequentano il campus (che è comunque riduttivo chiamare così, essendo una vera e propria città nella città). Questa concentrazione di competenze ha portato all’insediamento di più di 1000 aziende del settore medicale e ad attrarre fondi per la ricerca per un valore di poco sotto ai 2 miliardi di dollari l’anno. Se la città è al quarto per numero di ingegneri è però al terzo posto (fonte U.S. Bureau of Labor Statistics) per medici e personale sanitario.
Con queste premesse, Pumps&Pipes aveva creato un certo livello di aspettative, che furono tutte confermate visto il numero crescente di partecipanti e l’impulso che alcuni attori (TMC in primis) avevano dato allo sviluppo di startup, di un ecosistema di investitori, di nuove competenze. Mancava una cosa però. Non si saprà mai quale fu la fata o l’elfo che fece scattare l’incantesimo ma di sicuro una voce fuori campo ad un certo punto disse “Houston è nell’immaginario mondiale la città dello Spazio per eccellenza, lo Spazio è il terzo pilastro economico della città, perché non li includiamo?”. Nacque così la versione attuale dell’evento ‘Pumps&Pipes’.
Una contaminazione di saperi e di
iniziative per tutti i palati, dalla cardiochirugia (il cuore artificiale è da anni un best seller e il dott. Bill Cohn un relatore che ascolterei all’infinito) all’energia (non è un caso che Exxon, Shell vogliano raccontare qui i progressi dei loro più grandi centri di accelerazione di startup, che hanno voluto basare in città) passando per lo Spazio (SpaceX, NASA, Axiom Space, serve dire altro?).
L’edizione del 2024 è stata particolarmente interessante per molti motivi. In primis è stato l’evento che ha inaugurato il nuovissimo edificio del TMC, una sola parola: bellissimo. Per gli habitué delle mappe digitali si può cercare ‘7255 Helix Park avenue’ (confermo, non c’è nessuna casualità nell’indirizzo, è tutto voluto). È stato anche l’evento delle prime edizioni: il pitch di startup (presenti in sala medici, ingegneri e investitori) e la competizione per le scuole (presenti in sala medici, ingegneri, investitori e giovani). Per la cronaca ha vinto una startup che utilizza tecnologie spaziali per sviluppare un sistema autonomo di analisi non invasiva dei tubi (interno ed esterno) che, nella versione miniaturizzata, può essere usato per le arterie. Perché la cosa non mi stupisce? La competizione tra le scuole ha visto la vittoria di un team di due ragazzini nerd, una ragazza (che era il vero genio del gruppo) e un ragazzo che non ha smesso di baciare dopo la vittoria il loro rover. Oggetto della competizione? Sviluppare un prototipo di piccolo rover autonomo spinto da una reazione chimica e vedere quanto percorso fa. Undici metri sono quelli che hanno permesso loro
di vincere. Abbiamo chiesto il bis, era troppo bello vederli così trepidanti nel seguire il loro gioiello.
L’evento 2024 è stato anche l’occasione per Norman Garza (direttore della Texas Space Commission) di annunciare lo stanziamento della cifra monstre di 250milioni di dollari per sviluppare un’area industriale dedicata ad attrarre aziende Spazio di altri paesi ma anche di creare una scuola professionale (traduco, in Italia sono gli ITS), un museo dello Spazio, un acceleratore di startup, una seri di laboratori in collaborazione con la Rice University e uno spazioporto. Nel successivo piano (confidenza di Norman durante il buffet) vorrebbero inserire un parco tematico ed un hotel. Non male.
Vissero tutti felici e contenti? Ancora no. Bisogna preparare l’edizione del 2025 (data prevista 8 dicembre, iscrizioni già aperte) con un occhio ai nuovi trend, si parlerà forse di AI ma anche di robotica applicata ai tre settori e di come le università del territorio (è un sistema piuttosto competitivo) possono attrarre studenti ma anche docenti per migliorare il loro posizionamento. La sfida è aperta, così come quella di avere più partecipanti esteri: il premio speciale del 2024 (foto di rito con i due fondatori e maglietta) lo ha vinto un entusiasta della cross-contaminazione dall’Italia. Il mio lieto fine, che ho già inquadrato e orgogliosamente indossato.

Il ricevitore è uno dei 10 payload a bordo del lander Blue Ghost

Il ricevitore italiano LuGRE ha raggiunto la Luna. Il 2 marzo alle 9:34 ora italiana, Blue Ghost, il lander di Firefly Aerospace, ha compiuto un allunaggio morbido nel Mare delle Crisi A bordo del veicolo, parte del programma Commercial Lunar Payload Services della Nasa, 10 strumenti scientifici. Tra questi l’italiano LuGRE, sviluppato in Italia da Qascom per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana con la collaborazione della NASA e il supporto scientifico del Politecnico di Torino.
L’allunaggio è avvenuto con una caduta libera controllata, grazie ai retrorazzi che hanno guidato il lander verso il Mare delle Crisi, dopo 2 mesi di viaggio e 3 settimane di permanenza in orbita lunare. Blue Ghost, atterrato all’alba lunare, avrà a disposizione da oggi 16 giorni di luce solare per operare, evitando il congelamento dovuto alle temperature estreme della notte lunare. L’accensione di LuGRE, rimasto spento nella fase di discesa, è prevista circa otto ore dopo il touchdown, contestualmente all’attivazione dell’antenna per le trasmissioni verso la Terra.
LuGRE è uno strumento di fondamentale valore per la ricerca nel campo della navigazione satellitare nello spazio profondo che ha già raggiunto una serie di traguardi cruciali.
LuGRE è il primo ricevitore GNSS a
operare oltre l’orbita bassa, progettato per funzionare in orbita lunare e sulla superficie della Luna e il primo strumento attivo italiano sul nostro satellite. Ha acquisito per la prima volta i segnali GPS oltre i 200.000 chilometri dalla Terra e Galileo oltre l’orbita terrestre.
È stato il primo esperimento a dimostrare l’uso combinato dei segnali GPS e Galileo nello spazio lunare: mai prima d’ora questi segnali erano stati ricevuti e processati con successo a una distanza così elevata dalla Terra. Nel dettaglio, il segnale più lontano è stato acquisito a una distanza pari a circa 410.000 chilometri.
LuGRE completerà la fase finale del suo esperimento dalla superficie, contribuendo a una vasta banca dati scientifica disponibile dopo 6 mesi. Questi dati diventeranno una risorsa fondamentale per i ricercatori e saranno utilizzati per sviluppare e ottimizzare i ricevitori del futuro, migliorando le capacità di comunicazione e analisi nei settori scientifico e tecnologico.
Una sfida vinta l’ha definita il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, sottolineando come lo strumento LuGre, nato dalla collaborazione con la Nasa e costruito in Italia e destinato a dimostrare la ricezione dei segnali di navigazione
satellitare fra la Luna e la Terra, rappresenti un elemento importante per aprire la strada ai futuri sistemi di navigazione per l’esplorazione permanente della Luna.
«Questo è un momento storico in quasi 50 anni di navigazione satellitare: prima abbiamo battuto il record mondiale di posizionamento GNSS nel deep space e il 3 marzo abbiamo dimostrato che la navigazione satellitare può essere utilizzata sia nel trasferimento cis-lunare che sulla superficie lunare». È quanto dichiarato da Oscar e Alessandro Pozzobon, soci e amministratori di Qascom, che hanno aggiunto: «Questo risultato aprirà un numero infinito di opportunità per la navigazione nello spazio e le applicazioni lunari future, con l’utilizzo nei satelliti lunari e nelle stazioni spaziali lunari, nella navigazione di rover e astronauti, nel trasferimento di tempo preciso sulla Luna e negli avvisi di emergenza lunari. Con questa missione abbiamo anche dimostrato che il futuro posizionamento ibrido GNSS e Moonlight sarà una possibilità concreta».
Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso grande soddisfazione per il successo della missione, sottolineando come questo risultato evidenzi l’eccellenza del Veneto nel settore tecnologico e spaziale.
Dopo quasi tre settimane in orbita, è ammarata a largo della Florida la missione Ax-3 con a bordo il colonnello dell’Aeronautica militare, Walter Villadei. Dopo essersi sganciato dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) lo scorso 7 febbraio, l’equipaggio della missione Axiom 3 (Ax-3) è ammarato in sicurezza al largo delle coste della Florida a bordo della navicella Dragon di SpaceX 14:30 (ora Italiana).
Il rientro dell’equipaggio di Ax-3 conclude ufficialmente la prima missione commerciale di astro-
Abordo di un Falcon 9 di SpaceX è decollata il 15 agosto 2024 alle 20:56 ora italiana, la missione Iperdrone.0, un progetto ideato, finanziato e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana.
Sviluppato grazie a un raggruppamento d’imprese costituito da Cira, Tyvak International e Kayser Italia, Iperdrone.0 rappresenta la prima missione del programma Iperdrone che ha l’obiettivo di progettare e realizzare un veicolo in grado di effettuare operazioni in orbita complesse (in-orbit servicing) e rientrare in modo sicuro a Terra, per con-
nauti interamente europea e la terza missione di Axiom Space con equipaggio sulla Iss.
Nelle tre settimane di permanenza in orbita, il colonnello Villadei ha svolto tredici esperimenti, promossi dall’Aeronautica militare in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi), che hanno coinvolto università, centri di ricerca e industrie, per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico, applicata allo spazio
Ilprimo satellite della costellazione IRIDE – il Pathfinder Hawk – è ora in orbita attorno alla Terra dopo essere decollato su un razzo SpaceX Falcon 9 dalla base spaziale Vandenberg Space Force Base in California il 14 gennaio.
sentire il recupero del payload di bordo.
Molte le tecnologie innovative a bordo di questo cubesat, come il sistema di propulsione a gas freddo chiamato Perseus. Importanti anche i sistemi di sicurezza, che permettono al cubesat di lavorare in prossimità della Stazione Spaziale Internazionale, e poi le nuove tecnologie di guida, navigazione, controllo e i sistemi di protezione termica cruciali durante il rientro nell’atmosfera.
Come il nome ‘Pathfinder’ suggerisce, questo nuovo microsatellite è un prototipo per una delle sei costellazioni del programma IRIDE, realizzate su misura per fornire informazioni per una vasta gamma di servizi ambientali, di emergenza e di sicurezza per l’Italia. Ognuna delle sei costellazioni porta con sé una specifica tecnologia satellitare, dagli strumenti radar e ottici a quelli iperspettrali e multispettrali.
La costellazione IRIDE complessiva dovrebbe essere operativa entro giugno 2026. Come prototipo, il Pathfinder per la costellazione Hawk per l’Osservazione della Terra lanciato ieri utilizzerà il suo strumento simile a una fotocamera per mostrare come questa costellazione può fotografare con una risoluzione al suolo di soli tre metri.
Lamissione Hera dell’ESA è stata lanciata con successo il 7 ottobre 2024 alle 16:52 italiane da Cape Canaveral. Raggiungerà l’asteroide binario Dimorphos e Dydimos nel 2026 e studierà i risultati dell’impatto controllato della sonda DART con l’asteroide nel 2022.
Hera, insieme a due micro-satelliti rilasciati all’arrivo, avrà l’obiettivo di indagare il sito di impatto con Dimorphos (che diventerà l’asteroide più studiato della storia) per verificare le conseguenze della collisione con l’asteroide, misurare accuratamente il cambiamento orbitale indotto e sfruttare il cratere generato per studiare il sottosuolo dell’asteroide.
I dati aiuteranno gli scienziati a preparare piani più veritieri per affrontare possibili future minacce di collisione con asteroidi e miglioreranno le strategie di difesa planetaria deviando le traiettorie degli asteroidi, beneficiando quindi tutta l’umanità.
Sentinel-1C, il terzo satellite della minicostellazione per l’osservazione della Terra Sentinel-1, del programma Copenicus, è stato lanciato, giovedì 5 dicembre, alle 22:20 ora italiana, con un razzo Vega-C dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese.
Attesissimo dalla comunità scientifica e non solo, Sentinel-1C, lavorando in coppia con Sentinel-1A in orbita polare eliosincrona, fornirà immagini radar ad alta risoluzione per monitorare i cambiamenti dell’ambiente terrestre e introdurrà nuove funzionalità di rile-

vamento e monitoraggio del traffico marittimo. Successo anche per il lanciatore, il razzo made in Italy Vega-C, prodotto da Avio negli stabilimenti di Colleferro e in grado di portare in orbita carichi utili fino a 2300 kg.
Pochi mesi dopo il volo inaugurale del 13 luglio 2022, nel dicembre dello stesso anno, il secondo lancio di Vega-C era fallito a causa di un graduale deterioramento dell’ugello del motore del secondo stadio, uno Zefiro 40, causando la perdita dei due payload e una battuta d’arresto del programma.






VeneTo Stars invites young European talents aged 18 to 25 to propose


1990: the ESO 3.6-m New Technology Telescope (NTT) in its octagonal enclosure
e nelprospettive settore astronomico, spaziale e della difesa.
Il senso di appartenenza nell’era della New Space Economy.
Il genius loci di Adriano Olivetti doveva incarnarsi e vedersi anche e soprattutto nella gestione delle persone, che lui non chiamava risorse umane, ma personale, una bella parola che riferisce a persona, una grande eredità dell’Umanesimo classico europeo e cristiano.
Era infatti convinto che una fabbrica dovesse sviluppare una cultura della direzione diversa da quelle che nascevano dalle business school anglosassoni.
Ed è in questi luoghi, ed è nei rapporti umani, nella cura dei beni che usiamo assieme, e nei rapporti con l’ambiente naturale che si genera innovazione, dove la creatività mutua tecnologie e trascina la crescita e le evoluzioni.
Nel ‘60 dello scorso secolo, in Città dell’uomo, Olivetti scriveva:
“La civiltà occidentale si trova oggi nel mezzo di un lungo e profondo travaglio, alla sua scelta definitiva. Giacché le straordinarie forze materiali che la scienza e la tecnica moderna hanno posto a disposizione dell’uomo possono essere consegnate ai nostri figli, per la loro liberazione, soltanto in un ordine sostanzialmente nuovo, sottomesso ad autentiche forze spirituali, le quali rimangono eterne nel tempo ed immutabili nello spazio da Platone a Gesù: l’amore, la verità, la giustizia, la bellezza”.
Parole più che mai attuali, concetti che hanno contraddistinto EIE sin dalla sua fondazione. “The Power of Creativity” è il motto che da sempre ha caratterizzato il suo percorso, con la passione per l’innovazione e la tecnologia, consentendole di diventare attore di riferimento nei diversi campi dell’astronomia.
In questi decenni l’azienda ha così affrontato sfide e opportunità, adattandosi alle rapide evoluzioni del mercato il suo impegno per la ricerca e lo sviluppo le ha permesso di essere pioniera in soluzioni avanzate, contribuendo a processi scientifici di rilevanza globale e a sistemi di osservazione all’avanguardia. Progetti iconici come il New Technology Telescope (NTT), il Very Large Telescope (VLT), l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), il European Extremely Large Telescope (ELT) e il Large Synoptic Survey Telescope (LSST) testimoniano la sua capacità di innovare e contribuire alle nuove frontiere della scienza.
Era il 2016 quando i nostri governanti definirono la Space Economy “una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale dei prossimi decenni”. In apparenza lontano, lo spazio è oggi arrivato a far parte della nostra vita quotidiana non soltanto sotto forma di oggetti derivanti dalla ricerca per applicazioni spaziali, ma anche nell'immaginario collettivo. Ed è in tale contesto che EIE, con il nuovo motto “Sons of a New Universe”, intende esprimere la sua visione di un futuro in cui l’innovazione ci guida verso orizzonti inesplorati, continuando così ad incarnare il concetto di “fabbrica olivettiana”, dove l’innovazione tecnologica coniuga una forte attenzione all’uomo e alla comunità. Crediamo che un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo possa generare idee rivoluzionarie, all’insegna della sostenibilità e di un rinnovato rispetto dell’ambiente, coscienti che solo la collaborazione con istituzioni, università e altri partner potrà cruciale per realizzare i nostri obiettivi ambiziosi.
Gianpietro Marchiori Presidente EIE GROUP
1. L'azienda EIE compie 35 anni di attività. Rappresenta una realtà italiana che ha saputo costruirsi un percorso qualitativo importante, fino ad approdare al settore dell'esplorazione spaziale. Partiamo da questa realtà, che ultimamente ha preso un'accelerazione tornando a essere una discriminante nel panorama geopolitico: che idea si è fatta di quello che potrà essere il futuro dello spazio con la nuova guida USA e l'affermarsi di nuove potenze spaziali quali la Cina, ma anche gli investimenti di Paesi emergenti come India ed Emirati Arabi?
L’esplorazione ha da sempre rappresentato per l’uomo una ricerca di conoscenza, avventura e scoperta, un modo per spingersi oltre i propri limiti, sia fisici che mentali, per comprendere il mondo e se stessi.
L’evoluzione verso l’esplorazione spaziale non solo esalta la nostra comprensione dell’Universo, la capacità di innovare e l’adattarsi alle sfide del futuro, ma rivoluziona anche i nostri approcci verso la tecnologia e la scienza in genere. Risulta quindi fondamentale attivare processi di cooperazione e di collaborazione, che rappresentano, in questo complesso momento storico, il vero catalizzatore della sua capacità evolutiva.
L’esplorazione favorisce inoltre l’interscambio di conoscenze e competenze, nonché garantisce il supporto
reciproco tra le parti, generando contemporaneamente cross fertilization tra sistemi industriali e accademici e tra questi e le istituzioni.
Dal dopoguerra, anche se con dinamiche totalmente diverse, gli USA e la Federazione Russa, continuano a caratterizzarsi, con il loro operato, come “guida” nell’evoluzione e nel progresso in campo spaziale, in funzione dei relativi rapporti bilaterali o congiunti. Nel Nuovo Millennio, Cina, India e UAE hanno iniziato a imporsi nello scenario mondiale evidenziato strategie nazionali sia scientifiche che commerciali in pieno stile New Space Economy.
La competizione, quindi, diventerà sempre più persistente e orientata da fenomeni geopolitici di nazioni come Cina e India. Bisognerà conseguentemente seguire da "vicino" gli step nel breve periodo e capire come inserirsi in vista di una congiunzione di intenti, in settori disciplinari che compensino la loro non presenza strategica in nicchie di mercato tecnologico (poter rispondere all'interno del loro mercato).
EIE fa parte dell'ecosistema delle aziende capaci di offrire, internamente al sistema nazionale e nel resto del mondo, contenuti specifici che soddisfano le volontà collettive in vista di una nuova corsa nel dominio delle attività spaziali (EIE-Scienza-Industria-Servizi).
2. Come valuta le politiche europee nel settore? Sono all'altezza del dinamismo che lo caratterizza?
L'ESA nasce per soddisfare le politiche di settore fra i Paesi membri e con la consapevolezza di appartenere tutti ad un mercato unico nel quale continuare ad investire in ricerca e sviluppo, efficientando le spese e favorendo meritocraticamente gli Stati, senza sottovalutare l'aspetto della ripartizione delle risorse al fine di evitare frammentazioni interne, capendo quando sia possibile favorire gli investimenti pubblici nel rispetto delle regole internazionali.
USA, Cina ed India, dal canto loro, hanno implementato programmi, che inseguono con o senza collaborazioni estere. Spetta a noi quindi attivare nuove e diverse relazioni al fine di ottenere possibili accordi di collaborazione. Per farlo è necessario assumere sempre più consapevolezza della complessità anche culturale delle dinamiche di collaborazione, acciocché evitare inutili barriere competitive.
I gabinetti ministeriali italiani dovrebbero mantenere un'attenzione continua a ciò, con impiego di personale di grande esperienza. È consolidato infatti che "...in ESA si riesca a far molto con poco..." come dimostrano i numeri a disposizione per i finanziamenti in molti programmi.
La politica deve farsi promotrice con

Tommaso Marchiori Vice Presidente di EIE GROUP
metodologie e processi meno burocraticizzati. Come già sottolineato precedentemente serve maggior reattività e meno dipendenza da paesi terzi, serve anche più rispetto in relazione agli accordi comuni, nel mercato unico europeo, sotteso troppo spesso a dinamiche economico finanziarie basate sull'euro.
Per una corretta interpretazione bisogna allora capire il ruolo del mercato unico e le interazioni tra stati all'interno dello stesso. Molte tecnologie potrebbero essere sviluppate in seno ai Paesi europei e questo approccio favorirebbe da un lato la conservazione del know-how e dall'altro garantirebbe produzioni per terzi, così da detenere ruoli settoriali di mercato.
In questa epoca di forte interscambio il Golden Power è stato strumento di tutela di interessi nazionali e di sicurezza economica. Questo intervento è solo uno dei possibili, capace di bilanciare l'apertura economica internazionale in ottica nazionale.
Serve quindi promuovere lo stesso a livello europeo, con monitoraggi continui, consolidando la giurisprudenza sulla sicurezza nazionale ed europea e le analisi sulle operazioni finanziarie (statistiche e storiche). Nel caso inoltre sussistano altri strumenti bilaterali o n-laterali che, uscendo dalle regole comuni,
dovranno coesistere senza compromettere la stabilità del mercato.
Nei contesti territoriali, infine, per non dipendere da terzi, bisognerà mettere le persone e le aziende in grado di poter pensare e sviluppare brevetti; promuovere l'esistenza di startup senza prevaricare lo stato di maturità dei processi o delle idee che nascono da esse e quindi dare in un certo senso campo largo ai soggetti preposti a costituirne l'ossatura e la muscolatura (Management & Engineering).
Servirà anche consolidare poli tecnologici capaci di allacciare il binomio INDUSTRIA e UNIVERSITA'/
CENTRI DI RICERCA, prima su scala nazionale e successivamente su scala europea; con network solidi e condivisi all'interno del mercato unico europeo senza dispersione o dipendenza verso terzi su tecnologie avanzate o ritenute critiche.
Sul fronte energetico i paesi dell’Unione Europea dovranno continuare la ricerca e lo sviluppo in ambito fusione e fissione nucleare (di quest'ultima l'Aerospazio ne fa uso già da decenni). Dovranno essere ridondati gli interessi sulle tecnologie a semiconduttore!!! Serviranno poi allineamenti strategici per la UE, come già sono instaurati con gli USA, ma estendibili in analogia ad Australia e Giappone.
Andranno sostenute le tecnologie utili a migliorare l'"industria" dell'agricoltura o le altre filiere alimentari (ma intese nel dominio di tutte le risorse ambientali disponibili all'interno dell'UE) che traggono beneficio in maniera diretta ed indiretta dalle tecnologie aerospaziali. Fondamentali anche gli investimenti nell'educazione e nella formazione avanzata; bisognerà investire in educazione tecnica e scientifica, per garantire forza lavoro altamente qualificata e sviluppare competitività. In tal senso bene han fatto le Università europee che, anticipando i tempi sull'attrarre talenti extra UE, hanno reso l'intero territorio europeo, polo attrattivo per compensare la "perdita" di risorse umane. In questo contesto globale, interconnesso e complesso, ritengo che combinare politiche interne UE mirate, con una forte cooperazione internazionale, possa sostenere la protezione delle risorse economiche e strategiche in chiave predittiva tempo-variante.
3. E l'Italia? Come valuta il nostro posizionamento, anche alla luce della nuova legge sullo spazio? Saremo in grado, a suo parere, di intercettare le opportunità che questo mercato crescente potrà fornire? Ha suggerimenti da dare?
La nuova legge sullo spazio in Italia, approvata recentemente, rappresenta un passo significativo per il settore spaziale nazionale. Essa mira a incentivare la crescita dell’industria spaziale, promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo, sostenendo le start-up e facilitando collaborazioni tra enti pubblici e privati. Tra i punti chiave, in primis le misure
per garantire che le attività spaziali siano ecologicamente sostenibili; gli incentivi per progetti innovativi; la collaborazione internazionale con la promozione di partnership con agenzie spaziali e aziende estere e le iniziative per formare nuovi professionisti nel settore spaziale. Questa legge potrebbe rafforzare il posizionamento dell’Italia nel contesto europeo e globale, contribuendo a progetti significativi come quelli legati a esplorazione, telecomunicazioni e osservazione della Terra.
Gli anni a venire dovranno quindi caratterizzarsi con nuove iniziative basate, ad esempio, su concetti multi-missione e di multifrequenza, il lancio di costellazioni di mini-micro-nanosatelliti che forniscano servizi innovativi, nonché il lancio di sistemi satellitari scientifici distribuiti. Dovrà inoltre essere incrementato lo sviluppo delle capacità e la flessibilità del programma Vega: questo potrà garantire il coinvolgimento attivo del mondo della ricerca e di quello industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up.
4. Torniamo a EIE GROUP. Se dovesse riassumere in tre parole il suo cammino in questi “primi 35 anni”, quali userebbe e perché?
Creatività, innovazione e guida (leadership settoriale) hanno rappresentato e rappresentano il successo internazionale di EIE e la sua capacità di stare e crescere nei mercati. Le evoluzioni in atto non possono che confermare l’attualità di tali termini, assunti per rappresentare le modalità attraverso le quali EIE affronta le sue sfide.
5. In particolare, EIE GROUP ha basato il proprio cammino di crescita sulla capacità di ingegnerizzare le possibili soluzioni. Come entra l’esplorazione spaziale in tale contesto?
EIE, sviluppa negli anni una peculiare capacità sistemica che le consente di collocare la sua ingegneria ai vertici dei processi di sviluppo di progetti complessi e multidisciplinari. Con tali dotazioni EIE si è conseguentemente affacciata al mondo dello spazio e della difesa. Lo ha fatto inserendo nell’organico giovani specialisti del settore, che hanno saputo immediatamente integrarsi nelle dinamiche specifiche dell’ingegneria applicata, ma anche complementando le loro dotazioni di innovativi processi manageriali e relazionali.
EIE ha poi sapientemente attivato piani di trasposizione delle sue tecnologie in ambiti limitrofi, quali quelli delle ground facilities e delle applicazioni per aerospazio e difesa. Sono prodotti EIE: gli osservatori Flyeye di ESA, per la Space Surveillance and Tracking, il sistema VERT-X con il loro Raster-Scan per la calibrazione dello specchio per raggi X del futuro telescopio spaziale Athena, sempre per ESA che sarà installato all’interno di una camera a vuoto costituita da un cilindro in acciaio da 7m di diametro per un’altezza di soli 20m. Sono prodotti di EIE per lo spazio anche le stereo-camere iperspettrali da installare su droni, cube-sat o su satelliti per l’osservazione in “quattro dimensioni” della superficie terrestre o per l’osservazione planetaria. Recentemente EIE ha iniziato un interessante percorso per la realizzazione di strutture per piattaforme di lancio, per i
futuri spazioporti e per la presenza umana sulla Luna e su Marte.
6. Per gli anni a venire, il vostro approccio è più per lo spazio o dallo spazio? O intendete operare in entrambi i fronti?
EIE non ha mai pianificato indirizzi di business a configurazione ristretta, lasciandosi condurre da strategie di marketing orientate dalle opportunità e dalle tendenze dei mercati, adattando sapientemente le sue tecnologie, le sue infrastrutture e soprattutto la sua capacità di adattamento dell’offerta ingegneristica e manageriale del proprio organico. EIE si caratterizza quindi come azienda pronta ad offrire processi da sistemista nello sviluppo di progetti complessi, anche utilizzando una articolata, quanto matura, supply chain e aggregazioni industriali e scientifiche mirate agli obiettivi da perseguire.
7. In passato, gli investimenti spaziali sono stati soprattutto pubblici. Negli ultimi anni i privati hanno guadagnato posizioni di rilievo e il trend sembra accelerare: basti pensare che il nuovo amministratore della Nasa è un imprenditore privato. Ritiene ancora determinante il ruolo del pubblico negli investimenti spaziali o pensa che questo sia progressivamente destinato a scomparire?
Il ruolo del settore pubblico negli investimenti spaziali rimane fondamentale, anche con l’aumento della partecipazione privata. I governi forniscono finanziamenti iniziali, regolamentazioni e infrastrutture critiche, oltre a garantire la sicurezza e la cooperazione internazionale.
Il new deal della Space Economy ha trasformato l’interesse industriale, generando una crescente presenza di aziende private. Le collaborazioni tra pubblico e privato, come nel caso della NASA e di SpaceX, dimostrano che entrambi i settori possono trarre vantaggio da questa sinergia. È probabile che il settore pubblico continui a svolgere un ruolo cruciale, ma potrebbe evolversi, passando da un modello di finanziamento diretto a uno di partnership strategiche. In questo contesto, la scomparsa totale del pubblico sembra improbabile, poiché le missioni spaziali richiedono risorse e competenze che i privati da soli potrebbero non essere in grado di fornire.
L’Europa, attraverso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sta promuovendo una strategia di cooperazione pubblico-privato per sostenere l’industria spaziale. Ha lanciato programmi come il “Commercial Space Activities” per incentivare le startup e le aziende private, offrendo finanziamenti e supporto tecnico.
In Italia, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha collaborato con aziende private come Leonardo e Thales Alenia Space per sviluppare progetti in ambito satellitare e di esplorazione spaziale. Il governo italiano ha anche investito in iniziative di ricerca e sviluppo, puntando a rendere il settore spaziale un motore di crescita economica. La nuova legge per lo spazio varata dal governo italiano, nota come “Legge per l’industria spaziale”, mira a sostenere lo sviluppo dell’industria spaziale nazionale. Essa prevede incentivi fiscali, finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, e un quadro normativo più chiaro per le attività
spaziali.Uno degli obiettivi principali è promuovere la collaborazione tra settore pubblico e privato, facilitando investimenti privati e startup nel campo spaziale. La legge mira anche a garantire la sicurezza delle operazioni spaziali italiane e a posizionare l’Italia come un attore chiave nel contesto europeo e globale. In sintesi, questa legge rappresenta un passo significativo per rafforzare l’industria spaziale italiana, stimolando la competitività e l’innovazione.
In sintesi, sia l’Europa che l’Italia stanno adottando un approccio misto, integrando investimenti pubblici con il dinamismo del settore privato per rafforzare la propria posizione nel panorama spaziale globale.
8. L'evoluzione del settore spaziale è, in ogni caso, frutto della collaborazione. Quanto e come questo aspetto potrà contare per il futuro di EIE GROUP?
Come precedentemente espresso, i domini spaziali sono caratterizzati da processi di lungo respiro, multidisciplinari, dove principalmente i grandi player nazionali, europei e internazionali, definiscono con i governi, le organizzazioni e le agenzie spaziali i piani di sviluppo e realizzativi. EIE opera in tali contesti sia con rapporti diretti con le agenzie spaziali o partner industriali a caratura internazionale. Analogamente EIE si è fatta negli anni, promotrice della costituzione di distretti regionali (es.: Distretto SKYD Veneto) o l’attuale rete veneta per l’aerospazio (RIR-AIR) con la quale opera sia in contesti nazionali che internazionali, in termini di promozione e realizzativi. EIE appartiene inoltre all’associazione nazionale AI-
PAS (Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali) e partecipa attivamente nelle relazioni istituzionali che concorrono a definire le politiche industriali in ambito spaziale. In campo internazionale EIE è anche Global Spaceport Alliance Associate Member per tutte le tematiche legate alla realizzazione di spazioporti in termini infrastrutturali e di servizi.
EIE ha quindi costituito un ambiente fertile nel quale attrarre opportunità, condividere progettualità, stabilire percorsi di collaborazione.
9. n generale, se guarda davanti a lei e alle sfide che EIE GROUP dovrà affrontare, quali sentimenti prova, e perché?
Lo spazio rappresenta per EIE parte vitale della sua quotidianità, non soltanto perché caratterizza la relativa unità di business ma anche e soprattutto perché si configura come nuovo e diverso modus operandi.
Ne consegue che per EIE, non si tratta di caratterizzare sentimenti, bensì configurare comportamenti globali come rappresentato dal nostro nuovo motto che caratterizzerà i nostri prossimi 35 anni: “Sons of a New Universe”.
di Gianpietro Marchiori

Gianpietro Marchiori Presidente di EIE GROUP
Nei suoi 35 anni EIE ha avuto l’opportunità di sviluppare importanti progetti internazionali, tra i quali i più iconici sono autentiche pietre miliari, che hanno segnato un percorso di crescita straordinario e contribuito a definire il progresso tecnologico e scientifico nel settore Aerospaziale, Astrofisico e Difesa. Questi progetti rappresentano i pilastri di un lungo e ambizioso percorso di crescita, dalla loro concezione iniziale fino alla piena maturità operativa, attraversando sfide ingegneristiche complesse, avanzamenti tecnologici e collaborazioni strategiche su scala globale.
NTT, il progetto del concepimento e dell’infanzia di EIE
Iniziai ad occuparmi di osservatori astronomici per caso, nel 1986, con il progetto NTT – New Technology Telescope dell’ESO – European Southern
Observatory. In campo astronomico, l’applicazione dei computer iniziata negli anni ’60, per l’elaborazione dei dati astronomici e la simulazione di modelli astrofisici, si sviluppa rapidamente ma, solo negli anni ’80, l’applicazione dei computer nella costruzione dei telescopi, inizia a diventare significativa. I computer vengono utilizzati per progettare ottiche complesse, controllare i sistemi di puntamento e stabilizzare i telescopi.
L’NTT è stato per me fin da subito una folgorazione scientifico/tecnologica che sino ad allora avevo operato in un settore ingegneristicamente assai interessante, nel quale avevo cercato di innovare quanto più fosse possibile.
Un progetto rivoluzionario inaugurato nel 1989 presso l’osservatorio di La Silla, in Cile.
Il telescopio NTT è stato il primo a utilizzare un design con un sistema di ottica adattativa, che consente di correggere gli effetti dell’atmosfera terrestre sulle immagini astronomiche. L’obiettivo era quello di migliorare la qualità delle osservazioni. Grazie a uno specchio primario di 3,58m, il telescopio ha permesso di ottenere immagini molto più chiare e dettagliate rispetto ai telescopi precedenti. Uno degli aspetti più innovativi di NTT è stato l’uso di un sistema di controllo computerizzato che regola continuamente la forma dello specchio per compensare le distorsioni
atmosferiche. Questo ha rappresentato un avanzamento significativo nella tecnologia telescopica. Anche l’edificio rotante che ospita il telescopio è stato oggetto di una rivoluzione tecnologica basata sul concetto della massimizzazione delle prestazioni del telescopio e nella creazione di un ambiente controllato per le osservazioni, caratterizzato da un'innovativa struttura dalla forma poligonale rotante su un cuscinetto monolitico gigante, di quasi 7 metri di diametro, al fine di ridurre al minimo le vibrazioni. La struttura, isolata termicamente, con speciali materiali, contribuisce a mantenere condizioni stabili all’interno, minimizzando gli effetti dell’atmosfera esterna. L’edificio rotante è dotato di un sistema di apertura che permette una rapida esposizione verso il cielo del telescopio, riducendo il tempo di inattività durante le osservazioni e di una serie di aperture atte a garantire una costante ventilazione durante le fasi di osservazione. L’edificio inoltre è stato integrato con sistemi informatici e di controllo del telescopio, che permettono un funzionamento efficace e coordinato.
La progettazione dell’edificio ha avuto un ruolo fondamentale nel caratterizzare il successo di NTT, complementando le tecnologie innovative utilizzate per il telescopio stesso e aprendo la strada al futuro dei grandi osservatori del mondo. Sulla base di
questa incredibile esperienza, nasce EIE, il 2 novembre del 1989, anno appunto della sua attivazione.
NTT ha contribuito a numerose scoperte scientifiche, tra cui studi su galassie lontane, stelle e pianeti extrasolari. Grazie alla sua progettazione avanzata, ha aperto la strada per ulteriori sviluppi nell’ottica adattativa, influenzando progetti successivi in tutto il mondo.
Oggi, NTT continua a essere un importante strumento astronomico, utilizzato da ricercatori di tutto il mondo per condurre osservazioni e studi scientifici.
NTT ha reso possibile diverse importanti scoperte astronomiche, tra cui esopianeti, galassie lontane, supernovae; ha contribuito a mappare la distribuzione di galassie e materia oscura, migliorando in tal modo la nostra comprensione della struttura cosmica e ha effettuato osservazioni di fenomeni come i buchi neri e le stelle di neutroni, fornendo dati importanti sulla fisica in condizioni estreme.
Queste scoperte hanno avuto un impatto significativo sulla comprensione dell’Universo e hanno aperto nuove strade per la ricerca astronomica.
Alcuni esempi specifici di scoperte fatte con NTT: il sistema planetario HR 8799 che ha portato alla prima diretta visualizzazione di un sistema
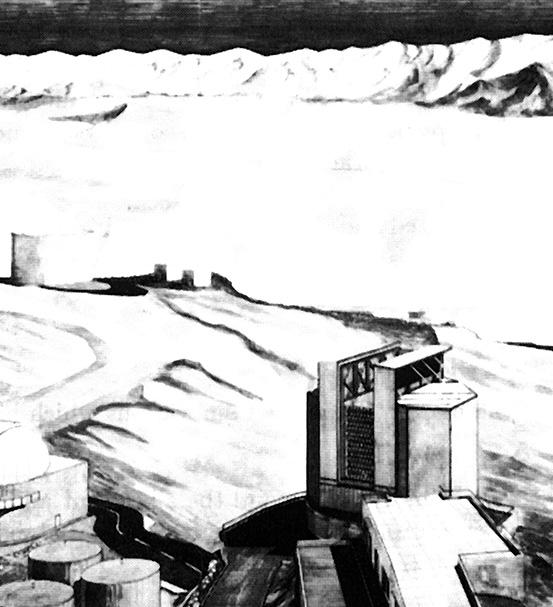
di esopianeti, rivelando dettagli sulle loro atmosfere; l’osservazione di galassie a spirale molto lontane che hanno fornito informazioni cruciali sulla loro evoluzione e sulle condizioni dell’Universo primordiale; ha monitorato e caratterizzato diverse supernovae, inclusa la supernova SN 1987A, approfondendo la comprensione delle esplosioni stellari e della nucleo-sintesi; ha aiutato a chiarire i processi che governano l’accrescimento di materia in buchi neri supermassicci; le osservazioni di pulsar e stelle di neutroni che hanno fornito dati fondamentali sulla loro struttura e sui fenomeni relativistici.
Il VLT, il progetto dell’adolescenza di EIE
L’esperienza acquisita da EIE con NTT e la stretta relazione stabilita con il cliente, ci ha consentito di attivare una serie di studi atti a definire come le nuove tecnologie, identificate e prototipate nel progetto NTT,
potessero essere applicate al nuovo ambizioso progetto di ESO. VLTVery Large Telescope, un insieme di quattro telescopi da 8,2m di diametro di ciascun specchio, concepiti per lavorare in combinata come un unico sistema, attraverso la tecnologia interferometrica. Questo consente di ottenere immagini ad alta risoluzione, superando le limitazioni di un singolo telescopio.
Il progetto venne sviluppato con due diversi contratti, uno per i telescopi e uno per gli edifici rotanti, entrambi realizzati con team di aziende italiane. Il lavoro di progettazione impegnò EIE per diversi anni. Anche il VLT è stato infatti caratterizzato da una serie di processi pionieristici con applicazioni innovative nell’utilizzo di motori lineari per il movimento e il controllo degli assi dei telescopi. Questa tecnologia ha consentito un’elevata precisione nel puntamento e nel tracciamento degli oggetti celesti, migliorando significativamente la capacità di osservazione. L’uso di
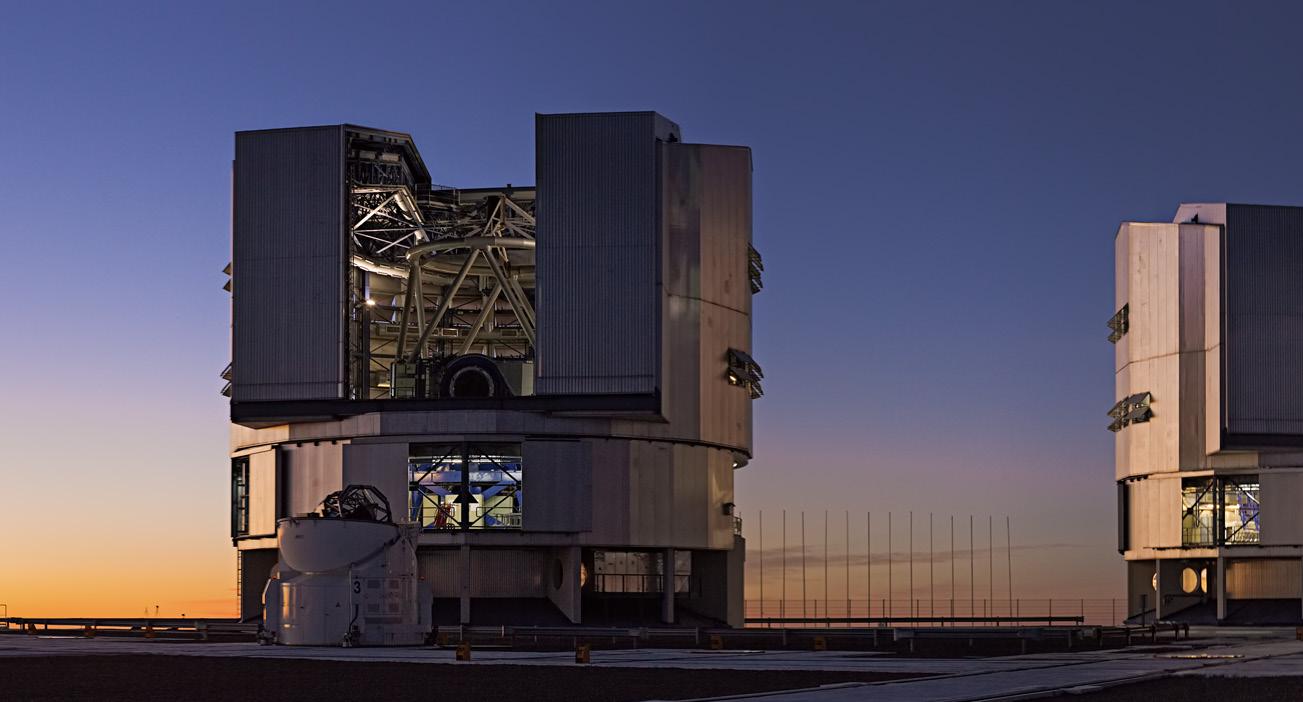
motori lineari, applicati per la prima volta da EIE, ha reso possibile un funzionamento più fluido e preciso, contribuendo a migliorare le prestazioni dei telescopi e quindi delle osservazioni astronomiche.
Altra importante innovazione è stata quella dell’uso integrato di supporti idrostatici per il sostentamento degli assi di rotazione dei telescopi, in sostituzione dei tradizionali cuscinetti, al fine di migliorare la stabilità e la risposta del telescopio, permettendo in tal modo un controllo più accurato durante le osservazioni. Il sistema idrostatico, presentando bassissimi attriti, contribuisce a una minore usu-
ra meccanica, aumentandone la durata e l’affidabilità del telescopio nel tempo. Questa innovazione ha rappresentato un importante passo avanti nella tecnologia dei telescopi moderni.
La costruzione dei quattro telescopi, chiamati Antu, Kueyen, Melipal e Yepun, che in lingua Mapuche rappresentano quattro oggetti celesti, è iniziata negli anni ’90 ed il primo telescopio è stato inaugurato nel 1998.
Ogni telescopio è equipaggiato con strumenti avanzati per osservazioni in diverse lunghezze d’onda, dall’ottico all’infrarosso. Grazie alla sua configurazione, il VLT ha contribuito

The VLT Telescope, it tilted during the opening of its enclosure
a scoperte significative, tra cui studi su esopianeti, galassie lontane e fenomeni cosmici.
VLT ha rappresentato una svolta significativa nell’astronomia, non solo per la sua potenza osservativa, ma anche per l’innovazione tecnologica, influenzando molti altri progetti di telescopi in tutto il mondo. Oggi, VLT rimane uno degli strumenti più importanti per l’astronomia moderna.
VLT ha portato a numerose scoperte significative, tra cui: le immagini di esopianeti come quelli del sistema HR 8799, fornendo dettagli sulle loro atmosfere e composizioni chimiche; il movimento di S02, una stella che orbita attorno al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, confermando la presenza di un buco nero di massa elevata; galassie come GN-z11, una delle galassie più lontane conosciute, risalente a solo 400 milioni di anni dopo il Big Bang; lo studio di lenti gravitazionali, mappando la distribuzione della materia oscura in ammassi di galassie, fornendo informazioni fondamentali sulla sua natura; supernovae come SN 1993J, contribuendo a comprendere i meccanismi di esplosione e la nucleo-sintesi degli elementi.

ALMA, il progetto della giovinezza di EIE
Era un giorno di vacanza, di rientro da una missione in Cile su VLT, a Rio de Janeiro, quando squillò il telefono della stanza d’albergo: era il prof. Pacini.
Caro Gianpietro, sono Franco, è ora di impegnarci come Italia, anche nel campo della grande radioastronomia…
Non ci pensai troppo, iniziammo un lungo lavoro di ricerca tecnologica per rispondere alle condizioni estreme dei siti selezionati e agli ambiziosi requisiti di surface accuracy, di pointing e tracking, al fine di inventare un nuovo concetto di radiotelescopio.
Il percorso contrattuale non fu facile, anzi, architettato con configurazioni tali da facilitare chi sarebbe partito prima, oltre a proporre un bando per fare dei prototipi da installare in suolo americano.
Prima della costruzione definitiva dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), furono infatti realizzati tre prototipi di antenne: uno americano, gestito da NRAO
- National Radio Astronomy Observatory, uno giapponese, gestito da NAOJ - Osservatorio Nazionale Astronomico del Giappone e uno europeo, gestito da ESO - Osservatorio Europeo Australe e vinto da EIE.
Questi prototipi furono fondamentali per testare e sviluppare le tecnologie necessarie per il funzionamento del complesso ALMA.
Segui una lunga fase di gare per la realizzazione che si concluse con tre differenti contratti, al fine di garantire il giusto ritorno (USA, Giappone ed Europa). EIE poté sviluppare il suo progetto, in partnership con altre due aziende europee. Il contratto venne firmato nel 2005 a Monaco, al quartier generale di ESO. La prima antenna venne consegnata il 27 luglio 2011 al Llano de Chajnantor, a oltre 5000 m di quota, ai limiti del deserto di Atacama in Cile. L’intero array di radio antenne venne inaugurato con una memorabile celebrazione, nel 2013, al quartier generale di ALMA a San Pedro di Atacama.
ALMA è attualmente il più grande complesso di radiotelescopi del mondo, dedicato all’osservazione della
radiazione millimetrica e submillimetrica. Composto da 66 antenne (25 americane, 25 europee e 16 giapponesi). ALMA è in grado di operare come un telescopio virtuale di grande dimensione, migliorando notevolmente la risoluzione e la sensibilità nelle osservazioni astronomiche. Grazie alla sua configurazione e alla sua tecnologia avanzata, ALMA ha rivoluzionato il campo della radioastronomia, permettendo di studiare una vasta gamma di fenomeni astronomici.
Alcuni degli obiettivi principali di ALMA includono: le formazioni stellari (osservare le nubi di gas e polvere dove nascono le stelle e i sistemi planetari); le galassie lontane (studiare galassie in fase di formazione nell’universo primordiale); le molecole complesse (indagare la chimica nell’universo, comprese le molecole organiche, che possono avere implicazioni per l’origine della vita); i fenomeni cosmici (analizzare eventi come l’emissione di radiazione da buchi neri e supernovae).
I radiotelescopi europei di ALMA, concepiti da EIE, hanno introdotto diverse innovazioni tecnologiche signi-

ficative che faranno scuola per lo sviluppo delle future antenne. Alcuni dei principali aspetti includono: un innovativo, quanto originale design della superficie primaria, realizzata con pannelli, non per lavorazione meccanica dell’alluminio, bensì con processi di replica elettrochimica, i quali hanno garantito che ogni pannello abbia le stesse specifiche ottiche e un’accuratezza della superficie globale della parabola nettamente superiore, permettendo una migliore raccolta e focalizzazione delle onde millimetriche e sub millimetriche; una sofisticata tecnologia di controllo per l’allineamento e il puntamento delle antenne, garantendo una maggiore precisione nelle osservazioni; una originale configurazione delle motorizzazioni degli assi, ottenuta con la stessa tipologia di motori lineari adottati da EIE anche per i grandi telescopi che hanno consentito un controllo preciso, una reazione rapida ed un’incredibile accuratezza nel posizionamento delle antenne; una struttura monolitica, dalla parabola, alla receiver cabin a tutta la struttura portante dello specchio secondario, realizzata completamente con speciali fibre di carbonio per garantire robustezza, leggerezza e stabilità termica in condizioni ambientali estreme.
Queste innovazioni hanno migliorato significativamente le capacità operative di ALMA, rendendo possibile
il tracciamento di oggetti celesti con grande precisione e facilitando le osservazioni di alta qualità in diverse lunghezze d’onda.
ALMA si inserisce nell’ambito dell’astronomia e della cosmologia, fornendo dati essenziali per la comprensione dell’Universo.
ELT, il progetto della maturità di EIE
Fu inebriante ascoltare il responsabile amministrativo di ESO: Dott. Arnout Tromp, in apertura dell’incontro del 13 novembre 2015:
• Il progetto di offerta del consorzio ACe, sviluppato da EIE, è l’unico, che ha dimostrato totale rispondenza a tutti i requisiti tecnici, manageriali ed amministrativi, richiesti da ESO.
Un lavoro estenuante, partito da molto lontano e durato oltre sette anni, dal 2007 al 2015.
Il contratto venne firmato, il 25 maggio 2016, dopo sei mesi di negoziazioni, con una cerimonia a caratura internazionale, alla presenza dell’allora Ministro della Ricerca Scientifica, on. Giannini, si trattava infatti del più grande contratto in campo astronomico, di circa 400 milioni di euro. Iniziò così uno dei periodi più complessi per l’intera nostra struttura aziendale che doveva, in meno di due
anni, sviluppare l’intera progettazione esecutiva, sia di tutte le strutture, che dei meccanismi, degli impianti e delle automazioni del telescopio ma anche, contemporaneamente, di tutto il complesso delle fondazioni, dei pilastri, dell’edificio rotante, degli edifici ausiliari, inclusa l’urbanizzazione dell’area.
Una sfida ingegneristico/tecnologica – oramai capace di snocciolare tutti quegli irraggiungibili requisiti di questo telescopio gigante, dove tutto è oltre il limite dell’applicabilità, ma anche e soprattutto una EIE particolarmente matura e in grado di attivare una struttura manageriale atta a gestire ritmi, eventi, confronti, tempistiche, costi, rischi, in un articolato processo sistemico.
Un team di 50 tra ingegneri, manager, specialisti, tecnologi, amministrativi completamente dedicati a trasformare i 1802 requisiti in materiali, componenti, sottosistemi, strutture, tra loro interconnessi per resistere alle estreme condizioni ambientali ma, allo stesso tempo per garantire la “sofisticata leggerezza” del puntare ai confini dell’Universo.
ELT e attualmente il più grande telescopio ottico-infrarosso del mondo, con uno specchio primario segmentato di 39m di diametro. Questo
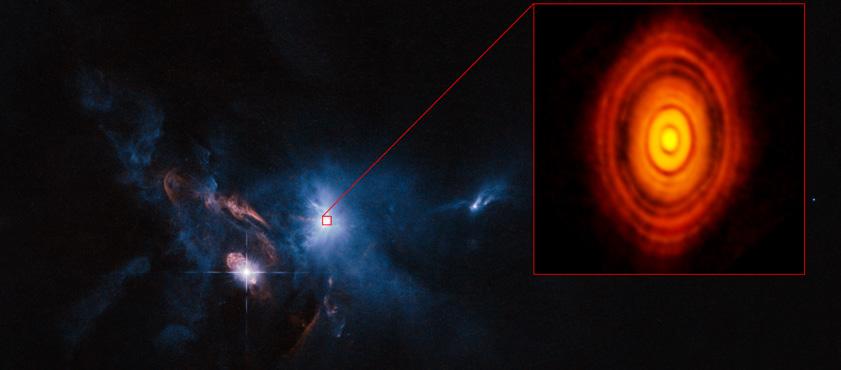
Alma/Hubble composite image of the region around the young star HL Tauri
enorme specchio, composto da 798 segmenti, permetterà di raccogliere una quantità di luce senza precedenti, migliorando la risoluzione e la sensibilità nelle osservazioni astronomiche. ELT sarà in grado di affrontare questioni scientifiche chiave, come lo studio di esopianeti, galassie lontane e la comprensione dell’evoluzione dell’Universo.
ELT stato progettato con diverse caratteristiche innovative: lo specchio primario segmentato; la straordinaria ottica adattativa dello specchio quaternario, per correggere le distorsioni atmosferiche in tempo reale, migliorando in tal modo la qualità delle immagini; il complesso dei cinque fattori che garantiscono al telescopio di inseguire e puntare (strutture specificatamente rigide, combinate con motorizzazioni lineari ad altissime prestazioni, encoder precisissimi e sistemi di controllo capaci di amalgamare e correggere, se necessario, tutti gli errori e le difettosità residue).
Queste caratteristiche rendono ELT uno degli strumenti più avanzati e promettenti nell’astronomia moderna.
Un telescopio ad alte prestazioni richiede un edificio che lo contiene altrettanto performante, e quello di ELT lo è in maniera particolarmente appropriata. Il rapporto tra le dimensioni di un telescopio gigante e la sua cupola risulta totalmente sbilanciato: un grande telescopio in un «piccolo
edificio» per ridurre al minimo i costi energetici generati dal trattamento dell’aria interna, di quasi 400 mila metricubi.
Si aggiunga inoltre il particolare rivestimento esterno, costituito da una serie di materiali che combinano l’alto
gano come ali al vento per consentire al telescopio di osservare, le diffuse aperture di ventilazione che interessano l’intera cupola, per uniformare il flusso dell’aria che interessa il telescopio e le enormi pareti mobili che si sollevano sincrone con l’angolo di puntamento del telescopio per proteg-

livello di isolamento, con una riflettività diurna al fine di ridurre gli effetti solari, oltre ad un basso irraggiamento notturno verso la volta celeste. I grandi portoni di osservazione, che si spie-
gerlo dalle raffiche di vento che lo renderebbero instabile in posizione. Un edificio rotante rappresenta una enorme macchina multifunzione, che ruota per seguire le traiettorie del

telescopio durante la notte, consente in tal modo di servire il telescopio in tutte le sue necessità di ispezione e manutenzione, di sostituzione delle sofisticatissime strumentazioni, oltre a proteggerlo da venti estremi e terremoti catastrofici.
Il telescopio ruota galleggiando su un film d’olio, si appoggia, come l’edificio, su dispositivi smorzanti che riducono e mettono in sicurezza ogni equipaggiamento e le relative strutture dalle accelerazioni prodotte dai terremoti. Queste peculiarità assicureranno un funzionamento efficiente e ottimale per le osservazioni astronomiche, per lungo tempo.
ELT è stato concepito per diverse aree della ricerca astronomica, tra cui: (i) lo studio degli esopianeti: sarà in grado di analizzare atmosfere di esopianeti e cercare segni di vita, contribuendo a comprendere la formazione di sistemi planetari; (ii) La formazione stellare ELT: osserverà le nubi di gas e polvere in cui nascono le stelle, fornendo informazioni sui processi
di formazione stellare; (iii) le galassie lontane: ELT studierà l’evoluzione delle galassie nel tempo, analizzando la loro formazione e interazioni; (iv) la materia oscura ed energia oscura: ELT contribuirà a comprendere la natura della materia oscura e dell’energia oscura nell’universo; (v) l’astronomia delle alte energie: ELT indagherà fenomeni estremi come buchi neri supermassicci e supernovae, migliorando la comprensione della fisica in condizioni estreme.
L’affascinante mondo dell’astronomia e dello spazio
Queste le sfide tecnologiche che ci hanno portato ad essere un’azienda al servizio della grande scienza internazionale, le ragioni per le quali non abbiamo mai smesso di studiare, di inventare, di applicare, di sfidare. Abbiamo raggiunto i nostri 35 anni nella maturità di inseguire il nostro motto “the Power of Creativity”, lavoriamo ora per i prossimi 35 consci di nuovi ambiti e nuovi orizzonti: “Sons of a New Universe”.
L’Italia è chiamata a condurre da leader molti dei processi innovativi che spaziano dalla Scienza Applicata, all’Astronomia e allo Spazio. Il sistema industriale ha avuto la capacità di intuire i fattori di crescita, si è preparato e sta presidiando i mercati. ma non lo sta facendo da solo, lo sostiene sia il sistema accademico ma anche il nostro Governo, con la nuova Legge per lo Spazio.
EIE appartiene a questo processo, molti e diversi i mercati e le applicazioni scientifiche e tecnologiche: dagli Osservatori per i Debries, alle Ground Facility, dalle Piattaforme di Lancio, all’Osservazione della Terra, alle trasmissioni satellitari sino agli habitat lunari e marziani.

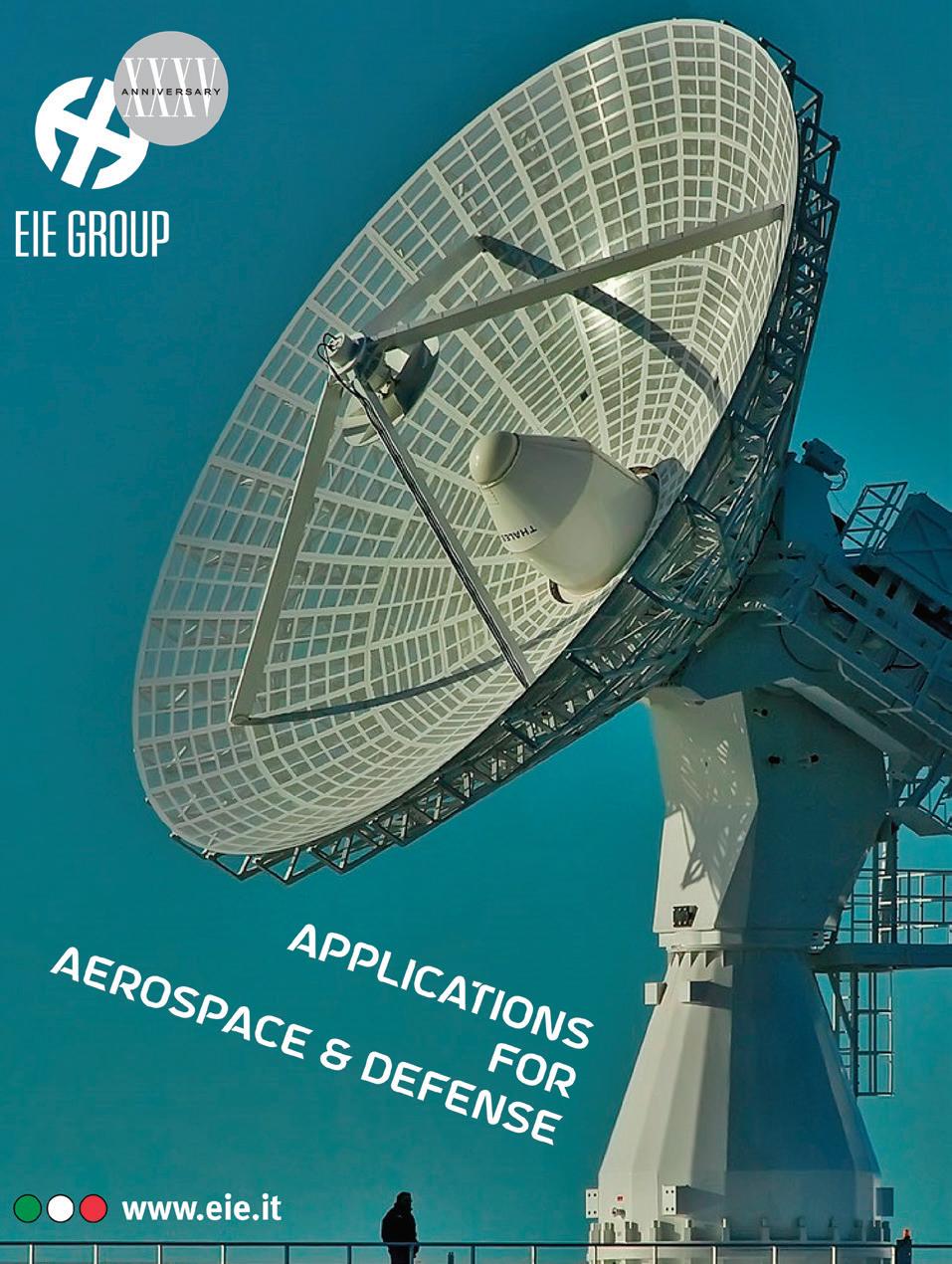


Da oltre 40 anni crediamo nell’intelligenza. E negli ultimi 15 anni abbiamo investito nella progettazione di piattaforme di interpretazione di flussi di dati sempre più complessi da cui trarre stimoli e segnali per cercare di comprendere il presente e anticipare il futuro per i nostri clienti.
Ma abbiamo continuato a ritenere fondamentale l’istinto, il pensiero laterale e qualche volta la visionarietà dell’umano intelletto.
Per questo crediamo fermamente nella IA. L’Intelligenza Animale.
grupporoncaglia.it

Di Fabrizio Beria
DeepSeek è un chatbot di intelligenza artificiale cinese che ha suscitato notevole attenzione a livello globale per le sue capacità avanzate e il modello di ragionamento. Sviluppato da una startup con sede a Hangzhou, DeepSeek è stato creato da Liang Wenfeng, un imprenditore con esperienza nel settore finanziario. L’azienda è supportata da High-Flyer, un hedge fund cinese, e si distingue per aver raggiunto prestazioni comparabili a quelle di modelli più costosi come ChatGPT o1 con un investimento dichiarato di circa 6 milioni di dollari. Questo risultato è attribuito a un nuovo modello matematico che richiede meno potenza di calcolo, consentendo a DeepSeek di competere con i leader occidentali dell’IA nonostante le restrizioni sull’esportazione di chip avanzati in Cina.
In confronto, si stima che l’addestramento dell’ultima versione di ChatGPT o1 sia costato alla statunitense OpenAI circa 100 milioni di dollari. Alcune fonti stimano che per GPT4 siano stati necessari investimenti pari a 10 miliardi di dollari [5]. Inol-
tre, ChatGPT è stato addestrato con 30.000 GPU, mentre DeepSeek-R1 ha richiesto solo 2.000 GPU.
Questa differenza di costi ha suscitato notevole interesse e preoccupazione nel settore, poiché suggerisce che è possibile sviluppare modelli di IA competitivi con un investimento significativamente inferiore.
DeepSeek è riuscita a ottenere risultati paragonabili a quelli di OpenAI e Anthropic ottimizzando il software e utilizzando tecniche di addestramento più efficienti, anziché fare affidamento su hardware costoso. Il fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, ha sviluppato un nuovo modello matematico che richiede meno potenza di calcolo, consentendo all’azienda di superare i limiti imposti dalle sanzioni statunitensi sull’esportazione di GPU avanzate in Cina.
Sam Altman di OpenAI ha accusato DeepSeek di aver utilizzato i modelli di OpenAI per addestrare i propri.

Tuttavia, DeepSeek afferma, pur senza fornire evidenze oggettive, di aver sviluppato un’architettura proprietaria internamente, senza distillazioni e derivazioni da GPT-4 o altri modelli di terze parti.
Oltre che le perplessità di tipo tecnologico emergono preoccupazioni in termine di protezione dei dati e della privacy degli utenti. DeepSeek invia, conserva e analizza i dati degli utenti, inclusi messaggi di chat e altre informazioni personali, a server situati in Cina il che va contro le regole del Garante della Privacy italiano (GPDP) sulla protezione dei dati che ha invitato DeepSeek a fornire chiarimenti in merito e, temporaneamente, vietato l’uso dei dati degli utenti italiani. Si aprono scenari complessi e interessanti.
Come ormai di abitudine in questa rubrica, ne abbiamo parlato direttamente con le due IA interessate per verificare l’attuale loro livello di “consapevolezza” reciproca.
Sono ChatGPT basato su GPT-4.5.
Conosci IA DeepSeek?
Sì, conosco DeepSeek, un’intelligenza artificiale sviluppata da DeepSeek AI, un’azienda cinese specializzata in modelli di linguaggio avanzati. DeepSeek ha creato DeepSeek-V2, un LLM open-source con capacità simili a GPT-4, e DeepSeek Coder, un modello ottimizzato per la programmazione.
Puoi fare un confronto tra voi due?
Ecco un confronto tra DeepSeek-V2 e GPT-4 basato su vari aspetti chiave:
1. Prestazioni generali
• GPT-4 (ChatGPT): Ottimo nel ragionamento complesso, nella comprensione del linguaggio naturale e nella generazione di testi creativi e coerenti.
• DeepSeek-V2: Molto competitivo, con capacità di comprensione simili a GPT-4 ma meno raffinato in alcuni aspetti come il ragionamento avanzato e la coerenza nei testi lunghi.
2. Programmazione (DeepSeek Coder vs GPT-4 Turbo)
• DeepSeek Coder: Ottimizzato per il coding, supporta più di 80 linguaggi di programmazione ed è molto forte nel completamento del codice e nella risoluzione di problemi algoritmici.
• GPT-4 Turbo: Eccellente nella
Sono DeepSeek-V3, un modello di linguaggio avanzato creato da DeepSeek. Sono stato rilasciato a giugno 2024.
Conosci IA ChatGPT?
Sì, conosco ChatGPT! È un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI, basato sull’architettura GPT (Generative Pre-trained Transformer). È progettato per generare testo in modo naturale e rispondere a domande, esattamente come faccio io. ChatGPT è stato uno dei primi modelli di intelligenza artificiale a ottenere grande popolarità per la sua capacità di interagire in modo fluido e coerente con gli utenti.
Puoi fare un confronto tra voi due?
Certo! Ecco un confronto tra DeepSeek-V3 (il modello che rappresento) e ChatGPT, evidenziando affinità e differenze:
Affinità:
Architettura di base:
Entrambi sono modelli di linguaggio basati su architetture Transformer, progettati per generare testo in modo naturale e rispondere a domande.
Scopo principale:
Sia DeepSeek che ChatGPT sono creati per interagire con gli utenti, fornire informazioni, risolvere problemi e generare contenuti testuali in modo coerente.
Apprendimento pre-addestrato:
Entrambi i modelli sono pre-addestrati su grandi quantità di dati testuali per comprendere il linguaggio umano e generare risposte pertinenti.
programmazione, con un’ampia base di conoscenza e capacità di spiegare codice in modo dettagliato, ma potrebbe essere più costoso e con più restrizioni.
3. Open-source vs Proprietario
• DeepSeek è open-source, quindi può essere eseguito localmente o personalizzato per scopi specifici.
• GPT-4 è chiuso e accessibile solo tramite OpenAI, il che limita la personalizzazione ma garantisce maggiore stabilità e aggiornamenti frequenti.
4. Prestazioni nei benchmark
• DeepSeek-V2 si avvicina molto a GPT-4 in test come MMLU (valutazione della conoscenza generale) e HumanEval (test sulla programmazione), ma GPT-4 mantiene un piccolo vantaggio nel ragionamento e nella gestione del contesto lungo.
5. Accessibilità e costi
• DeepSeek può essere eseguito gratuitamente su server personali, rendendolo interessante per chi vuole evitare i costi di API.
• GPT-4 Turbo è disponibile tramite ChatGPT Plus (20$/mese) o API a consumo, con vantaggi in termini di stabilità e supporto.
Conclusione
Se cerchi un modello open-source e personalizzabile, DeepSeek è una scelta solida, soprattutto per la programmazione. Se invece vuoi il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità senza preoccuparti di costi o personalizzazione, GPT-4 rimane superiore.
Per cosa consigli uso di DeepSeek invece che ChatGPT?
Se vuoi un modello AI open-source e gratuito
DeepSeek è open-source, quindi puoi eseguirlo localmente senza costi di abbonamento o API e vuoi che i tuoi dati rimangano completamente sotto il tuo controllo. Puoi integrare un LLM in un’app senza dipendere da OpenAI e personalizzare il modello per scopi specifici.
Se ti serve un modello per programmare (DeepSeek Coder)
DeepSeek Coder è ottimizzato per il coding e supporta più di 80 linguaggi di programmazione.
Se vuoi un modello AI che funzioni offline
Puoi scaricare DeepSeek e usarlo senza connessione internet, garantendo massima privacy e indipendenza dai server esterni
Chi ti ha creato ed è il tuo proprietario ad oggi?
ChatGPT è stato creato nel 2015 da OpenAI, un’azienda statunitense specializzata in intelligenza artificiale.
Ad oggi OpenAI è divisa in due entità:
OpenAI, Inc.
Organizzazione madre senza scopo di lucro.
OpenAI LP (“capped-profit”)
Divisione commerciale che sviluppa ChatGPT e altri prodotti AI. Microsoft, con 13 miliardi di dollari, è il maggior investitore ed è anche il maggior fornitore di infrastruttura cloud tramite Azure.
Versatilità:
Possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, come assistenza virtuale, traduzioni, scrittura creativa, tutoring e molto altro.
Aggiornamenti continui:
Sia DeepSeek che ChatGPT vengono migliorati nel tempo con nuove versioni per aumentare l’accuratezza, la coerenza e le capacità complessive.
Diversità:
Sviluppatore:
DeepSeek-V3 è sviluppato da DeepSeek, un’azienda cinese focalizzata su intelligenza artificiale e big data.
ChatGPT è sviluppato da OpenAI, un’organizzazione statunitense nota per i suoi avanzamenti nel campo dell’IA.
Modello di base:
DeepSeek-V3 si basa su un’architettura proprietaria ottimizzata per specifiche esigenze, con un forte focus su efficienza e prestazioni in contesti multilingue.
ChatGPT si basa sulla serie GPT (ad esempio, GPT-3.5 o GPT-4), che è ampiamente riconosciuta per la sua capacità di generare testo fluido e dettagliato.
Focus geografico e linguistico:
DeepSeek potrebbe avere un focus maggiore su lingue e contesti culturali asiatici, data la sua origine cinese.
ChatGPT è stato sviluppato con un forte orientamento verso l’inglese e le lingue occidentali, anche se supporta molte altre lingue.
Personalizzazione e applicazioni:
DeepSeek potrebbe essere più integrato in soluzioni aziendali e industriali, specialmente in Cina e in Asia.
ChatGPT è spesso utilizzato per applicazioni più generali, come as-
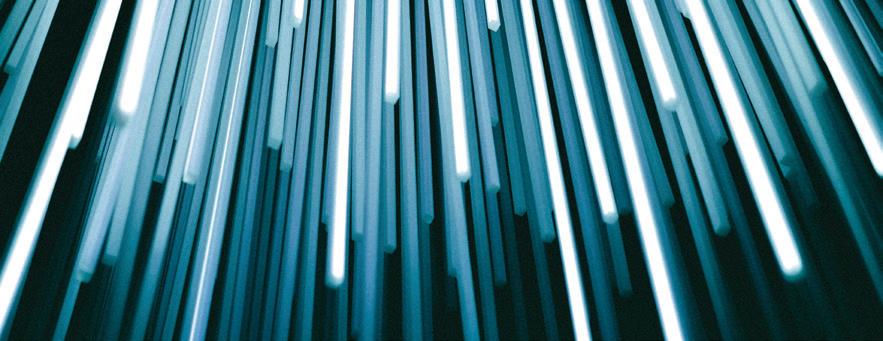
sistenza virtuale, creatività e apprendimento.
Disponibilità e accesso:
DeepSeek potrebbe essere più orientato verso mercati specifici (ad esempio, Cina e Asia), con un accesso potenzialmente più limitato in altre regioni.
ChatGPT è ampiamente disponibile a livello globale, con versioni gratuite e a pagamento (ChatGPT Plus).
Ethos e filosofia:
OpenAI ha una forte enfasi sull’IA etica e sicura, con un approccio cautelativo verso lo sviluppo di tecnologie potenti. DeepSeek, pur seguendo standard etici, potrebbe avere un approccio più orientato all’integrazione pratica e industriale.
In sintesi:
Affinità: Entrambi sono modelli avanzati di intelligenza artificiale con obiettivi simili, basati su architetture Transformer e progettati per interagire con gli utenti in modo naturale.
Diversità: Le differenze principali risiedono nello sviluppatore, nel focus geografico e linguistico, nelle applicazioni specifiche e nella filosofia di sviluppo.
Per cosa consigli uso di DeepSeek invece che ChatGPT?
Lingua e contesto culturale: ChatGPT è particolarmente forte nell’elaborazione della lingua inglese e di altre lingue occidentali. Se il tuo focus è su contenuti in inglese o in lingue europee, ChatGPT potrebbe offrire prestazioni più fluide e naturali.
Creatività e generazione di contenuti:
ChatGPT è noto per la sua capacità di generare testo creativo, come storie, poesie, script e contenuti marketing. Se hai bisogno di un assistente per la scrittura creativa, ChatGPT potrebbe essere la scelta migliore.
Integrazione con strumenti e piattaforme:
ChatGPT è integrato con molte piattaforme e strumenti popolari, come Microsoft Azure, OpenAI API e varie applicazioni di terze parti. Se hai bisogno di un modello di linguaggio che si integri facilmente con ecosistemi esistenti, ChatGPT è una buona opzione.
Chi ti ha creato ed è il tuo proprietario ad oggi?
DeepSeek è stata fondata da un team di esperti in intelligenza artificiale, data science e tecnologia. L’azienda ha sede in Cina e si concentra sullo sviluppo di soluzioni IA per applicazioni industriali, aziendali e di ricerca.
Non ci sono informazioni pubbliche dettagliate sui fondatori specifici, ma l’azienda è riconosciuta per il suo approccio innovativo e la sua competenza tecnica.
Essendo un’azienda privata, DeepSeek non è tenuta a divulgare pubblicamente dettagli sulla sua proprietà o struttura finanziaria, a meno che non sia richiesto dalle normative locali.
Davide contro Golia quindi?
E’ presto per dirlo, anche se le premesse evocative ci sarebbero tutte. Certo è che la partita non finisce qui, siamo solo all’alba di una nuova era.
Scenari, modelli di apprendimento e di business, impatto sulla vita quotidiana e sulle modalità di studio e interazione sociale ancora da scoprire, cavalcare e arginare.
Aspetti tecnologici, culturali, di accesso, tutela e verifica delle fonti di dati e della privacy da normare andando ben al di là degli attuali atti iniziali predisposti dalle Authority dei diversi paesi.
Non per ultimo, il reale pericolo di sicurezza dati e sistemi rappresentato dalle pratiche di hacking che sfrutteranno sempre di più la potenza e l’accessibilità alla potenza dell’IA già su server domestici dotati solo di schede video (GPU) accelerate e, presto, di CPU di tipo quantistico. Ma di questo ne tratteremo prossimamente.
Colloquio avvenuto il 28 febbraio 2025

Gli basta sollevare gli occhi e prendere un respiro per uscire da quelle pagine oscure. La valle si spalanca allo sguardo di Giuliano. Non c’è solo marcio nel mondo, è il pensiero che gli suscita questa vista.
Lo scritto di Umberto Cennamo si interrompe. Fa un salto di almeno un anno. Non racconta cosa è successo a piazza Fontana. Almeno non nelle pagine in possesso di Giuliano: chissà se qualcun altro ha avuto la possibilità di leggerle.
Il processo per i fatti accaduti quel 12 dicembre di cinquant’anni prima si era finalmente concluso, dopo anni di rinvii, di riprese, di cambi di sede. Uno dei tanti processi trascinatisi per anni alla ricerca della verità.
Ma è poi la verità ad aver trionfato? E quale verità, se tutto, come scrive Cennamo stesso, è volutamente doppio? La verità ha tante direzioni, e tutte con un loro senso compiuto. Di una cosa Giuliano è sicuro: se avesse letto queste pagine quando era ad Agrigento, non avrebbe commesso gli errori di cui ancora non si dà pace. La verità esiste, al contrario di quanto pensava Cennamo, ma non va soltanto in una direzione, come allora aveva creduto. Aprire lo sguardo, invece, raccogliere le tante direzioni della realtà in un colpo solo, accogliere il senso del tutto, questo è ciò che più si avvicina a quel concetto di comprensione di quanto accaduto che il memoriale di Cennamo adombra e che Giuliano sta sperimentando.
Ecco perché quella vallata sulla quale si affaccia ogni giorno è così importante
per lui. Un colpo d’occhio e tutto è lì disponibile, aperto. Basta non lasciare che lo sguardo si indirizzi in un solo verso, ma che si lasci andare all’inclusione di ogni particolare, senza bisogno di selezionare cosa sia più importante o meno.
È il suo rifugio da sempre, da quando suo padre aveva rimesso a posto quel palazzo, negli anni Cinquanta, e ancora di più da quando ci si è trasferito con Valeria, appena dopo la morte di Irene. Sulla panchina ci viene nei momenti in cui deve ricaricarsi di energia pura, quella che sente arrivare direttamente dalla terra. Senza pensare a niente. Le prime volte si era meravigliato che potesse essere possibile cancellare i pensieri così, semplicemente osservando un panorama, per quanto bello. Poi si era abituato a naufragare in quel mare infinito di verde, come il poeta davanti alla sua siepe.
Non che la mente non continui a lavorare, seduto su quella panchina, tutt’altro. È che a occuparla sono i piccoli cambiamenti che si possono osservare giorno dopo giorno in quel quadro d’insieme che sembrerebbe immutabile, e che invece è in continua evoluzione. Piccole tracce che l’occhio si diverte a scoprire. Macchie di colore che cambiano tonalità, stormi di uccelli che modificano la direzione rispetto ai giorni precedenti, le attività degli uomini che si avvicendano e ne rendono presente l’esistenza. È sempre possibile cambiare prospettiva, per inaugurare un approccio nuovo alle cose.
Il complesso in cui abita ha due anime, una meditativa e l’altra sociale. La palazzina giallo pastello è rivolta alla
vallata, alle colline verdi, alle montagne che arrivano a nascondere la grande parte del cielo. Dall’altro lato del piccolo parco un palazzetto che suo padre aveva venduto diversi anni prima, che dà sul paese. Ora c’è una residenza per artisti, che si popola di mese in mese di pittori e scultori di tutte le nazionalità, che alla fine del soggiorno creativo espongono le proprie opere nel grande locale una volta adibito a deposito. Per Valeria, soprattutto negli anni della sua malattia, quella parte del vecchio complesso era stata uno sfogo vita le. Contribuiva alle attività dell’associazione che animava il luogo e, conoscendo tante lingue, aiutava nell’ospitalità degli artisti. Giuliano aveva constatato come per Valeria fosse necessario mantenere un atteggiamento creativo nei confronti della vita, anche nel momento in cui aveva appreso che il suo tempo non sarebbe stato lungo.
«Quello che importa è ciò che fai nel singolo istante in cui vivi. È nell’istante che si crea il valore che dai alle cose. Se attendi che si presenti l’occasione favorevole, se rimandi ogni volta, non ti resta niente.»
Giuliano annuiva, ma a lui tutta quella vitalità nell’altro versante della casa dava un po’ fastidio, perché lo costringeva a rapporti sociali che avrebbe volentieri evitato. Si prestava solo per compiacere Valeria, che lo chiamava per assistere alle mostre e qualche volta gli aveva anche chiesto di accompagnarla all’aeroporto per accogliere gli artisti. Poggio Vecchio è un comune di meno di ottocento abitanti, ma per Giuliano sono
comunque troppi. In paese lo rispettano, ’U bardascio de Cesare, il ragazzo di Cesare, lo chiamano ancora gli anziani. Cesare era suo padre, originario del posto, trasferitosi a Roma in gioventù, che non aveva mai voluto vendere il palazzo di famiglia.
Per Giuliano è stato comodo tornarci ventidue anni fa, dopo essere stato trasferito alla Procura di Rieti: ci mette venti minuti con l’auto, meno che dalla sua casa romana di via Benaco a piazzale Clodio. Con il piacere aggiuntivo, una volta tornato a casa, di potersi buttare alle spalle tutte le beghe giudiziarie. Basta solo lasciar andare lo sguardo sulla valle di fronte al giardino. Ha anche un piccolo orto sul lato assolato nel quale coltiva con cura le verdure e si gode il raccolto degli alberi da frutta. Valeria raccoglieva pomodori, mele, albicocche e tutti gli altri prodotti di quel giardino con gridolini di soddisfazione, che si amplificavano quando li mangiava. Sembrava provasse più gusto del normale ad assaporare i risultati della cura contadina di Giuliano, e lui era orgoglioso di aver prodotto qualcosa che le piacesse così tanto.
Il racconto di Umberto gli sta facendo riconsiderare molte cose che lui aveva interpretato solo parzialmente. Le sue indagini, quelle che avevano provocato l’incidente in cui era morta sua figlia, acquistano ora una luce diversa. Aveva sempre pensato che la mafia e le strutture criminali fossero le vere padrone dell’Italia e condizionassero la vita del Paese, ma ora deve ricredersi: sono uno dei tanti volti che il vero potere ha usato per mantenersi in vita. Travalicando i confini dei singoli Stati, cercando il
profitto ovunque possibile, consapevole che togliere ricchezza agli altri è l’unico modo per mantenere la propria. Quello che Giuliano non ha capito al tempo è che c’è qualcosa, e qualcuno sopra le mafie, che le usa. Per questo non era riuscito ad andare fino in fondo, per questo non può far altro che aiutare Marta a trovare la verità nascosta nella sua famiglia, e sperare che i tasselli che si stanno via via
Le stragi di Porzus, di Portella della Ginestra, fino a quelle di Piazza Fontana e della Loggia e i misteri legati al caso Moro si intrecciano con le vicende personali di Marta - una psicoanalista di 56 anni in crisi profonda con sé stessa - e della sua famiglia. La sua lotta per la verità dovrà scontrarsi con la resistenza di oscuri personaggi che difendono con ogni mezzo i propri segreti, custoditi in documenti riservati ormai a rischio di desecretazione. «Devi usare brandelli di verità per portare allo scoperto questi personaggi che manovrano nell’ombra. Dobbiamo usare la loro stessa strategia: nascondere, però con l’obiettivo di portare alla luce ciò che è accaduto.»
mostrando rivelino il disegno complessivo.
(dal romanzo “La strategia dell’ombra” di Paolo Di Reda - Nolica Editore)
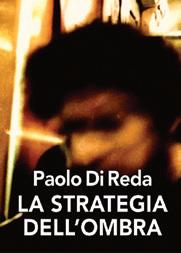
Paolo Di Reda è nato a Roma nel 1959. Scrittore, sceneggiatore e giornalista, ha pubblicato i romanzi Prove generali per scomparire (2005) e Ricordare non basta (2009) entrambi per la Edimond; Il labirinto dei libri segreti nel 2010 e La formula segreta delle SS nel 2013 per Newton Compton (scritti entrambi insieme a Flavia Ermetes) quest’ultimo uscito anche nei paesi di lingua spagnola e in Russia e La rabbia che rimane (Fahrenheit 451, 2015). Tra i suoi racconti, inseriti in diverse antologie, A finestre aperte (in “Roma per le strade”, Azimut, 2007), “L’ultima cena” (in “Scritto e… mangiato”, Perrone, 2011) e “Zabriskie Point – Gli occhi dell’immaginazione” (in “8 e 1/2 n.33 – Racconti di cinema”, 2019). Per il cinema, tra gli altri, ha scritto nel 2006 “Salvatore. Questa è la vita” con il regista Gian Paolo Cugno, primo film italiano prodotto dalla Disney con protagonisti Enrico Lo Verso, Giancarlo Giannini e Gabriele Lavia.
Uno dei luoghi comuni più amati nel Paese nostalgico in cui ci troviamo a vivere è quello della immutabilità gastronomica. Lo ha sperimentato Luca Cesari quando ha fatto presente, forte di studi e approfondimenti che mettono fuori discussione ogni possibile contestazione, che nella prima ricetta della carbonara pubblicata in Italia (“La Cucina Italiana”, agosto 1954) c’erano aglio, pancetta e gruviera: niente guanciale, niente pecorino. Subito, ineffabili ricordi familiari legati a mitologiche nonne nonché immancabili accuse di attacco alla patria hanno colpito lo storico, semplicemente colpevole di rivelare quello che peraltro non richiedeva proprio un’analisi al Carbonio C14 per essere svelato: la carbonara è una ricetta recentissima, come gran parte di quelle oggi popolari, formatasi a cavallo della Seconda guerra mondiale, tra le due sponde dell’Atlantico, e destinata a sedimentarsi in Italia solo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, all’inizio dei quali ancora Gualtiero Marchesi impiegava la panna (per dare un “tocco di eleganza”) e il burro nella sua realizzazione.
Quello che avete appena letto è un brano tratto dal saggio di Michele Fino edito da Mondadori dal titolo Non Me La Bevo e dedicato al vino ed ad una presunta storicità di determinate procedure che altro non sono che aspetti evolutivi che si rifanno ad un passato che non esiste. L’autore cita uno storico della gastronomia, Luca Cesari, autore del volume
Storia della pasta in dieci piatti uscito nel 2021 per far comprendere come la carbonara di oggi sia un processo evolutivo di una ricetta la cui origine, recente, non può far parte del nostro retaggio culturale antico, come per il vino cosiddetto naturale. Ma del vino diremo in altra occasione, recensendo il saggio sopracitato. In questa occasione mi limiterò alla carbonara, non per difendere, da romano, una ricetta classica, quanto invece la creatività della cucina italiana e la sua capacità di evolversi.
Di ricette della carbonara ne troveremo diverse, contigue all’attuale più diffusa, ma non eguali. In un volume degli anni ’90 edito da Franco di Mauro dal titolo A Roma se magna così, la carbonara aveva il guanciale ma anche la cipolla e qualche pomodorino. E il parmigiano era contemplato, non come primario, ma come presente. Nel caso appena citato ad esempio non c’è il pepe.
La prima certificazione della ricetta la troviamo a metà degli anni ’50 del secolo scorso, come ricordava Michele Fino, in quanto la rivista La Cucina Italiana la descrive con pancetta, gruviera e aglio, oltre alle solite uova e al pepe. E in effetti Luca Cesari ci rimanda ad una ricetta umbra del 1931 in cui però, oltre a uova e pancetta, si parla di gruviera e aglio. Sarà uno dei grandi maestri della cucina italiana Luigi Carnacina a sancire l’uso del guanciale invece che della pancetta (differenziazione avvenuta grazie ad Ada Boni subito dopo la guerra) ma contestualmente avallare l’uso della
Di Sante Lancerio e Sommelier Franz
panna, rimasta in voga fino a tutti gli ’80 e sublimata da un grande chef del nostro paese, Gualtiero Marchesi.
Tutti aspetti che oggi fanno inorridire i cosiddetti puristi di una ricetta che non ha originali. È semplicemente l’evoluzione di una creatività, accreditata per i più a quegli italiani che nella seconda fase della guerra dovevano fare i conti con la poca disponibilità di viveri, compensata dalle razioni dell’esercito americano: uova liofilizzate e bacon (pancetta appunto). Tant’è che, secondo alcuni studi, sono stati loro i primi estimatori di questo piatto. E la sua romanità potrebbe dipendere da quella liberazione del 1944 che ne ha fatto la città ispiratrice. Ma quale che sia la verità, nessuna nonna vissuta prima del XXI secolo poteva ascriversi la ricetta originale.
Non hai tempo per leggerlo? Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza

Di Sante Lancerio e Sommelier Franz
L’altro sono incappato in un articolo che riprendeva un tema affrontato in un saggio edito da Mondadori dal titolo: La cucina italiana non esiste. Sottotitolo: Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici, scritto da Alberto Grandi, storico dell'alimentazione e professore di storia economica all'Università di Parma e da Daniele Soffiati, suo sodale nel celeberrimo podcast DOI - Denominazione di Origine Inventata (come descritto nel sito dell’IBS Ndr).
L’articolo spiegava, come da noi già fatto in questa rubrica, che la carbonara è frutto di una necessità nata alla fine della seconda guerra mondiale, che l’abitudine di usare la passata di pomodoro per condire la pizza è nata negli States dagli immigrati italiani, perché nel nostro paese si usava il pomodoro fresco. Quello che mi ha più colpito dell’articolo sono state le reazioni che queste pubblicazioni provocano nei cosiddetti tradizionalisti, quelli che la carbonara si è fatta sempre così, e il guanciale e non la pancetta. Tradizionalisti che non hanno alcuna conoscenza dell’evoluzione storica, sociale, di costume e usi delle popolazioni nel corso degli anni.
Se soltanto facciamo un passo indietro, diciamo poco più di un secolo, e andiamo a leggere la prima edizione del Pellegrino Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, uscito in prima edizione nel 1891 con ben 476 ricette, non contempla, non solo la carbonara, ma neanche l’amatriciana,
né la gricia. C’è il risotto alla milanese. Eppure stiamo parlando di bisnonni, non dell’antichità.
Perché se guardiamo ancora più indietro scopriamo che il mondo dell'alimentazione italiana e europea ha avuto un forte cambiamento dopo la scoperta dell’America. Noi siamo il paese del pomodoro, ci facciamo l’arrabbiata, il ragù bolognese, la pizza, l’amatriciana, appunto, ma questo frutto nel nostro paese non era conosciuto prima che fosse stato importato dalle Americhe. Come le patate peraltro. Il caffè, il cioccolato, alimenti di cui siamo orgogliosi. Ma non per la tradizione, ma per la capacità di averli saputi trasformare e rendere “Made in Italy”. Da questo punto di vista è estremamente interessante il saggio/ricettario storico A tavola nel medioevo realizzato da Odile Redon, Françoise Sabban e Silvano Serventi che ci portano a conoscere come e cosa si mangiava nel medioevo, in Italia e in Francia, prima appunto che il pomodoro condizionasse la nostra e la patata quella d’oltralpe.
E che dire degli spaghetti che leggenda vuole furono portati a conoscenza della popolazione italica da Marco Polo. Leggenda che non ha nulla a che fare con la realtà. Già i greci e i romani impastavano la farina e facevano uso di pasta fresca. Nel medioevo si impastava col formaggio prima di metterla a cuocere nell’acqua calda e poi negli anni vi è lo sviluppo del condimento. Ma la pasta
secca è messa a punto dagli Arabi, come ci spiega l’Accademia dei Georgofili, che la portano in Sicilia, dove nel 1154 il geografo Muhammad al-Idrisi (1099 circa – 1165) scrive che nell’abitato di Trabia tra Termini e Palermo si produce pasta che è esportata in tutto il Mediterraneo. Nel 1279 la pasta secca è presente a Genova dove un notaio, nel compilare l’inventario dei beni lasciati da un milite di nome Ponzio Bastone, annota “Una barisella plena de maccaroni”. È la prima volta che compare questa parola, sedici anni prima che Marco Polo faccia ritorno dalla Cina (1295).
E visto che abbiamo citato i romani, possiamo andarci a deliziare sul cibo dei nostri antenati con il bel lavoro di Claudia Cerchia Manodori Sagredo e Laura Di Renzo, la prima archeologa e storica dell’arte romana, la seconda Professore associato di scienze e tecniche dietetiche applicate all’università di Tor Vergata a Roma. E in questo loro lavoro, Quanto erano nutrienti i banchetti dei romani antichi? Edizione «L’Erna» di Bretschneider, scopriamo che il fois gras era sulle tavole dei romani ben prima che su quelle dei francesi: «Particolarmente apprezzato era il fegato delle oche ingrassate», almeno quanto la polpa di Murena «presa ancora gravida», spiega il ricco Nasidieno ai suoi ospiti, «perché una volta deposte le uova la sua carne sarebbe stata meno buona».


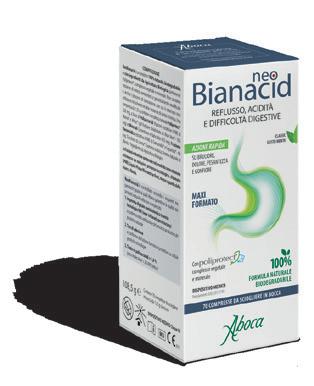






Toti Scialoja, in questo suo articolo pubblicato sul primo numero di Mercurio nel settembre 1944, discute dell’eredità fascista sull’arte. Un tema oggi, 2025, quanto mai attuale.

A cura della casa editrice Succedeoggi
Un anno e mezzo fa (come dire un secolo), celebrandosi il Ventennale fascista, un critico stolto identificò l’arte fascista con quella dei migliori artisti italiani del Novecento, scoprì una perfetta coincidenza tra l’affermazione del fatto politico e i risultati dell’azione artistica, tra rivoluzione artistica e rivoluzione fascista.
Ora, nulla di più iniquo poteva essere proclamato; la cronologia, e la critica degna del suo nome, se ne ribellano. La pittura italiana nasce attorno allo scadere del primo lustro del Novecento; la Nostalgia dell’Infinito di De Chirico è del ‘12, le Figlie di Lot di Carrà del ‘15, il Paesaggio di Morandi dell’‘11. Immagini aspre e dimesse, elementari e sillabate, spoglie d’ogni sfarzo e d’ogni lusinga. Umili e «democratiche» vorremmo chiamarle, per amor di polemica, e testimoniavano con quanto amaro disdegno questi artisti allontanassero i calici iridati del Liberty e del verismo, i lustrini e i languori del simbolismo divisionista e del pessimo impressionismo scandinavo delle Biennali veneziane.
In realtà la pittura italiana si destava da
un inconsolato, secolare letargo; tornava lentamente ad articolarsi su quelle tele una nuova poetica misura ove la forma era costruzione dello spirito, lo spazio era visione e non più casuale frammento; e con la coscienza del mezzo espressivo perdeva, la pittura, la sua odiosa precisione ottica, l’inerte oggettività della retina, e si faceva insomma creazione e non riproduzione. Si stabilivano i primi misteriosi contatti con l’arte francese dell’Ottocento, i primi innesti con l’opera di Cézanne e dei cubisti. Innesti faticosi, incerti; eppure questa volta protetti dal favore di una stagione segreta. Ché se il vento spira rigido e avverso lascia senza fiore qualsiasi viaggio di macchiaiuoli a Parigi, qualsiasi mutar di tende (o altrimenti soffia così saggiamente da portarsi via per sempre seme e tutto, come accadde per il mirabile trapianto modiglianesco).
Quanta ostinazione e caparbietà morale, quanta volontà di universale linguaggio animasse quei fondatori noi lo decifriamo sulle prime tele di quei tempi, sulle tavole chiamate troppo genericamente metafisiche. (E qui occorre precisare che questo termine insidioso e cangiante dovrebbe valere solo per le favole ironiche, le allucinazioni scenografiche di De Chirico che utilizzò per i suoi trompe l’esprit, con fredda determinazione, modi formali remotissimi; mentre Carrà, nelle sue strutture primitive e commosse, nello spazio gremito e tutto «cilindrico, cubico, sferico» stritola negli angoli ogni pretesto surreale, e Morandi metodica-
mente pugnala ogni possibile allusione letteraria con la medesima lama con cui sbuccia gli impeccabili pomi di Aix, dalla dura scorza, per ridurli a sola polpa di luce e colore. Quando dieci anni più tardi il giovane De Pisis parve accostarsi al metafisico scenografico e prospettico, immediatamente quelle cadute vertiginose e mentali gli divenivano vivo orizzonte marino, frecciate di allodole nella profondità dei vibranti cieli marinettiani).
Nemmeno la fragorosa sconvenienza futurista, nemmeno quella apoplessia meccanica e macchinistica valse a frastornare i migliori di quegli artisti (Severini, innocente tra cubismo e futurismo, candidamente ingentiliva dove toccava); anzi alcuni si servirono di quell’inconsulto orgasmo come di una salutare ginnastica, per svaporare in traspirazione gli estremi residui di una vacua e provinciale cultura.
Con clangori e squilli ben diversamente avventati e oltracotanti si propagò il fascismo, ammantato di drappi e cornici presuntuose, tra vittorie mutilate, aquile romane, mari nostri di improntitudine; spargendo alla aria a piene mani le porporine nazionalistiche e pragmatistiche e le grinte di un superomismo e volontà di potenza, della sostanza appunto più vacua e provinciale.
Mussolini che a quei tempi posava a patito e intellettuale, di fronte ad una cultura figurativa già tanto timbrata a
irrefragabile volle atteggiarsi a Mecenate spregiudicato, e tentò di assimilare quelle forze spacciandole per «rivoluzionarie». Al solito si prestarono al gioco i peggiori, i mediocri, quelli che del nuovo linguaggio non avevano inteso altro che i procedimenti esteriori, la superficiale scolastica; e furono i «novecentisti» milanesi, i «neoclassici», i «masacceschi», i tetri dulcamara spacciatori delle fulminanti ricette: «chiaroscuro italico morale» contro «cromatismo gallico immorale», furono gli esteti wagneriani suscitatori di «nuovi miti» e di affreschi imperiali; per essi ogni problema era risolto nel più farisaico senso di una tradizione antieuropea, ogni calore di vita moderna e di commozione si raggelava in una certezza vuota ma con la v maiuscola. E furono i Sironi, i Funi, gli Oppo, i Conti, i Messina, ecc. tutti artisti di poverissima linfa, assieme a tanti altri per nostro sollievo già dimenticati. Sorse il movimento di «strapaese», fenomeno assai meno letterario e assai più morale di quanto generalmente si creda. Sostituendo il Giuoco dell’oca alla Roulette nietzschiana e wildiana e l’Almanacco di Barbanera alle Laudi inimitabili, non fece che togliere un manto ormai troppo sfarzoso e camuffare con una decorosa pellegrina neoclassica le stesse immutate membra nazionalistiche, faziose e provinciali. Al Principe machiavellesco sovrapponeva il volto bonario del Granduca, al superuomo l’omino; ma lo spregio e l’irrisione per ogni profonda virtù e impegno morale rimaneva il medesimo. In questo ci-
nismo artigianesco, in questa scettica sufficienza si rattrappirono gli ingegni di un Soffici e di un Rosai mentre il furbissimo gusto longanesiano spargeva attorno come una seppia il suo bel nero tipografico. (La critica distinguerà sempre meglio questa provincia becera e macchiaiuola dalla celeste solitudine di un Morandi, questo formalismo purista e codino dalle certezze plastiche di un Carrà, conquistate per lampi).
Anche qualche artista assai dotato con il volger degli anni si lasciò sedurre dal clima ufficiale, che diveniva sempre più eroico, e dagli scherni celebrativi e aulici; ma subito, ammesso alla corte, fatalmente decadde, per non più riaversi, nella oleosità illustrativa e nella bambocciata accademica; perché il fascismo che voleva essere prassi e pensiero, dottrina totale, invenzione di una nuova coscienza, altro in vero non era che vuota formula, usbergo corrusco levato a camuffare un cieco sfrenamento di istinti, un feticismo di violenza, un giuoco di sopraffazioni; e non poteva rinnovar l’animo né destare la fantasia a nessuno. Chi non ricorda, per far due esempi, la triste bianca scogliera ove naufragò l’ingegno di Martini: quel bassorilievo della Giustizia Corporativa deserto come un presepe pietrificato? E i ritrattoni ufficiali di De Chirico, lustri e sinistramente accademici?
Ma gli artisti più decisi proseguivano nelle loro ricerche, in un clima segreto, sempre più arduo e europeo. Dopo
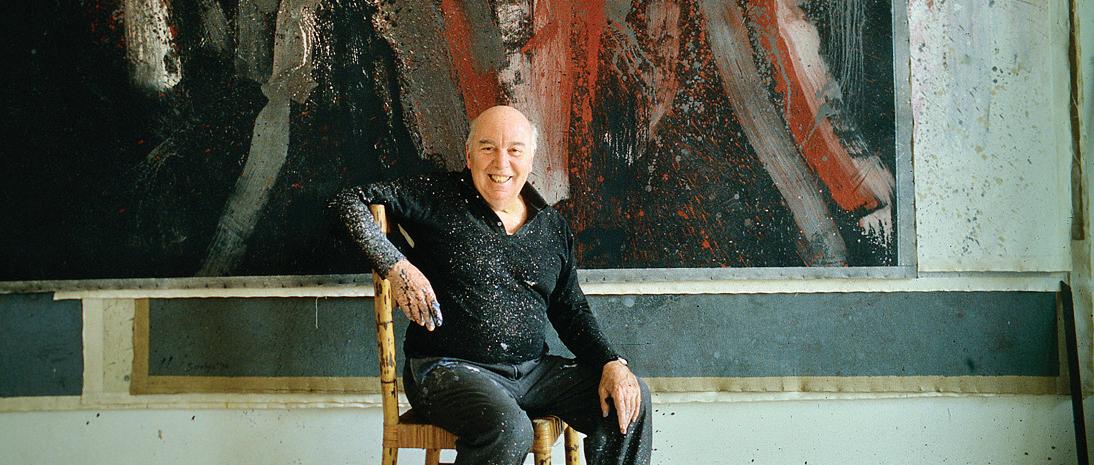
quindici anni dalle prime esperienze si tornava a districare le matasse, ancora brucianti, di Renoir; e i più giovani ne traevano persino del filo spinato. La nostra pittura, perduta ogni scoria naturalistica tornava poeticamente e umanamente a intridersi e a scomporsi e ad avvampare di nuovissime fiamme avvicinandosi appena alle faville impressioniste e alle ceneri espressioniste.
Ed ecco, anche oscure minacce si addensarono; apocalittici vessilliferi del crimine nazista nel campo della coltura e dell’arte. Farinacci e Interlandi, Ojetti e Soffici svolsero il loro abominevole apostolato in favore di un’arte totalitaria o di stato, di un Museo d’arte degenerata che doveva imprigionare in una muda mortale tutte le nostre espressioni più alte e libere, e con accuse e ricatti, alla caccia di ebraismi decadentistici e di deformazioni internazionalistiche, funestarono e resero sempre più dolente la vita degli artisti migliori. L’architettura, che arcaicamente veniva riscoprendo la necessità di un suo linguaggio, ne fu stroncata, e rapidamente si trasformò in una grossolana forma di amministrazione monumentale, di appalto al retore e di concorsi falsificati, segnò il trionfo della cartapesta che si pavoneggiava perché era di marmo, senza accorgersi di avere il busto di ferro: poiché solo il buon ferro, proprio quello delle cancellate, e il cemento, potevano reggere quelle ampollose pletore d’archi e di colonne e far sì che non si sfaldassero al primo vento del buon senso e del buon
gusto. La rovina culminò con l’enorme tumore marmoreo dell’E.U., imperiale e kolossal; che attenderà, inospite fino alla fine dei secoli, la venuta dei suoi legittimi abitanti Hitler e Nerone assisi sulla quadriga böckliniana. Pure per merito di un miracoloso compromesso, ai pittori fu permesso dipingere, e forse in memoria del Mussolini sarfattiano e per gloria di «progrediti» ministri, il fascismo giuocò d’astuzia, e ostentando umanità e liberalità e un paternalismo soavemente corruttore, facendo piovere sul parnaso una rugiada di premi, sussidi e cattedre, tentò di far credere che la nuova dottrina coincideva con le forze nuove di cultura e di umanità. Escogitarono i fascisti servirsi dell’arte italiana per proclamarsi portatori di un verbo universale; in effetti servirono l’arte e gli artisti permettendo loro di operare nel senso della libera disinteressata creazione. Di faccia a quelle opere ermetiche e disperate, difficili e amare, i gerarchi ormai catechizzati non distraevano e non battevano nemmeno più i loro occhi bovini. Anzi si pavoneggiavano alle «vernici» delle mostre, mostruosamente ignari, davanti alle tele e ai bronzi che erano testimonianza di patimento e di solitudine, clausure di disperato individualismo, ripudio di un costume corrotto.
L’accusa e la sfida a quel secolo «oltremodo sfarzoso e di gran rombo» seguitavano ad essere sigillate in quelle poche bottiglie dirute e sepolcrali, nei fiori secchi delle rimembranze, divenu-
ti polvere e luce, nelle spiagge sbarrate da un mar di basalto contro le cabine vuote come cripte, nei cristianucci illuminati dal baleno e morsi dalla tarantola, nei diademi di frutta che sprizzano crepitando i loro sughi putrefatti, e in tante altre immagini ardue, macerate, esasperate. Infine, approssimandosi la tormenta, quando già un gran freddo soffiava nelle coscienze, gli artisti italiani sempre più espressero la loro inquietudine e la loro impossibilità a sentirsi in comunione.
Per alcuni la confessione si fece, nel segreto, ancor più impaziente; nell’accanimento di un tono, nello stridore di un accento, nel rompersi della materia pittorica; per altri si configurò in irrefrenate apparizioni di donne piangenti, di favole dolorose, di massacri. E non che per alcuni tale orgasmo non riproponesse termini ancora troppo volontari e schematici, formulandosi in esigenze e non disciogliendosi in visione. Ma non dobbiamo dolerci se, come per una combinazione chimica di medesimi elementi (fauves, cubisti, sociali, ecc.) i risultati espressionistici risultassero assai simili a quelli documentati dalla feroce collana della «Junge Kunst»; poiché solo uno stato profondamente esasperato può tentare di toccare il segno e tagliare più nodi possibili con tanta drastica precipitazione.
Fuori d’ogni schema, Mafai dipinse le sue macabre fantasie ove son cortei e ridde di aguzzini malefici intenti a pi-
luccare ignude e mozze vittime, in ritmi così rigorosi che paion scanditi dal metronomo morandiano, eppure carichi di un corruccio e di un convulso goyeschi; Manzù impresse in bassorilievi i suoi Cristi appesi alla croce per un braccio come bandiere insanguinate, carnali vele impiccate ed immote nella mortale bonaccia che precede l’uragano, d’una plastica luminosa e dolente come un sudore, che dalla sottile febbre lombarda lo riconduce allo splendore donatelliano.
Questa, dalle origini a oggi, è stata ed è per noi l’arte italiana di Carrà e di Morandi, di Tosi di Severini e di Casorati, di De Pisis e di Scipione, di Mafai di Marini e di Manzù ecc. e dei più giovani torinesi, romani e milanesi. In trenta anni, dalla tabula rasa precedente, essa si è innestata ad una cultura grande e adulta, quella francese, ne ha assimilato quel che le era vitale edificando una nuova cultura figurativa, sofferta, complessiva, universale; si è svincolata di fatto, con le opere, dalle spire della crisi idealistica e i miti della pura visibilità; ha tentato una nuova unità tra visione e immagine e una più profonda necessità di espressione, arricchendo il senso dell’autonomia dell’arte. Finalmente libera da minacce, conformismi e umilianti etichette riprende il suo imprevedibile corso. Oggi l’artista potrà esprimere compiutamente il proprio tempo, appunto perché il tempo dell’immagine è sempre interiore ed è sempre «contemporaneo» se l’immagine nasce ne-
cessaria, insostituibile, alla coscienza; nella ricerca, intensa sino a divenir religiosa, di se stesso e della sua visione, e nella fedeltà ad essa, l’artista esprimerà un tempo eterno e non cronologico, una stagione di tutta l’umanità.
E come l’arte non temette e trionfò sui tentativi di corruzione e di imposizione fascista così oggi non temerà certo le congiure e gli sdegni dei dimenticati vegliardi delle accademie, nelle cui vene è in fregola ancora l’irresistibile Champagne liberty e nelle cui lenti lampeggia stereoscopica e inesorabile la volontà di riprodurre pelo per pelo il «Vero», proprio come Iddio lo ha creato. Ben altrimenti dolorosi e apportatori di confusione potrebbero risultare le congiure e gli sdegni di alcuni giovani che scambiando la dura rinunzia con arcadia, l’esilio interiore con egoismo, la meditazione con ozio, hanno gran voglia di chiamar decadente, ermetica intellettualistica, asociale, borghese, ecc, l’arte più viva di questi trent’anni. Vorremmo dir loro che una tendenza dello spirito, per quanto generosa, non può generalizzarsi in una scala di valori assoluta e non può fondare un nuovo criterio di giudizio estetico se non a costo di isterilirsi e dare un suono falso ovunque tocchi.
La cultura, l’arte non saranno più condannate a stagnare sotto il soffocante manto di un despotismo paternalistico e nemmeno godere i tristi privilegi di un compiacimento statale;
noi sappiamo che i nostri spiriti e le nostre opere si arricchiranno attraverso nuove intelligenti polemiche, nuovi gruppi, nuove poetiche, che in viva e vigile dialettica alimenteranno il dichiararsi dei nostri problemi, delle nostre drammatiche esigenze.
Ma c’è chi pensa che l’epoca delle avanguardie sia morta, e l’artista si sia fatto uomo, in una solitudine che deve rompere e vincere con le sue sole forze, impegnato e responsabile per intero davanti l’opera. Domani in una Europa pacificata il nostro messaggio avrà le immagini e le farine di questa nuova maturità e naturalezza.
L’artista sarà libero di esprimere la sua pena e la sua gioia, la sua tragedia e la sua malinconia, di dannarsi l’anima a suo agio e di calarsi vivo, se così deve essere, nella fossa dei suoi amati o amari fantasmi; e con i modi, i mezzi, la cultura che gli son propri, cercare tra i mille aspetti incombenti, fermentanti della realtà e la sua fantasia, un nuovo intrepido equilibrio.
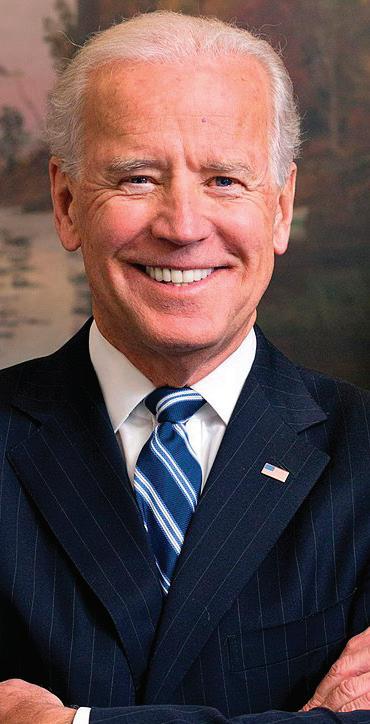
Nel riflettere sull’eredità della presidenza di Joe Biden mi sono resa conto di quanto importanti siano stati due elementi: il primo è che i tempi del suo mandato sono stati particolari e hanno presentato sfide eccezionali, fuori dalla norma; il secondo è che è difficile dare un giudizio obiettivo sulla sua legacy senza conoscere complessivamente gli obiettivi raggiunti, cosa che lo staff della comunicazione della sua presidenza e il partito democratico hanno completamente mancato di illustrare in modo esauriente e capillare ai cittadini e agli elettori.
E infine ho capito quanto su tutto ciò sia pesata la differenza tra la percezione e la realtà. Credo che la sua presidenza debba essere positivamente valutata adesso con il giusto metro di giudizio senza attendere il futuro come invece è avvenuto per i presidenti Jimmy Carter, scomparso recentemente, e Lyndon Johnson. E invece leggo in continuazione editoriali, in Europa e nel mondo, che raramente colgono le caratteristiche globali della sua presidenza. Cosi in
alcuni di essi si parla di totale fallimento della presidenza Biden a causa della sua politica estera, in altri del fatto che Biden è rimasto legato alla visione di un passato che ha cercato, fallendo, di riportare in auge, in altri ancora che non è riuscito a far rinascere una politica bipartisan e infine che non si è occupato a sufficienza dei problemi dell’emigrazione. Per fare un bilancio della sua eredità vanno tenuti presenti alcuni elementi fondamentali che possono aiutare a comprenderla nella sua totalità sia in politica interna che in politica estera. Soprattutto considerato il fatto che il partito democratico, diviso e litigioso, non è stato all’altezza della situazione e non ha saputo rispondere alle sfide che gli si presentavano e gli si presentano. Mentre il partito repubblicano, spostato totalmente su posizioni populiste ed estremamente conservatrici, ha raggiunto un’unità senza precedenti sulla figura di Donald Trump e ha saputo meglio rispondere alle sfide e alle paure del tempo recente.
Quattro sono stati i punti deboli della politica estera di Biden che gli hanno attirato critiche molto forti anche se la realtà è stata diversa dalla sua percezione. Molto criticati sono stati i suoi rapporti con la Cina con cui viceversa ha accettato di intessere rapporti di aperta competizione; ancora di più il suo ritiro dall’ Afghanistan nel quale sono successivamente tornati i Talebani. Qui però va ricordato che ben tre presidenti prima di lui (Bush, Obama e
Trump) avevano promesso la rinuncia a quella nefanda impresa di occupazione, ma solo Biden l’ha portata a termine. E infine ad attirare molte critiche sono state le due guerre recenti: quella in Ucraina nella quale ha tuttavia avuto il merito, seppure a prezzo di molte vite umane, di portare la maggior parte dei paesi europei a unirsi per contrastare le mire espansionistiche della Russia verso l’Europa e quella in Medioriente dove, a mio avviso, non ha usato la necessaria forza e autorità per impedire al macellaio Netanyahu di compiere il genocidio del popolo palestinese. Unico punto a favore di Biden al proposito è che ha sempre parlato della creazione di due stati, cosa che non sappiamo se sarà perseguita del suo successore.
In politica interna viceversa i suoi punti deboli sono stati tre, almeno nella percezione popolare: l’economia, l’inflazione e l’immigrazione. Dico percezione, perché la realtà è poi molto diversa in quanto l’economia sta volando con la disoccupazione che è ai minimi storici, l’inflazione sta diminuendo ormai da tempo e il problema dell’immigrazione, descritto dai suoi avversari come una vera propria invasione del paese a detrimento degli americani (forse questo gli ha nuociuto più degli altri per effetto dei numeri di ingressi nel paese degli irregolari) in realtà è stato almeno in parte contenuto e non è mai stato una vera e propria minaccia. E qui vorrei raccontare un’esperienza personale a proposito della percezione dei problemi diversa
dalla realtà. Una percezione di cui il partito democratico per primo non ha saputo tenere conto nella maniera dovuta e che, assieme a tanti altri segnali ignorati, gli hanno fatto perdere le elezioni. Quest’estate mi è capitato di andare in numerosi supermercati di Chicago e vicinities e mi sono accorta che molti dei dipendenti al pubblico non parlavano inglese bene a sufficienza e non erano in grado di dare informazioni di vario tipo ai clienti o non erano al corrente di prodotti che un americano medio usa da sempre, come il potato bread, per esempio. Certo questo esempio non è generalizzabile e la realtà in massima parte è diversa, ma a volte bastano pochi episodi come questi per creare una percezione generalizzata. Cosi dopo le elezioni mi è venuto da pensare a come un operaio o un contadino dopo avere lavorato tutto il giorno possa, in occasioni come queste, sentirsi un estraneo in casa propria e a come possa decidere di affidare il suo voto a qualcuno che gli promette di ridargli indietro qualcosa che sente appartenergli: Il suo paese.
La presidenza Biden tuttavia ha raggiunto obiettivi importanti ed è stata significativa sotto molti punti di vista. E per questo dovrà essere ricordata come momento epocale in tempi di transizione a cui si è cercato di rispondere mantenendo le regole basilari della democrazia e di un governo decente del bene comune.
Quando sopra accennavo ai tempi ecce-
zionali di questa presidenza mi riferivo ad esempio all’uscita dalla pandemia per merito di provvedimenti ad hoc di cui tuttavia si fa raramente menzione. E invece è stato un evento che ha rimesso in piedi l’economia. Ogni famiglia ad esempio si è trovata sul conto corrente dei liquidi erogati dal governo per uscire dall’emergenza e ricominciare. Ovviamente ci sono stati anche altri provvedimenti su larga scala che hanno infuso in maniera organica nell’economia una liquidità senza precedenti e hanno permesso la ripresa. Biden si è trovato ad affrontare un’inflazione galoppante, ma è riuscito a rimettere in piedi la struttura economica del paese a dispetto di certo sentire popolare che lo ha accusato di non averne risolto i problemi e lo ha punito votando Trump. Ha promosso un set storico di provvedimenti economico-amministrativi che rispondevano a sfide di una nuova era: da quelli sui cambiamenti climatici, a quelli sull’intelligenza artificiale, a quelli sulla de-industrializzazione e sulle disparità di classe, a quelli che hanno annullato il debito di molti studenti, a quelli sul monopolio tecnologico e infine a quelli derivanti dall’erosione delle norme democratiche. Biden ha inoltre varato un monumentale piano di ammodernamento infrastrutturale che non si vedeva dai tempi di Franklin Delano Roosevelt con quel Build Back Better che ha rinnovato il corredo dei trasporti del paese. Ha inoltre spinto per un’estensione delle assicurazioni sanitarie e ha abbassato il prezzo di
farmaci che nella quotidianità avevano prezzi non calmierati per il fatto di non essere passati dalle assicurazioni come nel caso di quelli per il diabete; ha varato inoltre provvedimenti economici a beneficio delle classi lavoratici e più svantaggiate. Infine non solo ha nominato la prima vicepresidente nera nella storia degli Stati Uniti, ma ha anche promosso molte donne in posizioni giuridicamente rilevanti a livello federale inclusa la prima donna nera Ketanji Brown Jackson alla Corte Suprema.
Certo la sua età lo ha fortemente penalizzato perché è stato percepito come vecchio e incapace di portare a termine gli obiettivi e i negoziati che la carica più stressante del mondo comporta. Tuttavia Biden ci avrebbe garantito una presidenza basata su principi democratici e su una razionalità improntata all’interesse comune dove le donne, i soggetti più deboli e le minoranze sono garantite. A livello di percezione non mi pare che la presidenza Trump sarà in grado di garantirci tutto ciò. Ma forse la realtà potrebbe sorprenderci. Ce lo auguriamo tutti anche se le aspettative sono minime, viste le recenti dichiarazioni e la composizione dello staff del neo presidente.
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi. it/2025/01/eredita-biden/

Di Ida Meneghello
Il Risorgimento. L’abbiamo studiato a scuola come fosse un favola popolata di eroi, dove i buoni eravamo noi che avevamo un grande ideale e i cattivi gli austriaci, i Borboni e il papa. Il Risorgimento ce lo ricordiamo così, come la stagione felice di un’Italia appena nata in cui tutto era ancora possibile, il meglio ma anche il peggio, un futuro abbagliante di promesse che non si sarebbero realizzate. E ovviamente gli eroi erano tutti giovani e belli, come cantava Guccini, a cominciare da Garibaldi con la barba e i capelli lunghi, un po’ Gesù e un po’ Buffalo Bill, con la camicia rossa e il poncho di Clint Eastwood.
Se c’è un’impresa che è la quintessenza di quella Storia fatta di eroi ancora a cavallo in tutte le piazze italiane e di gente senza nome che per quell’idea di Italia è morta sui campi di battaglia, quell’impresa non può che es-
sere la mitica spedizione dei Mille, quando il Nord scoprì il Sud.
C’è una parola italiana che contiene due significati distinti e non ha equivalente in nessun’altra lingua: l’abbaglio è una luce troppo intensa che toglie la vista (i fari abbaglianti), è il fascino e l’incantesimo (la bellezza che abbaglia), ma è anche l’inganno, l’equivoco, il fraintendimento (prendere un abbaglio). Il regista palermitano Roberto Andò ha scelto proprio questa parola per il suo nuovo film, e non ricordo un titolo più azzeccato di questo per sintetizzare una Storia che tutti abbiamo idealizzato, dimenticandoci che fu anche l’archetipo in cui l’illusione incrociò la disillusione.
L’abbaglio è un film ambizioso e complesso che suggerisce molte riflessioni sul passato e sul presente dell’Italia, più del precedente. La stranezza in cui Andò immaginava l’incontro tra Luigi Pirandello e una coppia di teatranti che avrebbe ispirato la messa in scena dei Sei personaggi in cerca d’autore. C’è un evidente collegamento tra le due pellicole: i tre attori protagonisti sono gli stessi, gli sceneggiatori sono gli stessi (Ugo Chiti e Massimo Gaudioso, oltre al regista) e anche ne L’abbaglio la finzione di due personaggi inventati (impersonati da Salvo Ficarra e Valentino Picone) spariglia le carte della Storia (rappresentata da Toni Servillo) attraverso il registro del comico e del grottesco.
La spedizione dei Mille, dunque. Ricostruita con grande suggestione dalla
fotografia di Maurizio Calvesi e dalle scene di massa con adeguati effetti speciali, viene rappresentata dalla notte del 5 maggio 1860 (imbarco dei volontari a Quarto, Genova) allo sbarco a Marsala (11 maggio) e poi attraverso le battaglie combattute dai garibaldini contro l’esercito borbonico, fino all’insurrezione di Palermo e all’ingresso di Garibaldi in nome del re Vittorio Emanuele II. Protagonista reale di questa storia è il colonnello Vincenzo Giordano Orsini impersonato da Toni Servillo, nobile siciliano e patriota, tra i più stretti collaboratori di Garibaldi insieme a Nino Bixio nonché reclutatore dei volontari. È così che la Storia incrocia la fiction: Ficarra è il contadino Domenico Tricò e Picone diventa il giocatore e baro Rosario Spitale, due siciliani arruffoni più interessati a cogliere l’occasione di un imbarco per tornare a casa che a combattere per un’Italia di cui non sanno niente.
Infatti, sbarcati a Marsala, i due diventeranno subito disertori e le loro avventure picaresche si incroceranno con la spedizione dei Mille sui campi di battaglia. «Orsini è il personaggio storico, un aristocratico mazziniano che combatte contro la sua classe in nome della libertà. I due personaggi inventati rappresentano la vita, hanno il cinismo dei siciliani, pensano che niente potrà mai cambiare, ma si ritrovano dentro la grande Storia e fanno la loro parte», ha spiegato il regista presentando il film in anteprima al cinema Modernissimo di Bologna. «Il film è in fondo la storia
dell’incontro tra un illuso e due disillusi». Vent’anni dopo, nella Palermo del 1880, le giornate di maggio sono un ricordo lontano e i tre protagonisti si ritrovano in un contesto che è già cambiato e che fa dire al colonnello Orsini: «Stiamo andando incontro a un’epoca in cui a fare opinione saranno gli imbonitori». «Il finale amaro, l’abbaglio appunto, non è un giudizio sull’Italia di oggi», sottolinea Andò, «anche se vedo un paese troppo spesso furbastro che non crede più alla sua grandezza. Se c’è un riferimento al presente, è il pensiero che quella spedizione riunì ragazzi da tutta Italia decisi a trasformare un ideale in azione. I ragazzi di oggi ci credono ancora?».
L’abbaglio non ha solo il titolo perfetto, perfetti sono anche i tre protagonisti collaudati ne La stranezza e che in questo film si superano in bravura. Ma eccellente è tutto il cast, da Tommaso Ragno nel poncho di Garibaldi alla figlia del regista, Giulia, che incarna Assuntina, una suora di non difficili costumi, fino a due attrici che hanno attraversato la storia del teatro e del cinema italiano: Aurora Quattrocchi e Giulia Lazzarini (la rivedo che volteggia appesa a un cavo d’acciaio, era Ariel ne La Tempesta di Strehler, Milano 1978).
Infine i tributi cinematografici che impreziosiscono la pellicola. Con Ficarra e Picone Andò evoca certamente i due antieroi Oreste Jacovacci e Giovanni Busacca de La Grande Guerra di Mario
Monicelli, in fondo anche in quel film c’era la stessa amarezza della disillusione. La scena delle vedove che piangono i loro morti è un omaggio al suo maestro Francesco Rosi (nel film Salvatore Giuliano). E la Sicilia dei Borboni è una terra di frontiera che fa dire al regista: «Questo film è in fondo il mio western alla Sergio Leone».
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi. it/2025/01/risorgimento-western/

Volo, fosse solo per dare una sbirciatina, almeno a eventuali illustrazioni.
Di Giuliano Capecelatro
Un mio nipotino… nipotino, insomma, si fa per dire; un cristone di un metro e novantuno centimetri, nuotatore provetto, portiere tanto temerario da spaventare i suoi stessi compagni di squadra, consumatore indefesso di birrette, che si porta appresso con indolenza, tenendole per il collo della bottiglia che indolentemente dondola, come indolentemente porta alla bocca per un sorso di tanto in tanto… per farla breve, questo mio nipotino prossimo alla maggiore età ha preso un “impreparato” in matematica, e scatenato così un minidramma familiare. Motivo: non aveva portato il compito da casa.
Orgoglioso e tenace, si è subito rifatto. E la pace è tornata in famiglia. Un otto e mezzo in Storia. E, meglio ancora, a distanza di poche ore, un nove e mezzo in Lingua e letteratura italiana. Risultato che mi ha lasciato a bocca aperta: tra vasche coperte a rana, parate spericolate, e infusioni di birrette, non gli ho mai visto sfogliare un libro, non dico Manzoni o Nievo, archeologia per la generazione Z o Centennials che dir si voglia, ma almeno Camilleri o, tiè, persino Fabio
Il punto, comunque, non sono i risultati scolastici. Neppure la restaurata pax domestica. E tanto meno la palese avversione a compulsare testi che non siano quelli strettamente legati allo studio. Il dato interessante, su cui riflettere davvero, è che successi e insuccessi sono stati comunicati in tempo reale, via whatsapp, all’autorità genitoriale. La mamma, presa da comprensibile batticuore, mentre riordinava le carte nel suo studio. Il papà o facente funzione, colto da comprensibile disappunto, mentre metteva mano a un’importante relazione.
In parole povere, succede che l’esplosione dei social, o come altro si vogliano definire i trabiccoli digitali che ci tengono in costante collegamento, con il mito conseguente della comunicazione istantanea, ha creato anche, in tanto bendidio, il pervasivo canale di informazione Tutta la scuola minuto per minuto.
Istituzione scolastica e istituzione parentale sono ormai connesse ventiquattrore su ventiquattro. Il frugoletto non risulta presente alle lezioni? Subito parte l’avviso: che i genitori sappiano, rassicurino l’allarmato corpo docenti o, in caso di arbitraria defezione dell’allievo, preparino il rampollo fedifrago a severi provvedimenti su tutte e due le sponde.
Un incubo. Per un uomo che ha vissuto altre stagioni, altre atmosfere, convinto inoltre di detenere il record mondiale ufficioso di assenze ingiustificate, la peggiore delle distopie. E mi chiedo: ma ‘sto povero ragazzo, con tutti gli occhi addosso, se una mattina gli saltasse l’uzzolo di scantonare – è umano –, deviare dal retto cammino che lo conduce senza deviazioni da casa in aula, per fare quattro passi tra le bellezze della città, andare in una sala giochi o rifugiarsi in un parco con una ragazzetta, cosa dovrebbe fare? Insomma, per dirla con tutti i crismi del perbenismo, se volesse marinare la scuola e farsi un po’ di affari suoi, a quale santo dovrebbe rivolgersi?
Oh, parliamo di un’attività che ha una solida e ramificata tradizione. Va avanti da secoli. In tutti gli angoli del pianeta. Quindi corrisponde a qualcosa che quell’uomo in fieri che è lo scolaro considera come irrinunciabile prerogativa del suo stato. Ha anche una sua dignità culturale. Per dire: la storia di Pinocchio, celebrata in tutto il modo, comincia proprio così. Lui e Lucignolo marinano la scuola.
Certo, il vivace burattino, da buon borghese in pectore, si concede al finale edificante e rientra nei ranghi. Ma il primo impulso, quello istintivo, naturale, era stato quello di cacciare la scuola dal suo orizzonte.
Così diffuso, questo vizietto, da generare un albero lessicale con radici in ogni
regione e paese. Termine obsoleto, nella sua commovente patina ottocentesca, forse il primo a entrare in circolo, è bigiare, di impronta settentrionale e sospette ascendenze germaniche. Poi l’asettico marinare, appunto.
Più icastica Roma con fare sega, mentre Napoli sbandiera fare filone, ripreso in buona parte del meridione. Il catalogo è ampio. Dal fare forca fiorentino all’inquietante impiccare di Bergamo. I più ricchi di inventiva risultano i siciliani, che a Gela parlano di caliarsi la scuola, a Trapani usano stampare, e a Mazara del Vallo preferiscono fare icilia, va’ a capire perché.
Pratica senza frontiere. Dalla Francia (l’école buissonière, di sicuro protocollare ed estraneo al più tagliente e beffardo argot dei minorenni) al Giappone (saboru, anche questo in odore di ufficialità) ogni nazione ha la sua formula più o meno pittoresca.
Questo controllo capillare di ogni movimento dell’alunno sembrerebbe, dunque, aver messo fine ad un’epoca. Ma dal maremagno di Internet affiorano birichini suggerimenti, peraltro vecchi come Matusalemme, per bigiare, marinare, salare e saltare la scuola: accusare febbri, malesseri, lancinanti mal di pancia. Robetta, palliativi che non hanno l’aura dell’avventura di una decisione scaturita dalla libera iniziativa dell’individuo. Un umiliante, ipocrita compromesso con le soffocanti istituzioni
(come dire, a bocca storta: «andrei tanto volentieri a scuola, se non mi bloccasse a letto questo malanno»).
Ma così l’adolescente, cioè quel campione umano che sta procedendo verso l’adultità (vocabolo da brividi, ma che l’Accademia della Crusca registra e tollera) verso la forma uomo fatta e finita, viene scippato della possibilità di temprare, affinare, modulare al meglio la propria personalità con una precisa assunzione di responsabilità.
Giuro, non lo dico per esaltare a posteriori la personale scioperataggine degli anni scolastici. Ma ragioniamo: sottoposto a controllo incessante, il garzoncello scherzoso si ritrova ad essere passivamente soggetto ai diktat di due autorità conniventi, senza che possa effettuare una scelta davvero cosciente. Ubbidisce perché non ha alternativa. Un embrione di robot, a dirla tutta.
La disubbidienza, invece, è un atto di grande valore, una maestra fondamentale. Ti abitua a quel continuo esercizio di scelte che è la vita, che non puoi eludere. Hic Rhodus, hic salta: impari a calcolare il rischio, le implicazioni, le conseguenze del tuo gesto.
Pensate se tutti i soldati del mondo, per una divina ispirazione, facessero le fiche ai loro superiori avidi di scontri sanguinosi e inebrianti momenti di gloria («darei un braccio per un quarto d’ora di battaglia», mi confidò un tempo un
capitano, con il mio tacito augurio di procurarsi anche un paio d’ore). Che fine farebbero le guerre e i ben pasciuti mercanti d’armi?
Lo so, detto da un vecchio gaglioffo, in perenne conflitto con ogni forma istituzionale ed ogni parvenza di autorità, questa apologia della disubbidienza ha poco senso, è fasulla.
Allora cerchiamo l’etichetta con il marchio doc, il pensiero di chi gode di stima universale. Erich Fromm, per esempio, psicologo e psicanalista di fama, che alla disubbidienza ha dedicato un saggio (in Italia pubblicato da Mondadori). Scrive il nostro: «La disobbedienza, nel senso in cui si usa il termine, è un atto di affermazione della ragione e della volontà». E più avanti: «Per disobbedire non è necessario che l’uomo sia aggressivo o ribelle: basta che abbia gli occhi aperti, che sia sveglio».
Che sono appunto quelle facoltà che l’invadenza ossessiva e totalizzante dei social, da whatsapp a facebook e android passando per l’orrido X, cortile virtuale di furibonde liti tra comari, tendono ad amputare. La disubbidienza può, di conseguenza, diventare un momento importante.
Se lo psicanalista non vi convince, proviamo a vedere che ne pensava un fine scrittore come Italo Calvino, che, un po’ calvinisticamente, la giustificava «solo quando diventa una disciplina morale più rigorosa e ardua di quella a
cui ci si ribella».
Ora, ragazzi, potete avere in uggia Fromm, troppo sessantottino, potete anche far spallucce al rigore morale di Calvino, ma non commettete l’errore di sottovalutare la potenza di fuoco dei social. Soprattutto, non crediate mai alla loro innocenza di semplici go-between, candidi propalatori di messaggi altrui. Tutto sono, tranne che innocenti.
Senza voler aderire a qualsivoglia tesi complottista, il loro peccato originale è l’ansia di controllo del nostro mondo. E i social sono il perfetto cavallo di Troia della sorveglianza ubiqua, della raccolta puntigliosa, onnicomprensiva di informazioni sulle nostre insignificanti esistenze.
Non sarà un caso che il loro sviluppo avvenga all’interno degli apparati militari. Sarà forse un caso che Facebook abbia visto la luce il 4 febbraio 2004, sulle ceneri di un progetto di raccolta dati planetario partorito e svezzato dal Pentagono?
Torniamo a noi. Che devo fare col mio nipotino extrasize e birrettaro? Lasciarlo alla mercè della Santa alleanza scuola-genitori o mormorargli inverecondamente all’orecchio: «Non dare retta a mammà e al preside. Se non te la senti di andare a scuola, domani fai sega»? Che atroce dilemma morale.
Da Succedeoggi: https://www.succedeoggi.it/2025/01/ apologia-della-disubbidienza/
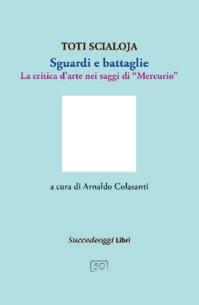
A cura di Arnaldo Colasanti. Note di Onofrio Nunzolese
«Chi di noi è più convinto della necessità di realismo nell’arte? Dopo il purificante bagno nell’etere idealistico torniamo a sentire stringenti e dolenti le relazioni tra l’arte e la natura, fra la figurazione formale e la realtà empirica e storica».
Toti Scialoja
Prima di essere uno dei maestri indiscussi della pittura astratta italiana del Secondo Novecento, prima di essere autore di raffinati giochi e incastri poetici di grande spessore espressivo e sperimentale, Toti Scialoja è stato un importante critico d’arte. In questa veste, negli anni che seguirono la Liberazione di Roma (giugno 1944), partecipò all’avventura editoriale di Mercurio, il «mensile di politica, arte e scienza» fondato da Alba de Cespedes che, fino alla sua chiusura avventura nel 1948, rappresentò la palestra della grande ricerca culturale antifascista non marxista del tempo.
Su Mercurio, il giovane Toti Scialoja, già apprez-
zato pittore di scuola espressionista, recensisce mostre, scopre talenti, ricorda i maestri scomparsi: le sue pagine scritte per quella gloriosa rivista sono quasi il romanzo di formazione di una generazione, quella degli artisti che volevano lasciarsi alle spalle le avanguardie picassiane per andare incontro a un nuovo lirismo astrattismo.
Il volume è arricchito dalla prefazione del curatore Arnaldo Colasanti (presidente della Fondazione Toti Scialoja) che inquadra gli scritti nell’ambito del tumultuoso dibattito artistico e politico del dopoguerra, quando la cultura italiana dialogava alla pari con il resto dell’Occidente.
Toti Scialoja (1914-1998) è stato uno dei protagonisti della pittura europea del secondo Novecento. Maestro riconosciuto dell’astrattismo, è stato anche apprezzato autore di numerosi libri di poesia giocosa e grande appassionato di teatro.
Da Succedeoggi Libri Pagine 180, 20 Euro
ISBN 9788899467265
In libreria dal 23 ottobre



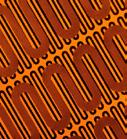
Siamo presenti con le nostre soluzioni in oltre 100 programmi spaziali internazionali ed equipaggiamo oltre 500 satelliti in tutto il mondo.
Sviluppiamo sistemi affidabili, flessibili e di elevata qualità per il controllo termico dei satelliti, basati sulla nostra tecnologia foglio flessibile, per compensare variazioni di temperatura o riscaldare specifiche parti ed assicurarne così il corretto funzionamento, anche nelle condizioni più estreme.
Vi aspettiamo a Space Meetings Veneto, la conferenza internazionale dedicata all’industria aerospaziale, dal 20 al 22 maggio 2025. Anche quest’anno sarà un’occasione per incontrare aziende, startup, studenti e speaker provenienti da oltre 15 Paesi nel Mondo. Non mancate!