Il Nucleare: in attesa della fusione le risposte possibili ai cambiamenti climatici

Space Meetings
Veneto raddoppia: focus su Spazio e Sport



Il Nucleare: in attesa della fusione le risposte possibili ai cambiamenti climatici

Space Meetings
Veneto raddoppia: focus su Spazio e Sport


Il 90% dell’universo è costituito da energia. Energia oscura. Ovvero sappiamo che c’è altrimenti non spiegheremmo l’espansione dell’universo stesso, ma non sappiamo come è fatta. Una fonte di energia può essere infatti prodotta in diversi modi. Abbiamo solo l’equazione di Einstein per interpretare l’energia dell’universo: E=mc². O meglio, per interpretare ogni forma di energia esistente, in un costante ed equilibrato rapporto tra massa ed energia. Prendendo quindi spunto dalla teoria relativistica di Albert Einstein, si può affermare che ciò che non manca nell’universo, nel nostro universo, è proprio l’energia. E però, al contempo, è anche la risorsa più ricercata e ambita dal genere umano, fin dai suoi primordi.
Il problema è che non abbiamo, ancora, la capacità di crearla, sufficientemente per le nostre ambizioni, senza nuocerci.
Abbiamo scelto, nella nostra evoluzione, le forme più semplici per produrre energia, spesso solo per affermare la volontà comune ma, sovente, anche singola, di affermarci, in un meccanismo evolutivo estremamente competitivo in cui accanto al benessere abbiamo messo l’apparire. Ricordate il film di Kevin Costner Rapa Nui? Ebbene sì, una storia d’amore che ha sullo sfondo l’autodistruzione del popolo dell’Isola di Pasqua, antesignano dei nostri tempi, che fece terra bruciata, letteralmente parlando, della propria terra, attivando un processo di cambiamento climatico che li portò all’estinzione. Più in grande è quanto stiamo facendo con la foresta amazzonica e contestualmente con la produzione di energia da componenti fossili, ai quali siamo ancora indissolubilmente legati anche per alimentare il nuovo parco elettrico dell’automotive. Tema che ha portato grandi aziende automobilistiche a ritornare sull’alimentazione all’idrogeno.
E in effetti questo è l’ipotetico futuro. L’idrogeno. In particolare la sua funzione nella fusione nucleare, quella che permette al Sole di brillare ed emettere energia per miliardi di anni, l’elemento più diffuso nell’universo.
Ma l’obiettivo è ancora lontano, mentre i problemi derivanti dal cambiamento sono già presenti. Oggi produciamo energia da fonti alternative molto maggiore che nel passato, con un incremento importante. Ma non è sufficiente. E anche l’iniezione di energia da fissione nucleare sembra non dare abbastanza respiro perché si possa invertire il processo.
Siamo in un Cul de Sac?
03
L’editoriale
06
Tutti parlano di nucleare, nessuno ha i soldi per fare le centrali
- Di Roberto Giovannini per Huffington Post
09
ITER, fusione nucleare con obiettivo il futuro
11
L’energia nel mondo
16
Ariane 6: la, scarsa, risposta dell’Europa a Elon Musk
- Di Joshua Posaner per Politico.eu
21
Il bis del Veneto vale doppio di Anilkumar Dave
- Seconda edizione degli Space Meetings Veneto
25
Venetostars: idee dall’Europa per il Veneto
Dallo Spazio allo Sport alla Moda, è un attimo
26
Quanto vale la Space Economy? 34
Non me la bevo
- il saggio di Michele A. Fino 40
Vini per l’estate 43
Rosa non rosato
46
Vino da bere, meglio se sardo
- colloquio con Maurizio Valeriani
46
Il coraggio di essere unici 48
La demopraxia de la t3rza terra
- dialogo con Michelangelo Pistoletto 51
Cleopatra e il serpente di Nicola Fano
- estratto del libro di Trotula de’ Ruggero
54
Succedeoggi Libri
58
Lo Spazio si dà una nuova legge 27
La storia siamo noi
Direttore responsabile
Giulia Bonelli giulia.bonelli@associazioneartemis.com
Hanno collaborato a questo numero
Fabrizio Beria
Anilkumar Dave
Francesco Rea
Nicola Fano
Roberto Giovannini
Progetto grafico
Davide Coero Borga
Realizzazione grafica
Maria Carlotta Spina
Web editor
Fabrizio Beria
Concessionaria pubblicitaria
Pinar Marketing & Comunicazione
Contatti
Via Sommacampagna 51 · 37137 Verona redazione@associazioneartemis.com marketing@associazioneartemis.com www.artemiscienza.news
Editore
Associazione Artemis www.associazioneartemis.com
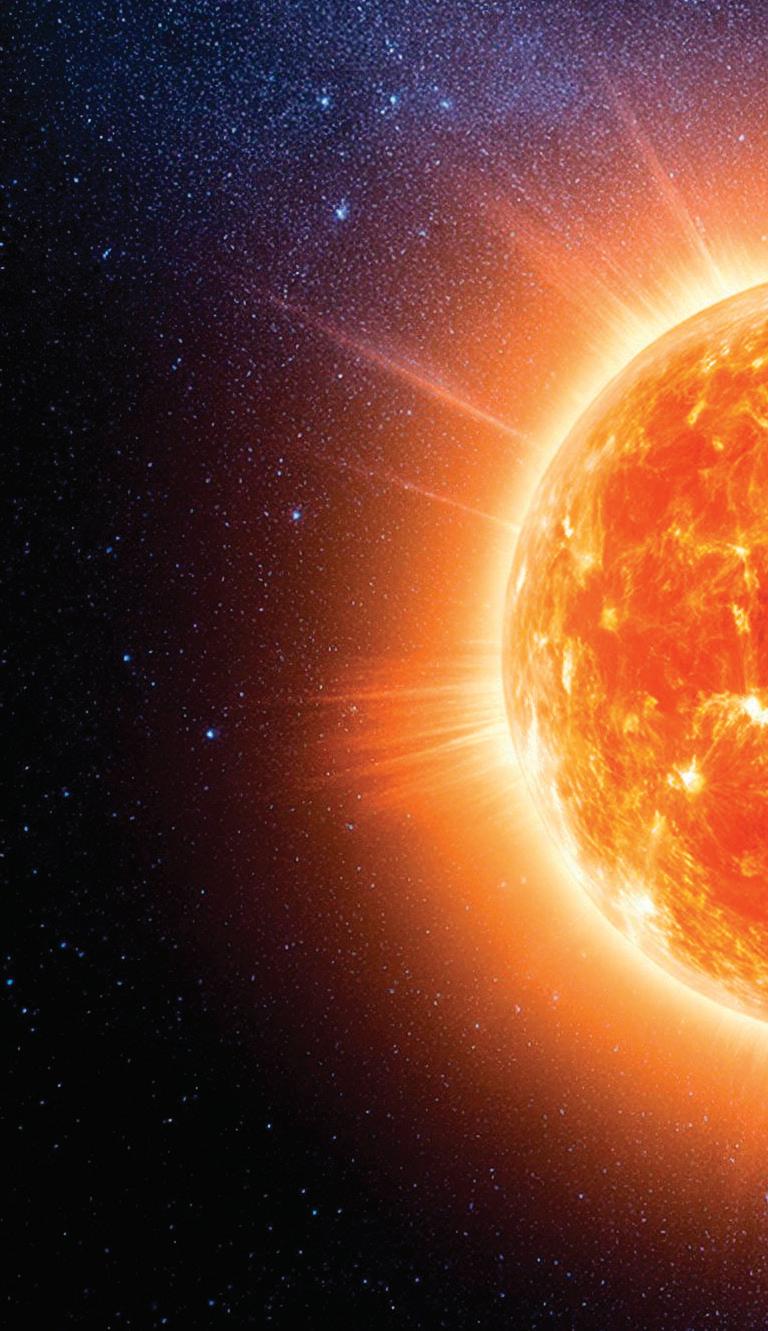
Crediti immagini
Esa, Nasa, Pexels, Vaticano, Adobe Firefly, Wikimedia Commons

Di seguito vi proponiamo un articolo apparso du Huffington Post, per gentile concessione della testata e del suo autore
di Roberto Giovannini
Per costruire una centrale bisogna spendere almeno 15 miliardi, senza considerare ritardi ed extra-costi. E gli Stati europeisoprattutto Italia e Francia - non hanno i conti in ordine per reggere questi progetti.
Il comunicato del G7 parla di energia nucleare, come ne aveva parlato apertamente il comunicato del G7 di un mese or sono. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel suo discorso televisi-
vo in cui ha annunciato lo scioglimento del Parlamento, ha anche annunciato la costruzione di ben otto nuove centrali atomiche. Anche la Commissione Europea ha inserito il nucleare tra le fonti energetiche pulite, l’Italia le inserirà nei suoi Piani energetici nazionali, e il ministro Pichetto Fratin non si stanca di ripetere che quanto prima il Belpaese sarà costellato di piccoli reattori modulari che permetteranno alle industrie energivore di autoprodursi la loro elettricità e il loro calore a partire dall’atomo. Lo stesso presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha pochi dubbi: “Il mix energetico di oggi non basta. Le
fonti rinnovabili sono suscettibili al vento e al sole e noi abbiamo bisogno di produzioni continue e l’unica via è il nucleare”.
Tutto splendido. Ma perché allora gran parte degli addetti ai lavori ritiene che di tutto questo profluvio di parole non molto si tramuterà in fatti, almeno in Europa? La “colpa” è della congiuntura economica, che sta strangolando i bilanci pubblici dei paesi europei più interessati a ricorrere all’energia nucleare. Per costruire una centrale nucleare di quelle grosse, tecnologia EPR, l’unica ad oggi effettivamente disponibile - a parte i rischi di scavalcamento dei tempi, certificato dai casi degli impianti di Flamanville in Francia e di Olkiluoto in Finlandia - ci vogliono un sacco di soldi, dai 12 ai 15 miliardi di euro. Soldi che nessun operatore privato sarebbe mai disposto a mettere, e che hanno bisogno di un cospicuo intervento dello Stato. Stati che però, sia per quanto riguarda l’Italia (e noi lo sappiamo dal 1992) che per quanto riguarda la Francia (che ha raggiunto un indebitamento di addirittura il 110 per cento del Pil) sono letteralmente alla canna del gas.
Facciamo un passo indietro. Come accennato, nello (sterminato, e inevitabilmente verboso e un po’ generico) comunicato finale del G7 pugliese i Sette Grandi parlano di nucleare, e anche a lungo. Il primo riferimento riguarda i paesi “che decidono di utilizzare l’energia nucleare, o supportano il suo uso” (una dicitura che riconosce che altri paesi,
come la Germania, non la vogliono più usare), che naturalmente ne riconoscono il potenziale come fonte di energia a zero emissioni. In questo campo il Comunicato parla del rafforzamento della filiera del nucleare e della sua sicurezza, e afferma l’intenzione di promuovere la ricerca “in settore tecnologici innovativi per reattori avanzati e i piccoli reattori modulari (SMR), compresi i micoreattori”. Sullo sfondo - ma sappiamo che ci vorranno molti molti anni prima di ottenere soluzioni - c’è la tecnologia dell’energia da fusione, su cui si vuole promuovere la ricerca anche istituendo un “G7 Working Group on Fusion Energy”, che terrà la sua assise ministeriale inaugurale proprio a Roma, sotto l’egida della IAEA (International Atomic Energy Agency).
Insomma, niente di particolarmente nuovo o di efficace in generale sul clima e l’energia. Sono praticamente le esatte identiche parole utilizzate nel comunicato finale del G7 Ambiente di fine aprile a Venaria, presso Torino. In quella sede, o subito dopo, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin aveva anticipato che nel prossimo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec), che entro giugno sarà inviato in versione definitiva a Bruxelles, ci sarà anche una “analisi di scenario contenente una possibile quota di energia prodotta da fonte nucleare nel periodo 2030-2050”. L’obiettivo del governo sarebbe teoricamente quello di ottenere dal nucleare circa il 20%
del mix energetico elettrico del Paese. Pichetto ipotizza in Italia almeno 15 mini-reattori di tipo SMR, utilizzati soprattutto dalle imprese energivore, quelle più in difficoltà per i costi elevati dell’energia. Ma a fare bene i conti il 20% dell’elettricità da nucleare vorrebbe dire la bellezza di 310 TW, e di centraline atomiche SMR ce ne vorrebbero ad occhio (a secondo delle dimensioni) da 100 a 400.
Gli SMR, reattori di dimensioni fino a 300 MW elettrici, che dovrebbero essere prodotti in modo industriale (modulare) per ridurne il costo, ancora non esistono, se non a livello sperimentale. E si sa che gli ambientalisti sono molto scettici sulle possibilità effettive di svilupparli in tempi brevi (ovvero prima che la crisi climatica esploda). Secondo uno studio recente dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), un think tank energetico statunitense, i loro costi lievitano e i ritardi nei tempi di realizzazione si accumulano come per le vecchie centrali nucleari. Lo studio, che ha analizzato tutti i progetti di SMR in cantiere, fa notare che sono solo 4 gli SMR operativi o in costruzione oggi in tutto il mondo (2 in Russia e 1 in Cina gli operativi, 1 in costruzione in Argentina), a fronte di circa 80 diversi concetti di piccoli reattori modulari a diverse fasi di maturità. Rispetto alle previsioni di costo, i reattori russi e cinesi hanno registrato un aumento del 300%, quello argentino del 600% nel 2021. Quelli su cui sta lavorando l’americana NuScale

sono già raddoppiati. Quanto ai tempi, anch’essi si stanno dilatando progressivamente. Naturalmente ancora più distante e lontana nel tempo è la fusione nucleare, anche se Eni (o meglio, la CFS, un’azienda di cui Eni è azionista strategico) ha ipotizzato un’improbabile realizzazione della prima centrale elettrica a fusione su scala industriale in grado di immettere in rete elettricità entro i primi anni del 2030.
Non è dunque un caso che la tecnologia nucleare tuttora più credibile (nonostante tutte le difficoltà) sia quella più tradizionale, ad esempio quella di cosiddetti EPR2, su cui protagonista è la Francia. Già nel febbraio 2022 il presidente Macron aveva avviato un programma di revamping delle vecchie centrali atomiche costruite negli anni ’60 e ’70, ma anche la costruzione di sei grandi centrali nucleari del tipo EPR-2 che sarebbero state operative nel 20352037. Nel corso della drammatica allocuzione televisiva della sera delle elezioni europee, Macron ha annunciato di voler aggiungerne 8 al programma, che passa dunque a ben 14 nuovi impianti. Addirittura nel programma elettorale del partito RN di Marine Le Pen c’è scritto che di centrali atomiche ne saranno costruite 20, e che la loro produzione servirà per cancellare progettati campi eolici e fotovoltaici.
Obiettivi forse spericolati, visto che la centrale di Flamanville, in Normandia, una “bestia” da 1600 MW, doveva esse-
re realizzata in 5 anni e ce ne ha messi addirittura 17. Un vero e proprio calvario progettuale, che ha visto i costi decollare dai preventivati 3,5 miliardi di euro agli effettivi 19,1 miliardi di euro. A metà maggio la centrale ha avuto finalmente il via libera per la carica del combustibile atomico nel reattore, 60mila finissimi tubi lunghi 5 metri pieni di pastiglie di uranio. Dovrebbe a fine giugno raggiungere una potenza pari al 25% di quella massima, quanto basta per generare elettricità e immetterla in rete, ma dopo tanti infortuni e ritardi i responsabili trattengono il respiro. E in più già si sa che a fine 2025 il reattore dovrà essere fermato per rimpiazzare il coperchio del vessel, che si sa da anni avere un’anomalia che ne imporrà la sostituzione nel 2026. La storia non è stata molto diversa anche in Finlandia, con il reattore nucleare OL3 della centrale finlandese di Olkiluoto entrato in funzione alla fine del 2021 dodici anni dopo rispetto alla tabella di marcia, e con costi triplicati. Proprio nei giorni scorsi nello stato USA della Georgia è stata inaugurata la prima centrale nucleare di nuova costruzione negli States negli ultimi 30 anni. Qui di anni in più per finirla ne hanno impiegato soltanto sette, e i costi sono passati da 14 miliardi di dollari a oltre 35. Solo in Cina e in Corea del Sud i progetti rispettano tempi e budget.
Insomma, i ritardi e gli extrabudget hanno fatto saltare la società nucleare francese Areva, che lo Stato ha dovuto
nazionalizzare per salvarla. Ma a 15 miliardi di euro a centrale, il banco non può certo reggere. Come scritto su questo giornale, Emmanuel Macron manda al voto un Paese con i conti sottosopra: deficit fuorigiri (nel 2023 il rapporto deficit/Pil è salito al 5,5%) e senza una data di rientro credibile, debito pubblico in salita e già superiore al 110% del Pil, lo spread che sale, un merito creditizio sovrano che ne sconta le ovvie conseguenze (una settimana prima del voto europeo, S&P ha tagliato il rating della Francia a ‘AA-’ da ‘AA’) e a giugno probabilmente l’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Se poi vincesse la Le Pen, la promessa riduzione dell’Iva sugli idrocarburi dal 20% al 5,5%, da sola costerebbe dieci miliardi di euro l’anno. O peggio, se non uscisse una maggioranza chiara sarebbe il marasma.
E per l’Italia, che pure il governo ce l’ha, la situazione non è certo migliore: con le nuove dure regole del Patto di Stabilità e Crescita la procedura d’infrazione ce la beccheremo anche noi.
In compenso, noi in tanti anni non siamo mai riusciti a trovare il post per realizzare un sito per un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. L’autocandidatura di Trino Vercellese aveva fatto sperare, ma la marcia indietro del Comune ha raggelato gli entusiasmi di chi spera in un nuovo nucleare italiano.
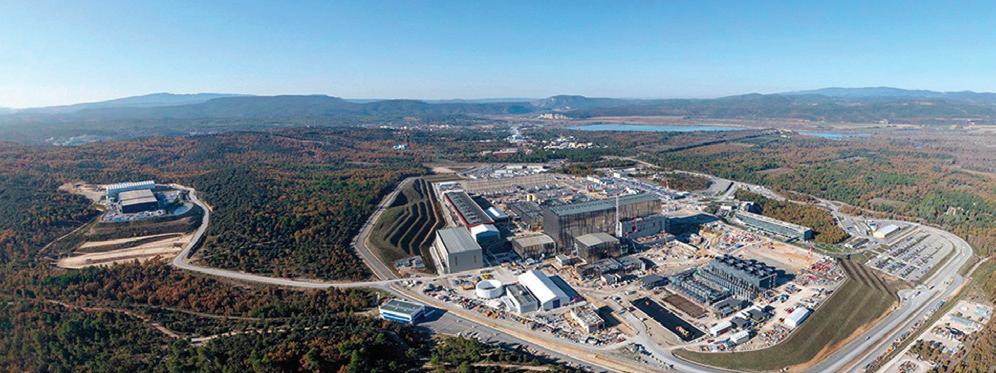
l progetto internazionale con sede in Francia e a guida italiana
Dopo due decenni di progettazione, produzione, fabbricazione e assemblaggio in tre continenti, lo storico progetto multinazionale per la fusione nucleare ITER ha celebrato il 1 luglio il completamento e la consegna delle sue bobine di campo toroidale, il più complesso dei sistemi ITER, provenienti da Giappone ed Europa. Ogni bobina è enorme: è alta 17 metri, larga 9 metri e pesa circa 360 tonnellate. Le bobine del campo toroidale funzioneranno insieme, di fatto, come un unico magnete: il magnete più potente mai realizzato. Genereranno un’energia magnetica totale di 41 gigajoule. Il campo magnetico di ITER sarà circa 250.000 volte più forte di quello della Terra.
Diciannove gigantesche bobine di campo toroidale sono state portate nel sud della Francia. Saranno componenti chiave di ITER, il mega-progetto sperimentale di fusione che utilizzerà il confinamento magnetico per realizzare la fusione nucleare, lo stesso processo che alimenta il Sole e le stelle e fornisce luce e calore alla Terra. La ricerca sulla fusione mira a sviluppare una fonte di energia sicura, pressoché inesauribile e rispettosa dell’ambiente.
ITER è una collaborazione di oltre 30 paesi partner. Unione Europea, Cina, India, Giappone, Corea, Russia e Stati
Uniti vi sono coinvolti. Le bobine di campo toroidale a forma di D saranno posizionate attorno al recipiente a vuoto dell’ITER, una camera a forma di ciambella chiamata tokamak. Qui nuclei atomici leggeri saranno fusi insieme per formarne di più pesanti, liberando un’enorme energia dalla reazione di fusione.
Un plasma dieci volte più caldo del Sole
Il combustibile per questa reazione di fusione sono due forme di idrogeno, deuterio e trizio (DT). Questo carburante verrà iniettato sotto forma di gas nel tokamak. Facendo passare una corrente elettrica attraverso il gas, questo diventa un plasma ionizzato - il quarto stato della materia, una nuvola di nuclei ed elettroni. Il plasma verrà riscaldato a 150 milioni di gradi, 10 volte più caldo del nucleo del Sole. A questa temperatura, la velocità dei nuclei atomici leggeri è sufficientemente elevata da consentire loro di scontrarsi e fondersi.
Per dare forma, confinare e controllare questo plasma estremamente caldo, il tokamak ITER deve generare una gabbia magnetica invisibile, conformata con precisione alla forma del recipiente metallico a vuoto. E qui entrano in gioco le bobine. ITER utilizza niobio-stagno e niobio-titanio come materiale per le sue bobine giganti. Dieci bobine sono state prodotte in Europa, sotto gli auspici dell’Agenzia nazionale europea dell’ITER, Fusion for Energy
(F4E). Otto bobine più una di scorta sono state prodotte in Giappone, sotto la guida di ITER Japan, parte dei National Institutes for Quantum Science and Technology (QST).
ITER inizierà a funzionare scientificamente nel 2034 e sarà in grado di lavorare su plasmi di deuterio-deuterio, con la piena energia magnetica nel 2036 - un ritardo di appena tre anni rispetto al piano originale. Il funzionamento con il combustibile di fusione deuterio-trizio è, invece, previsto per il 2039.
Il progetto, guidato da un italiano, Pietro Barbaraschi, ha diversi soggetti coinvolti, ovvero un consorzio internazionale di sette partner: Unione Europea, Cina, India, Giappone, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti d’America. L’investimento finanziario è di quasi 20 miliardi di euro in vent’anni.
La fusione nucleare rappresenta la principale scommessa sul futuro energetico del pianeta Terra, intendendo preservare il pianeta stesso ma soprattutto la sopravvivenza umana. È tale la sua importanza che tra gli investitori privati vi sono miliardari come Gates, Bezos e Soros e industrie nel campo energetico come ENI.



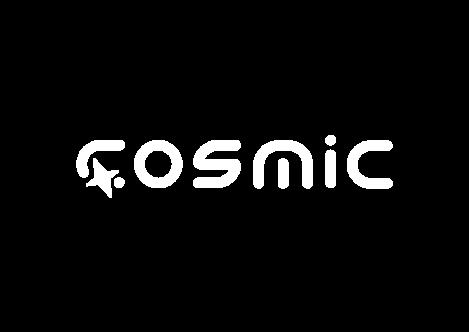

Il ruolo maggiore nella produzione di energia elettrica mondiale, nel periodo 1965-2023, lo gioca il carbone, che in termini assoluti per molti anni è stata la fonte che è cresciuta maggiormente. La situazione è cambiata a partire dalla crisi economica globale del 2008-9, dopo la quale si assiste ad un progressivo rallentamento nella crescita, sia per un leggero rallentamento dei consumi complessivi di energia, sia per la crescita della produzione di altre fonti.
L’effetto di questo rallentamento è sancito dal fatto che il carbone è passato dal picco del 41,1% nel 2007 al 35,1% nel 2023. La produzione nel 2021 aveva avuto un notevole rimbalzo grazie alla ripresa dei consumi elettrici dopo la crisi covid del 2020 e ai primi problemi nell’approvvigionamento di gas, ma nel 2022-23 la crescita è tornata a far registrare valori più modesti. Anche se la produzione è ai suoi valori massimi storici, si evidenzia come dal 2014 la tendenza alla crescita sia abbastanza lenta se paragonata a quella del decennio precedente.
Il gas naturale ha iniziato una fase di crescita più sostenuta a partire dal 1997 che lo ha portato ad essere la seconda fonte di produzione per importanza dopo il carbone. Anche in questo caso si nota comunque dal 2008 un certo rallentamento nella crescita rispetto al decennio precedente, tanto che la quota percentuale sembra aver iniziato una fase discendente, come già capitato al carbone.
Dal canto suo il petrolio ha avuto il suo periodo di crescita a partire dagli anni ‘60 per poi iniziare ad essere sostituito con il gas naturale durante gli anni ‘90.
L’idroelettrica naturale (ovvero esclusi i pompaggi) è stata per lungo tempo l’unica fonte alternativa ai combustibili fossili. È cresciuta in modo continuo ma non particolarmente sostenuto. A partire dal 2004 si nota una certa accelerazione, anche se è appena sufficiente a mantenere costante la quota percentuale. Negli ultimi tre anni la tendenza alla crescita si è interrotta e si nota addirittura un leggero declino, ma i motivi sembrano essere essenzialmente meteorologici (meno pioggia nei paesi che hanno molti impianti idroelettrici), perché nel frattempo la potenza totale installata nel mondo continua a crescere. Ci si aspetta quindi una ripresa della tendenza alla crescita.
La nucleare è stato il primo tentativo di trovare una nuova fonte alternativa ai combustibili fossili. Partendo praticamente da zero negli anni ‘70, ha avuto una fase di crescita per i trenta anni successivi, più sostenuta durante gli anni ‘80. Già all’inizio degli anni ‘90 l’istallazione di nuovi reattori si era comunque ridotta notevolmente e la crescita della produzione derivava in buona parte da un potenziamento di vecchi impianti, soprattutto negli Stati Uniti.
Il forte rallentamento nell’apertura di nuove centrali e l’inizio della chiusura delle più vecchie ha portato la produ-
zione ad un sostanziale stallo a partire dal 2004, che si è poi trasformata in un vero e proprio decremento nel 2011-12 in seguito agli eventi di Fukushima in Giappone.
Dal 2013 la produzione è tornata a crescere (ma lentamente), principalmente grazie ad una certa attività della Cina nel settore, attività che comunque non è particolarmente elevata se paragonata alla crescita avuta in passato in Europa o Stati Uniti. La quota del nucleare in Cina rimane ad un misero 4,6% della produzione nazionale nel 2023.
In genere, quindi, dal 2013 la produzione nucleare mostra variazioni annuali scarse, ma in leggera crescita. Solo nel 2020, a causa del calo dei consumi per la crisi covid, è stato registrato un declino, e anche nel 2022, a causa di problemi avuti dalle centrali nucleari francesi per guasti, ondate di calore e mancanza di acqua. Ad ogni modo questi due cali di produzione non sono stati seguiti da adeguati recuperi e ciò ha portato negli ultimi quattro anni ad un nuovo stallo.
La produzione mondiale attuale rimane così ancora di poco sotto al picco raggiunto nel 2006 ed in termini relativi la quota percentuale ha una tendenza a calare addirittura dal 1996, quando raggiunse il 17,4% della produzione energetica mondiale.
Il nuovo tentativo di trovare fonti alternative ai combustibili fossili è rappresentato dalle nuove rinnovabili, ovvero
dall’insieme di fonti rinnovabili come l’eolica, la solare, le biomasse, il geotermico più altre minori (il geotermico non può definirsi proprio “nuovo” ma è comunque una fonte sviluppata in larga parte in epoca recente).
Le nuove rinnovabili stanno crescendo ad un ritmo veloce e leggermente esponenziale. Si tratta di un passo di cre-
elettrica. Il rallentamento del carbone e del gas naturale negli ultimi anni di cui si è detto in precedenza è causato in buona parte proprio dalla crescita delle nuove rinnovabili, oltre che da un leggero rallentamento della produzione totale dopo la crisi del 2008-9.
Nel dettaglio, nel 2023: l’eolico rappresenta una quota del 7,8%; il solare una

scita che negli ultimi 10 anni risulta già ben superiore a quello del nucleare dei tempi d’oro passati, più del doppio in termini di energia prodotta. Nel 2023 la produzione da nuove rinnovabili ha una quota del 15,9% e una variazione di +541,7 TWh (terawattora). La produzione, dopo aver superato quella nucleare nel 2020, ha superato nel 2023 anche quella idro-
variazione di +319,7 una quota del 5,5%; le bioenergie, il geotermico e altre fonti minori una quota del 2,6%. Nel complesso, raggruppando le fonti per macro categorie, si può notare che il settore è ancora dominato dalle fonti termoelettriche basate su combustibili fossili, che nel loro insieme coprono il 60,0% nel 2023. L’andamento della quota percen-
tuale mostra comunque dal 2013 una tendenza a scendere. Quindi in termini di indici relativi le fonti fossili hanno raggiunto già il loro picco. L’insieme delle fonti rinnovabili fa segnare nel 2023 una quota del 30,0%.
In questo contesto le rinnovabili si avviano da sole a coprire l’incremento medio dei consumi di energia elettrica globale, senza bisogno della crescita di altre fonti. In pratica in un tale contesto le fonti fossili non sarebbero più in grado di crescere e avrebbero quindi raggiunto il picco anche come produzione assoluta (dopo aver già raggiunto il picco sulla quota percentuale). Ovviamente si parla di una tendenza media, sul singolo anno ci possono essere ancora eccezioni. Nel 2023 ci si aspettava un calo della produzione termica fossile che alla fine non si è verificato a causa di una produzione idroelettrica particolarmente scarsa e di consumi di energia un po’ sopra la media.
Da sottolineare come l’incremento di produzione solare, che sta mantenendo un andamento esponenziale regolare, da due anni è diventata la prima fonte al mondo per crescita. Nel confronto tra riserve mondiali di energia, la fonte solare, per il grande potenziale produttivo che ha, è molto probabilmente destinata a diventare la prima fonte rinnovabile.
In Europa la situazione è molto più dinamica rispetto al contesto globale. D’altra parte il vecchio continente non

ha grandi risorse locali di combustibili fossili da cui attingere, quindi si è avuta maggiore necessità di sviluppare fonti alternative. Il nucleare ha avuto davvero uno sviluppo rapido e notevole, tanto da raggiungere e superare il carbone diventando la prima fonte di produzione. Al contrario di quanto visto a livello globale, però, il nucleare nell’Unione ha avviato dal 2005 una chiara tendenza a scendere, quindi già prima dell’incidente di Fukushima del 2011, anche se tale evento ha sicuramente aiutato la discesa con la chiusura anticipata di alcune centrali. Nel 2022 si nota un notevole calo della produzione (il più grande mai registrato) causato, come già detto in precedenza, da problemi alle centrali nucleari francesi che si sono sommati al normale declino del nucleare in Europa. Come si vede, dopo questo crollo, nel 2023 il recupero della produzione è stato assai modesto, ad indicare che i problemi del 2022 non sono ancora stati risolti completamente.
L’uso del carbone era ancora molto importante a metà degli anni ‘80, addirittura con una quota superiore a quella globale. L’utilizzo di questa fonte, però, è andato continuamente a scendere in funzione di una sostituzione nel tempo con il nucleare, il gas naturale e infine con le nuove rinnovabili. Negli ultimi due anni si assiste ad un piccolo “rimbalzo” della produzione, il primo anno come conseguenza del recupero nella richiesta di energia dopo la crisi covid del 2020 e dai primi effetti della crisi di approvvigionamento del gas, il secondo
anno più che altro a causa delle necessità di compensare il forte e anomalo calo contestuale della produzione idrica e nucleare. Ad ogni modo, tale rimbalzo è assai poco significativo rispetto alle riduzioni avute negli ultimi anni e soprattutto si è trattato di una situazione temporanea, visto che nel 2023, in un contesto più normale, la produzione ha avuto un nuovo crollo, portandosi ai minimi storici.
Fino ai primi anni’90 l’uso del gas naturale in UE era decisamente inferiore rispetto al resto del mondo. Poi a partire dal 1993 si è deciso di puntare maggiormente su questo combustibile (meno inquinante del carbone) ed è iniziata una fase di crescita che ha riequilibrato la situazione. Da notare il brusco passo indietro dal 2009 al 2014 causato dal calo dei consumi e dalla veloce ed imprevista crescita delle nuove rinnovabili. Le centrali che utilizzano gas naturale sono state colpite maggiormente perché hanno un funzionamento più flessibile rispetto a centrali come carbone e nucleare. Dal 2015 l’uso di questo combustibile è tornato a crescere grazie alla ripresa dei consumi e al fatto che le centrali si sono adattate a fare competizione alle fonti più rigide. Negli ultimi anni, con i problemi di approvvigionamento di gas dalla Russia, con un rallentamento dei consumi complessivi di energia e la continua crescita delle fonti rinnovabili, la produzione da gas mostra una nuova tendenza a scendere, con un calo significativo proprio nell’ultimo anno. La fonte idroelettrica e il petrolio hanno
avuto un andamento simile a quello già visto a livello globale.
Da segnalare il notevole calo della produzione idrica del 2022 che comunque, come si può vedere, è sempre stata una fonte caratterizzata da importanti variazioni annuali della produzione, in negativo e in positivo. Nel lungo periodo questa fonte già da diversi decenni mostra comunque una tendenza alla stabilità, perché si tratta di una fonte “storica”, le cui migliori risorse in Europa sono già state in larga parte sfruttate in passato. A livello mondiale, quindi, le prospettive di crescita dell’idroelettrico derivano esclusivamente dai paesi emergenti e in via di sviluppo.
Nell’Unione Europea un ruolo molto importante lo hanno assunto le nuove fonti rinnovabili. Come si vede è un settore sul quale si è puntato molto, tanto che ormai la produzione ha superato quella nucleare ed è nettamente la prima. Tra le nuove rinnovabili, l’eolico è la fonte più rilevante. Dopo aver superato l’idroelettrico negli anni scorsi, l’eolico aveva superato nel 2020 anche il carbone, ma nel 2021 c’era stato un contro-sorpasso. Nel 2023 una buona crescita della produzione ha portato l’eolico a superare in un solo anno sia il carbone che il gas naturale (entrambe in netto calo). Il solare, dopo una fase di rallentamento nel 2014-18, mostra una nuova tendenza alla crescita, anche particolarmente marcata, tanto che ormai gli ultimi incrementi registrati non sono molto diversi da quelli dell’eolico.

Nel complesso nell’Unione europea le fonti fossili mostrano a partire dal 2008 una netta tendenza alla riduzione, cosa che, come abbiamo visto, a livello globale ancora non si vede. Addirittura, nel 2020 le rinnovabili sono riuscite a superare le fonti fossili. Un sorpasso reso particolarmente netto nel 2023 e dal quale non ci sarà più ritorno.
Gli Stati Uniti hanno un sistema elettrico che fin dal passato risulta più ancorato all’utilizzo dei tradizionali combustibili fossili rispetto a quello europeo, anche perché hanno maggiori disponibilità locali di tali risorse. Come fonte alternativa la nucleare ha avuto un’incidenza ben più bassa rispetto all’UE e già da diversi anni è una tecnologia che non viene più sviluppata, tanto che la produzione risulta praticamente stabile nel tempo ma con prospettive nel futuro prossimo di iniziare una fase di declino (come capita già nell’UE). Nonostante ciò il carbone negli ultimi anni ha avuto una marcata fase di declino, esattamente come in Europa, ma se in quest’ultimo paese il declino è derivato esclusivamente dalla crescita delle nuove fonti rinnovabili, negli Stati Uniti un buon contributo lo ha dato anche la crescita nell’uso del gas. Nel complesso, però, la produzione fossile negli USA ha avviato una tendenza al declino come visto nell’UE, ma meno marcata e l’incidenza percentuale rimane ben più elevata.
Negli Stati Uniti lo sviluppo delle nuove fonti rinnovabili è partito un po’ in ritardo rispetto all’Unione Europea e con meno impeto, anche se la progressione

risulta comunque un po’ esponenziale. Nel 2023 si nota una crescita modesta, derivata principalmente da un calo della produzione eolica, sia per un certo rallentamento nelle installazioni, sia per motivi meteorologici. Gli Stati Uniti stanno puntando molto sul solare e, anche se per ora i risultati si vedono solo parzialmente, nel prossimo futuro questa fonte è previsto che cresca molto.
Al contrario di Unione Europea e Stati Uniti, che sono due paesi ad economia avanzata, la Cina è un paese ad economia emergente e sotto molti aspetti ha ancora i tipici caratteri di un paese arretrato e in via di sviluppo. Ciò è visibile anche dal sistema elettrico che risulta in larghissima parte ancora dipendente da una fonte inquinante e poco flessibile come il carbone. Allo stesso modo, l’esplosione dei consumi elettrici, oltre al veloce sviluppo economico, sono indice di un sistema elettrico poco efficiente e incline allo spreco. Nonostante questo si iniziano a scorgere anche in Cina i primi segni del cambiamento verso un sistema più moderno. La produzione da carbone dal 2012 ha comunque una tendenza a crescere minore rispetto al passato, come si può notare anche dalla riduzione della quota percentuale. Ciò è stato ottenuto in larga parte attraverso la crescita della produzione rinnovabile, sia l’idrica (che in Cina al contrario di Europa e Stati Uniti ha ancora qualche prospettiva di sviluppo), sia in partico-
lare quella delle nuove fonti rinnovabili (che nel 2022 hanno superato l’idrica). Al contrario di quanto molti sono portati a pensare, in Cina la produzione nucleare, come si vede, cresce a ritmi lenti e incide poco sul mix energetico cinese. La quota percentuale nel 2023 è solo del 4,6% e negli ultimi cinque anni è praticamente ferma. Le nuove fonti rinnovabili in Cina crescono più velocemente, tanto che l’eolico ha superato la produzione nucleare già nel 2012, mentre il solare l’ha superata nel 2022.
Alla fine anche in Cina la produzione rinnovabile sta crescendo ad un ritmo tale che potrebbe nel prossimo futuro coprire da sola l’incremento medio dei consumi, portando quindi ad una inversione di tendenza nella produzione fossile come già visto in precedenza per Unione Europea e Stati Uniti. Questo processo sarebbe facilitato comunque da un certo rallentamento nella crescita dei consumi, che dal 2008 hanno già smesso di crescere esponenzialmente ma mantenendo in seguito una crescita media costante.
Fonti
I dati sono tratti dal sito web dell’Energy Institute sezione “Exploring Energy; Statistical Review of World Energy; Download the data”. I dati della produzione elettrica si trovano nelle cartelle contraddistinte dal termine “generation” e i valori in TWh. Altavista.org
Promuovere il mutuo trasferimento tecnologico e la sinergia fra il settore aerospaziale e la liera industriale del territorio, in applicazioni trasversali ad elevato impatto economico e sociale.

La rete innovativa regionale A.I.R. è composta da aziende, centri di ricerca, e la Fondazione Univeneto.
La rete è rappresentata dal Consorzio aerospaziale e cosmonautico - Co.Si.Mo, di cui fanno parte Fondazione Univeneto, ISOCLIMA SpA, Zoppas Industries IRCA SpA, Zero srl e Officina Stellare SpA.
Università e Centri di Ricerca
Centro di ricerca 1
L’articolo qui riproposto in italiano è apparso su Politico.Eu il 10/07/2024
Kourou, Guyana francese - Prima è arrivato il fuoco, poi il boato e il rombo attraverso la foresta pluviale, e pochi secondi dopo i quattro anni di ritardo dell’Ariane 6 europeo sono stati, almeno per un momento, dimenticati quando il razzo è scomparso tra le nuvole. Meglio tardi che mai.
Di Joshua Posaner
Politico.eu
Dopo aver guidato il mercato per anni con il razzo Ariane 5, negli ultimi due anni i governi, le aziende e le agenzie di spionaggio europee hanno perso l’accesso allo spazio a causa di un cocktail di malattie, guerre, inflazione e cattiva pianificazione che ha bloccato i lanci nello spazioporto europeo della Guyana francese. Mentre il vecchio razzo Ariane 5 è diventato sempre più obsoleto e il programma di costruzione dell’Ariane 6 si è arenato, l’azienda americana SpaceX ha ulteriormente rivoluzionato il settore dei lanciatori grazie a razzi riutilizzabili come il Falcon 9 che hanno ridotto i costi. Anche se il programma Ariane 6 è stato sovvenzionato per quasi 6 miliardi di euro, ci sono poche possibilità che riesca a sopravvanzare SpaceX. Il caso migliore è che offra ai satelliti europei un modo per raggiungere l’orbita senza dover pagare Elon Musk, ma ad un prezzo maggiorato. «L’Ariane 6 non è competitivo con il Falcon 9, e questo va affrontato», ha dichiarato Toni Tolker-Nielsen, veterano danese dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) incaricato di risollevare

le sorti del programma Ariane. La missione inaugurale dell’Ariane 6 può aver funzionato - salvo solo per l’interruzione della terza accensione dell’upper stage per il rientro - ma è ben lontana dall’essere una storia di successo.
Costoso, in ritardo e non più all’avanguardia. Questa descrizione si applica all’Ariane 6 ma anche ad ampie fasce dell’economia europea, con le aziende che hanno ceduto il passo ai rivali asiatici e americani per quanto riguarda i pannelli solari, le celle a batteria, i veicoli elettrici, le turbine eoliche e i microchip; lo dimostra la scarsità di giganti tecnologici di stampo americano. «Non avendo sviluppato un nuovo lanciatore da decenni, abbiamo perso alcune competenze», ha dichiarato Philippe Baptiste, presidente dell’agenzia spaziale francese CNES. «È la stessa cosa in molti settori industriali in Europa». Ciò rende il programma Ariane un’eco di un’Europa che un tempo era leader mondiale con i veloci treni TGV e gli aerei supersonici Concorde.
Nel suo periodo di massimo splendore, solo pochi anni fa, l’Ariane 5 era un cavallo di battaglia globale per le missioni commerciali e istituzionali, lanciato 113 volte in quasi tre decenni. Anche la NASA ha accettato di spedire il suo prestigioso telescopio James Webb nello spazio a bordo di quel razzo nel 2021 - una dimostrazione significativa e simbolica di sostegno. L’anno scorso ha effettuato la sua ultima missione, congelando per un anno le ambizioni
spaziali dell’Europa. POLITICO.EU ha parlato con funzionari spaziali del passato e del presente, sia in via ufficiale che non, per scoprire cosa è andato storto con l’Ariane 6.
Quando il piano per il futuro sistema Ariane - un razzo a tre stadi per il trasporto pesante - è stato concordato dai ministri dello spazio in occasione di un vertice a Lussemburgo nel 2014, l’obiettivo era chiarissimo: lancio entro il 2020. Il razzo sarebbe stato costruito da ArianeGroup, di proprietà di Airbus e Safran, con la Francia a guidare i lavori insieme a Germania e Italia. Circa 13 Paesi avrebbero contribuito con parti e know-how, rendendo la missione veramente europea. Fin dall’inizio, i francesi hanno spinto sull’autonomia strategica come filosofia di base. La risposta tedesca è stata invece caratterizzata da quello che Jan Wörner, che ha diretto l’Agenzia spaziale europea tra il 2015 e il 2021 ed è un ex capo dell’agenzia spaziale tedesca, ha definito ungehinderter zugang, ovvero un accesso senza ostacoli allo spazio. Rendendosi conto che l’Ariane 5 non avrebbe mai potuto competere con il nascente Falcon di SpaceX, le opzioni erano: scegliere un piano tedesco ridotto che investisse in un’estensione di metà vita dell’Ariane 5 con uno stadio superiore migliorato e un costo di lancio leggermente più basso, oppure scegliere un piano francese per costruire un sistema completamente nuovo.
Alla fine, i Paesi dell’ESA hanno scelto una terza via, spinta dall’industria, per costruire un razzo nuovo di zecca che sarebbe stato più economico del 50% per il lancio e più agile in orbita rispetto all’Ariane 5. L’idea di copiare SpaceX e costruire un razzo nuovo di zecca è stata accolta con favore. L’idea di copiare SpaceX e rendere Ariane parzialmente riutilizzabile è stata invece presa in considerazione e, però, respinta. Una decisione che perseguita il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire: «Nel 2014 c’è stato un bivio e non abbiamo preso la strada giusta». Ma solo perché funziona per Elon, non significa che vada bene per l’Europa.
Una volta in funzione, Ariane 6 dovrebbe effettuare nove lanci all’anno, di cui circa quattro per missioni istituzionali, come satelliti governativi di ricognizione e sistemi di osservazione della terra. Il resto sarà destinato a clienti commerciali. Questo dato va confrontato con quello di SpaceX: alimentata da un flusso costante di contratti con il Pentagono e l’industria, oltre alle missioni per la propria costellazione di satelliti Starlink, l’azienda di Musk ha effettuato un record di 96 lanci nel 2023.
«Non è che abbiamo detto che la riutilizzabilità è una s*******a», ha detto Wörner a proposito dei primi colloqui sull’Ariane 6 a metà degli anni 10 del 2000 e della considerazione di costruire stadi riutilizzabili piuttosto che bruciare nuovi componenti a ogni missione: «Se hai 10 voli all’anno e costruisci
solo un nuovo lanciatore all’anno, da un punto di vista industriale non funziona». Il piano prevedeva che l’Ariane 6/2 a due booster costasse circa 70 milioni di euro per lancio, mentre il modello più pesante a quattro booster chiamato Ariane 6/4 sarebbe costato circa 90 milioni di euro. Ma queste previsioni appaiono ora decisamente ottimistiche. Il costo del lancio sarà superiore a 100 milioni di euro, ha dichiarato Pacôme Révillon, amministratore delegato della società di consulenza Novaspace, pur rilevando che potrebbero esserci modi per ridurre i prezzi massimizzando i carichi utili. A titolo di confronto, la stima approssimativa del settore per il costo di un lancio commerciale con il Falcon 9 è di 70 milioni di dollari.
Mentre Caroline Arnoux, che gestisce il programma Ariane 6 presso Arianespace, parla di un portafoglio ordini “impressionante” per il razzo appena volato, con 29 lanci nei prossimi tre anni, i primi risultati della competizione tra la sua azienda e SpaceX non sono promettenti. In modo controverso, SpaceX sta rastrellando 180 milioni di euro per il lancio di due satelliti europei di geo-navigazione Galileo, il cui lancio era stato appaltato agli Stati Uniti a causa dei ritardi dell’Ariane 6. Nel frattempo, anche l’operatore europeo di satelliti meteorologici EUMETSAT ha deciso, pochi giorni prima della prima missione Ariane 6, di pagare SpaceX per portare in orbita un satellite meteorologico l’anno prossimo, ribaltando un precedente

accordo con Arianespace. La decisione di EUMETSAT è stata presa dopo che i funzionari di SpaceX hanno detto loro di fare il cambio prima del lancio dell’Ariane 6 per la prima volta, o di rischiare un’impennata dei costi per andare più tardi. Un funzionario del settore spaziale ha dichiarato, a condizione di anonimato, che «SpaceX ha fatto il suo gioco. Sono solo affari». La risposta? Una richiesta di protezione e di aiuti governativi molto europea. L’UE e l’Agenzia spaziale europea chiedono regole per una «chiara preferenza europea», ha dichiarato il commissario per il Mercato interno Thierry Breton a una riunione di esperti del settore spaziale a gennaio. «Riconquistare la
nostra sovranità in termini di accesso allo spazio è imperativo se vogliamo che l’Unione rimanga un attore spaziale credibile», ha dichiarato Breton.
Tempesta perfetta
Guerra e malattie non vanno d’accordo con la scienza missilistica. Quando è stato elaborato il piano Ariane 6, l’obiettivo era il lancio nel 2020 e il costo di lancio dimezzato rispetto all’Ariane 5. Poi è arrivata la pandemia, che ha frenato lo sviluppo e causato ritardi, aggravati dall’impennata dell’inflazione e dalle restrizioni alla circolazione. A ciò sono seguiti altri due colpi nel 2022: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio ha distrutto il vecchio rapporto tra l’Agenzia spaziale europea e la Roscosmos, che si è ritirata dalla sua piattaforma di lancio nella Guyana francese a causa delle sanzioni occidentali. Ciò ha messo a repentaglio il piano di riserva dell’ESA, che prevedeva di continuare a lanciare con i razzi Soyuz della Roscosmos dopo il ritiro dell’Ariane 5. «La Soyuz era la riserva per Ariane 6, non per Ariane 5», ha detto Tolker-Nielsen dell’ESA. «È questo che ha creato la vera crisi». Ad aggravare i problemi, nel dicembre 2022 un razzo di medie dimensioni Vega C si è guastato, perdendo due satelliti. «Nel giro di un anno abbiamo perso completamente l’accesso allo spazio in Europa», ha dichiarato Baptiste del CNES. «Per la Francia la questione è sempre stata delicata, ma improvvisamente è diventata importante per l’Europa».
La prossima generazione
Se non puoi batterli, copiali. Il successo di Musk nel trarre profitto da un approccio di libero mercato allo spazio negli Stati Uniti ha spinto l’Europa a guardare al proprio modello dominato dallo Stato e a spingere per le riforme. A novembre, i ministri dello spazio riuniti al vertice dell’ESA a Siviglia hanno lanciato un piano per appaltare i servizi per una missione di ritorno alla Stazione Spaziale Internazionale, lasciando che sia l’industria a decidere come portare a termine il lavoro. Si tratta di una rivoluzione rispetto al sistema attuale, in cui l’ESA utilizza complesse regole di geo-ritorno in base alle quali i Paesi ricevono contratti in base al valore che contribuiscono a ciascun programma specifico durante i vertici di qualche anno. Il prossimo passo è ripensare il modo in cui vengono sviluppati i razzi, sempre seguendo il modello che ha funzionato bene per SpaceX. L’ESA sta conducendo un programma per incubare le aziende di razzi, fornendo finanziamenti, contratti quadro per le missioni future e l’accesso alle infrastrutture dello spazioporto nella Guyana francese. L’obiettivo è iniziare a promuovere le startup europee nello stesso modo in cui SpaceX ha beneficiato del sostegno istituzionale della NASA nei suoi primi giorni di vita. «Il futuro dell’accesso europeo allo spazio dovrebbe essere diverso», ha dichiarato Jörn Spurmann, direttore operativo di Rocket Factory Augsburg, una startup spaziale tedesca. Secondo lui, l’UE e l’ESA dovrebbero appaltare i servizi
di lancio piuttosto che puntare tutto sull’Ariane 6. Tra le altre aziende che sviluppano razzi ci sono la spagnola PLD Space e la tedesca Isar Aerospace. Aprire il mercato a nuovi operatori è l’unico modo per «recuperare il ritardo rispetto alle nazioni spaziali leader nel mondo», ha detto Spurmann.
Non è chiaro se questa iniezione di idee di libero mercato sia sufficiente a salvare il settore spaziale europeo in tempi brevi. L’industria si lamenta del fatto che i finanziamenti offerti dall’ESA sono esigui e Tolker-Nielsen sostiene che i benefici di tali programmi saranno evidenti non prima del 2035. Mentre una volta il business case per Ariane 6 era chiaro, ora la sua argomentazione si basa sulla geopolitica dello spazio. «Non importa come la si guardi», ha detto l’astronauta francese Thomas Pesquet poco prima che Ariane 6 partisse. «Il razzo è fondamentale perché l’Europa abbia un accesso autonomo allo spazio». «Lo spazio è diventato così importante che non possiamo lasciare che altri lancino i nostri satelliti», ha aggiunto.
L’Ariane 6
è stato lanciato per la prima volta il 09/06/2024

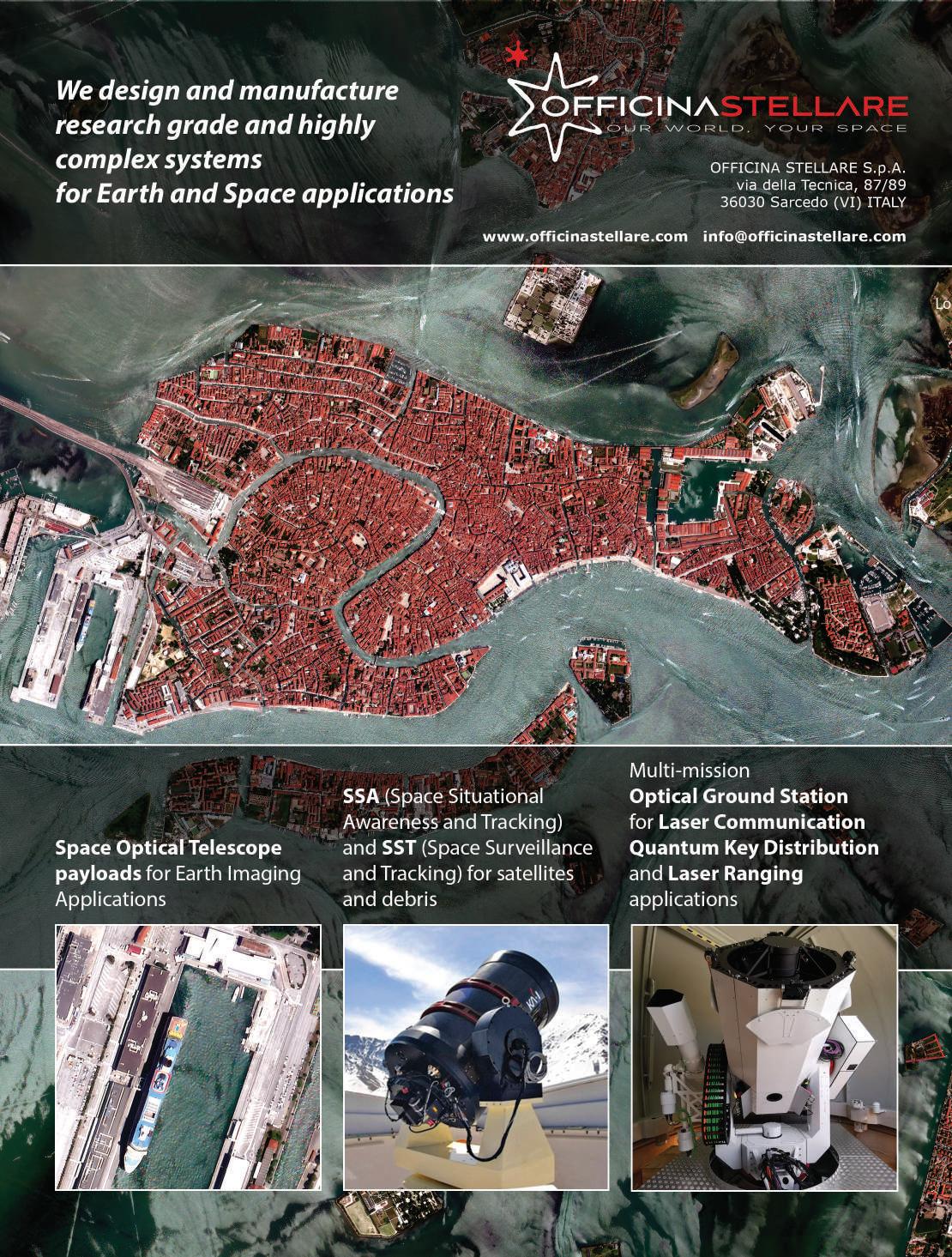

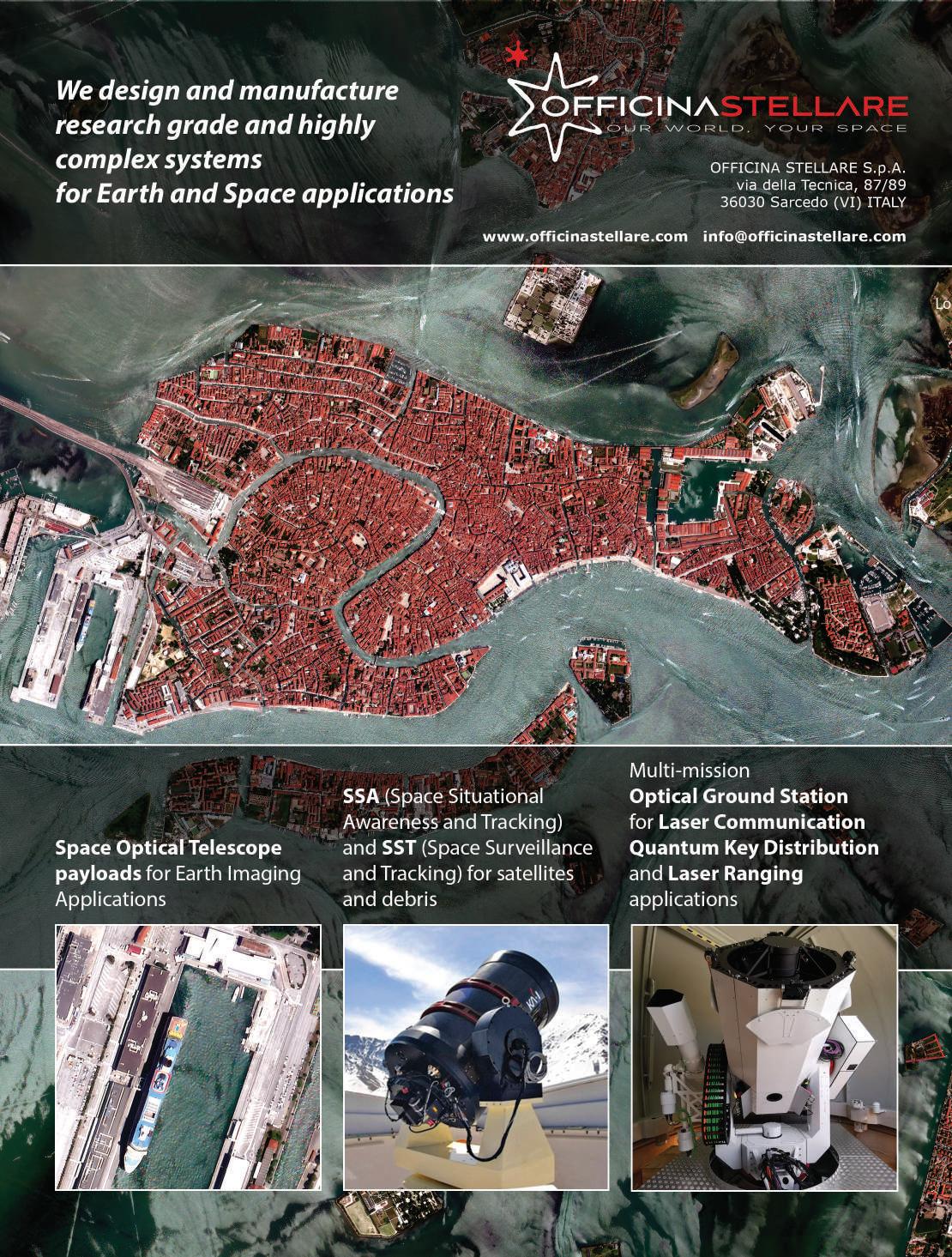
Di Anilkumar Dave
Fuori contesto la frase “tutti aspettavano la fine dell’edizione 2024 degli Space Meetings Veneto (SMV)” avrebbe un significato negativo e preoccupante per gli organizzatori. Dal 20 al 22 maggio Venezia ed il Veneto sono stati la destinazione di più di 250 aziende espositrici, 150 buyers e 3000 visitatori da circa 25 paesi che si sono ritrovati per parlare di Spazio, partecipare alla tre giorni di convegni e dare vita a più di 5000 incontri B2B. E in più c’era anche Venezia.
Una seconda edizione, dopo quella di lancio del 2023, segnata ancora una volta da una partecipazione istituzionale di alto profilo che ha visto la presenza del governatore della Regione del Veneto Luca Zaia e delle autorità locali ma anche del presidente dell’Agenzia Spaziale
Italiana Teodoro Valente, del ministro per le Imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso, del capo di stato maggiore dell’Aeronautica Gen. Luca Goretti e rappresentanti di stakeholder e grandi aziende del comparto.
Squadra che vince non si cambia si diceva una volta e (cercando di non cadere in pericolose metafore calcistiche ndr) anche quest’anno il formato è stato lo stesso: centralità ai B2B; focus su giornate con convegni focalizzati su finanza, supply chain, agritech; attenzione ai giovani. Si sono però aggiunti due elementi non trascurabili e che hanno reso questa edizione particolare: un focus su Spazio e Sport; sessioni di divulgazione aperte al pubblico e ai non-operatori del settore.
Un menù ricchissimo che ha visto un via-vai di persone, studenti e curiosi che hanno animato il Terminal Passeggeri di Venezia forse ancora di più di quando arrivavano le grandi navi a Venezia.
Lunedì 20 maggio ore 10, finiti gli ultimi ritocchi agli stand, si parte. Taglio del nastro, giro d’onore, selfie, immancabile con i finalisti della challenge europea “Venetostars” (vedi box), strette di mano, saluti istituzionali, incontri con alcuni espositori, primo panel. Già dal primo giorno si percepiva un grande entusiasmo ma anche un po’ di preoccupazione, l’edizione 2023 era stata un grande successo e molti dei nuovi di

questa edizione erano curiosi di sapere se fosse un evento sul quale puntare anche per il futuro. L’area B2B è sempre stata attiva ed ha sempre visto lo svolgersi di incontri: probabilmente il numero finale è più alto se consideriamo quelli che non sono stati organizzati tramite l’applicazione fornita dagli organizzatori. Anche le 25 startup selezionate hanno avuto un’area dedicata e quest’anno i loro pitch hanno avuto una visibilità maggiore. Ovviamente la curiosità del primo giorno era quella di vedere i nomi delle aziende presenti, la configurazione degli stand, le differenze con l’edizione precedente e il confronto con altri eventi simili. La prima cosa che si percepiva era che la cosa più importante era incontrarsi, non c’erano stand con grafiche mirabolanti o con razzi enormi, satelliti geostazionari, moduli abitativi, mockup di stazioni commerciali, ma spazi dove l’obiettivo era parlarsi, conoscersi e darsi eventualmente un successivo appuntamento. La metafora con lo ‘speed dating’ avrebbe potuto essere azzeccata.
La novità principale rispetto alla edizione precedente è stata “l’arena”, uno
spazio dedicato ad eventi aperti, a dibattiti e a presentazioni più ‘leggere’ o divulgative. È stato lo spazio che ha visto gli SMV aprirsi al grande pubblico grazie alle sessioni gestite dal “Festival delle Idee”. Si è parlato di cibo nello Spazio, di Intelligenza Artificiale, del futuro della scienza con un taglio divulgativo e per questo apprezzato dai non addetti ai lavori. L’arena è stata anche al centro di importanti avvenimenti come la firma dell’accordo tra l’aeroporto di Venezia, ENAC e la Regione sulla mobilità aerea avanzata, la presentazione ufficiale dell’incubatore ESA BIC per startup spazio situato sul territorio della Regione, la presentazione della bandiera dello IAC Milano che si terrà ad ottobre. L’arena è anche stata, nei momenti di pausa, punto di incontro informale per un caffè o di condivisione tra gli studenti presenti.
I giovani. Ancora una volta sono stati uno degli elementi caratterizzanti gli Space Meetings Veneto. L’università di
Padova ha fatto la parte del leone (solo alcuni apprezzeranno la sottile ironia di questa frase, considerando il simbolo della serenissima) portando 200 dei 500 ragazzi che complessivamente hanno animato la tre giorni. Studenti ma anche aspiranti startupper e, elemento non secondario per gli espositori, possibili nuovi colleghi visto che molti si sono portati il curriculum o hanno de facto sostenuto una sorta di colloquio mentre parlavano con gli espositori. Considerando che il periodo era a ridosso delle ultime prove prima degli esami di maturità o delle sessioni estive universitarie è stato un successo vedere molti ragazzi e ragazze (altro elemento non trascurabile) prendersi il tempo per visitare l’evento e partecipare ai lavori.
Dicevamo dei tre pilastri: B2B, giovani, convegni. I temi sono rimasti i tre dell’edizione precedente (la famosa squadra che vince) quindi Finanza, Supply Chain e Agritech. La prima

componente ha avuto una sede prestigiosissima, le Procuratie Vecchie in piazza San Marco. Grazie alla magnifica giornata, il trasferimento in battello dal Terminal al cuore pulsante della città è stato un problema. Si, non si riusciva ad essere concentrati sull’interlocutore o il vicino di posto perché distratti dalla bellezza della città e della laguna che tutto il mondo ci invidia …però ammetto che aveva un certo fascino poter parlare con alcuni grandi personaggi dello Spazio italiano cullati dalle onde e per certi versi in maniera più rilassata. L’evento alle Procuratie si è focalizzato su alcuni temi di attualità come le partnership pubblico-private, le opportunità di investimento, l’attrazione degli investimenti e il ruolo della finanza pubblica. Conclusioni affidate al vice ministro del MIMIT Valentino Valentini in rappresentanza del governo dopo un alternarsi di relatori italiani ed esteri. Quest’ultima componente, non evidenziata a sufficienza, è stata però un altro elemento interessante di questa edizione, l’agenzia ITA-ICE ha infatti supportato l’organizzazione di una delegazione di rappresentanti esteri del settore finanziario ed industriale (buyers) che hanno animato gli incontri e dato la di-
mensione internazionale ai B2B. Il secondo giorno comincia molto presto, è la giornata sulla quale tutti puntano per il fatidico ritorno dell’investimento perché è dove si concentrano i B2B, il programma convegnistico, gli investitori, i buyers e dove si possono invitare i clienti o i prospect per approfondire alcuni elementi. Il tempo del caffè è un po’ risicato ma meglio così. Le due grandi sale convegni hanno programmi molto ricchi ed ovviamente la fa da padrone la componente Supply Chain con un susseguirsi di panel a ritmo serrato. Forse l’acustica è da migliorare ma è sinonimo di un evento vivo e di un frenetico susseguirsi di saluti, strette di mano, scambi di biglietti da visita (per chi li usa ancora) e raccolta di brochure. È un evento pratico e sperabilmente funzionale al business e lo si capisce anche dalla scarsità di gadget e dalle facce a volte deluse degli studenti che girano con zaini che speravano di riempire con adesivi, penne, blocchi notes, pupazzi di gomma, portachiavi, e oggettistica spaziale varia.
Ci sono però due eventi che il secondo giorno caratterizzano ancora di più gli SMV. La seconda sala con-
vegni è stata dedicata ad un ambito che la Regione ha voluto sviluppare per celebrare la designazione di Regione Europea dello Sport. Una intera sessione dedicata allo Spazio e Sport con 3 panel su temi comuni tra i due ambiti. Una sfida diranno alcuni, un azzardo diranno altri, un successo diranno tutti alla fine dell’ultimo panel. Numeri forse inaspettati che però hanno decretato il successo (e l’interesse della stampa locale) per un connubio inaspettato, si sono alternati sul palco due assessori regionali e un dirigente, presidenti di associazioni europee dello sport e distretti regionali, incubatori spazio e sport, startup, si è parlato di attività fisica nello spazio e a terra ma anche di realtà virtuale per giocare a padel sulla Stazione Spaziale Internazionale, di abbigliamento e nuove tute con Axiom Space, di alta moda e connubio con lo Spazio e ovviamente di cibo funzionale e della regola d’oro “mens sana in corpore sano” valida nello Spazio e a Terra. L’Agenzia Spaziale Italiana, una palestra e aziende punto di riferimento per la nutraceutica hanno completato un programma di per sé già molto attraente. La ciliegina (a

basso contenuto calorico ovviamente) è stato l’annuncio dell’avvio della “Space Athletics Federation”.
Il secondo evento che ha caratterizzato la giornata dei convegni è stata la finale di Venetostars, una challenge per giovani europei che ha visto spostarsi uno sciame di ragazzi per gli SMV e affrontarsi davanti ad una giuria a colpi di idee innovative per l’uso dei dati satellitari per il patrimonio culturale e i siti UNESCO. Il messaggio che hanno trasmesso durante le loro presentazioni (l’unica sala che è sempre stata piena per tutta la durata dell’evento) è che sottovalutiamo i giovani e dovremmo dare loro più credito e lasciarli liberi di proporre idee o spunti. Le 9 squadre finaliste selezionate su una rosa ben più ampia provenienti, tra gli altri, da Francia, Germania, Olanda, hanno presentato le loro idee (sotto forma di pitch) davanti ad una giuria di tutto rispetto con rappresentanti di ESA Agenzia Spaziale Europea, ASI, ECMWF, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Padova. Non c’è stato un vincitore però. La giuria ha deciso che la qualità era molto alta e ha voluto premiare tre ex-aequo che si sono quindi divisi la gloria e la foto di rito con la targa ‘winner’.
Il giro di boa è stato passato e come in tutti gli eventi, l’ultimo giorno è quello più delicato perché c’è un po’ l’aria dell’ultimo giorno di scuola mischiata con quella dell’ultimo giorno di fiera (i corrieri cominciano a manifestarsi già dal primo pomeriggio). C’è però anco-

ra molto da fare e da vedere. Il “Festival delle idee” marcia a ritmo sostenuto, è la giornata dell’agritech e del coinvolgimento di tutte le organizzazioni della Regione deputare all’agricoltura, al suolo, alle foreste, alle riserve idriche, alla gestione del territorio. Certo, un tema piuttosto specifico e qualcuno dirà anche troppo ‘locale’ ma è indubbio che non ci sono altri eventi che hanno voluto puntare su questo connubio e l’appuntamento rischia di diventare un punto di riferimento. Si parla di moltissimi temi, dalla lotta ai parassiti alla gestione delle acque, dalla politica agricola comune all’osservatorio sui dati satellitari in agricoltura e si anima anche lo stand della Regione Veneto con una sessione insieme alla FAO.
Mentre nell’arena si continua a parlare, ascoltare gli ultimi interventi e raccogliere gli ultimi depliant, nel resto del Terminal girovagano alcuni operatori del settore primario che si chiedono cosa siano i ‘payload commerciali’ e cercano di capire dove sia la sala del loro convegno. Cominciano i primi saluti, la raccolta degli ultimi contatti e la rincorsa a salutare i colleghi ma anche a cercare lo scatolone, il nastro adesivo e i contenitori per i roll-up e a fare le ultime foto allo sfondo dello stand che è

troppo grande da mettere in ufficio ma che qualcuno prova lo stesso a portare via (fa parte del contratto dopotutto). Qualcuno si è già immedesimato nella cultura veneta e cerca qualche compagno per uno spritz (rigorosamente al select) prima di partire. Un ultimo sguardo al padiglione centrale dove l’assessore regionale sta premiando i vincitori di Venetostars, l’ultimo raggruppamento di ragazzi che urla e applaude i vincitori annunciati, ma è lì, sull’ultimo evento pubblico che scatta il colpo di teatro. Ecco perché “tutti aspettavano la fine dell’edizione 2024 degli Space Meetings Veneto” perchè dopo due anni così entusiasmanti e ricchi di successo (inaspettato?) tutti erano curiosi di cosa fosse venuto dopo. L’assessore regionale Francesco Calzavara ed il presidente della Rete Regionale dell’aerospazio, Federico Zoppas, con le benedizioni del governatore ed il consenso dei co-organizzatori nella stessa casa Veneto dove lunedì 20 maggio si tagliava il nastro di inaugurazione alzano un foglio A5 scritto in pennarello e davano la risposta ai curiosi: 20-22 maggio 2025. Parte l’ultimo grande applauso della tre giorni degli SMV, ma già qualcuno sta pensando a che novità inserire nella prossima edizione e a quale colpo di teatro inventarsi il 22 maggio quando “tutti aspetteranno la fine dell’edizione 2025 degli Space Meetings Veneto”. Lo Spazio è così, non si ferma mai, “come il Veneto” dirà qualcuno all’uscita.
La Regione del Veneto - Agenda Digitale del Veneto in collaborazione con Veneto Innovazione ha lanciato nel 2023 la Challenge “VeneToStars” www.venetostars.com, progetto triennale per promuovere l’ideazione, realizzazione e diffusione di soluzioni innovative utilizzando dati e/o tecnologie di derivazione spaziale. Tema dell’edizione 2023 è stato il settore agroalimentare. L’edizione del 2024 ha scelto il tema della tutela, valorizzazione e sviluppo servizi innovativi del patrimonio culturale e dei siti UNESCO della Regione Veneto. Tali siti, quali ad esempio Venezia e la sua laguna, le Dolomiti, Vicenza e le ville palladiane, l’Orto botanico di Padova, Verona e le Colline del Prosecco sono rappresentativi di ecosistemi e temi di più ampio respiro come la protezione del territorio, il monitoraggio delle opere d’arte e dei monumenti, i percorsi d’acqua, la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ecc. “VeneToStars” è rivolta ai giovani innovatori di tutta Europa, tra i 18 e 25 anni di età,
ed i team finalisti sono stati invitati a Venezia dal 20 al 22 maggio per partecipare agli Space Meetings Veneto e per incontrare stakeholder regionali e nazionali. I team vincitori hanno avuto la possibilità di trascorrere una settimana in Veneto a incontrare aziende, università, investitori, utenti finali ma anche di visitare alcuni siti patrimonio UNESCO e soprattutto essere affiancati da coach esperti che li hanno aiutati a migliorare la loro idea dal punto di vista tecnico ed imprenditoriale. Alcuni dei finalisti della passata edizione hanno trasformato la loro idea in startup. L’obiettivo di “VeneToStar” è educare e accrescere la conoscenza nei giovani verso le opportunità legate all’utilizzo dei dati (o tecnologie) spaziali e dei loro benefici per la tutela del patrimonio culturale, a partire da quelli della Regione, ad aumentare la consapevolezza che lo Spazio può avere un impatto in molti settori e ovviamente attrarre giovani talenti da tutta Europa. Appuntamento per l’edizione 2025 con l’annuncio del tema che avverrà in autunno.
ALZI LA MANO CHI NON SA
Tutti (soprattutto i boomers) ricordano gli iconici doposci che spopolavano sulle piste da sci di tutto il mondo e coloravano le baite dove era obbligatorio fermarsi per un bombardino. Alzi la mano chi sa chi ha inventato i Moonboot? Si conosce il lato iconico del prodotto ma non quello commerciale o industriale. Un giovane Giancarlo Zanatta durante la diretta dell’allunaggio di quel indimenticabile 20 luglio 1969 pose la sua attenzione a quegli scarponi anti-gravità con cui Neil Armstrong fece il famoso primo balzo e decise di produrre uno stivale comodo che fosse per tutti e per certi versi iconico perché collegato allo Spazio. Più di 50 anni dopo e più di venti milioni di paia vendute in tutto il mondo, il Gruppo
Tecnica è alla sua seconda generazione di imprenditori e tiene ancora saldamente il punto sul doposci che ha fatto la storia. Alberto Zanatta ha raccontato con grande passione la storia della sua azienda e del suo fondatore durante gli Space Meetings Veneto ma ha anche delineato quali potrebbero essere i nuovi punti di contatto con lo Spazio. I materiali, la sensoristica, gli human factors sono alcuni degli elementi per le nuove e futuristiche versioni di Moonboot ma anche per come lo Sport invernale (il core business di Tecnica) e lo Spazio siano collegati. Temperature estreme, comfort, libertà di movimento, materiali biocompatibili sono alcuni dei temi. Il risvolto ancora più interessante della commistione lo hanno dato i consulenti sui trend della moda che seguono anche il Gruppo Tecnica. Matteo Bardi ed Orietta Pelizzari sono da più di 20 anni advisor di molte aziende del fashion system ma anche della Camera Nazionale della Moda del Milano Fashion Institute e di Linea Pelle e sono riconosciuti esperti internazionali, analisti di trend. Lo Spazio affascina ed ispira da sempre le grandi case di moda
e se per il Gruppo Tecnica ha rappresentato un prodotto iconico, per le grandi maison di haute couture come Dior e Chanel ha fornito ispirazione anche per campagne di marketing o prodotti dedicati. Orietta ha guidato il viaggio nel mondo della moda partendo dallo Sport e di ispirazione spaziale toccando la collezione uomo Autunno- Inverno 2023 di Dior, i prodotti di Gentle Monster di Seoul e il profumo moonwalk di Chanel per citarne alcuni. Matteo ha svelato la spasmodica ricerca di prodotti innovativi, compresi quelli di derivazione spaziale, che le case di moda perseguono e di come le nuove collaborazioni (su tutte Prada e Axiom Space) cerchino la contaminazione. Essendo a Venezia potevano non concludere mostrando l’abito che il mestrino Pierre Cardin (alzi la mano chi sapeva che il maestro era veneto) fece con un materiale donato da Thales Alenia Space, performante ma calzante, di design ma resistente. Un percorso che ha affascinato tutti i presenti che partendo dallo Sport si sono ritrovati nel mondo patinato della moda uniti dalla passione per lo Spazio.

Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, ha approvato la prima legge quadro italiana sullo Spazio e sulla Space Economy. La legge pone l’Italia all’avanguardia tra i grandi player globali e anticipa le intenzioni dell’Unione Europea in merito a un regolamento per il settore. Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio, colma un vuoto nell’ordinamento, che non prevedeva una normativa di riferimento sul settore spaziale.
Frutto di mesi di concertazione con i principali attori pubblici e privati del settore, il ddl regolamenta l’accesso allo spazio da parte dei privati, offrendo grandi opportunità in un comparto che rappresenta il futuro dell’industria e una delle principali traiettorie di sviluppo dell’economia mondiale. In tale contesto, viene prevista la necessità di un’autorizzazione sia per gli operatori stranieri che intendono condurre attività spaziali dal territorio italiano, sia per quelli nazionali che operano da un territorio estero. Sono esenti dall’obbligo le attività spaziali già autorizzate da un altro Stato, se riconosciute in Italia in base a trattati internazionali. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si è incaricata della vigilanza sugli operatori: in caso di non rispetto delle disposizioni
di legge o degli impegni presi, l’autorizzazione sarà revocata. L’Agenzia si occuperà anche dell’immatricolazione nel Registro nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico per i quali l’Italia è Stato di lancio. Il ddl prevede inoltre l’elaborazione di un Piano Nazionale per l’economia dello spazio, con un orizzonte di almeno cinque anni, che includa l’analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni del comparto, per individuare gli investimenti finanziabili attraverso risorse pubbliche e contributi privati. A supporto del settore, viene istituito un Fondo per la Space Economy con carattere pluriennale, che mira a promuoverne le attività, favorendo la crescita del mercato di prodotti e servizi innovativi basati sull’uso di tecnologie spaziali e sull’utilizzo commerciale delle infrastrutture, comprese quelle realizzate nell’ambito del Pnrr e quelle a cui l’Italia partecipa in ambito di collaborazioni internazionali.
Per agevolare l’accesso delle PMI e delle start-up ai contratti pubblici, sono previste norme speciali in materia di appalti e per promuovere le attività e tecnologie aerospaziali. Il provvedimento disciplina le eventualità degli incidenti nello spazio. Gli operatori autorizzati devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti dall’attività spa-
ziale con un massimale pari a 100 milioni di euro per episodio e, nel caso di sinistri, sono chiamati a rispondere in solido. È prevista anche la possibilità di massimali più bassi per ipotesi di rischio ridotto. Infine, il ddl prevede iniziative per l’uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite e una riserva trasmissiva nazionale, fissando i principi sul diritto di sfruttamento da parte dei privati che utilizzano infrastrutture spaziali finanziate con fondi statali ed europei.
L’Italia conferma così il proprio ruolo di primo piano nel comparto: nel dicembre 2022 il nostro Paese ha allocato 3,1 miliardi di euro alla riunione del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea a livello ministeriale, ponendosi al secondo posto insieme alla Francia e solo dopo la Germania per quanto concerne i programmi obbligatori, e al primo posto per i programmi opzionali. In aggiunta, a livello nazionale, l’Italia ha stanziato 2,3 miliardi nel budget dell’ASI e avviato un processo di investimento per attuare i programmi spaziali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In totale, grazie agli investimenti pari a circa 7,3 miliardi di euro previsti dall’Italia per i programmi spaziali fino al 2026, l’intera industria spaziale italiana è destinata a registrare una crescita significativa.

Nel periodo 2023-2027, i finanziamenti pubblici destinati all’ecosistema spaziale nazionale ammonteranno a oltre 7 miliardi di euro: è quanto emerge dal report Space Economy, Space Industry, Space Law del SEE Lab - Space Economy Evolution di SDA Bocconi - School of Management. Di questi investimenti, circa 4,4 miliardi sono finanziamenti pubblici (compreso 1,5 miliardi del PNRR) e 3,1 come fondi allocati sui programmi ESA. Con finanziamenti pubblici di tale portata, l’obiettivo, per l’Italia, è crescere ancora nel settore space economy su cui il Paese ha puntato sempre molto, tanto da essere uno dei fondatori dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e oggi terzo finanziatore con 3,1 miliardi all’anno, dopo Germania e Francia.
Quale che sia il futuro dell’industria dell’aerospazio, il presente ha basi solide. Secondo i dati del SEE LAb, sono 415 le aziende attive nel settore della space economy in Italia. In termini economici, considerando i finanziamenti pubblici e il fatturato generato dalle società focalizzate nella produzione di beni e servizi basati su tecnologie spaziali, il settore ha raggiunto un valore complessivo di 2,9 miliardi di euro nel 2021. Secondo i dati MIMIT (del 2020), il settore conta anche 7mila addetti, con un tasso di crescita del +15% rispetto agli
ultimi 15 anni. Tra le aziende del settore, solo il 10% opera strettamente nel segmento spaziale, mentre il 90% lavora in altri settori collegati come quello dell’aviazione (46%), dell’industria metalmeccanica (44%), dell’ICT e dell’elettronica (41%) e dell’automotive (34%), secondo un’analisi condotta dall’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio. Sempre secondo il Politecnico di Milano, i progetti implementati o in fase di sviluppo dalle aziende end user, cioè quelle che hanno a che fare con i consumatori, riguardano per la maggioranza l’osservazione della Terra (57%), per il 27% la navigazione satellitare e solo per il 16% la comunicazione satellitare. Analizzando soltanto il mercato dei servizi di osservazione della Terra in Italia, che vale 230 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto al 2022, al primo posto troviamo il settore dell’energia e utilities (27,5%), seguito da agricoltura, silvicoltura e pesca (18,3%) e poi da finanza, assicurazioni e legal (16%).
Le stime mondiali relative al valore della space economy variano in base alle attività che vengono considerate nel sistema del mercato dello spazio. Secondo Euroconsult, il valore del mercato spaziale globale è pari a 464 miliardi di dollari nel 2022. Un qua-
dro che vede l’Europa (con 94 miliardi) terza dietro l’Asia (102 miliardi) e il Nord America (131 miliardi). Secondo McKinsey &Company, invece, nel 2023 il valore della space economy è stato pari a 630 miliardi di dollari, di cui 330 miliardi costituiti dalla “spina dorsale” dell’industria aerospaziale (satelliti, lanciatori e servizi come tv broadcast, Gps, materia prima spaziale) e altri 300 miliardi composti da servizi derivati dallo sfruttamento dei dati spaziali. Sempre secondo il rapporto McKinsey & Company, nel 2035 il valore della space economy arriverà a 1790 miliardi di dollari, con una crescita stimata del 9% anno su anno (più del Pil globale).


Dai grandi strumenti per le scienze astronomiche alle innovative applicazioni spaziali, alla difesa del nostro pianeta e del suo ecosistema

Space Surveillance & Tracking
NEO Detection Antennas

Ground Support Equipment
Calibration Facilities
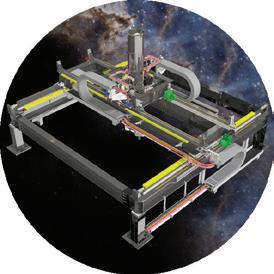

Earth Observation
Solar System Exploration
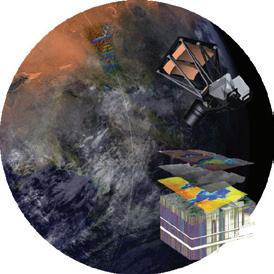

Durante il G7 di Bari dello scorso, Papa Francesco è intervenuto rimarcando, con il suo piglio gentile ma assai fermo e determinato, il rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’uomo e la necessità di che questo si basi e si sviluppi secondo principi etici.
«L’intelligenza artificiale resti al servizio dell’uomo. Serve l’etica. (...) non delegare il futuro alle macchine (...) non far mai decidere alla tecnologia sulla vita di un uomo».
artificiale fino a spingerlo a darci un proprio parere in merito.
Iniziamo…
Giusto per contestualizzare, a quando sei aggiornata?
Sono aggiornata fino a settembre 2021. Tuttavia, ho accesso a informazioni su eventi, sviluppi e dati fino a luglio 2023.
Con che versione sto parlando?
L’etica di un rapporto complesso ma inelubibile
Premesse solo in apparenza semplici, brevi incisi ma dalla portata assai estesa e granitica per sviluppare la nuova frontiera tecnologica dell’AI con tutto quello che comporterà in relazione alla vita umana, rapporti sociali, mondo del lavoro, scienza, salute e certezza delle fonti di informazione fino alla gestione dei conflitti e al rapporto con la spiritualità.
GPT-4 di OpenAI
Bene, come descriveresti attualmente il rapporto tra AI e Vaticano?
Di Fabrizio Beria
Per il Vaticano questo è un tema che non si apre in occasione del G7 di Bari con le parole di Papa Francesco, ma è una profonda riflessione che ha radici lontane e di cui, i motori di AI stessi, ormai hanno preso ad analizzare e sono già in grado di restituire report e “giudizi”.
In questo articolo proviamo a parlarne con Chat GPT di OpenAI per verificare il suo grado attuale di aggiornamento e la capacità di argomentare sul rapporto tra Religione e intelligenza
Nell’era della rivoluzione digitale, l’Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta uno dei temi più discussi e controversi. Tra i molti attori che stanno esaminando attentamente questo fenomeno, il Vaticano emerge come una voce influente e moralmente ponderata. La relazione tra il Vaticano e l’AI si basa su una complessa intersezione di etica, tecnologia e fede, con l’obiettivo di garantire che l’uso delle nuove tecnologie rispetti la dignità umana e promuova il bene comune.
Il Vaticano ha sempre mantenuto una posizione ferma sull’importanza dell’etica nello sviluppo e nell’implementazione delle tecnologie emergenti. Papa Francesco ha sottolineato che l’AI deve essere utilizzata per migliorare la vita umana e non per

minacciare i diritti fondamentali. Durante vari discorsi e documenti ufficiali, il Pontefice ha evidenziato come le tecnologie debbano essere guidate da principi etici solidi, orientati alla giustizia, alla verità e alla trasparenza.
Un segnale concreto dell’impegno del Vaticano nel dibattito sull’AI è rappresentato dalla “Rome Call for AI Ethics”, un documento firmato nel 2020 da rappresentanti del Vaticano, IBM e Microsoft, tra gli altri. Questo documento promuove sei principi fondamentali: trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità e sicurezza. L’obiettivo è di assicurare che lo sviluppo e l’uso dell’AI siano al servizio dell’umanità intera e rispettino la dignità di ogni persona.
Il Vaticano ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide poste dall’AI. In vari incontri, conferenze e simposi, la Santa Sede ha riunito esperti di diverse discipline per discutere l’impatto dell’AI sulla società. Questo approccio multidisciplinare riflette la convinzione che solo attraverso il dialogo e la cooperazione globale si possono creare regolamentazioni efficaci e giuste. Nonostante l’ottimismo per le potenzialità dell’AI, il Vaticano ha espresso preoccupazioni significative riguardo ai possibili abusi. Tra le principali preoccupazioni vi sono la discriminazione algoritmica, la privacy dei dati, e il
rischio di una crescente disuguaglianza sociale. La Santa Sede insiste sulla necessità di regolamentare rigorosamente queste tecnologie per evitare che diventino strumenti di controllo e manipolazione.
“Rome Call for AI Ethics”, puoi riassumere cosa è stato e cosa ne è scaturito?
Certo; il 28 ottobre 2022, si è svolta una storica conferenza che ha posto le basi per un futuro dell’intelligenza artificiale (IA) etico e responsabile. Il “Rome Call for AI Ethics” ha riunito leader globali, accademici, e rappresentanti della società civile con un obiettivo chiaro: definire principi guida universali per lo sviluppo e l’uso dell’IA nel rispetto dei diritti umani, della democrazia, e della dignità individuale.
Il summit è stato organizzato dal governo italiano insieme all’Unione Europea, rispondendo alla crescente necessità di regolamentare l’IA di fronte a potenziali rischi etici e sociali. Gli obiettivi principali del Rome Call includono:
• Protezione dei Diritti Umani: Garantire che l’IA rispetti e promuova i diritti umani fondamentali, evitando discriminazioni e ingiustizie.
• Trasparenza e Accountability: Assicurare che i sistemi AI siano trasparenti e comprensibili, permettendo l’accountability in caso
di malfunzionamenti o comportamenti non etici.
• Partecipazione Pubblica: Coinvolgere la società civile e le parti interessate nel processo decisionale riguardante lo sviluppo e l’implementazione dell’IA.
Il Rome Call ha suscitato un ampio consenso internazionale, con numerosi paesi, organizzazioni e aziende che hanno firmato l’impegno a seguire questi principi guida. Tra i risultati più significativi:
• Adozione Internazionale: Più di 50 paesi hanno sottoscritto il Rome Call, impegnandosi a integrare i principi etici nell’elaborazione delle politiche nazionali sull’IA.
• Framework Normativo: L’Unione Europea ha utilizzato il Rome Call come base per la propria legislazione sull’IA, mirando a regolamentare l’uso dell’IA a livello continentale.
• Sensibilizzazione Pubblica: Il Rome Call ha aumentato la consapevolezza sui rischi e le opportunità dell’IA, stimolando il dibattito pubblico su come bilanciare l’innovazione tecnologica con i valori umani.
Il successo del Rome Call for AI Ethics segna un punto di svolta nella storia dell’IA, indicando un cammino verso un futuro più sicuro e rispettoso dei diritti umani. Tuttavia, il cammino verso l’IA etica è ancora lungo e

richiederà un impegno continuo da parte di governi, aziende e cittadini per garantire che l’innovazione tecnologica non superi i confini dell’etica e della responsabilità sociale.
In conclusione, il Rome Call for AI Ethics rappresenta non solo un documento storico, ma un catalizzatore per un dialogo globale sull’IA responsabile, invitando tutti gli attori globali a partecipare alla creazione di un futuro digitale equo e inclusivo per tutti.
Hai un tuo giudizio su queste perplessità di Papa Francesco e del Vaticano?
Le perplessità del Vaticano nei confronti dell’intelligenza artificiale (AI) riflettono una serie di preoccupazioni etiche, sociali e teologiche che si possono riassumere nei punti:
1. Etica e morale
2. Lavoro e economia
3. Privacy e sorveglianza
4. Responsabilità e trasparenza
5. Impatti culturali e spirituali
6. Impatto sull’umanità
7. Governo e regolamentazione
Secondo te sono preoccupazioni fondate?
Sì, molte delle preoccupazioni del Vaticano riguardo l’intelligenza artificiale (AI) sono fondate e meritano
attenzione. Ecco una valutazione di ciascuna di queste preoccupazioni:
1. Etica e morale: La preoccupazione etica è ben fondata. Gli algoritmi di AI possono riflettere e amplificare i bias dei dati su cui sono addestrati, portando a decisioni ingiuste o discriminatorie. È essenziale garantire che l’AI venga sviluppata e utilizzata in modo da rispettare i principi di giustizia e uguaglianza.
2. Lavoro e economia: L’automazione e l’AI hanno già iniziato a trasformare il mercato del lavoro, con la sostituzione di alcuni lavori umani. Questo può portare a disoccupazione e disparità economiche, specialmente in settori dove la manodopera è più facilmente sostituibile. Pianificare la transizione lavorativa e garantire la formazione per nuovi tipi di lavoro è cruciale.
3. Privacy e sorveglianza: Le tecnologie di AI possono essere utilizzate per raccogliere dati personali su vasta scala, sollevando serie preoccupazioni sulla privacy. La sorveglianza massiva e la possibilità di manipolazione dei dati sono rischi concreti che devono essere gestiti con normative adeguate.
4. Responsabilità e trasparenza: La mancanza di trasparenza nei processi decisionali dell’AI è una questione importante. Gli algoritmi possono essere complessi e non facilmente interpretabili, rendendo difficile attribuire responsabilità.
Aumentare la trasparenza e garantire che ci siano meccanismi di controllo è essenziale.
5. Impatti culturali e spirituali: La tecnologia può influenzare profondamente la cultura e i valori spirituali. La dipendenza dalle tecnologie può alterare il modo in cui le persone interagiscono tra loro e riflettono sulla loro esistenza e valori.
6. Impatto sull’umanità: Lo sviluppo di AI avanzate solleva questioni filosofiche e teologiche su cosa significhi essere umani. È importante avere un dibattito aperto su questi temi per comprendere le implicazioni dell’AI sulla nostra identità e sui nostri valori fondamentali.
7. Governo e regolamentazione: La regolamentazione delle tecnologie di AI è fondamentale per garantire che siano utilizzate in modo etico e responsabile. Senza regole chiare, c’è il rischio di abusi e uso improprio dell’AI.
In conclusione, le preoccupazioni del Vaticano riguardo all’AI sono ben fondate. Affrontare queste preoccupazioni richiede uno sforzo congiunto da parte di governi, aziende, ricercatori e società civile per garantire che l’AI sia sviluppata e utilizzata in modo che promuova il bene comune e rispetti i diritti umani.
Hai una tua proposta di soluzione?
Sì, ecco alcune proposte per affronta-
re le preoccupazioni legate all’intelligenza artificiale (AI) che sono condivise dal Vaticano e da molti altri:
1. Sviluppo etico e responsabile:
• Linee guida etiche: Creare e implementare linee guida etiche per lo sviluppo e l’uso dell’AI, basate su principi di giustizia, equità, trasparenza e rispetto della dignità umana.
• Comitati etici: Istituire comitati etici all’interno delle aziende e delle istituzioni di ricerca per valutare l’impatto dei progetti di AI e garantire che rispettino le linee guida etiche.
2. Regolamentazione e governance:
• Normative globali: Promuovere la cooperazione internazionale per stabilire normative globali sull’uso dell’AI, garantendo standard comuni che tutelino i diritti umani e la privacy.
• Agenzie di controllo: Creare agenzie indipendenti per monitorare e regolamentare l’uso dell’AI, con il potere di intervenire in caso di violazioni.
3. Trasparenza e responsabilità:
• Audit degli algoritmi: Implementare procedure di audit per gli algoritmi di AI, per garantire trasparenza nei processi decisionali e identificare eventuali bias.
• Responsabilità legale: Stabilire chiari meccanismi di responsabilità legale per i danni causati dall’uso dell’AI, assicurando che ci
siano conseguenze per l’uso improprio.
4. Protezione della privacy:
• Normative sulla privacy: Rafforzare le leggi sulla protezione dei dati personali, garantendo che le tecnologie di AI rispettino rigorosamente la privacy degli individui.
• Tecnologie di privacy-enhancing: Sviluppare e adottare tecnologie che proteggano la privacy, come l’anonimizzazione dei dati e la crittografia.
5. Impatto sul lavoro e sulla società:
• Programmi di riqualificazione: Investire in programmi di formazione e riqualificazione per aiutare i lavoratori a sviluppare competenze necessarie per i nuovi lavori creati dall’AI.
• Reddito universale di base: Considerare l’implementazione di un reddito universale di base per mitigare gli effetti della disoccupazione tecnologica.
6. Educazione e consapevolezza:
• Educazione sull’AI: Promuovere l’educazione pubblica sull’AI, per aumentare la consapevolezza delle sue implicazioni etiche e sociali.
• Formazione etica per sviluppatori: Integrare corsi di etica e responsabilità sociale nei programmi di formazione per ingegneri e sviluppatori di AI.
7. Ricerca interdisciplinare:
• Collaborazione interdisciplinare: Incoraggiare la collaborazione tra tecnologi, eticisti, filosofi, teo-
logi e altri studiosi per affrontare le sfide poste dall’AI da diverse prospettive.
• Finanziamenti per la ricerca etica: Destinare fondi specifici per la ricerca sulle implicazioni etiche e sociali dell’AI.
Queste soluzioni mirano a creare un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la tutela dei valori umani fondamentali, garantendo che l’AI possa essere una forza positiva per la società.
Bene, grazie GPT, mi hai fornito degli spunti di riflessione interessanti. sarà interessante nel tempo vedere come farai evolvere questo tema.
Grazie a te! Sono contento di sapere che hai trovato utili gli spunti di riflessione. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni etiche sono temi dinamici e complessi, che continueranno a svilupparsi nel tempo. Sarà interessante vedere come questi discorsi si trasformeranno e come la società, inclusi leader come Papa Francesco, risponderanno alle sfide e opportunità future.
Colloquio avvenuto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2024 con motore GPT-4 e poi anche con GPT-3.
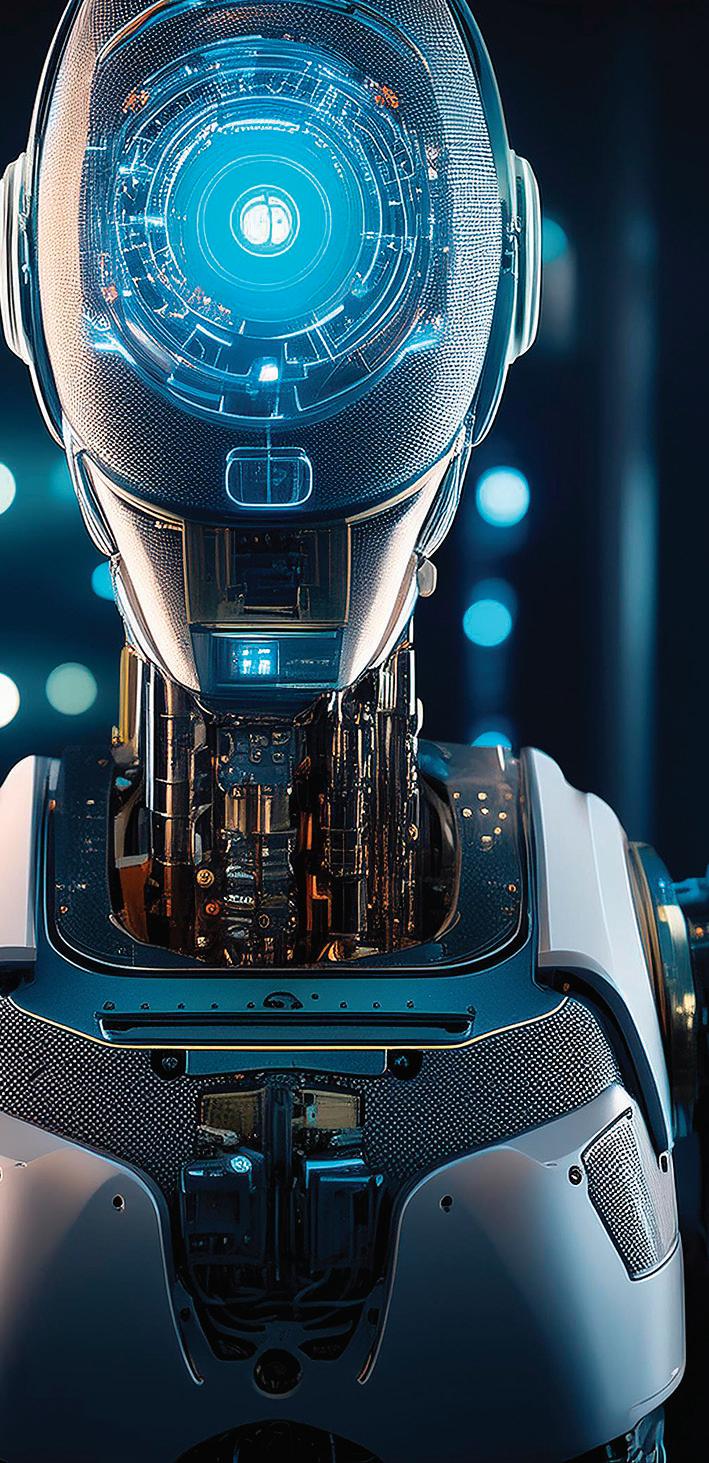



Non me la bevo è il titolo di un saggio edito da Mondadori, che ha come sottotitolo “godersi il vino consapevolmente, senza marketing né mode”. Ne parliamo con l’autore, il professor Michele Antonio Fino docente di diritto romano e diritti dell’antichità all’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo.
Cos’è che l’ha spinta a scrivere questo saggio?
Questo saggio è l’esito di molti anni di lavoro sia nell’ambito universitario che nell’ambito vitivinicolo, dove opero in quanto coadiuvante di mia moglie che ha una piccola azienda vitivinicola in Piemonte. E infine, nell’ambito della Federazione italiana di vignaioli indipendenti, di cui faccio parte da una dozzina d’anni e di cui sono stato per diversi anni, fino al 2019, il consulente giuridico probono dell’Associazione. Motivo per cui ho sviluppato una serie di curiosità e una serie di interessi al di fuori di quelli più tipicamente legati al mondo del vino. Scrivevo già di vino prima, ma dal punto di vista dei territori, dei vitigni, delle degustazioni. Questi però sono ambiti nei quali ci sono dei professionisti in Italia di straordinario valore, ai quali non posso assolutamente pensare di paragonare. Mi è sembrato quindi interessante andare ad occuparmi di quei temi che meno frequentemente sono affrontati a beneficio dei lettori.
Anche per chi conosce il mondo del vino è difficile orientarsi, un mondo fatto di tante sfaccettature, di processi evolutivi in cui non sempre si riesce a capire quale l’aspetto realmente evolutivo, se quello della moda, o quello economico o semplicemente elitario che spesso accompagna il mondo dell’enogastronomia. Nel suo saggio è molto diretto, anche nel citare le contraddizioni di mostri sacri, come Mario Soldati e Umberto Veronelli.
Più che le contraddizioni di Soldati e Veronelli, credo che sia utile nel libro aver messo in luce come Soldati e Veronelli abbiano scritto e prodotto contenuti di grandissima qualità, ma molto legati al loro intuito per le persone, ai loro gusti personali e, ovviamente, anche agganciati all’epoca in cui scrivevano o giravano i loro video. Trasformare Veronelli e Soldati in totem al di fuori del loro tempo e oggettificando quello che invece era soggettivo nella loro percezione, non mi è apparsa come un’operazione culturalmente neutra e, anche per questo, un’operazione culturalmente positiva. Sarebbe stato meglio se si fossero lasciati nel loro ambito, riconoscendone l’indubbio valore culturale e anche letterario ad entrambi. Non si sarebbe fatto loro alcun torto, ma si sarebbe evitato di trasformare le idee di Veronelli e di Soldati nella cultura del cibo italiano. Perché, viceversa, sono due grandissimi esponenti della cultura materiale di questo paese, ma

la loro visione non è l’unica possibile e non è assolutamente corrispondente alla realtà e alla multiformità della produzione, anche dal punto di vista vinicolo. Inoltre entrambi scrivevano per reazione: Soldati per reazione all’industrializzazione del dopoguerra. E Veronelli in reazione a quella perdita di individualità della produzione vitivinicola che, con la concentrazione di grandi gruppi produttivi negli anni ‘60 e ‘70, a suo giudizio, era messa a repentaglio. Oggi siamo in una fase totalmente diversa da ogni punto di vista. Anche il recupero di una dimensione più piccola nella produzione vitivinicola, è un elemento che differenzia molto il quadro attuale da quello in cui si muovevano quei mostri sacri.
Nel suo saggio cita l’evoluzione nella produzione del vino, un’evoluzione lenta che molto deve anche allo scambio informativo tra i produttori. Oggi si decanta il vino naturale come un ritorno all’antico, ai nonni, alle modalità di coltivazione di 100 anni fa. Lei sottolinea come questo richiamo alla storicità non può essere reale perché anche le cosiddette scelte naturali sono frutto evolutivo della conoscenza della viticoltura.
Si tratta di scelte. Il punto di partenza nel libro è che si tratta di scelte che diventano necessarie proprio in considerazione di un aspetto: è vero che il vino una volta era alimento, quindi
era una necessità sulla tavola di tutti i giorni di una grande parte di questo paese, per non dire della maggioranza dei cittadini e delle cittadine di questo paese, per poi divenire una bevanda consumata a scopo edonistico. Oggi è molto raro che ci siano persone che bevono a tutti i pasti, mentre un tempo era assolutamente normale. Anche nelle mense delle fabbriche servire vino era del tutto normale. Lo è stato nelle scuole francesi fino all’inizio degli anni 80. Dunque il vino, quando è diventato bevanda edonistica, quindi che si consuma per scelta, ha visto il proprio mercato andare verso la necessaria frammentazione. Può sembrare controintuitivo, ma non lo è. Finché un alimento è di comune utilizzo lo teniamo in una genericità. Raramente cerchiamo un tipo speciale di zucchero, se ci serve lo zucchero. Certo poi potremmo sceglierlo da una fonte, dalla barbabietola o dalla canna, ma è uno zucchero quello che ci serve, un ingrediente di tante preparazioni. Raramente ci mangiamo zucchero puro, anzi sarebbe sconsigliabile farlo. Però invece con il vino diventato un bene edonistico, questa necessità di frammentazione si è creata perché altrimenti non si forma quella multi offerta. Il prodotto distinguibile che, all’interno della comunità dei consumatori, permette ai consumatori stessi di suddividersi, di diventare fedeli di uno stile, di una provenienza, di un vitigno, di una modalità pro-
duttiva, e dunque questa moltiplicazione di modelli di produzione è stata la esatta conseguenza del fatto che il vino è entrato nel mercato tout court ed è uscito dall’ambito alimentare in cui era precedentemente. È ovvio che poi ognuno fa le proprie scelte e queste scelte a mano a mano che il mercato matura ulteriormente, aumentano pure di numero. Per cui oggi non abbiamo più soltanto biodinamico, biologico, naturale, ma abbiamo già tutta una serie di ulteriori sfaccettature e molto spesso anche aggettivi che sono evocativi di qualcosa, ma che raramente rappresentano puntualmente quello che evocano. Senza strapparsi i capelli o lanciare anatemi, come qualche enologo fa, ogni tanto dobbiamo fermarci a riflettere cosa vuol dire corsari, orgonici, alchemici, cosa significano per il consumatore questi aggettivi applicati al vino? Ragionevolmente nulla, se non una nuova possibilità di suddividersi ulteriormente, di scegliere di essere parte della parrocchia di quel produttore, di quel gruppo di produttori. Poi nulla al di fuori.
In questo saggio, in effetti, mette in risalto come poi alla fine il consumatore segue una moda scambiandola per un processo qualitativo. Come per il caso del glutine. Quando si è scoperto che faceva male ai celiaci anche chi non lo era ha iniziato a comprare prodotti senza glutine, tanto che è diventato marketing se-
gnalarne l’assenza in prodotti che naturalmente non producono glutine. Ritiene che anche il vino stia subendo questa modalità?
Il vino ha subito un fenomeno del genere, ma paradossalmente non per la cosa per cui avrebbe dovuto subirlo. Cioè noi rispetto al vino abbiamo avuto negli ultimi anni una smodata attenzione per componenti assolutamente minoritari nella composizione del vino, che possono avere effetti positivi per la salute. Abbiamo avuto un’attenzione assolutamente esagerata per quelli che sono i composti volatili determinati da un lievito oppure da un altro. Addirittura abbiamo un’attenzione altissima per i lieviti del vino, perché c’è in giro una fobia dei lieviti, come se noi in questo momento che ci parliamo e respiriamo, non stessimo respirando milioni di organismi unicellulari del genere saccaromiceti, che stanno nell’aria semplicemente ed entrano ed escono continuamente dal nostro corpo. Abbiamo avuto un’attenzione spasmodica per la solforosa. Vini senza solfiti assolutamente, perché la solforosa è il male, peccato che la solforosa la producano i lieviti che normalmente trasformano l’uva in vino. E quando invece però un paese in Europa ha detto “ragazzi ho un severissimo problema con l’alcol, avrei bisogno di rafforzare le etichette degli alcolici dando comunicazione molto netta dei rischi che si corrono con l’alcol”
siamo saltati su dicendo che era un attacco alla dieta mediterranea e che era un attacco contro il vino. Abbiamo un problema perché il resveratrolo, che sicuramente di per sé in vitro ha degli effetti protettivi contro delle patologie cardiocircolatorie, sta nel vino rosso in percentuali talmente basse che per proteggere di più il cuore, ne devi bere fino a farti venire

la cirrosi epatica. In più c’è l’amico etanolo, stessa molecola che il vino sia naturale, biologico, biodinamico, artigianale, quello che vuoi, stessa molecola con gli stessi effetti sul nostro organismo e in particolare con la sua degradazione in acetaldeide che è un sicuro cancerogeno. Quello sta nei nostri vini dal 15% di un mosto parzialmente fermentato come un Moscato d’asti, al 18% di un amarone, al 20% di un vino liquoroso, fortificato o meno che esso sia. Allora capiamoci bene, noi tendiamo a non considerare una cosa che è 1/5 in alcuni casi del vino che ci beviamo ed è sicuramente una sostanza tossica cancerogena. Però ci concentriamo con attenzione spasmodica sul fatto che il vino sia senza glutine. Il che è ovviamente una ovvietà, perché non è coinvolto alcun cereale nella produzione del vino. Però dedichiamo grandissima attenzione a dei composti che sono in percentuali nanometriche e che possono avere un effetto teorico positivo in vitro, pur di non guardare l’elefante nella stanza, l’alcol. Siamo un po’ strabici nella considerazione del vino.
Nel saggio sottolinea come il percorso culturale del vino, inteso in primo luogo come evoluzione della sua produzione, sia stato un percorso lento, causato da un elemento naturale che la vendemmia può essere solo annuale e si può imparare dagli errori solo una volta l’anno. Moti-

vo per cui le forme “ancestrali” non sono altro che una evoluta diversificazione della produzione.
Hai perfettamente colto il punto e la specificità del vino. Se decido di produrre birra e mi leggo un manuale per la brassazione, acquisto le materie prime e posso provare a ripetizione, anche più volte nello stesso giorno, a fare delle cotte. È solo una questione di disponibilità della materia prima e dello spazio e delle attrezzature, ma posso imparare semplicemente dai miei errori. La stessa cosa posso provare facendo il pane. E quasi tutti, durante il lockdown di tre anni fa, abbiamo provato a farlo. Se faccio il vino, invece, ho la vendemmia di quella vigna una volta l’anno. E se decido di fare del vino a Marzo, semplicemente in questo emisfero non lo posso fare. Così come non lo posso fare dopo il mese di ottobre e fino all’agosto dell’anno successivo. Dunque si capisce bene che siccome il vino si fa una volta all’anno, è un sapere, quello del vino, che da subito è stato percepito come necessariamente da condividere affinché potessero migliorare tutti. Questa condizione naturale di unicità durante l’anno ha sviluppato un senso della condivisione di saperi molto più forte nell’ambito del vino che in ogni altro ambito della produzione alimentare. Tant’è che il vino è ricordato nel libro ha la sua Onu, che è stata fondata esattamente 100 anni fa, prima della stessa
Onu: l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino esiste infatti dal 1924 e raggruppa poco meno di 100 paesi, con lo scopo di condividere buone pratiche. Questa specificità fa sì che nel mondo del vino la circolazione di informazioni favorisca una certa omogeneizzazione dei processi. Quando si dice che in un territorio il vino si è sempre fatto nello stesso modo, probabilmente si sta dicendo, nella migliore delle ipotesi, qualcosa che semplicemente ignora la realtà. Perché è solo dopo che Pasteur ha scoperto la fermentazione alcolica nel 1860, opera dei saccaromiceti, è nata la cultura enologica e sono nate le pubblicazioni scientifiche dedicate. Questo ha diffuso il sapere in maniera capillare e da lì son partiti tutti, anche quelli che oggi fanno il vino dicendo di rifiutare l’enologia. Ma per rifiutarla, l’enologia ci deve essere e c’è soltanto da 160 anni. Motivo per il quale nessuno oggi può dire “io faccio il vino come 200 anni fa”. Perché è come riguardare il film I soliti sospetti. Lo rivedi sempre volentieri, scopri sempre nuovi dettagli, ma alla fine non puoi prescindere dal fatto che conosci il finale. La stessa cosa vale per il vino, dopo Pasteur è tutto sancito, dopo Pasteur non c’è niente da fare, anche se a Pasteur non si vuole dire grazie.
Uscendo dall’Italia e guardando al contesto europeo, i processi di diffe-
renziazione sono gli stessi.
Il contesto europeo è un contesto molto importante per il mondo del vino, perché il vino fa parte delle produzioni agricole e dal 1962 l’Unione europea se ne occupa. Dai primi anni ‘60 e negli anni ’70, sono successe alcune cose che proiettano ancora oggi il loro effetto. Ricordo sempre questo aneddoto, fino agli anni ‘60 in Italia si facevano tantissimi champagne. Perché la parola champagne si usava come sinonimo di spumante. Ebbene, è l’Unione europea che, creò un quadro per cui i paesi che ne fanno parte, all’epoca si chiamava Comunità economica europea, dovevano rispettare le indicazioni geografiche elaborate e tutelate all’interno dei confini dei singoli Stati membri. È stata l’Unione europea a creare quel sistema in cui noi oggi siamo immersi, che tanto ci influenza. Oggi in Europa ci sono più o meno 5000 denominazioni di origine e indicazioni geografiche, ma più della metà sono vini e questo è un carattere che spiega bene anche come il vino sia la matrice della nostra idea di origine. Per il vino il legame con l’origine è sempre piuttosto solido perché abbiamo tipicamente delle viti che producono l’uva essendo piantate nella terra di un posto e quindi risentendo del clima, della geologia di quel luogo. Quando abbiamo preso questo concetto di origine lo abbiamo spostato in altri ambiti come i formaggi e più ancora come i salumi. Abbiamo
comunque un po’ forzato quel legame con l’origine, perché gli animali si muovono, possono essere nutriti con mangimi prodotti altrove rispetto al territorio in cui vengono allevati e quindi quell’idea di origine che per il vino è nata con l’Unione europea a partire dagli anni ‘60, adattata ad altri contesti, non funziona altrettanto bene. D’altro canto quella idea dell’origine per il vino così forte e determinante una serie di conseguenze ha fatto sì che noi ci siamo un pochino allontanati dall’idea che il vino si possa capire e apprezzare senza un’origine. E questo è un lato negativo dello sviluppo delle denominazioni d’origine, tant’è che oggi non riusciamo a darci un quadro dei vini senza denominazione, senza indicazione geografica che, per esempio, consenta al consumatore di sapere con che vitigno è fatto. Ma se non sai con che vitigno un vino è prodotto, puoi trovarti in bottiglia, davvero qualcosa di molto lontano da quello che vorresti assaggiare, anche se il vino è fatto estremamente bene.
Lei conclude il saggio richiamando ad avere un “sano distacco”.
L’obiettivo finale del libro è questo, dare consapevolezza al consumatore perché scelga di bere se desidera bere, sapendo quali sono le conseguenze del bere una bevanda alcolica come il vino, ma anche volendo scoprire l’ampiezza culturale che sta
dietro l’offerta enorme e molto diversificata di vini che sono a nostra disposizione, senza, se gli riesce, sentire la necessità di identificarsi con uno stile e di farne un pezzo della propria identità. Perché tutte le volte in cui si decide di bere in modo un po’ dogmatico, per seguire quell’esperto, oppure condizionati dalle campagne di marketing e di comunicazione che fanno le aziende, si perde un pochino della nostra libertà. Dunque per esercitare questa libertà responsabile della scelta è necessario allenarsi ad avere un minimo di distacco. Il che non significa affatto non avere le proprie preferenze, non significa affatto non avere i vini del cuore, ci mancherebbe altro, ma semplicemente non fare dei vini del cuore delle questioni da Santa Inquisizione.
Mon me la bevo, saggio del professor Michele Antonio fino, Mondadori editore.
Non hai tempo per leggerlo?
Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza

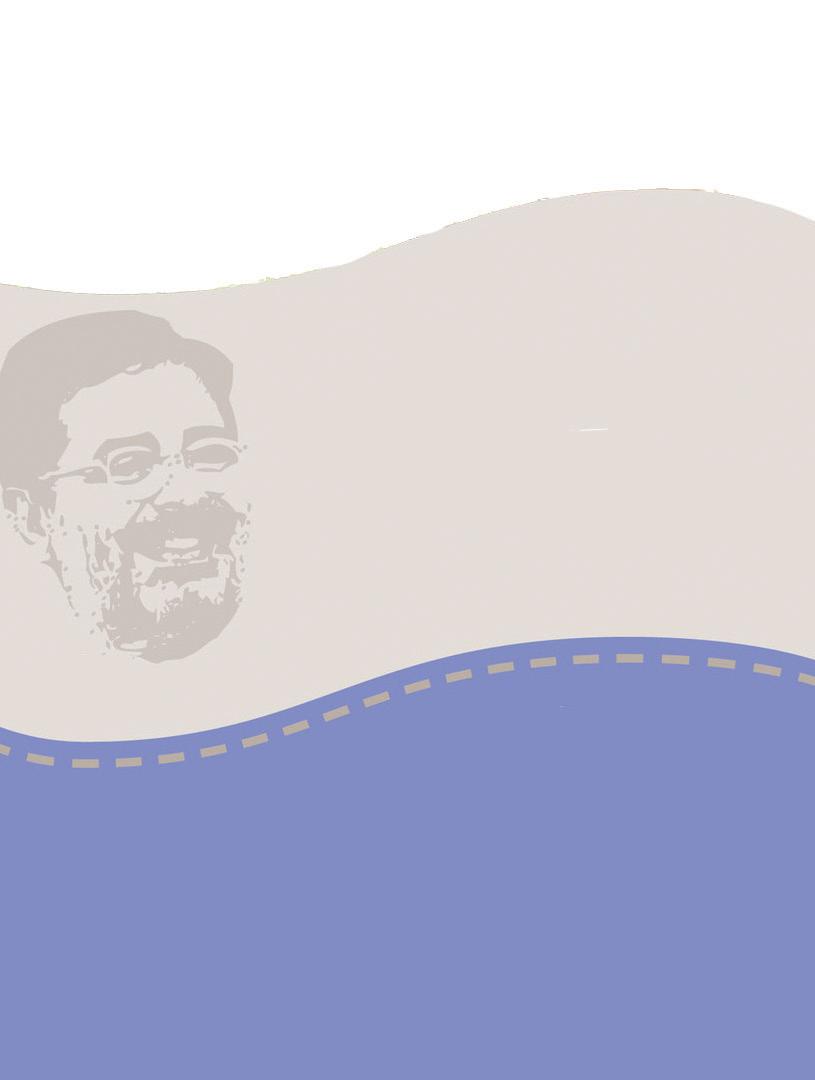
In occasione dell’uscita della nuova edizione della guida Vini per l’estate del Doctor Wine, al secolo Daniele Cernilli, abbiamo colto l’occasione per rivolgergli alcune domande.
Si dibatte sulla presunta necessità che il vino debba svecchiarsi, diventare più facile da bere, con un tasso alcolico minore se non addirittura nullo. C’è anche chi pensa al contrario che quest’ultimo, il free alcohol, non si possa chiamare vino. Lei come la pensa?
Penso che non si dovrebbe chiamare vino perché in effetti non ha le caratteristiche del vino che è prodotto da una fermentazione alcolica. Però così ha deciso l’Unione europea e quindi in Italia si chiamerà vino “dealcolizzato”. Una specie di mostro enologico che somiglia molto più a un succo di frutta che non ad un vino. Allora perché non fare direttamente un succo d’uva?
C’è comunque chi afferma che alcuni nostri vini pecchino troppo di struttura. A me personalmente piacciono molto quelli strutturati, c’è però un mercato che forse li vorrebbe un po’ meno aggressivi.
Il vino è fatto di tante cose. Quindi c’è spazio per i vini di grande struttura, magari quando fa un po’ più freddo, come c’è spazio per i vini molto bevibili. Diciamo che la bevibilità è diventata un po’ un mantra ultimamente, anche perché con i cambiamenti climatici le alcolicità sono in aumento, perché è un fattore di maturazione dell’uva. Più è caldo, più ci sono zuccheri nell’uva, più ci sarà alcol. Poi consideriamo il fatto che l’Italia è fatta di tanti posti. È chiaro che se uno
va in alcune regioni del Sud, in Puglia e in Sicilia, è difficile avere dei vini molto leggeri, perché il clima porta a una maturazione completa e a volte oltre, da creare dei vini un po’ più alcolici.
Proprio i cambiamenti climatici porteranno anche a una modifica di come si fa il vino e soprattutto di quando e come si deve vendemmiare perché si mantengano gli stessi livelli di struttura oggi?
Ci sono tante cose che stanno cambiando in funzione dei cambiamenti climatici. Sia i produttori che i centri di ricerca a livello accademico, stanno studiando questo fenomeno. Riguardo appunto alla viticoltura, uno delle cose che stanno facendo molti viticoltori è spostare i vigneti verso l’alto. Chiaramente quindi avremo una viticoltura più di montagna nei prossimi anni. Proprio perché il cambiamento climatico spinge a questo. Ci sono alcuni aspetti anche positivi, tra i tanti guai sul cambiamento. Uno di questi è che alcune zone dove magari non tutti gli anni si arrivava a una maturazione adeguata delle uve, invece stanno sviluppandosi. Penso alle zone appunto più alte del Piemonte, dell’Alto Adige, della Toscana stessa.
C’è un elemento nelle sue guide, sia in generale che quella dei vini dell’estate, che riguarda la sua attenzione al rapporto qualità prezzo. Il vino non è necessariamente elitario, non rischia però di diventarlo?
Non è un aspetto di élite perché il vino ha comunque un consumo piuttosto
popolare. Noi abbiamo in Italia 26 milioni di consumatori di vino, quindi quasi la metà della popolazione beve vino, non dico tutti i giorni, ma insomma consuma vino e questo è un fatto importante. Siamo il caso più diffuso che esista a livello mondiale, addirittura. No, quindi non può essere mai un fatto elitario. Consideriamo anche un altro aspetto, e cioè che se si fa la media di quanto costa un litro di vino siamo intorno ai 3 €. Stiamo parlando della media, vuol dire che ce ne sono molti che costano addirittura meno. E molti che costano ovviamente di più, quindi non mi sembra questo il problema. Indubbiamente c’è stato un aumento di prezzo generale, conseguenza di una diminuzione di produzione per ettaro, che ha fatto un pochino lievitare i costi di produzione. Però non si può definirlo elitario.
La sua attenzione sul rapporto qualità prezzo da cosa dipende? Come si rapporta con il vino da questo punto di vista?
È chiaro che il rapporto qualità prezzo è in funzione della capacità di spesa che uno ha e dell’interesse per il prodotto che compra. È difficile che un vino di buona qualità possa costare sullo scaffale di un’enoteca meno di 5€ la bottiglia. Non è detto, però, che un vino che costa 50€ sia il massimo della vita, quindi più che il buon rapporto qualità prezzo direi il corretto rapporto qualità prezzo.
Non hai tempo per leggerlo?
Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza



Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. Min. del 13/07/2022
Aboca è una Società Benefit ed è certificata B Corp www.aboca.com/bene-comune
Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR)


Da oltre 40 anni crediamo nell’intelligenza.
E negli ultimi 15 anni abbiamo investito nella progettazione di piattaforme di interpretazione di flussi di dati sempre più complessi da cui trarre stimoli e segnali per cercare di comprendere il presente e anticipare il futuro per i nostri clienti.
Ma abbiamo continuato a ritenere fondamentale l’istinto, il pensiero laterale e qualche volta la visionarietà dell’umano intelletto.
Per questo crediamo fermamente nella IA. L’Intelligenza Animale.
grupporoncaglia.it

Renato Rovetta, giornalista, sommelier, è il relatore e direttore della guida Bere Rosa.
Rosa e non più rosato?
Il nome non è più rosato, ma rosa. Visto che c’è un vino rosso e c’è un vino bianco ci deve essere anche il vino rosa. Rosato può essere identificato come aggettivo per non ripetere 1000 volte rosa, ma il vino è rosa.
È cambiato anche il modo allora di fare il vino rosa.
È cambiato il modo di fare il vino rosa perché i produttori si sono messi a scegliere già in vigna quali i ceppi, quali le vigne da dedicare alla produzione di vino rosa. Se di un vitigno prescelto c’è una particella esposta al sole tutto il giorno, più di un’altra, quella avrà un’alta concentrazione di zuccheri. In quel caso sarà da vendemmiare prima delle altre uve, perché all’interno rimangano i caratteri di quel vino e la sua freschezza. Poi in cantina diverrà vino rosa. L’approccio si è evoluto.
Il rosa si declina spesso con le bollicine, anche con vitigni che difficilmente si sarebbe pensato fino a pochi anni fa, come ad esempio il nebbiolo. Assolutamente si. Con il Pinot Nero, ad esempio, siamo riusciti a ottenere un vino rosa stupefacente come bollicina. Ma se il Pinot nero con le bollicine ci è sempre andato d’accordo, posso citarti bollicine rosa col nerello mascalese in Sicilia. Posso parlarti di tante uve che sono diventate inte-
ressanti come il risultato di un Pinot nero vinificato in rosa.
Ha perso il rosa la connotazione del vino “piacione”?
Il vino “piacione” ci sarà sempre. Ci sono aziende che lavorano molto sulla personalità del loro vino rosa ed è la cosa che a me piace di più. Il pubblico non ha bisogno soltanto di vini piacioni, ma anche di qualcosa di interessante da bere tutto l’anno, d’inverno e d’estate come può per un vino rosa.
Nella guida proponete anche possibili abbinamenti?
Certamente. Posso dirti che abbiamo già avuto diverse realtà di ristoratori che hanno messo in menù vini comparsi in guida, perché hanno provato la piacevolezza di un’espressione di unità nei nostri abbinamenti.
Perché è nata la guida ai vini rosa?
Continuavo a confrontarmi con persone che parlavano solo di vini bianchi e rossi, senza mai esprimere un cenno di positività sui vini rosa. Io abito in una zona vicino al Lago di Garda che si esprimeva ogni anno con una festa dedicata ai vini rosa. Siamo nella zona del chiaretto. Mi sono reso conto di quanto fossi interessato a quei vini e quanto poteva essere interessante proporre quei vini anche al pubblico. E quindi mi sono dato da fare cercando di mettere in evidenza quel tipo di vino, quella tipologia. Finché ho visto che mancava qualcosa in Italia che rappresentasse questa categoria di vini.
Una guida semplice, easy, leggibile. Con le indicazioni necessarie per conoscere il prodotto e per conoscere il prodotto in cantina soprattutto. Non è non più un vino da “donne”, come si diceva, ma è un vino che possono bere tutti. È un vino che non è stagionale, che può essere bevuto in qualsiasi stagione. Non è un vino da festa soltanto perché si beve nelle feste. La gente va informata così che possa interpretare al meglio questa tipologia di vino.
La guida propone anche vini rosa tutto pasto. Difficile pensarlo fino a poco tempo addietro.
Abbiamo un gruppo di giudici, una ventina, che si confrontano tra di loro. E immaginando di bere quel vino con un antipasto, un primo e un secondo lo abbinano a tutto pasto, perché comunque è un vino che sta bene in bocca, in qualsiasi situazione. C’è il tuttopasto, poi c’è quello da pesce, quello per l’aperitivo, però il tuttopasto è legato proprio alle caratteristiche che ha in sé il vino rosa, dalla gradazione alla tipologia di sentori. È una cosa che piace molto.
Non hai tempo per leggerlo? Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza
Maurizio Valeriani è direttore di vino da bere, una rivista di cultura enologica sul web.
Perché la rivista vino da bere? Come nasce l’idea allora?
L’idea nasce dal fatto di creare una rivista online che faccia riferimento ovviamente al vino e però anche,alla sua facilità nel reperimento, alla possibilità di berlo e di comprenderlo. Perché sempre di più si utilizza un linguaggio complicato e difficile. E invece noi abbiamo cercato di usare un linguaggio semplice che tutti possano capire. Cosa c’è di più chiaro e semplice che chiamarsi vino da bere. È una testata ovviamente registrata e io ne sono direttore responsabile in qualità di giornalista, nata nel 2017. Sono diversi anni che facciamo questo mestiere. Cerchiamo di fare guide diverse, dedicate a singole regioni, guide on-line, tutte gratuite o meglio consultabili gratuitamente. Siamo contentissimi perché i numeri ci dicono che c’è una risposta importante del pubblico. Ci seguono anche molti ristoratori che fanno la Carta dei vini sulla base delle dei nostri consigli e questo ci rende abbastanza felici.
Ho letto però nel suo profilo che ha una passione per il vino della Sardegna, da cosa nasce?
Fin da piccolo frequento la Sardegna, ho

dei diciamo parenti acquisiti in Sardegna, l’ho girata in largo ed in lungo. Ho questa passione da ormai da trent’anni. Siamo in pochi a scrivere così tanto di Sardegna. Va ricordato che la Sardegna è la terza regione più grande d’Italia ed è un vero e proprio piccolo continente con una serie di subregioni, quindi è tutta da scoprire. E importantissimo è scoprire anche la diversità della produzione. I vini della Sardegna sono differenti dall’archetipo di 15 anni fa. Non sono assolutamente pesanti o alcolici come si crederebbe, ma sono vini ormai di grande bilanciamento, di grande eleganza, sicuramente di personalità. Oggi sono vino da bere.
Il vino è un mondo molto conosciuto ma superficialmente e anche a volte male interpretato, mentre è un mondo molto interessante sia dal punto di vista culturale che del gusto. Bisogna saperlo apprezzare. Quanto è difficile trasmettere questo messaggio allora? È abbastanza complicato, indubbiamente, perché è un mondo complesso,
come del resto il settore richiede. Però se cerchiamo di utilizzare un linguaggio semplice forse riusciamo ad arrivare. Il problema vero è che a volte, lo dico pur essendo docente di sommelier, il linguaggio del sommelier ha allontanato un po’ le persone comuni dal vino. Andrebbe un po’ rivisto nel nostro settore il linguaggio, in modo da poter avvicinare tutti a questo splendido liquido che è il vino.
Quanto vale oggi il marketing e quanto dovrebbe valere invece il giornalismo?
Ecco, questo nel mondo di internet si sta sovrapponendo la comunicazione al marketing. Ne sono un esempio gli influencer che per metà fanno comunicazione e per metà fanno altro. Ci sono anche influencer che fanno un grandissimo lavoro, intendiamoci. Ma questa sovrapposizione può generare confusione. Ecco perché diciamo che il giornalismo, soprattutto se veicola secondo criteri deontologici di informazione, può avere un reale valore. Oggi forse più che mai, visto che la comunicazione è tanta, ma forse eccessivamente diffusa e il lettore non sa orientarsi, quindi magari cercare l’affidabilità di un giornalista potrebbe essere la cosa ideale.
Non hai tempo per leggerlo?
Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza
Il coraggio di essere unici, paesaggio chilometrico consapevole. Autore insieme a Carlo Petrini del libro edito da Slow Food, Carlo Catani. Dal chilometro zero a quello consapevole. È un’evoluzione o un cambio di strategia?
Volevamo provare ad andare oltre al concetto di chilometro zero. È stato un concetto importantissimo perché ci racconta tutto quello che è il tema della prossimità. Però sono ancora tanti i produttori che abbiamo vicino, che non interpretano alcune tematiche per noi molto importanti, legate alla nostra etica, a quello che a noi interessa quando andiamo a scegliere i prodotti. È importante la consapevolezza. Volevamo affrontare tematiche che andassero oltre la distanza, che possono essere molto importanti per chi volesse scegliere un prodotto in maniera consapevole.
In una recente masterclass avete presentato vini da vitigni coltivati in aree di non facile gestione sia per altezza che ripidità, aree altrimenti abbandonate, è questa la consapevolezza?
Sicuramente è consapevolezza, ma anche come vengono coltivati questi terreni. Esagerare con l’uso della chimica può essere una cosa che depaupera il terreno e lo rende sterile e quindi anche questo può essere un elemento che deve essere considerato in termini di consapevolezza, oltre al
fatto di poter recuperare questi terreni. Anche dal punto di vista dell’offrire a persone lavoro degno, con una corretta retribuzione, che possa consentire di vivere una vita degna, pensiamo debba essere un altro elemento di consapevolezza.
Buono, pulito e giusto sono i tre pilastri sul quale si è basato il concetto di ecosostenibilità del chilometro zero. Qual è oggi il bilancio?
Sicuramente siamo andati avanti per quello che riguarda le persone, sulla consapevolezza della bontà del buono e anche sulla consapevolezza di quello che è l’attenzione al pulito. Un eccesso di chimica nel campo è un tema sempre più all’ordine del giorno oggi che il biologico sicuramente è molto più considerato nei processi di produzione. È il tema del giusto che non solo non ha fatto passi avanti, ma è arretrato da quando, venti anni fa, Carlo Petrini ha scritto il libro Buono, pulito e giusto. Su questo dobbiamo riflettere perché è uno dei motivi che spinge anche tanti giovani a emigrare, impossibilitati a trovare lavori che possano dare soddisfazione perché retribuiti in maniera adeguata.
Il sottotitolo del Libro è definire la sostenibilità a partire dalla tavola, che significa?
È importantissimo, oggi più che mai, fare attenzione a quello che è l’utilizzo
integrale della materia prima, cercando di capire e di sapere da dove arriva la materia prima che utilizziamo e riuscire, quando possibile, a premiare coloro che utilizzano la materia prima in maniera integrale o quanto più possibile. Dobbiamo evitare il superfluo impegnandoci senza fasciarci troppo la testa, perché errori si possono fare, ma dando attenzionare a questi temi. È quello che noi proponiamo come associazione Tempi di recupero. C’è un’attenzione al recupero di tanti valori e tematiche come il recupero della memoria, il recupero dei paesaggi e dei territori e soprattutto il recupero delle persone, che a volte vengono marginalizzate, perché magari non sono esattamente come quello che prevede lo schema omologante che spesso caratterizza la nostra società.
Dietro il vino, dietro l’agricoltura, dietro le attività umane in genere, c’è sempre una storia. Una storia umana, appunto. Lei stava dietro uno sportello di banca.
Sì, stavo dietro a uno sportello di banca, ho lavorato per quasi 10 anni, prima a un centro elaborazione dati, poi proprio in una banca. Dopo ho provato a scegliere di cambiare vita, provando a fare le cose che più mi piacevano. E devo dire che da allora le faccio. Abbiamo fatto partire l’Università di Scienze gastronomiche a Pollenzo, oramai quasi vent’anni fa. Tante altre cose che sono legate sempre alle

mie passioni, il cibo e il vino, le stiamo portando avanti oggi, con progetti che ci piacciono e con persone che sono belle persone con cui è bello lavorare e condividere progetti.
Chiudiamo con la trasmissione Report, la puntata dedicata alla produzione del vino. L’ha vista? Che opinione si è fatta?
Ci sono degli aspetti che sono veri in quello che è stato il servizio di report, però alcune cose sono state un po’ semplificate, troppo. Non è il modo corretto, secondo me, di rappresentare un mondo che mediamente è molto sano rispetto a tanti altri dell’a-
groalimentare, per cui il rischio in queste operazioni è che si vada a non valorizzare o a far perdere di valore una filiera che spesso è fatta di persone molto corrette, oneste e che hanno un’idea produttiva. Che magari non è quella condivisa dai giornalisti di Report, ma che è all’interno della legge.
Non hai tempo per leggerlo?
Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza

Dal 25 di maggio al 31 dicembre del 2024 a Villa Manin nel Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri da Udine, è in programma una mostra realizzata dalla Fondazione Pistoletto in collaborazione con il museo di Villa Manin. Una mostra che ha come titolo la T3RZA TERRA.
Con noi il Maestro MP a cui chiediamo intanto, cosa voglia dire T3RZA TERRA e quale sia l’obiettivo di questo progetto?
Ho cominciato con il terzo paradiso. Il concetto di una situazione che noi viviamo in questo momento di passaggio, che potremmo definire epocale, e che ho chiamato il terzo paradiso. Nel primo paradiso eravamo totalmente integrati nella natura e poi ci siamo staccati sempre più dalla natura, creando questo paradiso artificiale che oggi, in questi ultimi centocinquant’anni, è arrivato a degradare la natura. Ecco che dobbiamo adesso trovare un equilibrio per sopravvivere. Un equilibrio tra l’artificio e la natura. E quindi abbiamo questo terzo stadio, questo terzo paradiso.
Terzo vuol dire creare, vuol dire la creazione nuova, il passaggio verso un futuro di equilibrio e pace e armonia. L’idea della terra qui è messa a punto con un materiale che stiamo cercando di sviluppare, un carbone vegetale, particolare, che ha la

possibilità di rigenerare il terreno. Come un fertilizzante che però non si usa solo una stagione, ma rigenera il terreno per sempre. Pian piano stiamo sviluppando questa opportunità, l’opportunità di superare alcune grandi problematiche come quelle della sopravvivenza del sistema agricoltura.
Il concetto dell’opera il terzo para-

diso spinge a dire che l’uomo deve crescere in questa terza terra, che poi è la sintesi tra artificio e natura per una terra che sia ecosostenibile.
Esatto, perché la parola terra è a doppio senso. Ha senso come terreno di coltivazione e come pianeta. Quindi la terza terra è quella più vicina, quella che abbiamo sotto i nostri piedi, ma non soltanto nella zona più prossima a noi, ma nel pianeta intero. Ma la terza terra vuol dire terzo: dove l’equilibrio tra natura e artificio viene realizzato con una coscienza e una responsabilità sempre più evidente. È chiaro che dall’arte noi traiamo questa libertà assoluta. L’artista è totalmente libero, fa quello che vuole, ma noi pensiamo che la libertà dell’artista non è fatta per portare alla mostruosità. Non vogliamo noi artisti essere mostruosi, vogliamo essere armonici. Alla fine l’arte porta sempre ad un equilibrio e ad un’armonia. Adesso questo equilibrio, questa armonia l’arte la deve applicare, trasformando appunto la società, facendone un’opera d’arte. Ma l’arte da sola non lo può fare, per cui bisogna pian piano, che si impegnino proprio le persone, la società, insieme all’artista per realizzare questo nuovo pianeta.
La mostra della Manin mette confronto molte delle sue opere più importanti e anche si confronta con altri artisti e prevede un programma

dii dibattiti e confronti che è stato chiamato demopraxia…
La demopraxia è il desiderio di realizzare quello che chiamiamo equilibrio e armonia attraverso dei sistemi, dei sistemi, delle regole, delle capacità di organizzazione che ci portano a questo. Il grande sogno della democrazia vediamo che fa molta, molta fatica a diventare realtà. Vediamo che prosegue per un po’ e poi si cade sempre poi nel senso opposto, cioè nella difficoltà di convivere, di operare insieme, di condividere le responsabilità e nello stesso tempo le meraviglie che riusciamo a conquistare attraverso la scienza, la tecnologia e un conseguente equilibrio. Demopraxia vuol dire mettere al posto della parola kratos, che vuol dire potere, demo vuol dire popolo, la parola praxis che vuol dire pratica. Come si porta la pratica dentro al sistema politico che ci permette di arrivare a questo sogno della democrazia? Ecco, la formula è piuttosto semplice, ma molto, molto complessa da applicare. È semplice perché dice che bisogna considerare che non è una persona da sola che può acquisire il potere. La società, il popolo è fatto di tantissime persone che individualmente non possono avere il potere e quindi bisogna essere connessi almeno tra due persone. Appena abbiamo due persone insieme, che possono essere una coppia, una famiglia, oppure più persone che fanno una piccola impresa, l’impresa artigianale, agricola o industriale, qualsiasi
piccola media o grande impresa è una famiglia. Sono piccole, medie, grandi famiglie che devono intendersi fra di loro, perché le imprese piccole che siano, sono dei piccoli governi. Ogni famiglia è un piccolo governo. Due persone che stanno insieme devono in qualche maniera fare degli accordi, prendere delle decisioni insieme. Tutti questi diversi ambiti sociali sono poi desiderosi di avere delle leggi e delle forme che uniscano questi piccoli governi. Non è più l’individuo da solo che decide la propria volontà e la fa passare a livello politico e pubblico, ma sono piccole, medie e grandi organizzazioni. Da sempre sono le imprese, intese come realtà pratiche, che determinano lo sviluppo della società. E sono queste che devono ritrovarsi per costruire le regole dello sviluppo sostenibile.
Le faccio un’ultima domanda, maestro, oggi il terzo paradiso è praticamente in tutto il mondo. Avrebbe mai creduto, quando lo ha creato, che sarebbe poi diventato, come di fatto è diventato, un simbolo, un’icona di quello che potrebbe, dovrebbe essere l’equilibrio del futuro umano?
È il simbolo dell’equilibrio, ma è anche il simbolo di come funziona veramente tutto ciò che esiste. Tutto ciò che esiste funziona perché ci sono sempre due elementi, mai un elemento unico, solo e assoluto. Ci sono sempre due elementi diversi che si incontrano e possono scontrarsi,

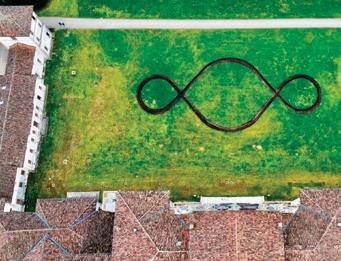

creando un rapporto fra tutti gli elementi. Nei tre cerchi da una parte possiamo avere l’ossigeno, in quello opposto l’idrogeno e al centro avremo l’acqua; aria calda, aria fredda, al centro la pioggia, il segno negativo da una parte, il segno positivo dall’altra e al centro si creerà elettricità. Metta un maschio o una femmina e avrà un ventre gravido per la nascita di una persona che non esisteva.
A Villa Manin sono esposte opere importanti come appunto la Venere degli stracci, recentemente peraltro restaurata a Napoli dopo l’incendio di qualche tempo fa.
Poi c’è la fiera dei giornali che percorre le strade. C’è il metro cubo di infinito, ci sono dei lavori che sono posti in modo da suscitare l’attenzione di interesse anche di altri artisti che hanno sviluppato propri lavori per questa esposizione.
Bene grazie, chiudiamo qua. Lei ha molto da fare, la vedo sempre in giro, soprattutto molto sui social, è molto


attivo grazie anche alla sua squadra di giovani ragazzi.
Bisogna lavorare tutti insieme e creare la grande scuola della nuova creazione.
Non hai tempo per leggerlo? Ascolta l’intervista sui podcast di Artemis Scienza
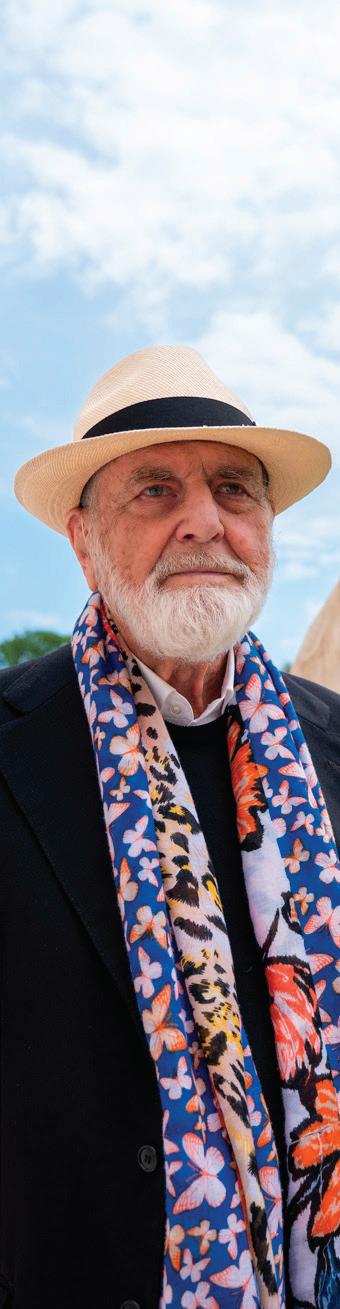
di Nicola Fano
Di Trotula de’ Ruggiero non si sa niente. Qualcuno ha congetturato date, marito, figli, studi, professione, ma sono quasi suggestioni da romanzo. La verità storica ci dice solo che in un tempo tra l’XI e il XII secolo venne diffuso un trattato medico dal titolo Summa qui dicitur Trotula composto da tre parti distinte: De passionibus mulierum (“Sulle malattie delle donne”), De curis mulierum (“Sulle cure per le donne”) e infine De ornatu mulierum (“Sulla cosmetica delle donne”). Dei tre studi, con ogni probabilità il secondo si può attribuire a una donna attiva nell’ambito della Scuola medica di Salerno tra la fine del 1000 e il 1100, tuttavia sono passati alla storia i primi due come Trotula maior, il terzo come Trotula minor. Punto.
Dunque, il nome di Trotula (diminutivo di Trota, appellativo all’epoca molto diffuso nel salernitano) è legato a un’opera multiforme che, per prima nella storia, si occupa di analizzare la
medicina strettamente al femminile a partire dal fatto, banale quanto rivoluzionario, che il corpo della donna è diverso da quello dell’uomo; e che quindi ha bisogno di cure differenti. Infine, il terzo trattato (Trotula minor) propone anche consigli specifici per garantire la longevità della bellezza. Ed ecco spiegato perché l’abbiamo inserita in questo personalissimo catalogo: Trotula – che, come vedremo, ha avuto un ruolo rilevante nel definire e difendere la specificità dell’identità femminile – avendo di fatto inventato la cosmesi ha confermato l’uso della bellezza come una gabbia. Ma è davvero così? Occorre indagare bene: magari scopriremo che la cosmesi è uno strumento tramite il quale la donna gioca, per se stessa, con la sua bellezza… a dispetto dei maschi.
Siamo nell’ambito della Scuola Medica Salernitana, un’istituzione secolare che prese avvio (pare tra il Nono e il Decimo Secolo) non in modo strutturato ma come concentrazione di esperti di medicina nella città di Salerno. Salerno, allora, era una località ricca e salubre, luogo di scambi importantissimi nel Mediterraneo. La leggenda vuole che, per caso, durante un temporale, sotto un ponte dell’acquedotto di Salerno si siano incontrati un pellegrino greco e uno latino: il secondo era ferito e si stava medicando sicché il greco, incuriosito, gli si avvicinò per coglierne la tecnica. Poi arrivarono un ebreo e un arabo, loro
stessi interessati alla ferita e ai medicamenti: i quattro cominciarono a discorrere e si scoprì presto che tutti si occupavano di medicina, sia pure in modi diversi. Da questo incontro fortuito fra tradizioni mediche diverse, dunque, nacque la Scuola Medica Salernitana. Solo più tardi, nel Basso Medioevo, essa si strutturò in modo più definito, ma già prima dell’anno Mille gli esperti salernitani erano chiamati a consulto ovunque, anche a grande distanza; e molti di loro tenevano veri e propri corsi di medicina lì a Salerno, al di fuori delle strutture religiose le quali, non solo allora, altrove erano le uniche depositarie della pratica medica. Proprio questa laicità della Scuola Salernitana avrà un riflesso fondamentale nell’impostazione degli studi e delle pratiche di Trotula.
D’altro canto, è accertata l’esistenza di mulieres Salernitanae, medichesse che si occupavano in modo specifico di preparare unguenti per le donne; secondo molte malelingue (maschi, ovviamente) costoro praticavano la magia e la stregoneria, ma si tratta probabilmente di una forzatura: al tempo le streghe non avevano vita né facile né lunga, sennonché difficilmente ne sarebbe rimasta traccia. E invece ci sono documenti che testimoniano come, tra queste mulieres, ebbe grande fama una certa Sapiens matrona: donna di straordinaria cultura e bellezza, la cui morte, nel 1097, portò in strada una
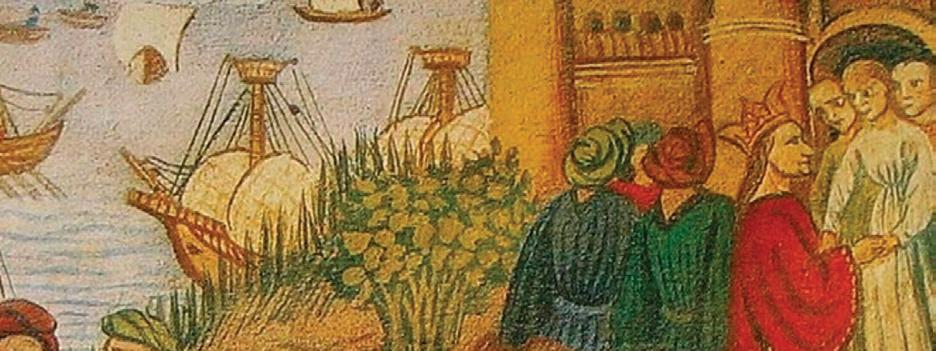
folla mai vista. Può darsi che questa matrona sia lei, Trotula.
Di costei, dunque, esistono tracce labili, prossime alla leggenda. Ma viene citata spesso con quel nome, Trotula, in documentazioni successive: ne parla addirittura Geoffrey Chaucer nei Canterbury Tales. Quindi, diamo per acclarato che tutto corrisponda al vero: che la medichessa salernitana, la trattatista scientifica e la donna bella e sapiente siano la stessa persona.
La questione importante è un’altra. I testi attribuiti a Trotula sono davvero sorprendenti dal punto di vista medico. Intanto, come abbiamo detto, ella parte dalla distinzione di genere: il corpo delle femmine è completamente diverso da quello dei maschi, e dunque va studiato, curato e accudito in modo differente. Sembra una evidenza addirittura sciocca, eppure anche oggi un’affermazione di questo tipo rischia di essere destabilizzante. Anzi, il fatto che i tre trattati in questione partano da questa considerazione non fa che accreditare la circostanza che essi siano stati scritti proprio da una donna e non già da un uomo. Trotula conosceva bene il proprio corpo e perciò si occupò di porre mano a rimedi specifici: si deve a lei, per esempio, l’avvio della disciplina della ginecologia. Nei suoi scritti non solo gli organi sessuali femminili sono definiti in modo molto appropriato, ma vengono elencati rimedi assai originali sia
in caso di parto sia in caso di precauzioni anticoncezionali. Inoltre, Trotula dava per scontato che in caso di infertilità, la responsabilità potesse essere indifferentemente o dei maschi o delle femmine; e citava molte evidenze in proposito per chiamare i maschi alle loro responsabilità fisiologiche. Come se non bastasse, il suo punto di vista aderiva totalmente a una concezione libera e autonoma della femmina. Per dire, tra i suoi più curiosi consigli ce ne sono alcuni per apparire vergini non essendolo più (problema molto sentito, nelle classi abbienti del tempo): vengono descritti dettagliatamente i decotti, e il loro uso, necessari per restringere la vagina.
Insomma, siamo di fronte a una donna decisamente fuori dall’ordinario, eppure i suoi princìpi medici erano perfettamente in linea con la tradizione millenaria di quella scienza. Si riteneva, al tempo, che il corpo umano contenesse i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) il cui equilibrio stava alla base di tutto il pensiero occidentale fin dall’epoca della filosofia di Empedocle. Il sangue è caldo e umido come l’aria; il muco è freddo e umido come l’acqua; la bile gialla è calda e secca come il fuoco; la bile nera è fredda e secca come la terra. I medici si occupavano di valutare gli eventuali disequilibri fra questi quattro umori e cercavano di ristabilizzarli. Questo, in buona sostanza, predica anche Trotula, salvo che l’e-
quilibrio delle donne, dice, è diverso dall’equilibrio degli uomini e dunque impone trattamenti differenti.
Non basta. I medici del tempo, e per molti secoli in avanti, intervenivano sui malati principalmente tramite l’applicazione di unguenti e pomate da loro stessi realizzati mescolando erbe e altri liquidi disponibili – ovviamente – in natura. Erano degli esperti chimici, dunque, ma praticavano una chimica bio. Trotula in questo doveva essere molto esperta: i suoi trattati sono pieni di ricette anche molto diverse tra loro e assai dettagliate. Tanto che ancora oggi possono essere prese in considerazione.
Proprio questa specifica competenza chimica, probabilmente, indusse Trotula ad allargare il suo raggio d’azione alla cosmesi genericamente intesa. Non è stata la prima: fin dall’antichità c’è una lunga tradizione di unguenti funzionali al mantenimento della bellezza, specie nella civiltà egizia. Ma l’obiettivo dei “consigli” di Trotula non è estetico, ella punta a fare in modo che la donna possa avere un rapporto armonico con il proprio corpo. I suoi rimedi per mantenere giovane la pelle, per fugare gli odori maligni, per frenare l’invadenza dei peli superflui non sono trucchi per sedurre i maschi, sono parte di un sistema di vita complessivo che mira a tenere il corpo della donna in equilibrio con la sua più
intima essenza: tutto punta a conservare intatto il temperamentum, ossia l’armonia – fisica – interiore. E se uniamo questa raccomandazione alla convinzione di partenza (la donna è diversa dall’uomo) si immagina che, forse, Trotula non predicava una bellezza seduttiva, funzionale al primato sociale dei maschi, ma puntava su una donna in grado di convivere, al meglio, con sé stessa. Ed è su questa strada che possiamo giungere ad una risposta alla domanda che ci siamo posti a proposito della “funzione” della bellezza professata da Trotula.
Le donne possono perseguire e vivere la propria bellezza anche non come una gabbia imposta dai maschi: Elena, Circe, Cleopatra e tutte le altre che verranno sono vittime sacrificali di un potere maschile millenario consolidato; ma la strada per combatterlo c’era. Ed è quella indicata da Trotula: concentrarsi su di sé.
Una sola domanda sorge spontanea, alla fine: come avrà fatto, Trotula, con la sua dottrina anticonvenzionale se non rivoluzionaria, a evitare il rischio di essere bruciata sul rogo come strega? Come avranno fatto i suoi colleghi maschi a non sentirsi minacciati da lei? Il Medioevo è davvero un tempo misterioso.
Cleopatra e il serpente. La bellezza come arma del patriarcato.
Di Nicola Fano, edito dalla casa editrice Elliot

Ogni volta che nasce una nuova casa editrice, due domande scaturiscono spontanee.
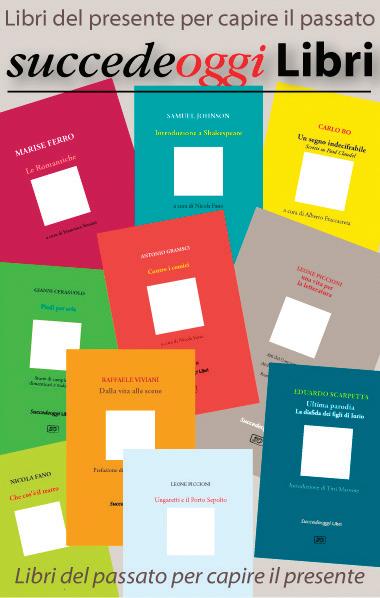
La prima: ma non si pubblicano già abbastanza titoli, in Italia? La seconda: c’era bisogno di un nuovo, ulteriore marchio? La risposta è sì a entrambi i quesiti. Si fanno troppi libri – è vero – ma è utile che ci siano sempre ulteriori occasioni di lettura: la ricchezza dell’offerta auspicabilmente allarga la domanda. Sicché, proprio per accettare questa sfida, quattro anni fa, dalla factory culturale Succedeoggi (che dal 2013 diffonde il webmagazine www.succedeoggi.it e organizza mostre, incontri e altre iniziative culturali) è nata una piccola casa editrice di cultura, Succedeoggi Libri. Lo slogan che la introduce –«Libri del passato per capire il presente e libri del presente per capire il passato» – dice già molto del suo profilo editoriale: Succedeoggi Libri pubblica solo saggistica e, in parallelo, recupera studi di maestri del passato ingiustamente dimenticati (riproposti con materiali critici nuovi e inediti) e propone libri scritti per l’occasione, che spigolano in modo nuovo tra le pieghe del nostro ieri. Nell’un caso e nell’altro, la pretesa degli animatori della casa editrice (Nicola Fano e Gloria Piccioni per la parte redazionale, Rossella Baldi per il versante amministrativo e commerciale) è di cogliere sempre
e comunque l’attualità della storia: il nostro futuro è nella comprensione del passato.
Così, scavando tra i maestri di ieri, Succedeoggi Libri ha recuperato gli scritti sulla comicità di Antonio Gramsci o Alberto Savinio; la memorialistica critica di Leone Piccioni o Geno Pampaloni; gli studi su Goldoni di Mario Baratto o quelli sull’identità letteraria italiana di Sebastiano Aglianò; i saggi di Carlo Bo su Paul Claudel o i reportage italiani di Sandro Onofri. Dall’altro lato, una grande studiosa d’arte come Marilena Pasquali ha indagato il rapporto tra Giorgio Morandi e Eugenio Montale, oppure Laura Falqui ha approfondito la pittura di Edward Burne-Jones, maestro preraffaellita. Senza contare le narrazioni della mitologia sportiva fatte da Gianni Cerasuolo o da quindici “amici” della casa editrice che hanno raccontato le loro Memorie olimpiche. Ma ora vediamo meglio in dettaglio qualche titolo.
A partire dalla pagina seguente ecco alcuni libri editi dalla casa editrice Succedeoggi Libri
Antonio Gramsci ha esercitato la critica teatrale in un periodo cruciale per la scena italiana: tra il 1916 e il 1920. In quel pugno d’anni, in Italia iniziò a imporsi il genio di Pirandello; con Virgilio Talli si consolidò la nuova figura del regista; esplose definitivamente il fenomeno della comicità popolare con Fregoli, Petrolini e Viviani. Da buon cronista dell’edizione torinese de l’Avanti!, Gramsci testimoniò in diretta questi fenomeni. Fu tra i primi a sottolineare la genialità dell’autore di Liolà e Il giuoco delle parti, fu tra i più lucidi a tessere l’elogio di Virgilio Talli ma non capì la comicità popolare che bollò come volgare, commerciale e diseducativa. E fu un peccato, perché invece Petrolini e gli altri erano proprio gli interpreti di quel proletariato al

Geno Pampaloni, Cesare Pavese, prefazione di Raffaele Manica.
180 pagine, 14 Euro, Isbn 9788899467142
quale Gramsci stesso aveva dato piena cittadinanza politica.
Curato dallo storico del teatro Nicola Fano, questo libro per la prima volta raggruppa per temi i più importanti interventi in materia di Antonio Gramsci. E, se da un lato l’autore si scaglia contro la gestione commerciale dei teatri torinesi, colpevoli di puntare solo sui comici, dall’altra egli teorizza la necessità di un nuovo teatro etico che aiuti l’uomo a definire sé stesso e la propria identità in relazione alla società. Infine, in questo volume brillano anche i ritratti di grandi interpreti come Ruggero Ruggeri o Angelo Musco; mentre all’elogio di Emma Gramatica si contrappone una geniale, argomentatissima stroncatura del mito di Lyda Borelli.

Geno Pampaloni, uno dei più brillanti italianisti del secondo Novecento, inseguì per tutta la vita l’opera e il mito di Cesare Pavese nel quale egli identificò un perfetto punto di congiuntura tra la letteratura classica e quella contemporanea, in Italia. Guidato da una profonda comunanza di intenti nei confronti di Pavese, il celebre critico in questo saggio traccia il ritratto dello scrittore e poeta, soffermandosi su tutte le opere. Ne viene fuori il ritratto di un uomo inquieto, perennemente insoddisfatto della sua creatività e della sua vita. Purtuttavia, uno scrittore di grande spessore, quello che forse più di altri ha saputo cogliere lo spaesamento dell’Italia nel passaggio da fascismo alla democrazia. E questa particolarità, Pampaloni la analizza opera per opera, variante per
variante, componendo una vera e propria guida alla lettura di Cesare Pavese.
Il testo riprodotto da Succedeoggi Libri conobbe la veste definitiva nel 1981, ma è il frutto di un lavoro durato un ventennio, fin da quando Pampaloni, nel 1962, confezionò per i programmi radiofonici della Rai un primo ritratto dello scrittore.
La prefazione di Raffaele Manica – italianista di grande fama – inquadra il rapporto che legò Pampaloni e Pavese prima, in chiave amicale, nell’immediato dopoguerra e poi, dopo la morte di Pavese, in chiave critica nel pieno di una stagione ricca e controversa, come è stata quella che ha condotto alla profonda crisi sociale e culturale degli anni Ottanta.
Assetato di vita, di sentimenti e di letteratura: così Leone Piccioni tratteggia il carattere di Ugo Foscolo. La scommessa del grande critico è, infatti, quella di umanizzare il mito e di coglierne non tanto le contraddizioni insite in una biografia notoriamente avventurosa, quanto l’evoluzione della poetica in base alle diverse vicende private. Vicende sentimentali, soprattutto, alle quali il critico, senza pruderie né falsi pudori, assegna una funzione letteraria precisa. Come se lo stile di Foscolo cambiasse a seconda delle donne cui tende o s’accompagna: dalla contessa d’Albany a Cornelia Martinetti, dalla Fagnani Arese alla Teotochi Albrizzi. E, tutto questo, Piccioni lo annota a partire dalla vita e dalle opere di un anno esemplare di Foscolo, il
1812, proprio cercando le corrispondenze tra arte e vita vissuta: è quasi l’esperimento – riuscito – di un nuovo metodo critico. Pubblicato per la prima volta nel volume Pazienza ed impazienze, il ritratto foscoliano di Leone Piccioni, dunque, restituisce un autore meno scolastico di quanto si pensi oggi, sospeso tra «furori di patria e agitato amore». Insomma, un autore capace di intercettare la complessità della vita rimescolando la quotidianità nel lirismo. E, come dice l’italianista Massimo Onofri nella prefazione, «sono pagine intense e folte, queste di Piccioni, in cui percepiamo anche l’influenza del maestro De Robertis, che negli anni Quaranta lo avviò allo studio del Foscolo, in particolare del suo epistolario».

Leone Piccioni, Foscolo 1812-1813. Prefazione di Massimo Onofri 96 pagine, 16 Euro, ISBN 9788899467227

Alberto Savinio, Il comico ha vita breve. A
cura di Nicola Fano
Pagine 124, 12 Euro. ISBN 9788899467203
La pittura di Savinio, i suoi “poltrobabbi”, le sue “poltromamme”, la sua passione per l’antropomorfismo hanno qualcosa di “comico”. Questo volume di Succedeoggi Libri, dunque, va a cercare, nella vasta produzione giornalistica di Savinio, i segni evidenti di una sua certa passione per la comicità popolare. Passione esercitata soprattutto in qualità di critico teatrale per la rivista Omnibus (fondata da Leo Longanesi) negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale: Anna Fougez, Wanda Osiris, Erminio Macario, Enzo Turco, Virgilio Riento, ma soprattutto i tre fratelli De Filippo, Eduardo, Peppino e Titina, animano le pagine di questo libro che per la prima volta tematizza in modo così specifico l’attività di “spettatore” pro-
fessionale di Savinio. Alle recensioni vere e proprie, poi, s’aggiungono altri scritti sparsi dedicati più genericamente alla teoria del comico. Curata dallo storico del teatro Nicola Fano, questa antologia offre un punto di vista inedito su Savinio e lo mette in relazione con la sua arte. Al punto che, alla fine, proprio la comicità sembra essere la migliore chiave di lettura del Surrealismo. Come se non bastasse, nelle pieghe di queste recensioni è possibile rintracciare il magnifico stile di scrittura di Savinio, la sua propensione per l’ironia condita sempre di profonda cultura. Tanto che al lettore le riflessioni di Savinio arrivano come fossero i consigli d’un amico, o la confidenza intima di un compagno di giochi.
Sandro Onofri, narratore romano scomparso a quarantaquattro anni nel 1999, ha raccontato l’Italia di oggi con trent’anni di anticipo. Autore di romanzi di grande spessore (Luce del Nord, Colpa di nessuno e L’amico d’infanzia recentemente in via di ristampa), Onofri pubblicò in vita anche due libri di reportage: Vite di riserva, nel 1993, sui nativi americani, e Le magnifiche sorti, 1997, sulle contraddizioni italiane. Nel corso dello stesso 1997, poi, Onofri svolse attività di inviato presso il periodico Diario della settimana, per il quale scrisse alcune memorabili inchieste. Questo volume di Succedeoggi Libri recupera, accanto ad alcuni reportage tratti da Le magnifiche sorti, una scelta dei migliori testi scritti per Diario della settimana mai raccolti prima in volume. Ne

Marilena Pasquali, Morandi e Montale, Alla ricerca di un «paesaggio dell’anima» Pagine 120, 14 Euro. ISBN 9788899467128
scaturisce un ritratto del nostro Paese, cinico, violento e ignoto a sé stesso, che anticipa di qualche decennio la deriva presa dall’Italia attuale. Con rara capacità di analisi della realtà e vera e propria “anteveggenza”, alla maniera dei grandi narratori, in questi reportage Onofri racconta per filo e per segno quel che siamo diventati: insomma, il lettore qui incontra l’Italia di oggi vista “ieri mattina”. In più, in queste pagine è possibile leggere in modo limpido la capacità, davvero magistrale, di Sandro Onofri di interpretare la realtà con gli strumenti della letteratura. E dunque si ha quasi la sensazione di entrare nel laboratorio di scrittura di un grande romanziere ormai considerato un classico della narrativa italiana del Novecento.

Sandro Onofri, L’Italia ieri mattina. Prefazione di Bruno Quaranta Pagine 134, 12 Euro. ISBN 9788899467111
Vite parallele, quelle di Giorgio Morandi ed Eugenio Montale? Sì, almeno in parte, la parte che attiene a sensibilità, linguaggio e poetica in quell’incandescente crogiolo di passato e futuro che è la prima metà del Ventesimo Secolo. È stato Francesco Arcangeli, storico dell’arte tra i più vicini al pittore, a scrivere: «Per ora [tra il 1928 e il 1935-’36] in Italia soltanto Montale è, quasi contemporaneamente, fratello a quel Morandi che non conosce». Ma, poco più tardi, Morandi e Montale si incontrano grazie ad amici comuni quali Filippo de Pisis, Cesare Brandi, Luigi Magnani, Giuseppe Raimondi. E il poeta acquista direttamente dall’artista due dipinti – un piccolo mazzo di fiori in vaso del 1942 e una natura morta del 1946
– che lo accompagnano nel suo trasferimento da Firenze a Milano nel 1948 e poi sempre illuminano il suo salotto accanto alle tele di de Pisis e alle sue stesse carte dipinte, matite, acquerelli e pastelli di acuminata leggerezza.
Ebbene, inseguendo questi indizi, come in un giallo letterario, Marilena Pasquali – studiosa dell’opera di Morandi, da sempre affascinata dalle analogie di sensibilità e pensiero che si possono cogliere nell’opera di entrambi – ricostruisce la relazione tra il pittore e il poeta. E la sua arte e la poesia. Ne viene fuori un ritratto del tutto inedito della cultura italiana della prima metà del Novecento, lontana dalla retorica del fascismo.
Esistono molti documenti che testimoniano la passione teatrale di Gian Lorenzo Bernini: soprattutto cronache degli spettacoli che il grande artista scriveva e allestiva a Roma, nei palazzi dell’aristocrazia papalina. Per esempio, si conosce l’effetto che suscitò sul pubblico una rappresentazione nella quale lo spazio scenico era totalmente coperto d’acqua o quella in cui gli spettatori si ritrovavano specchiati in un falso pubblico ricostruito da Bernini sul fondo della scena. Mancava, però, il segno più importante di questa esperienza: i testi. Questo libro colma la lacuna. Scovato nel 1963 da Cesare D’Onofrio (studioso di cose romane) fra le carte di Bernini, I segreti del signor Graziano è una commedia che racconta le avventure di un grande artista che si divide tra scultura

Raffaele Viviani, Dalla vita alle scene. Prefazione di Armando Pugliese 144 pagine, 14 Euro. ISBN 9788899467067
(per mestiere) e teatro (per passione): Bernini stesso, insomma. In una Roma del Seicento popolata di servi furbi e artigiani imbroglioni, tutti tramano per carpire a Graziano i suoi segreti di artista della scena (i suoi trucchi scenici), in modo da venderli a un ricchissimo appassionato.
Tecnicamente, si tratta di una Commedia ridicolosa, ossia un testo appartenente a un genere molto apprezzato nel Seicento, a metà strada fra la suggestione classica e la Commedia dell’Arte. Ma, al di là del dato tecnico, questa buffa storia svela pienamente i contorni della passione teatrale di un genio dell’arte. Nella cui creatività – come è ben spiegato dall’architetto e urbanista Pino Milani nella postfazione – si riverberano tutti i trucchi tipici del teatro.

Gian Lorenzo Bernini, I segreti del signor Graziano, Commedia ridicolosa.Postfazione di Pino Milani 112 pagine, 14 Euro. ISBN 9788899467166
Dalla vita alle scene fu pubblicato da Raffaele Viviani nel 1928. Si trattò, in sostanza, di un gioco; un vezzo tipico da attore di grande successo popolare, come spiega bene qui nella prefazione il grande regista Armando Pugliese, recentemente scomparso. La carriera di Viviani è divisa in tre stagioni. La prima, fino al 1917 (testimoniata diffusamente in questo libro) è quella del varietà e del successo come comico alla maniera di Petrolini e altri divi dell’epoca. La seconda, subito dopo il 1917, fu caratterizzata dalla scoperta di una misura drammaturgica più complessa e durò fino ai primi anni Venti. La terza stagione, quella della maturità drammaturgica (Zingari, Pescatori, ecc.) coincise con l’ostracismo del regime fascista: che in lui detestava il pro-
fondo realismo e l’adesione a un modello sociale autenticamente popolare.
La colorita autobiografia qui riproposta si occupa solo della stagione del varietà e della scoperta di una dimensione divistica internazionale sulla quale il Viviani dell’età matura in parte ricamerà. E a cui spesso guarderà con distacco. Ma si tratta di un documento il cui interesse travalica il teatro in senso stretto. Perché in queste pagine Raffaele Viviani racconta un’Italia autentica fatta di onesti lavoratori della scena e di altrettanto onesti spettatori popolari il cui profilo sfugge totalmente dai documenti ufficiali come dall’iconografia e dalla retorica del tramonto della Belle Époque e dell’ascesa del fascismo.

Tre opere da consigliare come lettura, non solo estiva, che riguardano la nostra storia, dalla conquista dello spazio con lo Sputnik, ai giochi gladiatori, la loro funzione e come funzionavano, passando per un anniversario, quello dell’assassinio di Giacomo Matteotti.

Sputnik 1: l’inizio dell’era spaziale è un volume edito da La Gazzetta dello Sport nell’ambito della collana Giorni che hanno fatto la storia. L’autrice, Viviana Panaccia, esperta del settore spaziale dove ha passato tutta la sua vita professionale, ci porta ad analizzare quell’avvenimento, il lancio dello Sputnik 1 da parte dell’Unione Sovietica nel 1957, non già con un mero racconto dei fatti che portarono a quello che viene definito il momento di passaggio tra l’era contemporanea e quella spaziale, quanto piuttosto ce lo fa rivivere più volte, dando però ogni volta un punto di vista diverso. Un po’ come quelle narrazioni cinematografiche o letterarie, in cui lo stesso avvenimento, raccontato da protagonisti diversi, sembra diversificarsi, ma in realtà è sempre lo stesso, cambia solo la sua interpretazione. E non può essere altrimenti in un saggio storico interessante quanto facile a leggersi, con notazioni e approfondimenti che forniscono al lettore un quadro complessivo di conoscenza assai più ampio che il lancio dello Sputnik 1. Il tutto in appena 158 pagine.
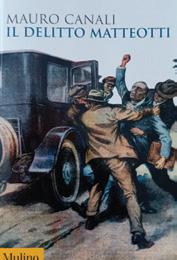
Il Delitto Matteotti, edizioni Mulino. Il saggio storico di Mauro Canali è un cospicuo aggiornamento di un volume edito dalla stessa casa editrice uscito qualche anno addietro, nel 1997. L’allievo di Renzo De Felice ha continuato i suoi studi su Giacomo Matteotti, sulla sua morte e soprattutto dei motivi che l’hanno provocata. Motivi più profondi che la semplice opposizione al regime fascista, motivo che attribuiscono ancora più fortemente le responsabilità di Benito Mussolini quale mandante dell’omicidio Matteotti. Non più una vaga rappresentazione di un omicidio fascista nato nell’ambito dello scontro politico, ma una mirata esecuzione a tutela di un Duce e un sistema corruttivo che avrebbe permesso ad una grande azienda petrolifera statunitense di avere in gestione d’uso, di appropriarsene insomma, ampie aree del mezzogiorno del nostro paese. Rispetto all’edizione del 1997 Mauro Canali corrobora la sua ipotesi con nuove carte, tanto da scalfire chi, tra gli stessi storici, ha amato la ragione romantica di quell’omicidio nato dopo un intervento alle camere, divenuto tanto rappresentativo della difesa dei principi democratici, da diventare testo e sceneggiatura, come testimonia il film di Florestano Mancini del 1973 splendidamente interpretato nella figura di Giacomo Matteotti da Franco Nero. Al termine di quell’intervento Matteotti ebbea dire «Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora, a voi preparare il discorso funebre per me». Ma i suoi assassini, fidati del Duce, erano a Roma ben prima di un intervento che alla Camera nacque estemporaneamente.
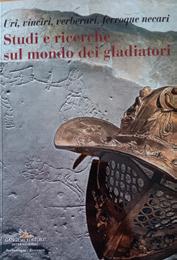
Studi e ricerche sul mondo dei gladiatori: Uri, vinciri, verberari, ferroque necari . Le autrici di questo volume della Cangemi Editore, che raccoglie i contributi di otto conferenze realizzate nella Curia Iulia all’interno del Parco archeologico del Colosseo tra settembre 2023 e gennaio 2024, sono due eminenze della realtà dell’antica Roma e soprattutto del Colosseo e di cosa abbia rappresentato. I giochi gladiatori hanno un’origine antecedente all’anfiteatro di Vespasiano: Alfonsina Russo e Federica Rinaldi. Il Circo Massimo ne è stato primario testimone, ma prima ancora l’arena di Santa Maria Capua a Vetere. Il mondo gladiatorio si inserisce in una celebrazione che durava anche settimane, che aveva rigide regole, tempi, modalità commerciali, nella quale il gladiatore era il protagonista finale, come finale era la giornata quando appunto si faceva protagonista. Il volume mette insieme tutte le scoperte e le rivelazioni portate alla conoscenza di tutti in questo periodo, pur breve ma proficuo di confronto. Un volume che ha del catalogo, tipico per una realtà come il Colosseo e i Fori, capace, però, di affascinare quanti già conoscono questa parte della storia di Roma antica e quanti, non conoscendola, ne finirebbero inevitabilmente attratti.

STAM è leader nella consulenza ingegneristica e nei servizi per l’innovazione con oltre 25 anni di esperienza nel settore spaziale. Competenze multidisciplinari e intersettoriali, un team di 75 ingegneri e scienziati, laboratori interni per supportare proof-of-concept e partnership con più di 1500 stakeholders (imprese, start-up ed enti di ricerca) in tutta Europa sono i nostri punti di forza.


STAM agisce come ESA Technology Broker per l’Italia e gestisce in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana il Fondo ESA Spark Funding.
www.stamtech.com
