INVA L S I QUIZ



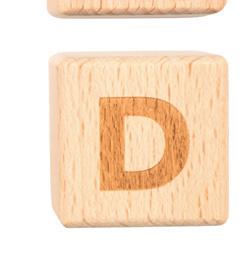

• PROVA UFFICIALE GUIDATA e altre inedite da svolgere in autonomia, con AUTOVALUTAZIONE
• ULTIMA PROVA UFFICIALE come verifica finale
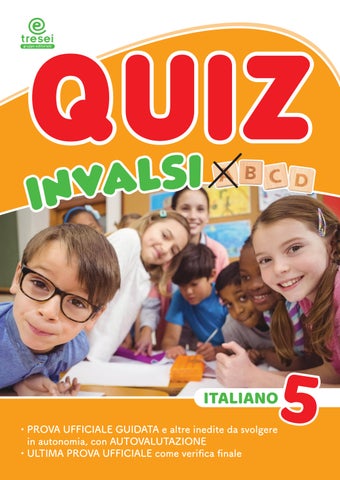



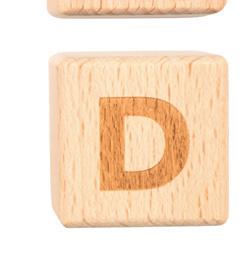

• PROVA UFFICIALE GUIDATA e altre inedite da svolgere in autonomia, con AUTOVALUTAZIONE
• ULTIMA PROVA UFFICIALE come verifica finale
Gli eserciziari QUIZ INVALSI contengono un ricco percorso (128 pagine!) per prepararsi con graduale autonomia alle prove nazionali di italiano e matematica, previste per le classi seconda e quinta della Scuola Primaria, e di inglese (classe quinta).
Ogni testo di italiano è così strutturato:
• una prova ufficiale guidata ;
• prove inedite da svolgere in autonomia con autovalutazione ; queste prove sono distinte in base agli argomenti dei testi su cui esercitarsi (un testo narrativo per classe seconda, e due testi, uno narrativo e un altro argomentativo, per la classe quinta; a seguire, gli esercizi di grammatica), indicati in alto, in ogni pagina da specifiche icone come ad esempio:
AMICIZIA E AVVENTURA
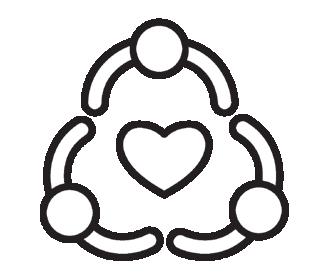
FAMIGLIA ED EMOZIONI

E TANTI ALTRI ARGOMENTI...
RIFLESSIONE SULLA LINGIUA
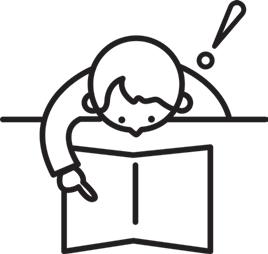
In questo volume, a pag. 36 è presente un indice ragionato in base al quale il bambino può scegliere la prova su cui esercitarsi e barrare quelle già completate.
La tabella di autovalutazione , alla fine di ogni prova, è strutturata come un istogramma , con le risposte corrette da colorare , in modo che al bambino sia ben visibile il livello della sua preparazione ; • in fondo al libro è riportata una prova ufficiale come verifica finale.
Ideatrice del testo: Federica Goffi
Redazione: Federica Goffi, Chiara Mammarella
Progetto grafico: Federica Goffi, Claudio Magrini
Copertina: Federica Goffi, Claudio Magrini
Impaginazione: Federica Goffi, Claudio Magrini
Illustrazioni: Istock photo
Editrice Tresei Scuola Via Meucci, 1 60020 Camerata Picena (AN) Tel. 071/946210 - Fax 071/9470951
www.tresei.com © Tutti i diritti sono riservati
ISTRUZIONI - PROVA DI ITALIANO
Prova ufficiale guidata
INDICE DELLE PROVE PER ARGOMENTI
Prova n. 1
Prova n. 1 - AUTOVALUTAZIONE
Prova n. 2
Prova n. 2 - AUTOVALUTAZIONE
Prova n. 3
Prova n. 3 - AUTOVALUTAZIONE
Prova n. 4
Prova n. 4 - AUTOVALUTAZIONE
Prova

ALLE PAGINE SEGUENTI,
TROVERAI LE ISTRUZIONI PER SVOLGERE
LA PROVA INVALSI DI ITALIANO.
SUBITO DOPO, C’È
UNA PROVA DI ITALIANO UFFICIALE
CON SVOLGIMENTO GUIDATO.
SUCCESSIVAMENTE, SONO PRESENTI
DIVERSE PROVE INVALSI DI ITALIANO
CON CUI ESERCITARTI IN AUTONOMIA.
INFINE, TI METTERAI ALLA
PROVA SVOLGENDO AUTONOMAMENTE
UNA RECENTE PROVA DI ITALIANO UFFICIALE.
BUON LAVORO!
La prova è composta da due testi che dovrai leggere per poi rispondere alle domande che li seguono e da alcune domande di Riflessione sulla lingua. Le istruzioni prima di ogni domanda ti diranno come rispondere. Leggile dunque con molta attenzione.
Nella maggior parte dei casi per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni risposta c’è un quadrato con una lettera dell’alfabeto: A, B, C, D. Per rispondere, devi mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta (una sola) che ritieni giusta, come nell’esempio 1:
Esempio 1
Qual è la capitale dell’Italia?
A. Venezia
B. Napoli
C. Roma D. Firenze
In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due esempi che seguono.
Esempio 2
In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche d el protagonista del racconto?
Metti una crocetta per ogni riga. SÌ NO
a. È coraggioso
b. È timido
c. Ama lo studio
d. Gli piace giocare
e. Non sa mentire
Esempio 3
Chi è il protagonista del racconto che hai letto?
Risposta: Enrico
Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere: devi scrivere NO vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell’esempio 4.
Esempio 4
In quale continente si trova l’Italia?
A. In America
B. In Asia
C. In Africa
D. In Europa NO
Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda.
Quale dei seguenti aggettivi ha significato opposto all’ aggettivo alto ?
A. Largo
B. Basso
C. Stretto
D. Magro
Per svolgere l’intera prova avrai in tutto un’ora e quindici minuti (in totale 75 minuti) di tempo*.
*Adatt. dalle istruzioni della prova nazionale di Italiano, classe quinta
Data:
«Un albero?»
Ho guardato Leila incredulo.
Lei ha annuito. «Una witkaree. Nome scientifico: Rhus pendulina.»
«Piacere di conoscerti, albero» ho detto io.
Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estinzione o cose così?»
«Non proprio» ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. «C’è un sacco di gente che si pianta una witkaree in giardino. Non hanno bisogno di troppa acqua e crescono in fretta» ha aggiunto con un tono da conduttrice tv.
Ero perplesso. «Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo?»
È rimasta parecchio a guardarmi, come se stesse cercando di farsi un’opinione su di me.
Chissà che cosa vede, mi chiedevo.
Non avevo i capelli biondi, gli occhi azzurri, i muscoli scolpiti e l’abbronzatura di mio fratello maggiore. Nemmeno il nasino all’insù pieno di lentiggini e il bel faccino adorabile di mio fratello minore.
Io avevo i capelli castani, un po’ troppo lunghi e pieni di ciuffi che non stavano da nessuna parte, e gli occhi verdi. Quand’ero con i miei fratelli, passavo sempre inosservato. Certe volte mi sentivo invisibile.
Senza distogliere lo sguardo da me, Leila ha fatto un lungo respiro.
«Quest’albero non è come tutti gli altri» mi ha risposto.
«È l’albero al centro del mondo.»
Non sono riuscito a trattenermi e sono scoppiato a ridere. Era fuori di testa. Cosa mi era saltato in mente di seguirla fino a quel parchetto, a tre isolati da casa, perché mi mostrasse un albero?
«L’albero al centro del mondo?» le ho chiesto.
«Lasciamo perdere.» Mi ha lanciato un’occhiataccia. «Pensavo che... Non importa. Chiudiamola qui.»
Sembrava arrabbiatissima, e infatti mi aspettavo che girasse i tacchi e se ne andasse. Ma da come mi guardava era chiaro che a dover smammare ero io.
Non c’era nemmeno da chiederlo.
Senza battere ciglio, mi sono incamminato verso casa. E poi avevo da fare in cucina. Prima finivo di lavare i piatti, meglio era.
«Quando ero piccola venivo sempre a giocare in questo parco» ha detto Leila mentre andavo via. Parlava così piano che avevo rischiato di non sentirla.
Mi sono fermato.
«È su questo albero che ho imparato ad arrampicarmi.»
Mi sono voltato verso di lei, ma sembrava non si fosse nemmeno accorta che ero lì in piedi a guardarla.
«Non ci si può arrampicare su tutti gli alberi. Le witkaree hanno la corteccia dura. È facile sbucciarsi quando si scivola, perciò non sono l’ideale. Ma questa qui ha i rami bassi, spessi e anche molto fitti perciò riesci ad arrivare praticamente fino in cima. È perfetta da scalare.»
Poi abbiamo sentito un rumore, ci siamo voltati e abbiamo visto un pick-up bianco che veniva verso di noi passando sul prato.
«Sono loro» ha detto Leila con voce cupa.
Il pick-up si è fermato e sono scesi due uomini. Uno aveva in mano una cartelletta con dei fogli che gli davano un’aria importante. L’altro era alto e magro, con la faccia appuntita e i baffetti sottili. Senza degnarci di uno sguardo, ha cominciato subito a esaminare l’albero.
«Ho fatto una petizione» ha detto Leila all’uomo con la cartelletta. «L’hanno già firmata quasi cinquanta persone.»
«Troppo tardi» ha risposto lui senza nemmeno alzare gli occhi, «abbiamo già tutti i permessi.»
«Ma questa è una petizione!» lo ha incalzato Leila fulminandolo con i suoi occhioni azzurri. «Le persone l’hanno firmata perché non vogliono che l’albero venga abbattuto. Sono quasi in cinquanta! Ci tengono! Non potete fare come se niente fosse!» ha aggiunto.
L’uomo ha scrollato le spalle.
Quello magro ha cominciato a girare attorno all’albero con fare meticoloso.
«Quando prevedete di abbatterlo?»
La voce di Leila faceva le montagne russe.
«Posa delle tubature i primi di gennaio» ha risposto l’uomo, «l’albero va giù oggi.»
Leila ha fatto un bel respiro. Ha spalancato gli occhi. Si è tolta i sandali e li ha calciati via. Prima che potessi chiederle che cosa stava facendo, si è girata e si è fiondata sull’albero.
«Dove pensi di andare?» ha domandato l’uomo, stupito.
Io sono rimasto lì, assieme ai due tizi del Comune, a guardarla che sgattaiolava su e poi si accomodava su un ramo.
L’uomo con la cartelletta mi ha lanciato un’occhiata implorante, si aspettava che risolvessi io la situazione.
«L’albero era qui da prima!» ha urlato Leila.
Ho guardato su, tra i rami. Di colpo ha cominciato a girarmi la testa. Ho chiuso forte gli occhi.
Ho pensato a mio fratello maggiore e a mio fratello minore. Qualsiasi cosa succedesse, io scomparivo sempre tra i miei fratelli. Ero sempre schiacciato tra loro due e nessuno si accorgeva mai di me.
Quando ho riaperto gli occhi, ho abbassato lo sguardo e mi sono accorto che avevo ancora lo strofinaccio bianco e rosso appoggiato sulla spalla.
Me n’ero completamente dimenticato: avevo fatto tre isolati con uno strofinaccio sulla spalla. Era una di quelle cose strane che magari avrebbe potuto fare Leila. Forse la sua stranezza era contagiosa.
Ho pensato alla pila di piatti che mi aspettava a casa. Penso che certe volte si fanno le cose all’improvviso, senza stare a pensarci, cose che ti cambiano la vita.
Chiedi alla tua fidanzata di sposarti mentre state guardando un film dell’orrore, come aveva fatto papà con mamma. Oppure segui una ragazza strampalata tra i rami di un albero, con uno strofinaccio appoggiato sulla spalla.
(Tratto e adattato da: Jacobs J., L’albero al centro del mondo, RIZZOLI LIBRI, 2019, Italia.)
A1 A chi l’autore fa narrare la vicenda raccontata?
A. Al ragazzo.
B. A Leila.
C. Agli operai del Comune.
D. A un narratore esterno al racconto.

• Rileggi l’inizio del racconto:
«Un albero?»
Ho guardato Leila incredulo.
• Qual è il soggetto sottinteso del verbo sottolineato?
• Questo soggetto sottinteso...
- coincide con Leila? SÌ NO
- è presente alla vicenda del racconto? SÌ NO
Rispondi al quesito A1
A2 Dopo aver letto l’intero testo possiamo ricostruire quello che è successo subito prima della scena iniziale. Che cosa è successo?
A. Il ragazzo incontra Leila mentre torna a casa da scuola e inizia a parlare con lei.
B. Il ragazzo smette di lavare i piatti e segue Leila che lo ha chiamato.
C. Il ragazzo ha litigato con i suoi fratelli ed esce di casa per incontrare Leila.
D. Il ragazzo ha chiesto a Leila di aiutarlo in cucina e lei in cambio gli chiede di firmare una petizione.

TI AIUTO!
• Rileggi questa parte finale del racconto e fai attenzione alle parti sottolineate.
Me n’ero completamente dimenticato: avevo fatto tre isolati con uno strofinaccio sulla spalla. Era una di quelle cose strane che magari avrebbe potuto fare Leila.
Forse la sua stranezza era contagiosa.
Ho pensato alla pila di piatti che mi aspettava a casa. Penso che certe volte si fanno le cose all’improvviso, senza stare a pensarci, cose che ti cambiano la vita.
Ora rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito A2
La parte di testo che hai appeno letto ti fa pensare che il ragazzo...
- è partito improvvisamente da scuola? SÌ NO
- è partito improvvisamente da casa? SÌ NO
- a casa doveva finire di sistemare i piatti? SÌ NO
- aveva chiesto a Leila di aiutarlo? SÌ NO
- stava litigando con i suoi fratelli? SÌ NO
A3 Dove si svolge la vicenda narrata?
A. Nel giardino di una casa.
B. Lungo una strada.
C. In un bosco.
D. In un parco pubblico.

TI AIUTO!
• Rileggi la parte di testo seguente, fai attenzione alle parole sottolineate, poi rispondi al quesito A3.
Cosa mi era saltato in mente di seguirla fino a quel parchetto, a tre isolati da casa, perché mi mostrasse un albero?
A4 “Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estin zione o cose così?»” (righe 5-6). Per quale motivo il ragazzo fa questa domanda a Leila?
A. Cerca di capire perché Leila dia tanta importanza a quell’albero.
B. Vuole vedere se Leila sa davvero tutto su quell’albero.
C. È interessato a imparare da Leila tante cose su quell’albero.
D. Vuole trovare una soluzione per aiutare Leila a guarire quell’albero.

TI AIUTO!
• Rileggi di nuovo questa parte iniziale del racconto e fai attenzione alle parole sottolineate.
«Un albero?»
Ho guardato Leila incredulo.
Lei ha annuito. «Una witkaree. Nome scientifico: Rhus pendulina.»
«Piacere di conoscerti, albero» ho detto io.
Rispondi alla domanda che segue e, poi, al quesito A4.
- Secondo te, il ragazzo, all’inizio, ha capito il motivo per cui Leila lo ha portato a vedere quell’albero? SÌ NO
La parte di testo riportata a fianco può aiutarti a rispondere alla prossima domanda.
A5 “Ero perplesso. «Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo?»” (riga 10).
Che cosa si può aggiungere a questa frase per renderla più chiara?
Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estinzione o cose così?»
«Non proprio» ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. «C’è un sacco di gente che si pianta una witkaree in giardino. Non hanno bisogno di troppa acqua e crescono in fretta» ha aggiunto con un tono da conduttrice tv.
Ero perplesso. «Ma allora perché hai scritto una petizione per salvarlo?»
A. «Ma allora, se ha la corteccia ruvida, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»
B. «Ma allora, se non è a rischio di estinzione, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»
C. «Ma allora, se non ha bisogno di troppa acqua, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»
D. «Ma allora, se sai parlare come una conduttrice tv, perché hai scritto una petizione per salvarlo?»

TI AIUTO!
• Rileggi di nuovo questa parte iniziale del racconto e fai attenzione alle parole sottolineate.
Ho passato una mano sulla corteccia ruvida. «È a rischio estinzione o cose così?»
«Non proprio» ha risposto Leila, senza staccare gli occhi dalla chioma. Aiutandoti con un dizionario, scrivi il significato della parola “estinzione”, rispondi alla domanda e, poi, al quesito A5.
Estinzione =
La risposta di Leila: “Non proprio!” ti fa comunque pensare che l’albero sia in pericolo? SÌ NO
A6 Da riga 14 a riga 19 l’autore ci dice come il ragazzo vede i suoi fratelli e sé stesso. A quale scopo dà queste informazioni?
A. Per mostrare che il ragazzo è sfortunato perché ha due fratelli che sono più belli e simpatici di lui.
B. Per mostrare che Leila si rivolge al ragazzo solo perché non conosce i suoi fratelli.
C. Per mostrare che il ragazzo non è abituato a sentirsi considerato ed è stupito dell’attenzione di Leila.
D. Per mostrare che Leila preferisce le persone dall’aspetto più disordinato piuttosto che quelle troppo curate.

TI AIUTO!
• Rileggi di nuovo il racconto (dalla riga 13 alla 19) e fai attenzione alle parole sottolineate nelle parti di testo di seguito riportate.
È rimasta parecchio a guardarmi, come se stesse cercando di farsi un’opinione su di me. Chissà che cosa vede, mi chiedevo.
Quand’ero con i miei fratelli, passavo sempre inosservato. Certe volte mi sentivo invisibile.
Ora rispondi alle domande seguenti e, poi, al quesito A6
- Il ragazzo spesse volte si sentiva “non visto”? SÌ NO
- Leila, invece, lo ha fatto sentire al centro dell’attenzione? SÌ NO
- Secondo te, Leila era interessata ai fratelli del ragazzo? SÌ NO
A7 Quale informazione del testo aiuta a capire perché per Leila qu ell’albero “è l’albero al centro del mondo”?
Copia l’informazione dal testo o scrivila con parole tue nello spazio sotto.

TI AIUTO!
• Rileggi cosa dice Leila al ragazzo, mentre stava per ritornare verso casa.
«Quando ero piccola venivo sempre a giocare in questo parco» ha detto Leila mentre andavo via.
Rispondi alla domanda seguente e, poi, al quesito A7.
Secondo te, le parole sottolineate ti fanno pensare che l’albero è qualcosa di molto importante per Leila? SÌ NO
A8 Dopo che il ragazzo scoppia a ridere, Leila dice “Pensavo che.. . Non importa. Chiudiamola qui” (righe 27-28). Tenendo conto del testo, come potrebbe continuare la frase che Leila non finisce?
A. Pensavo che mi avresti lodata.
B. Pensavo che fossi più coraggioso.
C. Pensavo che mi avresti capita.
D. Pensavo che fossi più furbo.

• Rileggi cosa dice il ragazzo a Leila, soffermandoti sulle parole sottolineate.
Non sono riuscito a trattenermi e sono scoppiato a ridere. Era fuori di testa. Cosa mi era saltato in mente di seguirla fino a quel parchetto, a tre isolati da casa, perché mi mostrasse un albero?
«L’albero al centro del mondo?» le ho chiesto. Rispondi alle domande seguenti e, poi, al quesito A8
- Secondo te, il ragazzo, dicendo quelle parole, ha compreso l’importanza che quell’albero aveva per Leila? SÌ NO
- Secondo te, Leila si è sentita capita? SÌ NO
A9 “«Ho fatto una petizione» ha detto Leila” (riga 51). Dal testo si capisce che una petizione è un documento scritto. Indica quali sono, in base al testo, le caratteristiche di una petizione.
La petizione è un documento scritto che...
Metti una crocetta per ogni riga. SÌ NO
a. Denuncia un reato.
b. Contiene una richiesta.
c. Viene firmato da più persone.
d. Fissa una regola.

TI AIUTO!
• Rileggi questo pezzo di testo e sottolinea il motivo per cui Leila ha fatto questa petizione.
«Ma questa è una petizione!» lo ha incalzato Leila fulminandolo con i suoi occhioni azzurri. «Le persone l’hanno firmata perché non vogliono che l’albero venga abbattuto. Sono quasi in cinquanta! Ci tengono! Non potete fare come se niente fosse!» ha aggiunto.
Aiutandoti con un dizionario, riporta il significato della parola “petizione”.
Petizione:
Ora puoi rispondere ai quesiti A9 e A10.
A10 Che cosa ci può essere scritto nella petizione di Leila?
Con questa petizione
A11 Quando Leila dice che ha fatto una petizione, uno dei due uomin i le risponde “«Troppo tardi» […] «abbiamo già tutti i permessi»” (righe 53-54). Di quali permessi parla?
I permessi per

TI AIUTO!
• Ricorda il motivo per cui questi due uomini sono arrivati al parco. Che cosa volevano fare a quell’albero?
Ora rispondi al quesito A11.
A12 “L’uomo con la cartelletta mi ha lanciato un’occhiata implorante, si aspettava che risolvessi io la situazione” (righe 70-71). Qual è la situazione che il ragazzo dovrebbe risolvere?
A. Se Leila non rimette i sandali, rischia di ferirsi i piedi.
B. Se Leila resta sull’albero, l’albero non può essere abbattuto.
C. Se Leila presenta la petizione, i loro permessi non valgono più niente.
D. Se Leila urla ancora, rischia di irritare molte persone.

• Rileggi questa parte di testo e fai attenzione alle parole sottolineate. «l’albero va giù oggi.»
Leila ha fatto un bel respiro. Ha spalancato gli occhi.
Si è tolta i sandali e li ha calciati via. Prima che potessi chiederle che cosa stava facendo, si è girata e si è fiondata sull’albero.
«Dove pensi di andare?» ha domandato l’uomo, stupito.
Io sono rimasto lì, assieme ai due tizi del Comune, a guardarla che sgattaiolava su e poi si accomodava su un ramo.
Ora rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito A12
- Gli operai del Comune erano venuti per abbattere l’albero? SÌ NO
- Leila era salita sull’albero per evitare che fosse abbattuto? SÌ NO TI AIUTO!
A13 In base al testo, quali caratteristiche ha il ragazzo, quali Le ila e quali caratteristiche hanno tutti e due?
Metti una crocetta per ogni riga. Il ragazzo Leila Tutti e due
a. Lo spirito d’iniziativa.
b. L’impressione di contare meno degli altri.
c. La determinazione.
d. Il fare cose strane.

TI AIUTO!
• Rileggi alcune parti del testo se necessario, poi rispondi alle domande che seguono e al quesito A13
- Chi ha preso l’iniziativa di andare a vedere l’albero nel parco?
- Chi è salita sull’albero nonostante gli operai volessero tagliarlo?
- Chi si sentiva spesso “non considerato” e “inferiore” ai sui fratelli?
- Secondo te, salendo sull’albero come segno di protesta, Leila ha fatto una cosa “strana”? SÌ NO
- Il ragazzo, seguendo Leila nel parco con uno strofinaccio sulla spalla, ha fatto una cosa “strana”? SÌ NO
Chi dice: “Forse la sua stranezza era contagiosa.”
A14 Sotto sono riportati alcuni eventi della vicenda. Metti questi eventi in ordine cronologico cioè nell’ordine in cui sono successi. Il primo evento è già stato indicato. Scrivi un numero da 2 a 5 per ordinare gli altri eventi.
Ordine in cui gli eventi sono successi
a. Leila presenta la witkaree al ragazzo.
b. Leila scrive una petizione per salvare la witkaree.
c. Arriva il pick-up con due uomini per abbattere la witkaree.
d. Il Comune decide di tagliare la witkaree.
e. Leila si arrampica sulla witkaree e si siede su un ramo. 1

TI AIUTO!
• Completa il testo seguente che riepiloga la sucessione dei principali eventi, poi riporta i numeri in tabella. Poiché il Comune aveva deciso di tagliare la , Leila scrive una , poi chiama il suo amico e lo porta al parco. Mentre sono lì, arrivano gli operai del Comune con l’intenzione di l’albero, allora Leila si su di esso e si siede su un ramo.
A15 Dalle ultime righe del testo si può capire quello che succede a lla fine di questo episodio. Che cosa succede?
A. Il ragazzo va a chiamare in aiuto i suoi fratelli.
B. Il ragazzo chiede a Leila di sposarlo.
C. Il ragazzo torna a casa a lavare i piatti.
D. Il ragazzo raggiunge Leila in cima all’albero.

TI AIUTO!
• Rileggi la parte finale del racconto e fai attenzione alle parole sottolineate.
Ho pensato alla pila di piatti che mi aspettava a casa. Penso che certe volte si fanno le cose all’improvviso, senza stare a pensarci, cose che ti cambiano la vita.
Chiedi alla tua fidanzata di sposarti mentre state guardando un film dell’orrore, come aveva fatto papà con mamma. Oppure segui una ragazza strampalata tra i rami di un albero, con uno strofinaccio appoggiato sulla spalla.
Rispondi alle seguenti domande. Secondo te...
- ... il ragazzo lascia Leila da sola e torna a lavare i piatti? SÌ NO
- ... anche i suoi genitori avevano fatto una scelta importante senza pensarci troppo? SÌ NO
Ora puoi rispondere ai quesiti A15 e A16.
A16 Il ragazzo alla fine di questa vicenda sembra arrivare alla conclusione che a volte…
A. ... comportarsi in modo strano è più divertente che comportarsi nel solito modo.
B. ... alcune scelte importanti si fanno di slancio senza ragionare troppo a lungo.
C. ... aiutare gli altri è più importante che pensare solo a sé stessi.
D. ... i rapporti con le persone della propria famiglia insegnano come comportarsi con chi non si conosce.
Data:
Paragrafo 1
Giallo: cartone. Rosso: plastica.
Fucsia: tessuti. Blu: giornali. Verde: umido. Marrone: metalli. Bianco (o nero): generico.
Eskilstuna è la città che ha saputo trasformare la spazzatura in arcobaleno.
Ogni rifiuto ha il suo sacchetto colorato, naturalmente riciclabile.
Solo il vetro viene raccolto nella vecchia maniera.
Certo sotto il lavandino, nelle cucine di questa località a centocinquanta chilometri a Sud-
Est di Stoccolma, devono esserci sette secchi della spazzatura.
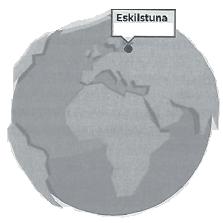
Un bello spazio e un bell’impegno per i suoi settantamila abitanti, che in gran parte hanno accettato il sistema. Il risultato è brillante: secondo l’azienda municipale della nettezza urbana, ha permesso di dimezzare i costi della raccolta differenziata e in pochissimo tempo ha consentito di raggiungere
l’obiettivo dell’Unione europea per il riciclo, cinquanta per cento dei rifiuti.
Funziona così: gli operatori ecologici mettono sui camion tutti i sacchetti insieme, ma quando questi arrivano agli impianti di raccolta, passando sui nastri trasportatori, grazie ai colori brillanti vengono riconosciuti da un lettore ottico che comanda ai bracci robotizzati di spingerli di volta in volta verso il giusto container di smaltimento.
I sacchetti vaganti rifanno il giro come i bagagli non riconosciuti agli arrivi dei voli in aeroporto fino al nuovo riconoscimento.
L’umido viene subito trasformato in biogas, carburante per i bus. Miracolo a Eskilstuna? No, la semplice traduzione pratica di una altrettanto semplice sensibilità ecologica.
In questo angolo di Svezia in effetti, tale sensibilità ha già dato vita a un’altra novità: il primo centro commerciale al mondo che vende soltanto oggetti riciclati.
Paragrafo 2
Si chiama RETUNA, RE come recycling (riciclo) e TUNA per la desinenza della città, ed è di proprietà del municipio e ospita quattordici eleganti negozi (giocattoli, libri, arredamento, abbigliamento, fai-da-te, pet shop…) oltre ad un ristorante in cui naturalmente si mangiano solo prodotti coltivati in modo sostenibile.

In tutta la zona chi vuole disfarsi di qualsiasi cosa la porta nel deposito sotterraneo: qui gli addetti smistano le donazioni (nessuna vendita) fra i negozianti, che poi valutano se è il caso di trasformare gli oggetti prima di venderli.
Non è un mercatino delle pulci1: Anna Bergstrom, che lo dirige, è un’ex manager della moda e punta a rendere anche quel centro commerciale un luogo alla moda. Intanto gli affari girano alla grande: nel 2018 le vendite sono state di 1,2 milioni di euro, con un aumento di oltre il trenta per cento rispetto all’anno precedente.
E negli spazi pubblici vengono organizzati corsi per insegnare comportamenti ecologicamente virtuosi.
Paragrafo 3
La raccolta differenziata “arcobaleno” fa già proseliti: a Berna, capitale della Confederazione Elvetica, 2500 persone stanno provando un progetto pilota per adottarla.
Fin da piccoli dobbiamo imparare che copiare è sbagliato e non si fa. Ma forse è arrivato il momento di rivedere questa stigmatizzazione2. Copiare, se il modello è buono, è cosa buona e giusta.
(Tratto e adattato da: Corriere della Sera n. 17/18, 25 Aprile 2019, testo di Edoardo Vigna.)
1 Mercato in cui si vendono cose vecchie e di scarso valore.
2 Stigmatizzazione significa condanna, forte disapprovazione.
B1 Il testo comincia con un elenco, “Giallo: cartone. Rosso: plastica. Fucsia: tessuti. Blu: giornali…”.
Che cosa è di colore giallo, rosso, fucsia oppure blu?
A. I rifiuti.
B. I camion della raccolta.
C. I contenitori del vetro.
D. I sacchetti della spazzatura.
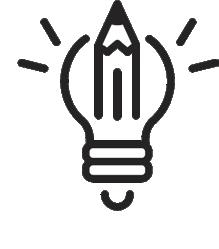
TI AIUTO!
• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle parti sottolineate.
Eskilstuna è la città che ha saputo trasformare la spazzatura in arcobaleno.
Ogni rifiuto ha il suo sacchetto colorato, naturalmente riciclabile.
Solo il vetro viene raccolto nella vecchia maniera.
Rispondi alle domande e, poi, al quesito B1
- Ad essere colorati sono i rifiuti o i sacchetti?
- Si parla di camion? SÌ NO
- Si parla dei contenitori del vetro? SÌ NO
Ora puoi rispondere ai quesiti B1 e B2.
B2 “Eskilstuna è la città che ha saputo trasformare la spazzatura in arcobaleno” (righe 5-7). Che cosa vuole dire l’autore del testo con questa frase?
Vuol dire che la spazzatura…
A. viene separata in sette gruppi diversi in base al colore dei rifiuti.
B. viene colorata con sette diversi colori per essere smaltita meglio.
C. viene messa in sacchetti di sette colori diversi secondo il tipo dei rifiuti.
D. viene messa su nastri trasportatori di sette colori diversi.
B3 Quale tipo di rifiuto viene raccolto in modo diverso dagli altri ?
A. Vetro. B. Tessuti. C. Generico. D. Umido.

TI AIUTO!
• Nel testo è scritto: “solo il vetro viene raccolto alla vecchia maniera”.
- Secondo te, la vecchia maniera prevedeva questa attenzione ai colori? SÌ NO
Ora rispondi al quesito B3
B4 Dove si trova la cittadina di Eskilstuna? Individua nel testo le informazioni e copiale negli spazi sotto.
Eskilstuna si trova in (nome del Paese) e più precisamente a chilometri da .

TI AIUTO!
• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle parti sottolineate.
... di questa località a centocinquanta chilometri a Sud- Est di Stoccolma...
In questo angolo di Svezia in effetti...
Usa le informazioni per completare il quesito B4.
B5 Come hanno reagito gli abitanti all’introduzione di questo sist ema di raccolta dei rifiuti? Individua l’informazione nel testo e poi c opiala qui sotto.

TI AIUTO!
• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle sottolineature.
Un bello spazio e un bell’impegno per i suoi settantamila abitanti, che in gran parte hanno accettato il sistema.
Usa le informazioni per completare il quesito B5
B6 Nel testo si dice che il risultato di questo sistema di raccolt a dei rifiuti “è brillante” (riga 23). Su che cosa si basa questa affermazione dell’autore?
A. Si basa sull’opinione degli abitanti di Eskilstuna.
B. Si basa sui dati forniti dall’azienda responsabile della raccolta dei rifiuti di Eskilstuna.
C. Si basa sui controlli fatti dall’Unione europea a Eskilstuna.
D. Si basa sulle vendite degli oggetti riciclati nel centro commerciale.

AIUTO!
• Rileggi questa parte del testo, facendo attenzione alle parti sottolineate.
Il risultato è brillante: secondo l’azienda municipale della nettezza urbana, ha permesso di dimezzare i costi della raccolta differenziata e in pochissimo tempo ha consentito di raggiungere l’obiettivo dell’Unione europea per il riciclo, cinquanta per cento dei rifiuti.
Rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito B6 .
- Se l’azienda è “municipale”, riguarda Eskilstuna o l’Europa?
- Che cos’è la “nettezza urbana”?
B7 Nel testo vengono citati due effetti positivi che spiegano perché il sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna è brillante. Quali sono gli effetti positivi? Trova nel testo le informazioni e scrivile negli spazi qui sotto. Questo sistema di raccolta dei rifiuti è positivo perché:

TI AIUTO!
• Rileggi di nuovo questa parte del testo.
Il risultato è brillante: secondo l’azienda municipale della nettezza urbana, ha permesso di dimezzare i costi della raccolta differenziata e in pochissimo tempo ha consentito di raggiungere l’obiettivo dell’Unione europea per il riciclo, cinquanta per cento dei rifiuti.
Usa le parti sottolineate per completare il quesito B7 .
B8 In base al testo quali sono le caratteristiche innovative della raccolta di rifiuti di Eskilstuna che permettono di avere risultati brillant i?
Metti una crocetta per ogni riga.
a. I rifiuti vengono distinti per tipo.
b. I rifiuti vengono differenziati in molti sacchetti diversi.
c. Gli operatori ecologici raccolgono i sacchetti dei rifiuti.
d. I sacchetti dei diversi rifiuti possono essere messi tutti insieme sullo stesso camion.
e. Lo smistamento dei diversi tipi di rifiuti si fa automaticamente con un lettore ottico.

È una caratteristica innovativa
Non è una caratteristica innovativa
• Prova a spiegare in modo semplice come avviene la raccolta dei rifiuti nei metodi più tradizionali, poi rispondi al quesito B8 . TI AIUTO!
B9 “Miracolo a Eskilstuna? No, la semplice traduzione pratica di una altrettanto semplice sensibilità ecologica” (righe 49-52).
Quale opinione esprime l’autore con queste parole?
A. Quello che succede a Eskilstuna non è proponibile altrove, perché richiede una grande sensibilità ecologica.
B. A Eskilstuna è successo un miracolo, perché questa città è riuscita a trovare il modo di tradurre in atti concreti l’attenzione all’ambiente.
C. Non è difficile raggiungere i risultati di Eskilstuna: basta essere sensibili all’ambiente ed essere disposti a fare uno sforzo per prendersene cura.
D. Quello che succede a Eskilstuna è il frutto di un grande progresso tecnologico, che può essere sfruttato ovunque.

• Rileggi di nuovo questa parte del testo, facendo attenzione all’aggettivo evidenziato in neretto.
“Miracolo a Eskilstuna? No, la semplice traduzione pratica di una altrettanto semplice sensibilità ecologica”.
Scegli le affermazioni giuste, poi rispondi al quesito B9
- Qualcosa di “semplice” secondo te...
... è improponibile ... avviene con un miracolo
... si ottiene con il progresso tecnologico non è difficile da raggiungere
B10 Nella città di Eskilstuna c’è anche Retuna. Che cosa è Retuna?
A. Una parte del Municipio aperta al pubblico.
B. Un deposito sotterraneo dove vengono portate donazioni dei cittadini.
C. Un mercato di alto livello che vende vestiti alla moda.
D. Un centro commerciale in cui si vendono oggetti riciclati.

TI AIUTO!
• Rileggi queste parti del testo, facendo attenzione alle parole sottolineate.
In questo angolo di Svezia in effetti, tale sensibilità ha già dato vita a un’altra novità: il primo centro commerciale al mondo che vende soltanto oggetti riciclati. [...]
Si chiama RETUNA, RE come recycling (riciclo) e TUNA per la desinenza della città.
Ora rispondi al quesito B10 .
B11 Come potrebbe essere completato il titolo perché includa anche ciò di cui si parla nel secondo paragrafo?
Una cittadina svedese trasforma la spazzatura in arcobaleno e…
A. inventa un centro commerciale che aiuta l’ambiente.
B. diventa più elegante grazie a un’ex manager della moda.
C. guadagna una fortuna con i rifiuti.
D. apre un ristorante con prodotti biologici.

TI AIUTO!
• Rileggi tutto il paragrafo 2 (righe 58-75). Il paragrafo 1 finiva così: In questo angolo di Svezia in effetti, tale sensibilità ha già dato vita a un’altra novità: il primo centro commerciale al mondo che vende soltanto oggetti riciclati ecc.
Qual è l’altra novità di cui si parla? Scegli la risposta giusta poi rispondi al quesito B11.
il tipo di centro commerciale. il ristorante “biologico”.
i prezzi dei prodotti riciclati. il lavoro dell’ex manager della moda.
B12 Come si può riassumere l’ultimo paragrafo?
A. Il sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna è convincente e la città di Berna sta giustamente provando a imitarlo.
B. La città di Berna protesta contro l’adozione del sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna e non vuole copiare questa soluzione.
C. A Berna i cittadini stanno raccogliendo firme per copiare il sistema di raccolta dei rifiuti di Eskilstuna, ma c’è chi dice che copiare è sbagliato.
D. Eskilstuna ha copiato il suo sistema di raccolta dei rifiuti da quello della città di Berna e questo non è giusto.

• Rileggi di nuovo tutto il paragrafo 3 (righe 76-81).
Qual è il significato della prima riga di questo paragrafo? (Se necessario cerca sul dizionario la parola “proselite”).
La raccolta differenziata “arcobaleno” fa già proseliti...
La raccolta differenziata “arcobaleno” ha nuovi oppositori
La raccolta differenziata “arcobaleno” ha nuovi seguaci
Ora rispondi alle domande che seguono e, poi, al quesito B12.
- In quale città è stata inventata la raccolta “arcobaleno”?
- La parte finale del testo dice che quando un modello è buono può essere copiato/imitato? SÌ NO TI AIUTO!
B13 Nel testo mancano i titoletti dei paragrafi. Indica quale titole tto è adatto a ciascun paragrafo.
Collega con una freccia ciascun paragrafo con il titoletto corrispondente. Attenzione, ci sono due titoletti in più.
a) Come gestire un centro commerciale
Paragrafo 1
Paragrafo 2
Paragrafo 3
b) In che modo si trasformano i rifiuti in energia a Eskilstuna
c) Come portare l’ecologia anche nel commercio
d) Quando le idee sono buone si diffondono
e) Come avviene la raccolta di rifiuti a Eskilstuna

• Rileggi velocemente tutti e tre i paragrafi se necessario, poi rispondi alle domande che seguono e al quesito B13 .
- Nel paragrafo 1 si parla del metodo innovativo di raccolta dei rifiuti a Eskilstuna? SÌ NO
- Nel paragrafo 2 si parla di un tipo di attività commerciale “ecologica”? SÌ NO
- Nel paragrafo 3 si parla della possibilità che le idee di Eskilstuna possano diffondersi anche in altri luoghi? SÌ NO
- C’è un paragrafo che spiega come i rifiuti si trasformano in energia? SÌ NO
- C’è un paragrafo che spiega come gestire un centro commerciale? SÌ NO
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
C1 Identifica l’unica frase nella quale il soggetto (sottolineato) compie l’azione espressa dal verbo.
A. Grazie alla sua diligenza Anna riceve sempre ottimi voti.
B. Stamattina Luca sembra preoccupato.
C. L’imperatore proviene da una famiglia antica e nobile.
D. Al concerto di stasera mio fratello suona il violino.

TI AIUTO!
• Rispondi alla domanda che segue e, poi, al quesito C1.
Quale tra le seguenti frasi minime ti suggerisce che il soggetto COMPIE ATTIVAMENTE UN’AZIONE?
Anna riceve L’imperatore proviene
Luca sembra
Mio fratello suona
C2 I bambini di una classe fanno una gara linguistica. Ritagliano delle parole dai giornali, le raggruppano e le usano per costruire frasi nuove. Maria ha proposto le seguenti frasi:
1. ragazza abita a Roma
2. cielo è nuvoloso
3. bambina piange
Secondo la maestra le frasi sono incomplete. In quale gruppo, di quelli elencati sotto, bisogna cercare le parole per completarle?
A. Aggettivi qualificativi e avverbi di qualità.
B. Articoli e aggettivi determinativi.
C. Nomi.
D. Congiunzioni.

TI AIUTO!
• Prova a completare tu queste frasi, poi, per ognuna, specifica cosa hai aggiunto.
1. ragazza abita a Roma
2. cielo nuvoloso
3. bambina piange
Che cosa hai aggiunto perlopiù? Nomi Avverbi
Aggettivi qualificativi Aggettivi e articoli determinativi
C3 I seguenti gruppi di parole sono formati da sinonimi, in ogni gruppo c’è un intruso. Indicalo con una crocetta.
Metti una crocetta per ogni riga.
1. (a) libro (b) manuale (c) testo (d) autore
2. (a) intrappolare (b) imprigionare (c) introdurre (d) catturare
3. (a) re (b) sovrano (c) fondatore (d) monarca
4. (a) nascondere (b) rivelare (c) insabbiare (d) celare

TI AIUTO!
• Completa la definizione scegliendo la parola giusta, scrivi un esempio di sinonimi, poi rispondi al quesito C3.
I sinonimi sono parole con significato UGUALE CONTRARIO
Esempio di sinonimi:
C4 Nelle seguenti frasi manca il pronome relativo adatto al contesto (es. che, di cui, in cui, a cui ecc.). Scegli l’unica frase che deve essere completata con il pronome relativo “che”.
A. Lo scoiattolo è uscito dal rifugio ? si era rintanato.
B. Viene a trovarmi Maria, la ragazza ? gioco a pallavolo.
C. Questo è un indovinello ? nessuno sa risolvere.
D. Questa è la linea immaginaria attorno ? ruota il nostro pianeta.

TI AIUTO!
Completa le frasi inserendo le parole adatte tra quelle proposte, poi rispondi al quesito C4 a cui che con cui in cui
Lo scoiattolo è uscito dal rifugio si era rintanato.
Viene a trovarmi Maria, la ragazza gioco a pallavolo.
Questo è un indovinello nessuno sa risolvere.
Questa è la linea immaginaria attorno ruota il nostro pianeta.
C5 In quale delle seguenti frasi il verbo “avere” è usato come ausiliare?
A. Orazio è un gatto dormiglione: ha sonno tutto il giorno.
B. La regina di ghiaccio ha aperto le porte del suo regno.
C. Oggi ho le tasche piene di caramelle.
D. Dopo l’allenamento ho sempre fame.

TI AIUTO!
Ripassa la regola, poi rispondi al quesito C5. Il verbo “avere” è usato come ausiliare quando “aiuta” un altro verbo a formare il tempo composto. Esempio: “Ieri ho visto Marco”. È invece usato con significato proprio quando indica “possedere”, “sentire”, ad esempio: “Marco ha una bicicletta nuova”; “Anna ha fame!”.
C6 Completa in modo corretto le parole incomplete presenti nelle seguenti frasi.
1. Il mago ha estratto un coni io dal cilindro.
2. La vita di una stella può durare mi ioni di anni.
3. Nel giardino di mio nonno cresce un cespu io di rose.
4. Finalmente possiamo tirare un sospiro di so ievo.
5. Per questo piatto servono a io, o io e peperoncino.

Ripassa la regola: non confondere il suono GLI con LI!
Il gruppo GL, quando è seguito dalla vocale I, ha un suono dolce, come nelle parole: maglia, coniglio, moglie...
Ha un suono duro in alcune parole che fanno eccezione come: glicine, glicemia, negligente...
Il suono LI si trova: nei nomi di alcuni mestieri (gioielliere, stalliere, mobiliere); all’inizio di alcune parole (liana, lievito, liuto); quando c’è la doppia L (allietare, allievo); con alcuni nomi geografici (Sicilia, Italia, Australia).
Scrivi una parola con GLI e un’altra con LI, poi completa il quesito C6. GLI LI
C7 Nelle seguenti frasi le parole in grassetto sono usate in senso proprio o in senso figurato. Per ognuna indica in quale senso è usata.
Metti una crocetta per ogni riga.
Esempio: sei un tesoro
a. Le colonne di questo tempio sono di granito.
b. Sei la luce della mia vita.
c. Durante la partita mi sentivo un leone
d. Non posso uscire: ho una montagna di compiti da finire.
e. L’alpinista è scivolato nel burrone e ha battuto la testa

Ripassa la regola, poi rispondi al quesito C7
Senso proprio Senso figurato
Il significato “proprio” di una parola è quello letterale e indica una cosa, una persona, un animale o un’azione specifica; il significato figurato è, invece, simbolico. Oltre a indicare una persona, una cosa o un’azione esprime anche le sue qualità.
Es.: In mezzo ai sassolini ho trovato una pietra. Senso proprio Valerio ha un cuore di pietra! Senso figurato
C8 Quanti sono i nomi nella frase seguente?
“Quest’anno per il mio compleanno vorrei una slitta, un monopattino, tanta felicità e allegria.”
A. Quattro
B. Cinque
C. Sei
D. Sette

TI AIUTO!
Ripassa la regola, poi rispondi al quesito C8
I nomi sono parole che indicano persone, animali, cose; sono concreti se rimandano a qualcosa o qualcuno “percepibile” con i sensi; sono astratti quando, invece, indicano sentimenti e sensazioni.
Ad esempio: tavolo = nome di cosa, concreto, maschile, singolare; tristezza = nome di cosa, astratto, femminile, singolare.
C9 Scegli l’espressione più adatta per completare il testo che seg ue.
Evian, un signore francese, in un anno e mezzo ha vinto alla lotteria due volte. Secondo le statistiche, la probabilità che questo accadesse era vicina allo zero. ………… ? …………. ha acquistato entrambi i biglietti dalla sua tabaccaia di fiducia, una signora molto simpatica che si chiama Sandrine.
A. Il nobiluomo
B. Il coraggioso
C. Il fortunato
D. Il furfante

TI AIUTO!
Analizza il significato delle parole indicate nelle varie opzioni, poi rispondi alle domande che seguono e al quesito C9
- Elvian ha vinto alla lotteria per ben due volte... per vincere alla lotteria bisogna essere:
- coraggiosi? SÌ NO - imbroglioni? SÌ NO
- di origini nobili? SÌ NO - fortunati? SÌ NO
C10 Il suffisso –tore può aggiungere alla parola di base il significa to di “persona che compie un’azione”, ad es. vincitore, addestratore, allenatore, fumatore, ammiratore.
In quale delle seguenti parole il suffisso –tore aggiunge quel s ignificato?
A. Presentatore
B. Radiatore

C. Refrigeratore
D. Ventilatore
TI AIUTO!
Rifletti sul significato delle parole indicate: scrivile sotto a ogni disegno corrispondente, cerchia la “persona che compie un’azione”, poi rispondi al quesito C10.

In base ai testi che preferisci, scegli tu l’ordine da seguire per esercitarti nelle prove invalsi di seguito riportate (puoi seguire l’ordine proposto o quello che più ti piace). Ricordati di barrare con una X le prove che hai già svolto!
AMICIZIA E AVVENTURA

LA TV E LA PUBBLICITÀ

pag. 37 - Prova n. 1
TESTO A - UN BAGNO NELLA LAGUNA
TESTO B - A FAVORE O CONTRO LA TV?
IL TEMPO E LE STAGIONI
SPORT E BENESSERE

pag. 72 - Prova n. 3
TESTO A - CHE BELLO QUANDO...
TESTO B - LO SPORT PREPARA ALLA VITA
FANTASIA E MAGIA
ANIMALI DOMESTICI
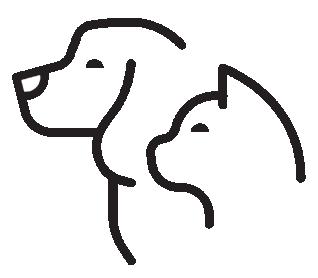
pag. 54 - Prova n. 2
TESTO A - UNA STRANA PIETRA
TESTO B - AMICI ANIMALI
FAMIGLIA ED EMOZIONI
I NOSTRI ANZIANI
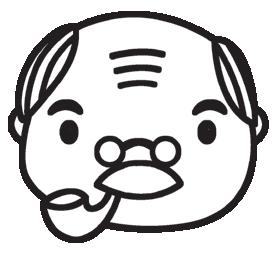
pag. 88 - Prova n. 4
TESTO A - UNA GIORNATA IN SPIAGGIA
TESTO B - I NOSTRI CARI ANZIANI

Data:
– Beh, sei contenta adesso che ti abbiamo portata al mare? – chiese Veronica gettandosi sulla spiaggia all’ombra di un grande cespuglio di ginepro.
– Se avessi saputo che era così lontana non sarei venuta – boccheggiò Giulia.
– Pappamolle – la derise Pietro. – Quante storie per un po’ di caldo!
Guardati attorno! Valeva la pena o no di pedalare sotto il sole?
Giulia guardò e dovette riconoscere che ne era valsa la pena, e come!
La strada per arrivare alla spiaggia era stata tremenda: polverosa, piena di buche, senza un albero o un cespuglio che offrisse un minimo filo d’ombra ai poveri ciclisti.
E, per finire, nell’ultimo tratto i ragazzi avevano tagliato per i campi trascinandosi le biciclette a mano.
– In questa spiaggia con le automobili non si può arrivare – aveva detto Vincenzo soddisfatto. – Perciò i turisti non l’hanno ancora scoperta.
O ci arrivi dal mare, o devi fare quest’ultimo tratto a piedi.
– E, come vedi, – aveva aggiunto Veronica – non c’è neppure un sentiero.
Siamo in pochi a conoscere la direzione giusta, e così la spiaggia è tutta per noi.
La spiaggia era bellissima, di sabbia bianca e fine, disseminata di conchiglie e pezzetti di corallo.
A pochi metri dalla riva si sollevava in piccole dune su cui fiorivano ciuffi di giunchi e gigli selvatici e crescevano folti cespugli di ginepro modellati dal vento in modo da formare delle capanne naturali.
Ma ciò che la rendeva così pittoresca, pensò Giulia, era il fatto che la lingua sabbiosa era profonda soltanto una ventina di metri, al di là dei quali si apriva una specie di laguna di forma allungata che comunicava con il mare aperto solo attraverso un canale ostruito da una diga di canne.
L’acqua, in questo bacino naturale, era limpida come quella del mare aperto e vi si potevano vedere guizzare banchi di pesci di tutte le dimensioni.
I ragazzi cominciarono con il fare il bagno nella laguna, e Giulia dette uno strillo

Poi raggiunsero la riva del mare e si inseguirono sul bagnoasciuga, schizzandosi, lanciandosi delle grosse pallottole di alghe marroni buttate a riva dalle onde. Alcuni fecero una gara di tuffi da uno scoglio.
Verso l’una mangiarono il pranzo che si erano portati dietro nelle borse termiche e sonnecchiarono all’ombra dei cespugli chiacchierando sottovoce.
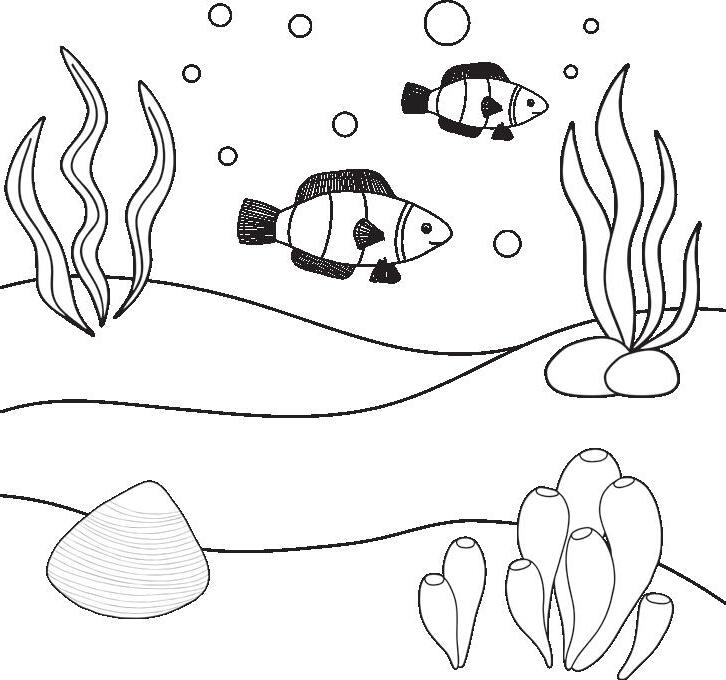
Giulia era contenta. Sentiva un grande benessere non solo nei pensieri, ma in ogni parte del corpo, dalle dita dei piedi alle spalle, dove la pelle le prudeva un poco perché l’acqua asciugandosi le aveva lasciato un velo di sale.
(B. Pitzorno, Sulle tracce del tesoro scomparso, Mondadori)
A1 A chi l’autore fa narrare la vicenda raccontata?
A. A Giulia.
B. A Veronica.
C. A Pietro.
D. A un narratore esterno al racconto.
A2 Alla riga 3 è scritto: “... boccheggiò Giulia”. Ciò significa ch e... altissimo quando un grosso pesce d’argento le sfiorò una gamba nuotando.
A. ... Giulia non riusciva a rimanere in silenzio.
B. ... Giulia faceva delle smorfie.
C. ... Giulia era affaticata.
D. ... Giulia parlava con voce stridula.

A3 – Pappamolle – la derise Pietro (riga 4).
Come potresti sostituire la parola sottolineata?
A. Codarda.
B. Sfaticata.
C. Maleducata.
D. Simpaticona.
A4 Perché, secondo te, “Giulia dovette riconoscere che ne era vals a la pena”? (riga 6).
A. Perché il paesaggio era meraviglioso.
B. Perché non tutti avevano la fortuna di percorrere quella strada.
C. Perché aveva dimostrato il suo coraggio.
D. Perché aveva dimostrato la sua forza.
A5 Da quello che puoi capire dal testo, questo gruppo di amici è c omposto da almeno...
A. ... d ue bambini e una bambina.
B. ... d ue bambine e due bambini.
C. ... tre bambini e una bambina.
D. ... tre bambine e un bambino.

A6 Come arrivò alla laguna questo gruppo di amici?
A. In automobile.
B. In barca.
C. Nuotando e camminando.
D. Pedalando e camminando.
A7 Di che cosa era soddisfatto Vincenzo (riga 12-13)?
A. Di aver trovato un posto senza traffico.
B. Di aver trovato un’isola deserta.
C. Che solo poche persone sapevano dove si trovava quella laguna.
D. Di essere riuscito ad arrivare a nuoto.
A8 La spiaggia era disseminata (riga 17) di conchiglie e pezzetti di corallo. Come potresti sostituire la parola sottolineata?
A. Decorata.
B. Cosparsa.
C. Piena.
D. Seminata.

A9 Alle righe 20-21 è scritto “in modo da formare delle capanne na turali”.
Da che cosa erano formate queste capanne naturali?
A. Dai cespugli di ginepro piegati dal vento.
B. Dai ciuffi di giunchi modellati dal vento.
C. Dai gigli selvatici modellati dal vento.
D. Dall’intreccio dei giunchi con i gigli selvatici.
A10 Cos’è che rendeva la laguna così pittoresca agli occhi di Giuli a?
A. La sabbia bianca e fine.
B. La presenza di un’isola in mezzo al mare aperto.
C. Il fatto che solo una piccola fascia sabbiosa la separasse dal mare.
D. La limpidezza dell’acqua del mare.
A11 Sotto sono riportati alcuni eventi della vicenda. Metti questi eventi in ordine cronologico cioè nell’ordine in cui sono successi.
Il primo evento è già stato indicato. Scrivi un numero da 2 a 5 per ordinare gli altri eventi.
Ordine in cui gli eventi sono successi
a. I ragazzi osservarono con stupore le meraviglie della laguna.
I ragazzi arrivarono alla laguna.
b. Giulia diede uno strillo altissimo.
c. Mangiarono il pranzo e sonnecchiarono all’ombra dei cespugli.
d. I ragazzi giocarono a rincorrersi sulla spiaggia e a fare tuffi in acqua. 1

A12 Nella laguna i ragazzi hanno fatto diverse esperienze divertent i.
Quale fatto, tra i seguenti, NON viene descritto nel testo?
A. Hanno fatto una gara di nuoto.
B. Si sono lanciati pallottole di alghe.
C. Hanno fatto un sonnellino.
D. Hanno mangiato il pranzo che si erano portati.
A13 Qual è la frase che riassume al meglio l’ultima parte del testo riportata qui accanto?
Giulia era contenta. Sentiva un grande benessere non solo nei pensieri, ma in ogni parte del corpo, dalle dita dei piedi alle spalle, dove la pelle le prudeva un poco perché l’acqua asciugandosi le aveva lasciato un velo di sale.
A. Stando in laguna, Giulia sentiva prurito in ogni parte del corpo.
B. Giulia aveva pensieri negativi, poiché sentiva uno strano prurito nel corpo.
C. Stando in laguna, Giulia si sentiva bene fisicamente, ma aveva strani pensieri.
D. Per Giulia stare nella laguna è stata una piacevolissima esperienza.
A14 Dopo aver letto l’intero racconto, si capisce che cosa pensano della laguna i componenti di questo gruppo di amici. Indica quali potrebbero essere i loro pensieri e quali no.
Metti una crocetta per ogni riga.
La laguna SÌ NO
a. Non era facile da raggiungere.
b. Non offriva molti divertimenti, perché era quasi deserta.
c. Offriva un meraviglioso paesaggio naturale.
d. Trasmetteva una sensazione di solitudine e il mare aperto faceva spavento.

Data:
Paragrafo 1
Alcuni sono molto preoccupati. A causa della televisione i ragazzi parlano poco con i genitori, non giocano, non si incontrano con i compagni, si adeguano a modelli di comportamento uniformi, diventano preda del consumismo stimolato dalla pubblicità. L’uso eccessivo della TV li distrae anche dalla lettura e dallo studio.
Qualcuno afferma inoltre che gli spettacoli televisivi, anche quelli per bambini, sono troppo violenti e quindi possono spingere alla violenza o creare paure e ansie.
Altri non vedono nello strumento televisivo un nemico. Essi ritengono innanzitutto che i bambini, senza la televisione, passerebbero buona parte della loro giornata in solitudine, poiché i genitori sono al lavoro.
Tanti bambini vivono poi in famiglie in cui il dialogo è molto limitato. La televisione in questi casi offre stimoli e interessi inesistenti. I ragazzi conversano idealmente con i loro personaggi televisivi, e, imparando a conoscere realtà lontane, vivono avventure con la fantasia.

Senza la televisione i ragazzi avrebbero meno stimoli per la loro riflessione e creatività. Tra l’altro alcuni spettacoli televisivi possono invitare a leggere libri da cui sono stati tratti o quelli creati successivamente con i personaggi nati per il video.
La televisione integra soltanto l’azione formativa della società, della scuola e della famiglia.
Alcune recenti ricerche in Italia hanno evidenziato che un’altissima percentuale di genitori non vede più nella televisione un pericolo, contemporaneamente, però, c’è la generalizzata richiesta di una TV migliore, capace di arricchire culturalmente con spettacoli e con trasmissioni piacevoli e allo stesso tempo intelligenti.

In sostanza, la televisione è ormai accettata; ora si chiede che venga utilizzata al meglio. Inoltre, i programmi televisivi vengono spesso interrotti dalla pubblicità che, anche se non ce ne rendiamo conto, può condizionare molto le nostre scelte e, di conseguenza, le nostre vite.
Paragrafo 2
Alcuni economisti mettono in discussione la funzione della pubblicità, individuando in essa uno spreco di risorse. In particolare questa corrente afferma che la pubblicità riduce il benessere economico. I suoi costi, infatti, sono sostenuti dal produttore, ma vengono pagati dal consumatore con un incremento del prezzo del prodotto pubblicizzato. Soprattutto per i prodotti di largo consumo, con costi di produzione relativamente bassi, gli elevati costi di pubblicità incidono in maniera determinante sul prezzo finale.
Una seconda argomentazione a favore di questa teoria è che la pubblicità si limita sempre a mettere in luce aspetti migliori o più desiderabili di un prodotto, ma non permette al consumatore di valutare con obiettività il valore effettivo del prodotto. Infine, è evidente la potenza invasiva della pubblicità; essa infatti utilizza tutti i mezzi di comunicazione; si incontra dappertutto, anche quando è indesiderata, ed è impossibile evitarla.
Per altri economisti, invece, la pubblicità sarebbe uno strumento per aumentare la concorrenza, perché rende note ai consumatori le diverse qualità dei prodotti simili. In tal modo le imprese sono costrette a ricercare continui miglioramenti dei prodotti per superare quelli delle altre imprese.
Un ulteriore elemento a favore sarebbe il fatto che il consumatore ha bisogno della pubblicità nei mercati in cui esistono moltissimi prodotti e in cui il grado di innovazione è molto elevato: in questi mercati, infatti, la pubblicità costituisce uno strumento indispensabile di informazione per il consumatore, che riesce ad avere un quadro pressoché completo delle alternative di acquisto. Inoltre la pubblicità non è in grado di trarre in inganno il consumatore, né di dirigere il suo comportamento, finché egli ricorda che la pubblicità è sempre una comunicazione interessata e di parte, da ricevere mantenendo il proprio senso critico.
(Adatt. da Detti, Ghionda, Golzo, Il primo libro del cittadino, La Nuova Italia; R. Zordan, Il quadrato magico, Fabbri Editori)

B1 Il testo comincia dicendo che “Alcuni sono molto preoccupati”... (righe 1-8).
Di che cosa sono preoccupati riguardo alla TV?
Metti una crocetta per ogni riga.
Del fatto che la TV SÌ NO
a. Impedisce lo sviluppo delle relazioni.
b. Offre programmi culturali molto interessanti, ma difficili per i bambini.
c. Produce un consumo eccessivo di energia elettrica.
d. Stimola il consumo, uniformando i comportamenti degli spettatori.
B2 Come potresti sostituire questa frase: “Altri non vedono nello strumento televisivo un nemico (righe 9-10)”.
A. Altri non pensano che la TV presenti personaggi negativi.
B. Altri non pensano che la TV sia uno “strumento” negativo.
C. Altri pensano che la TV non dovrebbe parlare di nemici.
D. Altri pensano che chi guarda la TV non abbia nemici.
B3 Chi non vede nella TV “un nemico”, che cosa sostiene innanzitutto (righe 11-16)?
A. Che gli spettacoli televisivi non sono troppo violenti.
B. Che la TV è un rimedio contro la solitudine.
C. Che la TV evita il dialogo in famiglia.
D. Che la TV non rappresenta alcun pericolo.

B4 Quali tipi di “benefici” offrirebbe la TV ai bambini (righe 16-21)?
A. Permette loro di parlare con personaggi ideali.
B. Consente di vivere avventure reali.
C. Stimola la riflessione e la creatività.
D. Consente di sostituire la realtà con la fantasia.
B5 Nel testo si dice che la TV potrebbe stimolare la lettura.
In che modo? Scrivi le due informazioni che puoi ricavare dal t esto.
B6 Che cosa vuol dire che “la televisione integra soltanto l’azione formativa della società, della scuola e della famiglia” (righe 24-25).
A. Che anche la TV può avere un ruolo educativo.
B. Che la TV ha molta importanza nella società.
C. Che la TV è sullo stesso piano della scuola e della famiglia.
D. Che senza la TV scuola e famiglia non basterebbero alla società.
B7 Anche chi non vede la TV come un “pericolo”, che cosa si aspetta che cambi?
A. Che dia programmi più facilmente comprensibili.
B. Che si specializzi su programmi per bambini.
C. Che possa essere adatta anche a chi è intelligente.
D. Che arricchisca culturalmente chi la guarda.

B8 Qual è la prima motivazione per cui alcuni economisti considerano la pubblicità uno spreco di risorse (righe 35-41)?
A. Che non sia necessaria per i prodotti di largo consumo.
B. Che pur non pesando sui consumatori, danneggia i produttori.
C. Che fa aumentare i prezzi dei prodotti, anche di prima necessità.
D. Che fa aumentare inutilmente i consumi.
B9 Sempre secondo alcuni economisti, in che modo la pubblicità danneggia il consumatore (righe 42-44)?
A. Gli impedisce di risparmiare.
B. Non gli fa vedere i prodotti per quello che sono realmente.
C. Rendono desiderabili solo i prodotti migliori.
D. Gli fa sviluppare un eccessivo senso critico verso i prodotti.
B10 Che vuol dire che la pubblicità “ha potenza invasiva” (riga 45) ?
A. Che è presente dappertutto.
B. Che influenza negativamente ogni ambito della vita.
C. Che caratterizza specialmente i prodotti più usati.
D. Che riesce sempre a essere convincente.
B11 Se la pubblicità fa aumentare la concorrenza (righe 48-50), vuol dire che tra le imprese...
A. ... c’è più collaborazione.
B. ... c’è più alleanza.
C. ... c’è più lealtà.
D. ... c’è più competizione.

B12 Ora che hai letto tutto il paragrafo 2, puoi stabilire quali affermazioni che puoi ricavare dal testo sono VERE o FALSE.
Metti una crocetta per ogni riga.
La pubblicità VERO FALSO
a. Non danneggia quei consumatori che riescono a mantenere il proprio senso critico.
b. Dà sempre informazioni false sui prodotti, ingannando, così, i consumatori.
c. Fa conoscere al consumatore più alternative di acquisto.
d. Stimola la competizione tra i consumatori che vogliono solo i prodotti più costosi.
B13 Nel testo mancano i titoletti dei paragrafi. Indica quale titole tto è adatto a ciascun paragrafo.
Collega con una freccia ciascun paragrafo con il titoletto corrispondente. Attenzione, ci sono due titoletti in più.
a) I bambini e la TV
Paragrafo 1
Paragrafo 2
b) Una TV a misura di bambino
c) Attenzione: la pubblicità inganna sempre!
d) La pubblicità: aspetti positivi e negativi
e) I bambini e la pubblicità
C1 Identifica in quali frasi la ha la funzione di pronome.
A. È arrivata una lettera per te, la puoi aprire subito!
B. La zia ci ha invitato a cena domani sera.
C. Ho tutti gli ingredienti per fare la torta.
D. La sorpresa più bella è stata incontrarti al mare!
C2 Quale dei seguenti verbi NON è un verbo alterato, cioè non è formato con un suffisso che si aggiunge al verbo di base?
A. Mangiucchiare.
B. Canticchiare.
C. Rubacchiare.
D. Chiacchierare.
C3 In quale delle seguenti frasi la parola sottolineata ha la funz ione di complemento oggetto (complemento diretto)?
A. Il miele è un alimento molto nutriente.
B. Il barattolo del miele è nella dispensa.
C. Viene prodotto dalle api il miele.
D. Come dolcificante ho preso del miele.
C4 In quale delle seguenti frasi il verbo essere è usato come ausiliare?
A. Oggi sono a pranzo al mare.
B. Ieri sono andato al cinema con Sara.
C. Le caramelle sono molto dolci.
D. Andrea e Paolo sono amici.
C5 In quale delle seguenti frasi la divisione in gruppi sintattici è corretta?
A. Questa estate / andrò in vacanza / in Sardegna con Mario.
B. Paolo / ha preso / un brutto voto / in matematica.
C. Ottavio preferisce / andare in palestra / alla mattina.
D. Giovanni prende / il caffè / senza zucchero.
C6 Uno dei seguenti nomi NON è un nome COMPOSTO. Trovalo.
A. Capogiro.
B. Capoluogo.
C. Capostazione.
D. Cappotto.
C7 Indica se la parola sottolineata ha la funzione di nome o di ve rbo.
Metti una crocetta per ogni riga.
a. Sono arrabbiato con lui e gli ho tolto il saluto.
b. Ti saluto velocemente perché vado di fretta!
c. Marco si è specializzato nel salto in lungo.
d. Quando salto il pranzo sono affamata!
C8 Indica se il pezzo di frase sottolineato è necessario o non è necessario perché la frase sia grammaticalmente completa e corretta.
Metti una crocetta per ogni riga. È NECESSARIO NON È NECESSARIO
Es.: Il cane rincorre il gatto nel giardino di casa mia
a. La mamma è andata a fare la spesa .
b. Le api volano intorno al fiore
c. Maria prende lezioni di musica
d. Mantenere la calma è indispensabile .
C9 Metti in scala di intensità le parole che seguono, scrivendo ne i riquadri i numeri dal 2 al 4. La prima parola è già stata indicata con il numero 1. Segui l’esempio.
Es. 1 asciutto 3 bagnato 4 fradicio 2 umido
a) 1 insapore salato saporito scondito
b) 1 tranquillo irrequieto agitato preoccupato
c) 1 brutto bello grazioso stupendo
d) 1 chiudere spalancare aprire socchiudere
C10 In ogni serie indica le due parole che hanno lo stesso significa to.
a. camminare saltare marciare correre
b. disegnare raccontare sognare illustrare
c. triste lieto contento simpatico
d. vocabolario testo parola vocabolo
Colora i quesiti a cui hai risposto correttamente.
C10-d
B13.2 C10-c
A14-d
A14-c
A14-b
A14-a
A13
RISPOSTE CORRETTE
B13.1 C10-b
B12-d C10-a
B12-c C9-d
B12-b C9-c
B12-a C9-b
A12 B11 C9-a
A11-d B10 C8-d
A11-c B9 C8-c
A11-b B8 C8-b
A11-a B7 C8-a
comprensione del testo e lessico (testo narrativo)
B1-a C1
comprensione del testo e lessico (testo argomentativo)
morfologia, sintassi e lessico
Ora osserva il grafico e rispondi: - hai risposto correttamente alla maggior parte dei quesiti? SÌ NO - quanti punti hai totalizzato sul totale? /63 - come hai trovato questa prova? Barra la faccina corrispondente.
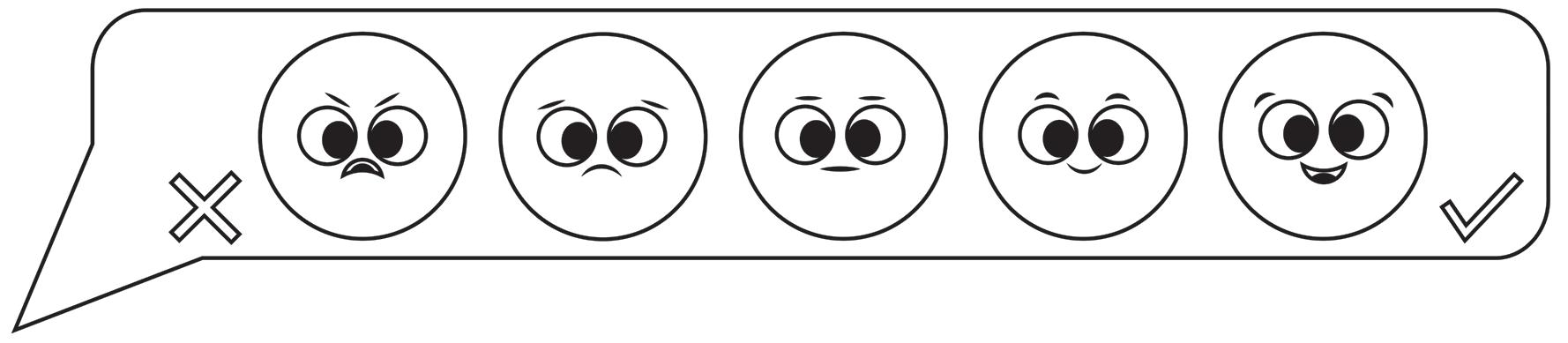
Data:
Eragon, caccia sulle montagne, trova una grande e splendida pietra azzurra. Affascinato, la raccoglie, senza sapere che segnerà il suo destino.
Quella notte Eragon si svegliò di soprassalto. Drizzò le orecchie. Uno squittio acuto lacerò il silenzio. Cercò a tentoni la scatola con l’acciarino e accese una candela.
Lo squittio era troppo forte per appartenere a un topo o a un ratto, ma controllò lo stesso sotto al letto. Niente. Un altro squittio lo fece sobbalzare.
Da dove veniva quel rumore? Il suo sguardo si posò sulla pietra. La prese dalla mensola e cominciò ad accarezzarla distrattamente, mentre esaminava la stanza. Un altro squittio gli trillò nelle orecchie e gli riverberò nelle dita: veniva dalla pietra. Quella cosa non gli aveva procurato che rabbia e delusione e adesso non lo faceva nemmeno dormire!
La pietra ignorò il suo sguardo furente e continuò a emettere qualche raro pigolio. Poi diede un ultimo, sonoro squittio e tacque. Eragon la rimise al suo posto e tornò sotto le coperte. Qualunque fosse il segreto della pietra, avrebbe dovuto aspettare la mattina dopo.
La luna filtrava dalla finestra quando Eragon si svegliò ancora. La pietra dondolava furiosamente sulla mensola, cozzando contro la parete. Eragon balzò fuori dal letto. Il movimento cessò, ma il ragazzo rimase in guardia.
Poi la pietra ricominciò a squittire e a vibrare più forte di prima. Le oscillazioni cessarono di nuovo; la pietra si acquietò.
Poi ebbe un fremito, s’inclinò in avanti e cadde sul pavimento con un tonfo.
Eragon fece un passo verso la porta, mentre la pietra rotolava verso di lui.
A un tratto, sulla superficie comparve una pietra. Poi un’altra, e un’altra ancora.
Affascinato, Eragon si chinò per osservarla. In cima, dove si incontrava la ragnatela di fessure, un piccolo frammento sussultò, come se fosse in equilibrio, si sollevò e infine cadde sul pavimento.

Dopo un’altra serie di squittii, dal foro sbucò una piccola testa nera, seguita da un bizzarro corpo contorto.
In pochi istanti la creatura sgusciò del tutto fuori dalla pietra.
Davanti a lui, intento a leccar via la membrana che lo ricopriva, c’era un drago. Il drago era lungo appena quanto il suo avambraccio, eppure aveva un’aria nobile e dignitosa. Le sue squame erano blu zaffiro, lo stesso colore della pietra.
Anzi, ormai era chiaro: no una pietra, un uovo.
Eragon si mosse appena, e il drago girò la testa di scatto e lo fissò con i suoi occhi azzurro ghiaccio. Con un frullo d’ali balzò sul letto e strisciò verso il cuscino, pigolando. La sua bocca spalancata aveva un che di commovente, come il becco di un pulcino, ma era irta di denti aguzzi.
Eragon ritrasse il braccio. Nell’osservare la piccola creatura, gli sfuggì un sorriso di tenerezza.
(C. Paolini, Eragon, Fabbri Editori)
A1 Dall’introduzione (righe 1-2) si capisce che...
A. ... che una pietra avrà un ruolo importante nelle vicende del racconto.
B. ... Eragon conosceva già l’importanza di quella pietra.
C. ... la pietra era fatta di un materiale molto prezioso.
D. ... Eragon avrebbe voluto legare il suo destino a una pietra.
A2 Nella terza riga è scritto che quella notte Eragon “si svegliò di soprassalto. Drizzò le orecchie”. Come potresti sostituire la frase sottolineata?
A. Si svegliò lentamente e si toccò le orecchie.
B. Si svegliò all’improvviso e si mise in ascolto.
C. Si svegliò con un salto e raddrizzò le orecchie.
D. Saltò giù dal letto e si coprì le orecchie.
A3 Quali emozioni provava Eragon nel sentire più volte quell’acuto squittio (righe 3-5)?
A. Gioia e curiosità.
B. Gioia e spavento.
C. Spavento e stupore.
D. Calma e stupore.
A4 Quando Eragon prese in mano la pietra, “un altro squittio [...] gli riverberò nelle dita” (riga 10). Che cosa vuol dire?
A. Che lo squittio fece vibrare la pietra.
B. Che lo squittio fece scivolare la pietra tra le sue dita.
C. Che dopo lo squittio, Eragon afferrò forte la pietra.
D. Che dopo lo squittio, Eragon accarezzò delicatamente la pietra.
A5 La pietra ignorò il suo sguardo furente (riga 13). Come potresti sostituire la parola sottolineata?
A. Affascinante.
B. Agitato.
C. Furioso.
D. Preoccupato.
A6 “Nel testo è scritto: “Eragon la rimise al suo posto e tornò sotto le coperte.
Qualunque fosse il segreto della pietra, avrebbe dovuto aspettare la mattina dopo” (righe 14-16).
Perché avrebbe dovuto aspettare la mattina dopo?
A. Perché la pietra avrebbe svelato il suo segreto la mattina dopo.
B. Perché la pietra alla mattina avrebbe smesso di squittire.
C. Perché era troppo arrabbiato per comprendere un mistero.
D. Perché Eragon aveva deciso di ritornare a dormire.
A7 Sotto sono riportati alcuni eventi della vicenda (righe 17-22) .
Metti questi eventi in ordine cronologico cioè nell’ordine in cui sono successi.
Il primo evento è già stato indicato. Scrivi un numero da 2 a 5 per ordinare gli altri eventi.
Eventi della vicenda
a. Eragon si svegliò ancora.
La luna filtrava dalla finestra.
b. La pietra cadde sul pavimento con un tonfo.
c. La pietra iniziò a rotolare verso Eragon.
Ordine in cui gli eventi sono successi
d. Eragon balzò fuori dal letto. 1
A8 Perché in cima alla pietra “un piccolo frammento sussultò” (righe 26-28)?
A. Perché dalla pietra stava per uscire fuori qualcosa.
B. Perché la pietra, cadendo, continuava a rotolare.
C. Perché la pietra, cadendo, si era frantumata.
D. Perché la pietra era stata rotta da Eragon.
A9 Come potresti sostituire la frase: “Il drago era lungo appena quanto il suo avambraccio, eppure aveva un’aria nobile e dignitosa.” (righe 34-35)”?
A. Anche se di grandi dimensioni, il drago era un’umile creatura.
B. Anche se di piccole dimensioni, il drago si dava importanza.
C. Anche se più piccolo di Eragon, il drago era più importante di lui.
D. Il drago era più grande di Eragon, ma più umile di lui.
A10 Eragon alla fine del testo lo scopre: che cos’era in realtà quel la pietra azzurra?
Risposta:
A11 Che cosa fece il drago appena vide Eragon?
A. Lo fissò attentamente e poi andò verso di lui.
B. Lo fissò attenamente e poi si mise a dormire nel suo letto.
C. Mosse le ali e iniziò a volare per tutta la stanza.
D. Mosse le ali e si infilò sotto il suo cuscino.
A12 Come potresti sostituire l’espressione “frullo d’ali” (riga 38)?
A. Fruscìo.
B. Sfregamento.
C. Rumore.
D. Battito d’ali.
A13 Come potresti sostituire la parola “pigolando” (riga 39)?
A. Strillando.
B. Piagnucolando.
C. Cantando.
D. Esultando.
A14 Che cosa suscita in Eragon la vista del drago?
A. Paura.
B. Gioia.
C. Dolcezza.
D. Sorpresa.
A15 Ora che hai letto tutto il testo, puoi stabilire quali affermazioni che puoi ricavare dal testo sono VERE o FALSE.
Metti una crocetta per ogni riga.
a. I rumori e i movimenti di una pietra disturbarono il sonno di Eragon.
b. Eragon era talmente arrabbiato con quella pietra che la fece cadere a terra, rompendola.
c. Eragon inizialmente provava spavento e rabbia, ma poi tenerezza.
d. Rompendosi, la membrana della pietra si trasformò in un drago azzurro.

Data:
Paragrafo 1
Gli animali domestici contribuiscono significativamente al miglioramento della salute mentale, riducendo stress, ansia e depressione. Interazioni come accarezzare un cane o giocare con un gatto promuovono relax e felicità. Inoltre, incoraggiano uno stile di vita attivo, promuovendo l’esercizio fisico regolare attraverso attività come camminare con il cane, che può migliorare la salute cardiovascolare e ridurre il rischio di malattie croniche.
Ai bambini, crescere con un animale domestico insegna il rispetto per gli esseri viventi, la responsabilità e la compassione, oltre a sviluppare competenze sociali ed emotive e stimolare l’attività fisica e l’immaginazione.
Anche nelle terapie assistite, gli animali domestici sono impiegati per migliorare la salute fisica e mentale di persone con varie condizioni, offrendo conforto emotivo, incoraggiando la comunicazione e migliorando le capacità motorie, con un impatto positivo sulla qualità della vita.
Prendersi cura di un animale domestico comporta responsabilità come fornire una corretta alimentazione, cure veterinarie adeguate, attività fisica e attenzione. È essenziale dedicare tempo ed energie alla loro cura per garantire una convivenza armoniosa e il loro benessere.
Paragrafo 2
Avere un gatto in casa fa bene alla salute. Per chi possiede animali in casa, ed è spesso criticato da coloro che invece sono contrari a tenerli perché “sporcano”, sarà una consolazione sapere che vivranno più a lungo dei loro oppositori. E le ragioni sostanzialmente sono due. In primo luogo, è noto che il contatto fisico con un gatto riduce notevolmente lo stress. Nel corso di esperimenti di laboratorio si è provato che persone con problemi nervosi quando incominciavano ad accarezzare i loro gatti, diventavano molto più calme.

La tensione si allentava e i corpi si rilassavano. Da uno studio condotto negli Stati Uniti è addirittura risultato che chi soffre di problemi cardiaci può letteralmente
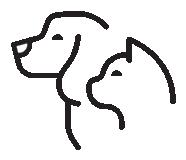
salvarsi la vita vivendo in compagnia di un gatto.
In secondo luogo, il piccolo felino ha un impatto benefico sull’uomo non soltanto per il contatto fisico, ma anche per certi fattori psicologici.
Il rapporto con un gatto è un rapporto nel quale mancano i tradimenti, le contraddizioni e le complessità che invece esistono nei rapporti tra gli esseri umani.
Per le persone che hanno perso fiducia negli altri, un legame con un gatto può far nascere la stima nell’uomo, ridurre la diffidenza e persino curare le ferite nascoste.
Paragrafo 3
È opinione diffusa che i gatti siano falsi e traditori. Si tratta in realtà di una stupidaggine, che di fatto non ha mai trovato sufficienti conferme da parte della scienza.
Sul muso di un gatto è sempre possibile leggerne chiaramente lo stato d’animo, e chi conosce questi felini lo sa bene: si capisce sempre ciò che gli passa per la testa, ed è altrettanto semplice prevedere quel che ci si deve attendere da lui. È inconfondibile la sua espressione di fiduciosa cordialità, quando rivolge all’osservatore il musetto con le orecchie diritte e gli occhi ben aperti. E ugualmente espressivi sono i suoi gesti di minaccia, che si differenziano a seconda che abbia davanti a sé un “amico” che si è preso un po’ troppa confidenza, o un vero e temuto “nemico”. A volte intende solo difendersi, altre volte, sentendosi superiore all’avversario, gli annuncia la sua intenzione di aggredirlo. E non manca poi di farlo: il gatto non graffia e non morde mai senza prima aver messo in guardia chi lo ha offeso; anzi, subito prima dell’attacco, di solito si assiste a un aggravamento dei gesti di minaccia. È come se in questo modo volesse dire: “Se non la smetti, sarò costretto ad aggredirti!”.
Di fronte alle minacce di un cane, il gatto risponde inarcando la schiena: la gobba, assieme al pelo arruffato del dorso e della coda, fanno sì che al nemico appaia più grosso di quanto non sia in realtà. Le orecchie sono appiattite, gli angoli della bocca tirati indietro, il naso arricciato. Dal petto dell’animale sale un lieve brontolio metallico che suona terribilmente minaccioso. Se l’avversario retrocede anche per un solo istante, il gatto ne approfitta per fuggire.
(K.Lorenz, L’anello di re Salomone, Adelphi; Ilgatto,tuttiiperché, Mondadori; adatt. da skuola.net)

B1 Rileggi il testo alle righe 1-3.
Quale affermazione le rissume meglio?
A. Interagire con cani e gatti migliora la nostra salute.
B. Interagire con gli animali domestici migliore la salute mentale.
C. Solo interagire con cani e gatti apporta relax e felicità.
D. Non tutti gli animali domestici aiutano a prevenire alcune malattie.
B2 Nel testo è riportato un esempio di come gli animali incoraggino uno stile di vita attivo. Scrivilo sulla riga.
a)
Ora pensa tu a un altro esempio e riportalo sulla riga.
b)
B3 Nel testo del paragrafo 1 sono riportati altri aspetti positivi degli animali domestici. Quali informazioni si possono ricavare dal testo e quali no?
Metti una crocetta per ogni riga.
Gli animali domestici Si può ricavare Non si può ricavare
a. Possono avere effetti positivi anche con persone che hanno bisogno di assistenza.
b. Influiscono sul benessere emotivo, sulle competenze comunicative e motorie.
c. Sono indispensabili per ridurre il senso di solitudine degli anziani.
d. Apportano benefici alla salute del cuore e aiutano a prevenire alcune malattie.
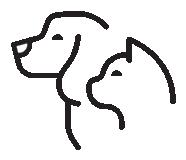
B4 Dalla fine del paragrafo 1, si può capire che...
A. ... se si ha un animale domestico, è giusto dedicargli tempo e dargli ciò di cui ha bisogno.
B. ... gli animali domestici riescono a procurarsi da soli ciò di cui hanno bisogno.
C. ... accudire un animale domestico è meno impegnativo di quanto si pensi.
D. ... accudire un animale domestico è un ottimo passatempo.
B5 “Per chi possiede animali in casa, ed è spesso criticato da coloro che invece sono contrari a tenerli perché ‘sporcano’, sarà una consolazione sapere che vivranno più a lungo dei loro oppositori” (righe 20-22).
Questo pezzo di testo ci vuole dire che...
A. ... non è vero che gli animali domestici “sporcano”.
B. ... chi critica gli animali domestici non avrà lunga vita.
C. ... chi possiede un animale domestico merita di essere criticato.
D. ... gli animali domestici possono migliorare e dunque allungare la vita di chi li possiede.
B6 Nel testo è scritto che il rapporto con un gatto “è un rapporto nel quale mancano i tradimenti, le contraddizioni e le complessità che invece esistono nei rapporti tra gli esseri umani” (righe 32-34).
Se al posto del punto ci fosse una virgola, quale frasi, tra le seguenti, potrebbe completare il pezzo di testo che hai appena letto?
A. , quindi facilita la capacità di dialogo.
B. , quindi facilita la capacità di relazione.
C. , quindi aiuta a sviluppare l’onestà.
D. , quindi educa alla fedeltà.

B7 Rileggi l’ultima parte del paragrafo 2 (righe 35-36).
Qual è il messaggio finale del paragrafo 2?
A. Il gatto è il miglior animale domestico che ci sia.
B. Il gatto non riconosce le tue ferite, ma ti aiuta a credere in te stesso.
C. Il gatto aiuta a recuperare il rapporto con le persone.
D. Il gatto è adatto alle persone diffidenti come lui.
B8 Come potresti riassumere le righe 37-39?
A. Non tutti i gatti sono falsi e traditori.
B. Chi crede che i gatti siano falsi e traditori non crede nella scienza.
C. Chi crede che i gatti siano falsi e traditori dovrebbe portarne le prove.
D. Che i gatti siano falsi e traditori non è scientificamente dimostrato.
B9 Collega i pezzi di frase, in base alle informazioni sul gatto che puoi ricavare dal testo.
Attenzione! Nella colonna di destra c’è un’informazione in più da escludere: barrala con una X.
1. ... si capisce il suo stato d’animo.
a. Chi conosce questi felini...
b. È semplice prevedere...
c. Dal muso di un gatto...
2. ... sa bene come accudirli.
3. ... sa cosa gli passa per la testa.
4. ... cosa aspettarsi da un gatto.
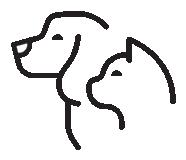
B10 Quando il gatto ha le orecchie dritte e gli occhi ben aperti (righe 43-44), vuol dire che...
A. ... si sente minacciato e sta sull’attenti.
B. ... si sente tranquillo ed è amichevole.
C. ... ha intenzione di aggredire l’avversario.
D. ... si sente spaventato e vuole difendersi.
B11 Quale affermazione riguardo al comportamento dei gatti è VERA?
A. Il gatto non è mai veramente aggressivo.
B. Il gatto non attacca mai senza prima aver avvisato.
C. Il gatto non graffia e non morde mai.
D. Il gatto quando si sente minacciato attacca immediatamente.
B12 Inarcando la schiena e arruffando i peli del dorso e della coda, il gatto vuole...
A. ... apparire più grande di quanto non sia.
B. ... lanciare un messaggio di aiuto.
C. ... dimostrare la sua forza.
D. ... dimostrare la sua rabbia.

B13 Il gatto quando si sente minacciato reagisce solo con i movimenti del corpo?
Rispondi, ricavando la motivazione dal testo.
Sì, perché
No, perché
B14 Il finale del paragrafo 3 ti fa capire che il gatto, di fronte a un avversario...
A. ... se può, evita di attaccarlo.
B. ... preferisce sempre attaccarlo.
C. ... diventa molto combattivo.
D. ... preferisce nascondersi.
B15 Nel testo mancano i titoletti dei paragrafi. Indica quale titole tto è adatto a ciascun paragrafo.
Collega con una freccia ciascun paragrafo con il titoletto corrispondente. Attenzione, ci sono due titoletti in più.
a) Gli animali domestici: dei veri salutisti!
Paragrafo 1
Paragrafo 2
Paragrafo 3
b) Gli animali domestici e la salute dell’uomo
c) Quello che non sai sul gatto: aspetti e curiosità
d) Evviva il gatto: il felino più traditore che ci sia!
e) I benefici del tenere un gatto in casa
C1 Nel testo che segue sono stati tolti tutti i segni di punteggia tura. Inserisci in ogni quadratino il segno di punteggiatura adatto. Attenzione, alcuni segni possono essere usati più volte.
Oggi al mare il cielo è sereno (a) Un gabbiano vola sopra le onde (b) poi si ferma sopra uno scoglio (c) guarda il mare e riprende il volo (d)
C2 Leggi le frasi che seguono e per ciascuna indica cosa esprime.
Metti una crocetta per ogni riga.
a. Sei meravigliosa!
b. Forse hai la febbre.
c. Sono partiti per le vacanze.
d. Hai finito di fare i compiti?
C3 Completa in modo corretto le parole incomplete presenti nelle seguenti frasi.
a. Dopo che è suonato l’allarme, sono arrivati i carabi eri.
b. A Marco piacciono molto le fiabe sugli omi che vivono nei boschi.
c. Carla ha gridato perché ha visto un ra o!
d. Il giardi ere ha finito di potare gli alberi del giardino.
C4 Leggi la frase:
“Paolo disse a Mirco che aveva comprato i biglietti per la part ita”.
Nella frase che hai letto si dice che Paolo compie due azioni: “dice a Mirco” e “compra i biglietti”. In quale ordine Paolo compie le due azioni nella realtà?
A. Prima dice a Mirco e poi compra i biglietti.
B. Dice a Mirco che comprerà i biglietti.
C. Prima compra i biglietti e poi lo dice a Mirco.
D. Mentre compra i biglietti lo dice a Mirco.
C5 In quale delle seguenti frasi l’articolo determinativo “il” è usato per indicare non un singolo parco ma tutti i parchi?
A. Il parco dietro casa di Mara è pieno di fiori.
B. Il parco di ogni città è come un polmone verde.
C. Il parco è stato pulito dai netturbini.
D. Il parco adiacente alla chiesa è recintato.
C6 Indica in quale di queste parole “pre-” NON è un prefisso.
A. Prescrittura.
B. Presente.
C. Preveggente.
D. Pregiudizio.
C7 Indica la frase che ha la virgola al posto giusto.
A. Quando cantano Luca e Paola, ricevono tanti applausi.
B. Quando cantano Luca, e Paola ricevono tanti applausi.
C. Quando cantano Luca e Paola ricevono, tanti applausi.
D. Quando cantano, Luca e Paola ricevono tanti applausi.
C8 Indica se l’espressione evidenziata è il soggetto della frase oppure non è il soggetto della frase. Guarda l’esempio e continua tu.
Metti una crocetta per ogni riga. È il soggetto Non è il soggetto
Es.: Illuminano la notte le lucciole!
a. Le amiche di mia madre sono simpatiche.
b. La moto di Mirco è dal meccanico.
c. Ho preso il pane per la cena.
d. Sandra e Paolo vanno al mare.
C9 Quale di questi nomi può essere anche un verbo?
A. Scavo.
B. Vento.
C. Panorama.
D. Istruttore.
C10 Leggi la frase.
“In spiaggia ogni ombrellone ha due lettini”. Quale delle frasi che seguono ha lo stesso significato?
A. In spiaggia molti ombrelloni hanno due lettini.
B. In spiaggia qualche ombrellone ha due lettini.
C. In spiaggia un ombrellone ha due lettini.
D. In spiaggia tutti gli ombrelloni hanno due lettini.
Colora i quesiti a cui hai risposto correttamente.
A15-d
B15.3
B15.2 C10
B15.1 C9
A15-c B14
RISPOSTE CORRETTE
C8-d
A15-b B13 C8-c
A15-a B12 C8-b
A14 B11 C8-a
A13 B10 C7
A12
A11
B9-c C6
B9-b C5
A10 B9-a C4
A9 B8 C3d
A8 B7 C3-c
A7-d B6 C3-b
A7-c B5 C3-a
A7-b B4 C2-d
A7-a B3-d C2-c
A6 B3-c C2-b
A5 B3-b C2-a
A4 B3-a C1-d
A3 B2-b C1-c
A2 B2-a C1-b
A1 B1 C1-a
comprensione del testo e lessico (testo narrativo)
comprensione del testo e lessico (testo argomentativo)
morfologia, ortografia, sintassi e lessico
Ora osserva il grafico e rispondi: - hai risposto correttamente alla maggior parte dei quesiti? SÌ NO - quanti punti hai totalizzato sul totale? /66 - come hai trovato questa prova? Barra la faccina corrispondente.
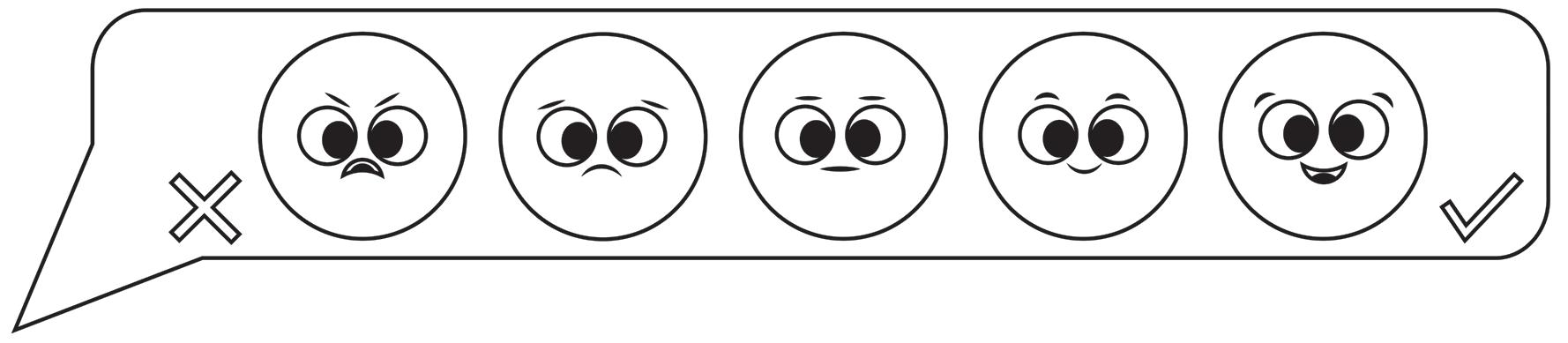
Data:
È cominciato di notte, un curioso rumorino metallico contro le persiane.
Ci si riaddormenta, ma al mattino, sorpresa! Le imposte sono bloccate.
È il ghiaccio che è caduto a raffica tutta la notte.
Ora è quasi giorno, ma il ghiaccio non si scioglierà. Pare addirittura che faccia più freddo.
“Perché non mi hai svegliato? Alle otto devo essere a scuola”.
“Hanno detto alla radio che gli scuolabus non passeranno. Niente scuola, oggi”.
Sembra incredibile, e poi cade a proposito: non eravamo troppo preparati.
I genitori, invece, hanno il muso lungo. L’auto non parte, e la mamma si preoccupa per il riscaldamento. Papà ha dimenticato di mettere l’antigelo nel radiatore.
Ma per i bambini è meraviglioso. Ci mettiamo tre maglioni uno sull’altro, e usciamo a fare un giro. Fuori, è ancora più bello quando è nevicato.
Si incontra qualche amico. C’è troppo ghiaccio per fare una scivolata, non si riesce a prendere lo slancio. Ci si spinge un po’, si fa chiasso, ma non troppo perché ci si può fare davvero male se si cade. Non c’è un granché da combinare, con quello strano tempo. Si procede a passettini, come vecchietti. Il paesaggio è così straordinario che dopo un secondo si ha solo voglia di tacere e guardare. Ogni ramo d’albero è racchiuso in una custodia di ghiaccio. Di tanto in tanto si sente un rumorino secco e bisogna essere pronti a spostarsi: un ramo è caduto. Il cielo è così azzurro che si penserebbe d’essere in piena estate, ma le orecchie pizzicano e anche la punta del naso. Si ha l’impressione che gli occhi tremino. Quando si torna a casa, disastro! Non c’è riscaldamento! Ma è un disastro piacevole. Tutti i pomeriggi, la mamma lascia acceso il forno per riscaldare la cucina. Sarebbe da stupidi farlo funzionare per niente, così la mamma ne approfitta per cuocere tre torte. Si avvicina il tavolo della cucina al gas. Si gioca a Cluedo fino a sera mangiando dolci.
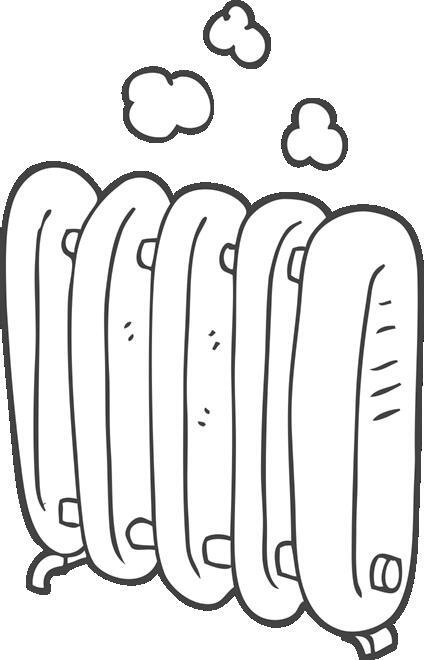
35
Dopo cena, i genitori sono distrutti e di pessimo umore: papà ha cercato di sgelare i tubi del riscaldamento con un asciugamano e l’asciugacapelli si è bruciato. Ma è veramente uno spasso: si dorme tutti insieme nella stessa camera perché c’è una sola stufa elettrica!
Gonfiamo i materassini, ci copriamo con tutti i piumini e le coperte che riusciamo a scovare. Immaginiamo di essere dei veterani di Napoleone alla battaglia di Mosca. Purché il freddo duri.
(P. Delerem, Che bello... fare i compiti sul tavolo da cucina e altri minuscoli piaceri, Salani)
A1 Il racconto è narrato...
A. ... da un adulto, che parla in prima persona.
B. ... da un bambino, che parla in prima persona.
C. ... da un autore esterno alla vicenda.
D. È impossibile saperlo.
A2 Rileggi il testo dalla riga 1 alla 3. Che cosa è successo dura nte la notte?
A. Ha piovuto.
B. Ha nevicato.
C. Ha grandinato.
D. Ha soffiato un forte vento.
A3 Alla riga 2 è scritto che “le imposte sono bloccate”.
Le imposte sono...
A. ... elementi delle porte.
B. ... elementi degli armadi.
C. ... elementi delle pareti. D. ... elementi delle finestre.
A4 Perché nel testo è scritto che gli autobus non sarebbero passat i quel giorno e che non ci sarebbe stata scuola?
A. Perché faceva troppo freddo.
B. Perché era caduta troppa neve.
C. Perché con il gelo gli scuolabus non si accendono.
D. Perché tutti, così, avrebbero potuto divertirsi sulla neve.
A5 “Sembra incredibile, e poi cade a proposito: non eravamo troppo preparati.” (riga 8). Come potresti tradurre le parole sottolineate?
A. Si realizza un nostro sogno.
B. Si verifica al momento meno opportuno.
C. Si verifica al momento giusto.
D. Accade una cosa straordinaria.
A6 Sempre in questo pezzo di testo: “Sembra incredibile, e poi cade a proposito: non eravamo troppo preparati.” (riga 8).
Che vuol dire che non erano “troppo preparati”?
A. Che non erano pronti a prendere l’autobus.
B. Che non si aspettavano la neve.
C. Che non avrebbero sopportato tutto quel freddo.
D. Che non avevano studiato abbastanza.
A7 Che cosa vuol dire che “i genitori hanno il muso lungo” (riga 9)?
A. Che sono infastiditi.
B. Che sono felici.
C. Che sono sorpresi.
D. Che sono preoccupati.
A8 Alle righe 10-11 è scritto: “Papà ha dimenticato di mettere l’antigelo nel radiatore”.
Se al posto del punto ci fosse la virgola, come potrebbe continuare la frase?
A. , quindi non si è potuto riscaldare la casa.
B. , ma la casa si è comunque riscaldata.
C. , quindi poco dopo si è rotto.
D. , ma abbiamo comunque trovato il modo di accenderlo.
A9 Alla riga 12 è scritto “Ma per i bambini è meraviglioso”. Che cos’è meraviglioso?
A. Quando a casa le cose non funzionano.
B. Quando i genitori hanno il muso lungo.
C. Quando fuori fa freddo.
D. Quando fuori nevica.
A10 Alle righe 12-13 è scritto “Ci mettiamo tre maglioni uno sull’altro, e usciamo a fare un giro.”
Quale tra le seguenti frasi riassume meglio questo pezzo di testo?
A. Ci cambiamo più volte, poi usciamo.
B. Ci copriamo molto bene, poi usciamo.
C. Passiamo molto tempo a vestirci, ma alla fine usciamo.
D. Anche se non sappiamo cosa indossare, usciamo ugualmente.
A11 Dal testo si può ricavare cosa fanno i bambini fuori quando ha nevicato. Cosa si può ricavare dal testo e cosa no?
Metti una crocetta per ogni riga.
a. Si fa una gara di velocità con gli slittini, dandosi delle spinte prima di partire.
b. Si incontrano gli amici, ma si evita di fare troppa confusione.
c. Si cammina molto lentamente, per non scivolare.
d. Si ha più voglia di guardare il paesaggio che di giocare.
Si può ricavare Non si può ricavare
A12 Perché “ogni ramo d’albero è racchiuso in una custodia di ghiaccio” (righe 20-21)?
A. Perché è trasformato dal gelo.
B. Perché è caduto tra la neve.
C. Perché è rivestito dal gelo.
D. Perché è freddo come il gelo.
A13 Perché alle righe 23-24 è scritto: “ma le orecchie pizzicano e anche la punta del naso. Si ha l’impressione che gli occhi tremino”?
A. Perché fa troppo freddo.
B. Perché si rimane stupiti.
C. Perché si rimane immobili.
D. Perché si fa difficoltà a sentire e vedere.
A14 Al rientro a casa, il narratore del testo ci fa capire che gli piace “una cosa” più di ogni altra.
Di cosa si tratta, secondo te?
A. Del fatto che la mamma usi il forno per cucinare torte.
B. Del fatto che si giochi a Cluedo.
C. Del fatto che anche al papà capiti di fare qualche sbaglio.
D. Del fatto che la famiglia sta tutta insieme e ci si sente uniti .
A15 Il testo che hai appena letto termina con un augurio da parte del protagonista. Quale?
A. Di trovare quante più coperte possibili.
B. Che ci siano ancora altri giorni di neve e freddo.
C. Che si possa rimanere a casa il più a lungo possibile.
D. Che si continui a immaginare di essere al freddo, come i soldati di Napoleone.

Data:
Paragrafo 1
Migliorare le proprie prestazioni, saper pazientare nel constatare i lenti miglioramenti, impegnarsi per migliorare le proprie capacità, affrontare un impegno continuo, ruscire a superare momenti di sconforto, rappresentano alcuni dei più significativi elementi che rendono lo sport capace di influire positivamente sull’evoluzione di un ragazzo.
La pratica sportiva prepara alla vita sociale: presenta infatti molte situazioni problematiche che ogni persona deve affrontare e vivere nella vita quotidiana. Essa permette di comprendere in quale modo ci si confronta con una sconfitta, ci si prepara costantemente per migliorare la propria prestazione, si lavora per un risultato futuro, ci si adatta agli altri compagni per raggiungere un obiettivo comune, ci si assume delle responsabilità personali in funzione delle proprie decisioni.
Fare sport dunque significa prepararsi alla vita sociale per inserirsi in essa, conoscendone regole e problemi.
Esistono poi alcuni aspetti specifici che rendono particolarmente utile al giovane la pratica di uno sport. Essa innanzitutto diverte, dando l’occasione di restare con gli amici, di effettuare nuove esperienze, di conoscersi meglio, divenendo un piacevole passatempo per il tempo libero.
Fare sport è anche un momento di evasione che permette di scaricare le tensioni accumulate nello studio, o a causa di situazioni difficili.

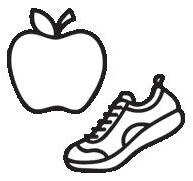
Praticare sport consente di utilizzare in modo controllato la propria energia, di imparare a gestirla e renderla produttiva, di indirizzarla verso una sana competitività. Imparare a gestire il proprio spirito di competizione consente inoltre di affrontare in modo più consapevole le situazioni della vita quotidiana.
Saper controllare le proprie reazioni nel rispetto delle regole, accettare il responso dell’arbitro, rispettare l’avversario, riconoscere gli errori, gestire correttamente la sconfitta e la vittoria, favorisce il controllo di sé ed è di grande importanza educativa.
Lo sport aiuta a migliorare la propria tenacia nel perseguire gli obiettivi, perché i risultati sportivi sono frutto di continui allenamenti.
Lo sport richiede dunque un adattamento rapido alle situazioni, soprattutto nei giochi di squadra.
Lo sport sviluppa la sicurezza nelle proprie capacità, attitudini, potenzialità.
In questo caso la persona acquisisce sicurezza di sé anche nella vita quotidiana. Se lo sport è in grado di produrre tutti questi effetti positivi in chi lo pratica correttamente non vi è dubbio che rappresenta un prezioso strumento, non solo per il miglioramento funzionale del proprio corpo, ma anche per la crescita della propria persona.
Paragrafo 2
Per ottenere dei risultati quando si pratica uno sport sono fondamentali buona volontà, impegno e determinazione, ma tutto ciò però non basta: occorre anche e soprattutto un’alimentazione completa ed equilibrata che permetta all’organismo di funzionare correttamente.
Ecco 10 regole d’oro che il CONI ha elaborato per tutti i ragazzi che desiderano praticare sport.
1. Se vuoi crescere nel modo giusto assaggia e mangia un po’ di tutto.
2. Fai ogni giorno cinque pasti: prima colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena.
3. A tavola sii rilassato, mangia con calma e mastica bene.
4. Bevi tutto il giorno acqua a volontà, aggiungi acqua a bibite e succhi di frutta.
5. Se vuoi un pieno di energie fai una prima colazione ricca: latte, yogurt, cereali, pane, marmellata, miele e frutta.

6. A pranzo, prima di fare sport, fai un pasto leggero: sì a frutta e verdura, sì a pasta o riso con olio extravergine di oliva, formaggio grattugiato e sughi leggeri, sì ad un dolce da forno semplice.
7. A cena scegli un secondo tra carne, pesce, uova, formaggio, prosciutto cotto e legumi, alternando questi alimenti nell’arco della settimana. Ricorda la verdura e la frutta.
8. Varia anche le merende e gli spuntini: preferisci i prodotti leggeri. Più la tua dieta sarà variata e semplice, più ti sentirai in forma.
9. Prima di fare uno sport evita i cibi grassi e quelli troppo elaborati: no a paste farcite, no a formaggi cremosi, no a fritti e dolci con panna e crema, anche se a malincuore...
10. Occhio all’orologio: più consumerai i tuoi pasti in modo regolare, più ti darai la ricarica giusta.
(I. Mantovani, Azionegestosport, EDI-ERMES Scuola; AA.VV. Lacompagniadeilettori, Paravia)
B1 Dalle righe 1-5 vengono elencati alcuni elementi che caratteriz zano gli effetti positivi dello sport sullo sviluppo di un ragazzo. Quale di essi NON viene menzionato nel testo?
A. Pazienza.
B. Impegno.
C. Prudenza.
D. Costanza.
B2 Che vuol dire che la pratica sportiva prepara alla vita sociale (riga 6)?
A. Che insegna a convivere con gli altri.
B. Che insegna ad aiutare gli altri.
C. Che insegna ad essere simpatici.
D. Che insegna ad essere generosi.
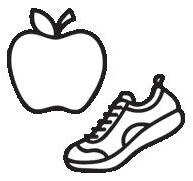
B3 Il testo del paragrafo 1 elenca alcuni aspetti specifici che rendono utile la pratica di uno sport. Quali aspetti si ricavano dal testo e quali no?
Metti una crocetta per ogni riga.
Praticare uno sport... Si può ricavare Non si può ricavare
a.
È anche un’esperienza piacevole e permette di fare nuove amicizie.
b. Permette di rilassarsi, soprattutto in caso di tensioni e periodi difficili.
c. Consente di controllare il peso corporeo e di avere un aspetto “competitivo”.
d. Consente di avere più energia e forza fisica.
B4 Rileggendo le righe 25-28, si ricava che lo sport è “educativo” perché favorisce il RISPETTO e l’AUTOCONTROLLO. Per ciascuna di queste due parole “chiave”, riporta una motivazione/un esempio che puoi ricavare dal testo.
a. RISPETTO:
b. AUTOCONTROLLO:
B5 Alla riga 29 è scritto che lo sport “aiuta a migliorare la propria tenacia nel perseguire gli obiettivi”, ciò vuol dire che lo sport aiuta a essere:
A. testardi.
B. determinati.
C. incoscienti.
D. insicuri.

B6 Rileggi le righe 33-34. Quale affermazione è FALSA?
A. Lo sport aiuta a riconoscere le proprie potenzialità.
B. Lo sport aiuta a farci sentire infallibili.
C. Lo sport sviluppa la nostra autostima.
D. Lo sport aiuta a farci sentire sicuri.
B7 Il paragrafo 1 si conclude affermando...
A. ... che lo sport apporta benefici a livello psicologico.
B. ... che lo sport apporta benefici a livello fisico.
C. ... che lo sport apporta benefici a livello fisico e psicologico.
D. ... che lo sport fa crescere sani e forti.
B8 L’introduzione del paragrafo 2 (righe 39-42) vuole affermare...
A. ... i principi di una corretta alimentazione.
B. ... le caratteristiche di un organismo che funziona bene.
C. ... l’importanza dello sport per l’alimentazione.
D. ... l’importanza dell’alimentazione per lo sport.
B9 Dalle prime 5 regole del CONI in materia di alimentazione (righ e 45-51), si può capire che è importante...
A. ... seguire un’alimentazione varia.
B. ... mangiare velocemente, per assimilare di più.
C. ... fare da un minino di 1 a un massimo di 5 pasti al giorno.
D. ... fare una prima colazione molto leggera.
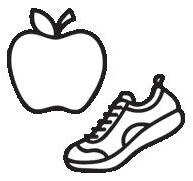
B10 Come dev’essere il pranzo, prima di fare sport?
A. Il più possibile completo di ogni nutriente.
B. A base di pasta o riso e un dolce.
C. Può includere vari alimenti, purché sia leggero.
D. Solo a base di frutta e verdura.
B11 Che cos’è consigliato per la cena?
A. Un secondo diverso ogni settimana.
B. Un secondo diverso ogni giorno.
C. Uno spuntino di frutta e verdura.
D. Carne, con uova e formaggio.
B12 I cibi che contengono fritti e dolci, con crema e panna...
A. ... sono vietati.
B. ... sono adatti per uno spuntino.
C. ... vanno evitati prima di fare sport.
D. ... fanno male al cuore.
B13 Come puoi sintetizzare con uno slogan le ultime righe del parag rafo 2?
A. Mangia piano e andrai lontano!
B. ll ritardo eviterai, se veloce mangerai!
C. Il tempo è denaro: non mangiare troppo piano!
D. A tavola vince chi corre!
B14 Ai paragrafi mancano i titoli. Quali delle seguenti frasi NON è adatta al titolo di nessun paragrafo?
A. Sport e benessere.
B. Sport e alimentazione: quale rapporto?
C. Lo sport aiuta a crescere!
D. Sport e dieta: i consigli per dimagrire!
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
C1 A quale categoria grammaticale appartengono le parole nel riquadro?
saliscendi - pellerossa - viavai - scorrimano - portaombrelli
A. Nomi alterati.
B. Nomi composti.
C. Nomi collettivi.
D. Nomi primitivi.
C2 In quale delle seguenti frasi il verbo sottolineato è al modo indicativo?
A. Non penso tu possa arrivare in tempo domani!
B. Riusciresti ad avvisare Matteo che la partità è rimandata?
C. Paola non prenderà facilmente quella decisione.
D. Ci piacerebbe essere coraggiosi come te!
C3 In quale frase il verbo AVERE è usato come ausiliare?
A. Ieri Mirco ha perso il treno.
B. Hai un cappellino nuovo?
C. Non hanno un bellissimo aspetto.
D. Ho sete: prendimi una bibita!
C4 In quale delle seguenti frasi la parola sottolineata è usata in funzione di aggettivo?
A. Mi piace il blu dei tuoi occhi.
B. La tenda blu è quella che preferisco.
C. Passami il blu: devo colorare il mare!
D. Quando penso al blu, penso al cielo.
C5 Quale frase contiene un predicato nominale?
A. Sandro è partito per le vacanze.
B. Michele gioca benissimo a calcio.
C. Andrea è stanco: niente cinema stasera!
D. Ieri ti ho pensato spesso.
C6 Scegli il nome più adatto per completare il testo che segue.
Paolo ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. Era una famiglia che lo richiedeva come ospite per animare la festa di compleanno di un bimbo. è famoso per i suoi giochi di prestigio che affascinano grandi e piccini. ?
A. L’illuso.
B. L’illusionista.
C. Il visionario.
D. Il sognatore.
C7 Collega le espressioni figurate al proprio significato. Attenzione: ce n’è uno in più!
a. Mara non ha aperto bocca.
b. Mara è rimasta a bocca asciutta.
c. Mara è rimasta a bocca aperta.
1. Mara è rimasta stupita.
2. Mara ha l’acquolina in bocca.
3. Mara è rimasta in silenzio.
4. Mara non ha ottenuto nulla.
C8 In quale frase la parola “alcuni” ha la funzione di aggettivo?
A. Guarda quanti gatti ci sono: alcuni sono neri!
B. Ieri in piscina ho incontrato alcuni amici.
C. Alcuni dicono che sarà un’estate afosa.
D. In nessuna delle frasi precedenti.
C9 Quale parola NON è scritta correttamente?
A. Selcie.
B. Alghe.
C. Celeste.
D. Ascensore.
C10 In quale delle seguenti frasi c’è un complemento oggetto?
A. Volano le rondini.
B. Sono con Chiara al mare.
C. Ho parlato continuamente.
D. In nessuna delle precedenti.
Colora i quesiti a cui hai risposto correttamente.
A15 B14
A14 B13
A13 B12
A12 B11
A11-d B10
A11-c B9
A11-b B8 C10
A11-a B7 C9
A10 B6 C8
A9 B5 C7-c
A8 B4-b C7-b
A7 B4-a C7-a
A6 B3-d C6
A5 B3-c C5
A4 B3-b C4
A3 B3-a C3
A2 B2 C2 A1 B1 C1 RISPOSTE
comprensione del testo e lessico (testo narrativo)
comprensione del testo e lessico (testo argomentativo)
morfologia, lessico, ortografia e sintassi
Ora osserva il grafico e rispondi:
- hai risposto correttamente alla maggior parte dei quesiti? SÌ NO - quanti punti hai totalizzato sul totale? /48 - come hai trovato questa prova? Barra la faccina corrispondente.
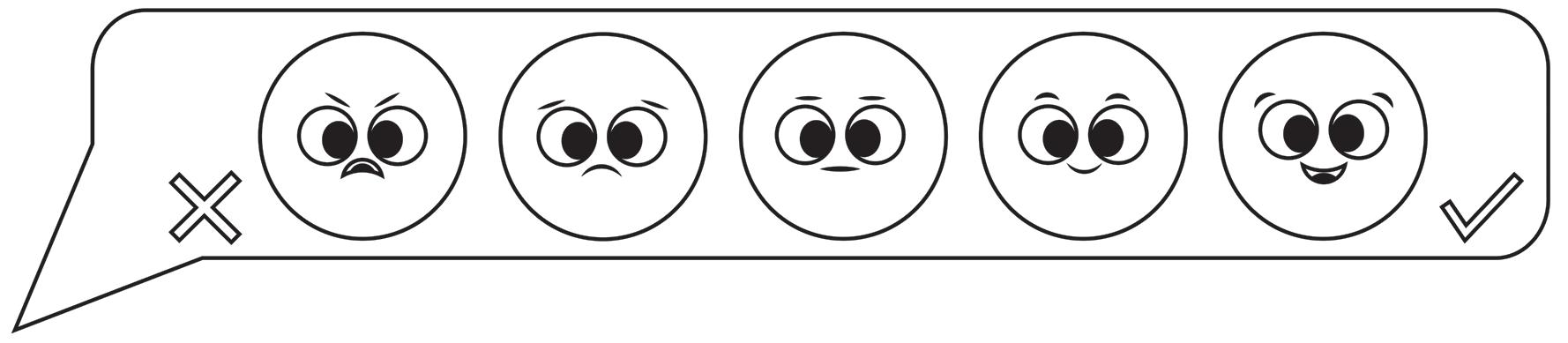
Data:
In spiaggia ce la spassiamo. Mi sono fatto un sacco di amici, c’è Biagio, e poi Fruttuoso, ed Eustachio; che stupido quello lì! E poi Irino, Fabrizio, Cosimo e poi Ivo, che non è in vacanza perché è del posto e giochiamo assieme, litighiamo, e non ci parliamo più, che forza!
“Va’ a giocare con i tuoi amichetti!” mi ha detto il papà stamattina, “io vado a riposare e a prendere il sole”. E poi ha cominciato a mettersi dell’olio dappertutto e gongolava mentre diceva: “Ah, quando penso ai colleghi che sono rimasti in ufficio!”.
Noi abbiamo incominciato a giocare con il pallone di Irino.
“Andate a giocare più in là” ha detto il papà, che aveva finito di mettere l’olio, e bam! Il pallone gli è cascato proprio in testa. Questo non gli è piaciuto al papà. Si è arrabbiato forte e ha dato una gran pedalata al pallone, che è andato a finire in acqua, molto lontano. Una bomba bestiale.
“Così lo capirete, insomma”, ha detto il papà.
Irino è corso via ed è tornato col suo papà. È proprio grande e grosso il papà di Irino. E non aveva affatto l’aria contenta.
“È lui!” ha detto Irino mostrando il mio papà col dito.
“È lei”, ha chiesto il papà di Irino al mio papà, “che ha buttato in acqua il pallone del piccolo?”
“Beh sì”, ha risposto il mio papà al papà di Irino, “ma quel pallone l’avevo preso in faccia”.
“I bambini vanno in spiaggia per sfogarsi”, ha replicato il papà di Irino, “se non le va stia a casa sua. Intanto, questo pallone bisogna andarlo a prendere.”
[...] Al papà, ce n’è voluto del tempo per andarlo a prendere, il pallone: il vento lo aveva spinto lontano. Sembrava stanco, il papà, quando ha ridato il pallone a Irino e ci ha detto: “Sentite, bambini, voglio riposare tranquillo. Allora, invece di giocare a pallone, perché non giocate a qualche altra cosa?”.
“Beh, a che cosa per esempio, eh, senta?” ha chiesto Eustachio. Che stupido quello lì!
“Non lo so, io” ha risposto il papà, “fate dei buchi, è divertente fare buchi nella sabbia”.
Noi abbiamo trovato l’idea formidabile e abbiamo preso le palette mentre il papà ha voluto cominciare a mettersi l’olio, ma non ce l’ha fatta perché non c’era più l’olio nella bottiglia.
“Vado a comperarlo al negozio, in fondo al lungomare,” ha detto il papà e la mamma gli ha chiesto perché non se ne stava un po’ fermo.
Abbiamo cominciato a fare un buco. Un buco da matti, grosso e profondo come non so che. Quando il papà è tornato con la bottiglia dell’olio, l’ho chiamato e gli ho detto: “Hai visto il nostro buco, papà?”.
“È molto carino, tesoro,” ha detto il papà, e ha provato a stappare la bottiglia dell’olio coi denti. E poi, è venuto un signore con un berretto bianco e ha chiesto chi ci aveva dato il permesso di fare quel buco sulla spiaggia.

“È lui, signore!” hanno detto tutti i miei amici mostrando il papà. Io ero molto fiero, perché credevo che il signore del berretto si sarebbe congratulato con il papà. Ma il signore non sembrava contento.
“Non è per caso impazzito, no, a dare di quelle idee ai bambini” [...] Allora il signore del berretto si è messo a gridare che era incredibile come la gente fosse incosciente, che ci si poteva rompere una gamba cadendo bel buco, e con l’alta marea la gente che non sapeva nuotare avrebbe perduto l’equilibrio e sarebbe affogata nel buco, e che poteva succedere un sacco di cose terribili nel buco e che bisognava assolutamente richiudere il buco.
[...] Il papà ha fatto un grosso sospiro e mi ha aiutato a chiudere il buco. Siccome avevamo solo una paletta piccola, c’è voluto un sacco di tempo e avevamo appena finito quando la mamma ha detto che era ora di tornare in albergo per mangiare e che bisognava sbrigarsi, perché, quando arrivi in ritardo, non ti servono mica, in albergo. “Tira su la tua roba, la paletta, il secchiello e vieni,” mi ha detto la mamma.
Io ho preso la mia roba e non ho trovato il secchiello. “Fa niente, torniamo indietro,” ha detto il papà. Ma io mi sono messo a piangere ancora di più.
Un secchiello pazzesco, giallo e rosso, che faceva delle formine fortissime. “Calma,” ha aggunto il papà, “dove hai messo, quel secchiello?”
Ho risposto che forse era in fondo al buco, quello che avevamo appena chiuso. Il papà mi ha guardato come se volesse darmi una sculacciata, allora ho pianto ancora più forte e il papà mi ha detto che, insomma, lo avrebbe tirato fuori quel secchiello, ma che non dovevo più rompergli le orecchie. Il mio papà è il più caro di tutti i papà.
Siccome avevamo sempre solo una paletta per noi due, non ho potuto aiutare il papà e lo lasciavo fare; a questo punto abbiamo sentito un vocione dietro di noi: “Mi prende in giro?” Il papà ha fatto un grido, ci siamo voltati e abbiamo visto il signore del berretto bianco.
“Se ricordo bene le avevo proibito di fare dei buchi”, ha detto il signore. Il papà gli ha spiegato che stava cercando il mio secchiello. Allora il signore gli ha detto d’accordo, ma a condizione che lo richiudesse di nuovo.
Ed è rimasto là al suo posto per sorvegliare il papà.
“Senti,” ha detto la mamma al papà, “vado in albergo con Nicola. Ci raggiungerai appena avrai ritrovato il secchiello”. E ce ne siamo andati. Il papà è arrivato in albergo tardissimo, era stanco morto, non aveva fame, è andato subito a dormire. Il secchiello non l’aveva trovato, ma non fa niente perché mi sono accorto che l’avevo lasciato in camera. Nel pomeriggio, hanno chiamato un dottore per via delle scottature del papà. Il dottore ha detto al papà che deve rimanere al letto per due giorni. “Roba da matti stare al sole così,” lo ha rimproverato il dottore, “senza mettersi dell’olio.”
“Ah!” sospirava il papà, “quando penso ai colleghi che sono rimasti in ufficio!”
Ma non se la spassava mica dicendo così.
(J.-J. Sempé e R. Goscinny, Le vacanze di Nicola, Emme Edizioni)

A1 Nella riga 1 è scritto: “In spiaggia ce la spassiamo”.
Come potresti tradurre questa espressione?
A. In spiaggia ci annoiamo.
B. In spiaggia il tempo passa veloce.
C. In spiaggia ci divertiamo.
D. In spiaggia passeggiamo.
A2 Il racconto è narrato...
A. ... in prima persona.
B. ... in terza persona.
C. ... da un genitore.
D. ... da un gruppo di amici.
A3 Alla riga 7 è scritto: “... e gongolava mentre diceva...”.
Qual è il significato della parola sottolineata?
A. Dondolava.
B. Esultava.
C. Piagnucolava.
D. Gesticolava.
A4 Perché il papà era molto arrabbiato?
A. Perché i bambini, giocando, lo avevano svegliato.
B. Perché Irino era andato a chiamare il suo papà.
C. Perché i bambini avevano lanciato il pallone in acqua.
D. Perché era stato colpito in testa dal pallone.
A5 Il pallone è finito in acqua perché... Metti una crocetta per ogni riga.
A. ... ce l’hanno lanciato i bambini mentre giocavano.
B. ... ce l’ha mandato il papà con un forte calcio.
C. ... ce l’ha mandato il papà mentre giocava insieme ai bambini.
D. ... ce l’ha mandato il papà colpendolo con la testa.
A6 Rileggi il testo (righe 5-27): quali fatti accadono prima dell’arrivo del papà di Irino e quali accadono dopo?
a. Il papà impiega molto tempo per recuperare il pallone caduto in acqua.
b. I bambini iniziano a giocare con il pallone di Irino.
c. Il papà comincia a mettersi l’olio dappertutto.
d. Il papà propone ai bambini di giocare a qualche altra cosa.
A7 Il signore col berretto bianco dà due motivazioni come esempio dei pericoli che potevano derivare dalla presenza delle buche sulla sabbia. Ritrovale nel testo e scrivile sulle righe.
A8 Collega ogni personaggio all’azione che ha compiuto.
1. Ha detto di sbrigarsi e che era ora di rientrare in albergo.
a. Il papà del protagonista
b. Il signore col berretto bianco
c. La mamma del protagonista
d. Il protagonista
2. Non riesce più a trovare il secchiello.
3. Aiuta suo figlio a richiudere la buca sulla sabbia.
4. Si mette a gridare, dicendo come la gente fosse incosciente.
A9 Perché il protagonista dice “ Il mio papà è il più caro di tutti i papà” (righe 69-70)?
A. Perché il suo papà riusciva sempre a mantenere la calma.
B. Perché il papà non gli ha dato la sculacciata, come avrebbe voluto.
C. Perché in fondo il suo papà non si arrabbiava mai.
D. Perché anziché tornare in albergo, lo aiuta a ritrovare il secchiello.
A10 Perché il signore col berretto bianco si è arrabbiato di nuovo con il papà (righe 71-78)?
A. Perché il papà continuava ad aiutare i bambini.
B. Perché aveva creduto che il papà avesse ricominciato a fare una buca.
C. Perché anche se tardi, il papà giocava in spiaggia come un bambino.
D. Perché aveva creduto che fosse stato il papà a perdere il secchiello.
A11 Secondo te, il signore col berretto bianco aveva fiducia nel pap à?
Riporta sulle righe la frase del testo che te lo fa capire.
Sì No
A12 Alla fine il papà è riuscito a ritrovare il secchiello?
Sì, perché No, perché
A13 Il papà alla fine si è scottato con il sole perché...
A. ... non aveva voluto mettersi l’olio.
B. ... avrebbe voluto mettersi l’olio, ma poi era finito.
C. ... mentre se lo stava spalmando, l’olio è finito in acqua.
D. ... avrebbe voluto mettersi l’olio, ma ha avuto sempre qualche impedimento.
A14 Nel testo compare per ben due volte la seguente frase: “quando penso ai colleghi che sono rimasti in ufficio!”, rispettivamente alle righe 7-8 e 87-88. In entrambi i casi, la frase ha lo STESSO significato?
A. Sì, perché il papà era comunque contento di essere in vacanza.
B. Sì, perché sapeva che i suoi colleghi lo stavano invidiando.
C. No, perché all’inizio il papà era contento di stare in spiaggia, ma, alla fine, avrebbe voluto essere in ufficio.
D. No, perché all’inizio era contento di prendere il sole, e non immaginava che si sarebbe potuto scottare.
A15 Quattro bambini hanno letto quattro racconti diversi.
Uno di loro ha letto lo stesso che hai letto tu. Leggi i fumetti. Chi di loro ha letto il tuo stesso racconto?

Il racconto narra di un’avventura tra amici, che, alla fine, si mettono in pericolo.
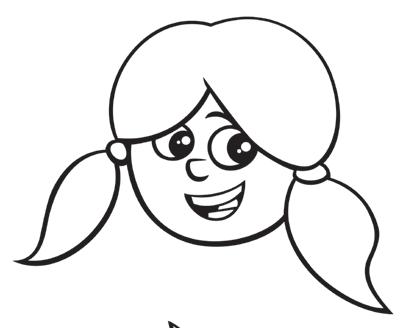
Il racconto narra di un bambino capriccioso che non dà mai ascolto ai suoi genitori.

Il racconto è di genere fantasy, ed è molto divertente!

Il racconto è piacevole e divertente e molto comico nel finale.

Data:
Paragrafo 1
La famiglia di un tempo, che aveva posto per tutti, dai bambini, ai giovani, ai vecchi, è ormai un ricordo. Nella nostra società, infatti, sembra talvolta che non ci sia posto per gli anziani.
Adesso la famiglia è nucleare, cioè formata da un piccolo nucleo: padre, madre, e figli. I nonni, di solito, vivono per conto proprio, a volte anche in località molto lontane da quelle dove abitano figli e nipoti.
Inoltre, gli alloggi sono piccoli e i ritmi di vita, condizionati dal lavoro fuori casa dei vari componenti della famiglia, sono pieni, intensi e adatti solo a gente molto attiva.
Secondo molti psicologi, tutti vogliono maggiore libertà e autonomia, anche gli anziani; però, per mantenersi “vivi”, gli anziani hanno bisogno di stare con gli altri, di sentirsi utili anche se non lavorano più.
Il discorso vale a qualunque età: se manca la possibilità di comunicare con gli altri, c’è il pericolo di rinchiudersi in sé e di intristire.
Per gli anziani il pericolo della solitudine è ancora più grave, perché la nostra società, attribuendo grande importanza all’efficienza fisica, li condanna a sentirsi inutili.
Alcuni riescono a evitare questo rischio: si mantengono attivi, svolgono piccole attività poco faticose, si impegnano in azioni di volontariato.
Altri, invece, non ci riescono e rischiano di isolarsi e di chiudersi in sé stessi.
Paragrafo 2
Quando gli anziani parlano con altre persone, si sentono meno soli e più felici; è proprio come tenere in allenamento un muscolo!
Possono anche fare cose divertenti insieme, come giocare a carte, fare gite o semplicemente parlare di quello che hanno fatto durante il giorno.
Inoltre, parlare con gli anziani può aiutare a mantenere la mente attiva, come se stessimo giocando a un gioco che stimola il cervello!
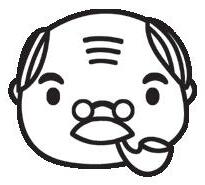
Quindi, è importante che anche tu, come bambino, sia un amico degli anziani. Puoi semplicemente sorridere, chiedere come stanno e parlare con loro. Questo farà sentire loro bene e ti aiuterà a imparare cose nuove!
Riassumendo, ecco perché le relazioni sociali sono importanti per gli anziani:
- gli anziani che parlano con le persone si sentono meno soli e più felici; - parlare e fare attività con gli altri aiuta a mantenere la mente attiva;
- le relazioni sociali aiutano gli anziani a sentirsi parte di una comunità e a non sentirsi isolati.
Paragrafo 3
Nell’intreccio delle relazioni familiari, i nonni sono come figure straordinarie, custodi di saggezza e dispensatori di un amore senza pari. Il loro ruolo, spesso sottovalutato, si rivela essere un pilastro fondamentale per il benessere di tutta la famiglia, creando un ponte unico tra passato e futuro. I piccoli, immersi in un mondo sempre più frenetico, trovano nei nonni un’oasi di calma e attenzione. Con loro scoprono il piacere della lentezza, imparano l’arte della pazienza e assaporano il gusto di fare le cose con cura. Mentre i genitori corrono da un impegno all’altro, i nonni offrono ai nipoti il dono più prezioso: il tempo. Un tempo dedicato a giocare, raccontare, ascoltare, senza l’assillo di notifiche o scadenze.

Non si tratta solo di una questione affettiva ma di uno scambio continuo, infatti i bambini che trascorrono regolarmente tempo con gli anziani hanno migliori competenze comunicative, nella lettura e nelle abilità sociali. Attraverso l’esempio, insegnano la pazienza, il pensiero critico e la risoluzione dei problemi, arti del vivere che solo l’esperienza può affinare. I bambini, dal canto loro, portano vitalità nella vita degli anziani, riducendo il senso di ansia, migliorando la mobilità fisica e la memoria, sfidandoli a restare al passo con i tempi e coinvolgendoli in giochi e attività.
(“Corriere della Sera”; generiamosalute.it )

B1 Rileggi il testo alle righe 1-3. Che cosa si può capire?
A. Che la condizione degli anziani oggi è cambiata.
B. Che la condizione degli anziani era la stessa in passato come oggi.
C. Che oggi gli anziani non vivono in spaziose abitazioni.
D. Che in passato le famiglie erano perlopiù formate da gente anziana.
B2 Come potresti sostituire l’espressione: “Adesso la famiglia è nucleare” (riga 4)?
A. Adesso la famiglia è fondamentale.
B. Adesso la famiglia è più numerosa.
C. Adesso la famiglia è meno numerosa.
D. Adesso la famiglia costituisce il nucleo della società.
B3 Dalle righe 5-14, si possono capire alcune caratteristiche che contraddistinguono la vita degli anziani di oggi. Quali caratteristiche puoi ricavare dal testo e quali no?
Metti una crocetta per ogni riga.
Gli anziani oggi...
a. Rischiano maggiore solitudine che in passato.
b. Raramente hanno la possibilità di vivere insieme a figli e nipoti.
c. Preferirebbero vivere in un istituto, dove non mancherebbero di certo le amicizie.
d. Gli anziani avrebbero bisogno di parlare di più con gli altri e di sentirsi utili.
Si può ricavare Non si può ricavare
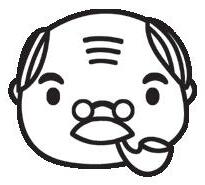
B4 Perché la nostra società, dando importanza all’efficienza fisica (righe 16-17), condanna gli anziani a sentirsi inutili?
A. Perché gli anziani non sono al massimo delle prestazioni fisiche.
B. Perché gli anziani non danno importanza al proprio aspetto fisico.
C. Perché gli anziani non hanno più voglia di impegnarsi.
D. Perché gli anziani vengono derisi per via del loro aspetto fisico.
B5 Che cos’è che negli anziani viene paragonato all’allenamento di un muscolo (riga 22)?
A. Aiutare gli altri.
B. Parlare con gli altri.
C. Giocare a carte.
D. Vivere insieme agli altri.
B6 Alle righe 25-26 è scritto: “Inoltre, parlare con gli anziani può aiutare a mantenere la mente attiva, come se stessimo giocando a un gioco che stimola il cervello!”.
A quale cervello ci si riferisce?
A. A quello degli anziani.
B. Non si può sapere.
C. A quello di chi fa un gioco stimolante.
D. A quello di chi parla con gli anziani.

B7 Alle righe 27-29, a chi si rivolge il testo?
A. A chiunque.
B. A tutti i bambini che stanno leggendo il testo.
C. Ai bambini amici degli anziani.
D. Ai bambini che sanno imparare dagli anziani.
B8 Dalle righe 30-34 vengono spiegati i benefici che agli anziani derivano dall’avere relazioni sociali. Quali affermazioni sono VERE e quali FALSE?
Metti una crocetta per ogni riga.
Attraverso le relazioni sociali... VERO FALSO
a. Gli anziani possono vincere la loro tristezza e il proprio senso di solitudine.
b. Evitano di incorrere in comportamenti pericolosi e non adatti alla loro età.
c. Riescono a partecipare alla vita della propria comunità di appartenenza.
d. Bloccano il processo di invecchiamento e si comportano come i giovani.
B9 Alle righe 37-38 si dice che i nonni “sono dispensatori di un amore senza pari”. Come potresti tradurre la frase sottolineata?
A. I nonni amano solo chi ricambia il loro amore.
B. I nonni non temono nessun tipo di paragone.
C. Nessun altro amore è paragonabile a quello dei nonni.
D. I nonni non si mettono a confronto con nessuno.
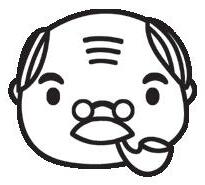
B10 Stando con i nonni, i nipoti possono trarre molti benefici (righe 42-48).
Quale affermazione è FALSA?
A. I nonni interrompono il flusso frenetico della vita quotidiana.
B. I nonni insegnano a non perdere tempo e a rispettare le scadenze.
C. I nonni insegnano a fare le cose con pazienza e attenzione.
D. Con i nonni si gioca, si racconta, si ascolta.
B11 Alla riga 49 è scritto: “Non si tratta solo di una questione affettiva ma uno scambio continuo”. Ciò vuol dire che...
A. Nonni e nipoti traggono benefici a vicenda dallo stare insieme.
B. Solo stando continuamente con i nipoti, i nonni possono migliorare.
C. Solo stando continuamente con i nonni, i nipoti possono migliorare.
D. L’affetto tra nonni e nipoti deriva dallo scambiarsi favori a vicenda.
B12 Stabilisci se le seguenti affermazioni si riferiscono ai nonni o ai bambini.
Scrivi nel quadratino, rispettivamente, N o B.
a. Riescono ad insegnare attraverso l’esempio.
b. Apportano vitalità e la voglia di muoversi.
c. Hanno tanta esperienza, senso critico e abilità nel risolvere i problemi.
d. Riescono a coinvolgere, trasmettendo la voglia di giocare e fare attività.

B13 Ora che hai letto tutti e tre i paragrafi sapresti stabilire qual è l’obiettivo dell’INTERO TESTO?
A. Far comprendere come i nonni siano un ponte tra passato e presente.
B. Dimostrare l’importanza degli anziani e insistere su quanto sia utile proteggerli, anche semplicemente parlando con loro.
C. Dimostrare l’importanza degli anziani nel ruolo di nonni.
D. Spiegare come avviene l’invecchiamento degli anziani.
B14 Nel testo mancano i titoletti dei paragrafi. Indica quale titole tto è adatto a ciascun paragrafo.
Collega con una freccia ciascun paragrafo con il titoletto corrispondente.
Attenzione, ci sono due titoletti in più.
Paragrafo 1
Paragrafo 2
Paragrafo 3
a) I nonni: com’erano in passato e come sono oggi
b) Le relazioni sociali “salvano” gli anziani
c) Gli anziani nel ruolo di nonni.
d) La solitudine degli anziani.
e) Come invecchiare bene: consigli e suggerimenti.
C1 Leggi la frase:
“Ieri Sonia ha costruito un castello di sabbia”.
Indica la frase che ha la stessa struttura della frase sopra, c ioè che è formata da “pezzi” (sintagmi) che hanno la stessa funzione sint attica.
A. Ieri Matteo ha lavorato duramente.
B. Oggi Sonia suona il pianoforte.
C. Giulio parla al telefono con Sofia.
D. Domani Andrea comprerà un tavolo di legno.
C2 In ogni gruppo sottolinea la parola grammaticalmente errata.
a. sogliola - bigliardo - ingegnere - Daniele
b. Guglielmo - oglio - sogno - coscienza
c. asciensore - asciutto - schiuma - scheggia
d. tamburo - aquila - ampiezza - aquedotto
C3 In quale delle seguenti frasi puoi inserire, al posto dei puntini, la congiunzione CHE?
A. Il bambino ......... ha cantato è mio nipote!
B. Potresti dirgli ..... oggi arrivo tardi in ufficio?
C. È lei ...... si mette in mostra, ma nessuno la noterà!
D. In tutte e tre le frasi precedenti.
C4 Leggi questa frase.
Il cagnolino del vicino di casa di mio nonno, che abita con suo figlio, è sempre agitato .
In questa frase, con quale elemento concorda l’aggettivo agitato?
A. Concorda con “mio nonno”.
B. Concorda con “vicino di casa”
C. Concorda con “cagnolino”.
D. Concorda con “suo figlio”.
C5 Leggi la seguente frase.
L’ ingegnere , dopo aver completato il suo primo progetto, ha affermato che la casa sarà davvero stupenda.
Nella frase che hai letto, ingegnere è un nome maschile o femminile?

A.

Secondo me “ingegnere” è di genere maschile, perché finisce per - e.

Per me “ingegnere” è sicuramente maschile, perché “SUO” è aggettivo possessivo maschile.
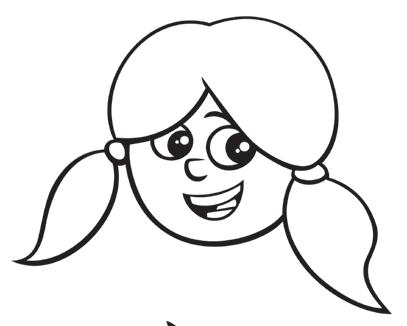
Non si può sapere, perché L’ davanti a “ingegnere” potrebbe essere sia LO sia LA.
La parola “ingegnere” è di genere femminile, perché finisce per - e.
Quattro bambini hanno risposto alla domanda in modo diverso: ch i ha ragione? D.
C6 Nelle frasi che seguono, ad alcune parole manca la lettera “h”. Scrivila nel quadratino solo quando è necessaria.
a) Mauro è andato 1) a giocare al parco, ma 2) a dimenticato lo zainetto 3) a casa.
b) 1) o chiesto 2) a Mirco se voleva il gelato 3) o un frutto per merenda.
C7 Indica in quali dei seguenti verbi “ri-” è un prefisso e ha il s ignificato di “azione che si ripete”. Guarda l’esempio e poi continua tu.
Metti una crocetta per ogni riga.
L’azione si ripete
L’azione non si ripete
Es. Ri-cominciare
a. Ritornare
b. Ricucire
c. Riparare
d. Rischiare
C8 Leggi la frase che segue:
Il papà ha chiesto a Mirco: “Metti in ordine la tua cameretta?” .
Trasforma la frase da discorso diretto a discorso indiretto, completando la frase che segue.
Il papà ha chiesto a Mirco di
C9 Leggi la seguente frase:
Anche oggi siamo usciti stremati dalla lezione.
A. Energici.
B. Soddisfatti.
C. Sfiniti.
D. Tristi.
Con quale delle seguenti espressioni puoi sostituire la parola sottolineata, senza cambiare il significato della frase? del giardino.
C10 Quale delle espressioni che seguono è indispensabile per comple tare la frase “Il papà taglia................... .”
A. il sabato mattina.
B. l’erba.
C.
D. di casa sua.
Colora i quesiti a cui hai risposto correttamente.
B14.3
B14.2
B14.1
A15
A14
A13
A12
RISPOSTE CORRETTE
B13
B12-d C10
B12-c C9
B12-b C8
A11 B12-a C7-d
A10 B11 C7-c
A9 B10 C7-b
A8-d B9 C7-a
A8-c
B8-d C6-b3
A8-b B8-c C6-b2
A8-a B8-b C6-b1
A7.2 B8-a C6-a3
A7.1 B7 C6-a2
A6-d B6 C6-a1
A6-c B5 C5
A6-b B4 C4
A6-a B3-d C3
A5
A4
A3
B3-c C2-d
B3-b C2-c
B3-a C2-b
A2 B2 C2-a
A1 B1 C1
comprensione del testo e lessico (testo narrativo)
comprensione del testo e lessico (testo argomentativo)
sintassi, ortografia, morfologia e lessico
Ora osserva il grafico e rispondi: - hai risposto correttamente alla maggior parte dei quesiti? SÌ NO - quanti punti hai totalizzato sul totale? /68 - come hai trovato questa prova? Barra la faccina corrispondente.
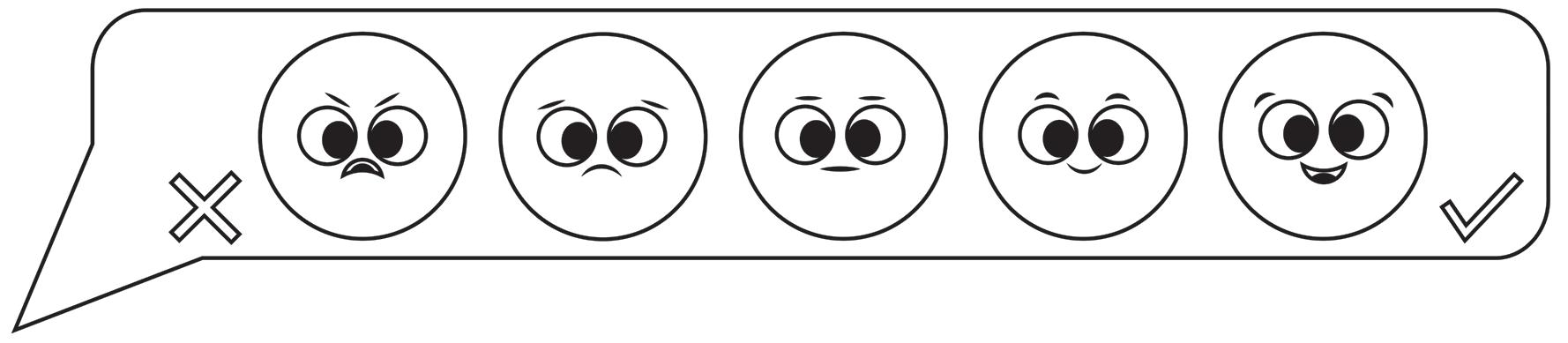
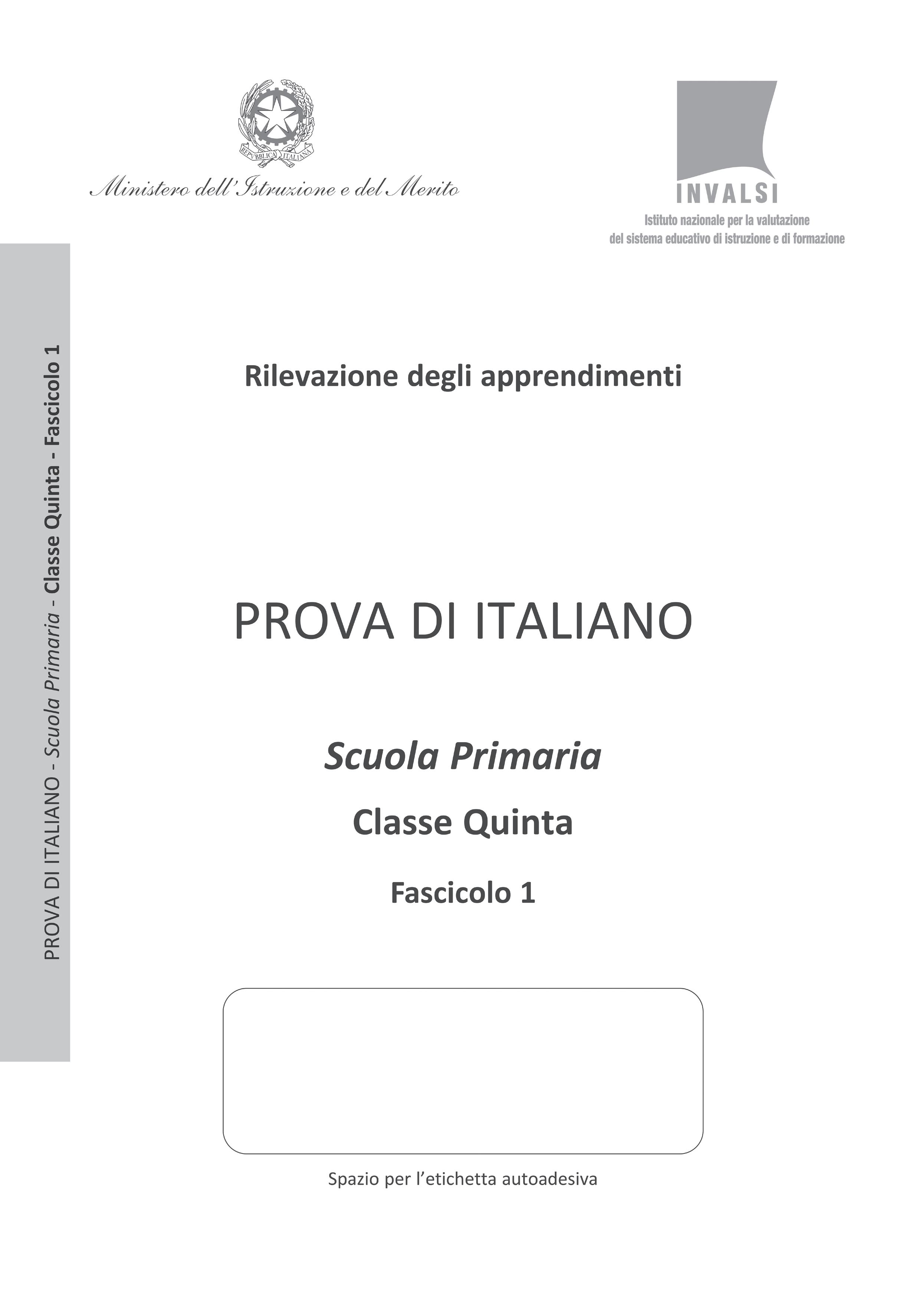
Era garzone1 di una panetteria, il giovane Dorando, piccolo e leggero, abituato ad alzarsi ancor prima dell’alba per portare sacchi di pane e vassoi di pasticcini di qua e di là tra le vie della città, ai caffè e alle trattorie, alle signore bene e al parroco, che senza pane – si sa – non si può. Sempre di corsa, Dorando, con il suo passo svelto e agile. 5
Era garzone di una panetteria, ma se c’era da correre anche di pomeriggio, dopo aver corso per lavoro, non si tirava certo indietro e, gara dopo gara, tremila metri a perdifiato, cinquemila, o persino trentamila, poco importava: lui correva felice e beato. Fino alla maratona vera e propria, con l’aria della Grecia antica a soffiare a favore, ed ecco che Dorando Pietri fu scelto per rappresentare l’Italia ai Giochi
10 olimpici2, nientemeno.
Alla linea di partenza, davanti agli occhi e al sorriso di principesse e principini, gli atleti saltellavano nervosi e vogliosi di fuggire verso il traguardo. Si scrutavano e si sbirciavano, cercando di intuire chi tra loro fosse un campione e chi no, chi più bruciante nello scatto, chi più potente in progressione. Finché la principessa non 15 alzò la bandierina, ottenendo il silenzio della folla, poi la abbassò di scatto dando il via e che vincesse il migliore.
Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria.
A metà gara qualcuno si era già ritirato, qualcuno si era attardato, ma più o meno
i migliori erano tutti lì, a correre e a badare gli uni agli altri, a cercare l’attimo per la fuga o per non venir presi in contropiede. È lungo il tempo di una maratona: ancor più lungo se ci sei tu tra i corridori.
Finché, a chissà quale chilometro, Dorando non girò lo sguardo a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, di qua e di là. A parte il pubblico lungo la 25 strada a incitare festante, nessuno era lì con lui, men che meno gli altri corridori. Nessuno. I casi, a questo punto, erano tre.
Aveva sbagliato strada. Ma allora la gente lungo la via cosa ci stava a fare? Se c’era folla sul marciapiede significava che il percorso era quello stabilito, per fortuna. Oppure era ultimo, miseramente staccato dagli atleti più forti e tanti saluti ai sogni 30 di gloria. Però anche questo gli pareva strano: avrebbe dovuto accorgersene correndo, con la vista delle schiene degli avversari allontanarsi davanti a lui, fino a perdersi dietro qualche curva. E la folla, di nuovo, sarebbe stata con lui meno festante ed entusiasta.
Allora era primo! Primissimo, addirittura. Lo stadio e il traguardo dovevano essere
a pochi chilometri e il secondo, il terzo a qualche decina di secondi di distacco.
1 Garzone: aiutante, commesso.
2 Giochi olimpici: si tratta delle Olimpiadi del 1908, anno in cui è accaduta questa vicenda.
Non poteva che essere così! Il pensiero entusiasmò il nostro Dorando, donandogli un ultimo soffio di energia.
Arrivò per primo davvero allo stadio, Dorando Pietri, senza il sacco di pane sulle spalle, ma ormai anche senza più quel refolo di energia. Arrivò barcollando, che
pareva un fantasma, ma era primo, primissimo, e la folla era in estasi. Entrò nello stadio e come facesse a restare in piedi non si sa. Infatti cadde, poveretto, ma si rialzò, barcollando ancor di più. Un passo e un inciampo, poi di nuovo per terra. Fu un giudice pietoso e impietosito a tendergli la mano, per aiutarlo a rimettersi in piedi e indicargli la direzione per gli ultimi sforzi: pochi metri, un ultimo passo e
finalmente il nastro del traguardo gli si avvolse intorno alla vita, simbolo di quel trionfo che non aveva mai osato sognare.
Bravo Dorando! Evviva Dorando!
Dopo mezzo minuto tagliò il traguardo anche l’americano Johnny, felice del suo meritato secondo posto, che riprese fiato e andò a festeggiare con gli amici 50 yankee sulle tribune. Una medaglia olimpica è una medaglia olimpica, quale che sia il suo colore, e Johnny era felice come un bambino.
55
«Bada che l’italiano è stato aiutato a rialzarsi» spifferò uno del gruppo. «Da un giudice, addirittura! Altrimenti sarebbe ancora lì per terra e la medaglia d’oro l’avresti vinta tu...»
Ci volle poco per sporgere reclamo. Tutto il pubblico aveva visto la scena: l’italiano Dorando era stato aiutato davvero, magari poco, comunque già troppo. E la squalifica fu quasi automatica.
Johnny primo, Dorando non più. E buona fortuna per la prossima volta.
Sa essere crudele, lo sport, ma le regole sono regole e il loro rispetto è alla base
di ogni competizione.
Fu però uno scrittore di quelli veri, celebre quanto il suo personaggio, Arthur Conan Doyle, autore nientemeno che dell’investigatore Sherlock Holmes e del suo fido Watson, ad avvicinarsi al palco reale. Fece un cenno di saluto alla regina Alexandra e un secondo cenno per dirle qualcosa: «Regina mia cara» sussurrò
devotamente «perché non fai qualcosa di regale davvero? Organizzi a corte una gran festa di ballo e inviti questo piccolo italiano, che prima ha vinto e poi no, poveretto. Lo inviti e magari gli regali una coppa, balli un giro di valzer con lui, ancorché così piccino, e lui tornerà in continente pensando a Londra e al tuo regno come a un posto amichevole, nonostante la squalifica.»
La regina Alexandra seguì il consiglio e quella sera, dopo la corsa e la sconfitta, Dorando Pietri divenne il corridore di maratona più famoso del mondo, mentre Johnny era chissà dove a festeggiare con gli amici.
(Testo tratto da: Valente A., Così per SPORT, illustrazioni di Fulghesu I., Lapis Edizioni, 2016, Roma.)
2.qxp_Layout 1 10/02/25 10:25 Pagina 6
A1. Quali informazioni vengono date su Dorando nella parte iniziale del testo (da riga 1 a riga 11)?
Metti una crocetta per ogni riga.
A1. Quali informazioni vengono date su Dorando nella parte iniziale del testo (da riga 1 a riga 11)?
Metti una crocetta per ogni riga.
a)
Come lavoro consegnava pane e dolci alle persone
b) Era amato da tutti
a) Come lavoro consegnava pane e dolci alle persone
Informazione data Informazione NON data
Informazione data Informazione NON data
c) Amava correre
b) Era amato da tutti
c) Amava correre
d) Dopo il lavoro era molto stanco
d) Dopo il lavoro era molto stanco
A2. “(...) tremila metri a perdifiato, cinquemila, o persino trentamila, poco importava” (righe 7-8). A che cosa fanno riferimento questi numeri?
A. □ Ai soldi che vinceva Dorando Pietri nelle gare
A2. “(...) tremila metri a perdifiato, cinquemila, o persino trentamila, poco importava” (righe 7-8). A che cosa fanno riferimento questi numeri?
B. □ Alla velocità con cui Dorando Pietri correva nelle gare
A. □ Ai soldi che vinceva Dorando Pietri nelle gare
C. □ Al numero di corridori nelle gare a cui partecipava Dorando Pietri
B. □ Alla velocità con cui Dorando Pietri correva nelle gare
D. □ Alla lunghezza del percorso nelle gare che faceva Dorando Pietri
C. □ Al numero di corridori nelle gare a cui partecipava Dorando Pietri
D. □ Alla lunghezza del percorso nelle gare che faceva Dorando Pietri
A3. “Si scrutavano e si sbirciavano, cercando di intuire chi tra loro fosse un campione e chi no” (righe 13-14). Chi si scruta e si sbircia?
A3. “Si scrutavano e si sbirciavano, cercando di intuire chi tra loro fosse un campione e chi no” (righe 13-14). Chi si scruta e si sbircia?
A3. “Si scrutavano e si sbirciavano, cercando di intuire chi tra loro fosse un campione e chi no” (righe 13-14). Chi si scruta e si sbircia?
A. □ Le principesse e i principini presenti nel pubblico
A. □ Le principesse e i principini presenti nel pubblico
A. □ Le principesse e i principini presenti nel pubblico
B. □ Gli atleti alla linea di partenza
B. □ Gli atleti alla linea di partenza
B. □ Gli atleti alla linea di partenza
C. □ Le persone nella folla
C. □ Le persone nella folla
C. □ Le persone nella folla
D. □ Dorando Pietri e la principessa che dà il via alla gara
D. □ Dorando Pietri e la principessa che dà il via alla gara
D. □ Dorando Pietri e la principessa che dà il via alla gara
A4. “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”. In questa frase l’autore non ha messo il verbo. In quale punto deve essere inserito il verbo per rendere la frase più chiara?
A4. “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”.
In questa frase l’autore non ha messo il verbo. In quale punto deve essere inserito il verbo per rendere la frase più chiara?
A4. “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”. In questa frase l’autore non ha messo il verbo. In quale punto deve essere inserito il verbo per rendere la frase più chiara?
A. □ “Con il pettorale c’era numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
A. □ “Con il pettorale c’era numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
A. □ “Con il pettorale c’era numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
B. □ “Con il pettorale numero 19 era appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
B. □ “Con il pettorale numero 19 era appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
B. □ “Con il pettorale numero 19 era appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
C. □ “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, c’era il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
C. □ “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, c’era il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
C. □ “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, c’era il baffuto Dorando, garzone di panetteria”
D. □ “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, era garzone di panetteria”
D. □ “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, era garzone di panetteria”
D. □ “Con il pettorale numero 19 appuntato sulla maglietta bianca, il baffuto Dorando, era garzone di panetteria”
A5. “È lungo il tempo di una maratona: ancor più lungo se ci sei tu tra i corridori.” (righe 22-23).
A5. “È lungo il tempo di una maratona: ancor più lungo se ci sei tu tra i corridori.” (righe 22-23).
A5. “È lungo il tempo di una maratona: ancor più lungo se ci sei tu tra i corridori.” (righe 22-23).
Con questa frase l’autore vuole fare capire che
Con questa frase l’autore vuole fare capire che
Con questa frase l’autore vuole fare capire che
A. □ la lunghezza di una maratona cambia da un corridore all’altro
A. □ la lunghezza di una maratona cambia da un corridore all’altro
A. □ la lunghezza di una maratona cambia da un corridore all’altro
B. □ una maratona sembra durare di più ai corridori per la fatica che fanno
B. □ una maratona sembra durare di più ai corridori per la fatica che fanno
B. □ una maratona sembra durare di più ai corridori per la fatica che fanno
C. □ ci vuole molto tempo per essere accettato tra i corridori di una maratona
C. □ ci vuole molto tempo per essere accettato tra i corridori di una maratona
C. □ ci vuole molto tempo per essere accettato tra i corridori di una maratona
D. □ una maratona è più lunga se ci sono tanti corridori che partecipano
D. □ una maratona è più lunga se ci sono tanti corridori che partecipano
D. □ una maratona è più lunga se ci sono tanti corridori che partecipano

A7. In base al testo, in quale posizione si trova Dorando durante la gara quando si accorge di correre da solo?
A7. In base al testo, in quale posizione si trova Dorando durante la gara quando si accorge di correre da solo?
Sotto trovi una sintesi divisa in due parti di come finisce la gara. Inserisci le parole che mancano.
Attenzione: in ognuna delle due liste ci sono 4 parole in più.
Sotto trovi una sintesi divisa in due parti di come finisce la gara. Inserisci le parole che mancano.
Attenzione: in ognuna delle due liste ci sono 4 parole in più. A8. Quando Dorando arriva allo stadio è così
A8. Quando Dorando arriva allo stadio è così
(1) che non vede il traguardo e ………………………………………………… (2); poi un giudice lo aiuta a ………………………………………………… (3) e gli indica dove andare. Allora riesce a ………………………………………………… (4) il traguardo.
(1) che non vede il traguardo e ………………………………………………… (2); poi un giudice lo aiuta a ………………………………………………… (3) e gli indica dove andare. Allora riesce a
RIALZARSI CONTENTO CADE RIDE TAGLIARE STANCO RIPOSARSI TROVARE
(4) il traguardo. RIALZARSI CONTENTO CADE RIDE TAGLIARE STANCO RIPOSARSI TROVARE
A9. Ma qualcuno ha visto la scena e
A9. Ma qualcuno ha visto la scena e
(1) a Johnny di protestare.
(1) a Johnny di protestare.
(2) Dorando, che era stato
proclamato ………………………………………………… (3), viene squalificato e a Johnny, che era arrivato secondo, viene data la medaglia ………………………………………………… (4).
COSÌ VINCITORE EROE EPPURE D’ORO SUGGERISCE D’ARGENTO IMPEDISCE
(2) Dorando, che era stato proclamato ………………………………………………… (3), viene squalificato e a Johnny, che era arrivato secondo, viene data la medaglia ………………………………………………… (4). COSÌ VINCITORE EROE EPPURE D’ORO SUGGERISCE D’ARGENTO IMPEDISCE
Sotto trovi una sintesi divisa in due parti di come finisce la gara. Inserisci le parole che mancano.
Attenzione: in ognuna delle due liste ci sono 4 parole in più.
Sotto trovi una sintesi divisa in due parti di come finisce la gara. Inserisci le parole che mancano.
Attenzione: in ognuna delle due liste ci sono 4 parole in più.
A8. Quando Dorando arriva allo stadio è così
A8. Quando Dorando arriva allo stadio è così
………………………………………………… (1) che non vede il traguardo e ………………………………………………… (2); poi un
………………………………………………… (1) che non vede il traguardo e ………………………………………………… (2); poi un
giudice lo aiuta a ………………………………………………… (3) e gli indica dove andare. Allora riesce a
giudice lo aiuta a ………………………………………………… (3) e gli indica dove andare. Allora riesce a
(4) il traguardo.
………………………………………………… (4) il traguardo.
A9. Ma qualcuno ha visto la scena e
RIALZARSI CONTENTO CADE RIDE
RIALZARSI CONTENTO CADE RIDE
TAGLIARE STANCO RIPOSARSI TROVARE
TAGLIARE STANCO RIPOSARSI TROVARE
A9. Ma qualcuno ha visto la scena e ………………………………………………… (1) a Johnny di protestare.
………………………………………………… (1) a Johnny di protestare.
COSÌ VINCITORE
………………………………………………… (2) Dorando, che era stato
proclamato ………………………………………………… (3), viene squalificato e a Johnny, che era arrivato secondo, viene data
………………………………………………… (2) Dorando, che era stato proclamato ………………………………………………… (3), viene squalificato e a Johnny, che era arrivato secondo, viene data la medaglia ………………………………………………… (4).
la medaglia ………………………………………………… (4).
COSÌ VINCITORE EROE EPPURE D’ORO SUGGERISCE D’ARGENTO IMPEDISCE
EROE EPPURE D’ORO SUGGERISCE D’ARGENTO IMPEDISCE
A10. L’autore commenta il risultato della gara dicendo “Sa essere crudele, lo sport (...)” (riga 60). Che cosa c’è di crudele in questa vicenda?
A10. L’autore commenta il risultato della gara dicendo “Sa essere crudele, lo sport (...)” (riga 60). Che cosa c’è di crudele in questa vicenda?
A10. L’autore commenta il risultato della gara dicendo “Sa essere crudele, lo sport (...)” (riga 60). Che cosa c’è di crudele in questa vicenda?
A. □ Prima Dorando vive un momento di trionfo e subito dopo viene squalificato
A. □ Prima Dorando vive un momento di trionfo e subito dopo viene squalificato
A. □ Prima Dorando vive un momento di trionfo e subito dopo viene squalificato
B. □ La gara è stata così estenuante che all’arrivo Dorando non riesce più a tenersi in piedi
B. □ La gara è stata così estenuante che all’arrivo Dorando non riesce più a tenersi in piedi
B. □ La gara è stata così estenuante che all’arrivo Dorando non riesce più a tenersi in piedi
C. □ Il giudice ha aiutato Dorando sapendo che così sarebbe stato squalificato
C. □ Il giudice ha aiutato Dorando sapendo che così sarebbe stato squalificato
C. □ Il giudice ha aiutato Dorando sapendo che così sarebbe stato squalificato
D. □ C’è stata una persona invidiosa che non voleva che Dorando vincesse
D. □ C’è stata una persona invidiosa che non voleva che Dorando vincesse
D. □ C’è stata una persona invidiosa che non voleva che Dorando vincesse
A11. Dove si svolgono i Giochi Olimpici a cui partecipa Dorando?
A11. Dove si svolgono i Giochi Olimpici a cui partecipa Dorando?
A11. Dove si svolgono i Giochi Olimpici a cui partecipa Dorando?
A12. Perché lo scrittore Conan Doyle chiede alla regina Alexandra di invitare Dorando a un ballo e di regalargli una coppa?
A12. Perché lo scrittore Conan Doyle chiede alla regina Alexandra di invitare Dorando a un ballo e di regalargli una coppa?
A12. Perché lo scrittore Conan Doyle chiede alla regina Alexandra di invitare Dorando a un ballo e di regalargli una coppa?
A. □ Perché è uno scrittore abituato a scrivere storie con un lieto fine e vuole che anche la vicenda di Dorando finisca bene
A. □ Perché è uno scrittore abituato a scrivere storie con un lieto fine e vuole che anche la vicenda di Dorando finisca bene
A. □ Perché è uno scrittore abituato a scrivere storie con un lieto fine e vuole che anche la vicenda di Dorando finisca bene
B. □ Perché ha paura che Dorando tornando a casa smetta di partecipare alle Olimpiadi
B. □ Perché ha paura che Dorando tornando a casa smetta di partecipare alle Olimpiadi
B. □ Perché ha paura che Dorando tornando a casa smetta di partecipare alle Olimpiadi
C. □ Perché vuole alleviare la delusione di Dorando e lasciargli un ricordo positivo del Paese in cui ha vissuto questa vicenda
C. □ Perché vuole alleviare la delusione di Dorando e lasciargli un ricordo positivo del Paese in cui ha vissuto questa vicenda
C. □ Perché vuole alleviare la delusione di Dorando e lasciargli un ricordo positivo del Paese in cui ha vissuto questa vicenda
D. □ Perché spera di essere invitato con Dorando al ballo della regina e di ricevere un regalo anche lui
D. □ Perché spera di essere invitato con Dorando al ballo della regina e di ricevere un regalo anche lui
D. □ Perché spera di essere invitato con Dorando al ballo della regina e di ricevere un regalo anche lui
A13. Il titolo del racconto è “Primo, primissimo, anzi no”. Quale informazione del testo fa capire perché l’autore ha scritto “anzi no” dopo “primo, primissimo”?
A13. Il titolo del racconto è “Primo, primissimo, anzi no”. Quale informazione del testo fa capire perché l’autore ha scritto “anzi no” dopo “primo, primissimo”?
A. □ “Dopo mezzo minuto tagliò il traguardo anche l’americano Johnny, felice del suo meritato secondo posto”
B. □ “Una medaglia olimpica è una medaglia olimpica, quale che sia il suo colore”
A. □ “Dopo mezzo minuto tagliò il traguardo anche l’americano Johnny, felice del suo meritato secondo posto”
C. □ “E la squalifica fu quasi automatica. Johnny primo, Dorando non più”
B. □ “Una medaglia olimpica è una medaglia olimpica, quale che sia il suo colore”
D. □ “E buona fortuna per la prossima volta”
C. □ “E la squalifica fu quasi automatica. Johnny primo, Dorando non più”
D. □ “E buona fortuna per la prossima volta”
A14. Come possiamo descrivere questo testo?
A. □ È la narrazione di un episodio vero
A14. Come possiamo descrivere questo testo?
B. □ È la spiegazione delle regole di un evento sportivo
A. □ È la narrazione di un episodio vero
C. □ È il racconto di fantasia di una vicenda drammatica
B. □ È la spiegazione delle regole di un evento sportivo
D. □ È la descrizione autobiografica di una gara
C. □ È il racconto di fantasia di una vicenda drammatica
D. □ È la descrizione autobiografica di una gara
5
Tra le centinaia di specie di primati – il gruppo di mammiferi di cui facciamo parte anche noi esseri umani – ne esistono alcune con caratteristiche molto particolari, che vivono soltanto sull’isola del Madagascar: i lemuri.
Il nostro protagonista, il sifaka candido, è uno di loro.
Ma come hanno fatto questi animali a colonizzare la grande isola situata nell’Oceano Indiano lontana 400 km dal continente?

Il sifaka candido (Propithecus candidus) è uno dei lemuri più rari del Madagascar. Ridotto a vivere in alcune aree protette del Nord-est, rischia di scomparire.

Gli studiosi hanno formulato varie teorie, ma al momento la più credibile è quella 10 della zattera.
Per quanto possa sembrarci un evento straordinario e improbabile, non è del tutto impossibile. Si ipotizza che un gruppo di antenati dei lemuri odierni sia riuscito ad attraversare l’oceano aggrappato ad alberi e ad altra vegetazione galleggiante, probabilmente sradicata dalla forza di un fiume che l’aveva
trascinata fino al mare. Sicuramente si è trattato di un viaggio tutt’altro che facile, durato almeno tre settimane.
Probabilmente questi colonizzatori erano piccoli lemuri abituati ad andare in letargo in gruppi anche di 15 individui, il che può avere reso più facile la sopravvivenza durante il viaggio in mezzo all’oceano e la successiva espansione,
una volta arrivati su una spiaggia del Madagascar.
Il sifaka candido è uno dei quattro lemuri più rari, e si trova solo in tre aree protette situate nel Nord-est del Madagascar, soprattutto all’interno del Parco nazionale di Marojejy.
I sifaka candidi sono attivi solo durante le ore di luce e si muovono quasi esclusivamente in maniera arboricola. Vivono principalmente in foreste di montagna, dalle pendenze molto pronunciate. In un giorno possono percorrere circa 700 mt di distanza. Sono molto rapidi nello
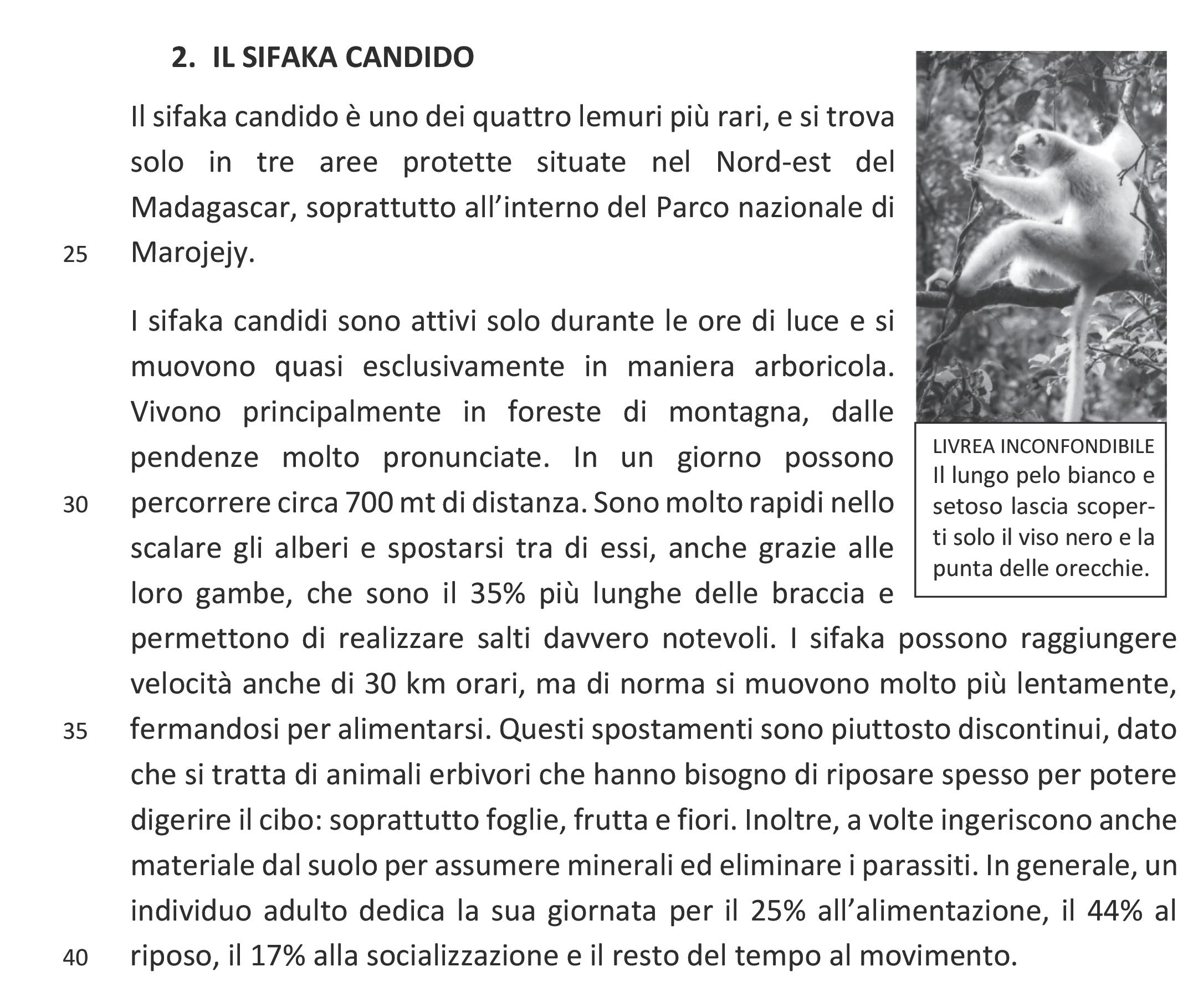
LIVREA INCONFONDIBILE
Il lungo pelo bianco e setoso lascia scoperti solo il viso nero e la punta delle orecchie.
scalare gli alberi e spostarsi tra di essi, anche grazie alle loro gambe, che sono il 35% più lunghe delle braccia e permettono di realizzare salti davvero notevoli. I sifaka possono raggiungere velocità anche di 30 km orari, ma di norma si muovono molto più lentamente, fermandosi per alimentarsi. Questi spostamenti sono piuttosto discontinui, dato
che si tratta di animali erbivori che hanno bisogno di riposare spesso per potere digerire il cibo: soprattutto foglie, frutta e fiori. Inoltre, a volte ingeriscono anche materiale dal suolo per assumere minerali ed eliminare i parassiti. In generale, un individuo adulto dedica la sua giornata per il 25% all’alimentazione, il 44% al riposo, il 17% alla socializzazione e il resto del tempo al movimento.
I sifaka vivono nelle foreste pluviali e purtroppo sono scomparsi dalle aree in cui gli alberi sono stati tagliati per vendere legname pregiato e fare spazio alle coltivazioni di vaniglia.
Ne rimangono meno di mille individui. Numeri come questi fanno di questa specie una delle più minacciate del pianeta. Il suo comportamento ne rende
impossibile la sopravvivenza in cattività, per cui l’unica strategia per conservarla è quella di preservare il suo habitat naturale. Le attività economiche collegate ai turisti che vengono a osservare i sifaka sembrano costituire la loro principale possibilità di salvezza, e si spera possano riprendere dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19.
(Tratto e adattato da: Focus Wild n° 119/giugno 2021, testo di Ugo Mellone.)
B1. “Il nostro protagonista, il sifaka candido, è uno di loro” (riga 6). A chi si riferisce “loro”?
B1. “Il nostro protagonista, il sifaka candido, è uno di loro” (riga 6). A chi si riferisce “loro”?
B1. “Il nostro protagonista, il sifaka candido, è uno di loro” (riga 6). A chi si riferisce “loro”?
B2. Nel paragrafo 1 si parla della teoria della “zattera”. Secondo questa teoria gli antenati dei lemuri come avrebbero raggiunto la spiaggia del Madagascar?
B2. Nel paragrafo 1 si parla della teoria della “zattera”. Secondo questa teoria gli antenati dei lemuri come avrebbero raggiunto la spiaggia del Madagascar?
A7. In base al testo, in quale posizione si trova Dorando durante la gara quando si accorge di correre da solo?
B2. Nel paragrafo 1 si parla della teoria della “zattera”. Secondo questa teoria gli antenati dei lemuri come avrebbero raggiunto la spiaggia del Madagascar?
Sotto trovi una sintesi divisa in due parti di come finisce la gara. Inserisci le parole che mancano.
Attenzione: in ognuna delle due liste ci sono 4 parole in più.
A8. Quando Dorando arriva allo stadio è così
B3. “Per quanto possa sembrarci un evento straordinario e improbabile, non è del tutto impossibile” (righe 12-13). Qual è l’evento di cui si parla?
B3. “Per quanto possa sembrarci un evento straordinario e improbabile, non è del tutto impossibile” (righe 12-13). Qual è l’evento di cui si parla?
A. □ I lemuri del Madagascar hanno sviluppato caratteristiche molto particolari
A. □ I lemuri del Madagascar hanno sviluppato caratteristiche molto particolari
B3. “Per quanto possa sembrarci un evento straordinario e improbabile, non è del tutto impossibile” (righe 12-13). Qual è l’evento di cui si parla?
B. □ I lemuri che sono piccoli sono riusciti a occupare una grande isola come il Madagascar
B. □ I lemuri che sono piccoli sono riusciti a occupare una grande isola come il Madagascar
(1) che non vede il traguardo e ………………………………………………… (2); poi un giudice lo aiuta a ………………………………………………… (3) e gli indica dove andare. Allora riesce a
A. □ I lemuri del Madagascar hanno sviluppato caratteristiche molto particolari
C. □ I lemuri sono arrivati in Madagascar spostandosi in mare per tanti chilometri
RIALZARSI CONTENTO CADE RIDE TAGLIARE STANCO RIPOSARSI TROVARE
B. □ I lemuri che sono piccoli sono riusciti a occupare una grande isola come il Madagascar
(4) il traguardo.
C. □ I lemuri sono arrivati in Madagascar spostandosi in mare per tanti chilometri
D. □ I lemuri sono riusciti a sopravvivere sulle spiagge dell’isola del Madagascar
D. □ I lemuri sono riusciti a sopravvivere sulle spiagge dell’isola del Madagascar
C. □ I lemuri sono arrivati in Madagascar spostandosi in mare per tanti chilometri
A9. Ma qualcuno ha visto la scena e
D. □ I lemuri sono riusciti a sopravvivere sulle spiagge dell’isola del Madagascar
(1) a Johnny di protestare.
(2) Dorando, che era stato
B4. Nello schema che segue sono riportate alcune informazioni date alla fine del paragrafo 1.
Completa lo schema scegliendo nel riquadro la risposta necessaria per rendere più chiara la relazione tra le informazioni date.
(...) erano piccoli lemuri abituati ad andare in letargo in gruppi anche di 15 individui...
A. □ ...quindi potevano stare senza mangiare per lungo tempo...
B. □ ...quindi potevano difendersi dai predatori…
C. □ ...quindi durante il viaggio stavano fermi...
D. □ ...quindi potevano aiutarsi e riprodursi una volta arrivati…
...il che può avere reso più facile la successiva espansione nel Madagascar
B5. Nel paragrafo 2 viene descritta la giornata tipica di un sifaka adulto, con i tempi che dedica a ciascuna attività. Quale grafico corrisponde alla suddivisione corretta dei tempi?
B5. Nel paragrafo 2 viene descritta la giornata tipica di un sifaka adulto, con i tempi che dedica a ciascuna attività. Quale grafico corrisponde alla suddivisione corretta dei tempi?
B6. In base al paragrafo 3, qual è la causa del rischio di estinzione dei sifaka?
B6. In base al paragrafo 3, qual è la causa del rischio di estinzione dei sifaka?
A. □ La minaccia di altri primati
A. □ La minaccia di altri primati
B. □ La pandemia di Covid-19
B. □ La pandemia di Covid-19
C. □ La distruzione delle foreste
C. □ La distruzione delle foreste
D. □ La vicinanza degli uomini
D. □ La vicinanza degli uomini
B7. In base al paragrafo 3, che cosa rappresenta una possibilità di salvezza per i sifaka in Madagascar?
B7. In base al paragrafo 3, che cosa rappresenta una possibilità di salvezza per i sifaka in Madagascar?
A. □ L’aumento della coltivazione della vaniglia
A. □ L’aumento della coltivazione della vaniglia
B. □ L’aumento dell’esportazione del legname pregiato
B. □ L’aumento dell’esportazione del legname pregiato
C. □ Il fatto che i sifaka possano essere facilmente allevati
C. □ Il fatto che i sifaka possano essere facilmente allevati
D. □ Il fatto che i sifaka siano una delle attrazioni turistiche dell’isola
D. □ Il fatto che i sifaka siano una delle attrazioni turistiche dell’isola
B8. Quella che trovi di seguito è la carta di identità dell’animale descritto nel testo. Alcune parti sono già compilate. Completa tu le parti mancanti cercando le informazioni nel testo.
B8. Quella che trovi di seguito è la carta di identità dell’animale descritto nel testo. Alcune parti sono già compilate. Completa tu le parti mancanti cercando le informazioni nel testo.
Famiglia: lemuri
Famiglia: lemuri
Nome scientifico: Propithecus candidus
Nome scientifico: Propithecus candidus
Nome comune: …………………………………………………………… (1)
Nome comune: …………………………………………………………… (1)
Dove vive: Nord-est del Madagascar
Dove vive: Nord-est del Madagascar
Habitat: ………………………………………………………………………. (2)
Habitat: ………………………………………………………………………. (2)
Alimentazione: ……………………………………………………………(3)
Alimentazione: ……………………………………………………………(3)
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
C1. Completa il seguente periodo inserendo negli spazi vuoti è o e.
C1. Completa il seguente periodo inserendo negli spazi vuoti è o e.
Il Boxer ……… (1) un cane di taglia grande, ha un’altezza media di circa 60 centimetri ……… (2) un peso compreso tra 25 ……… (3) 32 kg. Il corpo ……… (4) robusto, con una muscolatura non eccessiva, ed ……… (5) ricoperto da un pelo corto lucido.
Il Boxer ……… (1) un cane di taglia grande, ha un’altezza media di circa 60 centimetri ……… (2) un peso compreso tra 25 ……… (3) 32 kg. Il corpo ……… (4) robusto, con una muscolatura non eccessiva, ed ……… (5) ricoperto da un pelo corto lucido.
C2. In quale delle frasi che seguono la parola lungo è usata come aggettivo?
C2. In quale delle frasi che seguono la parola lungo è usata come aggettivo?
A. □ La festa a casa di Mario è durata a lungo.
A. □ La festa a casa di Mario è durata a lungo.
B. □ Ho trascorso un lungo pomeriggio di gioco.
B. □ Ho trascorso un lungo pomeriggio di gioco.
C. □ La pista ciclabile si snoda lungo il fiume.
C. □ La pista ciclabile si snoda lungo il fiume.
D. □ Paolo è il più bravo nel salto in lungo.
D. □ Paolo è il più bravo nel salto in lungo.
C3. Nel testo che segue, qual è il tempo di ciascun verbo sottolineato? Indica la risposta che riporta i tempi nello stesso ordine in cui compaiono i verbi nella frase.
C3. Nel testo che segue, qual è il tempo di ciascun verbo sottolineato? Indica la risposta che riporta i tempi nello stesso ordine in cui compaiono i verbi nella frase.
“Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l’ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d’Ombrosa […]”.
B. nella
“Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l’ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d’Ombrosa […]”.
A. □ Passato remoto, passato prossimo, presente, imperfetto.
A. □ Passato remoto, passato prossimo, presente, imperfetto.
B. □ Presente, passato remoto, futuro, imperfetto.
B. □ Presente, passato remoto, futuro, imperfetto.
C. □ Passato remoto, passato remoto, presente, imperfetto.
C. □ Passato remoto, passato remoto, presente, imperfetto.
D. □ Imperfetto, passato remoto, presente, imperfetto.
D. □ Imperfetto, passato remoto, presente, imperfetto.
C4. Le parole che seguono sono tutte composte. Indica quale parola è composta da un aggettivo e da un nome.
C4. Le parole che seguono sono tutte composte. Indica quale parola è composta da un aggettivo e da un nome.
C4. Le parole che seguono sono tutte composte. Indica quale parola è composta da un aggettivo e da un nome.
A. □ Tostapane
A. □ Tostapane
A. □ Tostapane
B. □ Saliscendi
B. □ Saliscendi
B. □ Saliscendi
C. □ Purosangue
C. □ Purosangue
C. □ Purosangue
D. □ Marciapiede
D. □ Marciapiede
D. □ Marciapiede
C5. Il prefisso a- in molte parole indica la mancanza di qualcosa (ad esempio asimmetrico significa non simmetrico). In quale delle seguenti parole il prefisso a- assume lo stesso significato?
C5. Il prefisso a- in molte parole indica la mancanza di qualcosa (ad esempio asimmetrico significa non simmetrico). In quale delle seguenti parole il prefisso a- assume lo stesso significato?
C5. Il prefisso a- in molte parole indica la mancanza di qualcosa (ad esempio asimmetrico significa non simmetrico). In quale delle seguenti parole il prefisso a- assume lo stesso significato?
A. □ Anormale
A. □ Anormale
A. □ Anormale
B. □ Aperto
B. □ Aperto
B. □ Aperto
C. □ Addolcito
C. □ Addolcito
C. □ Addolcito
D. □ Abbracciato
D. □ Abbracciato
D. □ Abbracciato
C6. In ognuno di questi gruppi di parole cerchia la parola che ha un significato più generico delle altre.
C6. In ognuno di questi gruppi di parole cerchia la parola che ha un significato più generico delle altre.
C6. In ognuno di questi gruppi di parole cerchia la parola che ha un significato più generico delle altre.
Es. tavolo, sedia, mobile, letto, scrivania
Es. tavolo, sedia, mobile, letto, scrivania
Es. tavolo, sedia, mobile, letto, scrivania
1. euro, moneta, dollaro, sterlina, franco
1. euro, moneta, dollaro, sterlina, franco
1. euro, moneta, dollaro, sterlina, franco
2. margherita, violetta, rosa, fiore, tulipano
2. margherita, violetta, rosa, fiore, tulipano
2. margherita, violetta, rosa, fiore, tulipano
3. cibo, risotto, bistecca, insalata, zuppa
3. cibo, risotto, bistecca, insalata, zuppa
3. cibo, risotto, bistecca, insalata, zuppa
4. trota, tonno, merluzzo, sardina, pesce
4. trota, tonno, merluzzo, sardina, pesce
4. trota, tonno, merluzzo, sardina, pesce
C7. Quale delle espressioni elencate sotto completa correttamente il periodo che segue?
C7. Quale delle espressioni elencate sotto completa correttamente il periodo che segue?
C7. Quale delle espressioni elencate sotto completa correttamente il periodo che segue?
“Sono stanco …………. dormirò a casa tutto il pomeriggio”.
“Sono stanco …………. dormirò a casa tutto il pomeriggio”.
“Sono stanco …………. dormirò a casa tutto il pomeriggio”.
A. □ anche se
A. □ anche se
A. □ anche se
B. □ perché
B. □ perché
B. □ perché
C. □ quindi
C. □ quindi
C. □ quindi
D. □ invece
D. □ invece
D. □ invece
C8. In questo inizio di fiaba la parola “boscaiolo” è preceduta una volta dall’articolo indeterminativo “un” e un’altra volta dall’articolo determinativo “il”.
C8. In questo inizio di fiaba la parola “boscaiolo” è preceduta una volta dall’articolo indeterminativo “un” e un’altra volta dall’articolo determinativo “il”.
C8. In questo inizio di fiaba la determinativo “il”.
“C’era una volta un boscaiolo che aveva due bambini: Hänsel e Gretel. Il boscaiolo era un uomo terribilmente povero e non aveva niente per sfamare i due piccoli”.
“C’era una volta un boscaiolo che aveva due bambini: Hänsel e Gretel. Il boscaiolo era un uomo terribilmente povero e non aveva niente per sfamare i due piccoli”.
“C’era una volta un boscaiolo che aveva due bambini: Hänsel e Gretel. Il boscaiolo era un uomo terribilmente povero e non aveva niente per sfamare i due piccoli”.
La seconda volta il nome “boscaiolo” è usato con l’articolo determinativo
La seconda volta il nome “boscaiolo” è usato con l’articolo determinativo
La seconda volta il nome “boscaiolo” è usato con l’articolo determinativo
A. □ per indicare che si tratta di un altro boscaiolo.
A. □ per indicare che si tratta di un altro boscaiolo.
A. □ per indicare che si tratta di un altro boscaiolo.
B. □ per non usare due volte l’articolo indeterminativo.
B. □ per non usare due volte l’articolo indeterminativo.
B. □ per non usare due volte l’articolo indeterminativo.
C. □ perché ormai il boscaiolo è noto al lettore.
C. □ perché ormai il boscaiolo è noto al lettore.
C. □ perché ormai il boscaiolo è noto al lettore.
D. □ perché all’inizio di una frase si usa l’articolo determinativo.
D. □ perché all’inizio di una frase si usa l’articolo determinativo.
D. □ perché all’inizio di una frase si usa l’articolo determinativo.
C9. In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso?
C9. In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso?
C9. In quale delle seguenti frasi il soggetto è sottinteso?
A. □ Domani arrivano gli zii.
A. □ Domani arrivano gli zii.
A. □ Domani arrivano gli zii.
B. □ Mi piace il succo di pesca.
B. □ Mi piace il succo di pesca.
B. □ Mi piace il succo di pesca.
C. □ Ieri mattina è nato il fratellino di Luca.
C. □ Ieri mattina è nato il fratellino di Luca.
C. □ Ieri mattina è nato il fratellino di Luca.
D. □ Andiamo in palestra tre volte a settimana.
D. □ Andiamo in palestra tre volte a settimana.
D. □ Andiamo in palestra tre volte a settimana.
C10. Nelle frasi che seguono, indica se le parole sottolineate sono o non sono usate come verbi.
Metti una crocetta per ogni riga.
a) Hai fatto i compiti per domani?
b) Quando è successo questo fatto?
c) Cerco sempre di andare a letto presto.
d) Ho già letto più di metà del libro.
e) Ascolto musica da sempre.
f) Non è stato educato all’ascolto.
g) Fascia bene il dito ferito.
h) Alla cerimonia il sindaco indossava la fascia tricolore.
È usata come verbo NON è usata come verbo

Colora i quesiti a cui hai risposto correttamente.
RISPOSTE CORRETTE
comprensione del testo e lessico (testo narrativo)
comprensione del testo e lessico (testo argomentativo)
morfologia, sintassi e lessico
Ora osserva il grafico e rispondi:
- hai risposto correttamente alla maggior parte dei quesiti? SÌ NO - quanti punti hai totalizzato sul totale? /57 - come hai trovato questa prova? Barra la faccina corrispondente.
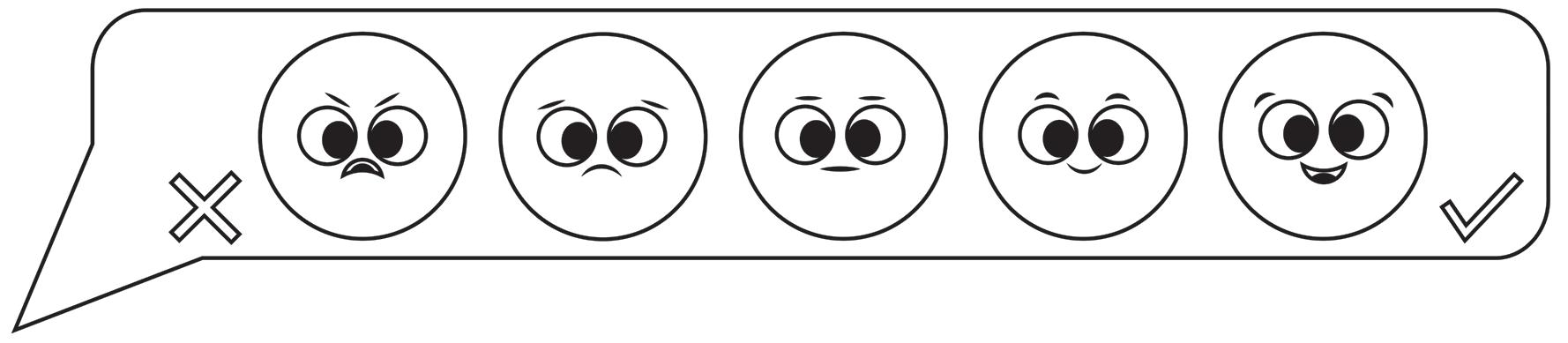

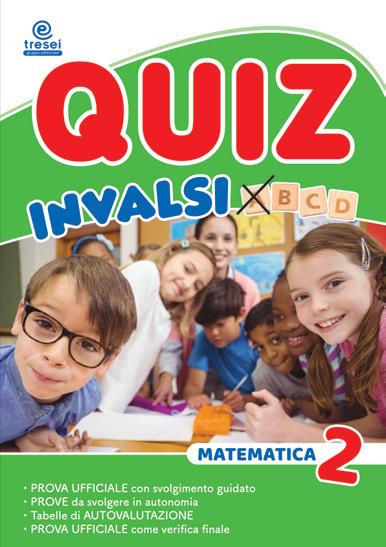
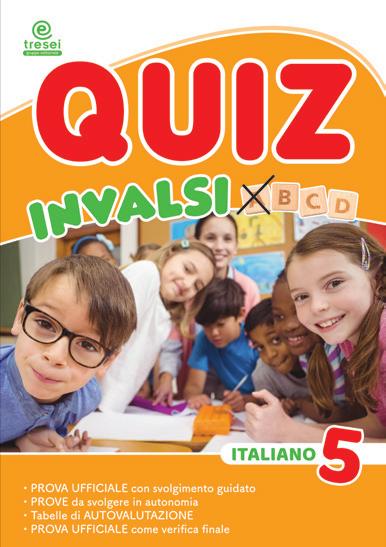
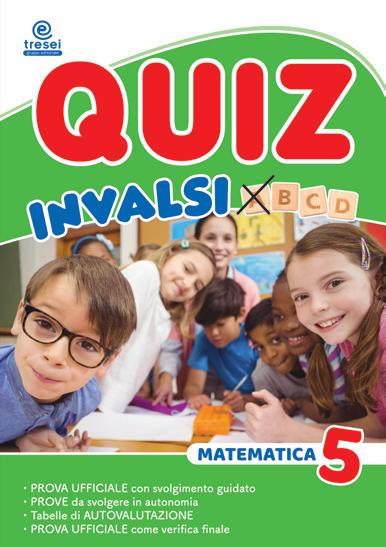
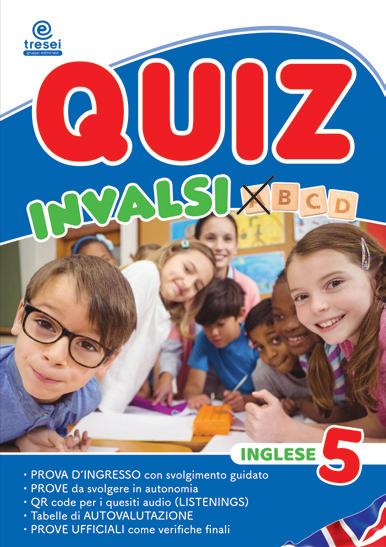
Gli eserciziari QUIZ INVALSI contengono un ricco percorso (128 pagine!) per prepararsi con graduale autonomia alle prove nazionali di italiano e matematica, previste per le classi seconda e quinta della Scuola Primaria, e di inglese (classe quinta).
Ogni eserciziario di italiano e matematica è così strutturato:
• una prova ufficiale GUIDATA e altre inedite da svolgere in AUTONOMIA, con autovalutazione (un istogramma, con le risposte corrette da colorare);
• ULTIMA PROVA UFFICIALE come verifica finale.
L’eserciziario di inglese contiene:
• prove inedite: quella d’ingresso GUIDATA e altre da svolgere in AUTONOMIA, con autovalutazione;
• QR code per i quesiti audio (listenings);
• ULTIME PROVE UFFICIALI come verifica finale;
• riepilogo delle REGOLE con GLOSSARIO.
In omaggio per l’insegnante: le soluzioni dei quesiti, sia nella versione cartacea, sia online (area riservata Primaria, sul sito www.tresei.com).
