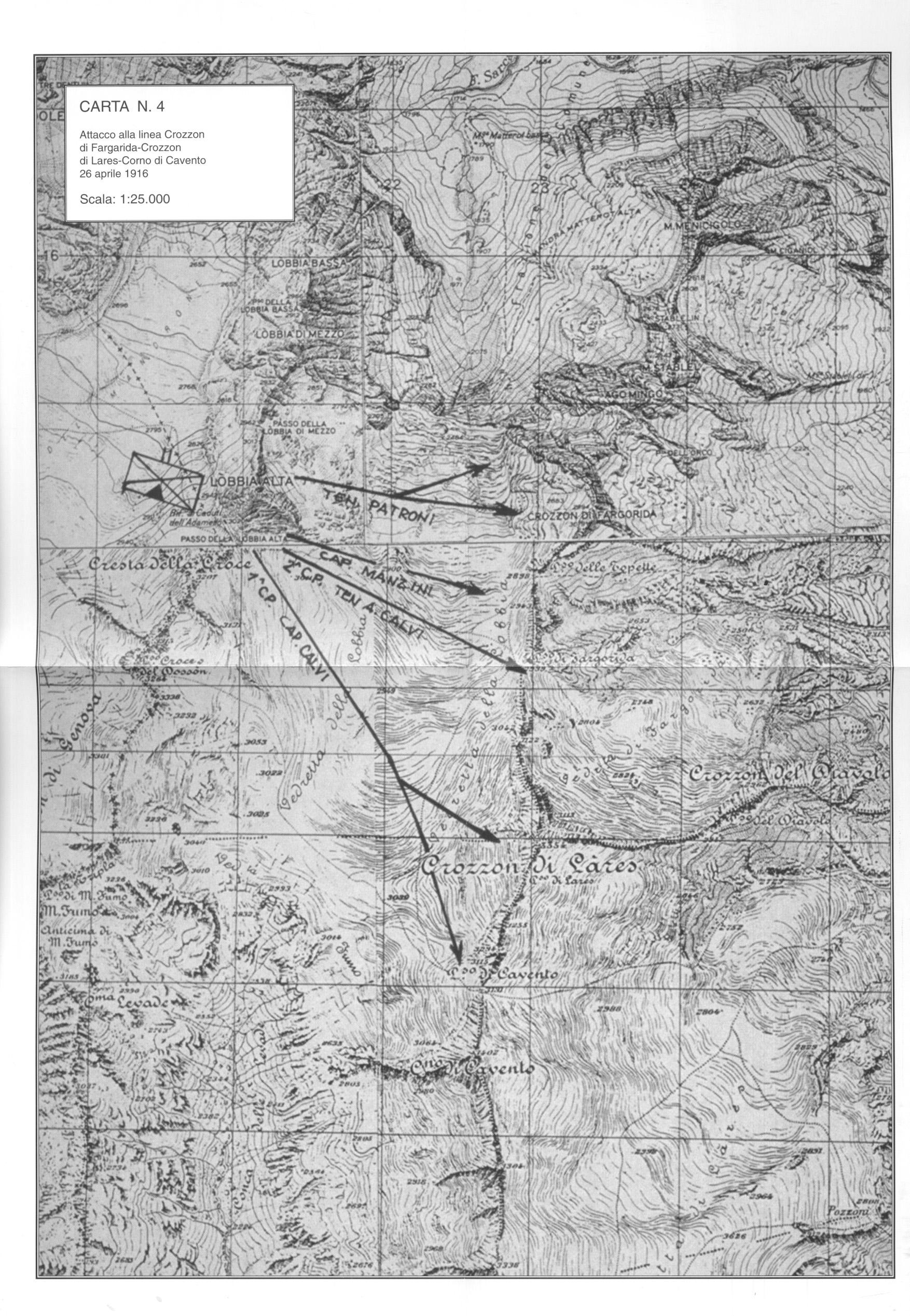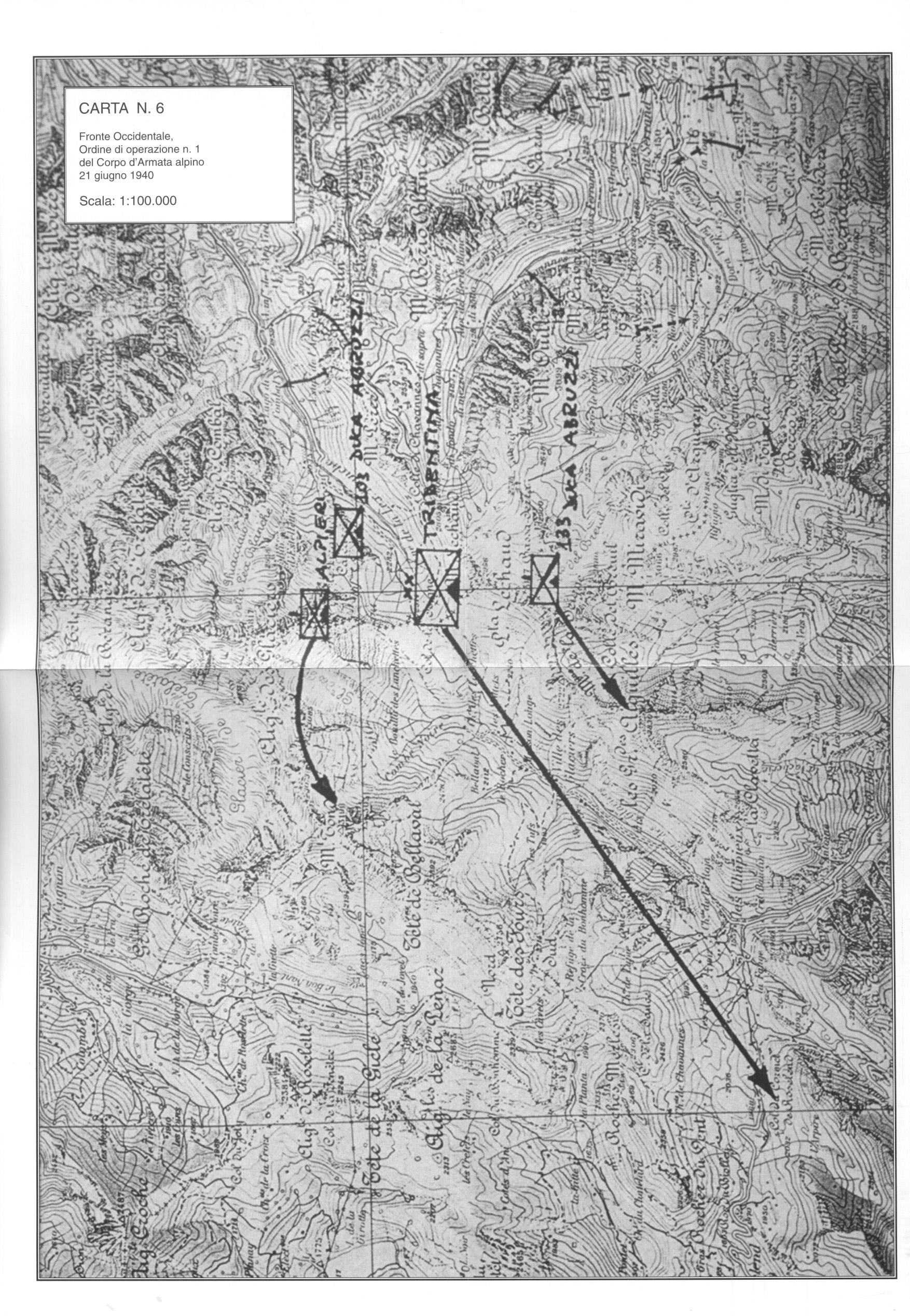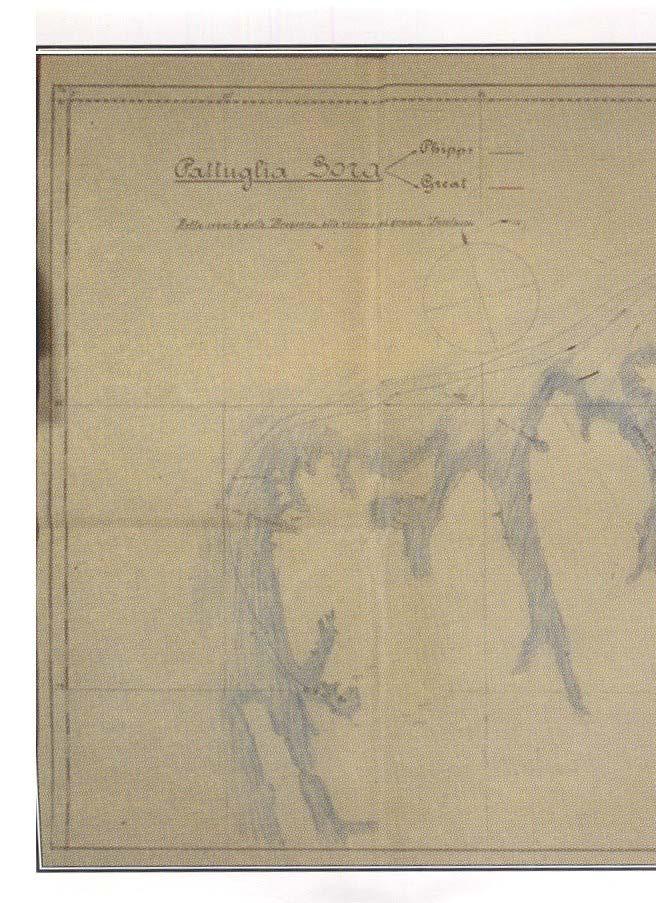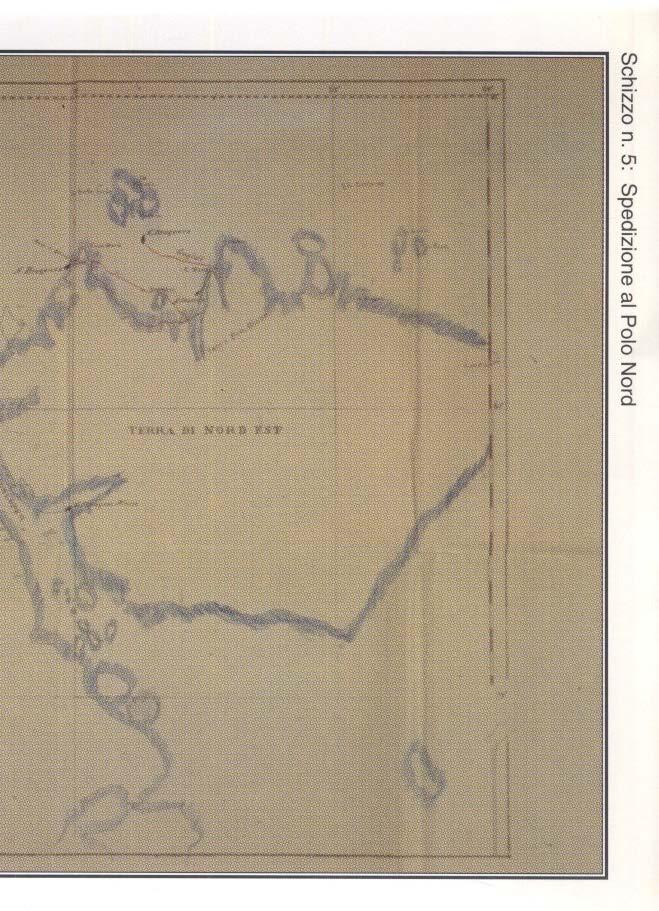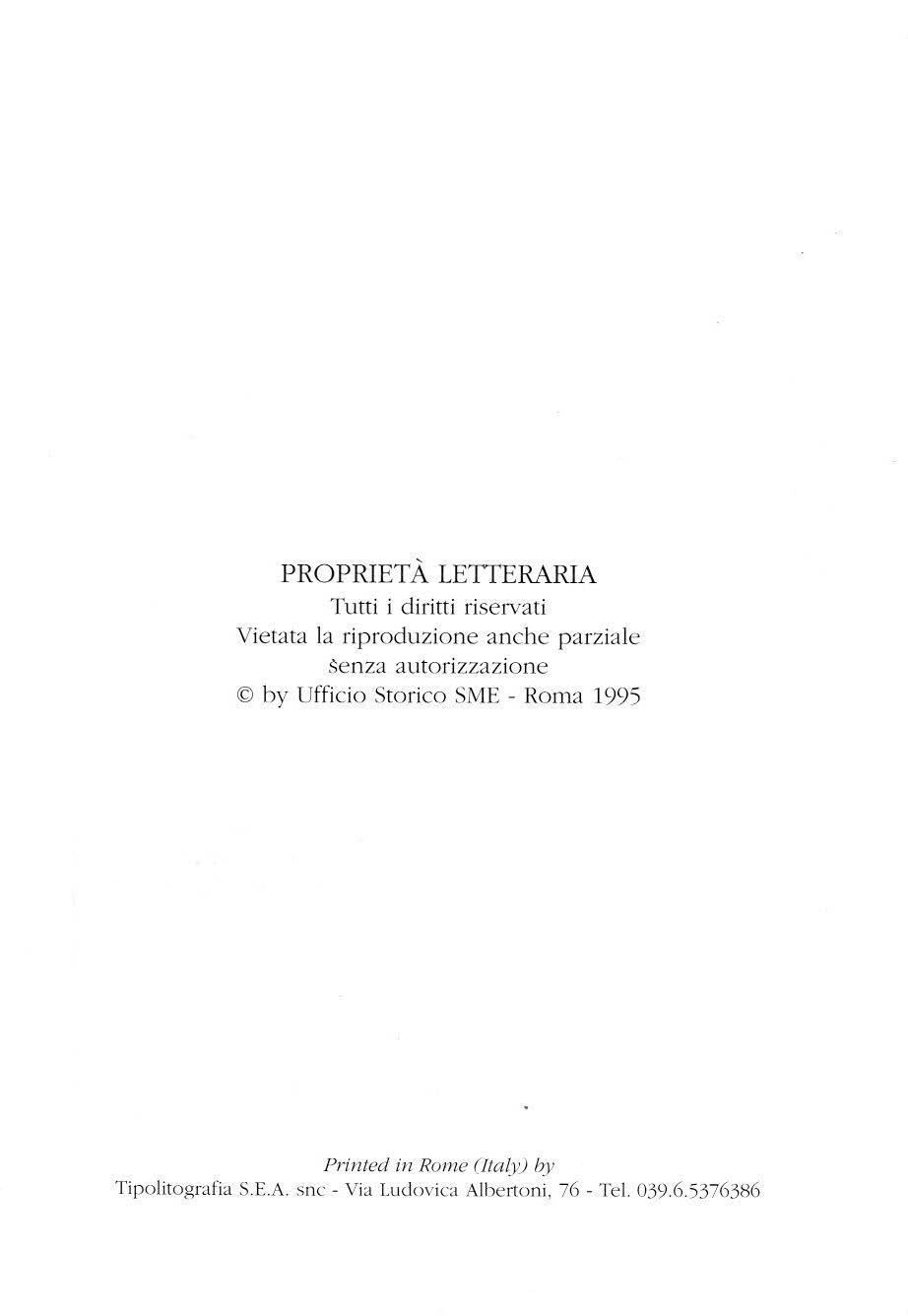
A mio padre Nico la Generale degli Alpini. e
a mio fratello Francesco Tenente Colonnello del Genio


Gli Alp ini hanno se m p re cos ti tu ito, n ell 'immagin a ri o collettivo del Paese, e le me nto trainante e di riferimento per va lori morali , tradizio ni , spirito di corpo ed onestà d' interventi.
Il volume non vuole assurgere ad u n testo sulla sro ri a degli Alpini , ma nell 'esaminare l'evo luzione dello sci, riesce a delineare con semplicità l' evolversi e le viciss itudini che le Trupp e AJp in e hanno avuto nel co rs o d egli ultimi novanta anni .
Due eleme nti caratterizzano questo lavoro : il fondamental e ruolo avuto dal personale che crede nell e is tituzioni ed opera serenamente affinch é possano assurgere a va lori o ttimali e l'u ni o n e che accu muna cittadini in armi e popolazio ne civile .
L'Ufficio Storico con questo volume che coniuga il rigore della ric erca ad una ric ca ed immediata illustrazione iconografica, ha voluto fornire un contributo all'evol uzione dell 'addestramento sciistico nell 'ambito dell'Eserc ito ed offrire un ulteriore s trume nto di conoscenza d e lle Truppe Alpine.


Ai g iorni nostri , quando si parla di sci, il pensiero corre s ubito alle vacanze invernali, le famose e sogn ate settimane bianche, in cui tu tti chi più ch i m e n o, c i sentiamo emu li dei va1i ero i delle piste.
Sogniamo infatti di trasformarci nei Ze n o Colò , n ei Klamm er, nei Thoeni e nei Tomba se a miam o lo sci alp in o, o ne i frat e lli Stella, n e i Nones , n e i De Zo lt , neg li Alba rello e nei Fauner se invece pr eferiamo lo sci n ord ico o d a fondo, senza dimenticare, peraltro , lo sci al femmin il e de ll e Compagnoni , delle Demetz , delle Di Centa , de lle Be lmondo e di tanti altri tra a tl eti ed atlete azzurr i e non.
Campioni del passato e di oggi che , co n le loro imp r ese agonistiche, hanno clonato attimi di partecipazione emotiva a tutti gli spo rtivi e contribuito alla diffusione di qu es ta sp lend ida d isc ip lin a sport iva.
Lo sci, tuttav ia, n on è solo sport; esso n acq u e come mezzo di trasporto per m u overs i più velocemente e con minor fatica su lla neve agevo la nd o l'uomo, in partico la re que ll o che viveva nelle regioni del Nord-E uropa, n e ll o sviluppo delle varie attività uman e q uali il commercio, la cac ci a e, talvolta, anche la guerra.
E' in q u esto contesto che la nostra ope ra si sv ilupp a per d esc rivere l' evol uzione dello sci n ell'ambito dell 'Esercito Italia no , inteso n o n so lo come attività sportiva, ma p rincipalm e nt e come mezzo atto a facilitare la m ob ilita ' de i reparti in terreno innev ato .
L'adozione dello sci da parte dell'Esercito Ita li a n o trova, qu ind i, la sua più naturale motivazione n el l'es igenza di fornire a quei reparti che sono c hi amat i a d operare in u n amb ie n te pa rt icolar e, quale la montagna innevata, materia li ed equipaggiamenti tali da facilitarne la mobilità e, contemporaneame nt e, in crementarne le capacità o pe rative.

Ed è sulla base di queste cons ide razi o ni c h e il 13 novembre
1902 il Min istro della Guerra dell ' epoca, Genera le Giuseppe Otto-
lenghi1, che in passato e ra stato Co mandante del 4° reggime nto Alpini , decise l' adozione degli sc i per i reggime nti Alpini con la segue nte motivazione: ··gli esperimenti pratic i sull·usodeglisci, eseguili sulle Alpi negli scorsi inverni, hanno dimostrato che tale m ezzo di locom ozione può rendere utili servizt" 2
a ra nno poi le success ive vicende che videro pr o tagonisti in particolare gli Alpini , naturali utilizzatori degli sci, e , nel 2° dopoguerra, anche g li Incurs o ri de l battag li o n e Paracadutis ti "Col Moschin " e l'Arma <lei Carabin ieri, a re ndere merito a qu esta lungimirante deci s ione.
Pur tuttavi a la determinazione di adottare g Li sci n e ll 'Esercito Italian o fu il fe lice risul tato della simbios i tra l'appassiona ta opern di alcuni "patiti " d e lla montagna , civili e militari, c he prend endo le mosse dal libro dell 'es ploratore no1vegese Fridtjof ansen: Attraver.so la Groenlandia, vero best se ller per l'Europa di fine '800, s i era n o così incu ri ositi a quegli stran i aggeggi ivi descritti: g li ski - co me erano chiamati allora - da dec idere di provarli essi tessi da una parte, e d il fe rmento evo lutivo che permeava la Forza Am1ata di inizio seco lo con l' introduzio ne di anni e d equipaggiame nti mode rni dall 'a ltra.
o n va , infatti, dim ent icato che s iamo nel period o nel qua le, anc he anrav e rso l' adozione del fucile m o d. ' 9 1 e, s uccessivam e nte , dell ' uniforme g rigio -verde, l'Eserc ico Itali ano si veniva tr asfo rmand o da esercito fin d e siécle ad ese rc ito mode rn o.
Ma prima di addent ra rci in que ll o che è il vero sco po di questo libro : il racco nto cioè dell'evoluzione d e llo sci nell ' Eserc ito Italiano , intendendo p e r evo lu zione s ia lo sv ilupp o tec ni co dell' attrezzo ch e l' attività addestrativa e normati va senza peraltro dim e ntica r e le v icend e belliche, gli uomini e d i re pani che ne furono i protagonisti, pare opponuno fare un breve excursus storico s ull e orig ini e lo sv ilup po di qu esto util e , dive rt ente e , perché no? affasci n ante attrezzo c he prima di ess e re uno strume nto di rila ssa nte dive nimento è un me zzo di tra s porto.
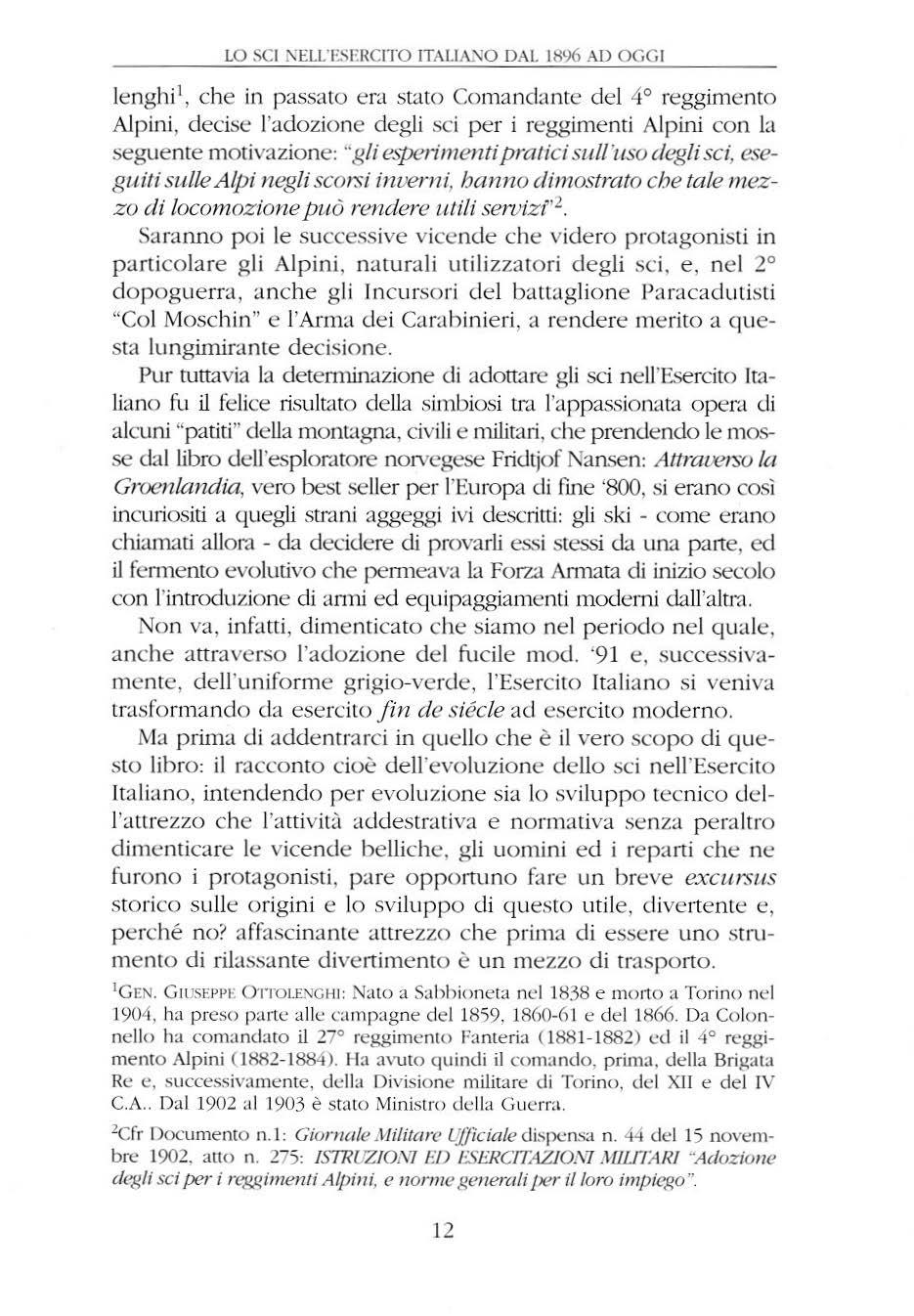
1GEN. G1usEPPE OrTOLE:,,JGHJ: Nato a Sabbion e ta nel 1838 e morto a Tor i no n e l 1904, ha preso parte a ll e c::i mpagne d el 1859, 1860-61 e del 1866 . Da Co lonnello ha co mandato il 27° regg im e nt o Fanteria (1881-1882) c<l il 4° reggimento Alpini (1882 -1 884). Ha avuto quindi il comando. prima, della Bri ga ta Re e, s uccess iv a mente, d e ll a Divis io n e militare di Torino, d el XII e de l IV
C.A.. Dal 1902 al 1903 è stato Ministro de l la G u e rra.
2Cfr Documento n. l: Gio rnale Militare Uffic iale dispe nsa n. 44 del 15 n ovembre 1902. atto n 275: JSTRUZJ0,\7 F.!) ESERCITAZJ0,\1 M.ILITART ·Adozione d c11,li sci per i regginienti Alpini, e norme generali p e r il loro impiego".


Si n da i temp i più antichi l' uomo aveva sentito la necessità di spostars i, di viagg iare per conoscere nuove terre , scambiare le merci, cacciare e, quando ciò e ra strettamente necessari o , fare la guerra.
Tuttavia l ' istinto al nomadi s mo dei nostri progenitori e d il desiderio d i conoscere nuove terre e nuove rea ltà , pur c on il sorgere dei paes i, d e i villaggi, delle città e qu indi con lo sviluppo di tutte q u elle attivi tà ad essi connesse che si d e finiscono stanz ia li , sono un qualche cosa di innato che l' u omo porta fermamente rad icato dentro il suo animo .
Per soddisfa r e ques ta ans ia l ' uomo ha dovuto necessariamente ingegnarsi a creare dei mezzi e d eg li equipaggiamenti in g rado d i permettergli di muoversi ed operare, con sempre maggior e comodità e ve locità, in ogni ambiente ed a tutte le lati tu d ini.
Le esigenze di mobilità , infatti, sono fo r teme n te co n dizionate dalle caratterist.iche fisiche dell'ambiente e delle la t itudini: il Pellerossa delle g ra n di p ianure nord americane si muove normalmente a cavallo, m e ntr e l 'Arabo, ne l deserto, pr e ferisce il cammello, da parte sua l'A borigeno che vive n e i vari atolli ci e l Pacifico u sa la canoa, mentre il Lappone, vivendo perennemente fra la nev e e d il ghiaccio, necessita di m e zzi idonei al particolare amb iente.

L'A rtico, oltre alle difficoltà del clima, prese nta il prob l ema di pote rs i muovere agevo lmente sulla neve , tale diffico ltà è rappr ese nta t a non t a nto da ll a qua n tità della stessa, ma dalla sua qualità che, favorendo un maggiore o minor e affondamento, rende la marcia più o meno faticosa e lenta.
Sulla n eve dura e ghiacciata l'affo n damento è minimo, in quella fresca o marcia è già disc reto , ma è in quella farinosa o
poh·erosa che si ha il masc;imo detraffondamento-1.
Per limiLarne gli effetti, sin dall'antichità, si è pertanto avvertita la necessità di studiare dei mezzi idonei che, permettendo un buon galleggiamento, aiutassero l'uomo a procedere più speditamente sulla superficie nevosa.
A questa ricerca aveva contribuito non poco la constatazione che sulla neve rimanevano le tracce della selvaggina, impronte che avrebbero permesso una facile ricerca ed un immediato inseguimento degli animali qualora si fosse trovato un modo per non affondare nella neve, ma, al contrario, muoversi rapidamente su di essa.
'\J'on è difficile ipotizzare che la soluzione iniziale a cui si pensò sia stata quella di modificare i calzari allargandone I~ base d'appoggio mediante fasciatura di più strati cli pelli; in un secondo tempo si fissarono alle suole delle armature di legno di larghezza superiore alla misura del piede.
Mancando tradizioni scrine da parte dei popoli nordici, le prime notizie ci giungono dal mondo greco ed in panicolare dal grande storico Erodoto 4 che, in uno dei suoi numerosi viaggi, visitò la reg ion e compresa tra l'attuale bassa Ucraina ed il Caucaso del '\orci abitata dagli Sciti e di cui scrisse, nel V libro delle Storie, che "han no piedi di capra" e che "vivono su alti monti che tagliano ogni comunicazione e che nessuno può valicarli'.
3Ne1 1e farinosa: neve caduta da poco e composta principalmente da un aggregato di minuti cristalli che racchiudono fra di loro abbondanza di aria.
1\'ece marcia: nev<: trasformata datreffeno calorico dei raggi del sok e dall'elevata temperntura, i cristalli non esistono pili per effetto dei vari processi di metamorfosi subiti; è ricca di acqua.
1Veve ghiacciata: neve che per effetto e.lei disgelo e del successivo conge lamento causati dall'azione della temperatura ambientale e dall'azione del sole, ha subito i vari processi di metamorfosi con aumento delle dimensionj dei cristal li e contemporanea diminuzione della qliant ità d'aria interposta; negli strati non superficiali l'aria , iene poi in p;irte espulsa anche per effeuo della pressione degli strati sovra:,tanti.
"'ERODOTO DI Auc.\R, \S.-,o: Storico gr1:co (ca 180-430 a.C.) è autore delle celebri Storie.
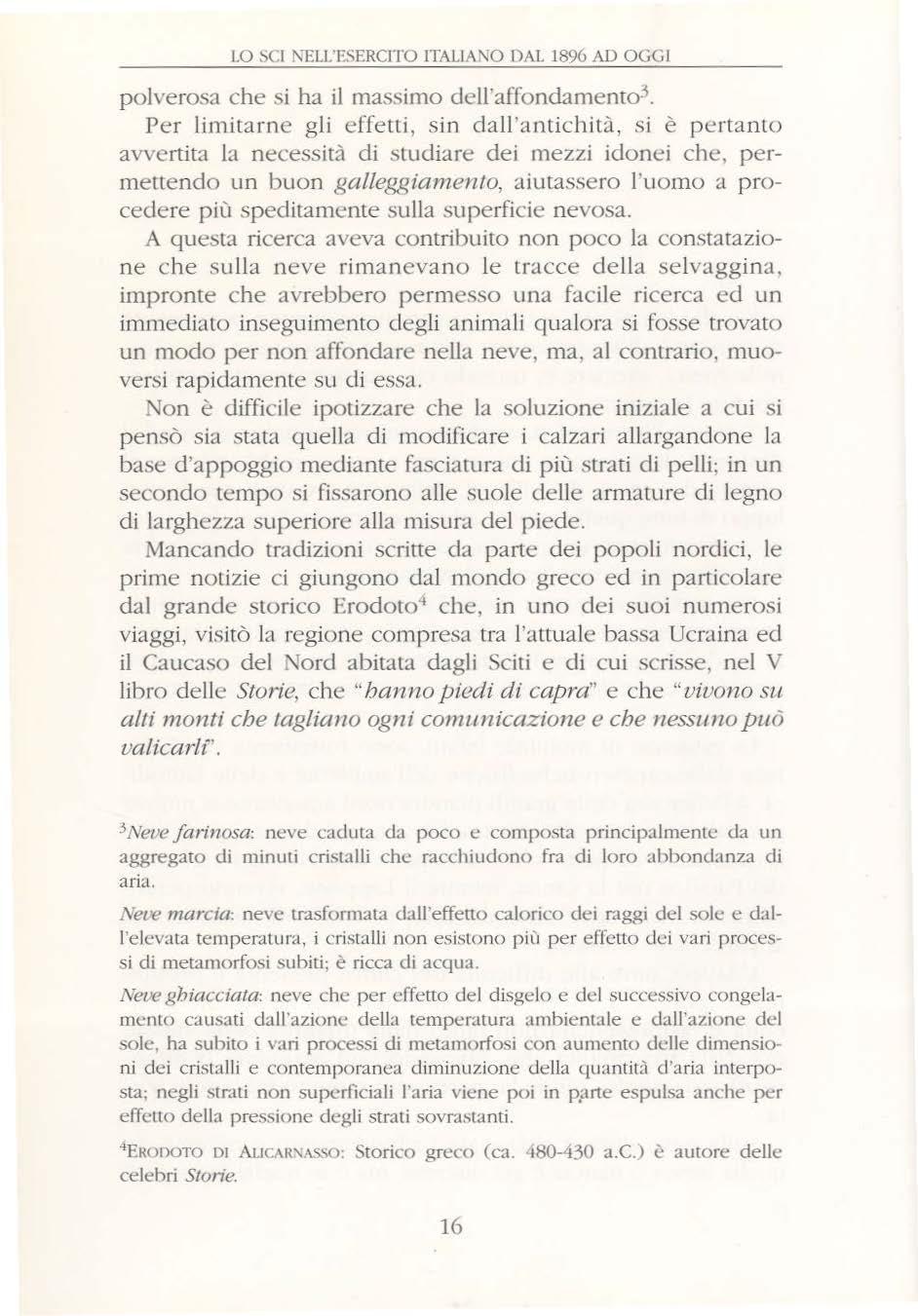

, e nofonte5. nel 400 a.e., racconta di avere imparato, nei monti dell 'Armenia, a legare dei sacchi all e zampe dei cavalli per impedire che affonda se ro nella neve fino al ventre.
Analogamente Strabone6, nel 20 a.C. , ci n arra che "i montanari del versante meridionale dei Caucaso si Legavano sotto i piedi delle piastre simili a tamburelli di pelle di bue conciata e munite di chiodi"; lo stesso c i dice che "in Armenia si usano anche dischi rotondi di legno con chiodi' .

Seco nd o Suidas anc h e Arriano 7 , nel 140 cl .C. , in u n 'o pera andata perduta, avrebbe scritto che ··Bruzio, durante una marcia su i monti armeni dove la neve era alta 17 piedi, comandò agli abitanti della regione. i quali erano avvezzi a trafficare anche d 'inve rno, di marciare dinnanzi all 'esercit o. Allora essi legarono cerchi di vimini sotto i piedi ...".
Da qu es te prime desc ri zioni pare chiaro che il primo strumento p e r camminare sulla neve adottato dall ' uomo sia stata la rac ch etta.
Pur continuando l'uomo a cercare nuovi strumenti, sollecitato anche dallo sv iluppo delralpinismo c he aveva aperto il campo a ll 'esp lorazione d e lle più alte reg ioni montuose e dei g hia cciai, non s i era riusciti a trovare niente di meglio della primitiva racchetta per non sprofondare n el manto n evoso.
Tuttavia anche con l'uso delle racchette la marcia sul terreno innev ato risu lt ava lenta e faticosa.
Lo sci nacque, dunque , dal bisogno di velocizza r e le ra cc hene ed in alcune regioni , s pecialmente del Nord , i primitivi dischi o cerch i eia neve assun ero una fo rm a p iù allungata e vennero
5SrnoroNTF: Gen erale a ten iese e storico (ca 430-355 a.C.). guidò i 10.000 Ateniesi che, assoldati da Ciro nella guerra contro il fratello Artaserse per l a successione al trono di Persia resos i vaca nte.; per la morte del padre Dari o, dopo la battaglia di Cunassa (40 1 a.C.) nella quale lo stesso Ciro aveva perso la vita e per mano di sicari erano stati uccisi rutti i Comandanti Greci. avevano intrapre so la rit i rata ve rso l a Patria. l\arrò l'impresa nel l'opera l'A11ahasi.
6 Tlù\BO:-.;E: Nato ad Amasia in A">ia ~1inorc e vissuto fra il 64 a.C. ed il 24 d.C.. E' autore di un'opera di ben 17 vo l umi intit olata Geop, rcifia.
- ARRIA'\O: Nato a ' icomedia in Bitinia, regione deirAsia Minore bagnata d~l i'vfar Nero e da l Mar di Marma r a e viss uto t ra il 95 ed i l 175 d .C Fu, per du e decenni. Governatore della Cappadocia sotto gli imperawri Traiano ed Adriano.
ri cope1t i da pe lliccia per renderli più sdrucciolev o li; si legge in molte descrizioni di viaggi che alcuni popoli si valgono appunto cli pellicce per scivola re giù per le montagne.
D'altra parte gli stessi Eschimesi, per indi care gli sci, usano un ' espressione che sig nifi ca "pelli ccia per sc ivo lare " ed i loro sci sono quasi sempre ri coperti di pelliccia.
Il passaggio dalle racchette ag li sci deve esse re staro graduale , in v irtù del normale processo di evoluzione delle cose, tanto da potersi affermare che le racchette cessarono di essere tali, assumendo la denominazione di sci, qu ando il m ov imento d al camminare tra slò in sc ivo lare.

Ciò avve nn e quando l'uomo si accorse c h e la pelle, resa ben liscia dall ' attrito , permetteva alla racchetta di scivolare invece di dover camminare muovendo i passi uno dietro l'altro.
Lo scivo lamento risult ava, inoltre, agevo lato allungando la rac ch etta, dandogli una curvatura verso l'alto n ella sua parte anteriore ed, infine, rest ring endola sui lati.
Da alc uni ra cconti emerge che i popoli uralo-altaici, che circa 17 secoli fa furono protagonisti deJJe prime migrazioni, usavano una so rta di sci di c ui il destro, di 1,45 m. di lunghezza e 0,16 m. di larghezza, che serv iva per dare lo slancio e ra r ives tito cl i pelle di renna mentre il sinistro era più lungo e sott il e .
Qui le notizie sug li sci scompaiono per riapparire nel 550 d.C. a cura del g reco Procopio8 e del goto Jordanis che, dando ai Lapponi il nome di Skridfinni intendevano sotto lin eare la caratteristica di quelle popolazioni significando il termine skrida "scivola re" .
Questo nom e fu ben presto dimenticato in Svezia ed in Norvegia , ma so p ravvisse nel res to dell'Europa e venne usato in tempi successivi da sc ri tto ri d i altri popoli di origine germanica per ind icare i Lapponi; lo utilizzò Paolo Diacono 9 nella sua Sto-
8 PRoco rro : Nato a Cesarea , in Pa lestina , verso la fine ciel V seco lo e morto a Costantinopol i nella seconda metà del VI secolo. Visse m olt i anni presso la eone cl i Bisanzio ed è au to re della Storia della guerre di Giustiniano
9PAOLO DIACONO: Paolo Varnefrido, detto anche più comunem e nte Paolo Diacono nacque tra il 720 ed il 724 <la Warnefrit , di nobile fam ig lia longobarda , e da Teodo linda, venne educato da l grammat ico Flaviano , probabilmente presso la corte del Re Rachi a Pavia Nel 786, ritiratosi nell'Abbazia benedettina d i Cassino, scrisse la Historia Longohardorum che lo ten n e impegnato fin o al la mo1te sopraggiunta il 13 aprile del 799.

ria Longobarda (790 d.C.), re Alfredo d'Inghilterra (890 d.c.)1°, Adamo di Brema (1070 cl.C.) l t ed infine Saxo Grammaticus (1200 d.C.) 12
Sin dai tempi più antichi i Lapponi erano, quindi, ritenuti i migliori pattinatori di ski tanto che Snorre Sturlasson fa affermare alla regina Gunilde, educata in Finlandia nel 920 d.C. da due Lapponi, che sono così abili sugli ski, che nulla può loro .'ifuggire, né uomo, né belva, e ciò che mirano colpiscono.
Questo e numerosi altri documenti dimostrano che l'uso degli sci fu importato in Norvegia dalle popolazioni lapponi.
Secondo il professore Gustavo Storm si può, quindi, affermare con ragionevole certezza che glì sci erano usati in Norvegia sin dal X secolo, come appare, tra l'altro, da numerosi poemi di quel tempo, nei quali venivano chiamati ski od oendurr che vuole dire: sci ricoperti da una pelliccia.
Nel 1100 i re norvegesi tra cui Sverre ed Harald, li adottano per l' esercito costituendo dei drappelli di sciatori che dettero una prova così efficace di sé, durante la battaglia di Oslo (1200 d.C.), da far si che questi reparti speciali divenissero fondamentali negli eserciti dei Paesi Scandinavi per mantenere i collegamenti e svolgere attività di ricognizione sui terreni innevaci.
Verso la fine ciel 1200, un autore anonimo norvegese, abitante a Vigten nella parte settentrionale della valle del Nam, ne parla nell'opera Konge,spiegel (Specchio del Re), dove, seppure nella loro conformazione primitiva, già si intravedono le forme degli sci; non si tratta però di sci veri e propri quanto piurtosro, come dice lo stesso autore nel suo racconto, di scarpe da neve
10 ALFREDO D' li'iG HILT ERRA: detto anche A. il Grande, Re di Wessex (848 - 899). La sua figura dominò la storia dell'Ingh ilterra dell 'Alto Medioevo sia come guerriero che come uomo cli stato e legislatore, nonché uomo pio e protettore oltre che cultore degli studi. Salito al trono ne l 871 combatté i Danesi sconfiggendoli , inizialmeme, ad Ashdown e poi, con alterne vicende giunse nell '896 alla pace definitiva dopo aver scacciato gli invasori Danesi.
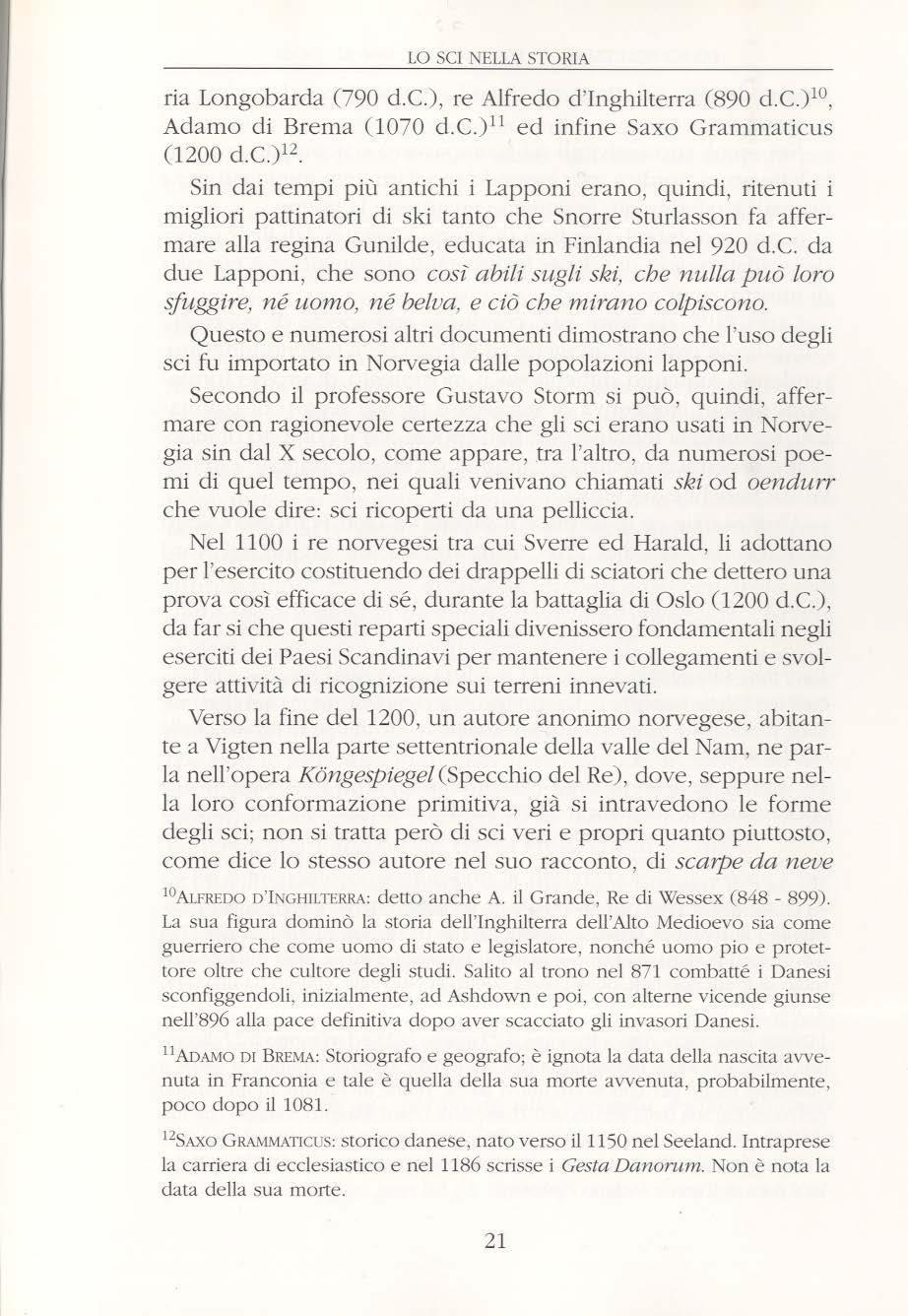
11 ADAMO nr BREMA: Storiografo e geografo; è ignota la data della nascita avvenuta in Franconia e tale è quella della sua morte avvenuta. probabilmente , poco dopo il 1081.
12SAXo GRAi\L'v1ATrcus: storico danese , nato verso il 1150 nel Seeland. Intraprese la carriera di ecclesiastico e nel 1186 scrisse i Gesta Danorum. Non è nota la data della sua mo1te.
lunghe da sette ad otto aime, dove l'auna corrisponde a circa sei centimetri.
ei secoli successi, i gli !)Ci scompa1Tero e ricomparvero nella letteratura nordica, pur essendo regolarmente impiegati per i normali trasferimenti, le attività venatorie e la guen-a.
Sappiamo, infatti, che il re di Svezia Gustavo Adolfo 13 usava dei soldati muniti di sci per le atti\'ità di ricognizione e raccolta cli informazioni.
Carlo XII 1 -1, da parte sua, condusse una !,pecie di guerriglia con piccole pattuglie montate su sci perché il terreno innevato. rendendo alquanto difficoltoso il movimento di grosse formazioni militari, suggeriva cli impiegare piccoli reparti cli pattinatori. secondo la terminologia dell'epoca, con il compito di indebolire il nemico mediante continue ed efficaci puntate offensive sui fianchi e sul tergo.
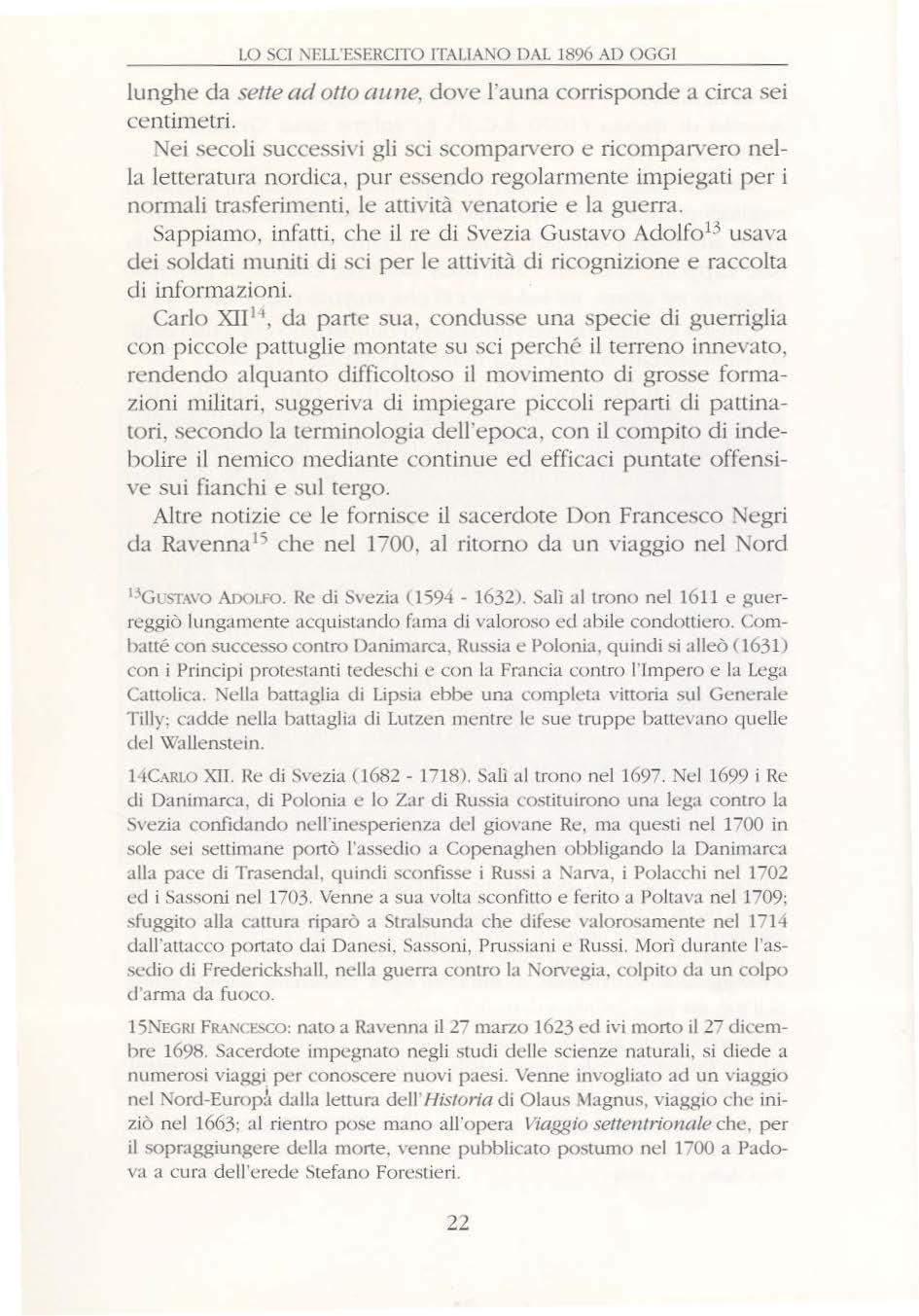
Altre notizie ce le fornisce il sacerdote Don Francesco :'-J'cgri da Ravenna 15 che nel 1700, al ritorno da un viaggio nel I\ord
· ~GLSTA\"O AlX>lfO. Re di ~vezia <1594 - 1632). Salì al trono nel 1611 e guern.:ggiò lungamente acquistando fama di va lorrn,o ed abile condottiero. Combatté con successo contro Danimarca. Ru'>sia e Polonia, quindi si alleò 0631) con i Principi protestanti tedeschi e con la Francia con tro l'Impero e la Lega Cattoli<.:a. !\'ella battaglia di Lipsia ebhe una wmpleta ,·ittoria sul Generale Tilly: cadde nella battaglia cli Lurzen mentre I<: sue truppe battevano quelle del Wallcnstein.
1 l.CARLO XTI. He di ~vezia ( 1682 - 1718). Salì al trono nel 1697 . Nel 1699 i Re di Danimarca, di Polonia e Io Z,lr di Russia costituirono una lega contro la :wezia confidando nell'inesperienza del giovane Re, ma questi nel 1700 in sole sei settimane portò l'assedio a Copenaghen obbligando la Danimarca alla pace di Trasendal, quindi sconfisse i Rus:-.i a ì'\arva, i PolacC'hi nel 1702 cd i Sassoni nel 1703. Venne a sua volta :-.confillo e ferito a Polrava nel 1709; sfuggito alla <.:allura riparò a Stralsunda che difese \'alorosamente nel 1-14 c.lall'anac.:co portato dai Danesi. Sassoni, Prussiani e Russi. Morì durante l'assedio di Fredcrickshall. nella guerrn contro la -onegia. colpito e.la un colpo d'arma da fuo<.:o.
15~EGRI FRA'ICl'-.CO: nato a Ravenna il r marzo 1623 ed ivi mono il 27 dicembre 1698. Sacerdote impegnato negli studi delle scienze naturali, si diede a numerosi viaggi per conoscere nuovi paesi. \'enne invogliato ad un viaggio nel Kord-Europa dalla lettura dcli Historìa cli Olaus \1agnus, viaggio che iniz iò nel 1663: a l rientro pose mano all'opera Vìaggio settentrionale che. per il sopraggiungere della morte, venne pubblicato postumo nel 1700 a Padova a cura dell'erede Mefano Forestieri.
dove era stato testimone oculare clelruso di attrezzi "per andare sui ghiacci e sulle altissime nevt", descrive nell'opera Viaggio settentrionale il narra, termine russo utilizzato dai Lapponi per indicare gli sci.
Il religioso , durante il soggiorno in Scandinavia , ebbe l'occasione di provare , primo abitante dell 'Europa centro meridionale , i narra e , nan-ando della caccia alrorso, scriveva che "i Lapponi hanno due tavolette sottili che non eccedono la larghezza del piede, ma sono lunghe otto e anche nove palmi, con le punte alquanto rilevate per non intaccare la neve. Nel mezzo di esse sono alcune.funicelle con le quali se le assestano bene l'una ad un piede e l 'altra all 'altro, tenendo poi un bastone alla mano conficcato in una rotella di legno al! 'estremità, perché non fori la neve. Ovvero anche senza tal bastone camminano sopra la neve, in tempo che non è agghiacciata né atta a sostenere un uomo . Non avrebbero però a temere, senza questi instromenti, di sprofondarsi sotto l 'alta neve e rimanere sepolti , perché è intraveduto a me, che avendola in simil caso penetrata con ambedue le gambe in un intervallo fra due gran sassi, che non si poteva conoscere, ci restai come a cavallo".
Dopo avere narrato la fat ica e la tecnica impiegata per uscire dall'impaccio il Nostro così continua: ·'Per camminare dunque con gli skie, che così chiamano gli Svezzesi quelle tavolette, che non le sollevano mai dalla neve alzando il piede, ma leggermente strisciando vanno avanzando con l'istessa agilità, che camminando liberi a piedi sopra la terra; e non fanno nella neue maggior impressione, che la grossezza di un ditd'.
Ed il racconto prosegue con la descrizione della tecnica utilizzata per andare in salita ed in discesa: '·E perché per tal causa alle salite dei monti non si avanzerebbero mai un sol passo, perché gli skie tanto ritornano indietro per causa del peso dell'uomo. quanto esso gli aveva spinto di sopra, però li foderano tutti di sotto di pelle di rangifero (la renna), in modo che il pelo riguarda ali 'indietro; e così alle sa,lite venendo compresso si caccia nella neve , e rabbuffandosi trattiene gli skie, che non possono sdrucciolar giù; poi giunti alla sommità, e volendo calar dall 'altra parte, l 'istesso pelo, per essere posto come dissi, non fa opposizione alcuna, anzi facilita il cammino. Ma perché non si può andar adagio, perché gli skie dopo aver cominciato a ca!-
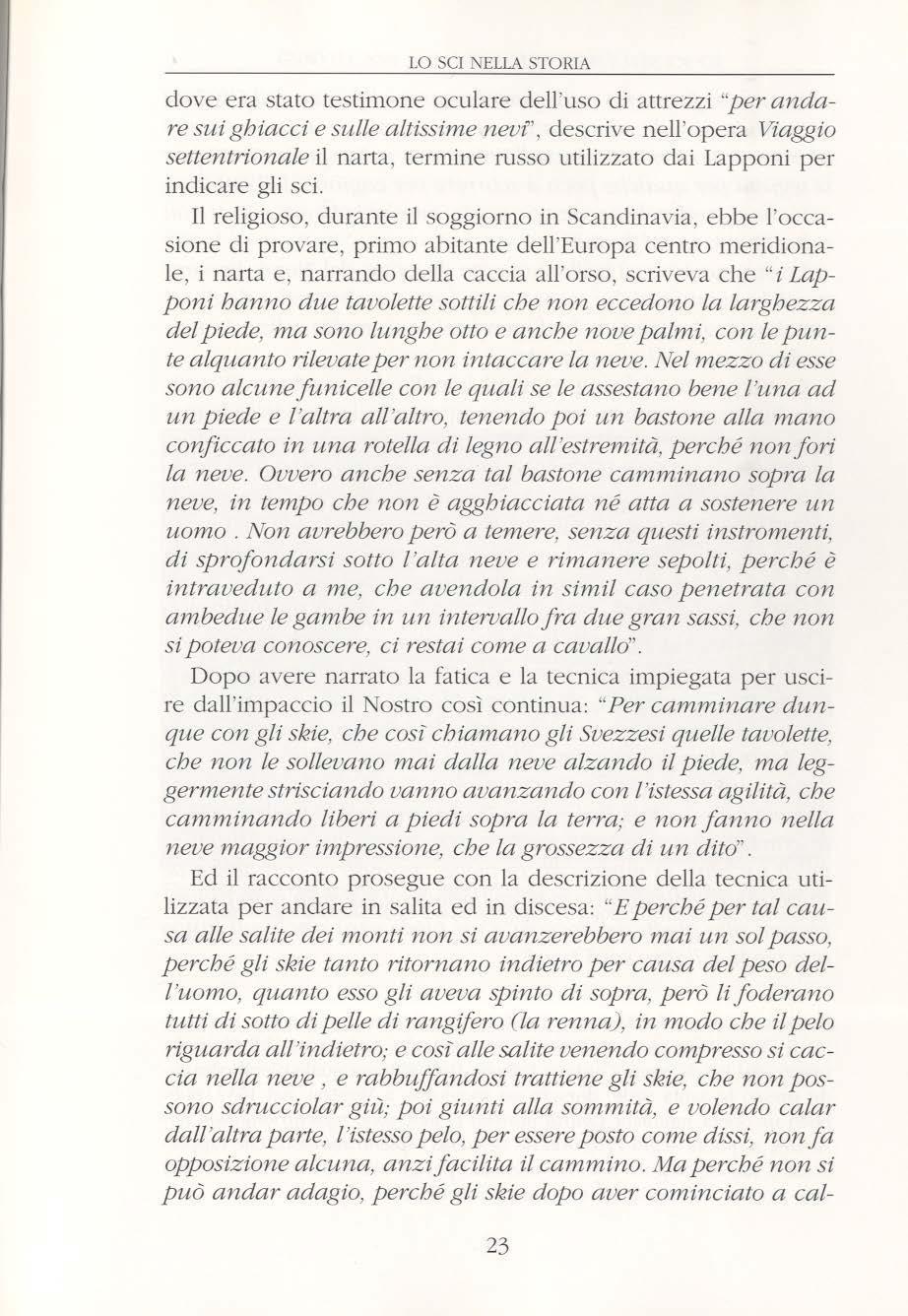
care non si fermano mai, però hisog,,a al punto della calata accomodarsi sodo come statua, sopra di essi, e in un sol tratto scorrere tu/lo il monte sino alla pianura; nella quale giunti pur si seguita per qualche poco a scorrere per cagione dell'impulso, con che si crederebbe senza prol'arlo, perché ipitì erti monti non si praticano in tal/orma".
Lo strumento così brillantemente descritto dal 1 egri, p resenta già le caratteristiche, seppure in forma embrionale, degli sci attuali e, analogamente, le dimensioni sono molto vicine a quelle che si usano ai giorni nostri.
Con il passare del tempo, infatti, la pelle che avvolgeva la struttura lignea era venuta via via scomparendo lasciando il legno, materiale molto più duttile e resistente e, soprattutto più rigido, quale unico mate1iale utilizzato per la costruzione degli sci.
Erano stati naturalmente i Lapponi a sperimentare la maggiore capacità di scivolamento del legno sulla neve come il grande ispiratore del l\egri, il vescovo svedese Olaus Magnus16 nella 1!istoria de Gentibus Septentrionalibus, già seri\ eva nei primi anni del 1500: "La Scri~(inia è una regione posta Ira la Biarma e la Fin marchia, la quale però si estende con una punta pilì delle altre verso l'Ostro ed il mare Botnico ed è chiamata principalmente Coda perché gli abitanti di quel Paese caminano con gran prestezza, però che si mettono in piedi certi zoccoli piani di legno e lunghi, et in punta ritorti all'insù a guisa di arco, e tenendo in mano un bastone, vanno all'erta et alla china come piace a loro. molto veloce-rnente, e massime per le nevi ghiacciate, con tutto ciò i zoccoli sono.fati i di maniera che uno è più lungo di un altro la misura di un piede. secondo la grandezza de huomini, o delle donne, cioè, se l'uomo o la donna sarà di lunghezza otto piedi, un zoccolo d'un piede sarà anch ·egli lungo otto piedi, e l'altro sarà nove".
H,OLAUs MAGNLS: Olaf Mansson ( I 190-1557) più noto con il nome latinizzato di Olaus Magnw,, cattolico, venne nominato Arcivescovo cli Cppsala. Inviato dal Re di Svezia Gustavo Erikson Vasa a Roma quale plenipot<.:nzi ario presso la Santa Sede, durante un soggiorno a Venezia, nel 1539, pubblicò un'opem intitolata Gha,ta marina et descriptio septenlrionalium termrum; a questa seguì t"Historia de Gentibus Septentrionalibus che rappresenta il suo capolavoro e che lo impegnò per gli ultimi dieci anni della sua vita. L'orera uscì nel 1555, due anni prima <ld la sua morte.
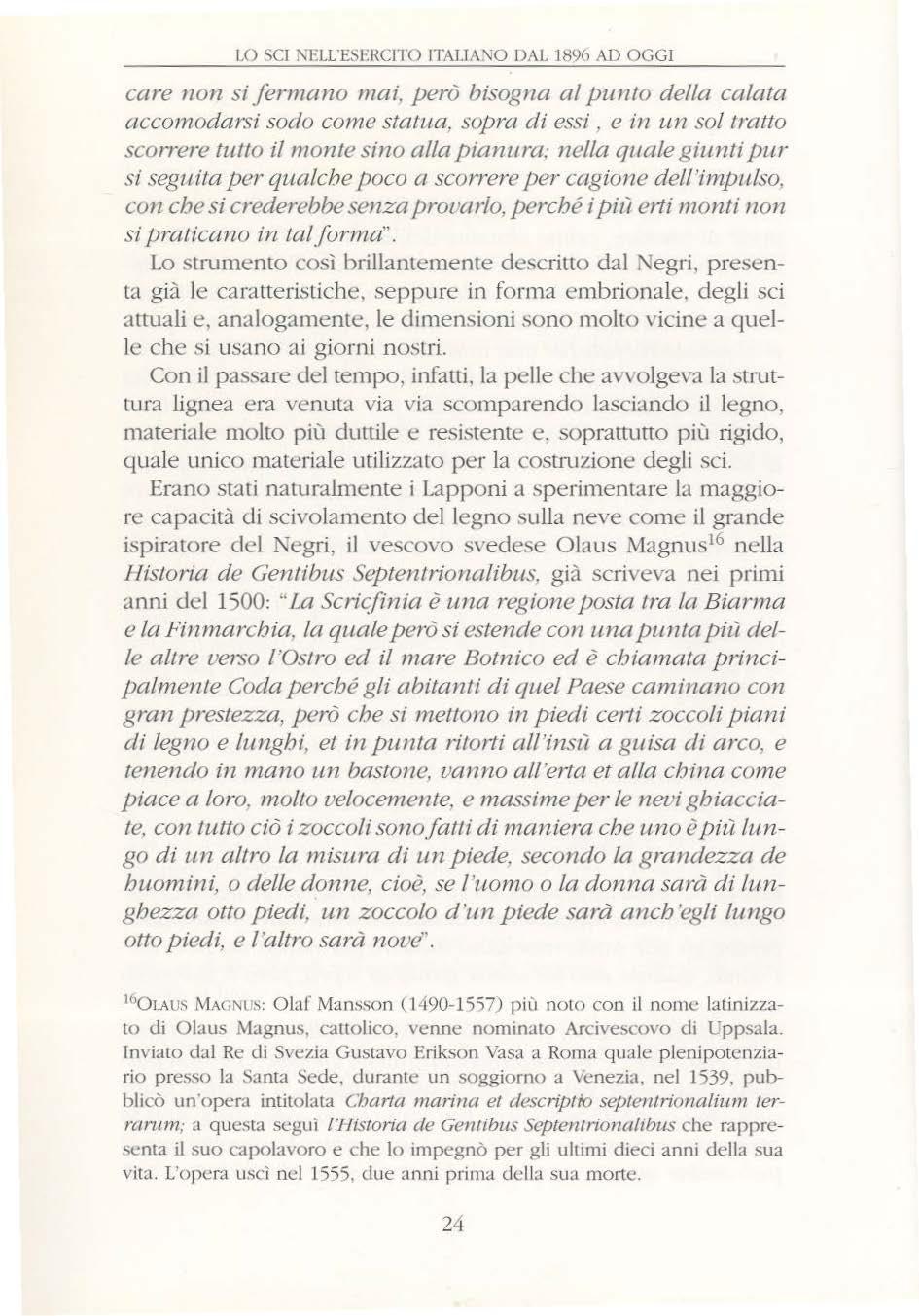
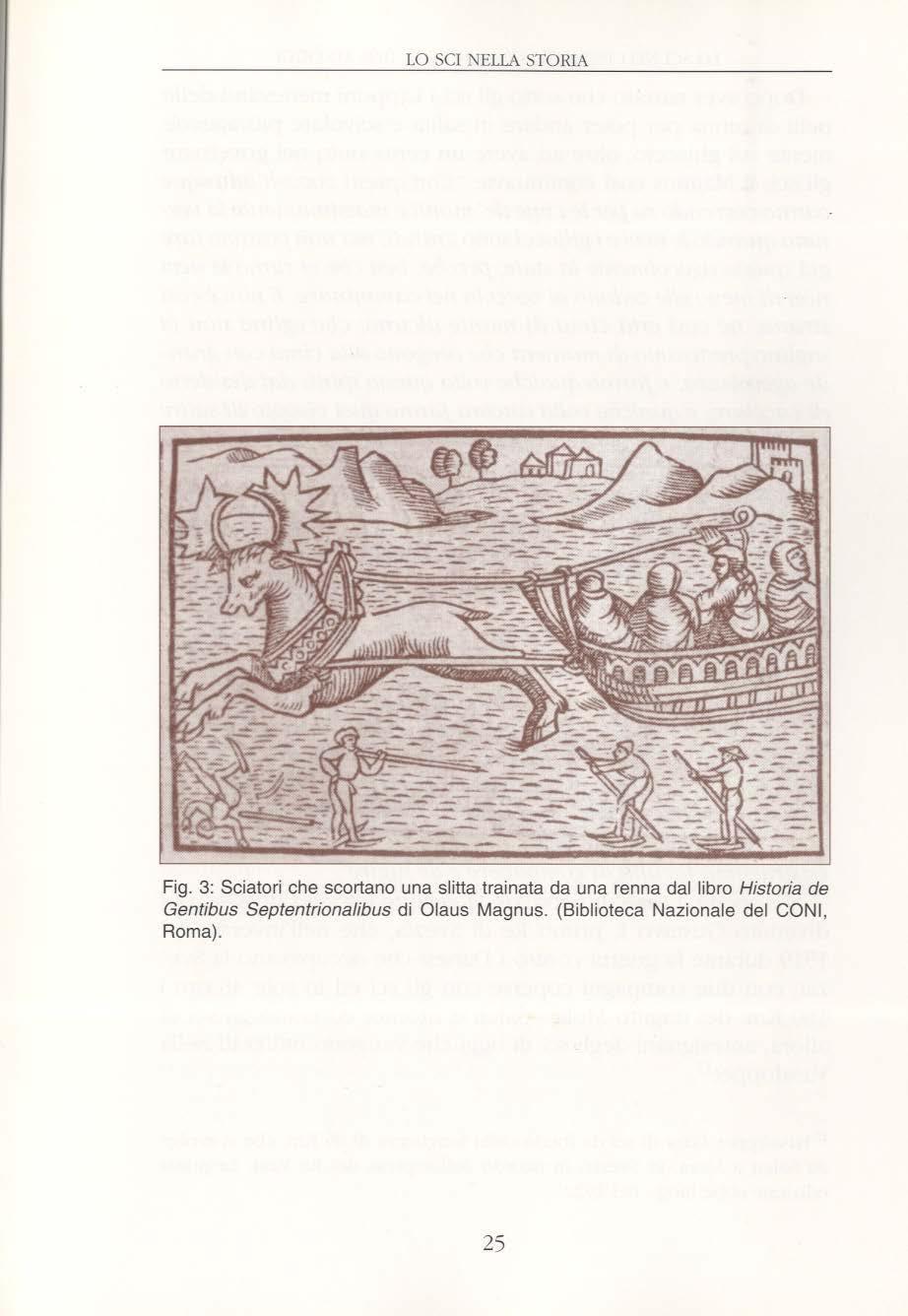
Dopo a\'er narrato che sotto gli sci i Lapponi mettevano delle pelli di renna per poter anelare in salila e scivolare più agevolmente sul ghiaccio, oltre ad a\-ere un certo aiuto nel governare gli sci. il Magnus così continuava: "Con questi zoccoli adunque L'anno correndo su per le cime de' monti e massimamente la l'ernata quando le neui e i ghiacci sono grandi. ma non possonofare già questo agevolmente la state, perché. be11 che ui siano le nevi non di meno elle cedono al zoccolo nel camminare. E non è così strana, né così erta cima dì monte alcuno. che egli110 non vi saglino prestissimo di maniera che uenP,ono alla cima con p,rande aget·olezza, e fanno qualche colta questo spinti dal desiderio di cacciare. e qualche l'Olla ancora fanno quel l'iaggio di salire alla cima di un monte per guadagnare qualche premio posto per darlo a chi sarà p,ima. come si suol fare di coloro che corrono il palio. I premi del corso sono cucchiari d'argento. vasi di rame. spade. uestimenti nuovi. cavalli giovani'.
Olaus .Magnus ci clarn così le prime notizie di gare disputate su sci soffermandosi anche ~ui premi posti in palio per i vincitori.

>l'el suo raccondo descriveva. inoltre, anche i guerrieri !>Ciatori scrivendo di essi: "questa gente del settentrione è solita/are corso con li scorrenti legni con reloce trasferimento e secondo che piace loro, a ogni parte si l'Ottano e potentissima mente si accostano e discostano come vogliono. acciò of/endino /'inimico: e con la medesima celerità con quella anchom si fuggono; né per il corso pilÌ lentamente tentano dì ritornare; per la qual cosa e con /'agilità dei c011Ji e per quelli legni ottengono una esperlissimafacultà di combattere e defugire·.
E' appena il caso di ricordare la celebre impresa di Vasa. poi divenuto Gustavo L primo Re di Svezia, che nell'inverno del 1519 durante la guerra contro i Danesi che occupavano la Svezia, con due compagni coperse con gli sci ed in sole q8 ore i 180 Km. del Lragitto Mo la - Salen e ritorno; ed erano gli sci di allora. antesignani degli sci di oggi che vengono utilizzati nella Vasaloppet 1 -..
17 Vasaluj>pet: Gara <li sci da fondo della lunghezza di 86 Km. che si svolge <la Salen a .\fora, in !wezia. in ricordo dell'impresa del Re Vasa. La p1ima ediz ione ebbe luogo nel 1922.

L'uso del legno aveva indouo i Lapponi ad arcuare verso l'alto la punta dello sci. inizialmente a colpi d'accena ed in un secondo tempo scaldando il legno nel vapore perché il piegamento delle fibre era facilitato dall'umidità.
In merito, delle stampe della metà dell"800 rappresentano delle donne che, alle prese con la curvatura delle punte dello sci oltenuta mediante una corda legata dalla parte da piegare, hanno vicino un enorme pentolone d'acqua bollente con il vapore che sale verso l'alto.
E. questa la prima lavorazione organizzata di cui si abbia menzione e dalla quale traspare in maniera del rutto evidente che lo sci non nasce più quale prodotto del caso o <lei capriccio della natura bensì come frutto dell'ingegno umano.
I primi sci. costruiti con questa tecnica, furono di frassino e di hickory 18 , legni che nel frauempo avevano sostituito la betulla del nord; il frassino, legno molto diffuso in Europa, fu ~celto per le sue doti di resistenza ed elasticità: è duro, bianco-giallastro e possiede fibre dritte e tenaci che si identificano con la struttura longilinea dello sci; l"hickory, di provenienza nord americana, per le sue caratteristiche di alta re~i~tenza meccanica.
Riprendendo il nostro excursus notiamo come compagnie di pattinatori, o sciatori a dir si voglia, furono istituite in >Jorvegia all'inizio del.XVfII secolo sul concetto che dovevano ··essercostituite dei migliori e pitì veloci uomini che si trovino nei reggimenli e che di buon grado e con ardimento vi pa,1ecipind'; a questi uomini venne fornita una nuova attrezzatura e furono destinati ad un trattamento uguale a quello che veniva riservato ai volontari.
Nel I 7 i7 questi reparti ebbero una loro precisa configurazione organica che comprendeva sci compagnie di pattinatori della forza di cento uomini cia~cuna; nell'anno successivo ne vennero costituite altre quattro mediante il contestuale scioglimento di un reggimento di Dragoni.
Il 1804 vide la nascita di uno speciale regolamento per il pattinaggio dei soldati.
La creazione di questi reparti portò a con~eguire quegli effetti


desiderati sia negli atti tauici veri e propri, sia nelle comunicazioni e nella rapida tr.ismissione di ordini. sia, infine, nei rifornimenti.
Verso la fine del secolo gli sci fanno la loro apparizione negli eserciti della Russia, della Germania, dell'Austria e della Svizzera, in parte in maniera definitiva ed in parte in prova, a conferma che i successi riportati con l'impiego di tale mezzo di trasporto avevano varcato i ristretti confini dei paesi nordici per approdare anche nel cuore dell'Europa e, come vedremo successivamente, anche in Italia.
Prove di una certa importanza vennero effettuate in Austria. nella regione dello Schneeberg. dove 15 ufficiali. 14 sottufficiali e 4 militari di truppa salirono l'Eiserne Thor (1400 m.) e lo Sruhleck O 783 m.).
In Svizzera i distaccamenti del Gottardo dell'Oberalp e del Furka si servivano degli sci, durante i mesi invernali, per mantenere le comunicazioni ed i rifornimenti con la base del Gottardo; alcune volte, a causa dell'elevato innevamento, le comunicazioni fra Airolo e Hospcnthal o Andermatt erano possibili soltanto con personale munito di sci.
In Germania i prinù esperimenti ,·ennero effettuati dall'inverno 1891-92 a Goslar nell'Harz. vennero quindi assegnati gli sci ai cacciatori prussiani; esercitazioni in tema con huoni risultati vennero. infine . tenute in Slesia, nei Vosgi e nella Foresta \fera.
J risultati così ottenuti sarebbero stati , tuttavia. nettamente migliori se fosse stato possibile utilizzare materiali di qualità superiore e, nel conternro. disporre di alcuni ufficiali esperti sciatoti che potessero realmente fare da maestri agli altri Quadri ed ai militari di truppa.
Ormai lo sci aveva fatto breccia ed i primi anni del ·900 furono un pullulare di imprese sempre più ardite sia in campo militare che civile, e che videro come principali attori Tedeschi ed Austriaci impegnati cavallere!'>camente ad affermare la superiorità cli una scuola sull'altra.
In Germania il grande protagonista fu il giovane sotn1fficiale Wilhelm Paulke, a lui va il merito di aver salito nel 1896 i 3380 m. delrOberalpstok. di avere compiuto la tr::iversata dell'Oberland l3ernese nel 1897 e quindi nel 1898 raggiunlO i 4200 m. sul Monte Rosa interrompendo l'ascensione verso la cima rer il sopraggiungere dell 'oscurità.
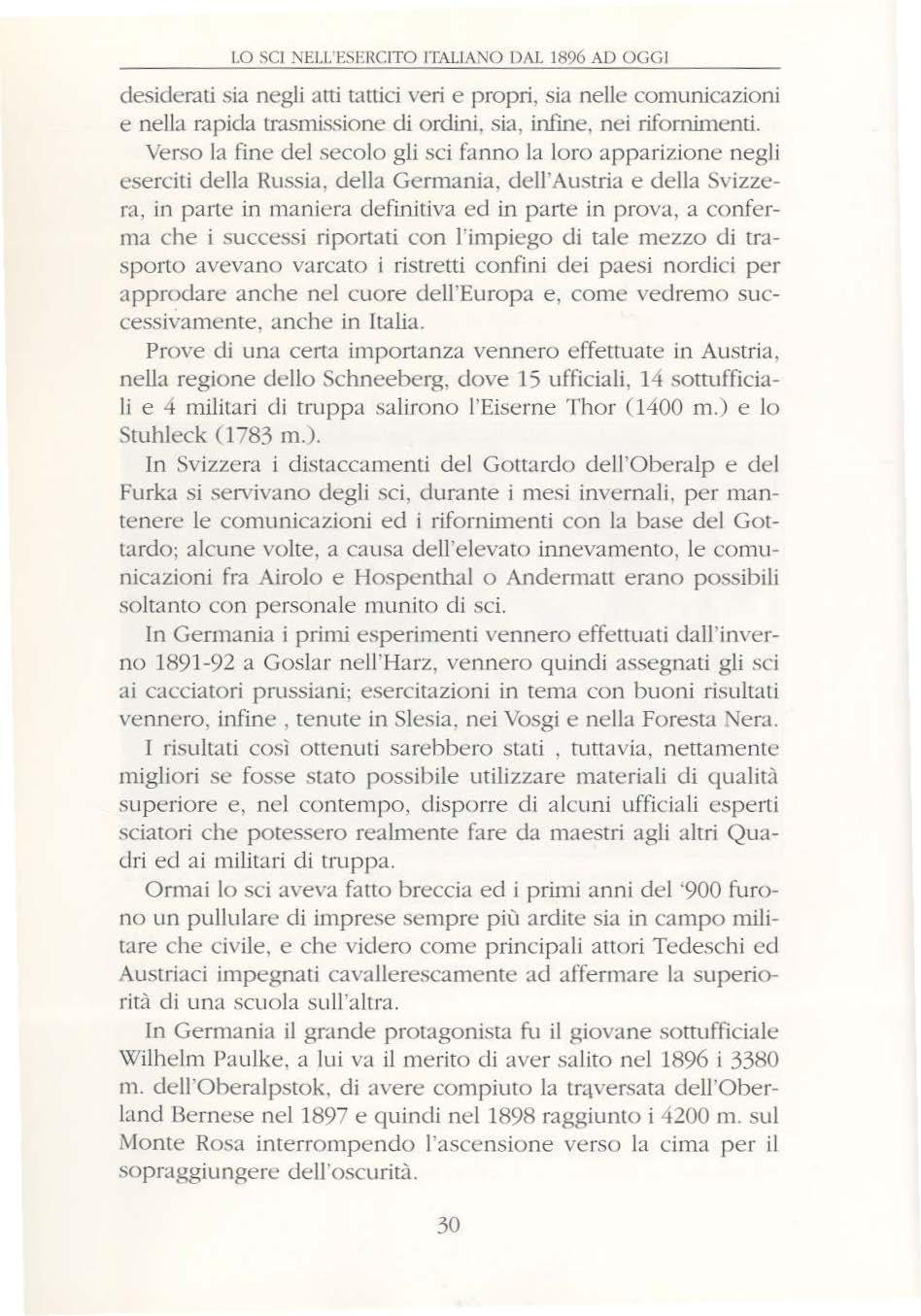
In Austria assunsero a notorietà le imprese del Tenente Richard Loschener che nel 1907 raggiunse i Caclini di Misurina ed il Passo del Cristallo (2822 m.) durante un raid sulle Dolomiti olientali, nel 1910, al comando di una pattuglia, Punta Penia (3342 m.) e nel 1913 Punta Rocca (3309 m.), rispettivamente prima e seconda cima della Marmolada e quelle del Tenente George Bilgeri, uno dei migliori allievi di Mathias Zdarsky ed inventore dell ' omonimo attacco, che nel 1908, al comando di un reparto di Tiroler Landesschutzen, compì la traversata: Hochkonig, Hochfeiler, Gross Venediger, Sonnblick.
In Francia, al contrario, il nuovo attrezzo non attirò subito l'interesse delle Autorità militari per un suo eventuale impiego da parte dei reparti di Chasseurs des Alpes, ma si dovette attendere l'impulso dato dai Capitani Cler e Bemard e dal Luogotenente Monnier, nell ' inverno 1900-01, per istituire la Scuola Militare di Sci a Briançon e per organizzare i primi corsi sciato1i che si concretizzarono, nel 1903, con la traversata del Delfinato attraverso il Col d'Arein, il Goléon ed il Roc GaLibier da parte di un intero reparto.
L'insufficiente esperienza dei Francesi era tale da costringerli ad assistere, il 25 febbraio 1904 , all ' impresa del tedesco Ugo Mylius che, accompagnato da due guide bemesi, conquistò la vetta del Monte Bianco.

A margine cli questi esperimenti che avevano, seppure con ampi risvolti nel mondo dell'alpinismo, prevalenti fini militari, lo sci s i stava affermando anche come disciplina sportiva e furono, naturalmente, i Norvegesi ad organizzare le prime gare.
La prima competizione ufficiale di fondo non si svolse a Christiania 19 , capitale della Norvegia, ma a Tromso nel 1843 e si trattò di una prova cli 5 Km. che vide il successo di un Lappone che coprì la distanza in circa 25 minuti.
Nel 1850 , su diretto interessamento del Re di Svezia, venne organizzata la prima grande competizione di sci da fondo che assunse la denominazione di Coppa Holmenkollen dal nome di una collina nei pressi di Christiania dove aveva luogo.
A queste seguirono altre gare: di salto prima e di discesa poi; quest'ultima, diventerà appannaggio quasi esclusivo dei Paesi Alpini.
19 Ch ristiania: Capitale della Norvegia fino al 1925 quando assunse l'attuale denominazione di Oslo.
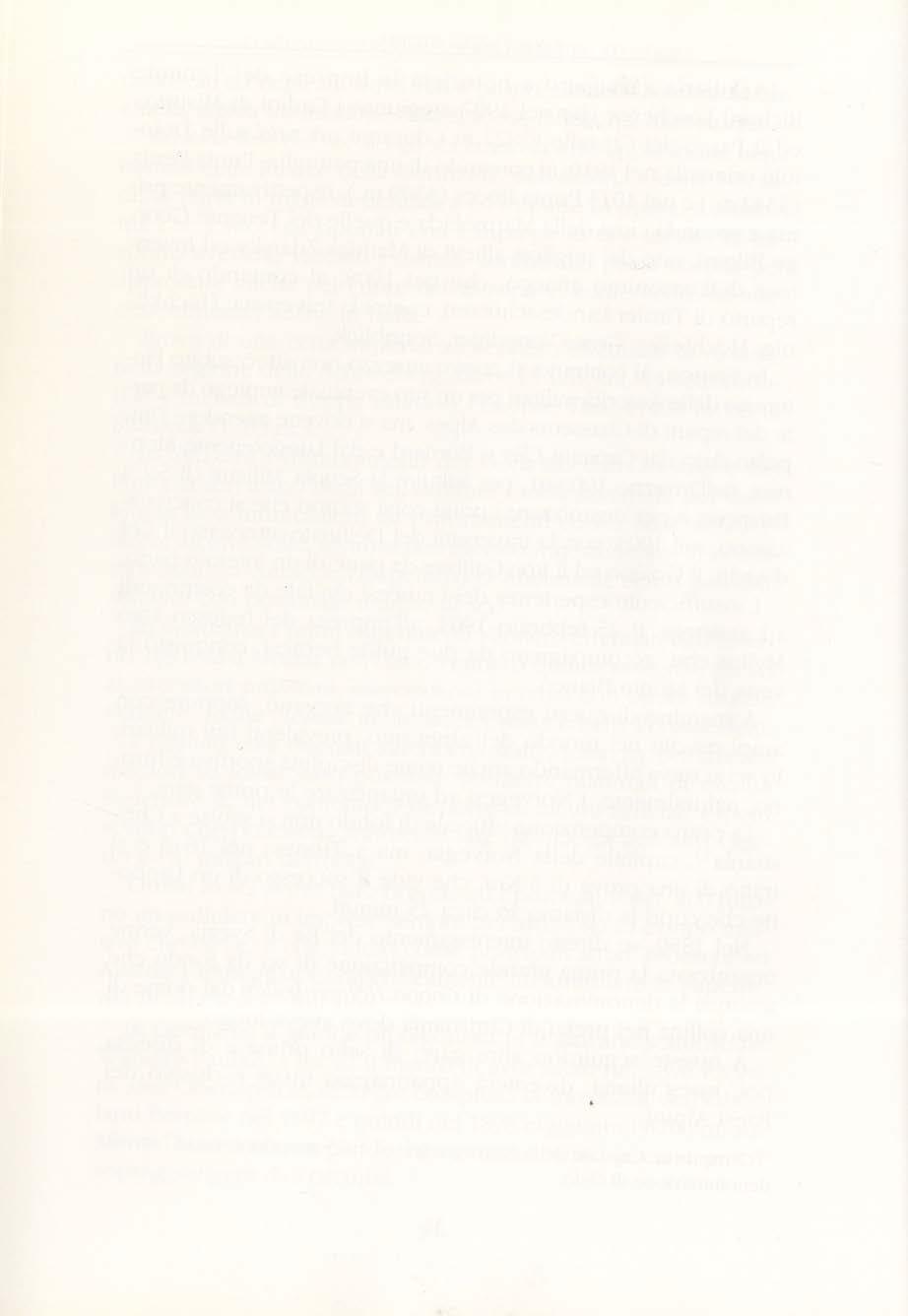


Le prime due paia di sci importati in Italia vennero presentate, in una domenica dell'inverno 1896, a Torino nel salotto dell'abitazione dell'Ingegnere Adolfo Kincl.
Il Kind, cittadino elvetico ed appassionato di montagna, era solito riunire presso la propria abitazione un gruppo di amanti della montagna torinesi per discutere di alpinismo ed organizzare gite ed escursioni da effettuare nelle giornate festive.
A questa riunione era presente anche il Tenente di Artiglieria da Montagna Luciano Roiti 20 che ebbe, pertanto, l'onore di essere il primo Ufficiale delle Truppe Alpine a venire a conoscenza di questo particolare mezzo di trasporto.
Lo spunto della discussione era stato dato dalla lettura, effettuata dall'ingegnere Kind, ciel libro Attraverso la Groenlandia dell'esploratore norvegese Fridtjof Nansen 21 che aveva incurio-
2°TENENTE Li ' CV\NO Rom: Nato a Pisa il 24 gennaio 1869 e mo1to a Roma il 12 ottobre 1944. Sottotenente nel 1892, con il grado di Tenente presta servizio nel
1° reggimento di Aitiglieria da Montagna dal 1'894 a l 1897 quando viene assegnato a l 22° reggimento Artiglieria da Campagna. Da quì svolgerà la sua artività prevalentemente negli arsenali e nei laboratori di artiglieria raggiungendo il grado di Generale di Bri gata. Durante la Prima Guerra mondiale svolge anività ispettiva nel <.-ampo delle aitiglierie prevalentemente sul fronte do lomitico.
11 FRJD1JOF NA-1':SEN. Esploratore e scienziato norvegese, nato il 10 ouobre 1861 a Store Froeden presso Cristiania e morto a Lysaker il 13 maggio 1930. La continua attività sport iva gli consentì di essere a soli 18 anni campione norvegese di sci, mentre si appassionava a ricerche ed a studi di zoologia; studente di scienze all"un iversità di Cristiania dal 1880, nel 1882 con una baleniera si spinse presso la costa della Groenlandia a studiare la vita delle foche. al ritorno è nominato conservatore a l Museo Zoo logico di Bergen. li 15 agosto, pa 1tendo da Umivik e procedendo verso occidente attraversò la Groenlandia, con temperarure che sfioravano i -47°, raggiunse, il 26 settembre. il

sito cd appassionato, oltre lo stesso Kind, molti sportivi di altre nazioni inducendoli a provare le emozioni offerte dallo sci.
Il Kind. uomo concreto, non ave, a perso tempo ed a\eva commissionato alla dilla di Melchior Jakober di Glarus (Svizzera) due paia di quei mirabili attrezzi, ciascuno munito del das::.ico unico bastone e da un pessimo attacco a giunco. che entrando spesso in a,·aria faceva triholare gli eroici precursori di questo sport in Italia.
I primi espetimenti pratici sulla neve vennero effettuati inizialmente al Parco del Valentino. quindi :,ulle colline torinesi ed infine, man mano che crescevano le conoscenze tecniche e la confidenza con gli attrezzi, in località sempre più distanti da Torino.
La prima fase di que:,to addestramento ebbe termine con una marcia su neve da Balme al Pian della Mussa, effettuata in meno di un'ora.
li 21 gennaio 1897 il Ten. Roiri con l'ing. Kind ed il figlio di questi Paolo. partì da Borgone (q. 398) eia dove, superato il contrafforte che separa il vallone del Sangonetto dalla "alle di ~usa e seguendo il costone di Case Mongirarclo, raggiunse la vetta del Monte Salancia (q. 2088). per poi discendere a Gia,·eno (ca1ta n. 1).
Il dislivello di circa 1700 m. venne :,uperato facilmente in circa cinque ore e mezza di marcia, tracciando sul manto nevoso un solco profondo appena 25-30 cm., nonostante che la neve fosse alta più di tre metri, leggerissima, caduta di fresco e nella quale affondava anche un uomo munito cli racchette.
L'"Gfficiale. entusiasta dell'esperienza fatta, ne illustrò i risullati in un articolo pubblicato su l Esercito Italiano del 12 marzo
1897 22 , che rappresentò la prima hreve guida tecnica sull'uso degli '>Ci.
crnak ùi Dan-. a 61'' e li' in un punto disabitato dove un'imharcazionL' lo porLò salvo al po1to <li Godthah l\el 1893 parte per conquistare il Polo. ma ril·-.cc , il - apnle 1H95. a raggiunger<.: I.I latitudine 86° e 1.i, la massima fìno ad allora raggiunta. ~i spense tra i due contlini mondiali dopo esser!->i ulteriormente distinto nell'opera di nmpatrio dei prigionieri.di guerra che gli ,·alse nel 1922 il premio l\ohcl per la pace.
icrr. Oon1menro n. 2: Periodico L Esercito //alia110 n. 28 del 12 marzo
1897. arricolo intito lato: J)e/f(! mc1rce sulla 11e1 1e.

In esso il Ten. Roiti scriveva che: "fatto assai notevole mi sembra questo: che chi apriva la strada, dovendo comprimere la neve e tracciare la strada durava una certa fatica, mentre gli altri due, seguendo la sue tracce, non affaticavano che pochissinio e lasciavano dietro una strada battuta. su cui, a mio avviso, avrebbero potuto comodamente camminare degli uomini a piedi, e non nascondo che, pensando alla mia specialità d'arma, mi sono detto che i nostri cannoni da montagna, posti su apposite slitte, avrebbero potuto seguirci'.
A queste prime esperienze aveva partecipato anche il Sottotenente Vittorio Viscontini su so llecitazione del Colonnello Ettore Troya 23 , Comandante del 3° reggimenlo Alpini. che ne aveva subito intuito l'importanza quale equipaggiamenlo per i reparti alpini.

Le Autorità Militari, che all'epoca cercavano una soluzione al grave problema di assicurare la difesa dei 1800 Km. cli frontiera alpina in inverno, avevano infatti prestato immediata attenzione a questa novità ed avevano subito disposto l'inizio di esperimenti pratici presso i Corpi per accertare l'utilità che se n e poteva trarre, a fini militari, dall'impiego del nuovo mezzo.
Tuttavia per l'elevato costo che allora avevano gli sci (gli Jakober costavano circa 22 franchi svizzeri il paio) e che ne impediva l'acquisto di un numero adeguato per condurre le prove, si era optato per farli costruire dal capo armaiolo di reggimento, ricopiandoli da un modello originale comperato in Svizzera.
Se il risparmio fu del 50% circa, i risultati furono inferiori alle aspettative non rispondendo gli attrezzi così ottenuti alle reali necessità.
Gli esperimenti vennero condotti dai Bersaglieri del distaccamento del Moncenisio e dal 3° reggimento Alpini 24 durante le 23COL. ETTORE TROYA. Nato iJ 23 maggio 1840 a Torino: frequenta il corso supp lett ivo della Regia Militare Accademia nel 1859 e viene promosso Sottotenente di Fanteria nel 1860. Nel 1878, con il grado cli Cap itano, è assegnato al 6° battaglione Alpini ciel DisLretto di Ivrea; dal 1892 al 1896 comanda il 3° reggimento Alpini; infine. nel 1912, viene promosso Tenente Generale. Ha partecipato alla Campagna contro gli Austriaci del 1866 ed a quella d'Africa ciel 1895-96. Si spegne a Roma 1'11 luglio 1920.
2"' Da : Memorie Storiche 3° reggimento Alpini, USSME

escursioni invernali con risultati che, seppure soddisfacenti, non furono decisivi per l'adozione del materiale.
Ciò era dovuto in parte al numero limitato di sci a disposizione, ed in parte aJ fatto che l'uso prolungato della racchette da neve, che avevano permesso autentici prodigi consentendo di raggiungere coJli e cime in montagne molto alte, acquistando in tal modo una grandissima notorietà, aveva ingenerato nei vecchi ufficiali degli Alpini un'illimitata fiducia in esse e molta freddezza verso il nuovo mezzo destinato a rivoluzionare la concezione del movimento in ambiente innevato.
Gli esperimenti furono quindi ufficialmente sospesi.
Fortunatamente, in quell'epoca, in fatto di montagna esisteva un legame molto stretto tra i civili ed i militari tanto che i problemi di quest'ultimi erano sentiti e discussi anche nell'ambito civile.

L'Hess ad esempio nel Bollettino del Club Alpino ltahano del 1899 25 , trattando l'argomento gli ski per uso militare scriveva che: "Anni fa alcuni ufficiali hanno, sotto la guida dell'ing. Kind, imparato il pattinaggio con gli ski, col proposito di studiarne tutti quei vantaggi che se ne potrebbero trarre a favore dell'esercito. Ma anche qui, in causa d'una male interpretata economia, invece di usare buoni pattini, ne furono confezionati di quelli certamente non perfetti, sopra un modello svizzero. Distribuiti nei van· distaccamenti, e mancando poi come sempre la guida di parecchi abili pattinatori, gli ski passarono ben presto nel dimenticatoio, e non ci si pensò più. Questo tentativo abortito cosi' sulle prime prove, non dovrebbe avere per conseguenza una rinuncia definitiva agli ski; anzi, voglio sperare che quando lo sport si sarà fatto strada fra di noi, per opera specialmente di pattinatori italiani, esso venga introdotto pure tra i soldati. Ho già detto che sarà nostra missione di diffonderlo fra i montanari. Questi, andando sotto le armi, formeranno i primi nuclei intorno ai quali si andranno formando i manipoli di soldati pattinatori.
L'Italia possiede fortunatamente un corpo di forti ad arditi soldati: gli Alpini. Essi stanno lunghi mesi dell'anno nella zona
delle nel'i. e si trovano quindi nelle pilì.fauorel'Oli condizioni per imparar hene il patlinag_c!)o".
l suggerimenti di questo articolo avevano quindi trovato dei validi ed appa~sionati sostenitori in un gruppo di t.,·fficiali degli Alpini quali il Maggiore Oreste Zavauari 26 • il Capitano Vialardi di ~avigliano. il Tenente Testafochi, il Tenente Asinari di Bernezzo ed il Sottotenente Viscontini, che continuarono con tenacia l'addestramento portando a rennine dh·erse traversate alpine nella zona del Moncenisio .
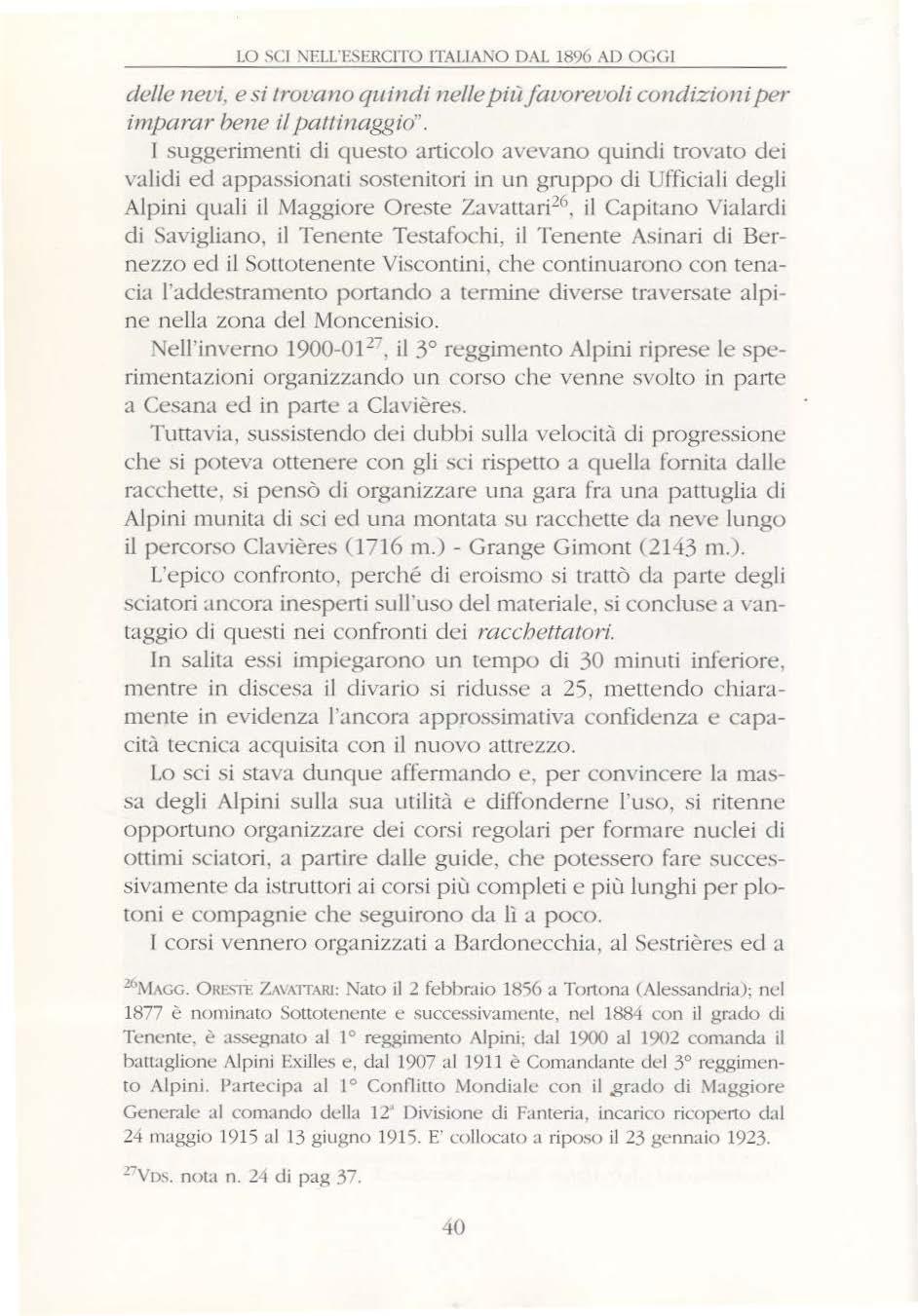
ell'inverno 1900-0lr, il 3° reggimento Alpini riprese le sperimentazioni organizzand o un corso che venne .svolto in parte a Cesana ed in parte a Cla\ ières.
Tuttavia, sussistendo dei dubbi sulla veloci tà di progressione che si poteva ottene re con gli '>Ci rispeno a quella fornita dalle racchette, si pensò di organizzare una gara fra una pattuglia di Alpini munita e.li sci ed una montata su racchette da neve lungo il percorso Cla\iè r es (1716 m.) - Grange Gimont (21-t3 111.).
L'epico confronto, perché di eroismo si trattò da parte degli sciatori ancora inesperti sull'uso del materiale, si concluse a vantaggio di questi nei confronti elci racchettatori.
In salita essi impiegarono un tempo di 30 minuti inferiore. mentre in discesa il divario si ridusse a 25, mettendo c hi aramente in evidenza l'ancora approssimativa confidenza e capacità tecnica acquisita con il nuovo attrezzo.
Lo sci si stava dunque affermando e. per convincere la massa degli Alpini sulla sua utilità e diffonderne l'uso, si ritenne opportuno organizzare dei corsi regolari per formare nuclei di ottimi sciatori, a partire dalle guide, che potessero fare successivamente da istruttori ai corsi più completi e più lunghi per plotoni e compagnie che seguirono da lì a poco.
I corsi vennero organizzati a Bardonecchia, al Sestrières ed a
.!òi\l\GG. OIU'>TE Z\\AITA.Rl: Nato il 2 febbraio 1856 a Tortona (Alessandria); nd 1877 è nominato Sottotl!nente e successivamente. nel 188<-J con il grado di Tenente. è assegnato al 1° reggimento <\lpini; dal 1900 al 1902 comanda il hatt.iglione Alpini Exilles e, dal 1907 al 1911 è Comandante dd 3° reggimento Alpini. Partecipa al I° Conflino l\londiale con il .grado di '\Jaggiore Generale al comando della 12 ' DiYisione di Fameria, incarico ricoperto dal 24 maggio 1915 al 13 giugno 1915. E' collocato a ripo:-.o il 2.3 gennaio 1923.
rvo~.
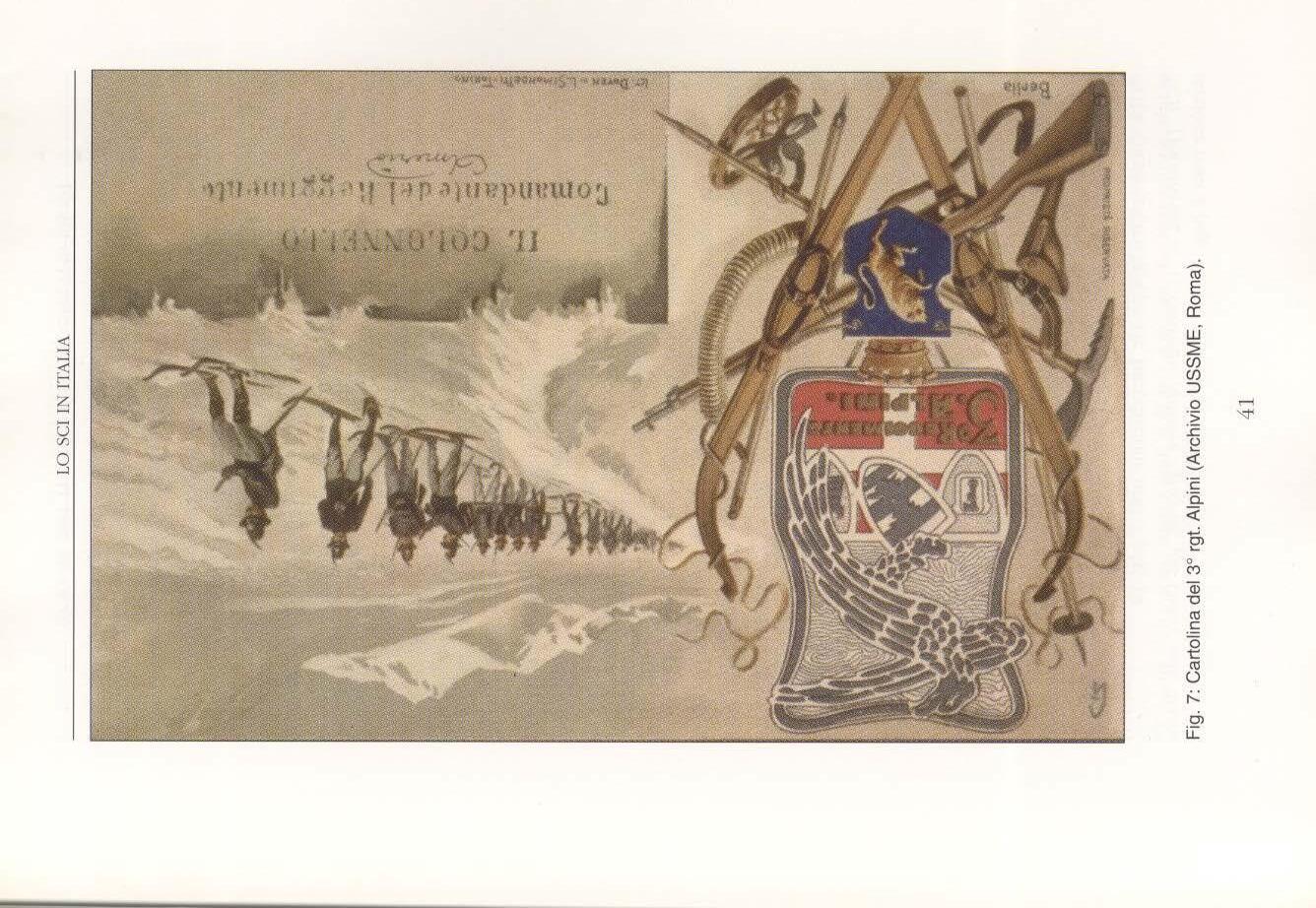
Clavières impiegando, per alcuni inverni, maestri svizzeri e, soprattutto, norvegesi.
Questa anività era, come abbiamo visto, ampiamente sostenuta da una vasta fioritura di scrirri di propaganda apparsi sulla Rivista Militare, sulla Rivista del Cluh Alpino Italiano (Sezione di Torino) e su alcune pubblicazioni edite daire<litore Casanova.
Subentrata finalmente la convinzione dell'utilità degli sci, apparve chiara la necessità che la loro adozione, almeno per le truppe da montagna quali gli Alpini e gli Artiglieii da montagna, fosse stabilita con un ano ufficiale.
Vi provvide il Ministro della Guerra del tempo, Generale Giuseppe Ottolenghi 28 , che con il Decreto n. 275 in data 13 novembre 1902 pubblicato sul Giornale Militare Ufficialè- 9 decise I "adozione degli sci per i reggimenti Alpini.
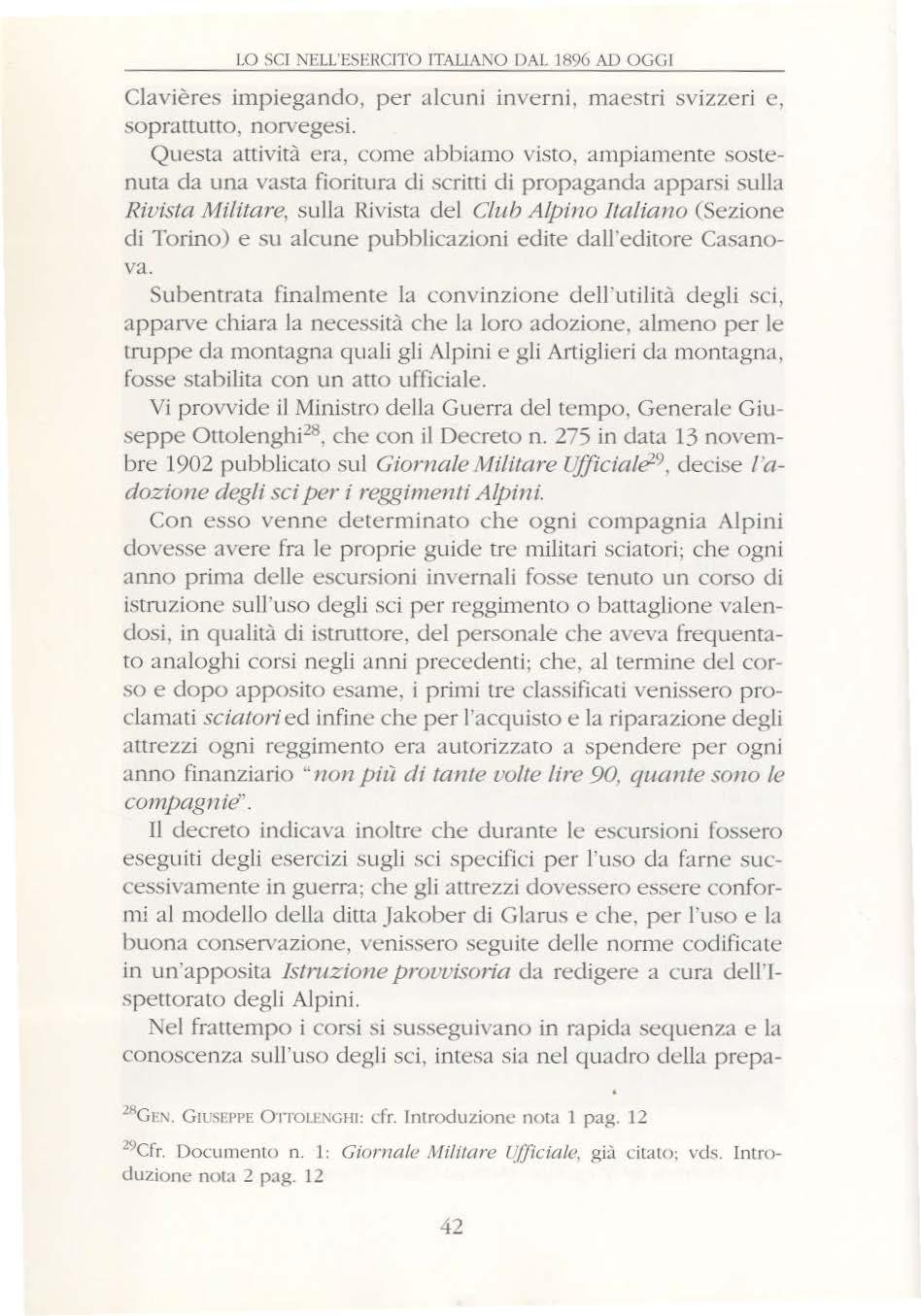
Con esso venne determinato che ogni compagnia Alpini dovesse a\'ere fra le proprie guide tre militari sciatori: che ogni anno prima delle escursioni im ernali fosse tenuto un corso <li istmzione sull'uso degli sci per reggimento o battaglione valendosi, in qualità di istruttore, del personale che aveva frequentato analoghi corsi negli anni precedenti: che. al termine del corso e dopo apposito esame, i primi tre classificati venissero proclamati sciatori ed infine che per l'acquisto e la riparaLione degli arrrczzi ogni reggimento era autorizzato a spendere per ogni anno finanziario ·· non più di tante 1:ulte lire 90. quante sono le compagnie' .
Il decreto indiGl\'a inoltre che durame le escursioni fossero eseguiti degli esercizi sugli sci specifici per l'uso da farne successivamente in guerra; che gli attrezzi dovessero essere conformi al modello della ditta Jakober <li Glarus e che, per l'uso e la buona conservazione, venissero seguite delle norme codificate in un'apposita Istruzione prol.)VLW>ria da redigere a cura dell'Ispettorato degli Alpini.
I\el frattempo i corsi si susseguivano in rapida sequenza e la conoscenza sull'uso degli sci, imesa sia nel quadro della prepa-
~GE,. Gtt:SLPPE 01To1.FI\Glll: <.:fr. IntroduLionc nota l pag. 12
.!'.lCfr. Documento n. l: Giornale i'vfifilc1re l!/ficiale, già citalo; \·ds. Introduzione noia 2 pag. 12
razione dei reparti alla guerra invernale alpina sia in quello della preparazione di sciatori ai fini agonistici sportivi, diveniva appannaggio comune di tutti i reggimenti Alpini dislocati sull'intero arco alpino.
Contemporaneamente, in funzione dell'impiego, lo sci veniva differenziandosi in alpino e nordico o da fondo, dove il primo Iiguardava quasi esclusivamente la tecnica da utilizzare in discesa, mentre il secondo ricercava la tecnica più redditizia per il trasferimento su tracciati generalmente piani pur comprendendo alcune salite e discese di piccola entità.
Quest' ultima specialità, più vicina all'impiego militare vero e proprio dello sci, fu la protagonista delle prime gare a cui parteciparono i reparti.
Il 7 gennaio 1906 , infatti, la compagnia sciatori del 3° Alpini prese parte alle gare di fondo organizzate in occasione dell'inaugurazione della prima stazione invernale di Oulx.
Il 24 gennaio dello stesso anno alcuni Ufficiali, militari di truppa e pattuglie dei battaglioni: Mondov~ Ceua, Pieve di Teco, Dronero, Saluzzo e Borgo San Da/mazzo parteciparono ad un concorso di sci a Limone Piemonte che prevedeva, per i reparti, un percorso di circa 7 Km. con 275 m. di dislivello in salita, da effettuarsi in pieno assetto <li guerra.
Dopo queste prime esperienze agonistiche, si avvertì l"opportunità di confrontarsi anche in campo internazionale; l'occasione venne data dal Concorso Internazionale di Ski del Monginevro, organizzato dalle Autorità Militari francesi, dal 10 al 12 febbraio 1907.

Il livello tecnico raggiunto fu tale che la rivista parigina Vie 1/lustrée così commentava l ' impressione che i nostri rappresentanti avevano lasciato in Francia: "Nos voisins sont très abiles en l 'art du ski. Leurs troupes aif)ines sont; sur ce point, des mieux exercées"30 .
Dopo questa felice esperienza il movimento sciistico continuò la sua espansione ed i militari italiani or.tenevano sempre maggiori successi , in campo sia nazionale che internazionale, confrontandosi con sempre maggior frequenza e con ottimi risultati con i rappresentanti delle altre nazioni.
30I nostri vicini sono molto ahili nclruso dello sci. Le loro truppe alpine sono , su questo puntò , tra le meglio addestrate.
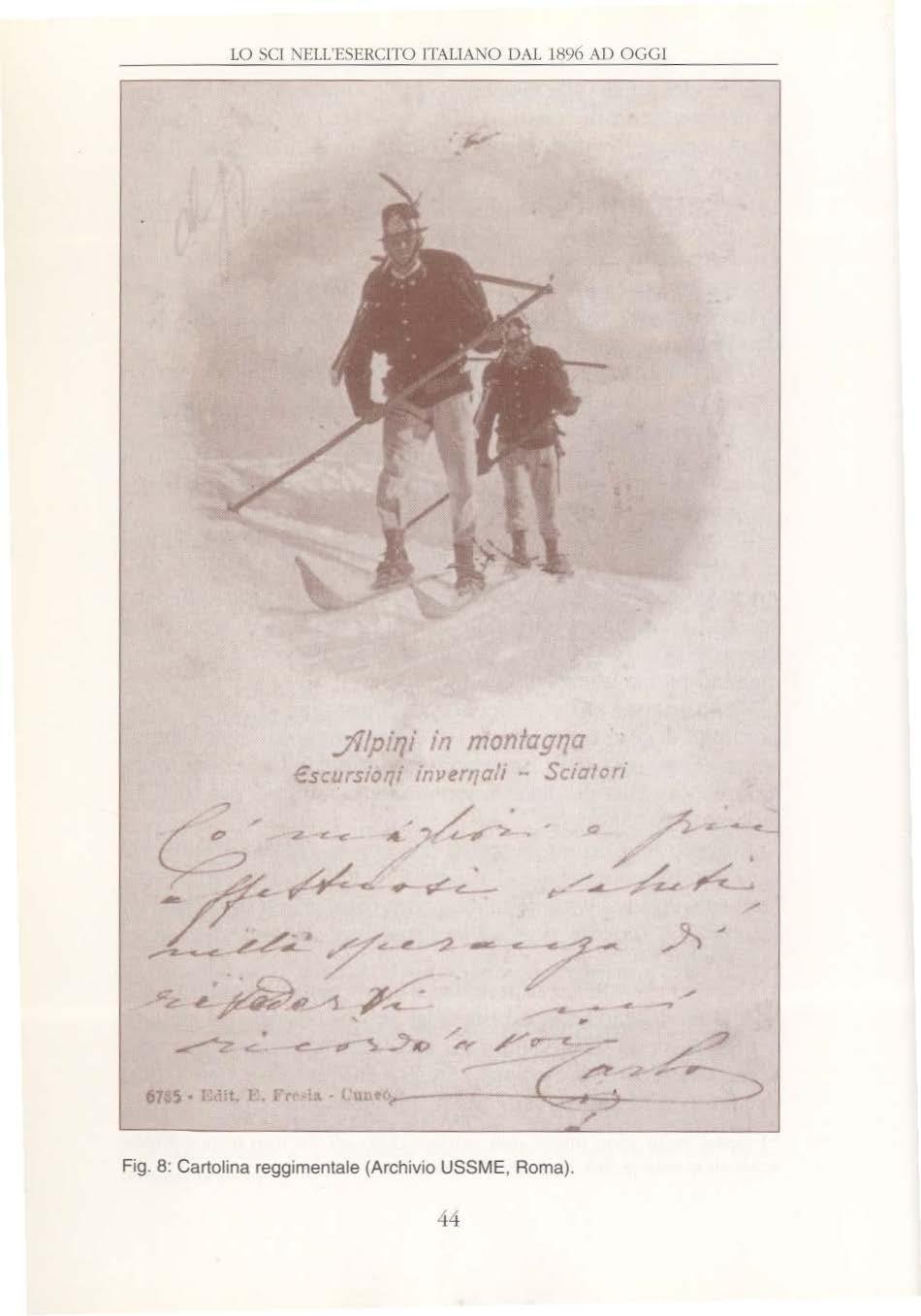
Spiccano in particolare il primo, secondo , quarto e quinto posto nella gara di fondo mililare per squadre , su di un percorso di 18 Km., ed il primo , secondo , terzo e quarto nell ' individual e militare di velocità , nonché a ltri primi post.i o ottimi piazzamenti ottenuti nelle gare internazionali cli sci svoltesi nei Pirenei nel 1910.
In Italia , nel 1908, su iniziativa di Paolo Kind figlio dell'ingegnere Adolfo, nasceva l 'Unione Ski Club Italiani che, l'anno success ivo, diede vita al Primo Camp ionato Nazionale di Sci.
La competizione si svolse a Bardonecchfa tra il 20 ed il 22 febbraio 1909 a cura dello Ski Club Tor in o e comprendeva, oltre alle tre ga re previste per il campionato: fondo , salto e combinata fondo -salto, anche gare internazionali e gare riservate ai militari.
Il campionato , dopo una sosta negli anni 1911 e 1912, riprese nel 1913 ai Roccoli dei Resinelli (Lecco) per svolgersi poi regolarmente con cadenza annuale fino all'inizio della guerra.
In quegli ann i la collaborazione tra i militari ed i civili , peraltro già ottima, era anda ta ulteriormente consolidandosi; nelle domeniche e nelle altre giornate festive, infatti, parecchi valligiani, soci de l CA I31 , frequen tavano dei corsi nelle zone dove si svolgevano i corsi di sci reggimentali, approfittando della disponibilità degli Ufficiali istruttori.
Tuttavia le diverse condizion i di innevamento ed una difforme attrazione verso l'attività sciistica eia parte degli abitanti delle vallate alpine , cond izionavano la regolarità e la periodicità dello svo lgimento delle ist ru z ioni .
Questa attività di collaborazione presentava inoltre il grosso vantaggio di avere del personale da arruolare o , all'emergenza, da mobilitare già addestrato ed in grado d i offrire in pochissimo tempo un ottimo livello di operatività.
Il problema della diffusione sull' uso degli sci era così sentito che il Capo di SM dell ' Esercito, il 29 gennaio 1913, aveva posto all'Ispettorato della Truppe da Montagna una serie di quesit i inerenti l'opportunità di un aumento degli sciatori nelle compagnie e batte1ie e l ' assegnazione cli q u esti anche ai Comandi superiori, la ch iamata invernale degli sciatori in congedo, la costituzio-
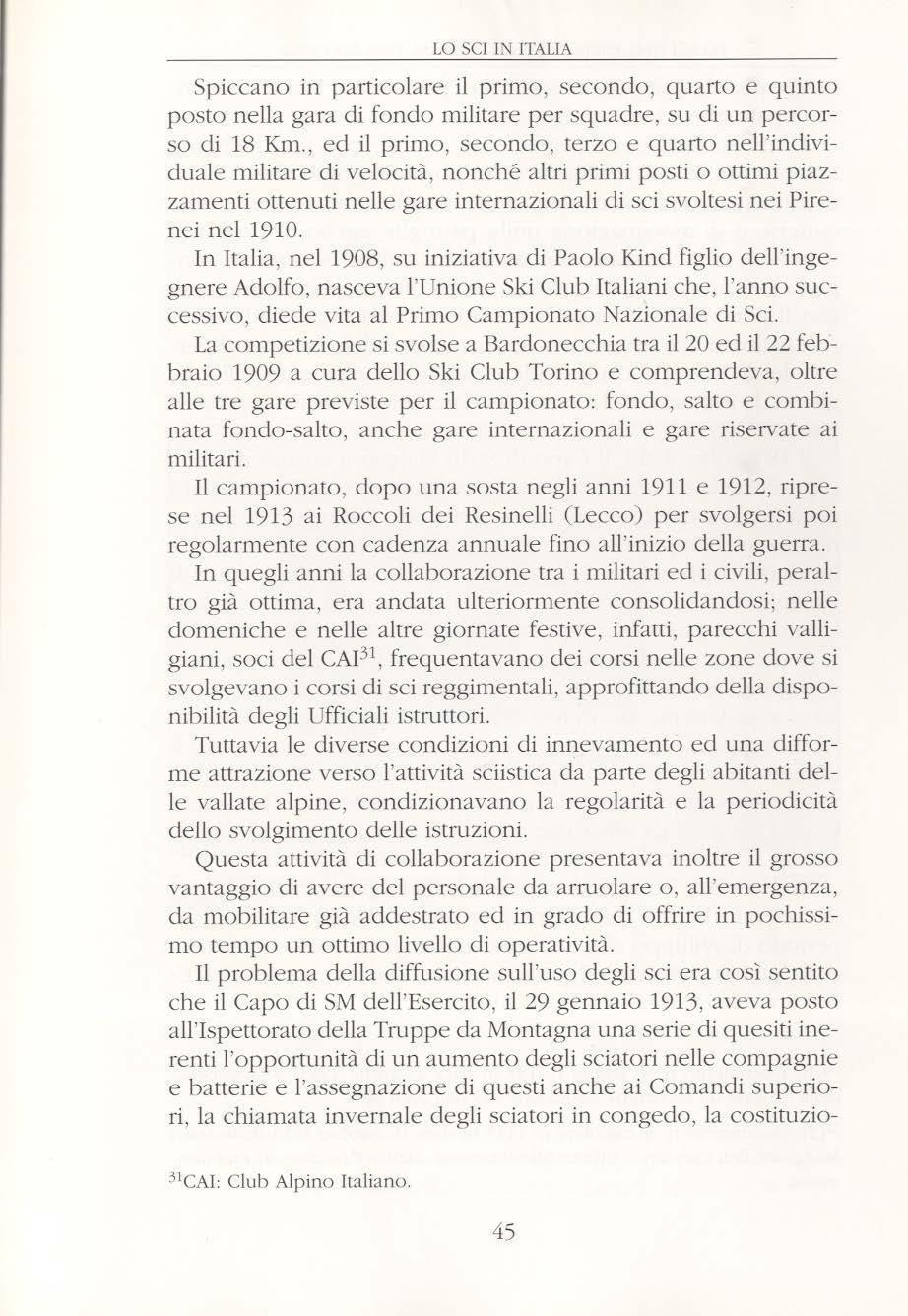
ne di speciali drappelli di sc iatori e. per ultimo. l'addestramento di pattuglie sciatori di Fanteria.
A tale sollecitazione l'Ispettorato rispose con una memoria art ico lata nella quale illustrava l'opportunità, oltre che l'utilità, di aumentare il numero degli sciatori delle compagnie e delle hatterie e di assegnazione delle pattuglie anche ai Comandi superiori, di richiamare annualmente i militari sciatori in congedo per un corso d'istruzione, di costituire speciali drappelli con il personale in congedo costituendo dei depositi cli materiali calihrati alle esigenze e di organizzare dei corsi per il personale di Fanteria comprendendovi anche elementi dell'Artiglieria da Fortezza, del Genio, de i Carabinieri e delle Gua rdie di Finanza 32
Il 18 ottobre 1913, il Capo di Stato Maggiore emanò una circolare33 nella quale. accogliendo i !->uggerimemi dell'Ispettorato della Truppe da Montagna. veniva definito il numero di sciatori che ogni compagnia e batteria dovesse avere in caso di mobilitazione. l'oppo1tunità di assegnare degli sciatori ai Comandi di battaglione e di reggimento e, limitatamente alla sola mobilitazione, ai Comandi di gruppo Alpino stabilendone anche l'entità.

Il documento definiva, inoltre, la dislocazione cli speciali depositi di materiali, ciascuno contenente 20 serie di paia di sci, a cui accedere in caso di mobilitazione per equipaggiare eventuali drappelli sciatori che si rendesse necessario costiluire, il numero di sciatori per i reggimenti di Fanteria e dei Bersaglieri, l'approvvigionamento dei mate r iali cd il loro accantonamento ed i corsi sci da effettuare annualmente sulla base di dirertivc che sarebbero state impartite al momento opportuno.
La circolare costituì una pietra miliare per lo sci militare, decretando la fine dell'età pionieristica e dando inizio ad un periodo di sviluppo che, sebbene momentaneamente interrotto dalla guerra, interessò il personale di numerosi repa rti dell'Esercito oltre, natu ralmente, gli Alpini.
32 Cfr. Documento n. '!: lettera n 19' in data 25 aprile 191.3 di Ispettorato della Truppe da Montagna nijji,siolle sull'uso degli ski.
HCfr. Documemo n. 5: circolare n. 1115 in data 18 ottobre 191.:3 dello Stato \laggiore <lell'Esen.: ito - Ufficio ;\Jobilitnione Skiatori in caso di mobilitazione.
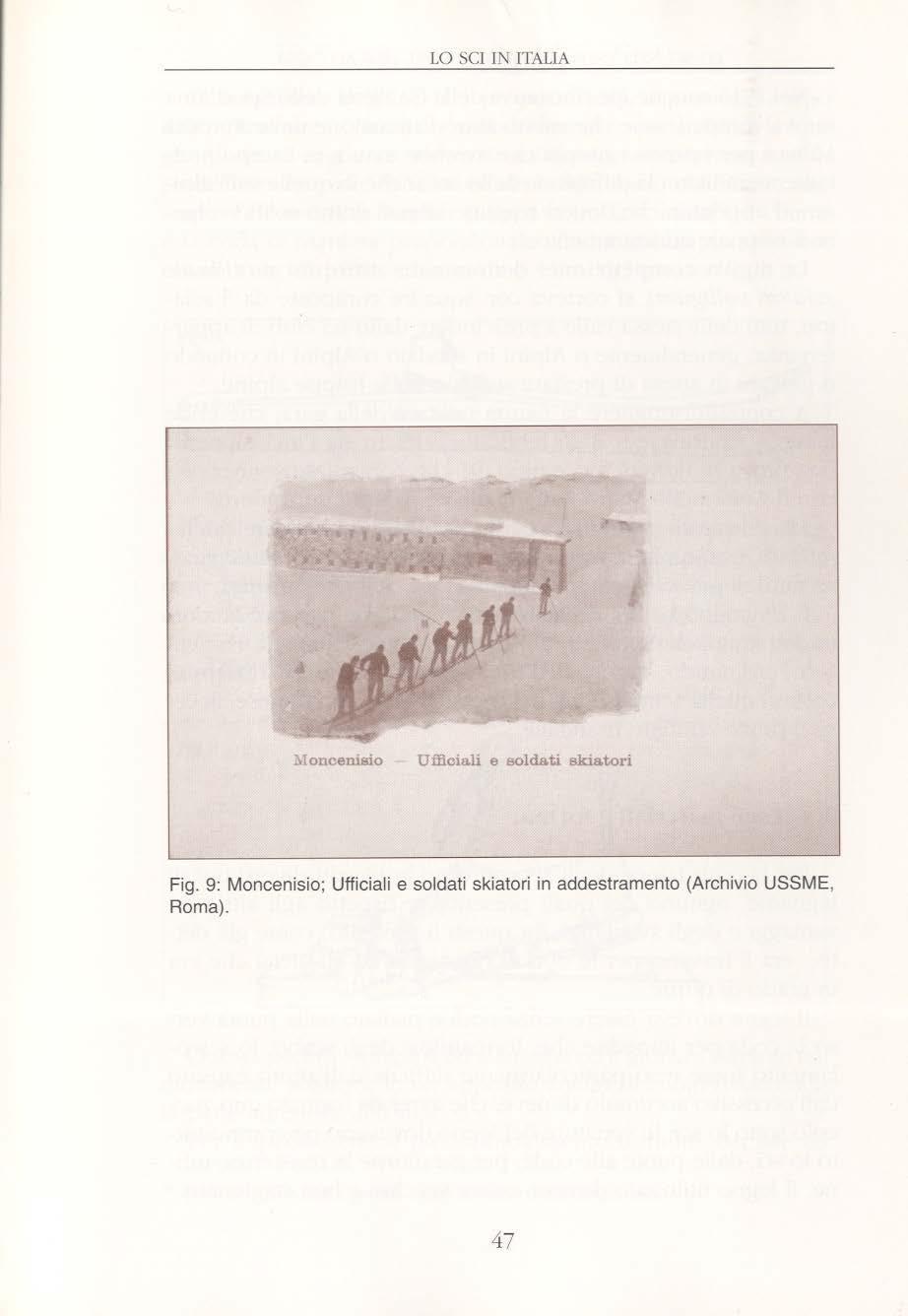
Kel 1915 nacque, per iniziativa della Gazzetta dello Sport, una nuo,·a competizione che subito attirò l'attenzione delle Autorità Militari per i positivi risvolti che avrebbe avuto, in campo prettamente militare, la diffusione dello sci anche in quelle valli alpine e<l appenniniche dove i reggimenti non erano c;oliti svolgere il normale addestramento.

La nuova competizione, denominata Adunata nazionale sciatori l'allip,iani, si correva con squadre composte da 5 sciatori, tutti della stessa valle a prescindere dallo sci club di appartenenza. generalmente o Alpini in servizio o Alpini in congedo o giovani in attesa di prestare servizio nelle tmppe alpine.
A contraddistinguere la natura milita re della gara, che ebbe luogo a Courmayeur il 26 febbraio 1915, fu sia l'inclusione di una prova di tiro col fucile mod. 91 che l'organizzazione stessa con il Colonnello Mario Raffa quale presidente della giuria.
Ma in questo periodo in cui lo sci. ed in particolare quello militare, era in piena espansione sia tecnica che sportiva. grosse nubi di guerra si erano addensate sui cieli dell'Europa.
I l 28 giugno 1914, l'attentato di Sarajevo. che pro,·ocò la morte dell'Arciduca ereditario al Trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando, nipote dell'Imperatore Francesco Giuseppe, costituì quella scintilla che. nd breve volgere di un mese, accese il primo conflitto mondiale.
Per la costruzione degli sci venivano imp iegati diversi tipi di legname, ognuno dei quali pre~enta"a. rit.petco agli altri. dei vantaggi e degli svamaggi; fra questi il preferito. come già <letto, era il frassino per le doli di resistenza ed elasticità che era in grado di offrire.
Il legno doveva essere senza nodi e piallato dalla punta verso la coda per impedire che, formandosi degli scabri, lo scivolamento fosse reso partico larmente difficile dall'attrito causato dall'eccessivo accumulo di neve, che avrebbe formato uno zoccolo sotto lo sci: le venature èlel legno dovevano percorrere lutto lo sci, dalle punte alle code, per garantirne la resistenza; infine, il legno utilizzato do\'eva essere ,·ecchio e ben stagionato.
La lunghezza degli sci era proporzionata al peso del corpo dell'utilizzatore, tuttavia un metodo empilico per stabilire la lunghezza era il seguente: tenuto lo sci appoggiato al terreno ed in posizione verticale, Lo sciatore deve. allungato il braccio, toccarne l'estremità; la larghezza variava tra la sparola 34, il centro e la coda in maniera proporzionale a ll a lunghezza; lo spessore era di 1 cm. in punta ed in coda e 3 cm. nel mezzo (fig.n.l).
Per il fissaggio al piede, si usava un attacco posto nella parte centrale dello sci: esso era composto da un giunco , di 12 - 14 mm. di diametro, ricurvo a ferro di cavallo, con le due estremità molto vicine, per irrigidire il cuoio dell 'attacco in quel punto cl1e deve circondare il piede e che, pertanto , era detto staffa posteriore (fig.n.II).
Questa poteva stringersi ed allargarsi ed il giunco, durante tali movimenti, scorreva in un apposito anello di cuoio fissato nella parte anteriore dell'attacco.
Per impedir e che il piede, movimenco durante, uscisse da

questa staffa, la scarpa ,·eniva introdotta in una seconda staffa, posta perpendicolarmente alla prima, e chiamata. per la sua posizione. staffa superiore.
Quest'ultima era composta da una cinghia di cuoio larga circa 3 cm. e foderata al suo interno con della pelliccia per impedire che c,;ercitasse una pressione troppo marc-.ita sulle dita dei piedi.
Secondo la tecnica usata dai Norvegesi. l'intero attacco, così descritto, era fissato allo sci mediante la staffo superiore che, penetrando lateralmente nello spessore del legno per circa 2, 5 cm. , i risultava solidamente incastrato.
Questo sistema presentava però il difeno che. e~endo lo .:;ci l~rgo nella sua parte centrale circa 8 a11. ed essendo cli ci.rea 5 cm. complessivi l'incastro previsto per la staffa superiore. la solidità dello stesso veniva compromessa in maniera più che evidente.

Per porre rimedio all'inconveniente e per rendere nel contempo più solido lo sci nella sua parte centrale. zona peraltro più sollecitata e sotcoposta a sforzi, l'ing. Kind fissò allo sci, con delle viti robuste, un'assicella di legno larga quanto lo sci stesso, lunga 30 cm. circa ed alta 2: con questo espediente la staffa superiore non ,·eni,,a più incastrata nel fianco dello sci. ma era infilata tra lo sci stesso e l'assicella: a questa venne applicata. superiormente. una copem1ra di gomma.
Lo sci. nella sua parte anteriore, presenta\'a una cu1Yatura verso l'ateo di circa 20 22 cm. per permettergli di solcare qualsiasi tipo di neve favorendo\'i il galleggiamento.
Un'altra curvatura era presente nella parte mediana in modo tale che l::t parre centrale dello sci. una ,·olca appoggiato al terreno, ne risultasse sollevato di circa :V4 cm.: quest'arco aveva lo scopo di agire come una molla che. discendendosi sono il peso dell'utilizzatore, distribuisse uniformemente la pressione su tutta la superficie agevolandone lo scivolamento.
Lungo la soletta~'> dello sci era rica, ara. per tutta la sua lunghezza, una scanalatura larga circa 1 cm. e profonda 0,5 che ne facililava la guida impedendone sbandamenti laterali.
Inoltre. ad eccezione della soletta. turro lo sci era verniciato per proteggerlo dall'acqua e dall'umidità. .
Un particolare di non secondaria importanza era. infine, quel-
'"Solei/a: faccia inferiore dello :,e.i posta a conwcto con la -;uperlìde O<:\'OS.'l.
lo che, durante la stagione estiva, quando non erano utilizzati, gli sci dovevano essere unti con olio di lino e riposti in luoghi asciutti e freschi; e legati fra di loro in punta ed in centro, facendo combaciare le due solette, interponendo fra queste, all'altezza degli attacchi , un cuneo dallo spessore di circa 5 cm. ed applicando sulle due punte un'assicella di circa 40 cm. cli lunghezza; il cuneo e l'assicella avevano la funzione di mantenere la curvatura degli sci (fig. n.III).
Fi g.11 1
Completavano l' attrezzatura due bastoncini di legno leggero, ma resistente, un po' meno lunghi dell'alpenstok36 in dotazione e muniti, come questo, di un anello di cuoio all'impugnatura e di un puntale ed un anello di giunco all'estremità inferiore, che permettevano la presa sulla neve senza affondarvi (fig. n.JV).
Gli sci adottati dall'Esercito Italiano avevano queste caratteristiche ad eccezione degli attacchi che erano del tipo Huitfeld con leva a snodo (fig. n.V).
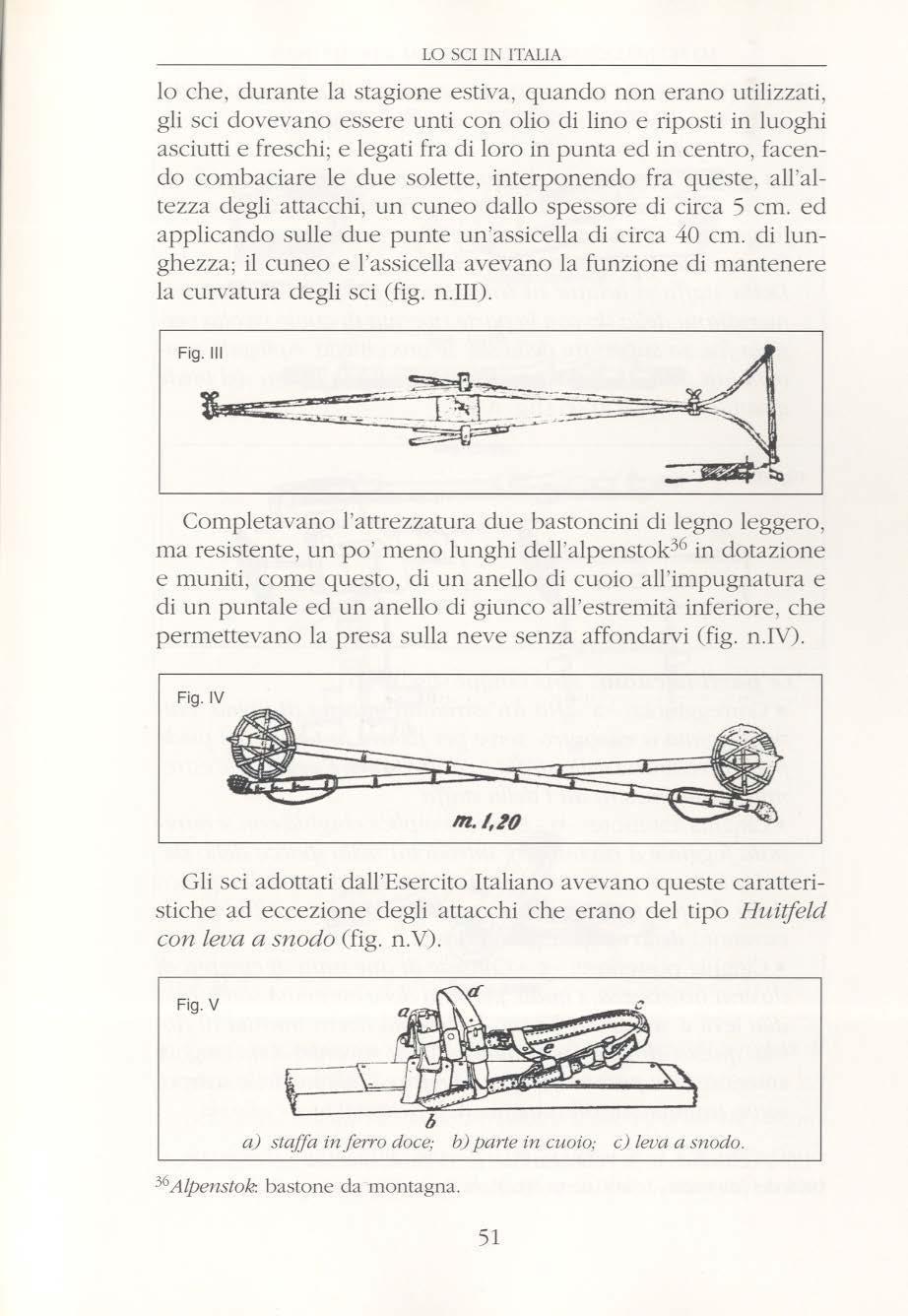
In proposito ~ulla normati\·a Istruzione sull'uso degli ski edizione 1908 ciel Ministero del la Gllerra -~~ si legge che: "E' costituito da tre pa11i p,incipali:
1. La staffa : è costituita da una piastra rettangolare in/erro dolce nella quale è praticata una finestra longitudinale a .fogp,ia di I: la/accia interna della stajjà è rù.:estila di cuoio: le estremità della piastra (orecchielfeJ sono alquanto in alto. Della staffa si aclal!a in uno spacco praticato nella parte meridiana dello ski con la parte ril'esti/Ci di cuoio rirolta l'erso la.faccia superiore dello ski: le orecchielle. ripieµ,ate contro i lati dello ski. servono a tener/erma la punta del piede quando si calza lo ski Cfig. n.VI).
2. Le parti in cuoio : sono cinque (fig. n.VU):

• Correggiuola: -a - Ha un·estremità munita difihhia. l'altra foggiata a riscontro: serve per fissare la punta del piede fra le orecchiette della staffa e contro lo ski. Passa per le estremità della finestra ad I della staffa.
• Cinghia anteriore: -b - lt u 11a semplice cinghia con le estremità foggiate a riscontro: è illfrodo!La nello spacco dello ski. nel quale scone: ai due riscontri. che sporgono dallo spacco dello ski quasi per uguale lu11f!,hezza. 1 1engono ajjìhbiate le estremità della cinghia posteriore c.
• Cinghia posteriore: - e - Consiste di due tratli di cinghia di diz·ersa lunghezza. i quali. per una delle estremUà sono uniti alla leva a snodo ed hanno l'estremità libera munita dijìbbia: questa cinghia t·iene allacciata ai riscontri della cinghia anteriore b e. passando sopra e contro il tallone della sccupa. sen:e. unitamente alla cinghia d, a.fissare il piede allo ski.
rcfr Documento n 3: Pubblicuione n 39 lstruz1 0 1Ze sutruso deP,li ski ed.
1908 del Ministero della Guerra. Voghern Enrico tipografo.
52
H• Cinghia superiore: -d - Si compone di due pezzi di cinghia di diversa lunghezza che hanno un ·estremità ripiegata ad occhiello, nel quale viene introdotto il corrispondente riscontro della cinghia anteriore b ; il pezzo più corto, che deve risultare dalla parte esterna dell'attacco, ha l'altra estremità





munita di fibbia e passantefi.sso. il pezzo pilì lungo, che deve risultare dalla pa11e j)izì ilztenza. ha /"altra estremità foggiata a riscontro. Cosicché. quando i due pezzi sono uniti alla cinghia anteriore, essi possono essere allacciati /'11110 all'altro per mezzo della fibbia e. dispo11endosi sopra il collo del piede, serz:ono ad adattare bene al piede tutto l'attacco.
• Cinghietta sottopiede: -e - E" una piccola cinghia che ha le due estremità npief!,ale ad occhiello. Per questi occhielli passano le estremità della cinghia c; la cinghietla dezie risultare sotto e contro f'incaz:o del piede. e serue. in contrasto con la cinghia superiore cl all'adattamento dell'attacco.
3. La leva a snodo : trol'asi inserita nella cinghia c. Abbassando il braccio della let•a si restringe il perimetro delle cinghie b e e, le quali stringendo in tal modo il piede in avanti, .fòrzano la punta del piede stesso contro le orecchiette che ne impediscono i mouimenti nel senso laterale e longitudinale.
Rimanendo sempre nell'ambito dell'attrezzatura sciis t ica è opportuno ~ottolineare che dovendo!:>i muovere in terreni accidenlati bisognava escogitare diversi sistemi di freni che impedissero lo scivolamento verso l'indietro in sali ta e la troppa velocità in discesa.

Il primo ve n ne risolto applicando sulla faccia inferiore degli sci. la soletta, un pezzo cli pelle di foca con il pelo rivolto verso l'indietro in modo tale che. arretrando lo sci, il pelo si arruffasse impedendone lo sdruccio lamento; il secondo app licando una correggia atcorno allo sci anterio rmente al piede.
Talvo lta su pendii partico larmente ripidi dove l'azione della pelle di foca si rivelava insufficiente vennero applicati agli sci dei ramponi; ne furono costruiti di svariati modelli,. ma quelli che apparvero migli ori erano quelli ideati dal Paulcke, in acciaio con -¼ denti ed applicabili alla soleua mediante una larga cinghia di fissaggio.
Come abbiamo già accennato. l'articolo del Tenente Roiti, oltre che una prima informaz ione sullo sci e sulle possib ilità da questo offerte per un più age\ ole e veloce movimento sul ter-
reno innevato, rappresentò il primo breve manuale tecnico sull' uso di quegli attrezzi.
In esso l'Autore, dopo essersi soffermato sulle esperienze fatte personalmente con gli attrezzi , descrive le operazioni iniziali che uno sciatore deve saper compiere come il camminare in piano , il dietro -front, la salita a spina di pesce o a scaletta e , infine, la discesa.
Particolarmente interessante è la descrizione che il Roiti fa di come affrontare le discese e soprattutto , su come evitare gli ostacoli e fermarsi in maniera repentina; ma sentiamo la sua descrizione : " Volendo scansare qualche ostacolo si può deviare a destra od a sinistra piegando La gamba interna e portando su questa il peso del corpo. Si possono eseguire, anche senza· l'uso del bastone, delle voltate ad angolo retto; ma, andando con forte velocità. oltre ad una grande sicurezza , è necessario avere forza ed energia. Non potendo schivare altrimenti un ostacolo qualunque, è meglio lasciarsi cadere lateralmente, senza che ci sia il minimo pericolo".
Questo sistema per evitare gli ostacoli , a parte il lasciarsi cadere lateralmente nella neve, era forse più facile a dirsi che non a farsi; tuttavia degli abili sciatori riuscivano a fermarsi immediatamente con una curva ad angolo retto detta slancio del Telemark38.
Queste indicazioni furono prese come base per gli esperimenti e per l'insegnamento dello sci nei nostri reparti alpini ad iniziare, come abbiamo già visto, da quelli del 3° reggimento Alpini.
Finalmente nel 1908 il Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Istruzioni e Manovre, attuando quanto disposto dal Decreto n. 275 del 13 novembre 1902 del Ministro della Guerra in merito all 'adozione degli sci per i reggimenti Alpini, emanò la pubblicazione n. 39 Istruzione sull 'uso degli ski edizione 190839 In essa, dopo una premessa in cui si fissavano gli scopi, le modalità ed i risultati da raggiungere ed una prima parte dedicata alla nomenclatura ed alla descrizione del materiale, ci si sof-

38 Telemark Località monta na d e lla Norvegia meridionale i cui abitanti , particolam1ente abili nello sci , hanno ideato un particolare metodo per curvare detto: slancio del Telemark.
39Vcls. Documento n. 3 già citato.
fem1ava in maniera approfondita sulla tecnica vera e propria dell'impiego dello sci dando, ed è questo raspetto più qualificante, suggerimenti ed indicazioni sulla melodica e sulla didattica più opportuna ccl idonea per un facile e rapido apprenclimenro.
Alla pa,te descritti\·a seguiva -;pes\o una rappresenlazione grafica che aveva la funzione di t.:splicitarc visivamente l'esercizio interessato come, tra gli altri, il dietrofront, la sciata in salita e la curva Tclemark.
Sulla puhhlicazione, infatti si legge:
• Dietro-front : si comincia sempre colla gamba posta dalla parie Ol'e si t•uofe girare e, sopra terreno inclinato. sempre colla gamba che si trul'a l'erso il basso.
Per/are il dietro-front a sinistra. per esempio. si segue il metodo indicato nei 6 tempi della figura. Per jètre il dietrofront a destra si/anno analoghi movimenti incomincia11do però con il piede destro.

In terreni pianeggianti è consigliabile il dietrofront nel seguente modo: !.>piccare a piedi uniti un salto i11 a/tu e contemporaneamente eseguire un mezzo giro a destra od a sinistra.
• Skiare in salita: (. ... .} J'vei brevi traiti molto inclinati è meglio salire lateralmente a gradini: si sollel'a cioè il piede a monte e lo si posa alquanto più alto, quindi si po,ta l'altro piede nel posto lasciato dal primo e così si conti11ua: oppure si porta ad OP,ni passo il piede che è rimasto più in gitì accanto a quello che si è sollevato pilì a monte e che torna a solleL'arsi appena compiuto il detto at:l'icinamento. Un altro metodo meno usato e pilìfaticoso consiste nel passo a spina cli pesce. Si tengono le gambe molto allontanate, gli ski dil'erµ,enti in aranti colle code sulla linea da percon-ere e p,li spigoli esterni sollevati per poter ùl}ìggere meglio nella nel'e quelli interni.
Con questo modo si superano strelfi passapgi, strade ilzcassate ecc. Ol'e il salire a gradini è cosa lenta o non concessa dalla ristrettezza dello spazio
• Tel e mark: 11 Telemark serve per voltare rapidamente a destra o a sinistra durante una scit •olata.
Telemark a sinistra:
7. Gral'itare sullo ski sinistro: 60
2. Vo ltandosi di sbieco ed inclinando il corpo verso l'interno portare il piede destro avantifinchè esso si trovi all'altezza deffa punta deffo ski sinistro, e piegare il ginocchio sinistro;
3. Gravitare sullo ski destro, e lavorare con questo, di costa. la neve, spingendo fortemen te alf 'i7~fuori col tallone destro fa coda dello ski in modo da provocare il camhiamento di direzione a sinistra;

4. Portare lo ski sinistro parallelo allo ski destro.
Per compiere il Telemark a destra si eseguiranno gli stessi movimenti invertendo il lavoro dei due ski sopra spiegato. Quindi, dopo aver illustrato come svi luppare le lezioni di sci, usare correttamente i bastoncini, cadere senza fa rsi ma le e rialzarsi faci lmente, la pubblicazione faceva dei cenni su ll'influenza delle condizioni della neve, i pericoli che si possono incontrare durante un'escursione sugli sci e come conseivare g li attrezzi.
Ne ll 'ultimo paragrafo era illustrato come svolgere gli accertamenti final i, le qua lifiche ed i premi da conferire e la nomina a skiatore scelto di quegli clementi che ottenuto la qual ifica di ottimo erano anche, limitatamente ai soli Alpini, tiratori di pr ima classe.
Per essi era previsto un distintivo da cucire sulla manica sinistra e consistente in due sci in croce di S. Andrea, ricamati in seta scarlatta o nera a seconda se apposto sulla giubba di panno turchino o grigio vcrclc'10 (fig. n.VIII); era inoltre prevista la consegna di un diplo m a t1
' 1Cfr documento n J gia <.:i1.a 1.o.
A questa ottima pubblicazione, che costituiva una pietra miliare nello sviluppo dello <;Ci in campo militare ed alla attività addcstrativa e sportiva, sostenuta peraltro con entusiasmo dalle stesse Autorità i\Witari, non corrispose la lungimiranza di costituire dei veri e propri reparti skiatori organici, inquadrati in maniera stabile nei ranghi dell'Esercito e pronti ad essere impiegati al momento del bisogno.
Con questa situazione l'Italia si accingeva ad entrare nel primo grande conflitto mondiale.

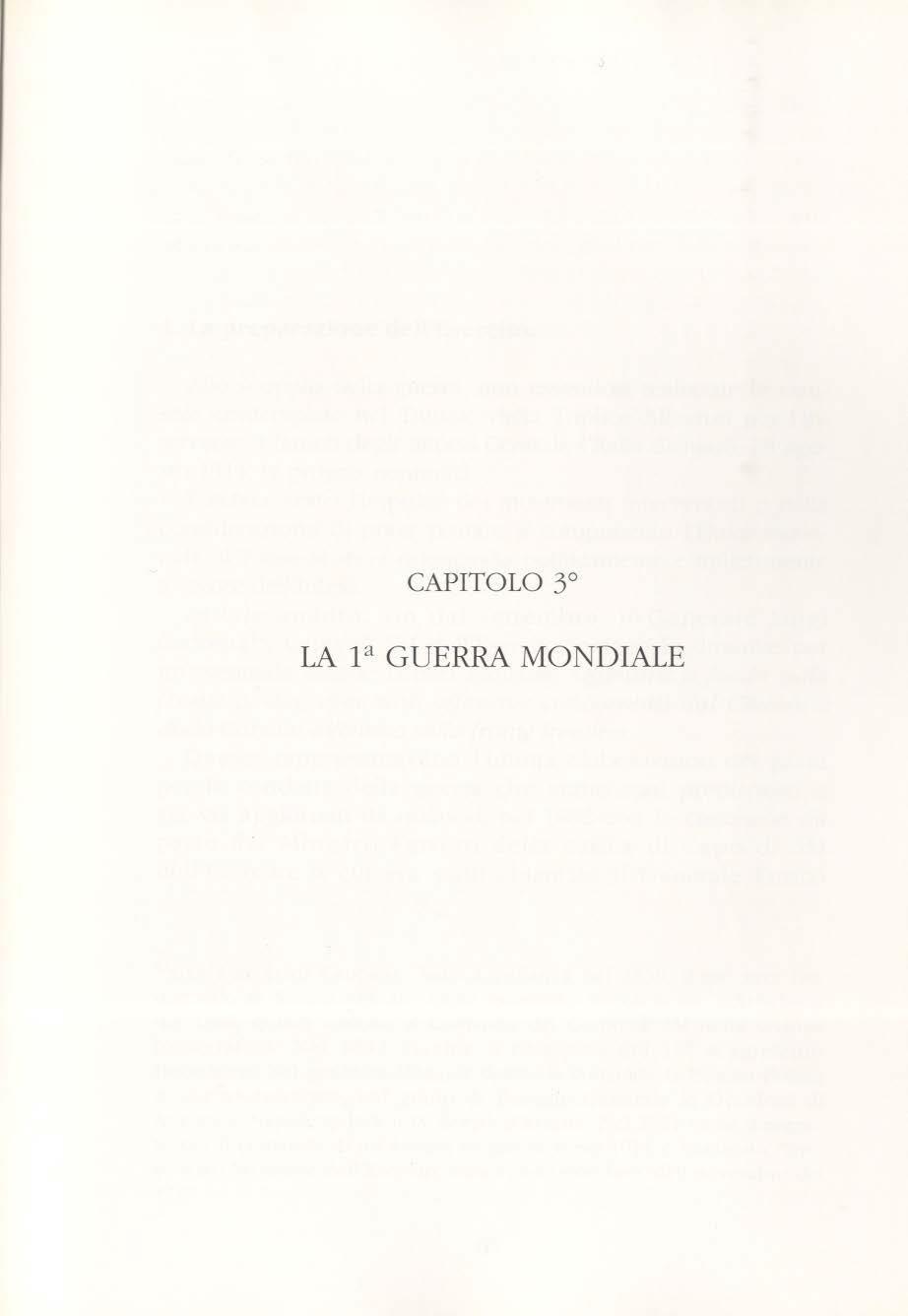

1.
Allo scoppio della guerra. non essendosi realizzate le clausole contemplate nel Trattato de ll a Triplice All eanza per l'intcrYento ,1 fianco degli Imperi Centrali. ncalìa dichiarò. n-i agosto 191 ~. la propria neutralità.

Tuttavia, sotto l' impulso <lei movimenti intc 1ventisti e nella considerazione di poter portare a compimento l'Unita nazionale. il Paese si sla\·a orientando politicamente e militarmente a ~avore <lelrlmec:;a .
. n tale ambito. si n dal settembre, i l Generale Lu i gi Cadorna 2 • Capo di S.\ J dell'Esercito. emanò le direlti\e per un'eventuale azione contro l'Austria: Offensil'a a fondo sulla / i·unte g !{/ iu· el'entuali o.f.Jensil'e concorrenli dal Cado r e e dalla C{lr 1ia: dijènsil'a sulla fronte trentina.
Queste rappresenta\ ,tno l'ultima elabor:.1/ione dL'i piani per la condotta della guerra che erano stati p r edisposti e via via aggiornati e.la q u ando. neJ 1882 con la creazione da parte del .\linistro Ferrero della carica cli Capo di S:\ I dell'Esercito. a cui era st,tto chiamato il Generale Enrico
'
1G E,rn\l.F Lnc.1 C.>.D O R'-A: '\.110 ,1 Pallanza nel 18">0. dopo ,l\ cr frequentalo la Scuola \ l ilitare viene nominato Souotencnte d'Arrig lieria nel 1868 , quindi ,tdcletto al Comando del Corpo di S\1 nelh1 s<:zione ropogr.ifica . .'.'\el 1892 as.,ume il com,1ndo del 10° rcggim<:nto Bersaglieri: '\;el grado di Slaggior Generai<: comanda la Brig.lla Pistoia e, !>UCCl"isì,·amente, nel grado d i Tenente Generale l e Di, ision i di Ancona e Napoli. quindi il IV Corpo d'A r mata. Nel 1911 v i ene.: <.ksignato per il comando dì un·-\.rm,lla in guerra e nel 191 tè nomin,Ho Capo di Stato \laggiort= dell'Esercito. carica che tiene fino alr8 no,·embre del 1917.
La pre parazione dell'Esercito.Cosenz 43 , era stata considerata l'ipotesi di una guerra contro l'Austria-Ungheria.
Al piano iniziale del Cosenz che, tenendo presente la netta superiorità dell'Esercito asburgico in quanto ad unità e capacità di mobilirazione, prevedeva inizialmente un'azione difensiva sulla linea del Piave seguirono nuovi aggiornamenti ad opera del Generale Tancredi Saletta44 , nel 1905, quindi del Generale Alberto Pollio45 nel 1909.
Sempre il Pollio, nel 1911, allo scopo di alleggerire la pressione che il nemico avrebbe esercitato in pianura, ritenne opportuno variare l'impiego della l' e della 4" Armata, poste a difesa del saliente trentino, da difensivo in offensivo attirando in tale settore un numero maggiore di forze avversarie.
Nel 1914, infine, mutata profondamente la situazione politica internazionale con la Monarchia ashurgica impegnata su altri
'"GENERALE faIRICO COSE:'-JZ: Nato a Gana il 12 gennaio 1820. nel 1832 frequenta il Collegio 1'vlilitare della )l'unziatella. :,l'eJ 1840 è promosso Ufficiale e. nel 1848. con il grado di Tenente viene inquadrato nel Corpo di spedizione napoletano inviato in Alta Italia per appoggiare l'azione piemontese contro gli Austriaci, nel 1860 è al fianco di Ga1ibaldi nell ' impresa dei Mille e, nella campagna del 1866. al comanùo della 6a Divisione. Il 6 ottobre 1882 assume la carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Si spegne il 28 settembre 1898 a Roma.
1'GE.:-,;ERALE TA\' CREDI SAT.E'ITA: Nasce a Torino il 27 luglio 1840. Entralo il 20 ottobre 1856 nella Regia Accademia di Torino ne esce con il grado di Sottotenente di Attiglieria il 26 aprile 1859. Prende pa1te a lla campagna dell'Umbria e delle Marche quindi a quella del 1866. Il 17 gennaio 1885 parte per Massaua dove rimane fino al marzo 1886 per poi rientrare in Italia. [I 23 aprile 1887 il Gen. Saletta torna a Massaua con l'incarico di Comandante Superiore fino al novembre dello stesso anno quando rientra definitivamente in Patria. Nel maggio 1896 viene nominalo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. carica che conserva fino al 27 giugno 1908 quando, per raggiunti limiti di età, lascia il servizio attivo. Muore a Roma il 21 gennaio 1909 stroncalo da un attacco di angina pectoris.
45GENERALE ALBERTO Pou.10: Nato a Casena nel 1852. Nel 1870 viene nomiru.uo Sottotenente d'Attiglie1ia e, nel 1878. passa al Corpo cli SM. Con il grado di Maggiore nel 1884 u·ansita in Fanteria; dal 1893 al 1897 è addçno all'Ambasciata di Vìenna. Ha comandato il 40° Fanteria, la Brigata Siena e le Divisioni di Cagliari e di Genova. Nel 1908 è nominato Capo cli State> Maggiore dell ' Esercito; come tale riordina l'Esercito, riorganizza la difesa della Alpi Orientali e organizza la guerra italo-turca del 1911 - 12. 1\1uore a Torino nel 1914.

fronti, il Capo di SM vide capovolto il concetto precedente in cui l'Austria avrebbe attaccato e l'Italia si sarebbe difesa e concepì un nuovo piano orientato nettamente all'offensiva.
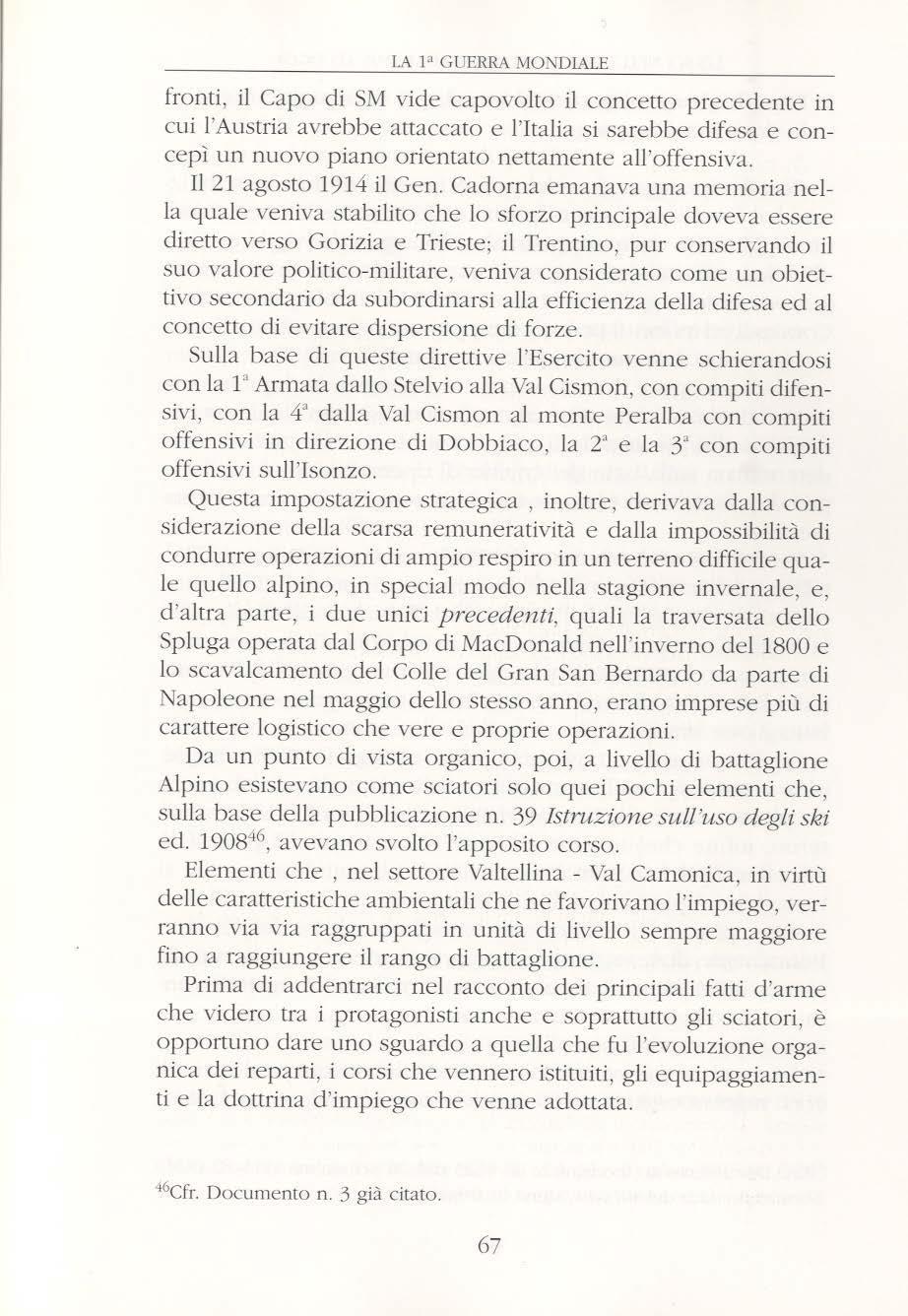
Il 21 agosto 1914 il Gen. Cadorna emanava una memoria nella quale veniva stahiliro che lo sforzo principale doveva essere diretto verso Gorizia e Trieste; il Trentino, pur conservando il suo valore politico-militare, veniva considerato come un obiettivo secondario da subordinarsi alla efficienza della difesa ed al concetto di evitare dispersione di forze .
Sulla hase di queste direttive fEsercito venne schierandosi con la r Armata dallo Stelvio alla Val Cismon, con compiti difensivi, con la 4" dalla Val Cismon al monte Peralba con compiti offensivi in direzione di Dobbiaco, la 2" e la 3' con compiti offensivi sull'Isonzo.
Questa impostazione strategica , inoltre, derivava dalla considerazione della scarsa remuneratività e dalla impossibilità di condurre operazioni di ampio respiro in un terreno difficile quale quello alpino. in special modo nella stagione invernale, e, d 'a ltra parte , i due unici precedenti. quali la traversata dello Spluga operata dal Corpo di MacDonald nell'inverno del 1800 e lo scavalcamento del Colle del Gran San Bernardo da parte di Napoleone nel maggio dello stesso anno, erano imprese più di carattere logistico che vere e proprie operazioni.
Da un punto cli vista organico, poi , a livello di battaglione Alpino esistevano come sciato1i solo quei pochi e lementi che, sulla base della pubblicazione n. 39 Istruzione sutruso degli ski ed. 1908'-16 avevano svolto l'a pposito corso.
Elementi che , nel settore Va ltellina - Val Camonica. in virtù delle caratteristiche ambientali che ne favorivano !"impiego, verranno via via raggrnppati in unità di livello sempre maggiore fino a raggiungere il rango di battaglione.
Prima di addentrarci nel racconto dei principali fatti cl'arme che videro tra i protagonisti anche e soprattutto gli sciatori, è opportuno dare uno sguardo a quella che fu l'evoluzione organica dei reparti , i corsi che vennero istituiti, gli equipaggiamenti e la dottrina d'impiego che venne adottata. -i<>cfr. Documento n. 3 già citato.
2. L'evoluzione o r g anic a, i corsi , gli equipaggiamenti e la dottrina d'impie go .
Con il sopraggiungere del primo inverno di guerra, st:ibilizzatosi il fronte montano su posizioni forti, sorse la necessità cli far soggiornare delle truppe in alta montagna per vigilare i valichi e le località che rivestivano una notevole importanza strategica, di assicurare l'esplorazione vicina ed i collegamenti tra i Comandi ed infine di poter contrapporre a reparti sciatoli avversari elementi dalle medesime caratteristiche.
Per fronteggiare questa situazione, iJ Comando Supremo era stato indotto ad aumentare in maniera considerevole il numero degli sciatori previsto dalla mobilitazione, la cui entilà era stata determinata sulla base del criterio di operazioni in alta montagna di po1tata notevolmente inferiore a quella che si stava concretizzando.
Pertanto sin dal settembre del 1915, con la circolare n. 4623-+', a firma del Sotto Capo di SM, il Comando Supremo stabilì che i reparti eia montagna, dell'Artiglieria da fortezza, del Genio. della Regia Guard ia di Finanza ed i battaglioni di frontiera raddoppiassero l'entità delle pattuglie; che i reggimenti di Fanteria e dei Bersaglieri dislocati in zone innevate assegnassero ad ogni battaglione una pattuglia di sciatori di 6 uomini. Comandante compreso; che i battaglioni Alpini dell'Esercito Permanente, oltre a raddoppiare la consistenza delle pattuglie, costituissero un plotone tattico di 70 sciatori agli ordini di un Ufficiale suba lterno: infine che, inverno durante, fosse istruito il personale necessario per la costituzione cli altri 26 plotoni da assegnare ai battaglioni Alpini della Milizia Territoriale.
Ogni plotone dì sciatori clei battaglioni Alpini dell'Eserc ito
Permanente doveva , inoltre, comprendere anche il personale idoneo all'impiego di almeno una mitragliatrice , arma indispensabile , in determinate situaz ioni tattiche, per garantire il necessario supporto di fuoco all'unità stessa.
La circolare comprendeva quindi le disposizioni per l'avvio di corsi regolari organizzati a cura del Comando Supremo d'intesa
~"cfr. Documento n. 6: circolare n. 4623 ciel 20 settembre 1915 CU O.M.) Skiatori per la prossima campagna inuemale.
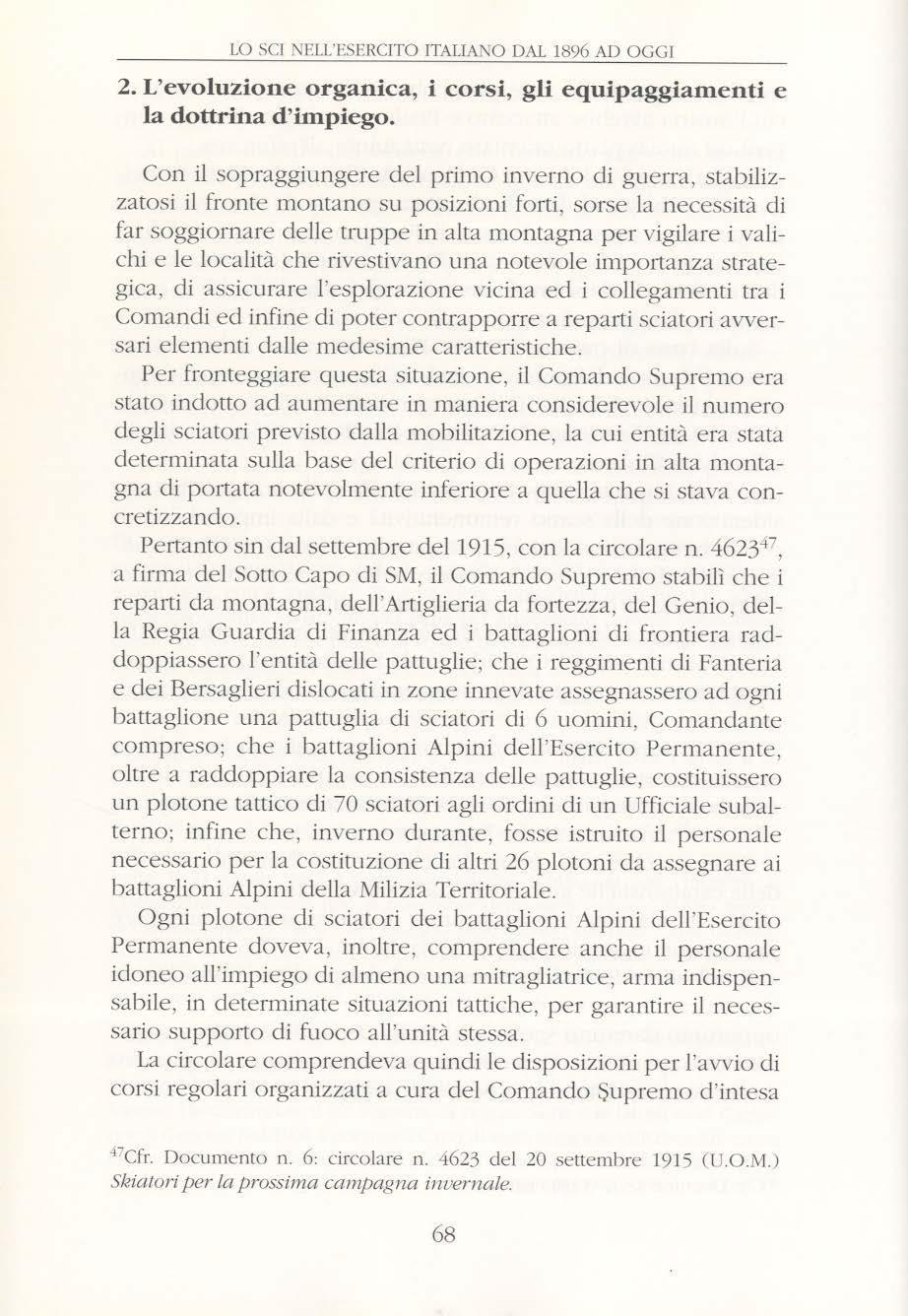
con il Ministero della Guerra ed indicava che, per gli istruttori, ci si sarebbe avvalsi del contributo di ottimi sciat01i scelti fra i valligiani ed i numerosi soci di Sci Club.
Infine si definiva l'eqLiipaggiamento che ogni sciatore doveva avere come complemento a quello normale di ogni soldato .
Con la circolare n. 5001 del 30 settembre 1915 (ll.0.M.) Indennità speciale per skiaton-48 , venne stabilito che agli Ufficiali, ai Sottufficiali ed ai Militari di truppa che intervenissero ai corsi venisse corrisposta, per tutta la durata del corso, un"idennità speciale pari all'assegno di cui godevano coloro che si trovavano in zona di gueITa.
I corsi si tennero principalmente nelle Alpi Occidentali presso il Colle di Tenda, Il Piccolo San Bernardo, la Valle del Gesso, l'alta Valle d'Aosta. la Thuille, Morgeux, Ulzio e nelle vicinanze di alcuni rifugi posti in prossimità della linea di combattimento come il Rifugio Garibaldi.
Va sottolineato che questi non furono dei corsi con tutti i crismi dell'ufficialità, ma trovarono la loro realizzazione grazie all'apporto di alcuni Ufficiali appassionati ed alla fattiva collaborazione del CAI e dei vari Sci Cluh, ad esso collegati, che misero a disposizione personale ed infrastrutture.
li primo corso ebbe luogo presso l'O::;pizio del Piccolo San Bernardo, alla testata della Valle Dora di La Thuile con Cesare Maggi e Piero Ghiglione come istruttori; un altro, sotto la direzione del Capitano Manzini e del Tenente Mezzalama, si svolse presso la ex casa di caccia Vittorio Emanuele II alla testata della Valle di Champocher in Valle d'Aosta .
Altri corsi vennero tenuti neì primi mesi del 1916 a Bardonecchia, a Clavière ed al valico del Monginevro.
Nello stesso periodo il crescente numero di sciat01i ottenuti da questi corsi aveva permesso cli apportare delle significative varianti organiche all ' ordinamento dei battaglioni Alpini con la costituzione, in essi, di plotoni sciatori.
Ma il vero impulso che lasciava trasparire una particolare attenzione <la parte del Comando Supremo a questa nuova specialità venne dato dalla circolare n. 28750 del 14 settembre 1916 18 Cfr. Documcmo n 7: circolare n. 5001 <ld 30 ~e tt e mhre 1915 (U.0.M.) Indennità speciale per skiatori.
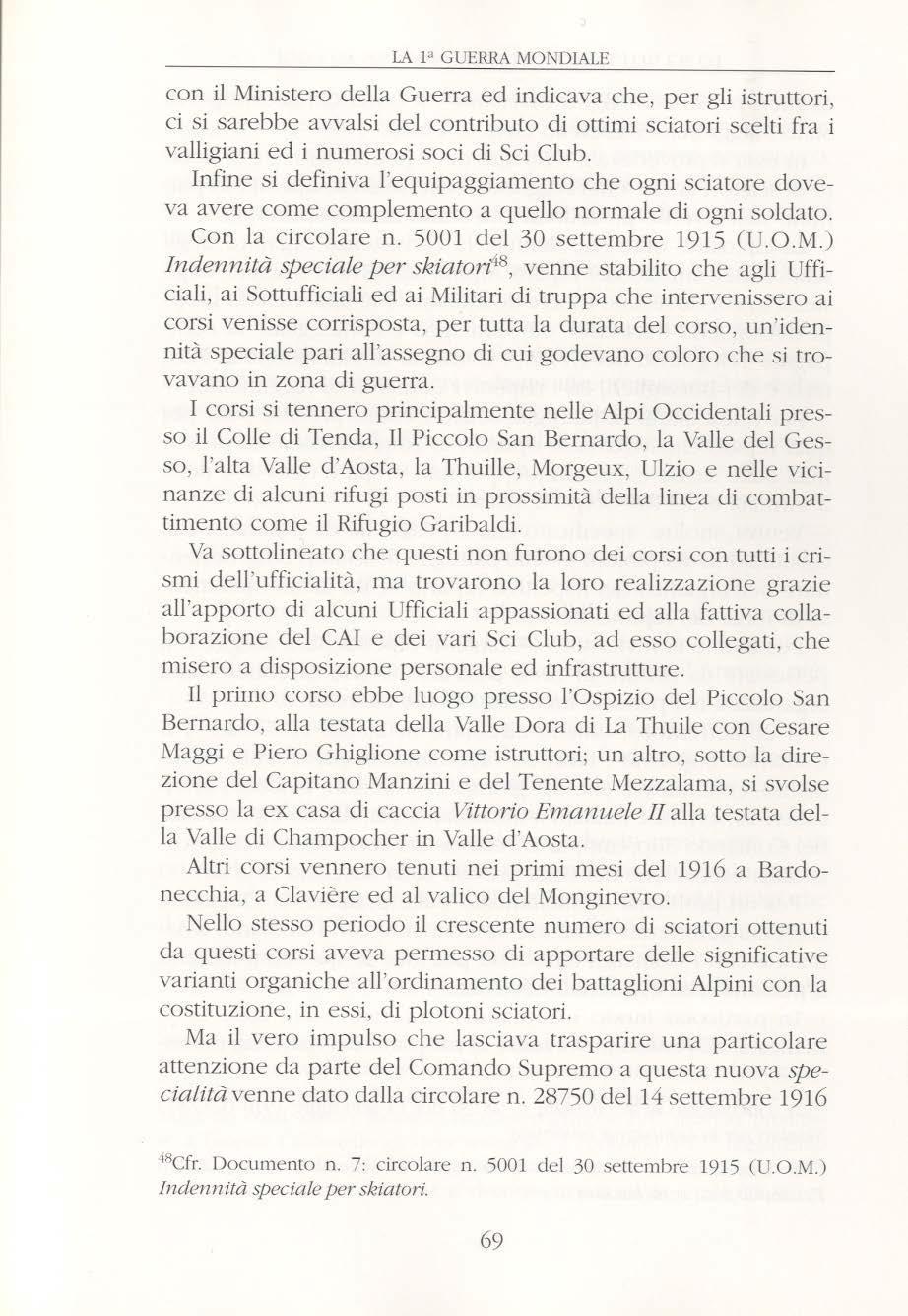
Skiatori per la campag;~a inverna!r!19 a firma del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen. C. Porro.
In essa si prevedeva il reintegro delle perdite subite e di dotare di sciatori anche quei reggimenti che, avendo operato in pianura ne!rinverno precedente, ne erano rimasti sprovvisti.
La circolare, oltre che definire la consistenza organica degli sciatori nell'ambito dei reparti Alpini, stabiliva il numero degli stessi di cui dovevano essere dotar.e anche le batterie ed i gruppi d'Artiglieria d'Assedio, da Montagna e Someggiata, le compagnie Telegrafisti del Genio, i Comandi di battaglione di Fanteria e dei Bersaglieri, ed i rispettivi Comandi di reggimento.
Per quest'ultimi le pattuglie sciatori erano previste solo per quei reparti che avrebbero operato in zone nevose o in prossimità delle stesse e, comunque, per rutti i reparti della 1" e della 2· Armata e del XII Corpo d 'Armata.
Veniva, inoltre, specificato che il personale da destinarsi alla costituzione dei plotoni e delle pattuglie di sciatori doveva rientrare nell 'o rganico del rispettivo reparto senza alcun incremento di forza del reparto stesso.
Per u !timo si invitavano i Comandi dipendenti a scegliere il personale da inviare ai corsi d'istruzione che sarebbero stati organizzati nel periodo immediatamente successivo.
Il 26 settembre, con la circolare n . 29478 (U.0.M.) 50 , il Comando Supremo , facendo riferimento al precedente documento, comunicava che dal giorno 27 a Torino, in Corso Moncalie1i 10, avrebbe iniziato a funzionare, alla diretta dipendenza del Comando Supremo, la Direzione dei corsi skiatori incaricata dalla esecuzione dei corsi previsti dalla succitata circolare.
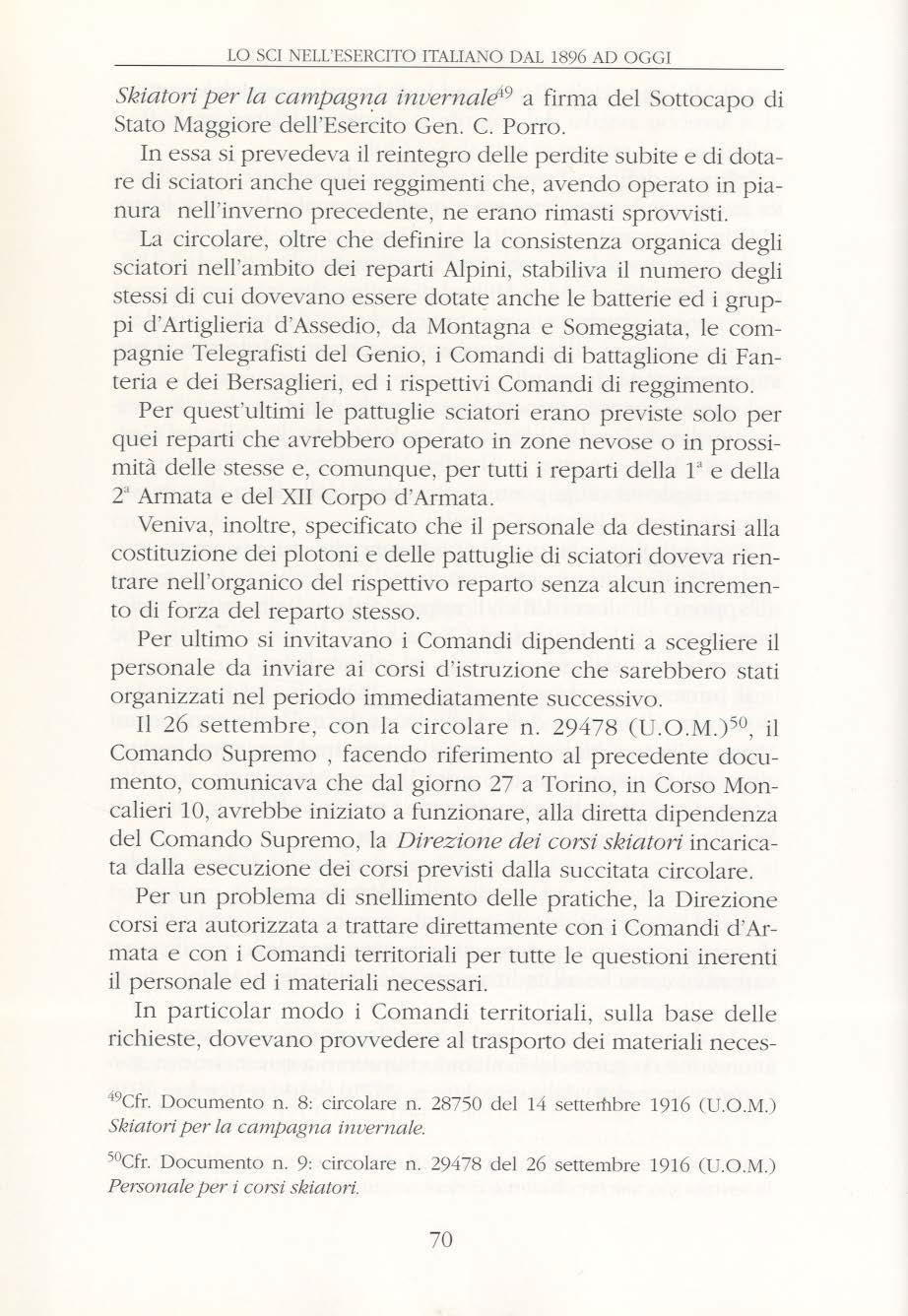
Per un problema di snellimento delle pratiche, la Direzione corsi era autorizzata a trattare direttamente con i Comandi d'Armata e con i Comandi territoriali per tutte le questioni inerenti il personale ed i materiali necessari.
In particolar modo i Comandi territoriali, sulla base delle richieste, dovevano provvedere al trasporto dei materiali neces-
49 Cfr. Documento n. 8: circolare n. 28750 del 14 setterhbre 1916 CU.0.M.) Skiatori per la campagna invernale.
5°Cfr. Documento n. 9: circo lare n. 29478 del 26 settembre 191 6 (U.0.M ) Personale per i corsi skiatori.
sari per l'impianto dei distaccamenti (stufe, materiali di casermaggio, materiale per cucine, ecc.), a fornire il personale strettamente necessario per le incombenze di carattere economico , quelJo sanitario e relativi materiali, personale di cucina ed infine personale per la riparazione degli sci e addetto ai materiali vari.
La direzione dei corsi era affidata a l Maggiore Umberto Mautino51 del 3° reggimento Alpini.
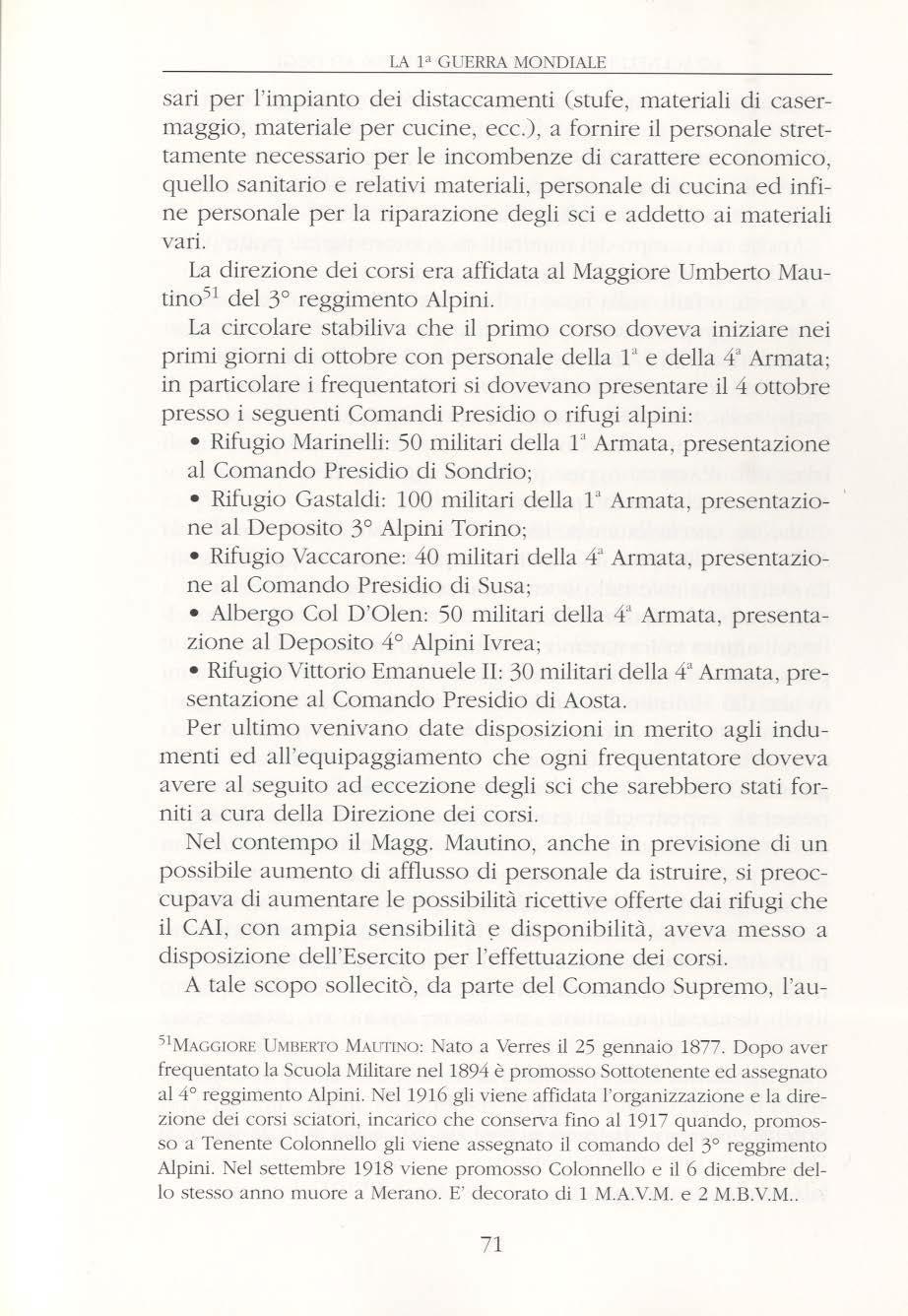
La circolare slabiliva che il primo corso doveva iniziare nei primi giorni di ottobre con personale della l" e della 4• Armata; in particolare i frequentatori si dovevano presentare il 4 ottobre presso i seguenti Comandi Presidio o rifugi alpini:
• Rifugio Marinelli: 50 militari della ll Armata, presentazione al Comando Presidio di Sondrio;
• Rifugio Gastaldi: 100 militari della 1'1 Armata, presentazione al Deposito 3° Alpini Torino;
• Rifugio Vaccarone: 40 militari della 4" Armata, presentazione al Comando Presidio di Susa;
• Albergo Col D'Olen: 50 militari della 4" Armata , presentazione al Deposito 4° Alpini Ivrea;
• Rifugio Vittorio Emanue le II: 30 militari della 4• Armata, presentazione al Comando Presidio di Aosta.
Per ultimo venivano date disposizioni in merito ag li indumenti ed aH'equipaggiamento che ogni frequentatore doveva avere al seguito ad eccezione degli sci che sarebbero stati forniti a cura della Direzione dei corsi.
Nel contempo il Magg. Mautino , anche in previsione di un possibile aumento di afflusso di personale da istruire, si preoccupa va di aumentare le possibilità ricettive offerte dai rifugi che il CAI, con ampia sensibilità disponibilità , aveva messo a disposizione dell ' Esercito per l'effeLtuazione dei corsi.
A tale scopo sollecitò, da parte del Comando Supremo, l'au-
51 MA GG TOR t: U~mrnTo Mi\ t.rnNo : :t\'ato a Verres il 25 gennaio 1877. Dopo aver frequentato la Scuola Militare nel 1894 è promosso Sottotcncmc ed assegnato al 4° reggimento Alpini. Ne l 1916 g li vien e affidata l'organizzazione e la direzione de i corsi s ciatori, incarico che conserva fino al 1917 quando, promosso a Tenente Co lonnello gli viene assegnato il comando del 3 ° reggimento Alpini. Ne l settembre 1918 viene promosso Colonnel lo e il 6 dicembre dello stesso anno muore a Mernno. E' decorato cli 1 t'vl.A.V.M. e 2 M.B.V.M
torizzazione ~1 costruire ad economia presso il Rffugio Gastaldi una baracca in grado di contenere confortevolmente <t8 uomini. le cui caratteristiche tecniche furono illustrale con un promemoria:;2 indirizzato al Tenenle Colonnello di SM Vacca-.Maggiolini nei primi giorni di sett<:mbre.
Anche nel campo dd materiali da sciatore venne posta panicolare cura da pane del ~Iagg. i\tautino.
Questi, infatti. sulla base dell'esperienza maturata durante la prima campagna invernale e dall'applicazione delle varie norme emanate dal Comando Supremo e dall'Intendenza Generale, aveva constatato che il recupero cli tutti i materiali speciali sparsi nella zona delle operazioni aveva permesso di riordinarli e farli riparare ad economia. per i piccoli guasti. dai singoli Jaboracori d'Armata e. per quelli di maggior entità, dal laboratorio centrale che si era costituito a Torino. inoltre. con la lettera n. 1881 del 29 ottobre 1916 Hateriafi da Skiaton-53 sollecita,·a il Comando Supremo. anche per la seconda campagna invernale. a tenere accentrati questi materiali ed a fare in modo tale che le richieste cli materiali. facenti parte dell'equipaggiamento ,;;peciale indi\ iduale <la sciatore e delle serie per reparti tattici. fossero soddisfatte in seguito alle ordinazioni rivolte dal Ministero esclusivamente al Laboratorio Equipaggiamento Indumenti Invernali sito presso la Direzione Corsi Skiatori in via ~loncalieri 10 a Torino; questa necessità trm·ava la ..,ua giustificazione nel fallo che solo presso tale Ente si trovava il pert>onale espctto ed in grado di giudicare che il materiale fosse il rnigliore da un punto di vista tecnico ed acquistato ad un giuMo prezzo.
Con determinazione del Ministro della Guerra, nel novembre dello stes!:>o anno, veniva. inoltre, modificata la pubblicazione n . .39 l,;truzione sul/ ·uso degli skz"' 'nella pane che riguarda,·a la nomina ed il distintivo da skiatore scelto, prevedendo quauro livel li di classifica: cattivo, mediocre, buono ed ottimo: quc-
' 2Cfr. DocumL'nto n. 10 Promemorw dr sen:izio per il Te11 Col. di S.lf Gat. Vacca-Maggiolini della Din:1.ione Cor-.i ~kiatori.

'iiCfr. Documento n. 11 k:ttera n. 1881 del 29 occobre 1916 .lfateriali da Skiatori della Om.:zione Corsi Skiatori.
''Cfr. Documento n. 3 gi~1 citato. .....) I -
st'ultima valutazione, alla quale potevano aspirare sia gli appartenenti alle truppe da montagna che quelli delle altre Armi e Corpi, non prevedeva più la limitazione di numero, il titolo di tiratori scelti e la consegna di un diploma, ma il solo distintivo da portare sulla manica destra della giubba e la pubblicazione sull"Ordine del giorno reggimentale.
Come già si è accennato i rapporti con il CAI e gli Sci Club erano ouimi e si basavano sulla reciproca collaborazione; è indubbio, tra l'altro, che all 'ano della mobilitazione i primi sciatori utilizzati nei reparti, oltre i quattro previsti dalla pubblicazione n. 39 del 1908, furono tratti da quel personale che, prima dell'arruolamento. praticava già Jo sci a livello di disciplina sportiva o per proprio diletto.
In occasione dei primi corsi tenuti nel primo inverno di guerra, poi, il CAI e gli Sci Club avevano contribuito in maniera tanto efficace quanto entusiastica mettendo a disposizione i loro rifugi ed il p e rsonale istruttore .
Con molta lungimiranza nell'autunno del ' 16 lo Sci Club di Torino, tramite la Direzione Corsi, aveva scriuo al Comando Supremo di avere l'intenzione di organizzare dei corsi di insegnamento della pratica sciistica ai montanari; in particolar modo i corsi avrebbero riguardato glì abitanti della Val di Susa e, comunque, quelli delle classi soggette quanto prima agli obblighi di leva (1895 e 1896).
Lo Sci Club, ottenuto il benestare e l'appoggio del Comando Supremo, si sarebbe, inoltre , fatto parte diligente per interessare le Autorità prefenizie e comunali della valle prescelta per dar vita alla necessaria opera di propaganda.

L'intensificarsi dell'isrruzione sciistica indusse il Magg. Maurino a chiedere, il 4 gennaio 1917, alle Autorità SupeJio1i di effettuare un censimento fra tutti i militari adibiti ad incarichi vari in Zona Territotiale per verificare se vi fossero dei buoni sciato1i addestrati dagli Sci Club prima della chiamata alle armi.
I dati raccolti tra le reclute del 1897, le Regie Guardie di Finanza ed i Reali Carabinieri avrebbero potuto fornire un contingente che, anche se modesto , sarebbe tornato uti le sia come sottoistruttori ai corsi che per essere destinato ai reparti sciatori di eve n tua le formazione.
Il 5 gennaio 1917 il Comando Supremo emanava, a firma de l
Souocapo di SM dell'Esercito Gen. C. Porro, la circolare n.58760 Skiatorz55 .
In essa si ordinava che i battaglioni Alpini dessero il massimo sviluppo all'addestramento degli sciatori: ciò anebbe dovuto realizzarsi a cura dei battaglioni stessi utilizzando i campi cli neve siti nelle vicinanze e servendosi. in qualità di istruttori. di Ufficiali e di personale di Truppa già addestrato all'uso degli sci; i Comand i d'Armata, inoltre. erano autorizzati ad organizzare addestramenti per gruppi di battaglione utilizzando così promiscuamente del personale isLruilo dei battaglioni stessi.
La circolare, nell'informare che alla fine di gennaio i plotoni sciatori dei battaglioni Alpini sarebbero stali ritirati per ordine del Capo di SM lasciando a ciascun Comando la sola pattuglia prevista dalla circolare n. 28750 56 stabili\ a che le unità Alpine avrebbero dovuto fare esclusivo affidamento sulle pattuglie dei Comandi di gruppo. di battaglione e delle compagnie la cui entità veni\·a definita in:
• Comando di compagnia Alpini: 2 pattuglie di 8 uomini (graduaci e soldati) ciascuna:
• Comando di battaglione Alpini: 1 sottufficiale e 12 sciatori;
• Comando di gruppo Alpini: 2 pattuglie di 16 sciatori ciascuna.
Con tali forze comunque i Comandami di battaglione avrebbero avuto ~empre la possibilità di formare, eventualmente riunendole, 1 plotone di 60 sciatori.
Veniva stabilito che il personale che stava frequentando il corso presso la frontiera occidentale e il cui rientro ai Corpi era previsto per il 15 gennaio \'enisse trattenuto in pa11i proporzionali fra le Armate per costituire le sezioni mitragliatrici speciali; in ultimo, il personale dei corsi previsti per gennaio e febbraio, al termine degli stessi. non sarebbe rientrato ai rispettivi bauaglioni. ma sarebbe rimasto a disprn,izione del Comando Supremo.
Tuttavia per non depauperare eccessivamente i battaglioni. la circolare prevedeva l'organizzazione di Lre nuovi corsi d'istruzione, denominati rispettivamente 1° bis, 2° bis e 3° bis di dura-
,;~Cfr. Documento n. 12: circolare n. 58760 del 5 gennaio 19 L7 (l'.O .M.) Skiatori
""Cfr. Documento n. 8 già cirnro.

ta di circa 40 giorni, a cui avrebbero preso parte circa 600 frequentatori scelti esclusivamente fra gli Alpini.
Infine il documento delineava le condizioni di efficienza richieste per i plotoni che sarebbero stati ritirati , definendone la forza e l'annamento 57 e stabilendo che, a cura dei reparti alpini di provenienza, tutto il personale dei plotoni dovesse essere perfezionato nell'impiego efficace delle pistole-mitragliatrici58 .
Per l'approvvigionamento delle slitte per le pistole-mitragliatrici i Comandi d'Armata erano autorizzati ad inoltrare direttamente le richieste all'Intendenza Generale mentre all'organizzazione clelJe sezioni mitragliatrici ordinarie (Fiat 1914 someggiate-slittate) avrebbe provveduto direttamente il Comando Supremo.
Il 3 febbraio 1917 , con la circolare n 63625 (G.0.M.) Costituzione delle unità skiatori59 , il Comando Supremo concretò l'ordinamento del plotone, della compagnia e del battaglione sciatori con i seguenti organici:
• plotone su: Comandante, un sottufficiale, quattro squadre di sciatori armati di moschetto mod. 91, due squadre per pistola-mitragliatrice (un'arma per squadra); per un tolale cli 1 Ufficiale, 1 sottufficiale, 63 militari di truppa, 2 pistole-mitragliatrici, 6 slitte (4 per le squadre pistole-mitragliatrici e 2 slitte-barelle);
• compagnia su: Comandante, tre plotoni ed una sezione mitragliatrici; per un totale di 7 Ufficiali (Comandante, 1 Ufficiale per i servizi di pattuglia. 1 Ufficiale Medico, 3 Comandanti cli plotone , 1 Comandante cli sezione mitragliatrici), 234 militari di truppa, 6 pistole-mitragliatrici e 2 mitragliatrici;
5- I repa1ti Alpini avevano in distribuzione. quale a1ma individuale. il fucile modello 1891; agli sciatoti dei plotoni che. sulla base della circolare n. 58760 del 5 gennaio 1917 vennero ritirati dai harraglioni Alpini. venne dato il moscbello. versione corta del '91 realizzata. inizialmente, per la Cavalleria e per le truppe speciali.
' 8 L'Esercito aveva in dotazione la pistola-mitraglìatrice Vi!/ar Perosa mod. 1915 ca!. 9 mm. C/isenli. Era un 'a rma dotala di due canne indipendenti in grado cli sparare circa 1200 colpi al minuto, era clorata di scudo smontabile e venne impiegata su larga scala durante la 1" Guerra Mondiale.
9 Cfr. Documento n. 13: circolare n. 63625 del 3 febbraio (ll.O.M.) Costituzione delle unità skiatori.

• battaglione su: un Comandante. un Comando ( 1 l-fficialc, 4 militari di truppa tratti dalle compagnie) . due compagnie ed una salmeria di compagnia alpina; pari a 16 Ufficiali, 513 militari di truppa, '0 quadrupedi, 16 mitraglialrici, -2 slitte e 7 carrette.
Sulla base di queMi organici vennero, tra il febbraio cd il marzo dello stesso anno, coslituiti 12 battaglioni sciatori su 2'± compagnie e 2 compagnie autonome.
Questi reparti di nuova costituzione vennero così assegnati alle Armate:
• 1· Armata: I battaglione o · e 9 ' compagnia>
II battaglione (2" e 10• compagnia)
III baltaglionc (11'' e 25' compagnia)
I\" battaglione (12 e 13~ compagnia)
24• cornpagnia autonoma;

• 2·· Armata: XII barcaglione (26' e 18"' compagnia):
• --r' Am1ata: IX battaglione (8' e 23• compagnia)
X banaglionc (T' e 21 " compagnia)
22· compagnia autonoma:
• 6. Armala: V bauaglione (3" e -+J compagnia)
VI baltaglione (14 ' e 15 ' compagnia)
\1 I battaglione (5• e 6 compagnia)
VIII ba tt aglione (19·· e 20· ' compagnia);
• ,II C.A.: XI battaglione 06 e 17' compagnia).
La Direzione dei corsi sciatori, oltre alla preparazione Lec.:nica ciel personale pro\Tedeva al collaudo dei materiali -;pedali occorrenti alla num a specialità. alJa loro omologazione, alla slcs u ra dei relativi manuali d'impiego cd all'a<ldesLramento su l loro uso.
fl 6 febbraio 1917, la Direzione corsi inviava al Comando Supremo, con la leuera n. ';016 lslruzioniper il monla!!J!,io e fuso di 11wleriali speciali distribuiti ai reparti tafficfi:\ dei manuali con la descrizione e le istruzioni per il montaggio e l'uso della slitta su <;ci Lipo Boido nelle \'Crsioni: per trasporto feriti. per traino di pistole-mitragliatrici, per tiro e traino di mitraglialrici tipo 1911 e tipo I911 e per trasporto di matet"iali vari, infor-
1i0cfr. Oocumento n. I 1: lette ra n 5016 del 6 fehhraio 1917 Tstm z ioni per il m o nlaf.!.RiO e /"uso di materiali speciali clistribuit, ai reparti tattìc..1
mandolo che un adeguato numero di copie era già stata inviata alle Armate ed alle Intendenze delle Armate più interessate per la successiva distribuzione ai reparti tattici dipendenti.
Questi manuali, concepiti per rendere il più semplice possibile l'uso de.I materiale, erano composti da tre parti: la prima in cui era descritta la slitta in tutte le sue parti componenti, la seconda nella quale il materiale era illustrato fotograficamente ed, infine, la terza contenente le istruzioni per il montaggio, il traino ed il tiro nelle versioni per le anni automatiche.
Anche le uniformi per gli sciatori erano soggette ad un continuo studio ed aggiornamento per renderle il più aderenti possibile alle necessità della gueITa in alta montagna.
Fin dal primo inverno di guerra infatti, si era posto il problema delradeguamento cromatico delle uniformi all'ambiente circostante, risolto inizialmente ed in via del tutto empirica, da parte dei componenti della Centuria Valtellina6 1 , con la sovrapposizione della seconda camicia, bianca, sulla divisa grigio-verde.
Tuttavia per risolvere in maniera uniforme il problema, venne istituita a Milano una speciale commissione che, dopo vari srudi ed esperienze, propose l'impiego di "tute mirnetiche. ovvero sopravesti bianche per sciatori in tela resistente, composte da pantaloni, giubba e cappuccio di colore bianco".
Organizzati i corsi, definiti gli organici e scelti i matelialL il Comando Supremo, sulla base delle esperienze fin qui maturate, il 18 febbraio 1917 emanò la circolare n. 4200 Criteri d'impiego dei ripartì skiatori di Affari Vari e Segreteria62 , con la quale, aJ fine di dare un indirizzo unico all'impiego degli sciatori, si fissavano i concetti generali a cui ispirarsi.
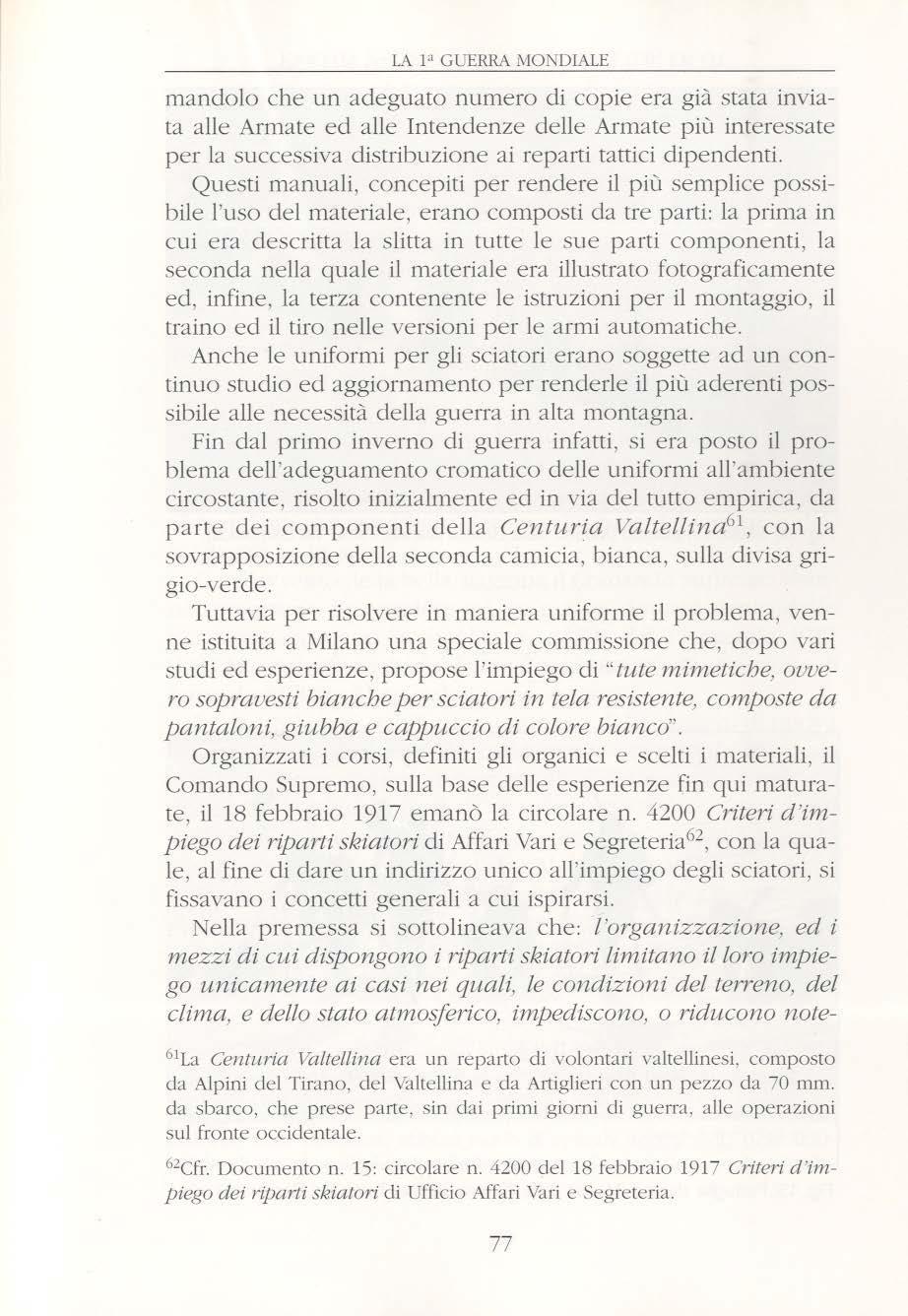
Nella premessa si sottolineava che: /'organizzazione, ed i mezzi di cui dispongono i ripa,1i skiatori limitano il loro impiego unicamente ai casi nei quali, le condizioni del terreno. del clima , e dello stato atmosferico. irnpediscono, o riducono note-
61La Cellfllria Valtellina era un reparto di volontari \·altellinesi, composto da Alpini del Tirano. del Vallellina e da Artiglieri con un pezzo da 70 mm. da sbarco, che prese parte. sin dai primi giorni di guerra, alle operazioni sul fronte occidentale.
6 2Cfr. Documento n. 15: circolare n. 4200 ciel 18 febbraio 1917 Criteri d ·;111piego dei riparti skia/01·i di Ufficio Affari Vari e Segreteria.
Guerra d1 redenzione - Bolzo in v nf, (f 8to( u
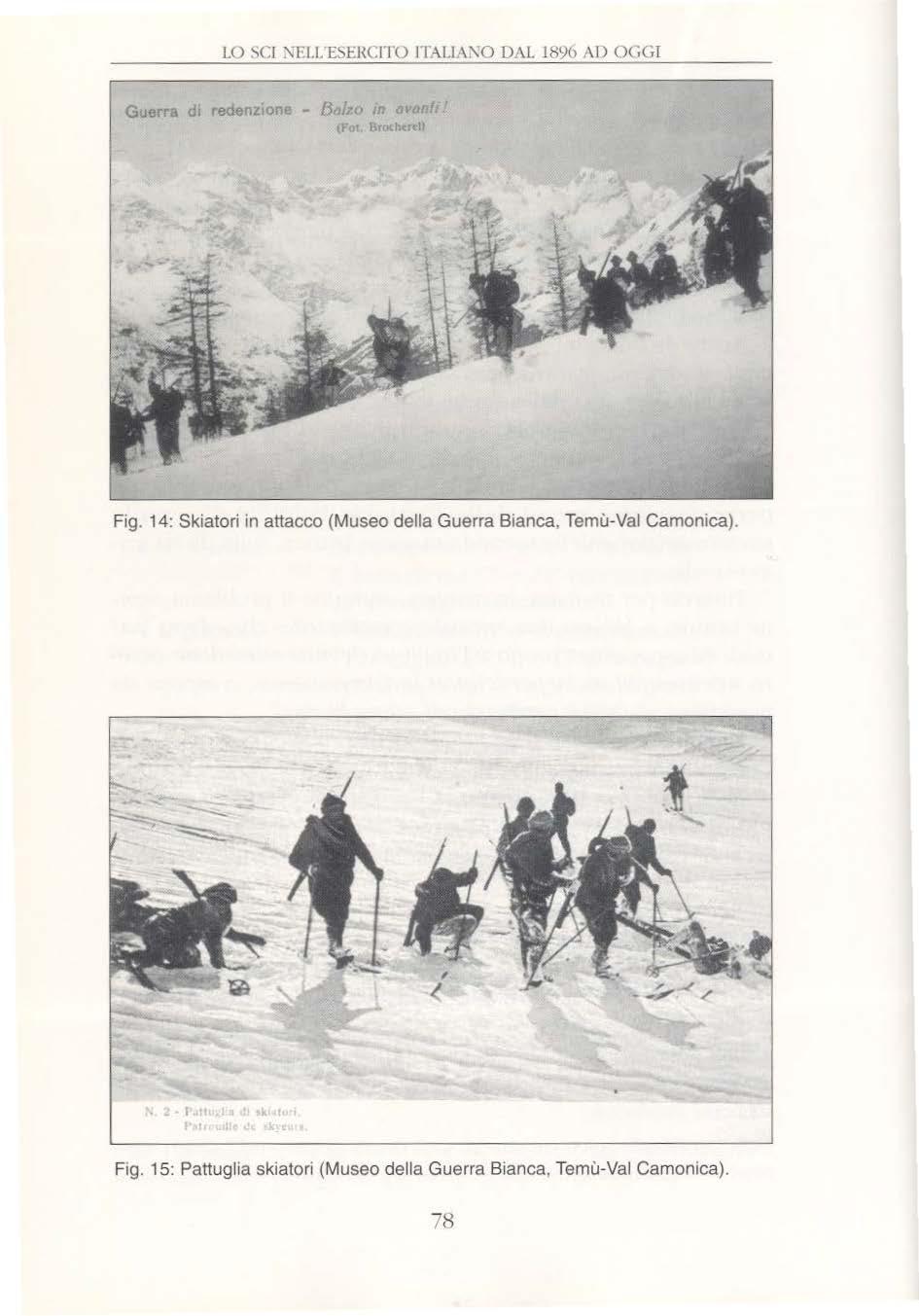
uobnente, l'azione delle altre truppe da montagna. Impiegare tali riparti in ordinari attacchi di salde posizioni, rafforzate da efficienti difese accessorie, od a presidiare stabilmente e permanentemente posizioni conquistate, anche se di difficile accesso, costituirebbe uno sciupio deplorevole di elementi preziosi di non agevole rifornimento.
La filosofia che stava alla base del documento era, quindi, orientata sul concetto di un ,impiego delle unità sciatori prevalentemente offensivo ed altamente selettivo, prevedendo azioni limitate nel tempo, condotte con estrema decisione. celerità e sorpresa; la difesa era considerata contingente e, comunque, limitata al tempo strettamente necessario all'afflusso di altre truppe destinate ad assumere la responsabilità delle posizioni stesse; le formazioni da assumere in campo tattico, seppure ilh.1strate sommariamente, erano lasciate aJla discrezionalità dei Comandanti che avrebbero deciso sulla base de l terreno e della situazione in atto.
Con l'avvento della bella stagione il Comando Supremo ritenne opportuno provvedere ad un nuovo riordinamento delle unità sciatoti e con la circolare n . 85583 del 15 maggio 1917
(L.O.M.) Scioglimento dei bauag!ioni skiatori - Costituzione di battaglioni Alpini63 ne stabili tempi e modi.
In particolare si stabilivano il numero di battaglioni di nuova formazione, la numerazione delle nuove compagnie chiamate alla loro formazione e si davano disposizioni sulle armi, sui materiali e sui quadrupedi.
I1 personale dei 12 battaglioni sciatori fu impiegato per la costituzione di 7 nuovi battaglioni Alpini (.Monte Pasubio, Monte Tonale, Monte Nero, Cuneo, Monte Marmolada, Courmayeur, Pallanza) che, nonostante le loro origini non operarono più come tali 64 , pur mantenendone, impropriamente, l'appellativo in onore delle loro origini.
63Cfr. Documento n. 16: circolare n. 85583 del 15 maggio 1917 (U.0.M.) Scioglimento dei hauaglioni skiatori - Costituzione di battaglioni Alpini.
64 Alcuni, impiegati su fronti m on tani come ad esempio il Monte Pasubio dislocato sulla Bainsizza, ebbe ro modo di operare ancora sulla neve utilzzando gli sci. ma più che altro limitatamente ad azioni di pattuglia e collegamento.

A quc-.ta_ristrumirazione fecero eccezione il r baltaglione sciator i ( l'' e 9• compagnia) ed il II bauaglione (2' e 10' compagnia) eh<.: il 22 fehhraio 1918, per ordine del Comando Supremo, dettero vita a due nuovi barraglioni: il Monle Ortler ed il }.1onle Ca\ ento.
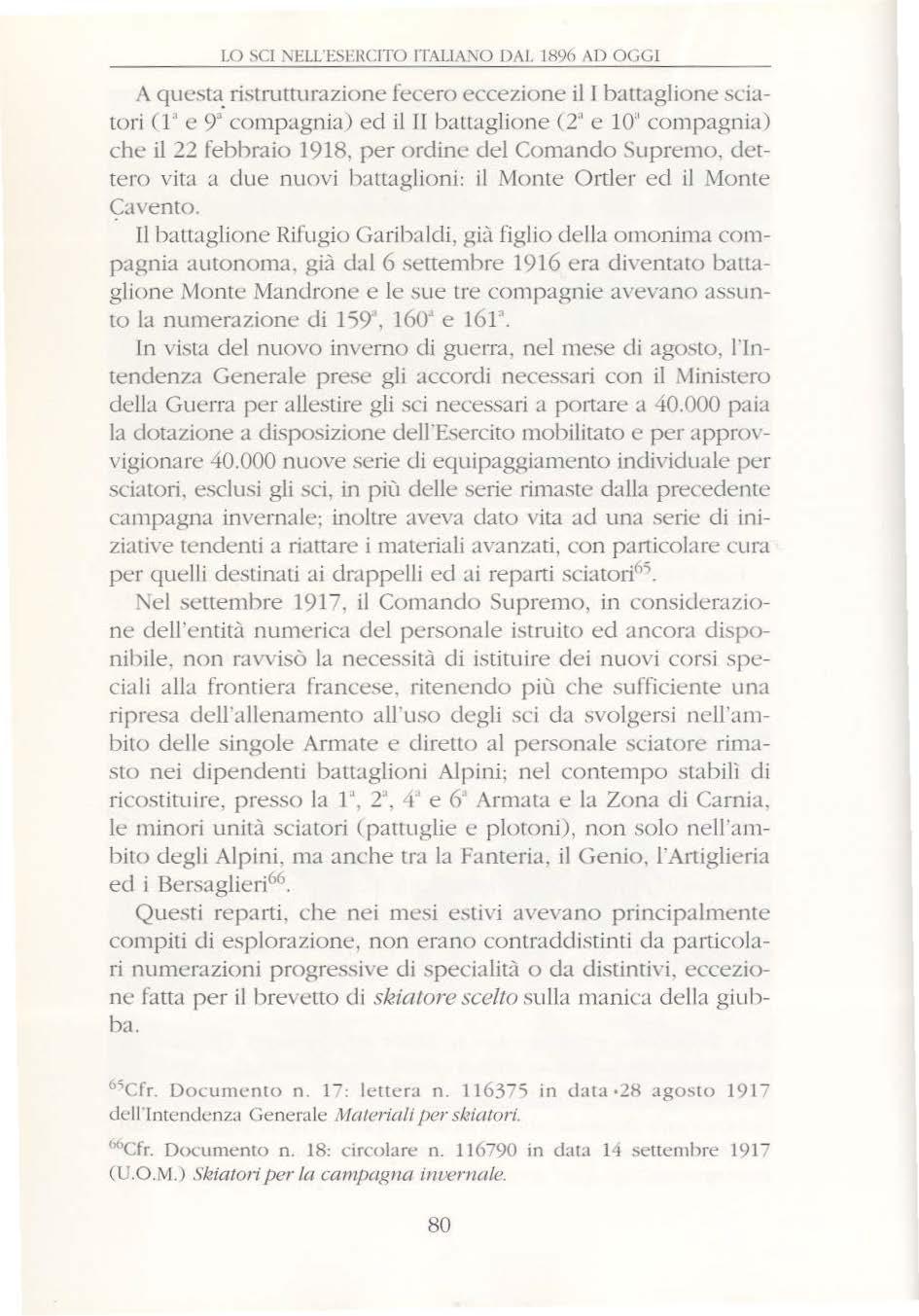
Il bauagl ione Rifugio Garibaldi, già figlio de lla omonima compagnia aulonoma, già dal 6 serremhre 1916 era diventato baltaglione Monte Mandrone e le '>Ue tre compagnie avevano assunto la nurnera7ione di 159,160' e 161.
In vbta del nuovo inverno cli guerra. nel mese cli ago-.Lo. l'Intendenza Generale prese gli accordi necessari con il \linistt:ro della Guerra per allestire gli sci necessari a portare a 40.000 paia la dotazione a disposizione dell'Esercito mohilirato e per apprO\vigionarc 40.000 nuove serie di equipaggiamento individuale per sciatori, esclusi gli sci, in più delle serie rimaste dalla precedenlc campagna invernale: inoltre aveva dato vita ad una serie di iniziative tendenli a riattare i materiali avanzati, con particolare cura per quelli deslinati ai drappelli ed ai repani c;ciatori"\
'\el settembre 1917. il Comando Supremo, in consic.leraz10ne dell'entilà numerica del personale istruilO ed ancora disponibile . non ravvisò la necessità di istituire dei nuovi corsi speciali alla frontiera francese. ritenendo più che sufficiente una riprec;a dell"allenamento all'uso degli sci da svolgersi nell'ambito delle singole Armare e dirello al personale sciatore rimasto nei dipendenti bauaglioni Alpini; nel contempo stabilì di ricostituire. presso la 1". 2 . 1 e 6 Armata e la Zona cli Carnia. le minori unità sciatori ( pattuglie e ploroni), non solo nell'ambito degli Alpini, ma anche tra la Fanteria, il Genio, l'Aniglieria ed i Bersaglieri66 .
Questi reparti. che nei mesi estivi m·evano principalmente compiti di esplorazione, non erano contraddistinti eia particolari numerazioni progressi\ e di specialità o da distintivi. eccezione fatta per il brevetto di skiatore scelto sulla manica del la giubba.
6 "Cfr. 00<.:unu:nto n. 1- : lett1:w n. 1163-:; in data•28 ago~to 1917 dell Intentll..!n:w Generale Materia/i per skiotori.
1''Cfr. Documento n. 18: circolare n. 116790 ìn data 1,1 :-.cttcmhre 1917 (L.0 M ) Skiatori per la campaw,a i1wemale.
3. Le operazioni sull'Adam e llo: "La guerra bianca".
L'alba del 24 maggio 1915 vide 41 battaglioni Alpini schierati nei punti più impervi della frontiera, dal passo dello Stelvio alle valli deJ Natisone e de lnsonzo, ma la zona che vide le maggiori imprese dei rep~uti sciatori fu, come abbiamo detto, la zona dell'Adamello, senza tuttavia dimenticare che gli sciatori agirono un po' su tutto il fronte, ma svolgendo principalmente piccole azioni di pattuglie e collegamenti.
In tale settore operativo, alle normali azioni svo lte dagli sciatori si aggiunsero due brillanti imprese, condotte in piena sintonia con le altre forze ivi presentL che rimasero memorabili per la loro temerarietà: la conquista del Monle Fumo nell'aprile del ·16 e quella del Corno di Ca vento nel giugno deJrl 7.
L'Adamello, dove si sviluppò la così detta guerra bianca è il grande massiccio che ~i estende a sud ciel passo del Tonale. all'origine della Val Camonica e della Val Chiese.
Il Generale Alherto Cavaciocchi 6 ~, Comandante della 5" Divisione, così lo descriveva nella sua monografia L'impresa dellAdamello: "Chi da Tennì in Va/camonica risalga la pittoresca Val d Avio e, superando tre successivi gardini, ghmga al r(fugio Garibaldi, si trouerà al centro di una chiostm montana racchiusa tra il Corno Baitone (3351 nz.). l'Adamello (3654 m.). la Cima Garibaldi e la Punta dei Frati (3383 m.): ine,picandosi poi sul margine orientale della chiostra ad uno dei passi che im mellono sul ghiacciaio (passo di Brizio. passo Garibaldi. passo del Veneroccolo), si troverà in presenza di un vasto tauoliere
67G1::--1:1w.E ALBJ:RTO CA\ACIOCCH J: Nato a Torino nel 1862: dopo aver frequentato l'Accademia è nominato Sottmenete d'Artiglieria nel 1881. con il grado di Capitano entra nel Corpo di SM e. nel 1897. è nominato insegnante alla Scuola di Guerra. Nel 1910. con il grado di Colonnello, comanda il 60° reggimento fanteria, con il qua le prende parte alla guerra italo-lllrca. meritandosi b Croce di l lfficiale dell'Ordine Militare. Promosso Maggior Generale. assume il comando della 13rigata Casale con la qua le partecipa alle operazioni in Libia nel 1913 meritandosi una Medaglia d'Argento al Valor Militare. quindi. nel 1914. comanda la Brigata Brescia. Nella 1a Guen-a Mondiale è Capo di SM della 3a Armata. qu indi Comandante della 5a Divisione, del VI e del TV Corpo d'Armata. Dopo la guerra assume l'incarico d i Ispeuore delle Scuole . E' autore cli numerose opere storiche ed arLicoli per le riviste militari. Muore a Torino nel 1925.
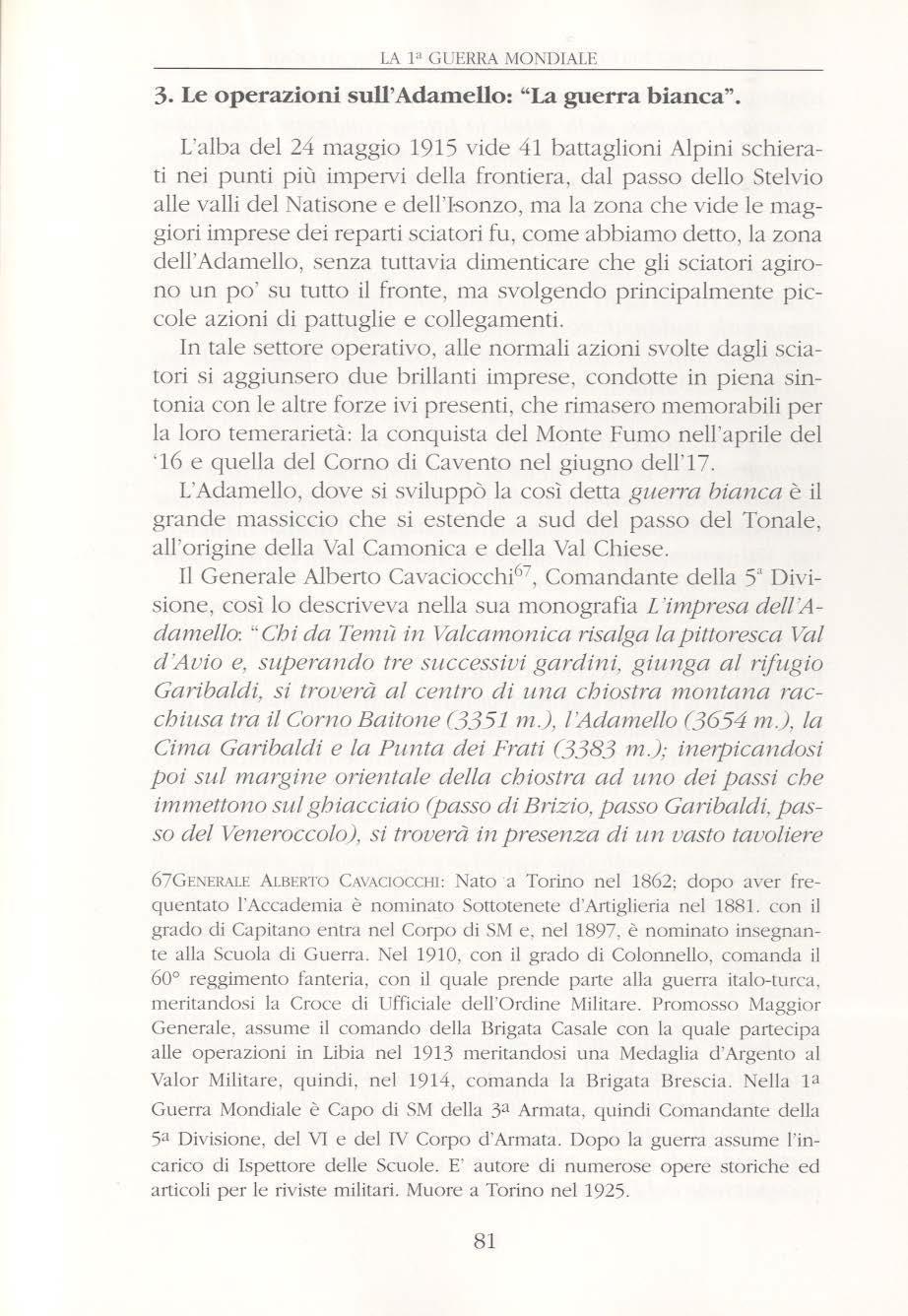
di ghiacc;o, inte1:çecato nel sensu dei meridiani da due successive catene rocciose, delle quali la prima comprende la Lobbia Bassa (2959 m.). la Lobbia Alta (3190 m.), la Cresta della Croce (3315 m.). il Dosson di Genova (3441 m.J e Jvlonte Fumo (3418 m.): la seconda il Me-nicigolo (2985 m.), il Crozzon di Fargorida (3082 111.J. il Crozzon di Lares (335·1 m.) ed il Corno di Cavenlo (3400 m.).
Quesle ed altre pizì o meno. cominue creste rocciose in senso trasversale suddividono l'immensa distesa di p,hiaccio in vari compartimenti. che prendono nomi diwrsi: Vedretta Pisf?a1-zt1. Fedretla del Mcmdrone. Ghiacciaio delf'Adamello. vedretta della Lobbia. l'edretta di Fargorida, vedrelfa di Lares e l'ia dicendo. il ghiacciaio dell'Adamello per la sua forma pianep,gianle caralleristica. è detto Pian di nel'e. A questo tal'oliere cli ghiaccio fa11110 capo, aumenlando l'importanza !altica, numerose l'alli: Val di Furno, Valle Adamè. Val Salanw. Val MilleJ: Val d'Al'io. Vàl ~'eneroccolo. l al dei Frati. Val .\arca11è. \ al di Genoz ·a e vari alt1i affluenti del Sarca" (ca1ta n. 2).
Delle tre creste rocciose gli Italiani occupavano quella più occidentale, gli Austriaci quella orientale mentre quella centrale rappresentava il vecchio confine.
Per Culto il 1915 le due parti contrapposte si limitarono a leggeri aggiustamenti delle rispettive posizioni in ossequio, gli It aliani, al concetto di assumere atteggiamento difensivo nel sa li ente trentino e limitare le a7.ioni offensive a quelle '-trettamcnte necessarie per migliorare le posizioni e le capacità difensive.
!\'ella notte del 3 aprile 1916 gli Austriaci. al fine cli raddoppiare le loro linee di difesa, occuparono la cresta centrale rafforzando in modo particolare la Lobbia Alta ed il Monte Fumo.
Il 7 aprile il lii Corpo d'Armata incitava la 5" Divisione a sollecicare J'anività in Valtellina telegrafando, tra l'altro: .. è però necessario impedire che il nemico occupi nuove posizioJ1i come fece per la Lohhia Alta. Al riguardo della quale conrnrrà non illdugiare, compatibilme77te coi preparativi indispensabili per assicurare il buon successo dell'impresa. ed attuare 12011 soltanto il colpo di mano progeflato dal Comandante del 4° Alpini per s01pre11dere il nuovo posto nemico. ma ancbe fa progettata occupazione del Dosson di Genoua e Monte Fumo· · .

Il Col. Carlo Giordana 68 , Comandante del 4° Alpini, affidò il compito a l Capitano Natalino Calvi 69 , Comandante della compagnia autonoma Garibaldi, mentre il Magg. Enrico Vitalini7° venne incaricato della d ir ezione e della coordinazione delle operaz ioni in tutt o il settore.
Pa1tito alle 23,30 dell'll aprile dal 1ifugio Garibaldi, all' una di notte il Cap. Ca lvi sbucò sul ghiacciaio daJ passo di Brizio; qui suddivise i suoi 220 scia tori inviando a sinistra, verso la Lobbia Alta ed iJ passo di Lobbia AJta, il Ten. Quadri con 70 uomini ed 1 mitragliatrice; al centro . contro la Cresta della Croce, il Ten. Attilio Calvi con 65 uomini: a destra verso il Dosson di Genova, il Sottotenente Del Culto con 40. Teneva una paltuglia di 15 sciawri al comando del Sergente Carrara all'estrema destrn con il compito di fiancheggiare e prendere collegamento con la compagnia dei Yolontad che proveniva dalla Valle Adamè e dalla Valle Salarno. Un ultimo nucleo di circa 30 sciatori al comando del Sottotenente Bartesaghi era in riserva a disposizione del Capitano (carta n. 3).
68COLONNELW CARLO G10RDA'\A: Nalo a Genova il 10 marzo 1871. dopo aver frequentato la Scuola Militare è promosso Sottotenente il 3 agosto 1891, con il grado di Tenente panecipa nel 1995-96 alla gue1Ta in Eritre;.i. ?'-Jel 1912 panec ip a con il grado d i Maggiore alla guerra italo-t1.1rc:_1. Rientra in Italia ne l 191--i con il grado di Tenente Colonnello. Dal 1915 è impegnato su l fronte de ll 'Adamello fino al 28 ottobre 1916 quando assume il comando del 7° Fanteria. Viene posto in aus iliari,i speciale il 4 lug lio 1920 e a riposo, con il grado cli Genera le di l3rigata il 26 gennaio 1933. Muore a Torino il 24 luglio 1949.
69CAPITANO ?'-JATALINO CA!.Vl: Kato in Val Brembana nel 1889. secondogenito cli una famiglia cli quattro va lorosi Ufficial i deg li Alp ini che si meritarono ben 10 .Medaglie al Valor Mil i tare (Attilio: 2 M.A.VM. e 2 M.B.V.M ; Nata lino : 3 M.A.V.M.; Santino: 2 M.A.V.M. e 1 M.B.V.M.; Giannino: morto cli spagno la contratta sul Monte Grappa), muore il 16 settembre 1920, precipitando sull'Adamello in un tentativo di scalata solita ri a su quei monti che lo avevano visto combaltcrc con tamo valore.
70MAGG 1rnu: E'\RICO VIT,\UNI: Nato a Mantova il 26 gennaio 1878. dopo aver frequentato la Scuola Militare è promosso Sottotenente nel 1898 ed è assegnato al 2° reggimento Alpini. Nel 1908 frequenta la Scuola di Guerra al termine della quak è inv iato in Tripolitan ia. Transitato nel Corpo di Stato Maggiore partecipa alla ia Guerra Mondia le. Nel 1926 assume il comando elci 5° reggimento Alpini. il 9 luglio 1932 viene collocato a riposo per infermità provenienti da causa cli servizio. E' stato decorato di una Medaglia d 'A rgento al V.M., una Medaglia di Bronzo al V.."v1. ed una Croce a l Meti lo


L'azione si svo lse nella tormenta che, se da una parte favorì la so rpresa tanto da permettere al nucleo del Ten. Quadri di conquistare all'alba la Lobbia Alta e di respingervi nmmediato contrattacco a ustr iaco, dall'altra rallentò il procedere degli altri due nuclei lìno alla fine della stessa ed al contemporaneo sorgere del sole svelando al nem..ico le intenzioni.
Tuttavia, nonostante le difficoltà, le capacità di comando del Ca p. Calvi e lo spiri to degli sciatori ebbero modo di brillare favorendo il conseguimento dei vari obiettivi preposti; solo il Monte Fumo resistette ancora per cinque giorni. fino al 17 aprile. quando anche il passo di .Monte Fumo venne conquistato. Ma l"impresa non era ancora terminata: bisognava cacciare il nemico anche dalle posizioni retrostanti sulle quali si era fortificato e dalle quali dominava, in pa1te, le posizioni appena conquistate; bisognava cioè attaccare la linea che da l Crozzon cli Farga1ida, a nord, per il Crozzon di Lares, culmina a sud nel Corno di Cavento affacciandosi, così, sulla Val di Genova a premessa di ulteriori possibili azioni condotte in profondità verso il Trentino.
L'azione iniziata all"alha del 29 aprile da parte del battaglione Autonomo Garibald i ed a cui presero parte anche i battaglioni Alpini Val d'Intelvi. Va l Baltea. Edolo ed Aosta terminò. dopo alterne fortune e ranti sacrifici, dovuti probabilmente ad una preparazione troppo affrettata che aveva consentito affavvers::irio un·emcace difesa, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati; unica eccezi.one il poderoso bastione rappresentalo dal Como di Cavento (carta n. 4).
In questa occasione, per la prima volta, fece sentire la proplia voce il cannone da 149 G che, dopo ben senantasette giorni di fatiche ciclopiche, era stato issato da Temù, in Yalcamonica, fino al Passo del Venerocolo.
Nel frattempo l'evolversi della situazione strategica in altri settori del fronte, si era infatti alla vigilia della offensiva austriaca dal Trentino" 1 , costringeva il Comando Supremo a sospendere
71 0ffensiva austriaca nel Trentino del maggio 1916, più nota con il nome di Sra.fe:,pedition o Spedizione p11nitiua. mirava, secondo gli intendimenti del Gen. Conrad all 'accerchiamento delle Armate italiane schierate sull'Isonzo con una manovra cbe da l sal iente; trentino. attraverso l'altopiano di Asiago portasse alla conquista di Vicenza. L"offensin, dopo un inizia le successo, fu bloccata grazie ad una britlame manovra per linee in terne che permise a l Gen . Ca<lorna d i far afnuire, in Lcmpi rapidi. i 1inforzi necessa,i.


le operazioni sull'Adamello e sull'Isonzo per concentrare gli sfo r zi sull'Altopiano di Asiago , ma i risu ltali conseguiti erano di enorme impo1tanza: era stata posta una seria ipoteca sul possesso dell ' intero massiccio delJ'Adamello e, come abbiamo visto, su ll a testata de ll a Val d i Genova.
Dall'aprile del 1916 alla primavera del 1917 le operazioni furono scarse perché i due avversari erano impegnati più a rafforza re le posiz ioni e ad attrezzars i per il terzo inve rn o d i guerra in alta montagna che ad affrontarsi senza, peraltro , rinunciare a prepararsi per la ripresa delle operazioni prevista con l'avvento della migliore stagione.
Rimaneva però per gli Italiani il prob lema Corno di Cavento: la form idabi le posizione austriaca presidiata da b en 200 tra Kaìserjager ed Artiglieri.
La pos izione si presentava come una fortezza inaccessibile dal versante italiano e protetta ai fianchi ed alle spalle, dove la salita era più agevole, da ben 14 ridotte comunicanti fra d i loro e scavate in profondità nel ghiaccio della Vedretta di Lares .
Per poter studiare un efficace piano d'attacco vennero condotte, durante tutto l'inverno, numerose ed audaci ricognizioni; tra cli esse particolarmente importante fu quella condotta nei giorni 12 e 13 gennaio 1917 da 15 Allievi Ufficiali che, agli ordini del Cap. Patroni e del Sten.Feruglia, rive lò tutte le difese nemiche in Val d i Genova ed in Val Fargorida.
Il 3 giugno il Colonnello Quintino Ronchi , che ne l frattempo era succeduto ne l comando della Zona Adamello-Val di Fumo a l Col. Giordana, emanò l'Ordine d'Operazione n. 1 Azione offensiva Corno di Cauento72 , tendente alla conquista delrimportante posizione (carta n . 5).
In esso si stabi li va che: la 1", 9" e 10" compagnia sciatori avrebbero dovuto attaccare, scendendo dal Crozzon del Diavolo, il centro della linea nemica della Vedretta del Lares, in particolare ne l tratto delle 1idottine 3, 4, 5 e 6, aggirarla e distruggerne le difese; la 2" compagnia sciatori, muovendo inizialmente dietro le altre tre, avrebbe dovuto puntare con il grosso verso il


Corno di Cavento, inviando, nel contempo, parte delle forze contro il Monte Folletto per tagliare la ritirata al presidio nemico del Corno di Cavento ed impedire l'afflusso di rinforzi dal Monte Folletto e dal Carè Alto; il battaglione Val Baltea, rinforzato clalJa 161" compagnia e da due plotoni di rocciatori del Monte Mandrone~3, avrebbe attaccato il Corno cli Cavento eia nord verso .sud con reparti particolarmente arditi ed attrezzati per la scalata (schizzi n. 1 e 2).
Alle 4,30 del 15 giugno 1917. 25 pezzi d'artiglieria aprirono il fuoco contro le posizioni austriache sul Corno di Cavento proseguendolo, salvo brevi e regolari interruzioni, fino alle 9.30 quando lo sparo cli un razzo dall'osservatorio della Lobbia Alta diede il segnale per l'attacco.
Le 4 compagnie sciatori, abbandonata la loro base di partenza, si lanciarono contro le ridotte del ghiacciaio del Lares, che per la loro posizione defilata non erano state battute dal fuoco dell'artiglieria, atlirandosi con l'attenzione anche il fuoco del nemico e favorendo il procedere delle due compagnie del Val Baltea che, con i plotoni del Monte 1vJandrone, avevano il compito di attaccare e conquistare il Corno di Cavento.
L'azione fu violenta quanto rapida e, alle ore 1:3, la cima venne conquistata mentre le compagnie sciatori continuavano la loro azione fino alle 14 quando, consolidatasi l'occupazione del Corno di Cavento, ricevettero l'ordine di cessare i loro attacchi e, al sopraggiungere della sera. rientrare sulle posizioni di partenza dalle quali, durante la notte, sarebbero rientrate alla linea dei passi Venerocolo e Brizio, per poi scendere al rifugio Garibaldi7-i.
Terminava così una delle azioni più belle e più importanti del settore Val Camonica-Adamello in cui gli sciatori , insieme con i rocciatori, erano stati i principali protagonisti.
L'aITetrarnento del fronte orientale a seguito della battaglia
- 3Cfr. Documento n. 20 : stralcio del Diario storico del banaglionc Monte Mandrcme, giorni 14- e 15 giugno 1917.
~'Cfr. Documento n. 21: Rapj)ortu sul combattimento del Corno di Cai•ento dal Diario storico del Comando della Zona Adamello - Val di Fumo. 18 giugno 1917.

di Caporetto non ebbe grosse ripercussioni nella condotta della guerra bianca sull'Adamello e sull"Ortles dove, pur essendo rrotagonist i di altri episodi, gli ~ciatori, che non erano più solo Alpini, ma comprendevano anche personale proveniente dalle altre Armi e Specialità dell"Esercito, vennero impiegati via via sempre meno e con formazioni sempre più piccole fino al 4 noYembre 1918 quando giunse la fine della guerra.



1. L'attiv ità addestrativ a ed agonistica tra le due Guerre Mondiali.
La smobilitazione che seguì alla guerra coinvolse, tra gli altri. anche i battaglioni sciatori e l'a ttività addestrativa sci istica dei repa1ti Alpini venne ridimensionata sulla base delle nuove e~igenze che prevedevano la ricostituzione, nell 'ambito dei reggiment i, dei plotoni sciatori con g li esclusivi compiti di esplorazione, pattugliamento e collegamento .
Questi reparti, in particolare, dovevano essere limitati a quelle sole unità le cui dislocazione territoriale ed il possibile impiego erano tali da renderne consigliabile e vantaggiosa la costituzione.
Il personale era tratto dalle dassi più giovani e gli istruttori degli elementi nuovi da addestrare, quando necessario, erano i commilitoni delle classi più anziane.
L' addestramento, la cu i responsabilità organizzativa era demandata alle singo le Almate, veniva svolto in località idonee e scelte nel territorio di competenza, ad eccezione del personale della 6" e dell 'S'' Armata che poteva essere affiancato rispettivamente a quello della 1·' e della 9·' Armata.

Ancora una volta fu l'entusiasmo di pochi che, in stretta collaborazione con gl i Emi c ivil i, diede un rinnovato impulso all'attività sciistica organizzando, nella stagione invernale 1919- 1920, la seconda edizione dell'Adunata Nazionale Sciatori Valligiani.
La manifestazione aveva le medesime caratterìstiche e.li quella che su era svolta nel 1915 a Courmayeur ad eccezione della prova di tiro che non era più prevista dal programma.
Fu il Comando Settore di Bolzano che si assunse p::ute dell'onere organizzativo della gara, che ebbe luogo il 22 febbraio de l 1920 a Selva di Val Gardena. mettendo a disposizione del
Comitato direrti,·o, presieduto dal Maggior Generale Mario Raffa-\ 11 Ufficiali e 30 Alpini sciatori.
Sull'ahbrivio di questa ripresa di attività e per iniziativa del noto alpinista Conte Aldo Bonacossa si ricostituì anche l'organinazione federale degli sciatori italiani che, nell'assemblea tenutasi a Milano nel settembre del 1920, a~sunse la denominazione di Federazione ltalia"a dello Sci.
'\el frattempo i termini ski. skiare e skiatore si italianizzavano e venivano sostituiti con i più comuni sci, sciare e sciatore.
Con il rifiorire delratth ·ità sciistica in It alia. il Ministro della Guerra mise a disposizione della Regia Guardia cli Finanza, per le esigen7e della neocostituita Scuola Sciatori di Predazzo- 6 • il Tenente degli Alpini Ottavio Berard per organizzare un centro di allenamento al Passo Rolle.
L·Ufficiale assobe al particolare comp ito con un entusiasmo ed una competenza tali che gli permisero di fare del Centro, per i quindici anni successivi. il punto <li riferimento dell'atti\ irà agonistica sciistica in Italia.
In quegli anni infatti. presso le Autorità Militari. si era faua strada la convinzion e che la molla necessaria e sufficiente per diffondere la pracica dello sci fosse l'attività sportiva.
Quest~l convinzione aveva pe1tanto inclouo il Ministero della Guerra ad organizzare. nel 1922. il l ° Campionato Taz ionale

-,J\I ,cc10R GEt\r.R\l t' .\1.\RtO Ri\ff\: J:\ato a Ca,riglionc dello ~ri\'ierl'; dopo an:r frequentato l'Accademia ,·iene promosso Sottot~:nent.e di Fanteria nd 1880. Dal 1883 Ufficiall' degli A lpini partecipa alla guerra ita l o-turca meitandosi una :1\Iedaglia di Bronzo al Valor \!ilitare. '\d 191-1 con il grado di Colonnello comanda prima il 3° e, successivamt.::nLc, il 1° reggimenw Alpini. Panecipa alla li\ Guerra 1\ tondiale con il grado di ì\laggior Generale: nel 1919 è collocato in ausiliaria. \luore a :'\lilano nel 193:t
-<>scuola Af/>ina della G'11ardia di FiJw11za: \iene Ì'.'>Cituita a Predazzo nel 1920. pre..,..,o una caserma ex !'><:<le cli un reparto <li Land..,1um1 3l1Striaci. sollo il comando del Colonne ll o Domenico Ol ivo come istituto di reclutamento per la G.d.F. e le prime 500 redllle \'Ì :iftluiscono sin dal 15 nm·embre. L'istilllLO, per la sua collocaziorn: geografica, a..,sume ben presto la connotazione di istituto di specializzazione al pina tanto che sin dall"inn:rno 1921. il Gen. C.\. Giuseppe Ferr..iri. bpeuore del ·corpo. i:,tillliscc ,11 Passo Rollc i p1imi cors i di addcstranwnco sciistico. Al gruppo degli istrultori. comandato dal Capitano Bartolomeo .\Iigliorl', ,·iene ,1ffiancato. con compiti di caranerc tecnKo, il Tenente degli Alpini Ottavio Berard.
Fig. 22 : Copia del Littoriale del 1936 riportante la vittoria della pattuglia italiana alle Olimpiadi Invernali (Biblioteca Nazionale del CONI , Roma)


Militare di Sci, con il chiaro intento di incrementare il numero dei praticami di questa disciplina.
La manifestazione, alla quale erano ammesse le rappresentative di tutte le Armi e Corpi delle Forze Armate, e che ebbe luogo a Limone Piemonte dal 5 all'll marzo, era suddivisa in due grnppi di gare: il primo, riservato alle categorie Ufficiali e Militari di Truppa, comprendeva: una gara individuale di resistenza sui 20-30 km circa, una gara di stile, una di salto e una di pentathlon costituita a sua volta da una prova di resistenza, una di velocità in discesa, una di stile, un percorso ad ostacoli ed una prova di tiro con il fucile; il secondo gruppo basato su di una gara di pattuglie sui 30-35 km.
Al programma vennero aggiunte delle gare riservate ai valligiani delle provincie di Genova e Cuneo, suddivisi, a loro volta, in due categorie: i seniores erano quelli che avevano già prestato servizio militare, gli juniores gli altri.
Nella seconda edizione, che ebbe luogo a Ponte di Legno dal 5 al 10 marzo 1923, venne inclusa anche una gara per pattuglie riservata ai soli battaglioni Alpini ed ai gruppi di Artiglieria da Montagna, denominata: De Adamello memento, in memoria degli eroici combattenti di quel settore alpino.
Seguirono altre tre edizioni: a Cortina d'Ampezzo dal 5 al 12 marzo 1924, a Cesana Torinese dal 2 al 10 marzo 1925 ed a Bormio dal 2 al 9 marzo 1926.
I maggiori protagonisti furono indubbiamente gli Alpini che conquistarono, con qualche rara eccezione, tutte le prove, ma buona figura la fecero anche i rappresentanti delle altre Armi e Corpi delle Forze Armare ad iniziare dai Carabinieri per finire alle Guardie di Finanza, senza dimenticare gli Aviatori ed i Genieri 77

In campo internazionale, nel frattempo, erano nati i Giochi
Olimpici Inv ernali che, per quanto riguardava gli sport della neve e del ghiaccio, venivano ad affiancarsi ai tradizionali giochi estivi.
Nel programma della p1ima edizione, che si svolse a Chamo-
77Tra questi è opportuno ricordare: il Tenente della Regia Aeronautica
Pietro Dente, il Tenente dei Carabinieri Cesare Ramelli di Celle: il Tenente dei Carabinieri Emilio Radaelli; il Brigadiere dei Carabinieri Pietro Bich; il Brigadiere dei Carabinieri Pietro Pellissier; il Vicebrigadiere della Guardia di Finanza Luigi Valtzer, il caporale ciel Genio Pontieri Giuseppe Sanclrini.
nix dal 25 gennaio al 4 febbraio 1924, era stata inserita una gara dimostrativa di fondo e tiro per pattuglie militari, sulla distanza di 25 km, composte da un Uffic iale, un Sottufficiale e due .Militari di Truppa .

Il Ministero della Guerra, dopo molte perplessità ed ince1tezze, decise di parteciparvi con una rappresentativa la cu i preparazione venne affidata al Maggiore Peroglio.
La pattuglia si 1iunì in Val di Gressoney, ma le incertezze iniziali, il ritardo di preparazione ed il campo di allenamento non idoneo, nonché il materiale non alrallezza di quello utilizzato dalle rappresentative delle altre Nazioni, ne condizionarono il risultato e. mentre la vittoria arrideva alla rappresentativa elvetica, la nostra squadra era costretta al ritiro scatenando, in Patria, aspre polemiche.
Infatti, mentre le altre pattuglie gareggiavano con sci eia fondo in hickory, attacchi Bergendahl da gara ed usavano la sciolina8 , la nostra rappresentativa utilizzò gli sci d'ordinanza in frassino, gli attacchi Huitfeld e corse senza la sciolina; inoltre i nost1i si erano preparati su percorsi comprendenti salite dure e discese impegnative mentre il campo gare olimpico era in gran parte pianeggiante con poche ondulazioni in cui contava più l'agilità e la velocità che non la potenza.
Con la nomina ciel Generale Ottavio ZoppC9 ad Tspettore del-
8Scio!ina: Preparato costituito cl,t un m iscuglio di grassi minera li, per lo più cera. paraffina e catrame, che si spa lm a sulla soletta degli sci per aumentarne la scorrevolezz:1 specialmente in piano, o per evitare lo scivolamento all'indietro in salita. E' ut ilizzata anche per rendere meno permeabile il legno degli sci ed evitare che si formi sotto di essi uno zoccolo di neve. La sciolina è applicata a caldo o a freddo stendendola con il palmo della mano. La scelta cli un tipo di sciolina adatta alle condizioni della neve è fattore imporrame per il buon esito di una gara.
- 9GE's'FRALE 011A\ 10 ZoPPl: )fato a Novara nel 1870: dopo aver frequentato l'Accademia, nel 1888, è nominato Scmotenence di Fanteria. Ha partecipato alla guerra italo-turca cd alla spedizione di Rodi dove gJj viene conferita una Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Nella 1' Guerra Mondia le, promosso Co lonnello per me,iti di guerra , comanda il 23 ° reggimento fanteria . Nel 1917, promosso Magg ior generale per meriti di guen.1. comanda la Brigata Salerno. Tn guerra viene decorato con una Medagl ia cli Bronzo al Valor l\lJil ita re e l'Ordine Militare cli Savoia. Nel 1926 è Ispettore delle Truppe Alpine e nel 1928 è promosso Generale di Corpo d'Annata. Nel 1929 è nominato Senatore del Regno.
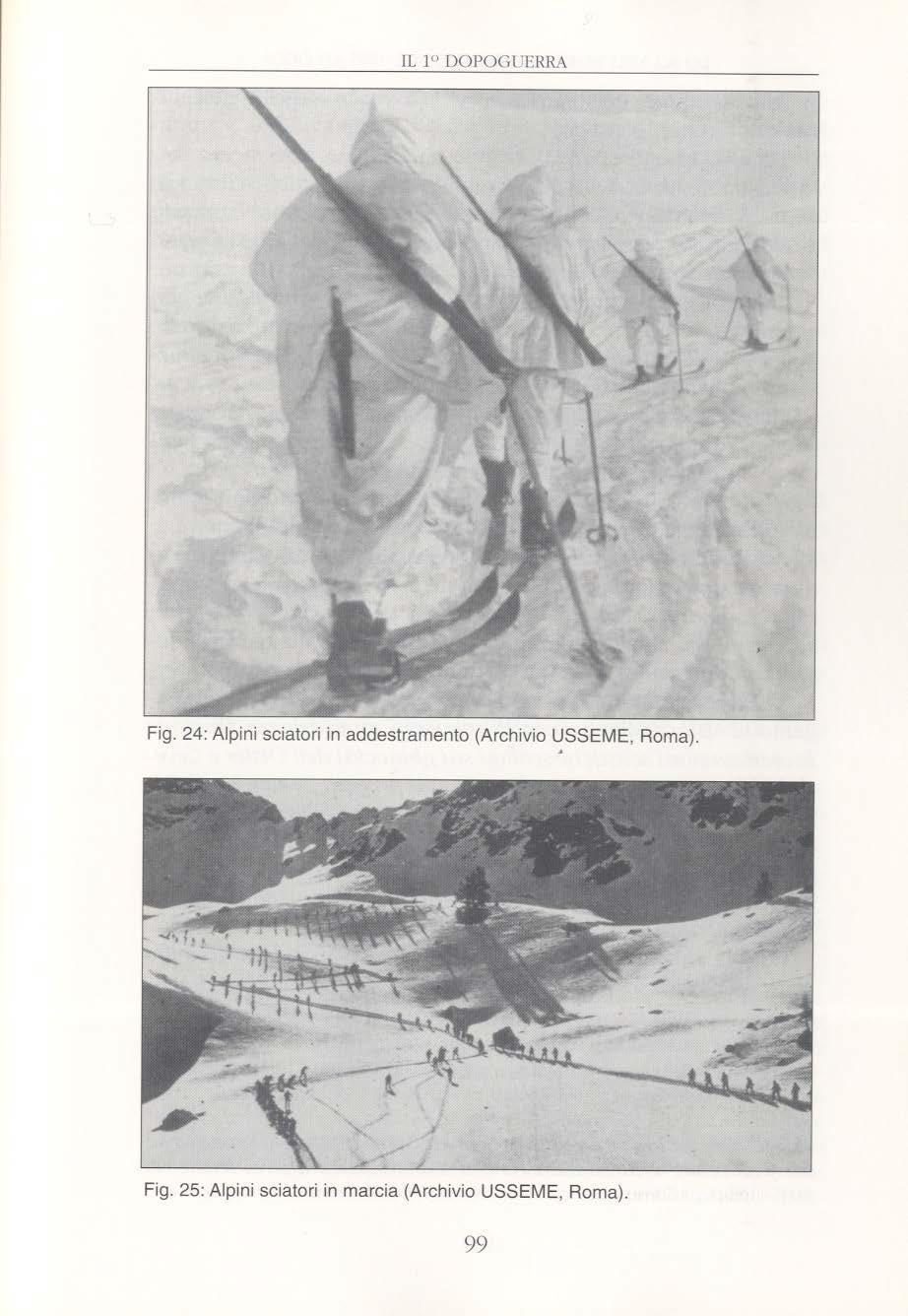
le Truppe Alpine. nel 1926. si ebbe una svolta radicale nell'attività addestrativa sciistica.
Il nuovo Ispettore, infatti, ritenne più utile un incremento delraddestramcnto colletth·o, ottenibile auraverso corsi sciistici di massa ed esercitazioni di interi reparti per costituire vere e proprie unità operntive, che gare e competizioni individuali che si erano rivelate di scarsa o nulla utilità ai fini dell'addestramento militare.
I reparci Alpini tornarono. quindi, sin dall'inverno 1926-27 ad esercitarsi ed ad operare in alta montagna. animati da un rinnm·ato spirito di arditezza e spregiudicatezza tanto da organizzare, in alcuni casi, dei corsi di sci anche in estate.
Fu in particolare il 6° reggimento Alpini che organizzò un corso da l 15 luglio al 1° agosto 1927 presso il Rifugio Vedretta Pendente sull'Adamello ed un'esercitazione, a cui presero parte gli sciatori di tutti i reggimenti Alpini, nei pressi del Rifugio Capanna Città di Milano sul ghiacciaio dell'Ortles Cevedale.
Quasi a sottolineare lo spirito con cui venivano intraprese queste attività è significativo ricordare la bella impresa del Caporale t-.taggiore Giovanni Verzeroli del battaglione Edolo che, accortosi esercitazione durante che il proprio Tenente era caduto in un crepaccio, vi si faceva calare riuscendo a salvarlo.
Al Caporale Maggiore \ enh·a concessa una ~1edaglia d'Argento al Valore Militare con la seguente motivazione: Durante le esercilazioni sciistiche svoltesi sui ghiacciai del/'Ortler e Cet·edale (6 agosto 1927) m;endo l'eduLo il proprio Tene11te precipitare in un crepaccio, si faceva calare, legalo ad una corda. nell'abisso per salvarlo. Trol'ato l'lJ]ìciale suenuto, lo legava alla propria corda e lojàceva issare in alto restando nel crepaccio in criticissirna posizione jìno a quando f!.li venne calata nllot•arnente la corda.
Con la circolare n. 610 del 5 novembre 1926 Addestramento sciisticcf>O ITfficio Addestramento dello St.!LO Maggiore dell'Esercito definiva le modaliLà da seguire per i corsi sciatori, l'addestramento sciistico degli Cfficiali. dei reparti, la propaganda valligiana e le relazioni e.la presentare sulle varie anività svolte.
w'Cfr. Documento n. 22: circolare n. 610 del Giornale J\lilitare. 55 dispensa, del 5 novembre 1926 blruzioni ed Esercitazioni Addestramento sciistico di SME - L'fficio A<ldestr.imento.
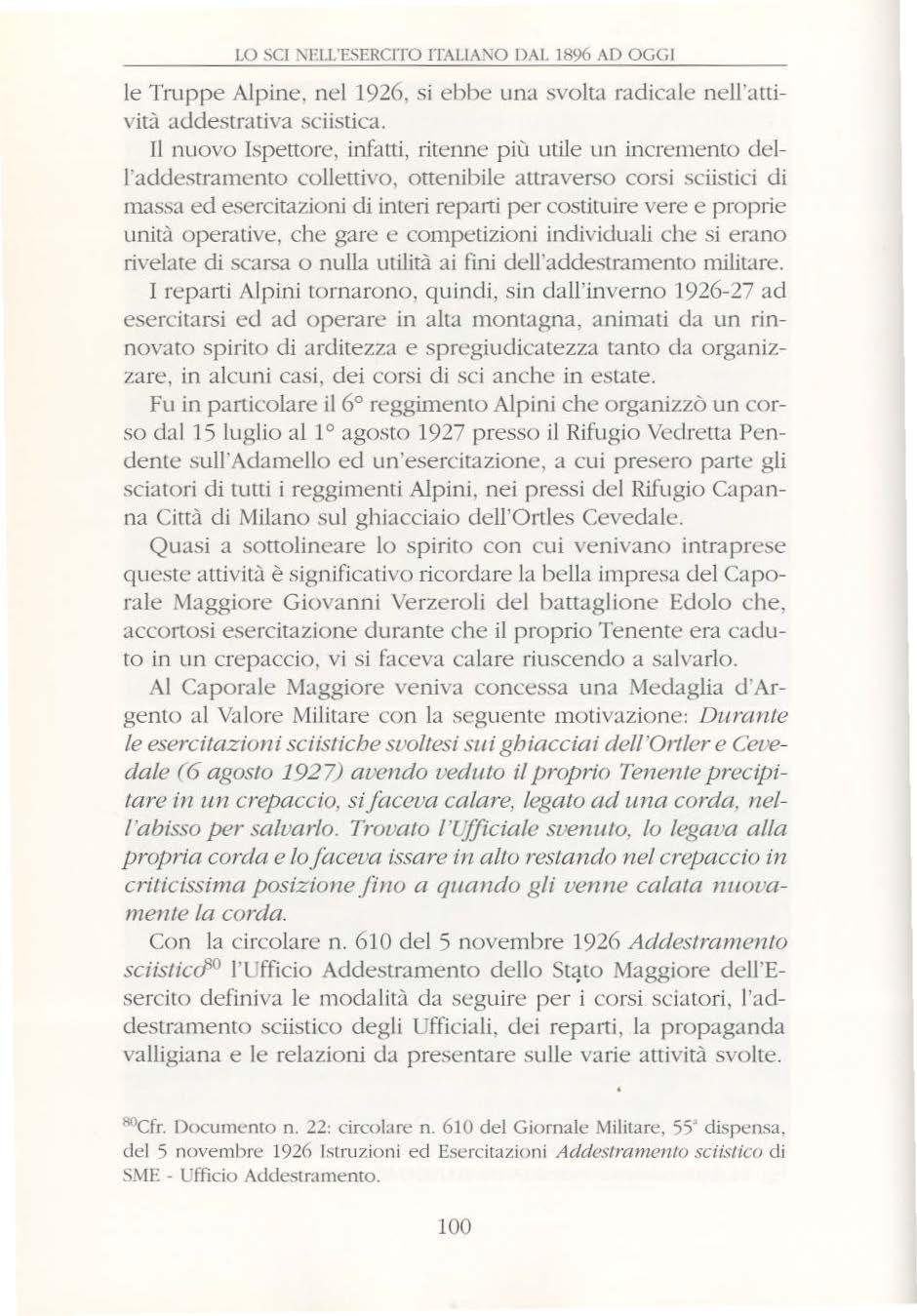
Il documento in particolare definiva lo scopo dell'addestramento, stabiliva un indirizzo unitario dell'istruzione sciistica militare basato su schemi e metodi addestrativi sostanzialmente differenti da quelli praticati fino ad allora, indicava come organizzare i corsi, la loro durata, le località ove effettuarli, come scegliere i partecipanti; inoltre si stabiliva l'equipaggiamento ed il materiale sciistico di ciascun allievo, il materiale sanita1io da avere al seguito, l'annamento ed il munizionamento che consisteva nel moschetto mod. 91 da Cavalleria e 6 pacchetti pari a 108 cartucce, la classifica finale ed infine le gare da organizzare con i relativi premi.
Per la propaganda valligiana la circolare indicava alcuni criteri di massima lasciando, tuttavia, ampia capacità discrezionale ai Comandi di reggimento per tutte le attività inerenti l'organizzazione, la conduzione ed i rappo1ti con le varie Autorità comunali, scolastiche, con le Società sportive e, comunque, con tutti quegli Enti pubblici e privati in grado di fornire il massimo apporto, sia morale che materiale, per un sempre maggior incremento alla conoscenza ed alla diffusione dello sci.
A questo documento fece seguito, di lì a poco, la circolare n. 150 Addestramento Laltico e impiego dei riparti sciatori del 10 gennaio 1927 del Ministero della Guerra - Ufficio Addestramemo81Nella premessa il Generale Pietro Badog1io82 , Capo di Stato
81 Cfr. Documemo n. 23: circolare n 150 del 10 gennaio 1927 Addestramento tattico e impiego dei riparli sciatori del Ministero della Guerra - Uffic io Addestramento-.
82 GE:s-iERALE PTETR O BADOGLIO: ~ato il 28 se nembre 1871 a Grazzano .'Vlonfe rraLo, Dopo ave r frequentato l'Accademia MiliLare di Torino è nominato Soctmenente nel 1890. Partecipa alla guerra italo-turca del 1911-12 a l termine della quale viene promosso Maggiore per merito di guerra. Durante la J ' Guerra Mondial e viene 1ipetutamemc promosso per meriti di guen·a e, nell'ottobre 1917 , è Comandante di un Co rp o d 'Armara. Dopo Caporetto , novembre 1917, viene nominato Sottocapo di Stato Maggiore e, nel 1919 diventa Capo di Stato Maggiore, carica che lascerà, a domanda , nel 1921 per riacquistarla nel 1925. Nel 1936 è al Comando delle tnippe italiane nella guerra italo-etiopica. Jl 25 luglio 1943 viene nominato Capo ciel Governo, c arica che la scerà il 4 giugno 1944. E' stato decorato con: Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare di Savoia , una Medaglia d 'Argento al V.M. , una Medaglia di Bronzo al V.M. e sette promozioni p e r meriti di guerra. Muore a Grazzano Badoglio (Monferrato) il 1° novembre 1956.


Maggiore Generale, affermava che: "La guerra alpina di movimento non ha nella sua essenza sensibilmente variato in confronto atlante guerra, per l'adozione dei nuovi mezzi d'qffesa.
I gas, i carri armati, le potenti artiglierie moderne, non influiscono in particolar modo, là dove la forma del suolo, la mancanza e la scarsità delle comunicazioni - e la loro primordialità - la variabilità del clima e delle condizioni atmosferiche ne uietano o quanto meno ne riducono considerevolmente l'uso, ostacolandone il movimento, impedendone i rifornimenti o attenuandone t·efficacia'·.
Il Generale, dopo essersi soffermato su alcune considerazioni circa le djfficoltà del terreno e le qualità morali, tecniche e fisiche necessarie per affrontarle e risolvere a proprio favore il combattimento, termjnava l'introduzione con la felice intuizione, estremamente moderna e tuttora valida, che: "Di tali condizion i speciali. che costituiscono l'ambiente di vita e di lotta della truppe alpine. devono saper valersi in particolar modo gli se iatori, per i quali. doti essenziali sono la velocità e /'ardire e, fattori precipui di successo, la s01presa e l'audacia".
La circolare era suddivisa in due parti: la prima trattava dell'impiego dei repatti sciatori con particolare attenzione ai compiti affidati ed alle possibili azioni cli combattimento; la seconda riguarda va le modalità esecutive specificando la composizione organica dei reparti, le possibili formazioni e l'impiego del fuoco, l'addest:rarnento degli esploratori e le marce.
In campo sportivo, avvicinandosi l'anno olimpico ciel 1928. l'Ispettorato, anche sulla base dell'esperienza maturata con la prima edizione, sin dal gennaio 1927 diede avvio alle selezioni per la costituzione della rappresentativa italiana ai Giochi.

Scelti gli elementi idonei, la preparazione ebbe inizio già dall'estate a Gressoney, sui ghiacciai del Monte Rosa, per essere completata nel corso dell'inverno a Livigno.
Tl risultato di questa preparazione razionale ed attenta non si fece attendere e, nonostante l'infortunio di un componente durante una discesa che rallentò la marcia della formazione, la pattuglia italiana si classificò ad un più che soddisfacente 4° posto dietro a Nazioni di consolidate tradizioni sciistiche quali la Norvegia, la Finlandia e la Svizzera, giunte nell'ordine.
La capacità cli impiego degli sci ed il livello addestrativo rag-
giunto dai repani furono tali che il giornalista Cesco Tomaselli, valoroso Ufficiale degli Alpini nella Guerra mondiale, ritenne opportuno suggerire al Generale L'mherto Nobile8 3 di an~re al seguico della spedizione di esplorazione del Polo Nord con il dirigibile ITALIA, prevista per il maggio <li quell'anno, un nucleo di soccorso, composto da Alpini sciatori, in grado di intervenire prontamente e con efficacia in caso di un atterraggio di fortuna dell'aeronave sui ghiacci del Polo.

Lasciando per un attimo il racconto delle imprese di questo valoroso nucleo di sciatori a cui dedicheremo successivamente l'ampio spazio che si meritano, è qui opportuno sottolineare come il Generale Zoppi, sin dal suo insediamento all'Ispettorato delle Truppe Alpine, avesse dato ai corsi .sciatori dei reggimenti un impulso spiccatamente alpinistico.
L'lspetlorato, partendo dalla considerazione che il confine terrestre si sviluppava nel cuore delle Alpi e che era opportuno che i reparti Alpini, preposti alla .sua difesa, lo conoscessero in tutti i suoi aspetti operativi, sia d'estate che in inverno, organizzò un grandioso raid sciistico militare attraverso l'intero arco alpino, dal Colle di Tenda nelle Alpi Marittime a Tolm.ino in Valle Isonzo, a cui presero parte i 9 reggimenti Alpini ed i 3 reggimenti di Artiglieria da Montagna.
L'organizzazione venne affidata al Colonnello Vincenzo Tessitore ed al Tenente Colonnello Luigi Mazzini, dell'Ispettorato, che suddivisero l'arco alpino in due senori: quello occidentale, da S. Dalmazzo di Tenda a Domodossola, quello orientale, che si sviluppava fra Tolmino e Chiavenna; il punto di unione tra i due settori era costituito dal cuneo centrale del Canton Ticino. Al raid, che ebbe luogo fra il 20 gennaio ed il 1° febbraio 1929, partecipavano pattuglie di sciatori composte ciascuna da un Ufficiale Comandante , un SoLLocomandante e da tre Militari di Truppa che, cambiando componenti ad ogni tappa. doveva-
83G1.,ERALF L \tBERTO Noo11.F.: Kalo a 'apoli nel 1885. Generale dei Genio Aeronautico costruì i dirigibili Nl, Norp,e e llalia. Con quest'ultimo ru protagonista della spedizione italiana al Polo Nord condu-.asi, -.ulla strada del ritorno, con il naufragio dell'aeronave. Ritenuto responsabile dell'incidente che causò la perdita di parte dell'equipaggio, nel 1929 diede le dimissioni e si trasferì in Russia dove continuò la '>Ua opera di progeua;,ione e costruzione <li dirigibili.
no muovere dalle estremità dell'arco alpino fino a raggiungere il cuneo centrale.
Il 10 gennaio iniziarono a muovere le pattuglie del settore occidentale (1 °, 2°, 3° , 4° Alpini e 1 ° Artiglieria da Montagna) a cui toccavano 23 tappe , mentre a quelle del settore orientale (5° , 6° , 7° , 8°, 9° Alpini e 2° e 3° Artiglieria da Montagna) che dovevano percorrere solo 17 tappe , il via venne dato solo il giorno 16; in questo modo si assicurava la contemporaneità dell ' arrivo delle pattuglie provenienti da ovest e quelle da est, rispettivamente a Domodossola e Chiavenna .
Gli itinerari prescelti seguivano da vicino l'andamento dello spaniacque alpino implicando lo scavalcamento delle catene radiali , ch e da esso si dipartono , con difficoltà sci- alpinistiche di notevoli proporzioni, ma la perfetta organizzazione ed il continuo supporto logistico assicurato dai reggimenti permisero di condutTe a termine , nel migliore dei modi e con ampia sicurezza per i singoli, l' attività programmata.
L'impresa, al di là della vasta eco che ebbe , mise a nudo la scarsità di Quadri preparati a condurre dei repatti nella montagna innevata; carenza che si faceva sempre più grave in un momento in cui gli sport invernali andavano diffondendosi rapidamente nel Paese in contemporanea ad un costante progresso tecnico -qualitativo dei materiali sciistici.
Nonostante gli sforzi dell ' Ispettorato per l 'organizzazione dei corsi interregimentali e la buona volontà di alcuni Ufficiali che, a spese loro, si recavano in Austria ad aggiornarsi , mancava , estintosi nel 1926 il Campionato Militare di sci, una manifestazione che permettesse di fare una verifica, con cadenza periodica, dei progressi registrati nel campo.
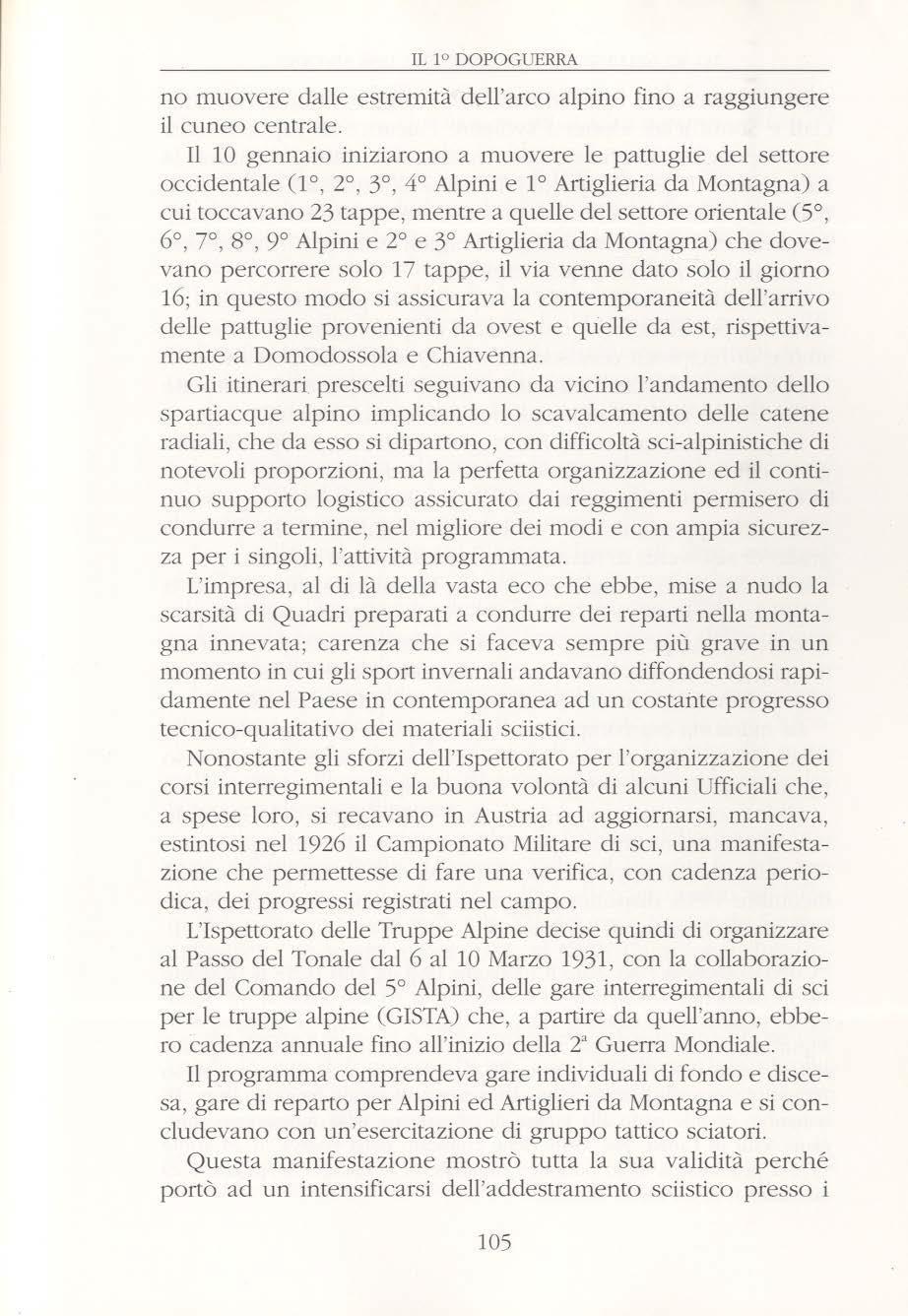
L'Ispettorato delle Truppe Alpine decise quindi di organizzare al Passo del Tonale dal 6 al 10 Marzo 1931, con la collaborazione del Comando del 5° Alpini , delle gare inteffegimentali di sci per le truppe alpine (GISTA) che , a partire da quell 'anno , ebbero cadenza annuale fino alrinizio della 2' Gue1Ta Mondiale.
Il progranuna comprendeva gare individuali di fondo e discesa , gare di reparto per Alpini ed Artiglieri da Montagna e si concludevano con un'esercitazione di gruppo tattico sciatori.
Questa manifestazione mostrò tutta la sua validità perché portò ad un intensificarsi dell ' addestramento sciistico presso i
reparti. permise la formazione cli un congn10 numero di Ufficiali e Sottufficiali idonei a svolgere l'incarico cli capopattuglia in competizioni interna1:ionali e nazionali e, infine, consentì la formazione di un gruppo di Ufficiali e Sottufficiali così cspe11i nell'organizzare manife!'>tazioni sciistiche da risultare, a nm·oggi. pressoché indispensabili per l'organizzazione di manifestazioni, anche civili, di grosso impegno.
L'annuale cadenza della competizione permise. inoltre. il ritrovarsi periodico ed il riannodarsi di quei legami di cameratismo e di reciproca conoscenza tra i Quadri. che ave \ ·ano così ropportunità di scambiarsi le reciproche esperienze maturate nelle diverse realtà ambientali dell'intero arco alpino.

Le prime edizioni delle Interre,_qime11tali c.:he, come abbiamo già accennato, avevano evidenziato la carenza, presso i Corpi. di un numero adeguato di Quadri istrutlori di sci, suggerirono l' idea dell'opportunità di coslituire un organismo che fosse in grado di risolvere, in maniera definitiva, l'intera materia.
Fu il Capitano Giorgio Fino81 che. fattosi interprete di questa esigenza, presentò, nell'estate del 1933, una memoria all'Ispettore della Truppe Alpine, Generale Celestino Be~. per la costituzione di una scuola militare di alpinbmo che avesse il compito di formare. con unicità di indirizzo. i Quadri istruttori.
La memoria era completata da un quadro di situazione delle scuole di specializzazione alpinistica e ~ciistica esbtenti presso i principali eserciti europei ed extraeuropei.
L'idea, recepita e presemata c.:on entusia~mo dal Generale Bes, trovò un favorevole riscontro presso lo Stato Maggiore dell'Esercito che, in applicazione di un decrero firmato dal Re il 22 dicembre 1933. disponeva l'immediata costituzione della Scuola Centrale Militare cli Alpinismo.
&i(Al'ITAI\O G10RGJO FtNo: ''fato il 10 ago::.lO 189-i ad Alba (Cl\). il 12 agosto l9Vi è nominato Souorenete di u>mplemento ed assegnato al .38° reggiml'nLO Fanteria. Il 24 febbraio 1918, con il grado di Tenete 0 trasferito al 5° Alpini. Il 12 marzo 19:3-1, nel grado di Capitano. , iene Jssegnato all'hpettorato delle Truppe Alpine. TI I 6 settembre 19'40 viene promosso Tenente Colonnello e trasferito al sottosettore autonomo L~vanna. Dopo 1'8 senembn.: prende pa11e alla guerra di Liberazione nella formazione partigiana Valli di Lanzo. '\lei 191 16 viene collocato nella riser\'a Il 23 aprile 19-0 è promossa a titolo onorifico Generale di Divisione. Si spegne il 29 dicembre 1976 a Pecetta Torinese.
Nel frattempo l' Ufficio Coordinamento del Gabinetto del Ministro emanava la circolare n. 48 Addestramento sciisticd35 con la quale si definiva che l' addestramento sciistico aveva lo scopo di abilitare e perfezionare gli Ufficiali delle Truppe Alpine all 'uso degli sci e di dare al militare una uniformità di metodo tecnico ed un addestramento professionale rispondente alle necessità ct·impiego nelle varie contingenze belliche.
Il documento prevedeva l'addestramento sciistico invernale da svolgersi a livello reggimenta le, l 'addestramento per gli Ufficiali della durata di una settimana da effettuarsi sui campi da sci più vicini alla sede del repa1to di appartenenza e reffettuazione di esercitazioni sciistiche estive sui ghiacciai per perfezionare gli istruttori.
La circolare veniva ad abrogare le precedenti ed in particolare la n. 610 del 5 novembre 1926 rispetto alla quale prevedeva il perfezionamento estivo degli istruttori.

La 4, edizione dei Giochi Olimpici Invernali 1936, assegnati alla Germania ed organizzati a Garmich-Partenkircher, era già alle porte e l'Ispettorato delle Truppe Alpine affidò , natura lmente, al la neo costituita scuola la preparazione della rappresentativa militare italiana.
La preparazione ebbe immediato inizio con uno studio preventivo e razionale dei metodi di allenamento per le gare di fondo, con l'affinamento della tecnica di corsa, la scelta dei materiali da gara e l'acquisizione di un ' approfondita conoscenza della tecnica della sciolinatura.
A tale scopo un primo nucleo di Ufficiali della Scuola tra i quali il Capitano Boffa, il Tenente Vida e i l Tenente Inaudi, presenziò ai Campionati tedeschi svoltisi a Berchtesgaden nel 1934. quindi partecipò fuori gara alla XV Adunata Nazionale Sciatori Valligiani a Sappada e , nel 1935, ai XXIV Campionati Internazionali di Francia a Chamonix.
In quest'ultima competizione, nonostante l'ancora insufficiente preparazione , i nostri rappresentanti si fecero onore vincendo la gara cli fondo sui 18 km. con l'Artigliere
Alpino EmilioRamella e classificandosi secondi nella gara delle pattuglie con la formazione de l Ca pita no Silvestri.
data 28 gennaio 1932
La preparazione proseguì attraverso le lnterregìmentali e la disputa della seconda edizione della Gara Internazionale Sciistica di alta montagna per squadre di rre uomini denominata: Trofeo Jfezzalamc/.6 che fu vinta dalla rappresentativa dello Sci Club Ruitor cli La Thuìle.
Il 14 febbraio 1936 a Garmisch, in una splendida giornata di sole, venne disputata la gara per pattuglie militari prevista dal programma olimpico e per i colori azzurri fu subito trionfo.
L'Italia, rappresentata dal Capitano Enrico Silvestri, dal Sergente Luigi Perenni e dagli Alpini Stefano ~ertorclli e Sisto Scil1igo, vinse, conquistando l'oro olimpico davanti alle rappresentative della Finlandia e della s,·ezia.
Questo successo portò alla costituzione, presso la Scuola Centrale Militare di Alpinismo di Aosta. del Nucleo Pattuglie lleloci Sci-Alpine quale diretto successore ciel nucleo preolimpico e destinalo a perpetrare l'attività sporriva dell'Esercito ai massimi livelli nazionali ed internazionali.
Il 1° ottobre 1938 lo Stato ~laggiore dell'Esercito. avvertita la necessità cli riordinare il complesso delle disposizioni che regolavano ranività addesrrariva sciistica ed alpinistica, emanò la pubblicazione n. : 167 Addestramento Alpinistico e Sciistica"'- che regolamentava l'atrività sia per i reparti alpini che per le altre unità.
La pubblicazione era divisa in :$ pani: la prima riguardava l'addestramento delle Truppe Alpine, la seconda quello <lei reparti non alpini e la rerza le norme amministrative.
Per quanto riguarda la prima parte !,i prevedeva l'organizzazione di corsi cli abilitazione alpinistica, sciistica e pratica del servizio nei reparti alpini per i Sottotenenti in !>ervizio pennanente delle 'IT.AA. da effettuarsi presso la Scuola Centrale Mili -
~Trofeo Jlezzalama: Gara internazionale sciistic,1 di .ilta montagna per :-.quadre cli tre uomini in cordata che si <;volge sui ghiacciai del !\fonte Rosa su di un percor,o di circa 10 km. che si '>noda -,u quote oscillanti tra i :3.000 e<l i , 1.000 mdi altitudine. Venne istituito nd 19:3.:$ per onorare la memoria dd famoso alpinista e sciatore Ottorino \1ezz.1lama, valente istrunore nei corsi sciistici effelluaù nel corso della l' Guerra :-.-londiale. caduto travolto da una valanga il 31 gennaio 19.:$1 nei pre:-.si del Rifugio Regimi Elena nel!<: ~lpi 13reonie.
8-Cfr, Documento n. 25: pubblicazione n. 3-167 del 1° ottobre 1938 Addeslramento Alpi11istico e Sciistico dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Addcstramento.

Alla OLIMrtADI INV•IINALI
Dtricolore d'Italia sul pennoa,
Mll tllllD Ì 15-16
u,,-iiaiiim,-Cmr.-itJ ~~~-=-
per la ss,eHacolosa vittoria delle Fiamme Verdi nella. gara delle pattuglie militari
I.a ...-m .... &IJlld (...U-larlNIIIIWlrt,..,..... 1.a111,...i,..ia11 11111111, lltNnlll) - '1llcllrlN - - cli llJllllalllll
YALORE DI ITALIANI JIBL I ONDO
REC.INA EXTRA
Fig. 28: Gazzetta dello Sport del 1931 con la vittoria della pattuglia italiana ai Giochi Olimp ici Invernali di Garmisch (Archivio della Gazzetta dello Sport , Mi lano).

tare di Alpinismo per una durata complessiYa di circa quamo mesi, l'addestramento alpinbtico con lo scopo di uniformare l"indirìzzo ed i metodi di addestramento in campo prettamente alpinistico da svolgersi sempre a cura della Scuola ed infine l'adc.b,tra mento sciistico di reparto ed i cor!>i regg ime n tali.
L'organismo competente al rilascio dei diplomi di fstmttore di A lpinismo e d i Jstrullore di Sci. per gl i Ufficiali ed i Sottufficiali. era slabilito nella ~cuoia Centrale Militare di Alpinbmo, mentre il Direttore tecnico dei corsi reggimentali. sulla ba<ie dei giudizi dei vari istruttori. era prepo.sto a conferire la qualifica di sciatore scelto ai Militari di Truppa merite\ oli.

La seconda parte trattava dell'addestramento da impartire a quei reparti che erano di stanza in zone montane o prossime a queste; in merito alla preparazione sciistica era prevista la partecipazione di un Cfficiale inferiore, per Div i'iionc di fanteria e Divisione Motorizzata. ai cor'>i organizzati dalla ~cuoia Centrale Militare di Alpinismo con la possibilità di essere nominati L,·truttori di sci e l'organizzazione. all'interno dei Corpi d'.\rmata. di giornate della nel'e ()Cr abituare il persona le dipcndeme a muo\ ersi 'iUl terreno inneYato.
L'ultima parte era dedicata alle norme amministrative a cui fare riferimento per lo s, olgimento dei corsi e delle attività previste dal documento.
~el frattempo il Comando Superiore Truppe Alpine:-iS, con il determinante aiuto della Scuola Centrale i\lilitare di Alpinismo, stava prov, cdendo alla stesura di un manuale che illw,trasse un metodo ed una tecnica cli insegnamento dell'uso degli sci rispondente alle finalità militari.
L'elaborazione e la stc'iura del testo. particolarmente curaro e ricco di illustrazioni grafiche. richiese un note, ole impegno da parte degli istruttori della Scuola e vide la luce solo nei primi mesi del 1941.
li documento, denominato lstruzio11e sull'uso degli scf K9 , che
N'.Co111m1du Superiore 'fru/J/J<! Alpine-. costitiuto il 1 mar.w 1939. con <lctcrm111az1one dd :\lin1stero della Guerra n 83830 in d,na 21' dicembre 1938. in ">Ost ituzionc dell'lspetlorato delle Tntppe Alpine.
""'Cfr. Documento n. 26: pubblicazione n. 3862 edizione 19<+0 lslruz:io11e ,11/t11so degli sci cld ~lini">tero della Guerra.
costituisce il primo vero manuale cli tecnica sciistica dopo l'analogo del 1908, era suddiviso in: premessa, 5 capitoli e un'appendice.

Il pr imo capitolo trattava dell'equipaggiamento di cui, con dovizia cli particolari, descriveva le caratteristiche tecniche e costitutive, quindi la ginnastica presciistica, suddiv isa in esercizi di immunizzazione e di preparazione, ed il metodo di insegnamento.
Il secondo era dedicato alla tecnica del lo sci nella discesa in cui venivano illustrati i principi fisici che sono alla base dello sci da discesa, il piano d'insegnamento da adottarsi, la discesa diretta, le curve lente , le curve veloci ed i salti.
li terzo capitolo riguardava la tecnica dello sci in piano ed in salita; in esso si trarra va della tecnica dello sci in piano comprendente i passi ed i cambiamenti di direzione, quindi quella in salita con analoga suddivisione.
ll quarto era dedicato alla particolare tecnica del salto dal trampolino.
L'ultimo capirolo era dedicato allo sci in alta montagna, descrivendo le caratteristiche della neve e le difficoltà ra ppresentate dallo sciare in terreno vario, nonchè la tecnica da adottare sui ghiacciai; il capitolo terminava con l'illustrazione dei pericoli insiti nell'ambiente e le previdenze da adottare.
Interessante era anche l'appendice per le norme sulla conservazione e la manutenzione del materiale sciistico.
Nel campo dei materiali sciistici non ci furono grandi novità; conclusasi la guerra, infatti, alla stasi generale in campo addestrativo, conseguenza diretta della smobilitazione, si era unita quella della ricerca non più sollecitata dalle imp e llenze e dalle necessità belliche .
In questo contesto l'evoluzione tecnica dello sci era demandata al mondo civile che, sulla spinta dell'attività sportiva che veniva sempre più differenziandosi tra sci alpino e nordico o da fondo, dava un impulso sempre maggiore alla ricerca.
Cambiavano gli sci da discesa a cui vennero aggiunte le lami -
n<:: laterali, gli sci da fondo resi sempre più leggeri e sottìli. gli attacchi da discesa e quelli da fondo.
Nel campo militare, con la ripre~a delle attività addestrative si sentì il bisogno di riordinare rutta la materia dando un'unicità di indi1izzo anche per i materiali che, guerra durante, avevano assunto, talvolta, aspetti del nnto particolaristici, legati più alle necessità contingenti e locali che non ad una ricerca vera e propria.
Basti ricordare, come esempio, la rapida evoluzione delle tute bianche che, dalle iniziali camicie sovrapposte all'unifonne grigio verde, si passò, attraverso dei camicioni, ai completi mimetici mono o bipezzo, con l'inevitabile difformità nell'ambito dei reparti stessi.
Ma se in guerra. specie in un ambiente totalmente sconosciuto e fino a poco tempo prima ritenuto non idoneo alla condotta di operazioni, la necessità di fronteggiare gli av, enimenti fece premio sulle regolamentazioni, in tempo cli pace era indispensabile far tesoro delle esperienze maturate e studiare dei materiali idonei ad affrontare, con buoni risultati, le \'arie situazioni che si sarebbero affacciate in futuro.
Del problema se ne occupò la Direzione generale dei servizi logistici che, con la circolare n. 398 del 30 giugno 1929 pubblicata sul Giornale Militare Ufficiale 90 , stabilì i materiali da dare in dotazione alle Truppe Alpine e, in particolare, agli sciatori.
La circolare riponava un elenco di tutti i materiali in dotazione; dagli sci, con relativi accessori come i bastoncini e gli attrezzi per la riparazione impiego durante, fino al vestiario mimetico bianco.
Il documento, oltre la semplice elencazione delle singole voci. ne conteneva una dettagliata de<;cri:lione, illustrandole e stabilendone la posizione categorica nel nomenclatore del materiale dei servizi logistici oltre che il prezzo di assunzione in carico.
Per quanto riguarda più specificatamente gli sci. non avendo questi ancora subito alcuna modifica cli carattere tecnico, la cir-
9ClCfr. Documento n. 27: circolare n. .398 in data .30 giugno 1929 puhblicata sul Giornale :\lilitare Ufficiale: Equipaggiamento, Adozione dei materiali per sciatori e per truppa da montaf!.1/CJ.


col~1re si limitava a descriverne le caraneris t iche generali. a stabilirne le proporzioni numeriche su cento paia in base alla lunghezza91 ed a scegliere, come materiale costituente. il legno di hickory al posto del frassino utilizzato fino ad allora.
:t\el docume n to era il lustrato rauacco Iluìtfeld m()( l. 1928 che rispecchiava. nell'impianto generale, quello in dotazione prima della guerra. ma che contemp!a,·a. al posto della le, a a snodo per tenere il piede dentro la staffa, una leva di tensione detta Ellej.i;en.
La misura minima dei bastoncini venne fissata in 1.--6 m. ed il materiale impiegaro era il legno di frassino o di nocciolo senza nodi o lesioni e be n stagionato.
Ovviamente la circolare non contempla,·a altri tipi di sci anche perché quelli da fondo, oltre a non essere in dotazione ed in uso comune, veni\·ano utilizzati unicamente dagli atleti per le gare e, comunque, il loro impiego crebbe solo dopo la de ludente esperienza olimpica del 192'-l.
Dopo questo documento ne seguirono altri. ma ciascuno contemplava solo piccole modifiche ai singoli ma te ri a li ; varia n t i che non compo1tavano grosse innovazioni tecniche sull'uso degli sci.

In campo militare rurta\"ia, come ebbe modo di ossef\'are il Gen. Ottavio Zopp i, la lunghezzn degli sci poteva rappresentare un p rob lema in quanto il terreno, che non era sempre innevato o facile da percorrere con gli sci nei piedi, imponeva tal\·olta di coglier~eli e procedere a piedi. se non addirittura arrampicare, pe r poi tornare a ca lza rli per procedere nu ovame n te su lla neve.
Bic;ogna\'a quindi pensare a come trasportarli senza che costit uissero un impedimento; era cioè un problema analogo a quello già b rill antemente riso lto per i Be rsag lieri con l'adozione della bicicletta pieghe\ ole.
Per risolvere il quesito, negli anni trenta, furono condotti vari esperimenti, il più importante di q u esti, studia to da l Cap. deg li Alpini Enrico Silvestri, riguardava la possibilità di ric.lLm-e la lunghezza degli sci. piegandoli a metà e riponendoli nello zaino. per facilitarne il traspo110.
91.,u 100 paia dc" e, ano essere così distribuiti: n. 50 da 2 a 2.05 m.: n. 15 da 2,10 a 2.15 m.: n. 5 da 2.20 a 2.25 m ..


Il sistema, chiamato "1934··, era ouenuto tagliando in due lo sci all'altezza della placca dell'attacco, dove appoggia lo scarpone, e tenendo unite le due parti mediante un sistema di leve e di viti a farfalla.
In pratica quando lo sciatore utilizzava lo sci questi veniva disteso e le due parti erano unite tra di loro ed inigidite da due lamine di ferro fissate sui bordi dello sci ed unite tra di loro, unite posteriormente, da una lamina metallica che veniva a trovarsi sotto il tacco dello scarpone ed era fissata da una vite a farfalla; quando, invece, lo si riponeva era suffici.ente svitare la vite e ripiegare i due elementi.
Per collaudare la fattibilità e la funzionalità del sistema, furono approntate diverse paia di sci e date in esperimento ad alcuni repani Alpini per le prove pratiche, ma nonostante l'entusiastico parere del Cap. Silvestri le diverse sperimentazioni diedero sempre esito negativo sia per la scarsa qualità del materiale utilizzato sia per la scarsa praticità e maneggevolezza del congegno.
Si ripiegò quindi sull'antico sistema di legare gli sci sullo zaino, ma l'idea non morì e verrà ripresa trent'anni dopo dagli Alpini Paracadutisti.
Solo nel 1941, la Scuola Militare Centrale di Alpinismo, Ente che istituzionalmente aveva il compito di studiare e sperimentare i nuovi attrezzi da adottare e le nuove tecniche di impiego degli sci, riuscì, come abbiamo già visto. ad emanare una pubblicazione92 in cui, insieme alla tecnica sciistica ed alla metodologia d'insegnamento, erano descritti i materiali in uso.
Nel primo capitolo, in particolare, venivano illustrate le caratteristiche sia degli sci detti da turismo, con la suddivisione in sci da discesa, da fondo e da salto, sia quelle degli sci per reparti militari.
La differenza era rappresentata dal fatto che mentre lo sci da turismo doveva fornire il migliore rendimento assoluto tecnicosportivo individuale (velocità-equilibrio-tecnica-stile), quello militare era soggetto alle esigenze connesse con l'impiego eminentemente collettivo in cui si preferiva sacrificare in parte la velocità per privilegiare la robustezza, la maneggevolezza e la


facilità di trasporto a spalla in luoghi di difficile percorribilità.
Per ottenere queste caratteristiche lo sci militare era più largo di quello turistico (da 72 a 75 mm . all'attacco), notevolmente più corto, con spessori maggiori e con le code irrobustite .
Nel medesimo capitolo un paragrafo era dedicato agli attacchi; anch'essi, infatti, avevano subito un aggiornamento; il vecchio attacco Huitfelci era stato sostituito cla un nuovo tipo che permetteva anche una trazione diagonale e che venne detto a staffa fissa.
Infine venivano illustrare le caralteristiche dei bastoncini, gli adesivi in tessil foca, eia utilizzarsi per procedere in salita, e le scioline, estremamente urili per dare scorrevo lezza e velocità agli sci.
la pubblicazione cli questa L,;truzione avvenne, pu1troppo, a guerra iniziata e la necessità di dedicare tutte le risorse del Paese allo sforzo bell ico, impedirono alla Scuola di continuare la prevista attività cli 1icerca e sperimentazione cli nuovi materiali da adottare.
Attività che verrà ri presa, solo nel secondo dopoguerra, dalla ricostituita Scuola Militare Alpina.
La seconda esplorazione del Polo Nord con il dirigibile ITALIA, progettata ed organizzata dal Generale del Genio Aeronautico Umberto Nobile, era prevista per il maggio del 1928.

Di essa facevano patte, in rappresentanza dell'Esercito, anche otto Alpini al comando del Capitano Gennaro Sora 93 in rappre-
93CAP ITA's:O GENNARO SORA : Nato il 18 novembre 1892 a Faresto (BG) . L'll aprile 1915 venne nominalo Sottorenente <li comp lemento ed assegnato al 5° reggimento Alpini; il 26 luglio 1916 trans ita net servizio attivo. nel 1921 viene trasferito al 6° Alpini con il grado di Capitano. Nel grado di Magg iore partecipa alla guerra d'Abissinia del 1936 nell'8" Brigata mista cc.nn. Pusleria. Dal 1937 è Comandante del hattaglione H?oi-k Amba fino al 12 aprile 1941 quando viene fatto prigioniero al Passo Marde Arussi (A.0.U. Colonnello nel 1945, è collocato in congedo il 18 novembre 1948 Muore il 22 giugno 1949 a Foresto Sparso CBG). Venne decoralo di 3 M .A.\'.M., 3
M.I3.V.M. e 1 C.G.V.M ..
sentanza dell'Esercito; il gruppo di uomini si affiancava a quelli dell'Aeronautica e della Marina, a simboleggiare l'unità di intenti di tutte le componenti delle Forze Armate.
Lo c;copo della partecipazione era di avere a disposizione degli elementi e dei dati che consentissero di val u tare eventuali impegni in regioni artiche. in funzione delle attitudini personali ed ataviche ad operare in climi freddi .
Il drappe ll o era composto dal Capitano Gennaro Sora ciel 6° Alpini, dai Sergenti .'.\Iaggiori Giuc;eppe San<lrini del 5° e Giovanni Gualdi del l 0 , dal Caporale Giulio Bich del 4°, dagli Alpini Beniamino Pellbieri. Giulio Gucdoz. Mario Dariarcl del -¾ 0 e Angelo Casari e Silvio Pedrotti del 5 ° Alpini.
Erano elementi questi, scelti dall'Ispettorato fra tutte le guide ed i portatori, in grado di dare un completo affidamcnco ed un fattivo contributo allorquando le circostanze avessero richiesto l'opera di esperti di ghiacci e di abili sciatori.

La missione ebbe inizio il 20 marzo 1928 con la partenza dal porto cli La Spezia a bordo della nave Città di lV!ilauo: unica eccezione. il Cap. Sora che aveva preceduto il gruppo. via terra fino alla Baia del Re , sede della base operativa della spedizione ciel dirigibile ITALIA.
Giunti alla Baia del Re gli Alpini contribuirono all'allestimento della bas~ e, all'arrivo del dirigibile il 6 maggio, furono ad ibiti alle atti\ ità di manovra e di ancoraggio dcll'aeronm e fino al giorno della partenza dell'JTALIA alla volta del Polo ~ord, avvenuta il 23 maggio.
Durante il ritorno dal Polo il dirigibile ITAL IA fece naufragio sulla banch isa polare ed il silenzio radio che ne seguì convinse la base operativa che era necessario iniziare immediatamente le ricerche di eventuali superstiti.
Il 27 la nave Cillà di Milano salpò dalla Baia del Re verso la zona del Kew Friesland, dove si presumeva potesse essersi verifica lo il naufragio dell'aeronave; lo spessore del ghiaccio costrinse, però, la nave a gettare l'ancora nella Baia della Maddalena senza poter raggiungere la zona prestabilita.
Il Cap. Sora chiese allora al Comandante della na,·e. Capitano di Fregata Romagna, l'autorizzazione a sbarcare con i suoi Alpini per potere raggiungere via terra la zona dove si supponeva fosse caduto il dirigibile ed iniziare le ricerche con esplo-
razioni a piedi; ma il Comandante , sentiro il parere di un cacciatore di foche del posto di nome Valclemar Kramer, consenti di far partire, con il cacciatore , il sol.o Sergente Maggiore Sandrini con l' Alpino Pedrotti e i due sucaini94 Albertini e Matteoda (schizzi n. 3, 4 e 5).
Nel frattempo il Città di Milano, con a bordo il Capitano Sora che fremeva per l' inattività, era ritornato alla Baia del Re dove, ai primi di giugno era giunta anche la baleniera Braganza appositamente noleggiata per le possibJlità che offiiva di navigare con una certa facilità nella zona artica.
Il Cap. Sora , dopo numerose discussioni con il Comandante Romagna, riuscì a salpare il 3 giugno sulla Braganza con il Caporale Bich e gli Alpini Casari e Pellisieri alla volta di Mossel Bay dove la baleniera gettò rancora il giorno 4.
L' Ufficiale italiano ed i suoi Alpini iniziarono subito le ricerche addentrandosi verso l' interno quando, 1'11 giugno, vennero raggiunti dai cinque sciatori della pattuglia Sandrini con la sospirata notizia che Nobile era sul pack, a nord della Terra di Nord -Est.
Ancora una volta nacquero dei contrasti su come condurre le ricerche ed ancora una volta il Cap. Sora riuscì , seppure a fatica e dopo essersi appellato telegraficamente a Roma , ad imporre la propria partecipazione attiva alle ricerche.
Tornati a bordo della Braganza, il 13 giugno , gli Alpini ripartirono verso Capo Nord da dove, si calcolava , mancassero circa 80 miglia in linea d ' aria per raggiungere la Tenda Rossa dei naufraghi.
Nel frattempo si era saputo che in direzione di Capo Nord, da circa 15 giorni , erano in marcia un grnppo di naufraghi che, guidati dal Comandante Mariani , si erano staccati dalla Tenda Rossa95; per soccorrere questo gruppo , venne organizzato dal danese Warming, dal Caporale Biche dall'Alpino PelJisieri , sbarcati dalla Braganza, un piccolo deposito viveri sulla banchisa.
94 Sucaini: tem1ine us ato per indicare i So c i d e lla Se zione Unive rsitaria del Club Alpino Italiano (S.U.C.A.L), fondata nel 1905.
95 U dirig ibile ITALIA aveva a h o rdo, come dotazi o ne di emergenza, una tenda di co lor rosso ,per facilitarne l'individuazione , c h e v e nne utilizzala dal Ge n . Nobil e e dagli altri superstiti dopo la caduta dell"aeronave.

Reimbarcati i tre, la Braganza riprese la navigazione fino ad ancorar-,i sui ghiacci di BeYerly ~ound da dm e fece part ire la spedizione a piedi per la ricerca di Nohile.
Da questa spedizione. composta dall'Ingegnere danese Ludo, ico \'larming. dalrolandese Dongen e dal Cap. ~ora. vennero e!:>cl usi tutti gli al t ri gli Alp ini. nonostante le accorate proteste clell·ufficiale.
La pattuglia, composta da tre uomini. una murn di cani e due .slitte, partì dalla Braganza il 18 g iugno con il compito d i intercettare il gruppo di naufraghi che si era staccato dalla Tenda Rossa. fornire loro Yh eri e medicinali e proseguire per portare !>Occorso al generale >loh il e ed a qua n ti erano rimasti con lui nella Tenda.
Dopo due giorni \,'arming rientrò sulla nave perché non era in grado di soppo1tare le fociche e la spedizione proseguì con due soli uomini tra innumerevoli diffico ltà, non ultima la fine dei \"iveri che costrinse ~ora ed il suo compagno a cibarsi dei cani da slitta per non intaccare le scorte clestinace a i'\obile.
I due proseguirono le ricerche fino al 12 l uglio quando vennero son·olati e recuperali da tre piccoli idron)ianti non cge:,i e portati in salvo sul Cillcì di J!ilcmo dove :,,i riunirono con i naufraghi de ll a Tenda Rossa recuperali nel frattempo. con i super-;titi del gruppo ~lariano e con gli otto Alpini che si erano tra!:>leriti dalla Brap,cnzza.
Nonostante il positivo epilogo. la spedizione de l dirigibile ITALIA al Polo ord acce-,e numerose polemiche in Italia.
Tutt;n ia. al di là degli errori e delle indecisioni dei singoli, l'eroico comportamento de l Capirano Sora e dei sui otto Alpini sciatori rimase quale pagina indelebile nella storia delle spedizioni polari.
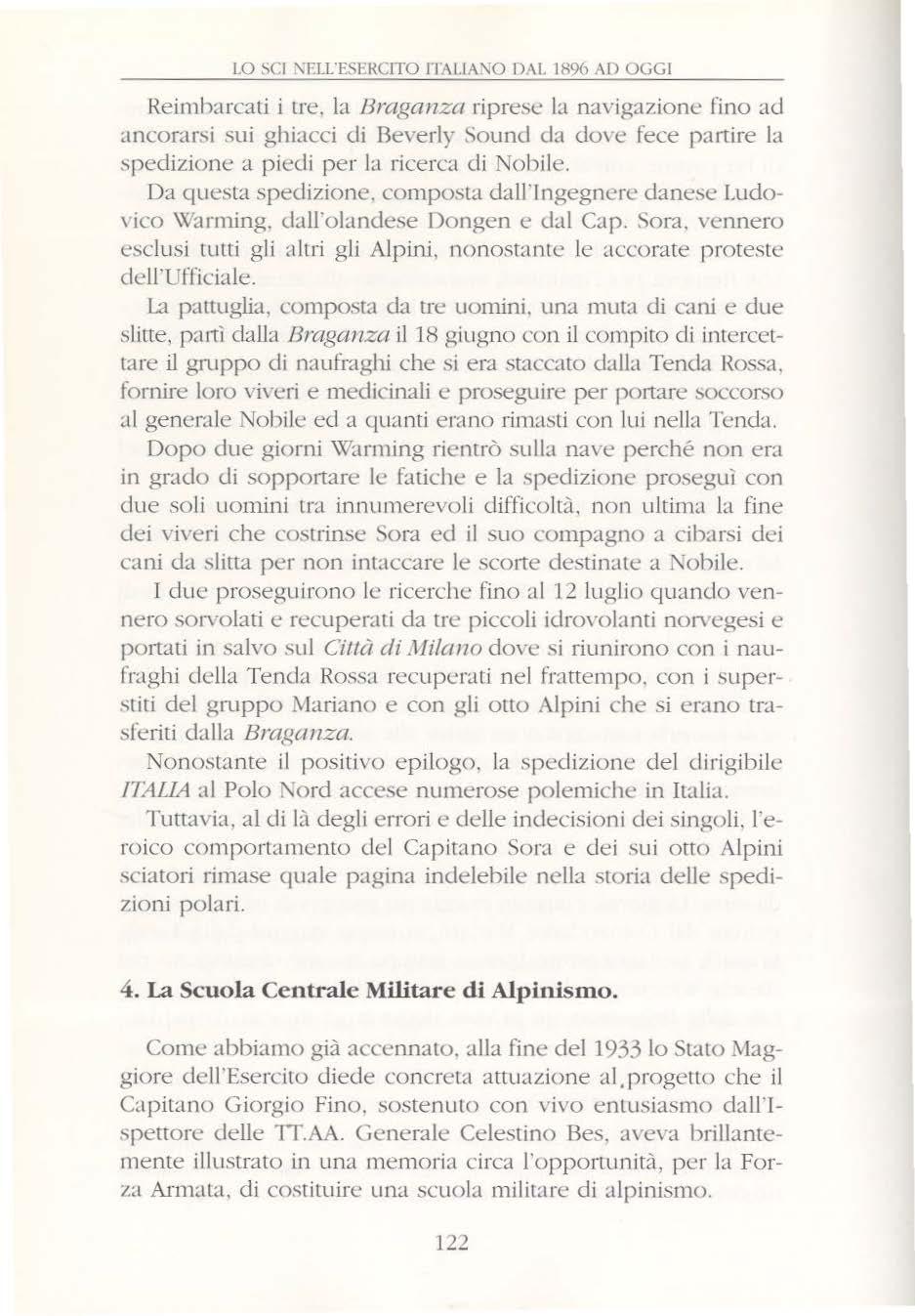
4 . La Scuola Centrale Militare di Alpinismo.
Come abbiamo già accennato, alla fine del 1933 lo Stato :ì\Iaggiore dell'Esercito diede concreta attuazione al. rrogcuo che il Capitano Giorgio Fino, :,ostenuto con vivo entusiasmo dau·1spettorc delle TI.AA. Generale Celestino Be.:;, aveva brillamemente illustrato in una memoria circa l'opportunità, per la Forza Armata. di costituire una scuola militare cli alpinismo.
Il compito del nuovo organismo era di formare sciisticarnente ed alpinisticameme dei Quadri che fossero in grado di portare nei reparti, con unicità di indirizzo, i dettami cli una moderna ed avanzata tecnica sciistica ed alpinistica.
l'bpenore non aveva per'>o tempo e. in arre-;a della sanzione ufficiale che awenne con Regio decreto pubblicato sul Giornale ~lìlìtare96 il 19 marzo 193 J con la circolare n. 292, aYeva definito gli organici e :-.uperaro le comprensihili resbtenze dei Comandanti di reggimento che temevano di vedersi privati dei migliori elementi a , :-i maggio del nuo,·o Istituto.
La Scuola n~nne inaugurata il 9 gennaio 1931. con una semplice cerimonia, nell'aula Con:-.iliarc del Palazzo di Città di Aosta ed as:-.unse il nome di Scuola Centmle Jlilitare di ,llpinismo
DUCA DEGLI ABRl ·zzr.
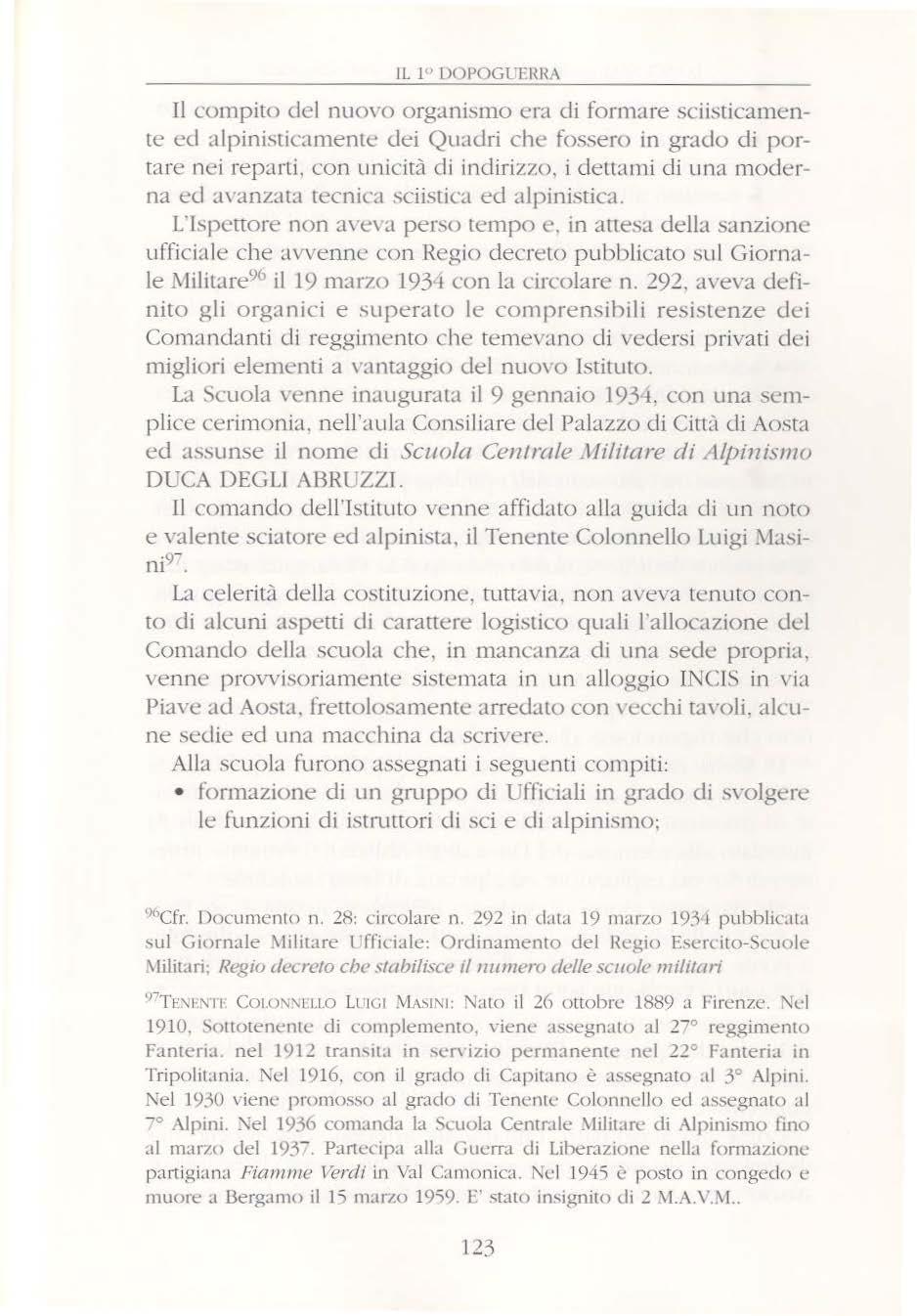
Il comando dell'btituto venne affidato alla guida di un noto e valente sciatore ed alpinista, il Tenente Colonnello Luigi ~ta-,i.9rn
La celerità della costituzione. tuttavia. non aveva tenuto conto di alcuni aspetti di carattere logistico quali l'alloca7ione dd Comando della scuola che, in mancanza cli una sede propria. venne provvi'-oriamente sistemata in un alloggio INCIS in via Piave ad Aosta. frettolosamente arredato con \ ecchi ca,·oli. alcune sedie ed una macchina da ~crivcrc.
Alla scuola furono assegnati i seguenti compiti:
• formazione cli un grnppo di Ufficiali in grado di svolgere le funzioni di istruttori di sci e e.li alpinismo;
9<,cfr. Documento n. 28: circolare n. 292 in data 19 marzo 1931 puhblicua
'>lii Giornale \ltlitare l ffit iale: Ordinamento del lkg10 Esl'ruto-Scuole \WirarL Regio decreto cbe stabilisce il munero delle scuole militari
,rTt-"\f-1\TI Crno'l,1:1.LO LUIGI 'vlA'ill\1. Nato il 26 ottobr<.' 1889 a Firenze. 'kl 1910, \ottocenenie di complemento. viene as-,egnato al 2ì 0 rl'ggimento Fancl'ri.1. nel 1912 cran-.it:i in '>en izio pt:rmanent<.' nel 22 ° Fancena 111
Tripolit:111ia. Nel l 916, con il grado cli Capitano è a-,segnaro al j 0 Alpini. I\'el 19:SO , ·iene promosso al gr:1clo di Tenente ColonndJo ed as:.egoato al - o Alpini. ~el 1936 comanda la Srnola Centrale .\lilit.m:' di Alpmhmo fino al mar/O del 193-. Partt.·urx1 alla (;uerra dì Liberazione nella formazione partigiana Fia1nme Verdi in Val Camonica. l\el 19--15 è posto in congedo l' muore .1 Bergamo il 15 m.irzo 1959 r' stato insignito di 2 .\I.A.\.J\I
• sLesura e successivi aggiornamenti di una regolamcnrazione tecnica uniforme per tutte le TI.AA.:
• preparazione di "piccoli condottieri"' (Ufficiali e Sottufficiali destinati all'addestramento tecnico ed all"impiego di piccoli repa1ti );
• reclutamento ed addestramenLo dei Souutficiali delle TT.AA.;

• studi ed esperienze su materiali cli vestiario e di equipaggiamento:
• studio di problemi tattici e logistici legati alla montagna;
• adc.lesrramenro di Militari di Truppa alle funzioni di Capi cordata (Alpieri):
• corsi per accademi<.:L guide e portc1tori.
La nocizia della costituzione della Scuola suscitò un immediato interesse tra ,asti strati dcll·opinione pubblica e lo stesso Sommo Ponrcnce Pio XI, l'a lpinista Papa Achille Ratti, inviò al Coman<lo dell"Istituto un messaggio augurale ed una sua fotografia con la seguente dedica: ··Grande maestra è la montagna: insegna il prudente coragRio, son·egge l'intelligente ~/orzo al raggiunp,i.menLo di altissime nzete, al'cicina a Dio e ne rirela come poche altre creafltre la maestà, la bellezza. la provl'ida potenza"·.
Per trovare una sede adeguata alla Scuola l'lsperroraLo de ll e TT.AA. affidò al Cap. Fino l'incarico di reperire in Aosta un edificio che rispondesse alle necessità.
La scelta cadde sul Castello di Beauregard, già appartenente ai Baroni Jocteau. che sorge alla periferia Est della città di fronte al massiccio del Monte Emilius-Becca di Nona; l"edificio fu int itolato a ll a memoria del Duca degli Ab ruzzi, il Principe Amedeo di Savoia esploratore ed alpinista di fama mondiale.
Sin dai primi giorni di esistenza iniziarono i corsi di sci che. in virtù de ll 'abbondante innevamento, si svolsero, inizialmente, a Ponte Suaz, alla periferia di Aosta, per proseguire poi a Pila, a Cogne, a La Thuile ed al Piccolo San Bernardo.
Durante l'estate, conLemporaneamente con la svolgimento dei corsi di alpinismo, l'Istituto diramò, ad uso esclusi\ o degli allievi, il primo m.anuale di tecnica di arrampicata su roccia e ghiaccio. ·
Come già accennato, unitamente ai corsi sci e roccia, nel dicembre dello Messo anno si era costituito, presso la Scuola, il Nucleo pre-olirnpionico, alla guida del Capitano Enrico Silvestri,
per la preparazione della rappresentativa mi litare italiana alle Olimpiadi di Garmisch del 1936 .
Dopo la vittoria olimpica il Nucleo si trasformò in un nuovo repa1to dell'Istituto: il Nucleo Pattuglie veloci sci-alpine.
Nel 1935 la Scuola andava perfezionando i metodi di insegnamento e le attrezzature sci-alpinistiche e scientifiche, dedicandosi, inoltre, allo studio ed alla stesura di una carta delle valanghe dell'intero arco alpino e della dorsale appenninica.
La durata dei corsi era di circa 30 giorni ed i programmi, calibrati sul tipo degli allievi e sulle finalità dei corso , comprendevano , oltre alle attività pratiche, lezioni riguardanti la geologia alpina, le valanghe ed i ghiacciai, il clima e la vegetazione delle Alpi, la guerra alpina: venivano, inoltre, effettuate delle proiezioni didattiche cinematografiche di tecnica di roccia e di sci e delle conferenze illustrative di spedizioni a carattere alpinistico .
Il pesante e complesso carico ad<lestrativo portò ad un potenziamento della Scuola che, con la costituzione del battaglione Duca degli Abruzzi in data 16 gennaio 193698 , assunse la configurazione di un Ente complesso con i seguenti organici:
• un comando;
• una sezione sci-alpinistica;
• una sezione studi ed esperienze;
• un laboratorio cine-fotografico;
• un laboratorio di fisiologia applicata per lo sport di alta montagna;
• il battaglione Alpini Duca degli Abruzzi su:
• Comando di battag lione;
• plotone comando;
• 8T compagnia Alpini;
• 88" compagnia Alpieri;
• 89a compagnia Allievi Sottufficiali;
• personale di inquadramento per i corsi per Alpieri, per i Militari di Truppa dei reggimenti Alpini;
• una biblioteca con annessa cartoteca;

• un ufficio amministrazione;
• un museo di minerali, fauna e flora alpina.
Il 20 marzo 193- il Tenente Colonnello Luigi \!asini cedeva il comando della Scuola al Colonnello Giacomo Lombardi; si concludeva così la delicatissima fase di impostazione e l'Islituto, per la modernità delle tecniche adde-;rraciYe. per le imprese ,;ci-alpinistiche portate a termine e per le prestigiose affermazioni sportive, ave,·a ormai acquistato una cale fama e prestigio. :,ia in campo nazionale che internazionale. da e'ìsere considerata all'avanguardia in Europa e nel mondo intero.
Il r dicembre 1938. il Re \'inorio Emanuele II con<..esse .1l1J Scuola lo stemma araldico con il mono ARDISCI B Cf?J~DI che costituirà lo stimolo morale per tutti quei gio,·ani. Quadri egregari, che si formeranno sciisricameme ed alpinisticamente sulle montagne della Valle <l'Aosta.
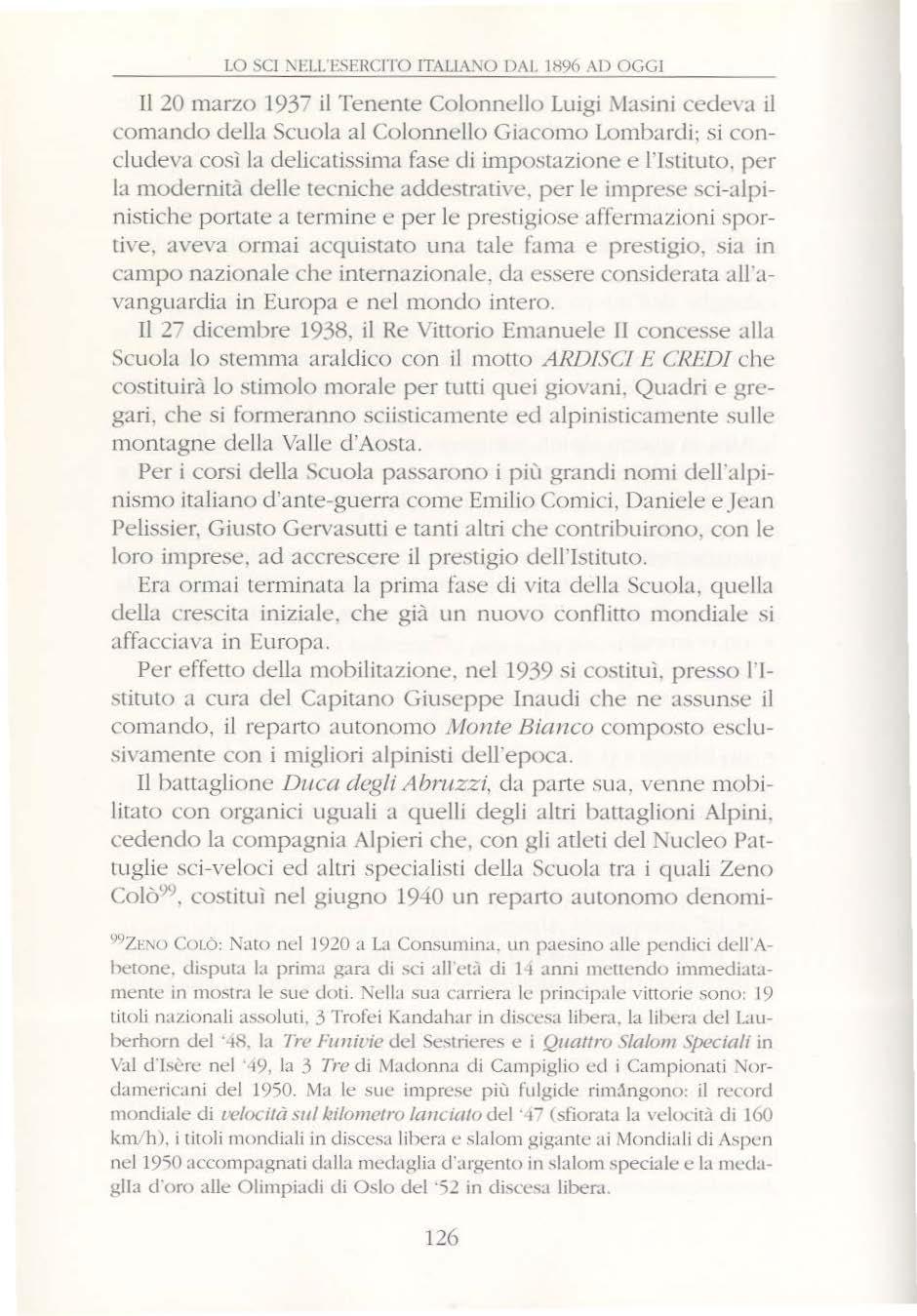
Per i corsi della ~cuola passarono i più grandi nomi delralpinismo italiano d'ante -guerra come Emilio Cornici, Daniele eJean
J>elissier, Giu,;to Gervasutti e tanti altri che contribuirono, con le loro imprese, ad accrescere il prestigio dell'Istituto.
Era ormai terminata la prima fase di vira della Scuola. quella della <..rescita iniziale. che già un num o conflitto mondiale si affacchn·a in Europa.
Per effetto della mobilit:.17ione. nel 1939 si costituì. presso l'!stituto J cura del Capitano Giuseppe Inaudi che ne assunse il comando, il reparto autonomo 1llonte Biancu composto esclusivamence con i migliori alpinisti dell'epoca.
Il battaglione Duca degli Abruzzi, eia parte sua. venne mobilitato con organici uguali a quelli degli altri battaglioni Alpini. cedendo la compagnia Alpie1i che. con gli atleti del I\ucleo Pattuglie sci-veloci cd altri specialisti della Scuola tra i quali Zeno Colò'>'>. costituì nel giugno 19'!0 un reparto auLOnomo clenomi-
'NZF,o Crn.ò: Kato nL'I 1920 a L.1 Consumina. un paesino alle pendici dell'Abetone. <.fo,puta l.t prima gara di ..,ci ali <.:l:i di I J anni rm:uendo 1mmeclialamentl' in moMra le su<.: doti. ì\ella .sua carriera I<.: principale vittori<.: sono: 19 titoli nazionali a..,..,oluti. 3 Trofei Kandahar in Ùi'>Cl''>a libera, la lih<.:ra del L1uherhorn dd '-th la fre F1111icie del St:..,t1R·re!' e I Quattru <.,/alom \peciah in Val d'h<.:re nel 19. la 3 Tre di ,\ ladonn.1 di Campiglio ecl i Campionati '\Jordamericini del 19'>0. ;\1;1 le sue imprese più fulgide rim;\ngono: il n:cord mondiale di t·elo<.ità sul kilomc>tru lmtcial<> del ,- (sfiorata la velocità di 160 km.h).i titoli mondiali in disces,1 lihera L' slalom gigante ai ,\londiali cli Aspen nel 19'>0 accompagnati dalla medaglia d'argento in -;lalom speciale e la mt•daglla eforo alle Olimpiadi di Oslo del ·:;1 in di..,ce'>a liber.1.
nato Reparto Arditi Alpieri, posto sotto il comando del Capitano Pietro Barhieri.
Con l'inizio delle ostilìtà la Scuola dovette ridimensionare le proprie attività e, pur continuando un'attività sportiva di un certo impegno, nel fehhraio del 1941 infatti si svo lsero a Cortina i Campionati Mondiali di Scì. adattarle ai nuovi compiti che erano tipici di un Ente addestrativo senza, tuttavia, tralasciare l'attività di studio e sperimentazione.
Questa particolare attività si era concretizzata nel 1941 con l'emanazione della pubhlicazione Istruzione sull'uso degli sci. che venne ad affiancarsi a quella già, in vigore, sulla tecnica cli arrampicata su roccia e ghiaccio
Terminata la Campagna su lle Alpi Occidentali del giugno 1940 , il reparto autonomo Monte Bianco venne scio lto e, in sua vece il 18 dicembre fu costituito il battaglione sciarori JtfonLe Cervino.
La Scuola continuò la sua attività di Ente addestrarivo fino all'8 sertemhre 1943 quando, a seguito dell'armistizio, si sciolse accumunandosi allo stesso tragico destino di tante altre unità dell'Esercito che caddero nelle mani <lei Tedeschi, mentre la sua sede divenne teatro di ruberie e saccheggio.



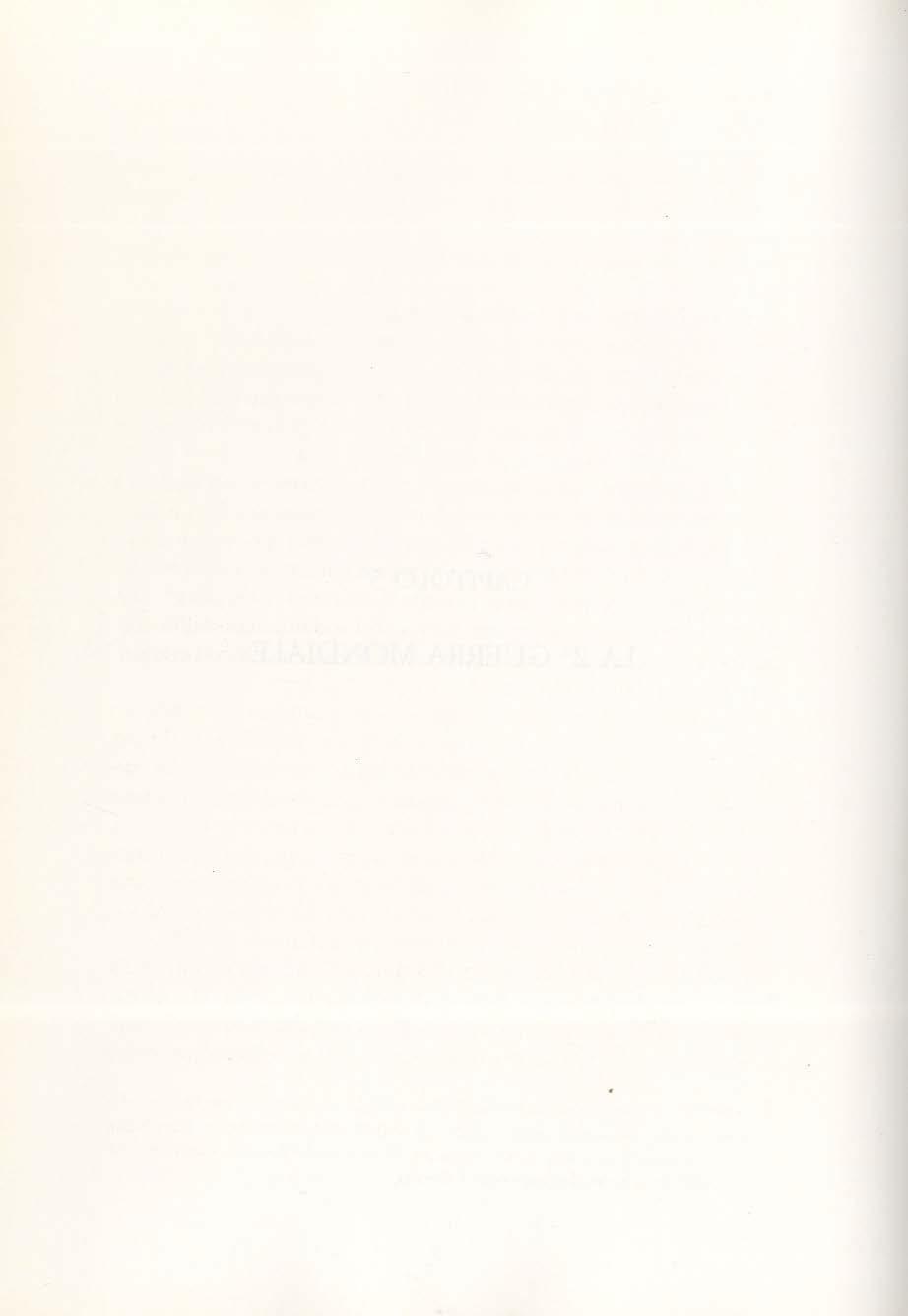
1. 1940: l 'intervento italiano in guerra.
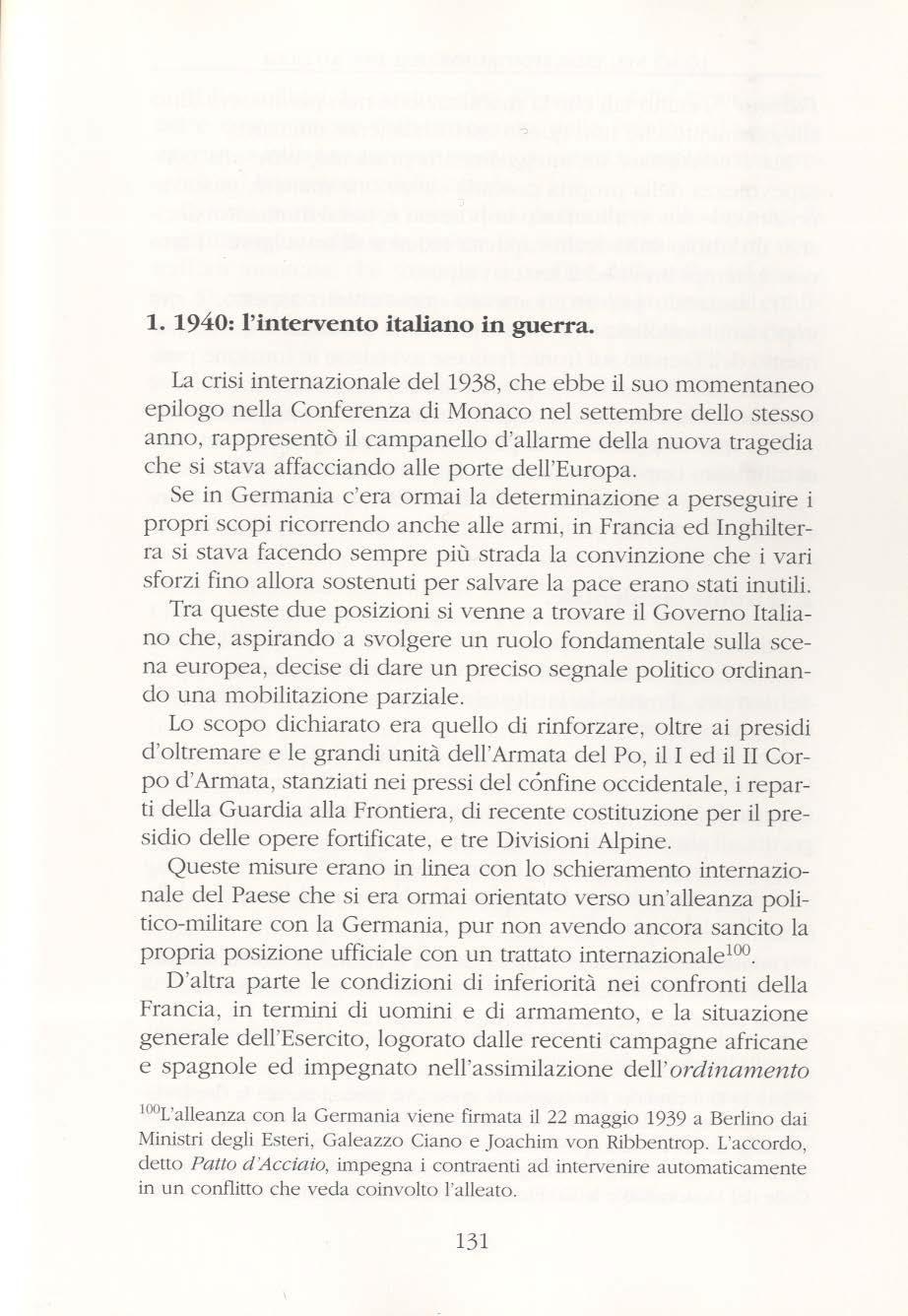
La crisi internazionale del 1938, che ebbe il suo momentaneo epilogo nella Conferenza di Monaco nel settembre dello stesso anno, rappresentò il campanello d'aJlarme della nuova tragedia che si stava affacciando alle porte dell'Europa.
Se in Germania c'era ormai la determinazione a perseguire i propri scopi ricorrendo anche alle armi, in Francia ed Inghilterra si stava facendo sempre più strada la convinzione che i vari sforzi fino allora sostenuti per salvare la pace erano stati inutili.
Tra queste due posizioni si venne a trovare il Governo Italiano che, aspirando a svolgere un ruolo fondamentale sulla scena europea, decise di dare un preciso segnale politico ordinando una mobilitazione parziale.
Lo scopo dichiarato era quello di rinforzare, oltre ai presidi d'oltremare e le grandi unità de ll 'Armata del Po, il I ed il II Corpo d'Armata, stanziati nei press i del confine occidentale, i reparti della Guardia alla Frontiera, di recente costituzione per il presidio delle opere fortificate, e tre Divisioni Alpine.
Queste misure erano in linea con lo schieramento internazionale del Paese che si era onnai orientato verso un 'a lleanza poUtico-militare con la Germania, pur non avendo ancora sancito la propria posizione ufficiale con un trattato internazionale 100
D 'a ltra parte le condizioni di inferiorità ne . i confronti della Francia, in termini cli uomini e di armamento, e la situazione generale dell 'Esercito, logorato dalle recenti campagne africane e spagnole ed impegnato nell'assimilazione dell'ordinamento
10°L'a1leanza con la Germania viene firmara il 22 maggio 1939 a Berlino dai Ministri degli EsLeri, Galeazzo Ciano e Joa chim von Ribbenlrop. L'accordo, deLto PatLo d'Acciaio, impegna i contraenti ad intervenire automaticamente in un conflirro che veda coinvolLo l'all eato.
Pariani101 , erano tali che la mobilitazione non permeneva altro atteggiamento che non quello esclusivamente difensivo.
Ma a consigliare un aueggiamento prudente, oltre alla consapevolezza della propria precaria situazione militare, giocavano altri due fattori altrettanto importanti e, per il momento, decisivi: il dubbio sulla reale capacità tedesca di travolgere i Francesi in tempi brevi ed il teJTeno alpino.
Tralasciando per un momento quest 'ultimo aspetto, è qui importante sonolineare il fatto che tutta la radunata e lo schieramento dell'Esercito sul fronte francese avvenisse in funzione prettamente difensiva e con la possibilità di limitate azioni offensive tendenti esclusivamente al miglioramento della linea di resistenza.
Con queste premesse, di per sé limitative e penalizzanti che al momento opportuno crearono improvvisazione e difficoltà di varia natura, il 10 giugno 1940 l'Italia entrava in guerra al fianco della Germania.
Prima di narrare le operazioni che videro impegnati i reparti sciatori è opportuno dare un breve accenno alle caratteristiche del terreno, limitando la descrizione a l solo settore che vide impegnate queste unità.
Ne l 1940 il confine era quello stabilito il 21 luglio 1860 a Plombières , con la cessione alla Francia della Savoia e della Contea di Nizza da parte del Regno di Sardegna, come contropartita all'aiuto militare francese in chiave ant i austriaca.
In particolare, seguendo criteri geografici ed etnici, il confine correva sempre lungo la dìspluviale alpina tra il bacino del Po e quello del Rodano102 .

101 Ordinamento Pariani: con questa dicirura si intende la riforma ordinativa dell'Esercito, arruaca nel 1939 dal Sottosegretario alla Guerrn e Capo di Stato Maggiore dell'Esercito generale Alberto Pariani. In essa si prevedeva il passaggio dalla classica Divisione ternaria, basata cioè su ere reggimenti, a quella binaria, su due reggimenti.
102Ne l 1940 il confine, pur seguendo pressochè costantemente la displuviate, talvolta se ne distaccava a vantaggio dell 'I talia. Dopo il trattato di pace di Parigi nel 1947, tutti questi salienti non solo sono stati eliminali, ma ne sono stati istituiti altri, a vantaggio francese, come l'alta Val Cenischia, il Colle del Moncenisio e la Val Fredda vicino a Bardonecchia.
Ai fini militari, la caratteristica principale delle Alpi occidentali è rappresentata dalla mancanza delle Prealpi sul versante interno o italiano, sistema montuoso invece ampiamente presente sul lato esterno della catena.
Questa particolarità orografica permetteva alla Francia di organizzare una difesa in profondità, articolata sui due o tre contrafforti montuosi che separano il confine dalla valle del Rodano; al contrario il versante italiano , superata la cresta cli confine , non presenta più ostacoli naturali allo sbocco in Val Padana.
Lo stesso andamento delle valli che, in Italia, da Torino si aprono a ventaglio verso il confine senza vie di comunicazione tra cli loro, se da una parte favorisce l'afflusso dei rifornimenti, dall'altra impedisce la possibilità di travasi di forze da una valle all'altra precludendo ogni possibilità cli manovra per linee interne.
Inoltre la parte settentrionale del confine tra i due Paesi coincideva con il tratto più elevato ed imponente dell'intero arco alpino comprendente il Monte Dolent (3823 m.), punto triconfinale tra Italia Francia e Svizzera ed il massiccio del Monte Bianco (4810 m.) 103
Questo tratto di frontiera, privo di vie di comunicazione e quasi integralmente ricoperto da ghiacciai perenni , era praticabile solo da piccoli gruppi di uomini particolarmente addestrati ed equipaggiati ed impediva ogni operazione di qualche importanza.
Il Corpo d'Armata Alpino, che aveva la responsabilità cli questo settore, vi impiegava la Divisione Alpina Tridentina a cui aveva dato in rinforzo, per il pa1ticolare terreno in cui era chiamata ad operare, il battaglione Alpini Duca degli Abruzzi ed il reparto Arditi Alpieri; in questa zona, inoltre, operava sin dalla mobilitazione del 1939 il reparto autonomo Monte Bianco.

Il battaglione Alpini Duca degli Abruzzi era il battaglione della Scuola Centrale Militare di Alpinismo che, all'atto della mobi-
103n massiccio del Monte Bianco, sul versante italiano, dal Monte Dolent (3819 m. ) al Col de la Seigne (2514 111.) è un'autentica barriera naturale che si erge quasi verticalmente sulle Valli Ferrel e Veny ed è formata dalle Grandes Jorasses (4206 m.), dal Dente del Gigante (4014 m. ). da Punta Helhronner (3470 m.), dal Monte Maudit (4468 m.), dal Monrc Bianco (4810 m ), dall'Aigulles de Bionnassay (4051 m.) e dal Tré la Tece (3920 m.).
litaz ione, aveva modificato la sua particolare struttura organica, per assumere quella di un no rmale battaglione Alpini; in segujto a tale ristrutturazione aveva ceduto la compagnia Alpieri perché destinata a costituire una nuova unità, altamente specializzata, denominata reparto Arditi Alpieri.
Il comando di quest'ultima unità venne affidato al Capitano Pietro Barbieri con i Tenenti Giuseppe Fabre e Giuseppe Lamberti quali subalterni.
Il reparto autonomo Monte Bianco, costituitosi presso la Scuola di Alpinismo a cura del Capitano Giuseppe Inaudi che ne assunse anche il comando, era operativo in zona già dal 1939 ed era costituito da guide e portatori del posto inquadrati da Ufficiali degli Alpini scelti fra i m igliori alpinisti italiani.
Questa unità aveva la responsabilità della catena del Bianco dal Monte Dolent al Col de la Seigne e, per assolvere al compito, era stato articolata in tre sottosettori: Ferret, Gigante e Miage; Comandante dell'intero settore era il Tenente Colonnello Arnaldo Voila.
Alla vigilia della guerra con la Francia il reparto cambiò denominazione assumendo quella di reparto Valligiani Monte Bianco e risultando costituito con il personale della precedente unità completato dagli elementi valligiani, da richiamare, già predesignati per tale repa1to 104
Durante il breve ciclo di operazioni sul fronte occidentale, 2125 giugno, il reparto Valligiani Monte Bianco svolse prevalentemente azioni di pattuglie, con lo scopo di prevenire eventuali aggiramenti, per l'alto, delle unità della Tridentina orientate, come da ordine di operazione n. 1 del Comando del Corpo d'Armata Alpino, lungo la direzione d'attacco: Col de la Seigne - Col Cormet de Roselend, per acquisire i coll i du Bonhomme e del Cormet de Roseland ed assicurarsi lo sbocco verso Beaufort105
Il battaglione Alpini Duca degli Abruzzi ed il reparto Arditi
Alpieri vennero, invece, inseriti nel dispositivo della Divisione
104cfr. Documento n. 30: circolare n. 14500 in data 28 maggio 1940 (U.O.M. Sezione MobiliLazione) Approntamento del Reparto Valligiani Monte Bianco e circolare n. 00320 in data 7 giugno 1940 (U.O.M. Sezione Ord inamento) reparto valligiani Monte Bianco.
105Cfr. Documento n. 31: Ordine di operazioni n. 1 in data 21 giugno 1940 del Comando del Corpo d'Armata Alpino, Ufficio Operazioni.
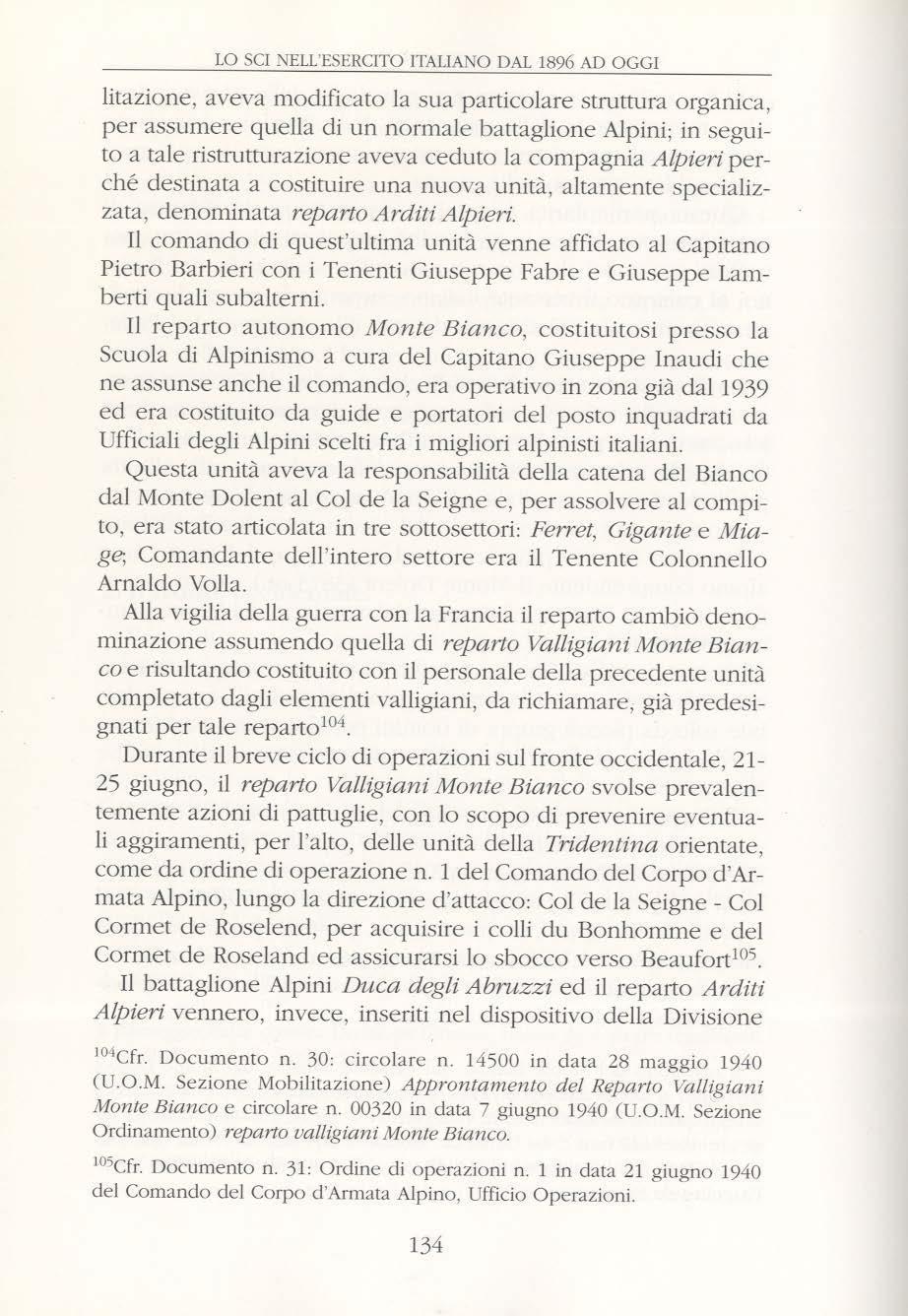
come colonna di destra con due battaglioni del 5° Alpini, agli ordini del Colonnello Carlo Fassi.
Questi, alle 8 del 21 giugno, raggiunto il Comando del battaglione sciatori, venne ragguagliato sull'esatto schieramento dei reparti dipendenti sulle pos izio n i di confine in quel momento.
La 133" compagnia , destinata ad operare al Col d'Oneillon, si trovava a q. 2713, a sud di Col de la Seigne; la 103" a q. 2760, a nord -ovest di Les Piramides Ca lcarées; il reparto Alpieri a q: 3012, nord di Col de la Seigne; 1'87" di rincalzo a q. 2760.

Il Colonnello Fassi illustrò, quindi, al Comandante del battaglione i compiti particolari assegnati alla sua unità: la 103" e 1'87" cp. ed il reparto Alpieri avrebbero svolto un'azione sulla destra e per l'alto in direzione cli Monte Tondu - Col d'Enclave, con gli Alpieri che sarebbero avanzati per la linea di cresta ciel Glacieres des Glacieres in direzione degli obiettivi assegnati dal Comando Divisione alla co lonna di destra (carta n. 6).
Inoltre , essendo ormai prossima l'ora stabilita per l'inizio delle operazioni , fissata per le 09,30, il Comandante del reggimento ordinò di far sconfinare i primi elementi esploranti del battaglione e del reparto Alpieri.
La sera del p1imo giorno di combattimenti , nonostante il tempo in peggioramento , vide il battaglione Alpini Duca degli Abruzzi e gli Alpieri giungere sul Combe Noire, mentre la 133·· cp. occupava il Col d'Oneillon.
Il 22 il battaglione sciatori proseguì la sua az ione fiancheggiante ed alla sera si attestò, con alcuni elementi, sul costone del Monte Tondu, con altri di fronte al Col d ' Enclave e con altri ancora sulla destra dell 'alta Valle des Glacieres.
La giornata del 23 giugno ebbe inizio, per il battaglione sciatori, con un tentativo di sorprendere , nottetempo, le posizioni nemiche di Col d'Enclave , ma la pronta ed efficace reazione francese ne impedì la rea lizzazione, costringendo il battaglione ad attestarsi sulle posizioni raggiunte.
La par ziale battuta d 'arresto venne sfmttata dal Col. Fassi per provvedere all 'alimentazione logistica del Duca degli Abruzzi e degli Alpieri, divenuta particolarmente impellente per le catt ive condizioni ambientali che, rese ancora più dure dal maltempo e dal freddo, avevano provocalo i p1imi casi di affaticamento e di congelamento.
Il giorno successivo il battaglione era ancora attestato sulle linee raggiunte, pronto a sostenere, appena le condizioni meteorologiche lo avessero permesso, l'azione dei battaglioni Tirano ed Edolo quando, alla sera, venne raggiunto dalla notizia dell'armistizio tra l'Italia e la Francia e della cessazione delle ostilità.
Si concludeva così la campagna sul fronte occidentale nella quale la smania di un concreto successo più politico che strategico si era venuta a scontrare con le difficoltà rappresentate da un terreno particolarmente ostile e da un'organizzazione difensiva altamente efficace; difficoltà che solo le capacità dei Comandanti e la dedizione dei subordinati erano riuscite. in parte, a mitigare.
Terminate le operazioni contro la Francia, mentre alcune Divisioni Alpine venivano spostate in zona di mobilitazione, la Tridentina si era portata a i confini con la Jugoslavia per una possibile azione offensiva in quel teatro.
Caduta tuttavia l'opzione operativa nei confronti di quel Paese, ai primi di ottobre Mussolini, che pure già aveva in mente di attaccare la Grecia, ordinò la parziale smobilitazione delle truppe .
A seguito di questa direttiva anche i repa1ti sciatori furono oggetto di un ridimensionamento organico, in particolare: il battaglione Duca degli Abruzzi, tornato alle dipendenze della Scuola Centrale di Alpinismo, venne smobilitaco e definito non più mobilitabile mentre il reparto Arditi Alpieri ed il reparto Valligiani M~onte Bianco vennero soppressi 106.
Rientrato in sede, il battaglione Duca degli Abruzzi riassunse i compiti e la struttura che aveva in tempo cli pace, riassimilando quel personaJe altamente specializzato che aveva dato vita
106cfr. Documento n. 32: circolare n. 14320 in data 8 agosto 1940 (U.O.M.)
Smob ilitazione Reparto Valligiani Monte Bianco e Reparto Guide Valli di Lanzo e circolare n. 24530 in daLa 18 ottobre 1940 (U.O.NI.) Smobilitazione del btg. alpini Duca degli Abruzzi.

al reparto Arditi Alpieri ed il reparto Valligiani Monte Bianco scioltL come abbiamo già accennato, a segujto della parziale smobilitazione ordinata dal Capo del Governo ed iniziata il 25 ottobre.
Nel frattempo, ad Aosta, la Scuola aveva continuato la propria attività di Ente addestrativo con un impegno ed una dedizione tali che, al successivo ordine di mobilitazione dell'inverno 1940, fu in grado di costituire in rapida successione i battaglioni sciatori Jvfonte Cervino e Monte Rosa utilizzando, in particolare per il primo, il personale del battaglione Duca degli Abntzzi e quello in esubero della Scuola stessa.
La necessità di ricostituire almeno un battaglione sciatori, in grado di condurre atti tattici che richiedessero una grande mobilità e capacità in terreni innevati o comunque difficili, era stata avve1tita in Grecia.
In quel teatro operativo, infatti, il fronte si era stabilizzato sul massiccio albanese del Tomo1i a seguito del decisivo intervento delle Divisioni Alpine inviate , in tutta fretta , a tamponare le falle che i Greci, con la controffensiva del novembre '40, avevano aperto nell 'intero dispositivo italiano con l ' intento di tibuttarci a mare privandoci dell'Albania.
Contemporaneamente anche la Scuola Centrale Militare di Alpinismo, sulla sco1ta delle esperienze maturate sul fronte francese, aveva proposto un analogo provvedimento con il fine di costituire un reparto in grado di svolgere servizi di ricognizione veloce su terreni montuosi.
Per fronteggiare questa esigenza la Stato Maggiore dell 'Esercito stabilì, con il foglio n. 008630 (U.0.M.) in data 14 dicembre 1940 , di dare corso alla costituzione, presso il deposito del 4° reggimento Alpini, del battaglione sciatori Monte Cervina1°7 che, a differenza degli altri battaglioni Alpini, aveva due sole compagnie , non numerate progressivamente come da tradizione, ma con l'anomalo numerico di 1• e 2•.
107n battaglione Monte Ceroino venne costituito nell 'inverno del 1915 dal deposito del 4° Alpini , come battaglione di Milizia Mobile. Inquadrava la 133" compagnia e, dal 1916, la 87' e la 103• compagnia , avute dal battaglione Alpini Aosta. Operò a Passo della Borcola, s ul Pasubio , sul Monte Vodice ed in zona del Monte Grappa. Venne dccof'J.to con una M.A.V.M Nel 1919 venne sciolto.

Il tempo stringeva e con il foglio n. 33220 (U.0.M.) del 25 dicembre lo Stato Maggiore ne definì formazione ed organici, data ed ora di approntamento e dotazion i di mobi litazione 108 Comandante di battaglione venne nominato il Maggiore Gustavo Zanelli ed a capo delle due compagn ie furono posti i Tenenti Carlo Maurino e Alessandro Brillarelli, impegnati in que l momento a Cervinia quali istruttori al 4° corso di specializzazione sciistica per Ufficiali subalterni delle Trnppe Alpine, mentre il personale proveniva, in gran parte, da l battaglione Duca degli Abruzzi.
I materiali rappresentarono un'aurentica chicca per quel tempo; al Cervino infatti venne assegnata, o ltre alle normali dotazioni in distribuzione alla Truppe Alpine, una serie di materiali individuali e di reparto cli prima qualità ed in gran parte in corso di sperimentazione e valutazione presso la Scuola di Alp inismo ed un'altra acquistata direttamente dal libero commercio.
In pa1ticolare l'e lemento più di spicco era rappresentato dagli scarponi con s u ole Vibram la cui acquisizione era stata in1rnecliatamente sollecitata dal Comandante di battaglione, il Magg. Zane lli, come si legge sui fogli n. 6 e n. 17 rispettivamente del 26 dicembre 1940 e 12 gennaio 1941 del Comando battaglione Monte Cervino, con oggetto: Materiali speciali per reparti sciatori.
In essi il Magg. Zanelli scriveva: "Il tipo attuale di scarpa da sci a suola di cuoio senza chiodature obbliga lo sciatore a portare nel sacco un secondo paio di scarpe chiodate per terreni non percorribili con gli sci. Questo notevole inconveniente dal punto di vista del peso e dell'ingombro può essere facilmente eliminato adottando scarpe da sci con suole di gomma Pirelli tipo militare (tipo di suola già usata in e:,perimenti per sca,pe da montagna, con ottimo esito). Le sca,pe con suola di gomma possono essere usate senza sci su qualsiasi terreno. Con gli sci presentano il vantaggio che la suola di gomma evita la formazione di ghiaccio sotto la scarpa. fatto frequentissimo con suole di cuoio. Sono inoltre più impermeabili all'umidità, e questa qualità potrebbe essere ancora migliorata con l'ado;zione di conce oleose per la tomaia".
108Cfr. Documento n . 33: foglio n. 33220 in data 25 dicembre 1940 (U.0.M.) Mobilitazione del battaglione sciatori Monte Cervino.
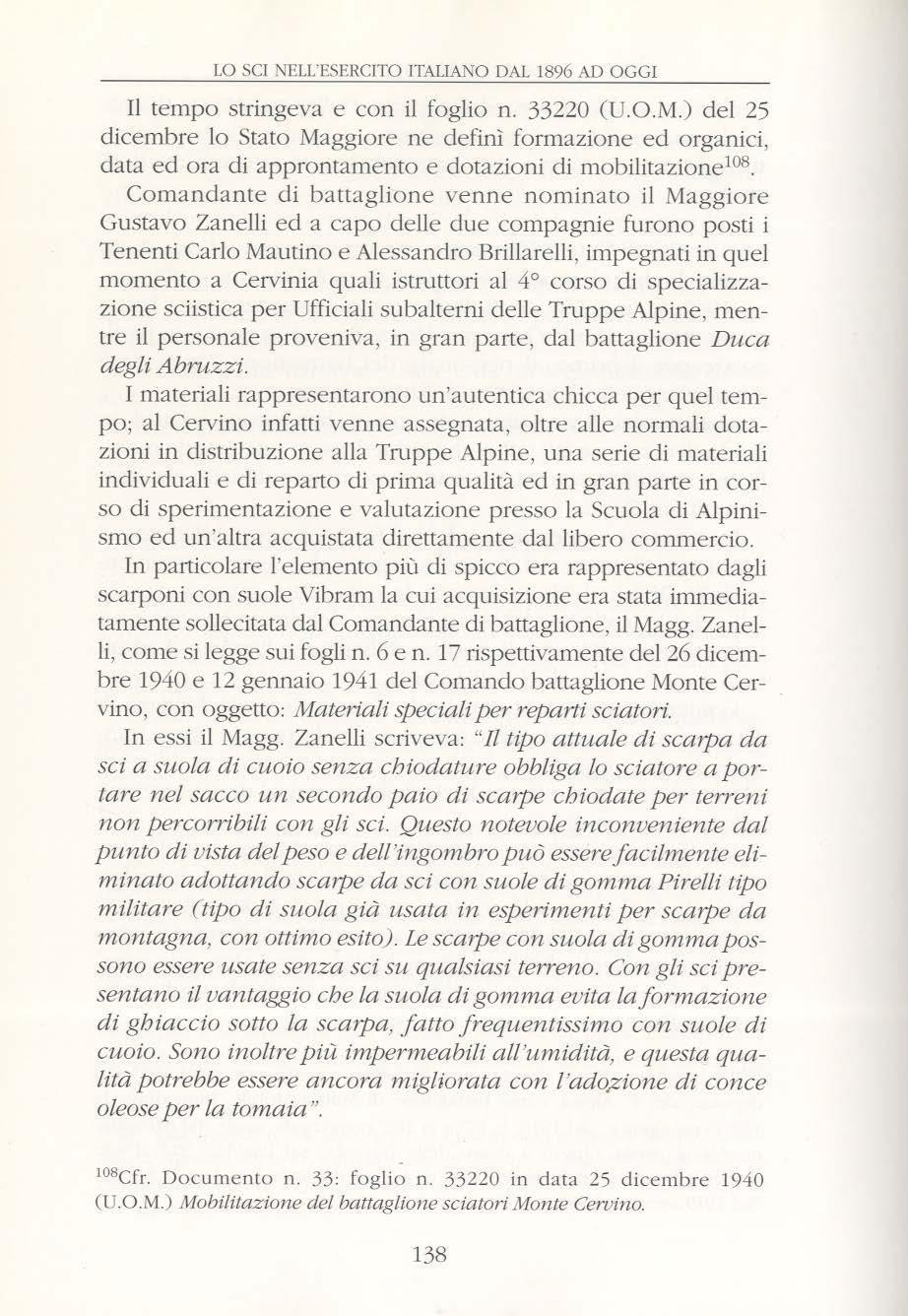
Per l'acquisizione si suggeriva di adottare una procedura snella con l'invio dell'ingente quantitativo di suole Vibram, giacenti presso la PireJli, ad un calzaturificio nel Veneto, specializzato nel confezionamento di scarpe da sci, per approntare il numero di paia ritenuto necessario.
Gli sci erano di frassino muniti di lamine laterali ed erano della ditta Persenico di Chiavenna; questi, sottoposti a prove valutative da parte della Scuola Centrale Militare di Alpinismo, offrivano, rispetto ad altri modelli, il vantaggio di una migliore tenuta a mezza costa su neve dura o ghiacciata, una maggiore scorrevolezza ed un minore deterioramento specie sugli spigoli; nella dotazione degli sci erano compresi, oltre agli attacchi ed ai bastoncini, anche gli adesivi in tessi! foca.

Per il trasporto dei materiali e delle mitragliatrici venivano utilizzati i pratici accoppiatori Staderini costituiti da un telaio metallico scomponibile ed adattabile ad un paio di sci.
Questo sforzo di dotare un repaito speciale di equipaggiamenti speciali fu inutile; il Cervino giunse in Albania il 18 gennaio 1941 ed il 21 era già in linea sul Mali Trebeshines, ma più che la neve trovò il fango e gli sci divennero inutili su quel terreno in cui fango, neve e roccia si mescolavano per rendere ancora più duro ed infido quell ' inverno sulle Alpi alhanesi, ed il Cervino non fu più sci-munito come sostenevano, non senza ironia, gli Alpini.
Nel frattempo in Italia , con il foglio n. 39850 del 13 febbraio 1941, lo Stato Maggiore dell'Esercito stabiliva l'immediata costituzione e mobilitazione di un nuovo battaglione sciatori: il Monte Rosa.
Il Monte Rosa doveva avere formazione ed organici identici a quelli del Cervino : gli Ufficiali, i Sottufficiali e gli Alpini dovevano essere prelevati, inizialmente dalla Scuola Centrale Militare di Alpinismo, quindi dai vari reparti della Divisione Alpina Taurinense, per ultimo dai centri di mobilitazione del I Corpo d'Armata.
In marzo il Monte Rosa giunse in Albania e venne assegnato al XXVI Corpo d'Armata.
La vita dei due battaglioni sciatori fu breve, entrambi, duramente provati dai combattimenti sostenuti, vennero rimpatriati e smobilitati nel maggio di quell ' anno, a seguito del foglio
n. 53580 del 16 maggio 1941 di Ufficio Ordinamento e Mobilitazione.
Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i militari di Truppa superstiti vennero fatti rientrare ai reparti di provenienza, se questi si trovavano in madre Patria o. in caso conrrario, ai rbpettivi centri di mobilitazione; alla Scuola Centrale Militare di Alpinismo rientrò il personale ceduto da quell'Ente.
Gli sci e gli altri materiali speciali furono accantonati presso il centro di mobilitazione dei due bauaglioni che era in comune con il magazzino di mobilitazione del battaglione Aosta ad Aosta.
Per ironia della sorte l'entrata in guerra <lell'Ita lia rappresentò, per la Scuola Centrale ~1ilitare di Alpinismo, una vera fortuna poiché, per effeuo della mobilitazione, il Nucleo Pauuglie Veloci si arricchì di molti fra i più noti sciatori che, richiamati alle armi, venivano assegnati alla Scuola di Aosta.
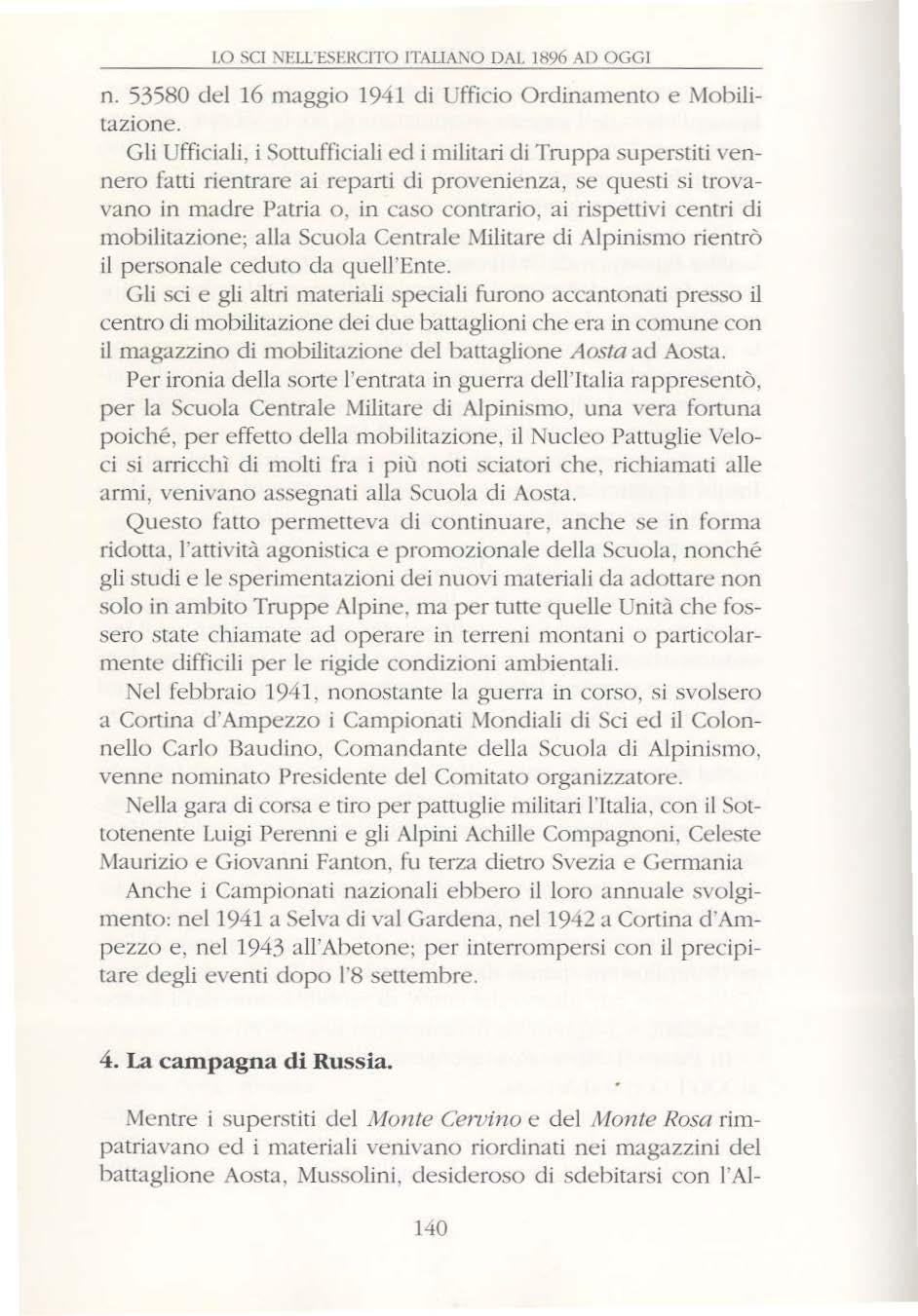
Questo fatto permetteva e.li continuare, anche se in forma ridotta, l'attiv ità agonistica e promozionale della Scuola, nonché gli studi e le sperimentazioni dei nuovi materiali da adottare non solo in ambito Truppe Alpine, ma per tutte quelle Unità che fossero state chiamate ad operare in terreni montani o particolarmente difficili per le rigide condizioni ambientali.
Nel febbraio 1941, nonostante la guerra in corso, si svolsero a Cortina d'Ampezzo i Campionati Mondiali di Sci ed il Colonnello Carlo Baudino, Comandante della Scuola di Alpinismo, venne nominato Presidente del Comitato organizzatore.
Nella gara di corsa e tiro per pattuglie militari l'Italia, con il Sottotenente Luigi Perenni e gli Alpini Achille Compagnoni, Celeste Maurizio e Giovanni Famon, fu terza dietro Svezia e Germania
Anche i Campionati nazionali ebbero il loro annuale svolgimento: nel 19-±1 a Selva di val Gardena, nel 19'¼2 a Cortina d'Ampezzo e. ne l 1943 all'Abetone; per interrompersi con il precipitare degli eventi dopo 1'8 settembre.
Mentre i superstiti ciel .iv!onte Ceruino e del Monte Rosa rimpatriavano ed i materiali venh·ano riordinati nei magazzini del battaglione Aosta, .Mussolini, desideroso di sdebitarsi con l' Al-
leato tedesco per l'aiuto ricevuto in Grecia, dispose la costituzione e l'invio in Russia di un Corpo di Spedizione, il C.S.l.R., da impiegare al fianco delle forze tedesche 109
Con il sopraggiungere dell'autunno si ebbero le prime awisaglie di quello che sarebbe stato l'inverno in quelle latitudini ed il Generale Messe, Comandante del C.S.I.R., rappresentò allo Stato Maggiore la necessità di poter disporre di un reparto alpino, di natura del tutto particolare, in grado di assolvere compiti di pronto intervento spostandosi ed operando, con gli sci, su terreni nei quali questo mezzo di traspo1to trovava la sua collocazione ottimale.
Inoltre avanzava l'idea di costituire dei centri di addestramento sciistici per abilitare rutto il C.S.I.R. ad operare sugli sci.
Del problema venne investita la Scuola Centrale Militare di Alpinismo sia per la costituzione del battaglione sia per !"organizzazione dei centri.
Ne nacque un interessante dibattito tra i tecnici, i responsabili della Scuola e l'Ispettorato delle Truppe Alpine, da una parte e lo Stato Maggiore dall'altra; quest'ultimo, in particolare, sospinto dalla preoccupazione di fare presto chiedeva l'immediata ricostituzione e mobilitazione del battaglione Monte Cervino con i medesimi organici del reparto mobilitato alla fine del dicembre 1940.
A questa so luzione si opposero sia il Comandante della Scuola, il Ten.Col. Carlo Baudino, che l"Ispertorato stesso con acute osservazioni di natura tanica e pratica.
Il primo, tra l'altro, scrisse un'accorata lettera 110 a l Colonne]-
109 corpo di Spedizione Italiano in Russia (C.S.I.R.): fermamente voluto da Mussolini sin dal 1940 per fiancheggiare i Tedeschi in eventuali operazioni contro la Russia, prese corpo nell'estate del 1941, assumendo il 9 luglio la denominazione di Corpo di Spedizione Italiano in Russia (C.S.I.R.). Era a livello di Corpo d'Armata ed era composto da: Unità di Corpo d'Armata, Divisione Pasubio, Divisione Torino e 3" Divisione Celere Principe Amedeo Duca d'Aosta, per un totale di: 62.000 uomini. U trasferimento in Russia iniziò il 10 lu glio e si concluse il 5 agosto. L'll agosto i primi element i italiani avevano U battesimo del fuoco nei pressi del fiume Dniester.
110Cfr. Documento n. 34: lettera in data 1° ottobre 1941 del Comandante della Scuola Centrale Militare di Alpinismo al Colonnello Emilio Magliano
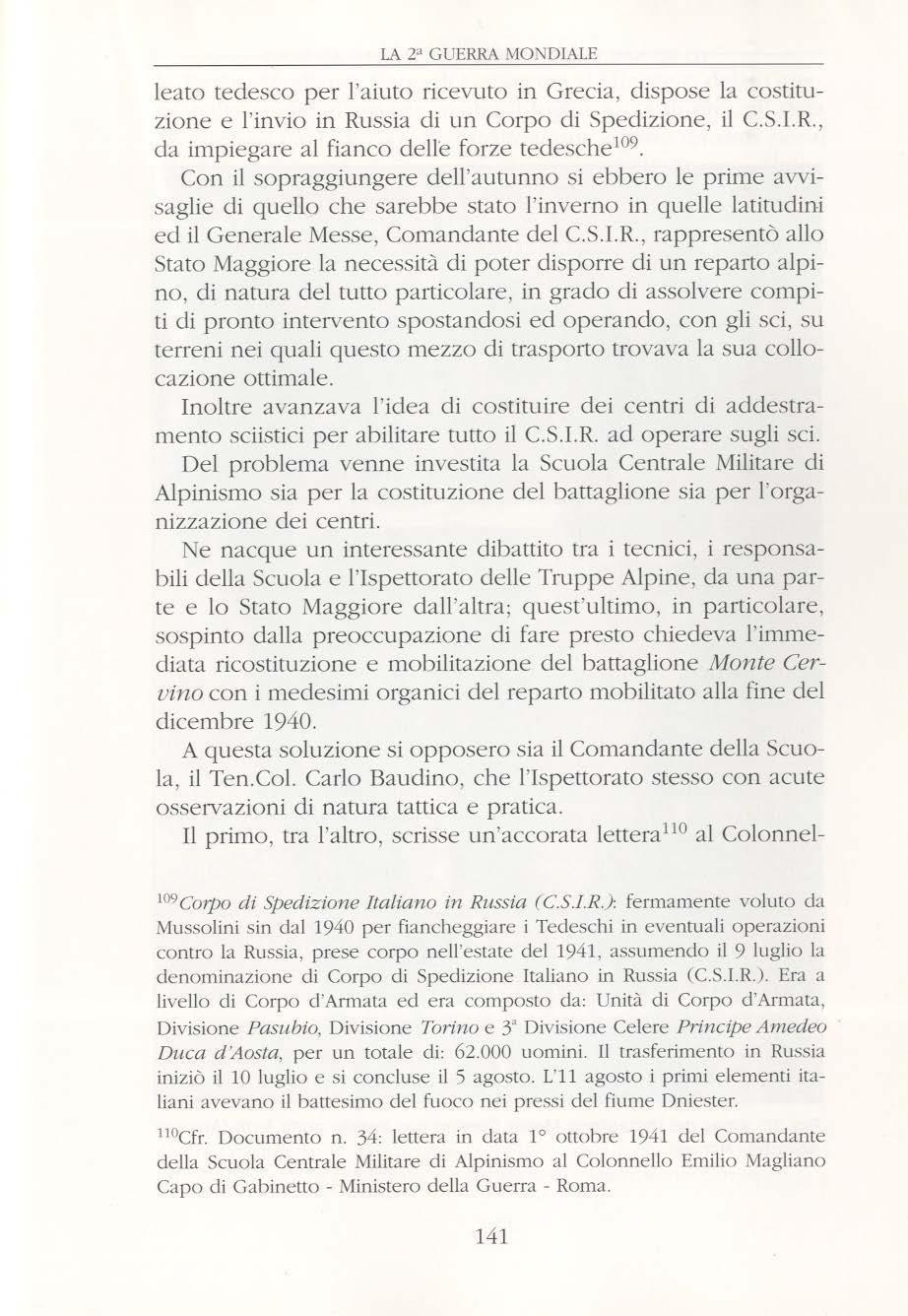
Capo di Gabinetto - Ministero della Guerra - Roma.
141

lo Emilio Magliano, Capo di Gabinetto al Ministero della Guerra. nella quale, allegando anche il foglio n. 24 di prot. in data
1° ottobre 19--!l di oggetto: Battaglione alpino sciatori per il C.S.J.R. indirizzato al Comando Superiore delle Truppe Alpine quale risposta al problema postogli da questi, sosteneva che 'per la guerra inl'ernale debbono essere irnpiegate le truppe create, addestrale ed allenate per la neve ed il freddo. Le truppe del C.S.I.R. anche dopo tre mesi di istruzione non potranno assolutamente muoversi cun gli scr.
Per l'impiego del battaglione era poi convinto che sarebbe staro destinato a far la fine del primo Cervino, utilizzato a compagnie se non a plotoni alle dipendenze di reparti di Bersaglieri e di Fanteria o, come il Monte Rosa. a ricevere plotoni mitraglieri e mortai dai reggimenti di Fanteria, con quei frammischiamenti cbe a livello cli comandahilità creano più problemi che risultati positivi.
Di queste osservazioni si fece carico ed acceso sostenicore anche l'Ispettorato delle Truppe Alrine, tuttavia lo Stato Maggiore. con la circolare n. 74010 de l 6 ottobre 1941 111 , stabiliva la ricm,tituzione e mobilitazione del battaglione sciatori Jfonte Cervino da effettuarsi, a cura del Comando del I Corpo d"Armata, enrro il 30 ottobre con organici pari a quelli del precedente ed aningenclo, per quanto riguarda il personale. alla Scuola Centrale Militare di Alpinismo ed alle unità Alpini cli tutte le Divisioni in territorio purché ahili sciatori; per i materiali e le dotazioni si rimandava a disposizioni a parte dell'Ufficio Servizi ed ad integrazioni ritenute opportune.dall'Ispettora to TT.AA..
Rinasceva quindi il Monte Cerl'inu con personale che. a differenza di quello d'Albania, non era solo del q 0 reggimento. ma proveniva da tutt i i repa rti Alpini ed era per un 30% volontario.
Come Comandante fu .scelto il Tenente Colonnello Mario d'Adda, di origine piemontese.
Nel campo dei mate riali, sulla ba.se dell'esperienze maturate in Albania. si fece un notevole sforzo per permettere al battaglione di panire per il fronte russo nelle migliori condizioni poss ibili e con tutte le dotazioni prev iste.
111 Cfr. Documento n. 35: circolare n. 74010 in data 6 o ttobre 19 11 (L .O.r-.t.) Ricoslìluzione e mobililaz ione del battaglione scia/ori /VI011te Ceruino.

In particolare ad ogni Alpino furono distribuiti. oltre al normale equipaggiamento, una mantellina bianca per favorire il mimetismo sulla neve, un giubbotto senza maniche foderato di pelo d'agnello da indossarsi sotto la giacca a vento, due paia di guanti, due paia di scarponj Vibram e, novità assoluta, un paio di pedule da riposo con suola di cuoio e rivestimento interno di pelo d"agnello.
Le dotazioni del battaglione rappresentavano un'autentica sciccheria in un contesto quale quello dei reparti del C.S.I.R. dove le notevoli distanze dalle basi logistiche, le condizioni delle piste e le temperature rigide che bloccavano gli organi meccanici di quei pochi automezzi disponibili, costringevano il Comando della Grande Unità a soluzioni di ripiego e, talvolta, d'emergenza.
Solo con grossi sforzi e superando notevoli difficoltà si era riuscito. verso la fine del mese di novembre, a distribuire a tutti i reparti in linea una dotazione completa di indumenti invernali limitata, però, aJ!a sola aliquota delle sentinelle. pattuglie e vedette ed a tutto quel personale che, per esigenze varie, era maggiormente esposto alle intemperie.
Anche l'armamento presentava alcune novità; ai Cervinotti, oltre il glorioso ma obsoleto moschetto 91, vennero distribuiti una quarantina di mitra M.A.B. 38 (Moschetto Automatico Beretta mod. :$8)112 destinati agli Lfficiali, ai Sottufficiali ed agli Alpini delle pattuglie che uscivano in perlustrazione; in più ognuna delle due compagnie disponeva di una squadra mitraglieri.
Dunque il Cervino partì il 13 gennaio 1942 dalla stazione di Aosta con destinazione Jassinowataja ìn Russia.
Con il battaglione era partito anche il personale per la costituzione di centri di addestramento sciistico presso il C.S.I.R. come aveva richiesto il Gen. Messe ed avvallato Lo Stato Maggiore dell'Esercito.

Si trattava cli 70 elementi (11 Ufficiali, 21 Sottufficiali e 47 Alpi-
112 Moschelto Automatico Bere/La mod.38 (M.A.B.): deriva dall"omologo mod.18 di cui corn,erva lo stesso meccanismo di scatto a doppio grilletto. E' un'arma automatica individuale a chiusura labile che spara cartucce cal. 9 ltingo. Venne progettata presso la Berctta di Brescia dall'ingegnere Tullio
Marengoni
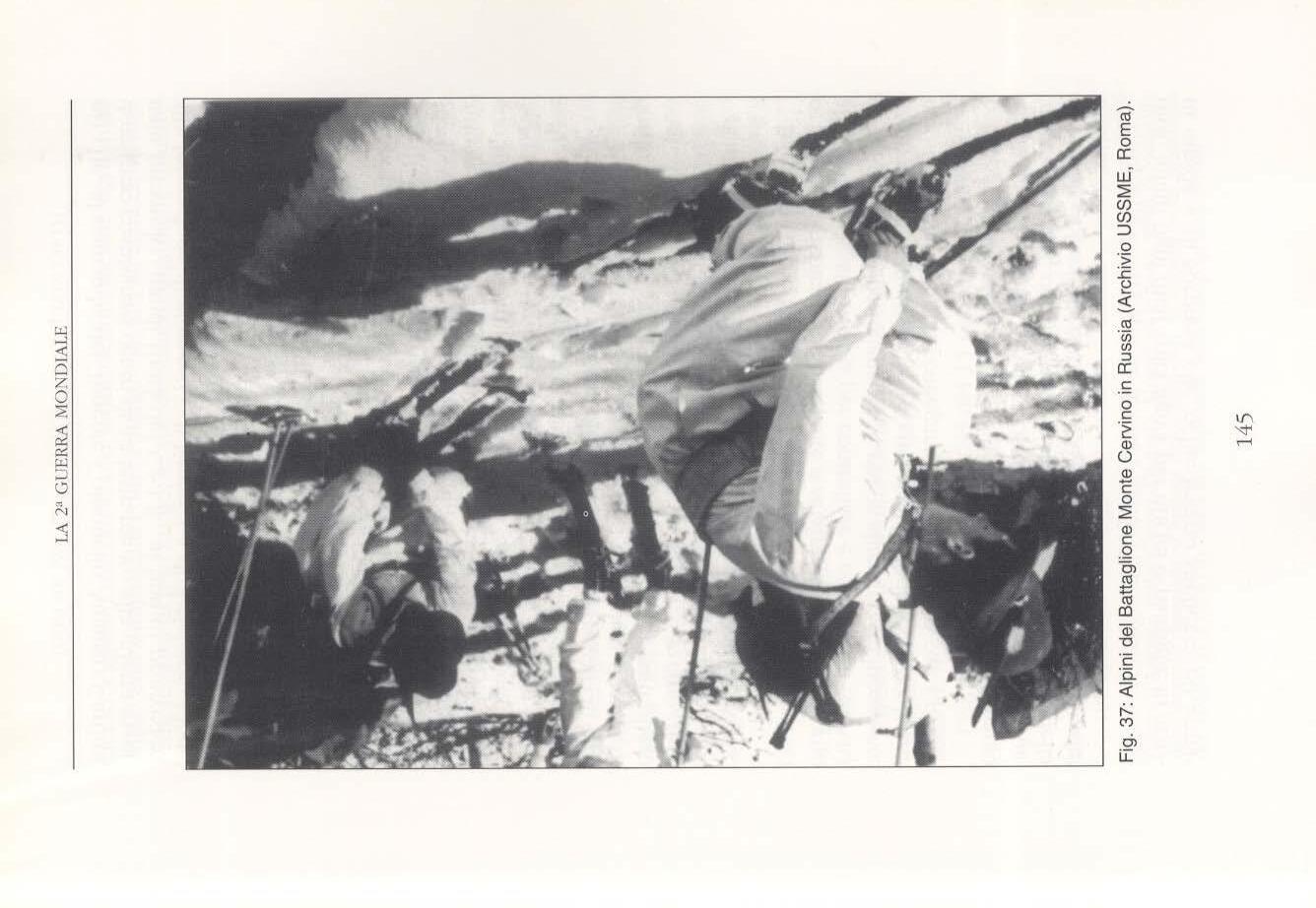
ni) che, al comando del Tenente Colonnello Augusto Gardini, dovevano costituire 8 centri di addestramento alla guerra invernale presso le Grandi Unità del C.S.I.R.. al fine di pro,Tedere alla formazione di elementi . di Fanteria e di Artiglieria, idonei al collegamento tra i reparti ed i Comandi nel campo tattico in quel particolare ambiente operativo.

Il personale dm·e,·a essere in possesso di piena capacità tecnica, piena idoneità fisica, avere autorevolezza ed essere possibilmente volontario; la scelta era a cura della Scuola Centrale ~lilitare di Alpinismo che. non appena il personale era affluito ad Aosta, do,eva sottoporlo ad un'accurata visita medica, svolgere degli esami cli tecnica sciistica individuale e e.lare. al person~tle prescelto. tutte le indicazioni necessarie per l'organizzazione e lo sviluppo di un corso sciatori svolro in circostanze e con finalità particolari e le norm e per la guerra invernale.
Nella realtà dei fatti poi. il CAS (Centro Addestramento Sciatori). come \'l?nne chiamato, più che dedicarsi all"addestramento del personale del C.S.I.R. \ enne utilmente impiegato in attività di esplorazione e collegamento fino alla prima decade di aprile quando. ad eccezione di alcuni uomini che a\Tebhero continuato a partecipare alle operazioni con il Cerl'ino. fece ritorno in Italia per provvedere all'addestramento di un altro battaglione sciatori in fase di avanzato approntamento ad Aosta: il J.'\.1onte Rosa.
In queff inverno l'attività bellica del 1l1onte Cervino con gli sci nei piedi fu rivolta principalmente a servizi di pattuglia intorno all'abitato di Jassinowataja per controllare e contrastare l'atti\·ità delle formazioni partigiane russe che svolgevano un'incessante azione di sabotaggio e disturbo nei confronti delle autocolonne italo-tedesche. o lt re che collegamento informativo con i propri Comandi.
Gli sci furono usati anche nei Lrasferimenti, infatti il 2 marzo il battaglione venne inviato, con gli automezzi. a Nowo Gorlowka e da qui. con gli sci ai piedi, a Ploskij, nel settore della Divisione di Fanteria Pasubio. a disposizione del Comando <lei C.S.I.R ..
L'impiego del reparto ne delineò subito l"inadeguatezza organica, infatti ogni qual , olta agirn per nuclei o pattuglie in azioni rapide e di sorpresa che richiedevano snellezza ed arma-
mento leggero i risultati erano soddisfacenti, mentre ogni qualvolta veniva impiegato come battaglione, alla stregua di un normale reparto di pali rango, le sue deficienze organiche in materia di armamento di reparto si evidenziavano in maniera palese costando a l Cervino gravi _e dolorose perdite in termini di vite umane.
Se poi si considera la qualità del persona le che costituiva il battaglione e le difficoltà oggettive cli reperire , in tempi brevi, dei complementi con le medesime caratteristiche, si ha un quadro esatto dei sacrifici che fu chiamato a sopportare.
Con l'afflusso di nuove unità dall'Italia e fra cli esse anche il Corpo d'Armata Alpino con le Divisioni Tridentina, Julia e Cuneense, il C.S.I.R. venne inglobaco nell'8" Armata 113 detta anche ARMIR e, con esso, anche il battaglione sciatori Monte Cervino .
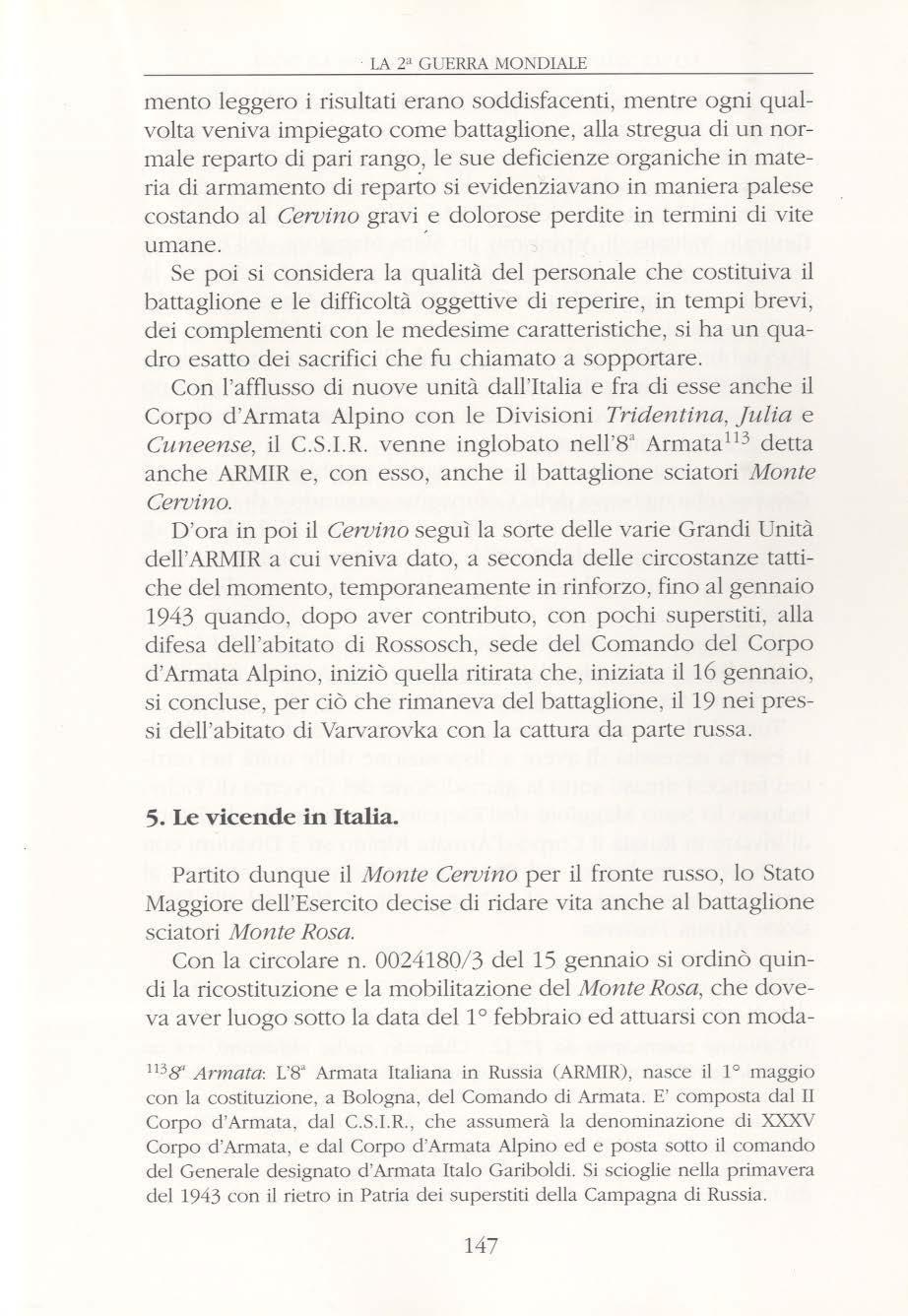
D'ora in poi il Cervino seguì la sorte delle varie Grandi Unità dell'ARMIR a cui veniva dato, a seconda delle circostanze tattiche del momento, temporaneamente in rinforzo, fino al gennaio 1943 quando, dopo aver contributo, con pochi superstiti, alla difesa dell 'abitato di Rossosch, sede del Comando de l Corpo d'Armata Alpino, iniziò quella ritirata che, iniziata il 16 gennaio, si concluse, per ciò che rimaneva del battaglione. il 19 nei pressi dell'abitato di Varvarovka con la cattura da parte russa.
Partito dunque il i'll.onte Cervino per il fronte russo, lo Stato Maggiore dell'Esercito decise di ridare vita anche al battaglione sciatori Monte Rosa.
Con la circolare n. 0024180/ 3 del 15 gennaio si ordinò quindi la ricostituzione e la mobilitazione del Monte Rosa, che doveva aver luogo sotro la data del 1° febbraio ed attuarsi con moda-
113 8' Armata: L'8" Armala TLaliana in Russia (ARivfIR), nasce il 1° maggio con la costituzione, a Bologna, del Comando di Armata. E' composta dal il Corpo d'Armata, dal C.S.I.R. , che assumerà la denominazione di XXXV Corpo d'Armata, e dal Corpo d'Annata Alpino ed e posta sono il comando del Generale designato d'Armata Italo Gariboldi. Si scioglie nella primavera del 1943 con il rielro in Patria dei superstiti della Campagna di Russia.
lità. organici, personale e materiali analoghi a quelli del Cervino, essendo, anche questo reparto, destinato al fronte ru::,so.
Inoltre. per dare maggiore organicità cli comando ai reparti sciatori e per accogliere in parte le osservazioni a suo tempo fatte. tramite l'Ispettorato delle IT.AA .. dal Comando della Scuola Centrale Militare di Alpinismo, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con la circolare n. 0024840/:3 del 24 gennaio 1942. dispose la costituzione e la mobilitazione del 20° gruppo Alpini sciatori 11 --i.
Con essa si disponeva la costituzione e la mobilitazione. per il 15 febbraio 19·-!2, del Comando del 20° gruppo Alpini sciatori. dell'80 · compagnia armi d'accompagnamento per gruppo Alpini sciatori, 2 Comandi di compagnia comando di battaglione sciatori e 2 plotoni mitraglieri sciatori.
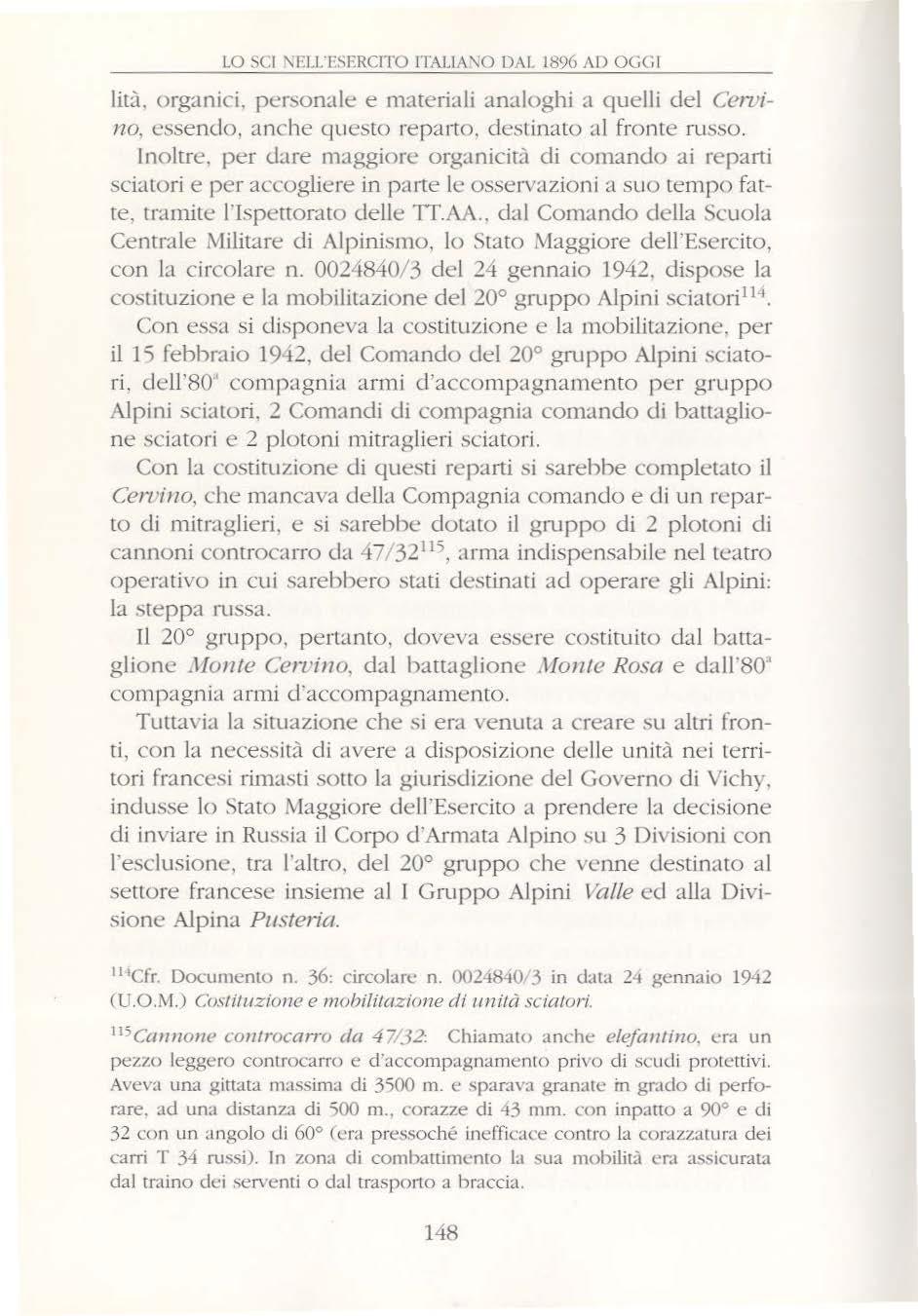
Con la costituzione di questi reparti ::,i sarebbe completato il Cerrino, che mancava della Compagnia comando e di un reparto di mitraglieri. e si sarebhe dotato il gruppo di 2 plotoni cli cannoni controcarro e.la "¼7 32 11 5. arma indispensabile nel teatro operativo in cui .sarebbero stati destinati ad operare gli Alpini: la steppa russa.
Il 20° gruppo, pertanto, doveva essere costituito dal battaglione 1\Io11te Cervino, dal battaglione tlonte Rosa e dall'80' compagni.:, armi d'accompagnamento.
Tuttavia la situazione che si era venuta a creare su altri fronti, con la necessità cli avere a disposizione delle unità nei territori francesi rimasti sotto la giurbdizione del Gm·erno di Vichy, indusse lo Stato Maggiore delrEserciro a prendere la deci~ione di inviare in Rus-;ia il Corpo d'Armata Alpino su 3 Dh, isioni con l'esclusione, tra l'altro, del 20° gruppo che venne destinato al settore francese insieme al I Gruppo Alpini Valle cd alla Divisione Alpina Pusteria.
111Cfr. Documento n. 36: circolar<: n. 002'-l8-'10 3 in data 2-~ gennaio 19-12 CU.O.J\1.) Costituzione e mobilitazio ne di unità sciatori.
115 Ccmnom! controcarro da 4732: Chiamato anche elefantino, era un pez;,o leggero controcam) e d':.iccompagnamenro privo di scudi protettivi. Aveva una gittata massima di 3500 m. e '>parav:1 granare in grado di perforare. ad una disranz::t di 500 m., corazze di -13 mm. con inpatto a 90° e di 32 con un angolo e.li 60° (era pre..,soché inefficace contro la corazzaLUra dei carri T 34 russi). In zona di combanim1..·nto l.1 sua mobilità era assicurata dal traino dei se rYenti o dal trasporto a braccia.
Con la circolare n. 0037850/ 3 del 19 giugno 1942 116 , lo Stato Maggiore determinò una nuova strnttura organica del 20° gruppo trasformandolo in 20° raggruppamento Alpini sciatori che comprendeva: il Comando di raggruppamento, i battaglioni Alpini sciatori 1l1onte Rosa, Val Toce e Val Cenischia, 1'85'' compagnia cannoni da 47/ 35 e.e., il gruppo Artiglieria Alpina sciatori Val d'Orco, la 1• compagnia mista Genio sciatori, una sezione di sanità, un nucleo misto e la l'' colonna slitte.
Pur formato con unit à chiamate sciatori, il 20° raggruppamento, nella realtà, non ebbe mai modo di mettere in pratica questa sua denominazione, limitandosi ad azioni di difesa del territorio fino all'8 settembre 1943 quando, con alcuni battaglioni che nel frattempo avevano cambiato denominazione come il Val Toce trasformato in Monte Cervino ed il Val Cenischia ribattezzato Moncenisio, venne catturato dalle forze tedesche.
Si concludeva così la partecipazione delle unirà sciatori alla seconda guerra mondiale dove errori di valutazione dell'ambiente operativo oltre che modalità d'impiego non perfettamente consoni a questo tipo di unità ne condizionarono spesso l'efficacia operativa, rendendo vana l'enorme possibilità di mobilità che gli sci offrivano sui terreni innevati.
116Cfr. Documento n.37: circo lare n. 0037850/3 in data 19 giugno 1942 (U.0.M.) Costituzione e mobilitazione del 20° raggruppamento alpini sciatori. Scioglimento di unità alpine.
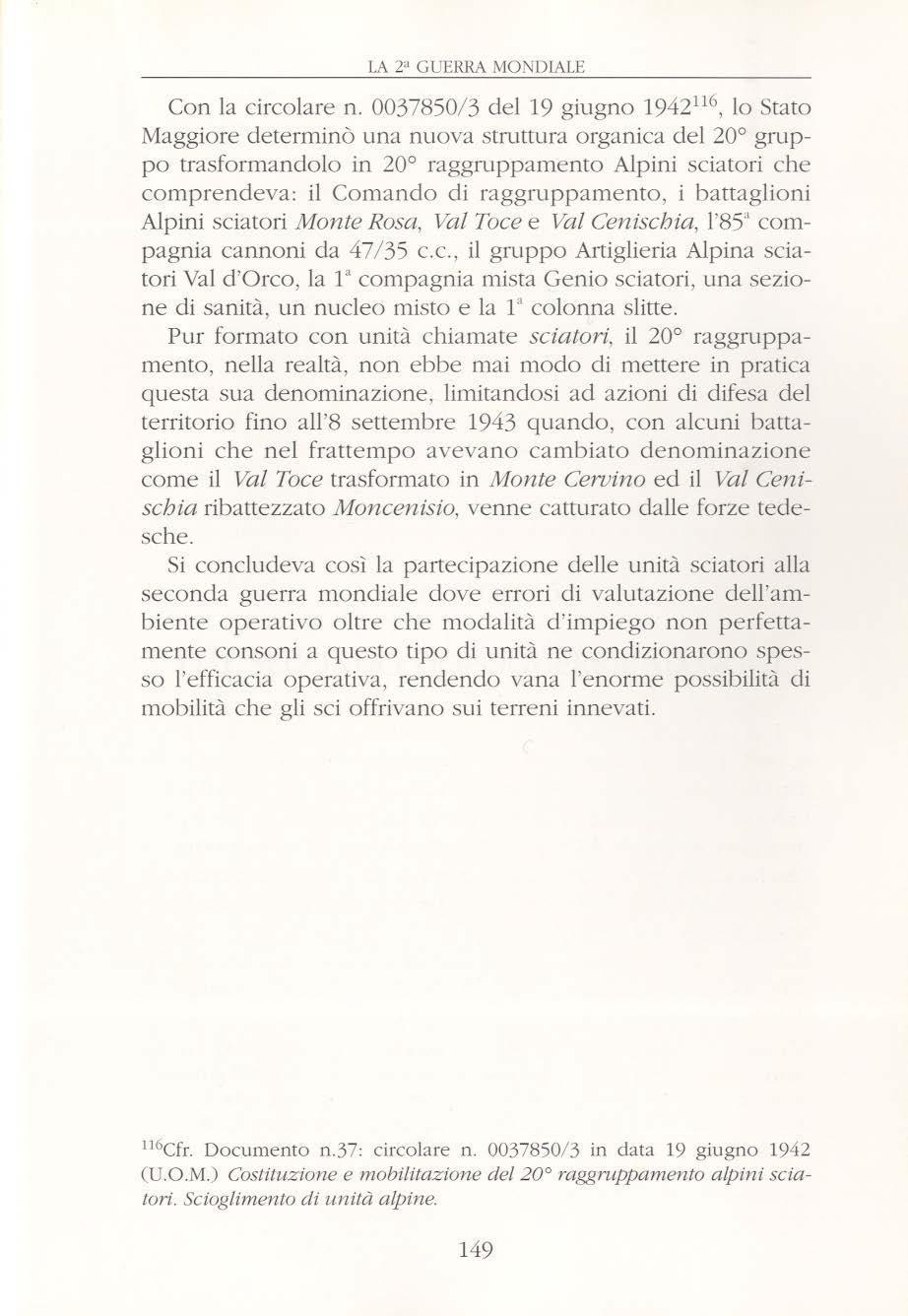
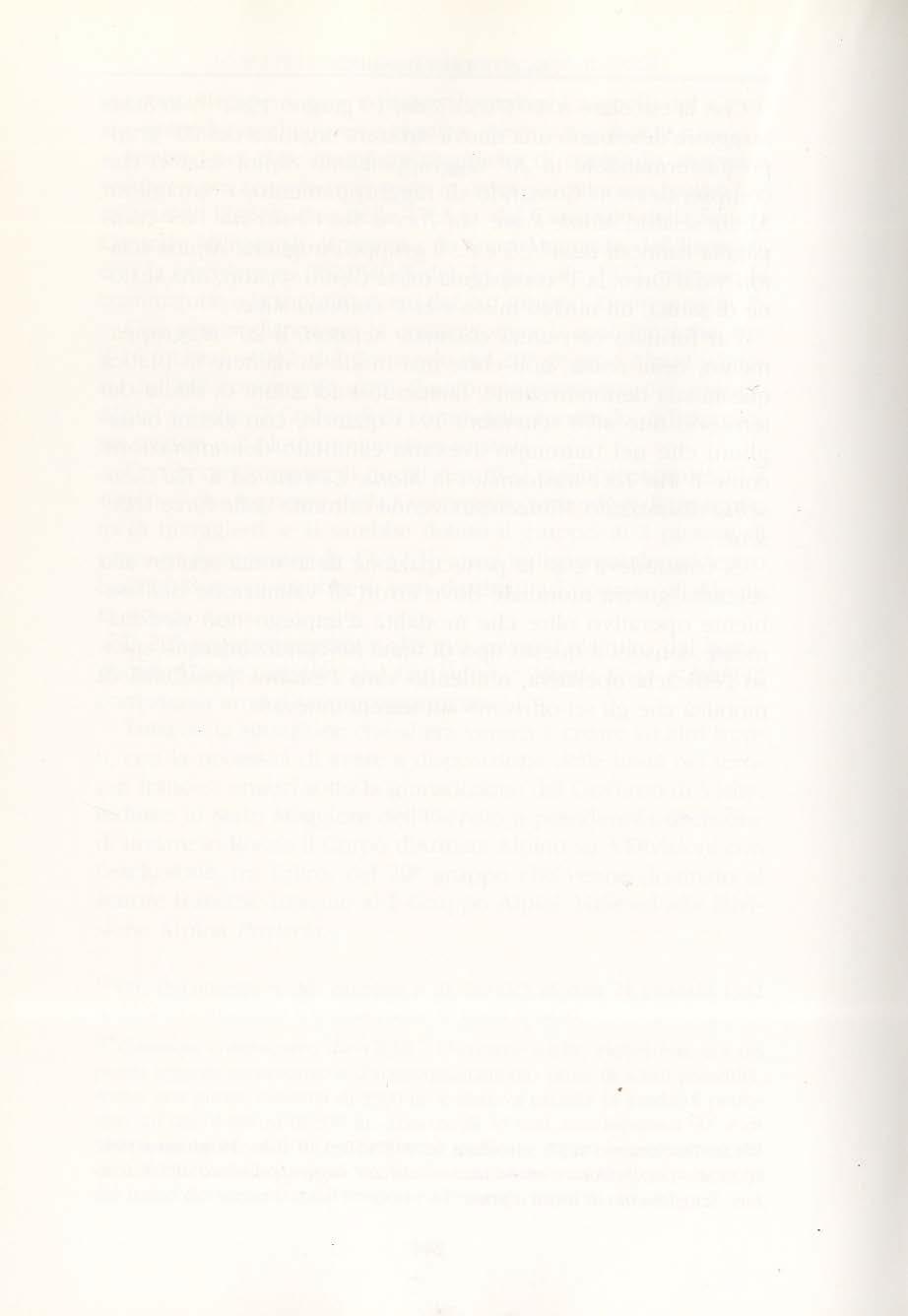
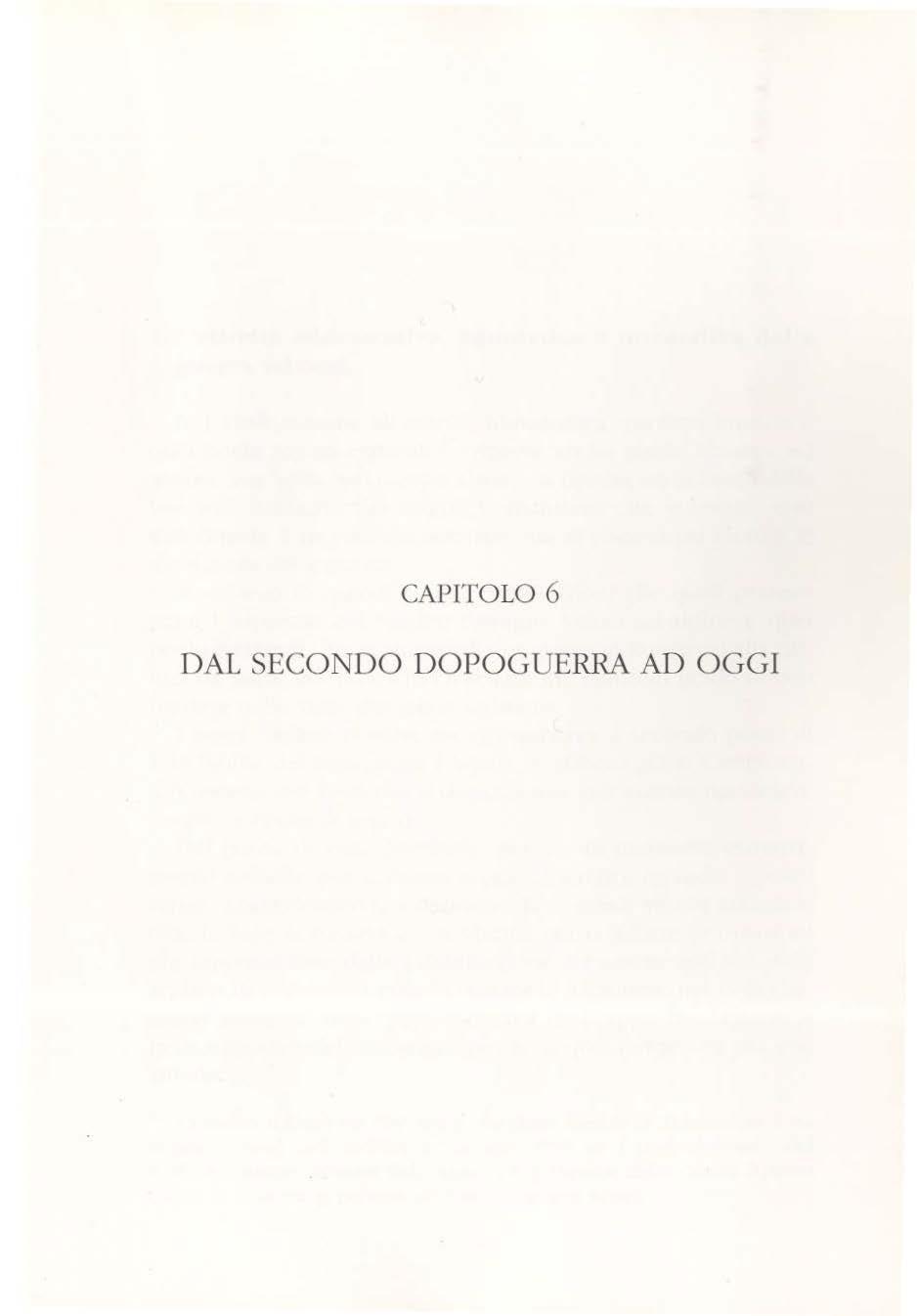

1. L'attività addestrativa, agonistica e normativa dalla guerra ad oggi.
Nel 1946 insieme all'attività addestrativa, peraltro limitata a quei pochi repa1ti esistenti 117 , riprese anche quella sportiva ed ancora una volta, nel campo alpino, la ripresa era il frutto della lodevole iniziativa dei singoli Comandanti che volevano così sottolineare il ritorno alla normale vita di pace dopo i lutti e le distruzioni della guerra.
Si ricominciò quindi con le competizioni alle quali presero parte i superstiti del Nucleo Pattuglie Veloci sci-alpine e quei pochi elementi che, scampati alla prigionia in Russia od alla cattura da parte dei Tedeschi 1'8 settembre. erano in grado di ben figurare nelle varie discipline sciistiche.
I primi risultati positivi , tra cui spiccava il secondo posto di Edy Bibbia del battaglione l'Aquila. si ebbero già ai Campionati Nazionali del 1946 che si disputarono, per quanto riguardava il salto, a Ponte di Legno.

Dal punto di vista dottrinale, poi, in un momento estremamente difficile per il Paese e per l'Esercito , quando i pochi reparti riprendevano faticosamente la normale attività addestrativa, la base normativa a cui riferirsi per condurre le istruzioni era rappresentata dalla pubblicazione Istruzione sull'uso dello sci fatta dalla Scuola Centrale Militare di Alpinismo nel 1941 che. come abbiamo visto, rappresentava una tappa fondamentale nella metodica dell'insegnamento e, in quei tempi, era più che attuale.
117 L'Esercito Italiano nel 1946 era il così detto Esercito di Transizione. i cui org:inici erano stat i stab ilili ne l maggio 1945 tra i rappresentanti del M.M.I.A. (Military Miss ion lraly Army) ed iJ Ministro della Guerra italiano Casati. ln esso erano presemi, tra l'altro, 2 gnippi Alpini.
Nel febbraio del 1947, a Misurina, ripresero vita le Gare Interregimentali di Sci della Truppe Alpine che, se da una parte rappresentarono una prova di coraggio e di volontà dei Comandanti a superare tutte le djfficoltà di quegli anni, dall'altra segnarono la conclusione del primo ciclo addestrativo invernale ciel dopoguerra delle Truppe Alpine.

L'evento, al di là della mera _manifestazione sponivo-addestrativa, rappresentò anche la felice occasione cl i ritrovarsi da parte degli scampati dalle terribili campagne cli Grecia, d'Albania, di Russia e della Guerra d i Liberazione.
Non solo in Italia, ma anche in campo internazionale c'era un fiorire di iniziative sportive ad alto I ivello; alla Svizzera, infatti, era stata affidata l'organizzazione dei V Giochi Olimpici Invernali, il cui programma comprendeva ancora una volta la gara di corsa e tiro per pattuglie militari, che tanta soddisfazione aveva dato ai colori azzurri nella precedente edizione di Garmisch, con la conquista dell'oro.
E per difendere quel titolo olimpico, che, sin dall'ottobre ciel 1946, erano stati fatti dei passi presso lo Stato Maggiore cleJl'Esercito per organizzare e preparare una rappresentativa mil itare italiana in grado cli ben figurare ai Giochi. tuttavia la grave elis i economica in cui versava il Paese e la conseguente ristrettezza dei bilanc i si 1ivelò un ostacolo pressoché insormontabile.
Ancora una volta fu l' ambiente civile a dare un conr1ibuto decisjvo alla causa, nell ' ottobre 1947 infatti i principali quotidiani nazionali diedero vita ad un·accesa campagna stampa per ottenere dal Ministero della Difesa che anche a San Moritz l'Italia fosse presente con una pattuglia militare.
rl 14 novembre, dopo aver riesaminato in senso favorevole il problema, l'Ispettorato dell'Arma di Fanteria assegnò al Tenente Colonnello Francesco Vida il difficilissimo incarico cl i organizzare la partecipazione ita liana all'Olimpiade.
Il compito si presentò subito estremamente arduo perché in tempi assai ristretti, la gara era infatti prevista per 1'8 febbraio 1948, bisognava individuare g li elementi, Ufficiali. Sottufficiali e Militari di Truppa, idonei per la formazione della pattuglia, scegliere le armi per il tiro, allenare tutto il personale ed infine selezionare i tito lari da comunicare, entro 1'8 gennaio, al Comitato Organizzatore per l'iscrizione alla gara.
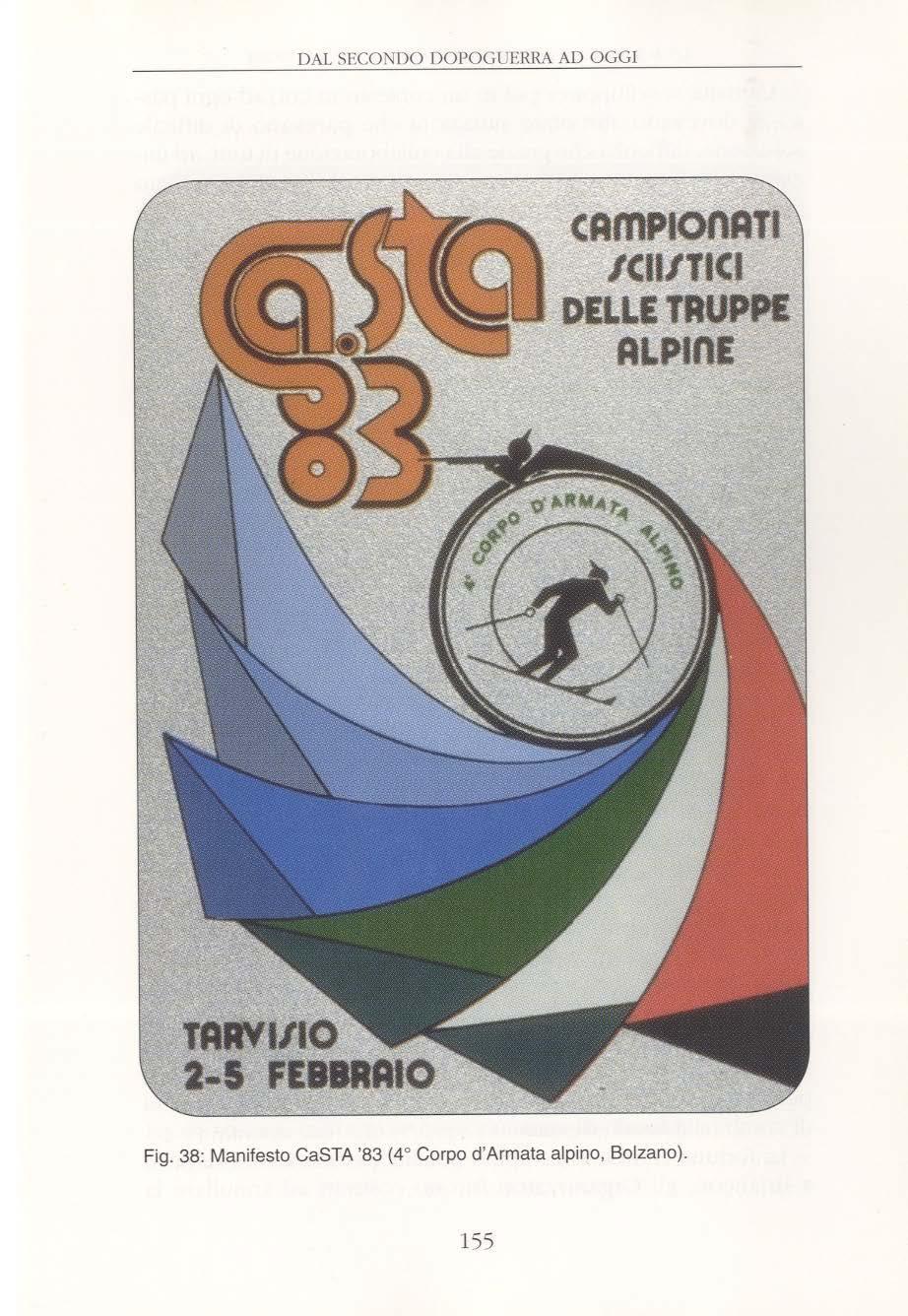
L'attività si sviluppava poi in un contesto in cui, ad ogni pas'>O, si do\·evano affrontare situazioni che parevano di difficile soluzione, difficoltà che grazie alla collaborazione di tutti, ad iniziare dalhl Federazione Italiana Sport Invernali e dal Comitato Olimpico azionale Italiano per finire atrl fficio Tnippe Alpine clell'lspettorato dell'Arma di Fanteria ed alle Autorità militari periferiche, furono risolte in maniera soddisfacente anche se non ottimale.
l\·onosranre l'impegno e l'enn1siasmo profuso non fu tullavia possibile ottenere un ottimo rbultato anche se, in considerazione dei limili della preparazione. la panuglia composta dal Tenente Costanzo Picco. dal Sergenle Aristide Compagnoni, dal Caporale Giacinto De Cassan e dall'Alpino Antenore Cuel fu proragonbta di una gar:1 più che dignitosa clas~ificandosi al quarto posto dietro a Svizzera. Fin landia e Svezia e lasciandosi alle spalle nazioni quali la Francia. la Cecoslovacchia. la l{omania e gli ~lati lJniti.
Mentre l'attività addcstrativa sciistica dei reparti prendeva di anno in anno sempre più conshtenza, lo Stato Maggiore dell'Esercito per <;oddbfare cui una necessitò profo11dame111e sentita e inderogabile ai.fini della preparazione e del/àp,gionzamento dei Quadri giocani delle Truppe Alpine ..." dispone\ a. il 1° luglio 19-18. la ricostituzione della Scuola Centrale Miliwre di Alpinismo di Aosta che, per sottolineare anche con il nome la sua essenziale ed unica funzione che deve essere rivolta a scopi ed attività esclusi,'amenre militari, assunse la denominazione di Scuola Militare Alpina.
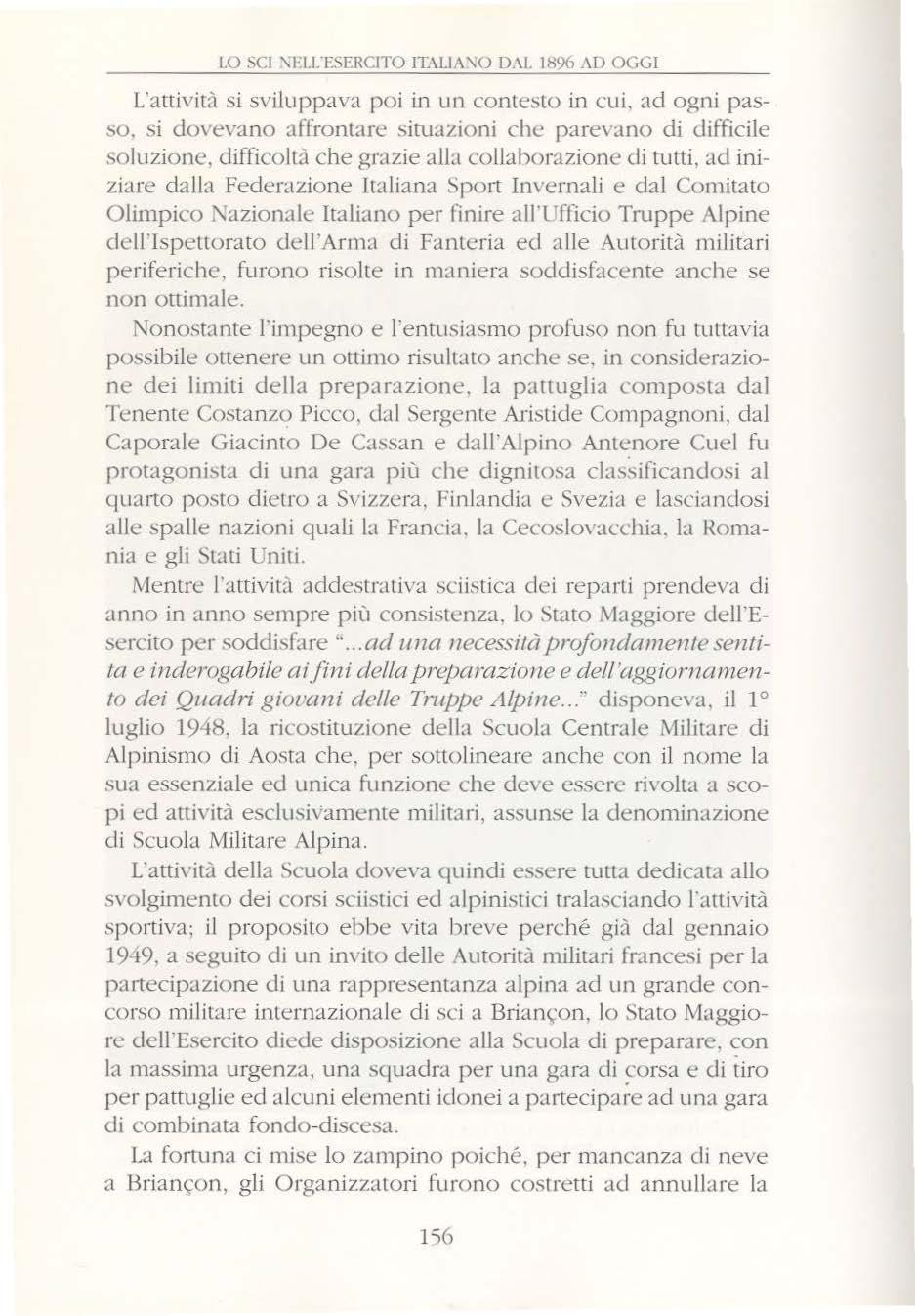
L'attività della Scuola doveva quindi c'>sere tutta dedicara allo svolgimento dei corsi sciistici ed alpinistici tralasciando l'atcività sportiva; il proposito ebhe vila breve perché già dal gennaio 19-½9, a seguito di un invito delle l\utorità militari francesi per la partecipazione di una rappresentanza alpina ad un grande concorso militare internazionale di sci a Briançon, lo Stato Maggiore dell'Esercito diede disposizione alla Scuola di preparare. con la massima urgenza, una squadra per una gara di corsa e di tiro per pattuglie ed alcuni elementi idonei a partecipare ad una gara di combinata fondo -discesa.
La fornma ci mise lo zampino poiché, per mancanza cli neve a Briançon, gli Organizzatori furono costretti ad annullare la

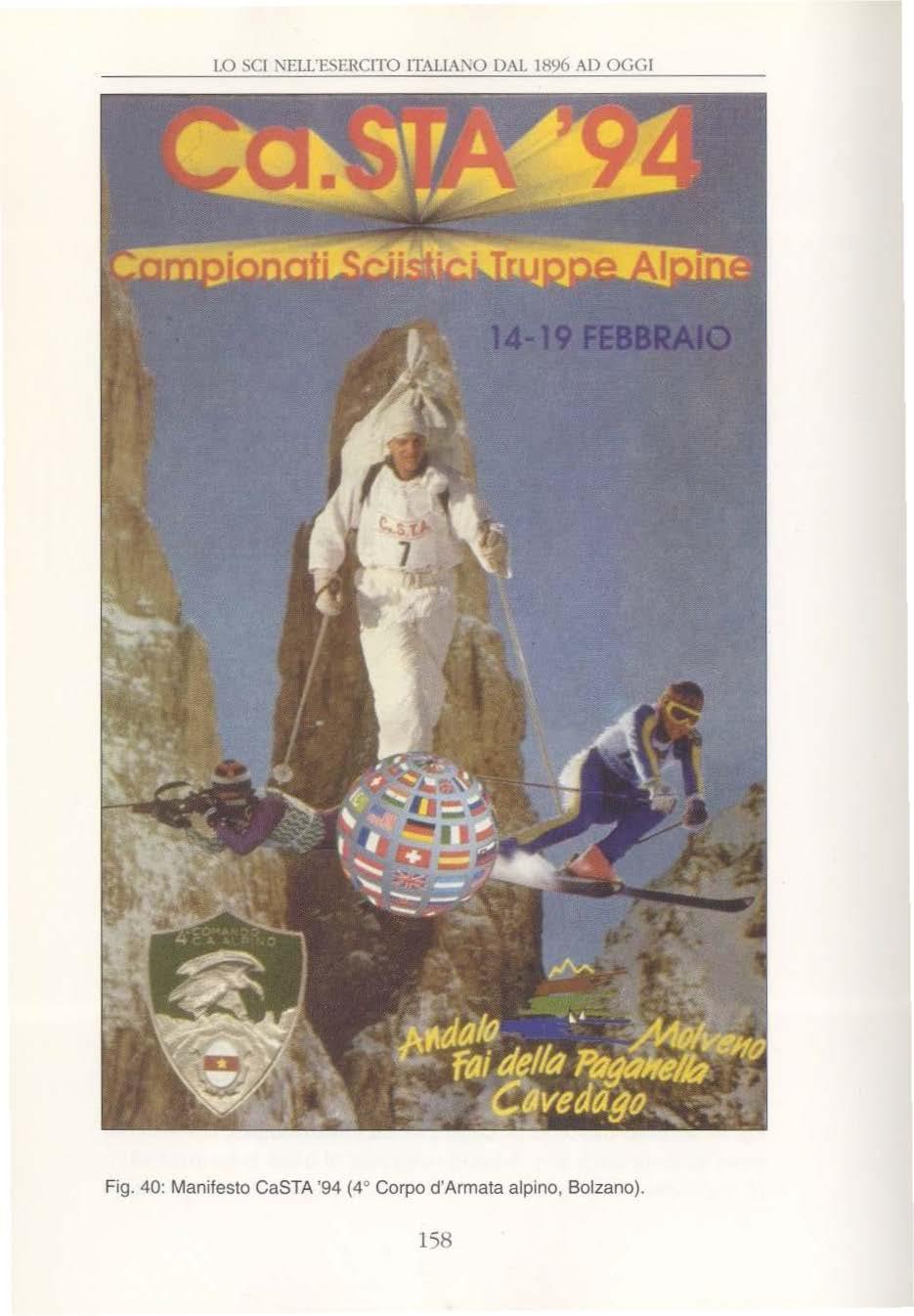
gara risparmiandoci risultati che, per l'improvvisazione e la fretta imposta. non sarebbero stati certo lu,;inghieri.
L'esperienza servì tuttavia ad aprire gli occhi delle Autorità Centrali inducendole a riesaminare i compiti e gli organici della Scuola ed ad introdurvi, il 5 maggio 1949, un nucleo di sciatori da preparare per l'eventuale partecipazione. quale rappresentanza delrfaercito, a gare internazionali.
Oltre alle competizioni, rattenzione era rin>lta anche al campo normativo e, pur essendo in vigore la pubblicazione Istruzione sull'uso dello sci del 19<-11. la Scuola, in stretta collaborazione con l"Ufficio Tr.AA. delrlspenorato delrArma di Fanteria, ritenne opportuno procedere all'elaborazione di un nuovo manuale, denominato Appunti sull'addestrame1lLo sciistico militare, per adeguare le nuove necessità militari alla tecnica sciistica civile in voga in quegli anni.
Il manuale vide la luce nel 1953 e, in atccsa di una nuova ed aggiornata edizione dell'Istruzione sulruso dello sci, !>i proponeva di dare un indirizzo unitario sul metodo e.li addestramento, di fissare le linee principali entro le quali insegnare la tecnica durante i corsi e di fornire alcune notizie, a puro titolo di memoria, sull'organizzazione elci corsi stessi.
Il documento si anicolava in vari capitoli in cui venivano trattate le modalità di svolgimemo dei corsi, l"attività preparaLOria elci corsi stessi, la ginnastica presciistica, il metodo <li addestramento da utilizzare nei corsi, la tecnica sciistica e alcuni suggerimenti sulla conduzione detraddestramento sciistico di massa da effelluarsi da pa,te di quei repatti dislocati in sedi ove le condizioni di inne,·amento ne permettevano I'e!>ecuzione; inoltre erano riportali uno schema di organi.aazione di un corso sciatori e le norme relative alla propaganda valligiana.
Per la conduzione clelrattiviLà istruttiva, assumeva poi una note\'ole imponanza la precisazione, riponata nel 1° capitolo Generalità del manuale, sulle finalità che si propone,·a raddestramento sciistico; in esso si legge: .. !addestramento sciistico tende essenzialmente ad abilitare il maggior numero possibile di elementi alruso dello sci ai.fini militari. Addestramento quindi rivolto non a formare il campione od il virtuoso, ma il combattente sciatore capace di muouere e manovrare i11 alta montagna


Ne.I 1956, dopo un adeguato periodo di sperimentazione sulla base della pubblicazione provviso1ia Appunti sull'Addestramento Sciistico Militare, vide la luce la pubblicazione Istruzione sull'Addestramento Sciistico Militare - Parte III - Addestramento sciistico a cura dell'Ufficio Tf.AA. dell'Ispettorato dell'Arma di Fanteria.

Il documento, che concerneva essenzia lmente l' addescramento tecnico sciistico, base e presupposto per l'addestramentO al combauimento individuale e di reparto deg li sciatori, sanciva un indirizzo unitario nella metodica addestrativa, indicava le norme generali da seguire nella preparazione, nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi sciatori e definiva le norme per la condotta di marce e per l 'esecuzione di imprese alpinistiche, introduceva inoltre il concetto che le norme riguardanti il metodo d'insegnamenro della tecnica sciistica, riportate in essa , erano tassative ed attribuiva ai Direttori dei corsi la responsabilità della loro esatta appUcazione.
Come si può notare nulla era più lasciato al caso o all ' iniz iativa dei singoli, ma ci si preoccupava di dare sempre e comunque un 'unicità d i indirizzo e di metodica addestrariva che. seppure aperta e pronta a recepire ogni innovazione tecnica legata al processo tecnologico dei materiali, consentisse a tutti i reparti di raggiungere un elevato ed uniforme livello adclestracivo.
Era una pubblicazione completa che , partendo dal conceno che lo sci può essere utilizzato in campo logistico per effettuare dei trasferimenti ed in campo tattico per sviluppare azioni di combattimento, definiva, oltre alla preparazione tecnica vera e propria , l'attività preparatoria dei corsi sciarori con la selezione del personale e, fattore fondamentale ed innovativo, l'aggiornamento degli istruttori , nonché l' organizzazione logistica da attivare .
Sulla base di questa normativa , l'attività addestrativa era effettuata con sistematicità ed unitarietà da parte di tutti i reparti dove ai Comandanti, naturali istruttori degli uomini posti alle loro dipendenze, si affiancavano tutti quegli Ufficiali e Sottufficiali che avevano conseguito il brevetto di istruttore militare di sci presso la SMALP ad Aosta.
ed in zone fortemente innevate con armamento ed equipaggiamento al completo".
Nel 1975, con la pubblicazione n. 5898 Addestramento sciistico ed alpinistico delle Truppe Alpine, l'Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria. partendo dal concetto evidenziato dalla normativa dottrinale della serie 800 che "il combattimento moderno si sviluppa attraverso un complesso di azioni e di reazioni fondato, più che sulla potenza, sulla manovra in cui acquista particolare rilievo la piena utilizzazione delle caratteristiche ambientali" e che quindi "le operazioni in montagna sono influenzate in misura determinante dal terreno e dalle condizioni ambientalt, mirò a disciplinare l'impostazione e lo svolgimento dell'addestramento sciistico stesso.
Nella pubblicazione, dopo aver indicato nel 4° Corpo d'Armata AJpino, nella Scuola Militare Alpina e nelle Brigate gli Enti preposti all'addestramento, venivano illustrate le competenze e le attività di ciascuno sottolineando, tra l'altro, la precisa responsabilità dei Comandanti ai vari livelli in merito all'addestramento sciistico individuale e collettivo con la facoltà di adeguare le diverse attività alle condiz ioni ambientali contingenti.
Nel 1983 l'Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria emanò la pubblicazione Istruzione sull'Addestramento Alpinistico e Sciistico Militare che abrogava Ja precedente del 1956.
In essa si legge che "L'addestramento sciistico militare ha lo scopo di formare istruttori militari di sci, preparare elementi capaci di superare Le difficoltà proprie della montagna innevata, abilitare tecnicamente la massa delle tntppe da montagna ad effettuare operazioni in terreno innevato.L'attività sciistica, che costituisce parte.fondamentale dell'addestramento delle Truppe Alpine, persegue, inoltre, un fine educativo, in quanto, sviluppando le qualità motorie di base e perfezionando l'efficienza fisica e l'autocontrollo psicofisico. contribuisce alla formazione del combattente alpino" 1rn.
La pubblicazione, tutt'ora in vigore, è stata redatta dalla Scuola :Militare Alpina secondo i più moderni dettami della tecnica didattica sciistica in uso anche presso le Scuole di Sci poste sotto il controllo della F.I.S.I. (Federazione Ita liana Sport Invernali).
11 x Ispettorato delle Armi di Fante1ia e Cavalleria: lsLmzione sull'Addestramento Alpinislico e Sciistico Militare - Parte III - Addestramento Sciistico edizione 1983.
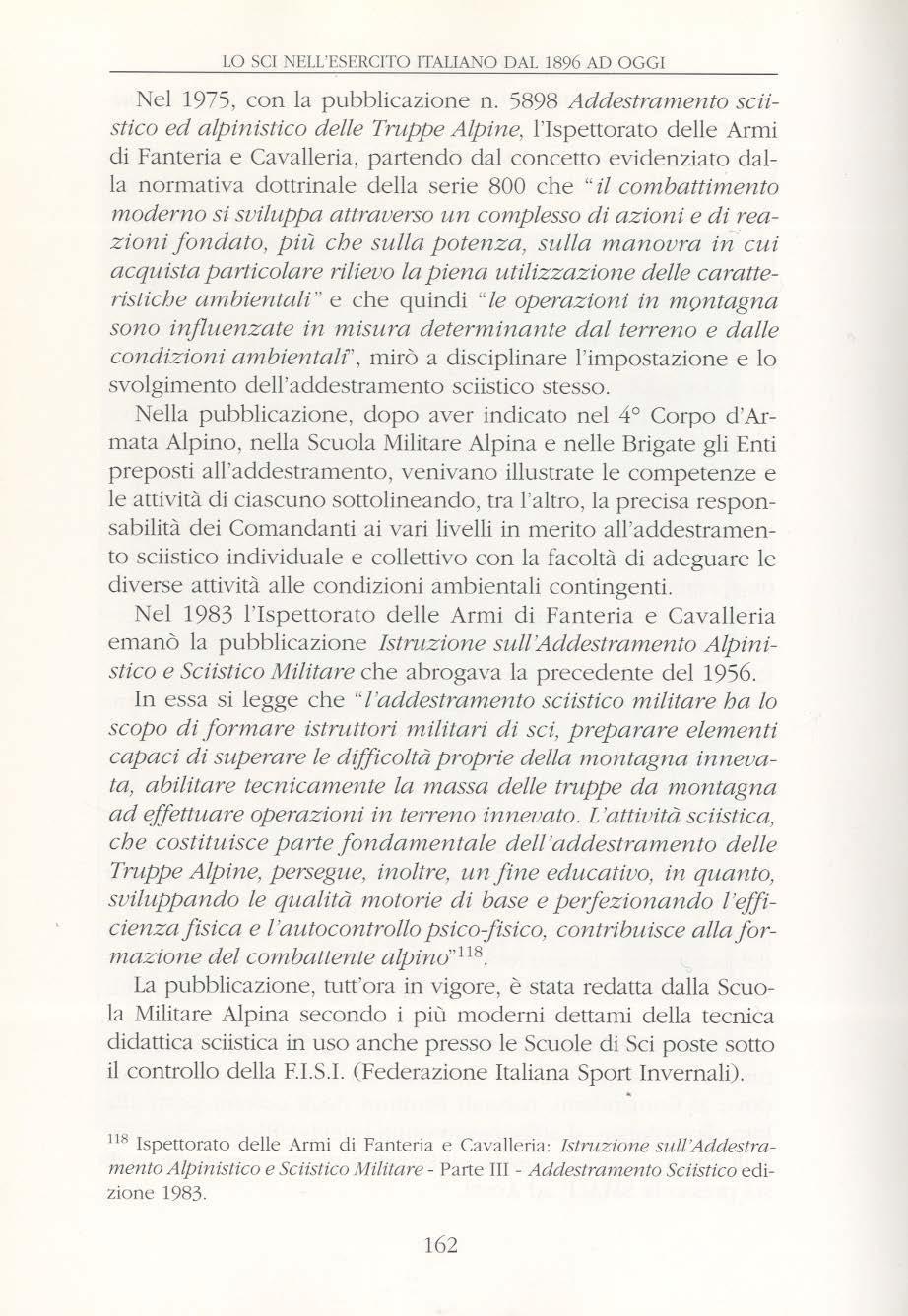
Nel mentre, insieme alla normale attività addestrativa svolta dai reparti, co n tinuava ranività agonistica sia della Scuola Militare Alpina che quella del 4° Corpo d'Armata Alpino .
La prima, tramite il Centro Sportivo Esercito - I Plotone Atleti, partecipando alle varie competizioni internazionali, Olimpiadi comprese, dapprima da sola e successivamente, con il sorgere dei nuovi gruppi sportivi militari delle Fiamme Oro, del Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri, che si affiancavano ~ i lle squadre degli Alpini e della Guardia d i Finanza, in un contesto interforze a partire dal concorso internazionale di Bardonecchia del 1958 .
Di pa1ticolare rilievo fu il risultato consegu ito dalla Scuola nel VII Trofeo Mezzalama, la prest igiosa gara sci- alpinistica disputatasi sui ghiacciai del Monte Rosa 1'11 febhraio 1971, dopo una sosta di ben trentatré anni.
In questa competizione, vero e proprio campionato mondiale di sci-alpinismo, la Scuola trionfò piazzando la squadra ..A" (Stella Gianfranco, Stella Aldo e Stella Robe,to) a l primo posto, la squadra ·'B" (Blua Romano, Stella Valent ino e Fauner Natalino) a l secondo, la squadra "D" (Ragazzi Edoardo, Zorzi Rino e Caran i Fermo) a l quinto ed infine la squadra "C" (Generale Gallarotti Bruno, Maresciallo Tassoni Alberto ed Alpino Murer Paolo) al dodicesimo.
Il 4° Corpo d'Armata con l'organizzazione e la disputa di gare, individuaii e di reparto, da tenersi con cadenza annuale a l termine dell'addestramento sciistico di massa.
Q u este gare, già disputate alcune volte ne l periodo tra le due gueITe, vennero rintrodoue a partire dal 1949 a Sella evea con la denominazione di ESCTA (Esercitazioni Sciistiche Conclusive delle Truppe Alpine), tale nom inativo cambiò, nell'edizione del 1969 disputatasi a Merano, in GISTA (Gare Interregimentali Sciistiche delle Truppe Alpine), per giungere, nel 1977 con l'edizione svoltasi a Campo Felice, in CaSTA (Campionati sciistici delle Truppe Alpine), denominazione che le contraddistingue ancora, pur avendo assunto, in viltù di una partecipazione non so lo esclusivamente alpina italiana, ma allargata a rappresentanti di Eserciti di Paesi Alleati ed At1li'-i nonché degli altri Corpi Armati dello Stato, una connotazione ed uno spirito da vera Olimpiade bianca in grigio -verde.

Nel campo dei materiali sciistici l'evoluzione tecnica assunse, negli anni c;eguenti la guerra, un ritmo sempre più serrato, conseguenza diretta del susseguirsi, con ritmo sempre più serrato. di competizioni ai massimi livelli.
Gli scarponi con la suola Vibram divennero di uso comune e. mediante appositi adattamenti costruttivi. erano idonei ad essere impiegati anche per gli sci.
Questi ultimi, in base al tipo di legno impiegato per la costruzione erano di due cipi: di frassino o di hickory. erano verniciati di bianco a scopo mimetico ad eccezione della punta che era verniciata di verde, la suola era laminata con segmenti di nastro d"acciaio e la puma era circumlaminata con lamiera di ferro.
Agli sci era applicato un nuovo tipo di attacco, il Kandahar che. pur essendo strutturalmente più semplice del vecchio Huitfeld, pcrmetteYa un ancoraggio fi!:>sO dello scarpone, idoneo per la discesa, mediante due guide metalliche fissate sui bordi dello sci attra,·erso le quali passava il cavo metallico di attacco che cingeva posteriormente lo sca rp one ed anteriormente e ra messa in tensione da una leva, un ancoraggio mobile che, dopo aver staccato il cavo metallico di attacco dalle due guide e regolata la tensione della leva anteriore, permetteva il naturale piegamento dello scarpone all'altezza della punta facilitando la progressione in piano o in salita .
I bastoncini erano di acciaio al nikel-cromo-molibdeno, con impugnatura di gomma munita di lacciolo regolabile e, nella parte inferiore, era applicata un a rotella pure di gomma.
Per fa\-orire lo sciatore, aumentando l'aderenza dello sci alla neve, !:>pecie in salita, erano usali dei nastri di ve lluto rasposo, detti adesivi di tessiJ foca, dotati di apposito dispositivo per la loro applicazione allo sci.
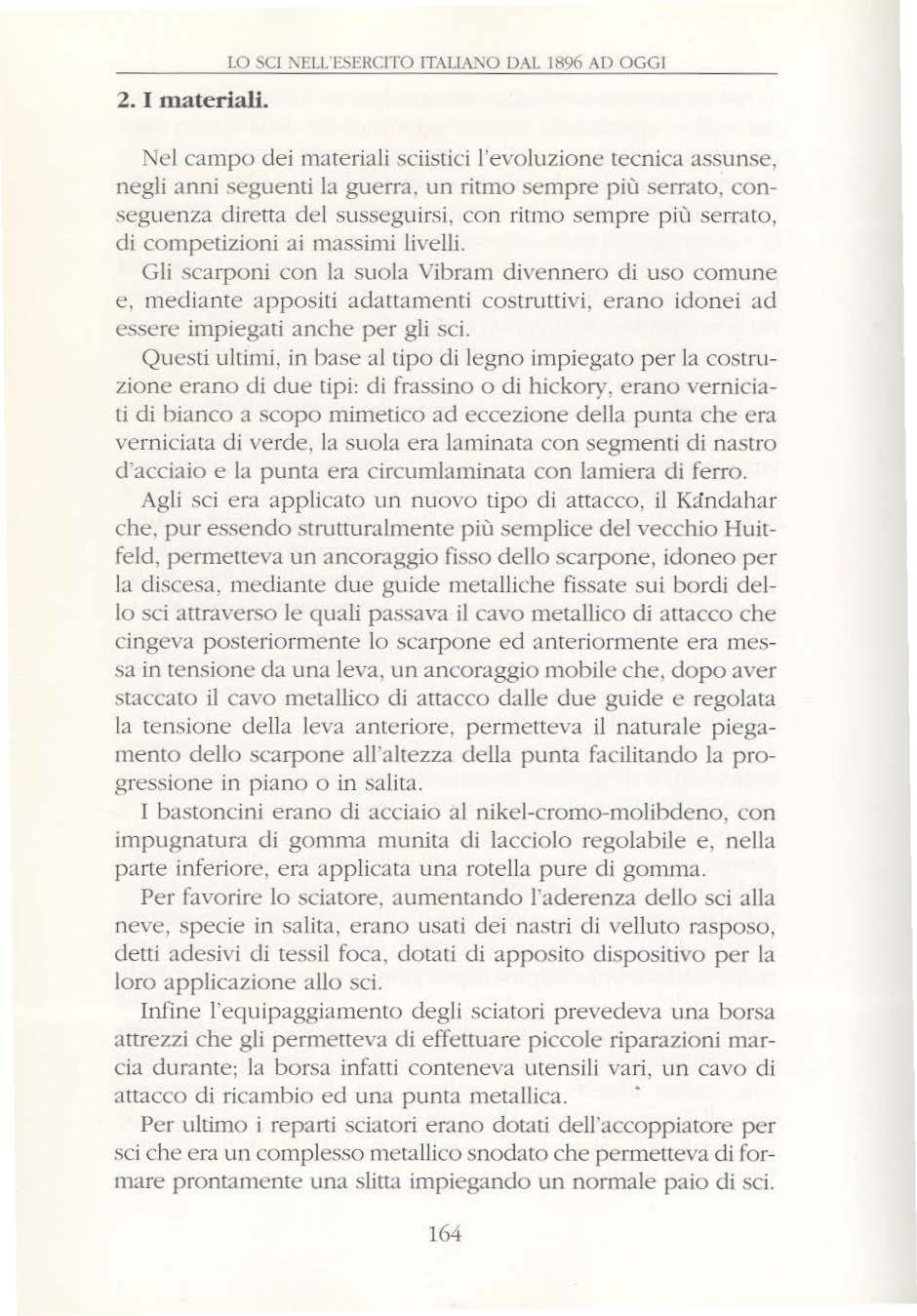
Infine l'equipaggiamento degli sciatori prevedeva una borsa attrezzi che gli permetteva di effettuare piccole riparazioni marcia durante; la borsa infatti conteneva utensili vari, un cavo di attacco di ricambio cd un a punta metallica.
Per ultimo i reparti sciatori erano dotati dell'accoppiatore per sci che era un complesso metallico snodato che permetteva di formare prontamente una slitta impiegando un normale paio di sci.


Con l'avanzare della tecnologia, aJJ'inizio degli anni ·80 gli sci in legno vennero sostituiti con quelli metallici da 2 m. di lunghezza che però, un po' per difetto de l sistema di inco ll aggio dei vari strati componenti lo sci e un po' per un cattivo stoccaggio si rivelarono inadeguati scollandosi e perdendo la forma.
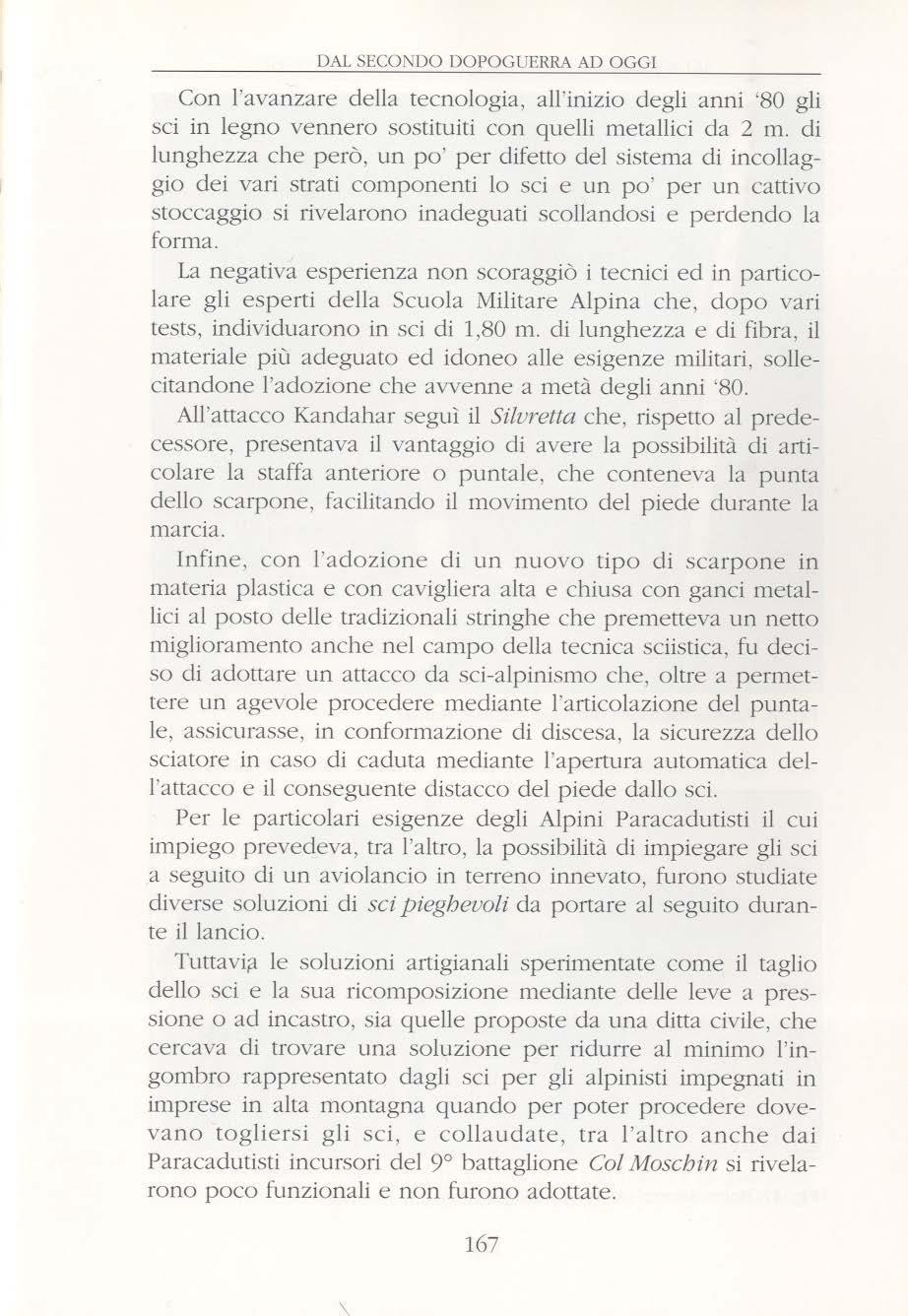
La negativa esperienza non scoraggiò i tecnici ed in particolare gli esperti della Scuola Militare Alpina che, dopo vari Lests, ìndividuarono in sci di 1,80 m. di lunghezza e di fibra, il materiale più adeguato ed idoneo alle esigenze militari, sollec itandone l'adozione che avvenne a metà degli anni '80.
All'attacco Kandahar seguì il Siluretta che. rispetto al predecessore, presentava il vantaggio di avere la possibili tà di articolare la staffa anteriore o puntale. che conteneva la punta dello scarpone, facilitando il movimento del piede durante la marcia.
fnfine, con l ' adozione cli un nuovo tipo di scarpone in matetia plastica e con cavigliera alta e chiusa con ganci metallici al posto delle tradizionali stringhe che premetteva un netto miglioramento anche nel campo della tecnica sciistica, fu deciso di adottare un attacco da sci-alpinismo che, oltre a permettere un agevole procedere mediante l'articolazione del puntale, assicurasse, ìn conformazione di discesa, la sicurezza dello sciat0re in caso di caduta mediante l' apertura automatica dell'attacco e il conseguente distacco del piede dallo sci.
Per le particolari esigenze degli Alpin i Paracadutisti il cui impiego prevedeva , tra l'altro, la possibilità di imp iegare gli sci a seguito di un avio lancio in terreno innevato, furono studiate diverse soluzioni di sci pieghevoli da portare al seguito durante il lancio.
Tuttavif! le soluz ioni anigianali sperimentate come il taglio dello sci e la sua ricomposizione mediante delle leve a pressione o ad incastro, sia quelle proposte da una ditta civile, che cercava di trovare una soluzione per ridurre al minimo l'ingombro rappresentato dagli sci per gli alpinisti impegnati in imprese in alta montagna quando per poter procedere dovevano togliersi gli sci , e collaudate , tra l'altro anche dai
Paracadutisti incurso1i del 9 ° battaglione Col Moschin si tivelarono poco funzionali e non furono adottate .
 Fig . 46: Adesivi tessilfoca (Archivio USSME. Roma).
Fig. 47: Borza attrezzi (Archivio USSME, Roma).
Fig . 46: Adesivi tessilfoca (Archivio USSME. Roma).
Fig. 47: Borza attrezzi (Archivio USSME, Roma).
3. La Scuola Militare Alpina.
Nel quadro della rinascita e della riorganizzaz ione delle Forze Armate dopo la guerra, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con la circolare n. 1480/ 0rd ./I datata 12 giugno 1948119 , disponeva la ricostituzione, il 1° luglio, ad Aosta di una scuola di alpinismo, erede della glo1iosa Scuola centrale Militare di Alpinismo, con la nuova denominazione di Scuola Militare Alpina.
L' Istituto veniva costituito con Ufficiali de l battaglione Aosta, per costituire il primo nucleo, e con assegnazioni ad hoc a cura delle Direzioni Generali compelenti d'intesa con l'Ufficio Ordinamento dello SME, le dotazioni erano a cura delrUfficio Servizi dello SME.
Alla Scuola inoltre non veniva data autonomia amministrativa che era invece demandata al 4° reggimento Alpini; la dipendenza era dall'Ispettorato dell'Arma di Fanteria, per l' ordinamento e l' addestramento, e dal Comando Militare Territoriale di Torino per quanto riguardava gli aspetti inerenti alla disciplina, all'amministrazione ed al benessere.
Il nuovo nome dell'Istituto discendeva, come indicato dalle direttive di massima per la Scuola, dalla necessità di meglio definire la sua essenziale ed unica funzione che era rivolta a scopi ed attività esclusivamente militari.
La sua rinascita , d 'altra parte, rappresentava da tempo una necessità profondamente sentita ed inderogabile per la preparazione e l' aggiornamento professionale dei Quadri giovani delle Truppe Alpine, digiuni , nella quasi totalità, di quelle nozioni tecnico-tattiche e logistiche indispensabili per la vita, il movimento e l'azione nel difficile ambiente costituito da!J ' aJta montagna.
In questo contesto vennero definiti i compiti della Scuola che riguardavano la preparazione dei Quadri, gli studi e la sperimentazione di nuovi materiali , l' aggiornamento della regolamentazione tattica relativa all 'impiego di reparti in a lta montagna comprendendo l'impiego dei paracadutisti e la guerriglia e controguerriglia , eventuale preparazione di nuclei o squadre di atleti sciatori per competizioni olimpiche o internazionali.
119 Cfr. Doc umento n.38: circolare n.1480/ 0rd./I in data 12 giugno 1948 , Costituzione Scuola lvlilitare di Alpinismo in Aosta.

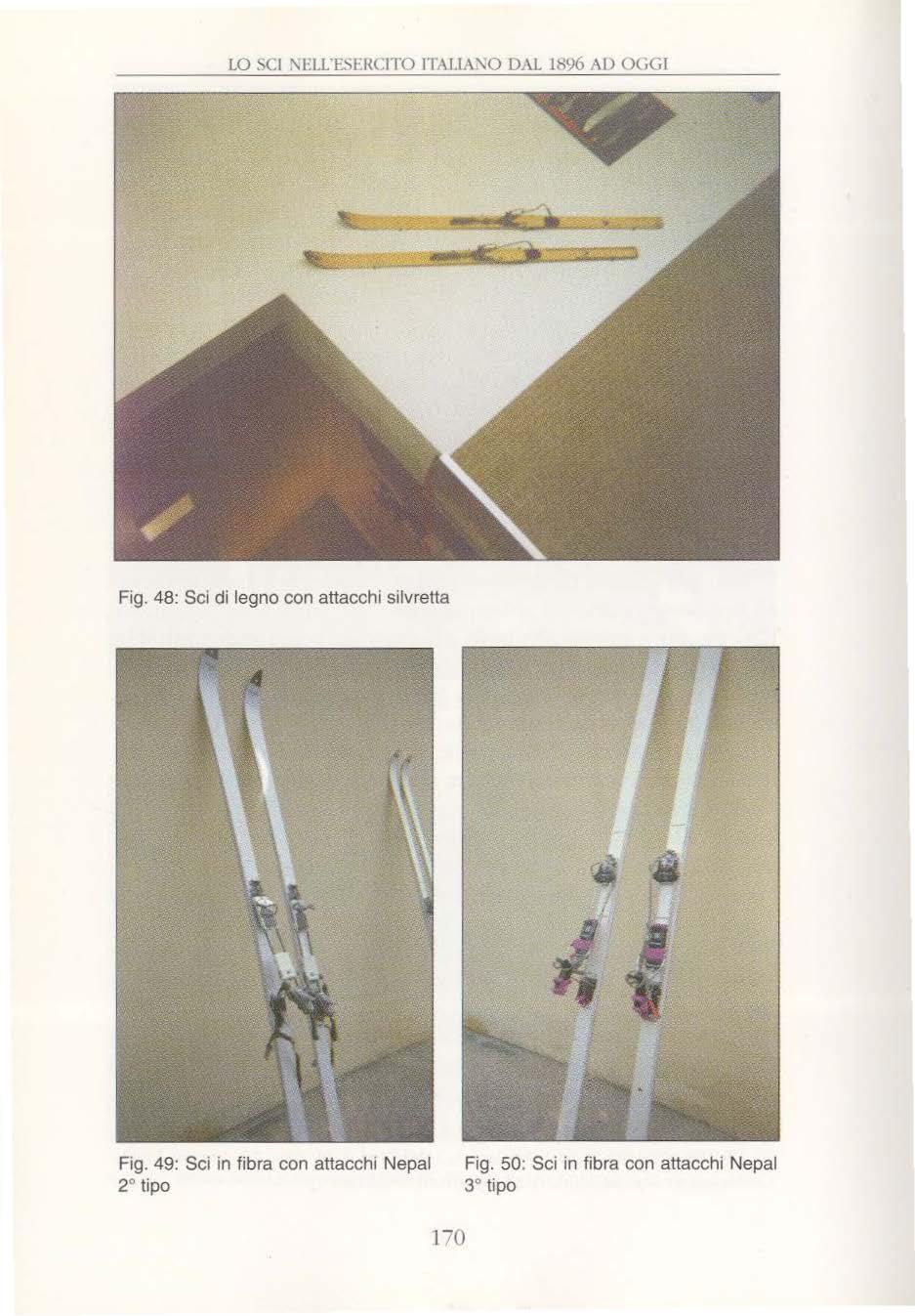
E fu così che domenica 22 agosto 1948 nel corti le del Cas Lello, che per l'occasione aveva anch'esso cambiato nome da Duca degli Abruzzi in Generale Antonio Cantore, ed alla presenza dell'Onorevole Meda Sottosegretario alla Difesa , il Comandante Tenente Colonnello Francesco Vida, dopo aver dato lettura dell'ordine con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito aveva sancito la riapertura della Scuola, ridava solennemente vita aJ prestig ioso Istituto.
IL nucleo embrionale era costituito da un Comando, una sezione roccia e ghiaccio, una sezione sci, una sezione studi ed espetienze ed un reparto comando.
Con la Direzione delle Telecomunicazioni - Ufficio meteodella lA Zona aerea tenitoriale di Milano iniziò un rapporto di collaborazione in campo meteorologico particolarmente utile per gli studi che la Scuola stava conducendo per una migliore conoscenza dei fenomeni legati al manto nevoso quali il ve1ificarsi delle valanghe.
Successivamente per far fronte agli impegni internazionali di rappresentanza in campo agonistico , lo Stato Maggiore dell'Esercito ritenne opportuno rivedere l' iniziale impostazione della SMALP, basata esclusivamente sull' addestramento militare dello sci, e decise di costituire, il 1° gennaio 1950. il Nucleo speciale sciatori ad indirizzo agon istico, con sede a Courmayeur.
Il 1° settembre 1951, per adeguarsi alle mutate esigenze addestrative, la Scuola ebbe un nuovo assetto ordinativo, articolandosi su un Comando Scuola e reparto comando, una sezicne studi ed esperienze, una sezione sci . una sezione roccia e ghiaccio , un nucleo sci-agonistico, erede del nucleo speciale, ed un gruppo addestramento; quest'u ltimo , in rea ltà si costituì a La Thuile solo il 1 ° febbraio 1952.
Negli anni successivi la Scuola ampliò il campo dei frequentatori dei corsi ammettendovi rappresentanti di Paesi alleati ed amici; particolare risalto assunse inoltre , a partire dal 16 marzo
1953 l' addestramento di un nuovo reparto: il plotone alpini paracadutisti della Brigata Tridentina, a l qua le seguirono negli anni successivi e man mano che si costituivano i plotoni paracadutisti delle altre quattro Brigate.
Sempre in quell'anno per poter addestrare in maniera più proficua alla vita in ambiente alpino le nuove generazioni di
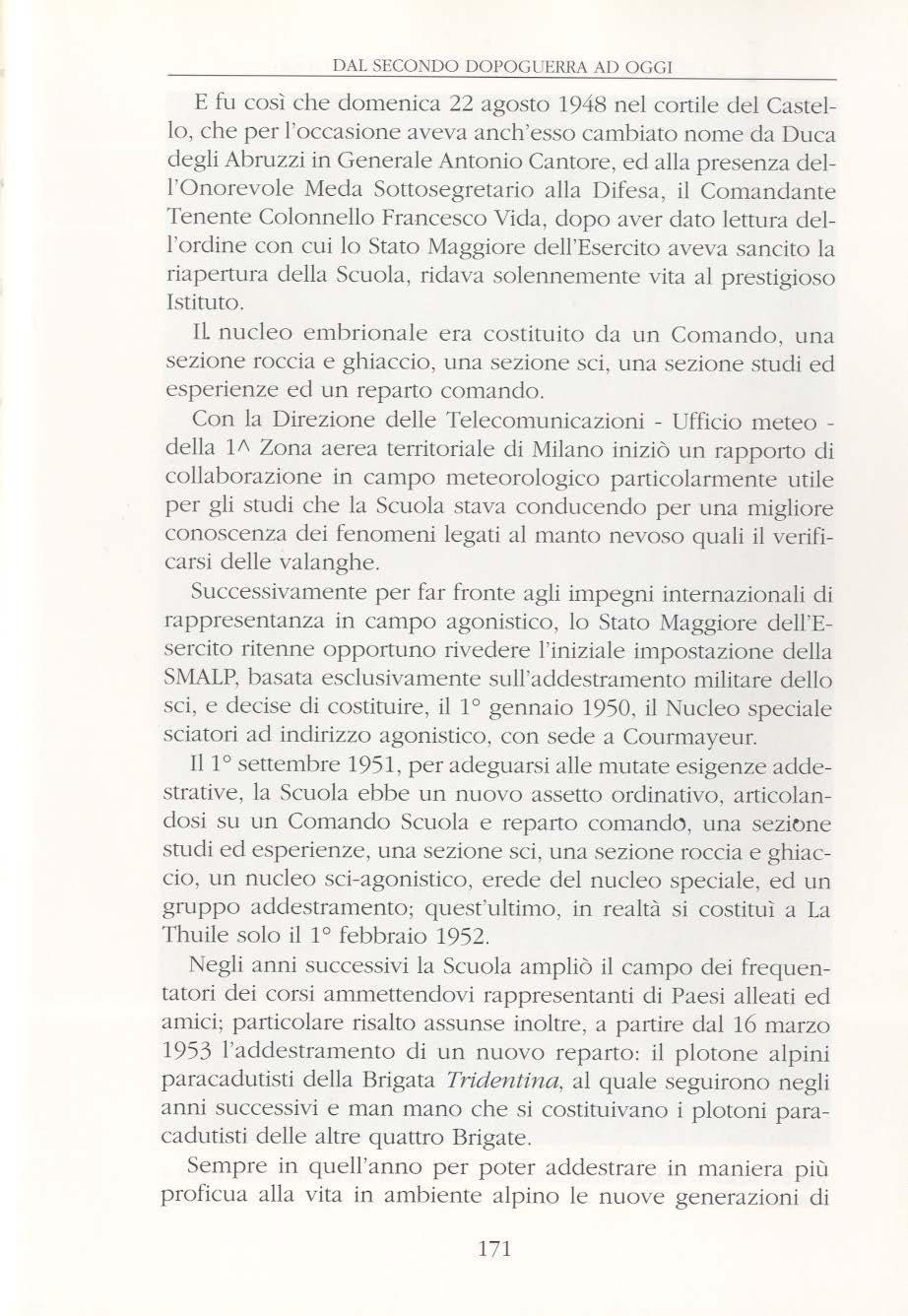
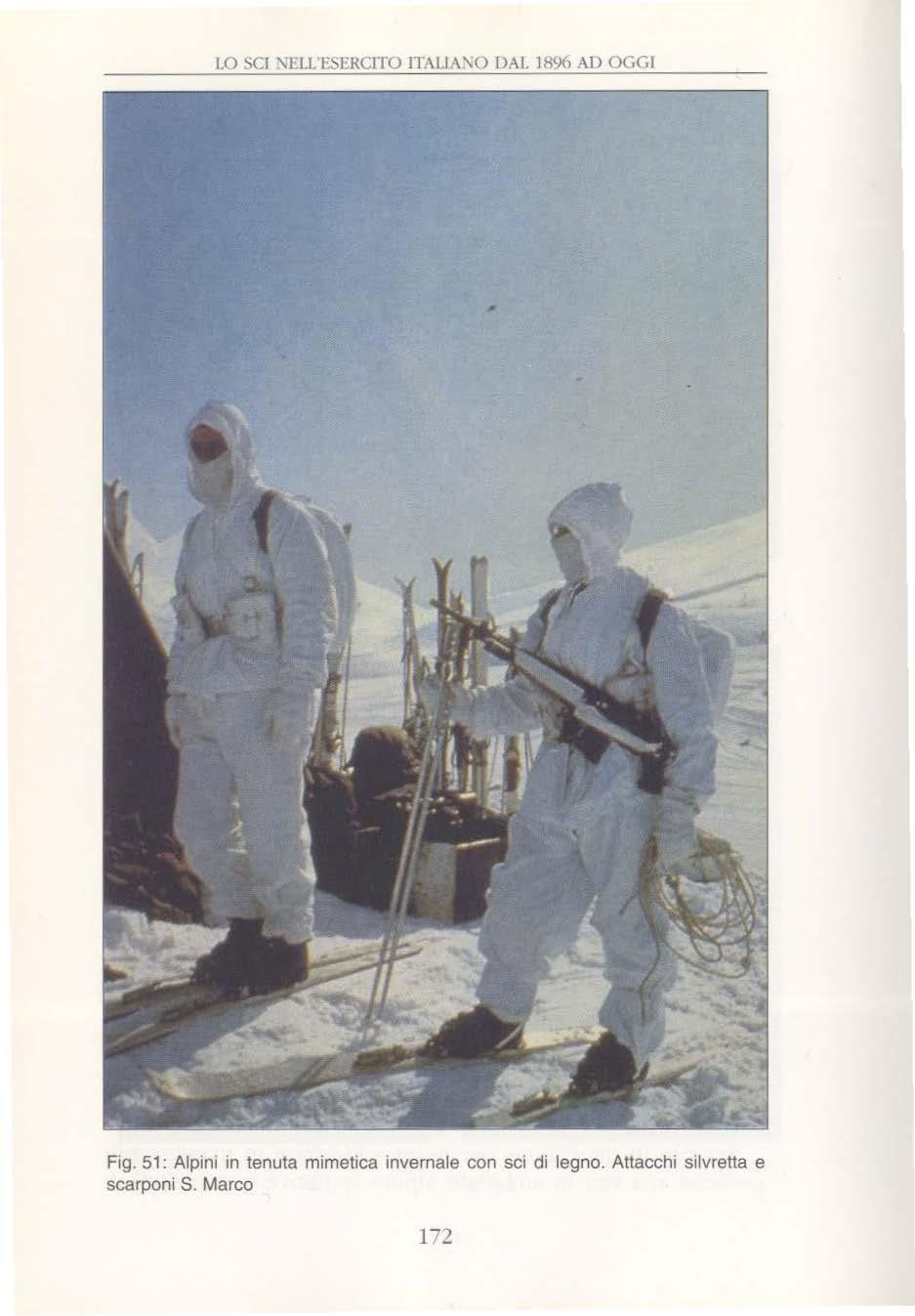


Quadri, il gruppo addestramento si trasformò in battaglione di addestramento su una compagnia comando, una compagnia allievi Sottufficiali cli complemento (A.S.C.) ed un reparto addestramento speciale.

Il 1° gennaio 1960, per addestrare in maniera unitaria le esigenze sportive ed agonistiche dell'Esercito, lo Stato Maggiore dispose la costituzione del Centro Sportivo Esercito e di alcuni Reparti Speciali Atleti, tra i quali il I plotone speciale atleti, organicamente inquadrato nella SMALP. e del quale facevano parte i militari designati per gli sports invernali; la nuova unità assorbì il nucleo sci-agonistico che venne sciolto sotto la stessa data.
Nel 1964 la Scuola subì un ampliamento organico, costituendosi su un Comandante (Generale di Brigata), un Comando, un Reparto Corsi Speciali (Sezione sci-a lpinistica. Plotone esploratori atleti, Plotone alpieri sciat01i) e un Reparto Corsi A.U.C.A.S.C. (Plocone Comando , btg . A.U.C., btg. A.S.C.-A.C.S., btg.
Oggi la Scuola prosegue, nel solco ormai consolidato da una quasi cinquantennale esperienza, nell'attività di preparazione scialpinistica dei Quadri delle Truppe Alpine, dei Paracadutisti e degli Incursori della Marina Militare collaborando, in maniera esemplare, anche con le Scuole similari dei Paesi Alleati ed Amici.
L'esigenza di costituire, nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, dei nuclei di sc iator i sorse nel primo dopoguerra quando ci si rese conto della necessità di avere degli elementi in grado di assolvere i compiti istituzionali anche in zone d'alta quota.
Per risolvere il problema, il Comando Generale dell'Arma istituì, nel 1922, i quadri degli sciatori, comprendente quei Carabinieri che erano stati specificatamente addestrati sia con una metodica preparazione tecnica sia con un 'a mpio addestramento pratico.
Gli allievi venivano scelti tra coloro che prestavano servizio nelle Stazioni site in località di montagna favorendo così un continuo affinamento tecnico del personale.
Nel secondo dopoguerra, con l' incremento del turismo in

montagna, si accentuarono proporzionalmente anche gli impegni operativi dei Carabinieri <leUe Stazioni di montagna nelle operazioni di soccorso e salvataggio.
In tale ambito, con lo scopo di assicurare ai reparti operativi un adeguato numero di sciatoti, venne istituita sul Monte Bondone una Scuola Alpina dell'Arma.
Questa, nell'ambito di una completa ristrutturazione operativa-addestrativa dell'Arma, venne, nel 1968, trasferita a Selva di Val Gardena assumendo la denominazione di Centro Carabinieri Addestramento Alpino.

Qui, oltre a provvedere all ' addestramento dei Carabinieri destinati alle stazioni montane, ebbe sede anche il Centro Sportivo Carabinieri per quanto attiene agli sports invernali.
Questi era nato nel 1965 a Canazei, località che si prestava particolarmente per gli allenamenti sciistici, ospitato nella locale Stazione ed alle dipendenze disciplinari del VII battaglione di stanza a Laives.
Oggi i Carabinieri sciatori sono presenti sulle piste delle maggiori località turistiche italiane a prestare la loro encomiabile opera a favore della popolazione, mentre gli atleti con la loro presenza e soprattutto con i loro risultati sportivi ottenuti in campo internazionale danno lustro e prestigio all'Arma ed alla Nazione.

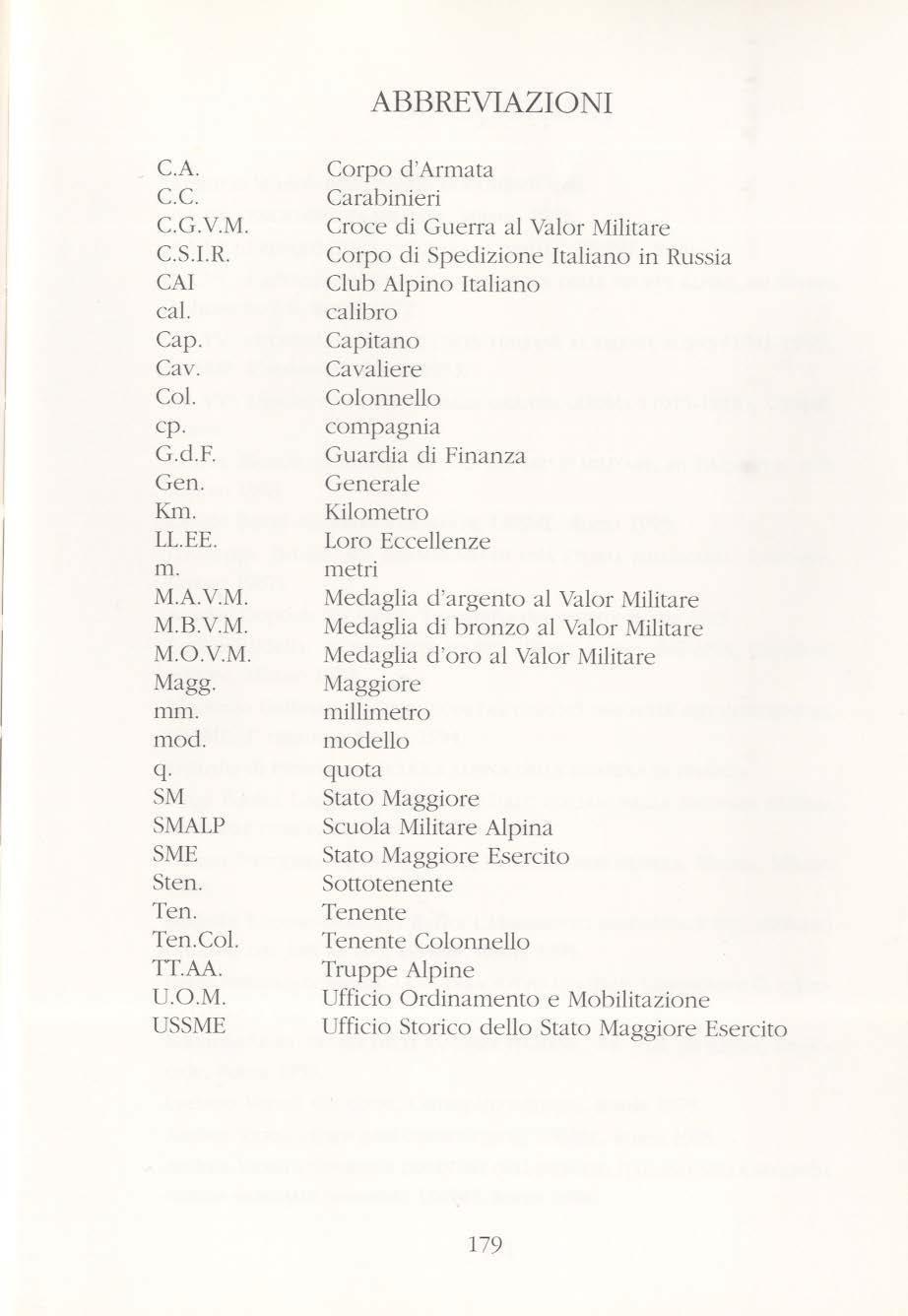
Corpo d'Armata
Carabinieri
Croce di Guerra al Valor Militare
Corpo di Spedizione Italiano in Russia
Club Alpino Italiano
calibro
Capitano
Cavaliere
Colonnello
compagnia
Guardia <li Finam:a
Generale
Kilometro
Loro Eccellenze
metri
Medaglia (i"argento al Valor MiUtare
Medaglia di bronzo al Valor Militare
Medaglia d'oro al Valor Militare
Maggiore
millimetro
modello
quota
Stato Maggiore
Scuola Mil it are Alpina
Stato Maggiore Esercito
Sottotenente
Tenente
Tenente Colonnello
Truppe Alpine
Ufficio Ordinamento e Mobilitazione
Ufficio Storico dello Slalo Maggiore Esercito


Archivio Storico dell'USSME: DOCUMENTl VARJ.
AA.VV.: ENCICLOPEDIA MILITARE, Milano 1933.
AA.VV.: l REPARTI DELLA l " GUERRA MO:'-JDIALE, USSME, Roma.
AA VV. : L ' ATTIVITÀ SPORTIVA SCI -ALPI;--1ISTICA DELLE TRUPPE ALPJNE, su Rivista Mi lita re n . 7/ 8, Roma 1972.
AA.VV.: LE OPERAZIONI DELLE UNITA' ITALIANE AL FRON'TE RUSSO (1941 - 1943), USSME, 1" ristampa, Roma 1993.
AA.VV. : L'ESERCrTO ITALIANO NELLA GRANDE GUERRA (1915 - 1918), USSME, Roma.
Gianni Bianco: INIZIO DEL SECOLO: LO 'SK1" E' MIUTARE, su l'Alpino n. 8/9, Mila n o 1983.
Oreste Bovio: SACERDOTI DI MARTE, USSME, Roma 1993.
Giuseppe Bruno: SCl. FRAMMENTI DI UNA STORIA MlLLENARIA, l'Arciere, Cuneo 1987.
Amelio Dup ont: GLI ALPINI, Tipografia del senato, Roma 1929.
Emilio Faldella: STORIA DELLE TRUPPE ALP INE, a c u ra dell 'ANA, Cava llotti editore, Mi lano 1972.
Vincenzo Gallin ari : LE OPERAZIONT DEL GIUGNO 1940 SULLE ALPI OCClDEl\:'TALI, USSME, 1" ristampa, Roma 1994.
Guardia di Finanza: LA SCUOLA ALPlNA DELLA GUARDIA Dl flNANZA.
Luigi Emilio Longo: I "REPARTI SPECIALI" TTAUANI NELL<\. SECONDA Gt:ERRA MOND IALE (1940-1943), Murs ia , Milano 1991.
Giannj Pieropan: 1914- 1918. STORIA DE LLA GRANDE GUERRA, Mursia , Milano 1988.
Rodolfo Rotasso-Maurizio Ruffo: L'ARMA.t\fEi\'TO INDIVIDUALE DELL'ESERCITO
ITALIANO DAL 1861 AL 1943, USSME, Roma 1995.
Carlo Fettarappa Sandri : LA GUERRA SOTTO LE STELLE, Casanova e C. editori, Genova 1929
Edoardo Sca la : STORIA DELLE FANTERIE ITALIANE, vo i. VIII: gli Alpini, Regionale, Roma 1950.
Luciano Viazzi: GLT ALPH\TJ, Ciarrapico edizionj , Roma 1978.
Andrea Viotti: Ll.iNlFORME GRIGIO-VERDE, USSME, Roma 1985.
Andrea Viotti: UNIFOR.tW E DISTINTIVI DELL'ESERCITO ITALIANO N"ELLA SECONDA GUERRA MOND1ALE 0940-1945), USSME, Roma 1988.

PRESENTAZIONE DEL CAPO UFFICIO INTRODUZIONE
CAP. I: LO SCI NELLA STORIA
CAP. II: LO SCI IN ITALIA
1. L'avvento dello sci
2. Gli sci: materiali e forma
3. La tecnica sciistica
CAP. UI: LA l ' GUERRA MONDIALE
l. La preparazione dell'Esercito
2. L·evoluzione organica , i corsi, gli
3. Le operazioni sull 'Adamello: '' La guen-a bianca "pag. 81

CAP. lV: IL 1° DOPOGUERRA
1. L'attiv ità addestrativa ed agonist ica tra le due Guerre Mondiali
2. I materiali
3. La spedizione a l Polo Nord del dirigibile "ITALIA"
4. La Scuola Centrale Militare di Alpinismo
CAP. V: LA 2 ' GUERRA MONDIALE
1. 1940: l'intervento italiano in guerra
2. Il fronte occidentale
3. I nuovi ordinamenti de i reparti sciatori
4. La campagna di Russia
5. Le vicende in Italia
CAP. VI: DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI
1. L' att ività addestrativa, agonistica e normativa dalla guerra ad oggi
2 . I materiali
3 La Scuola Militare Alpina
4. I Carabinieri sciatori ABBREVIAZIONI