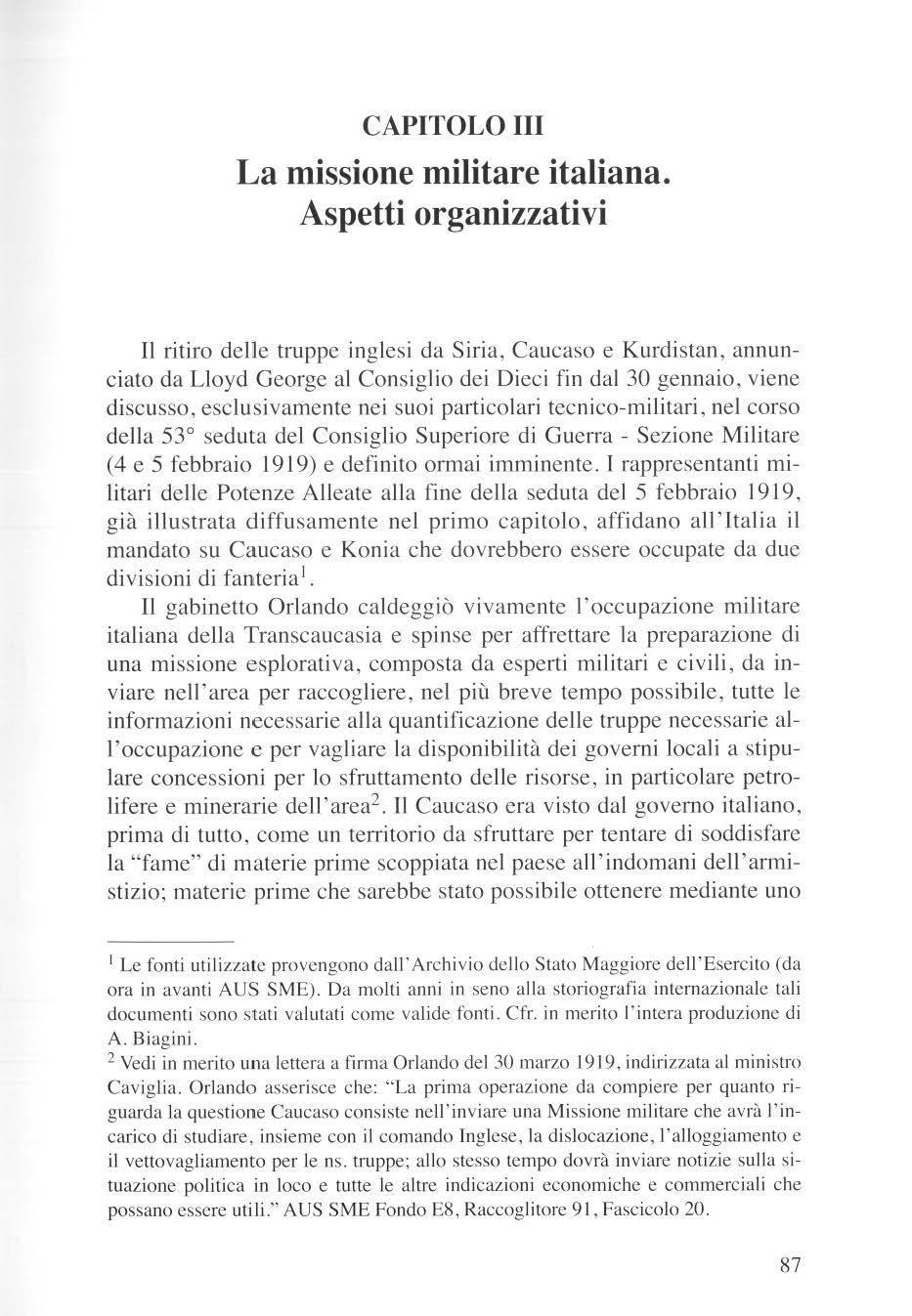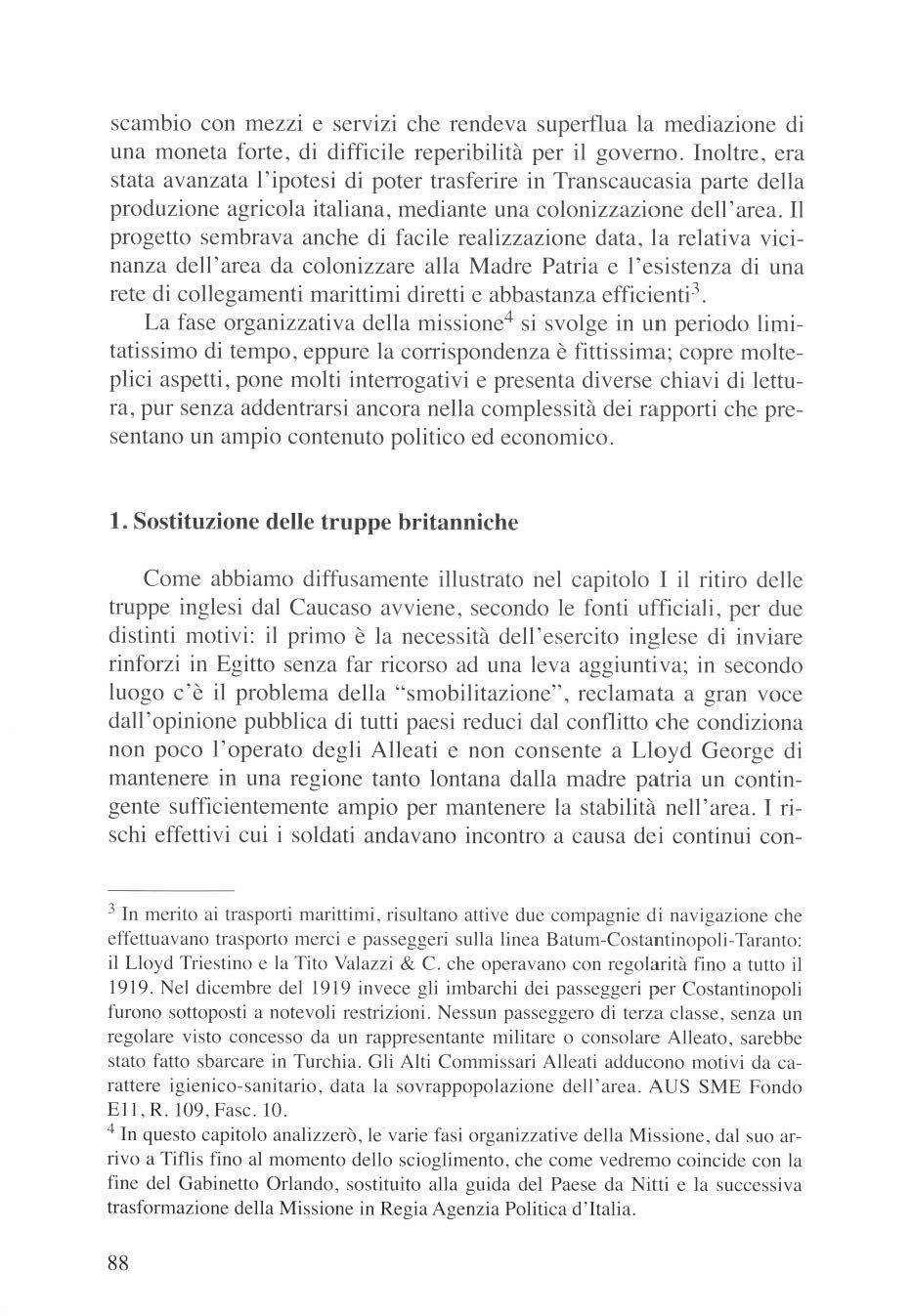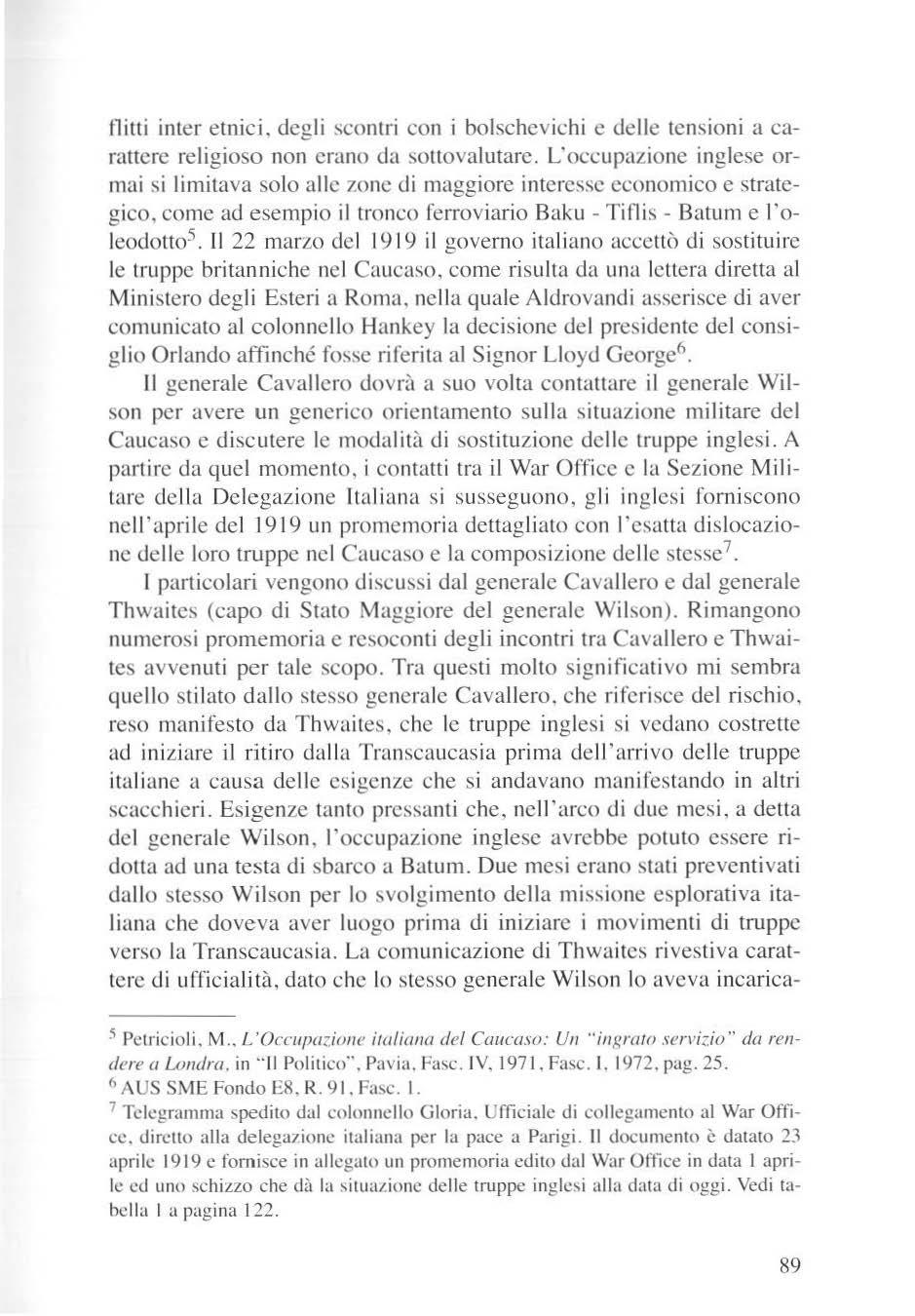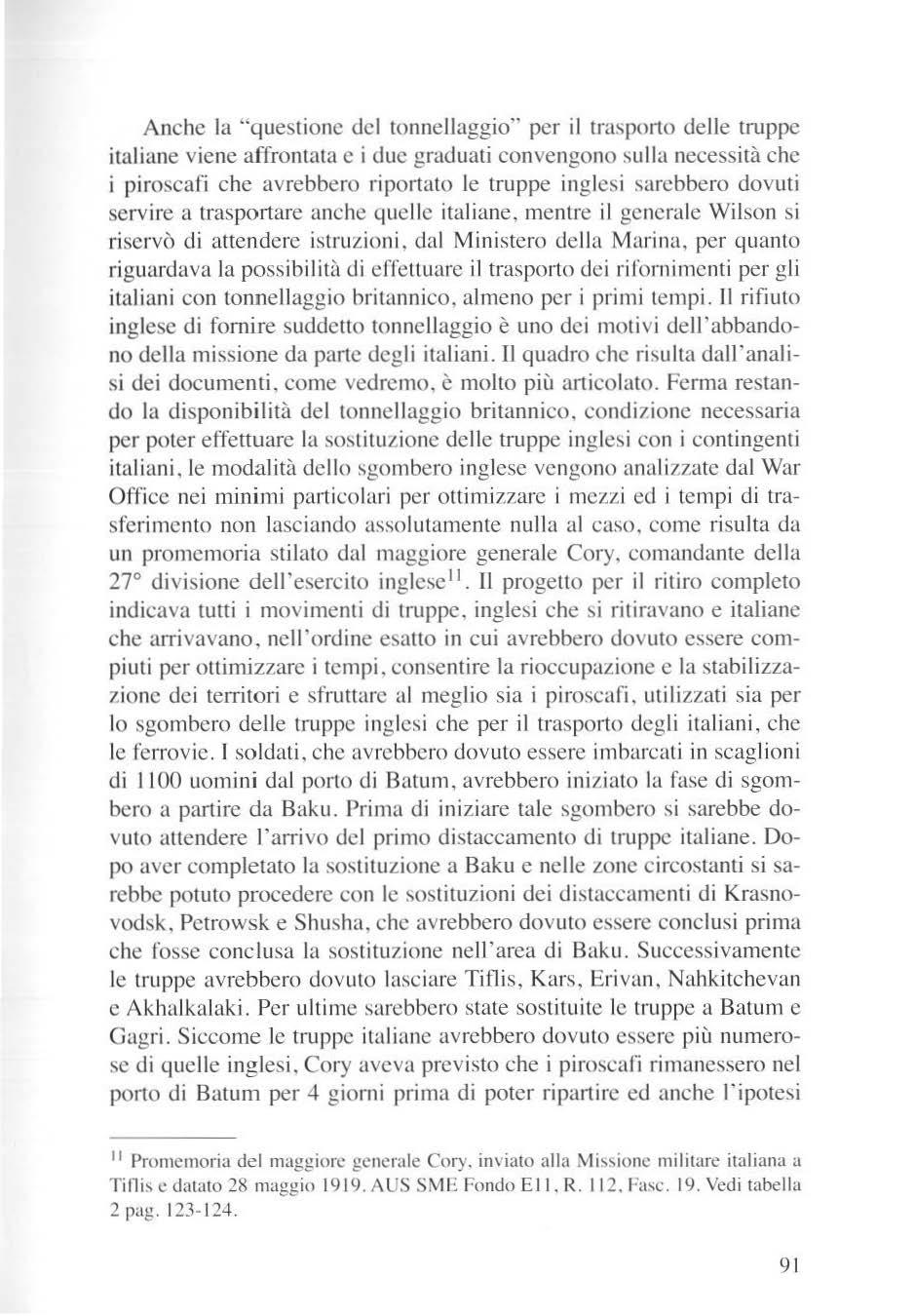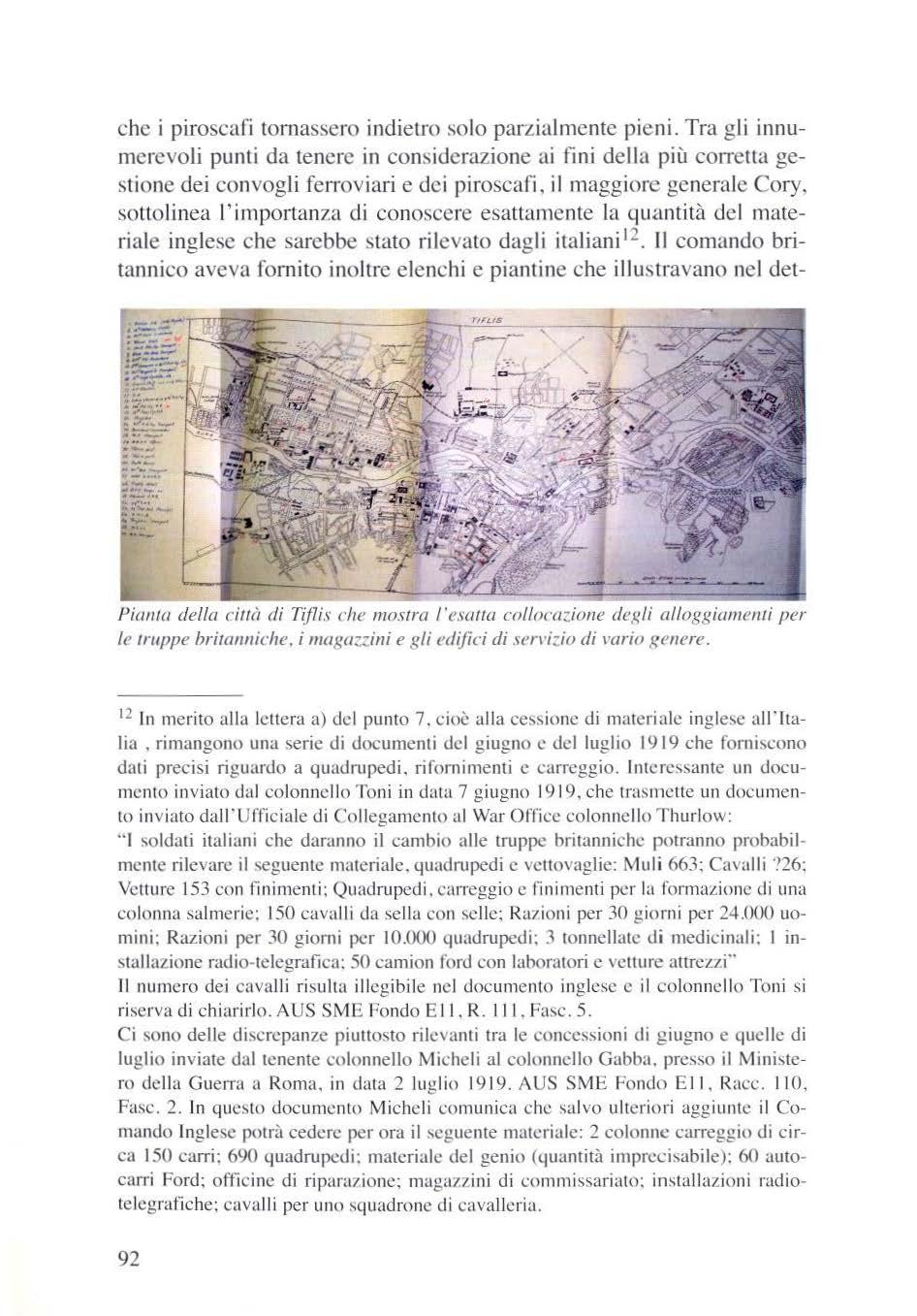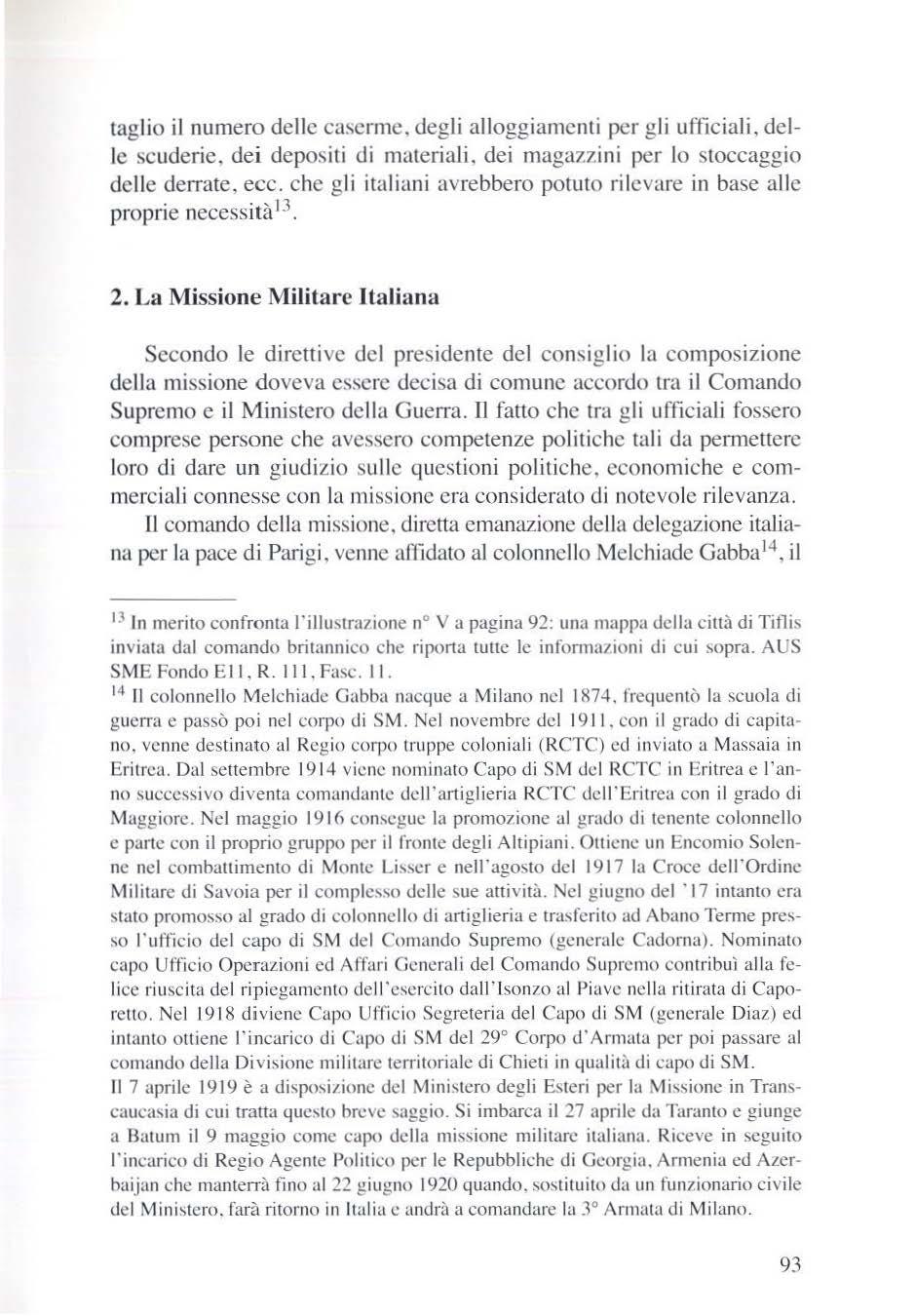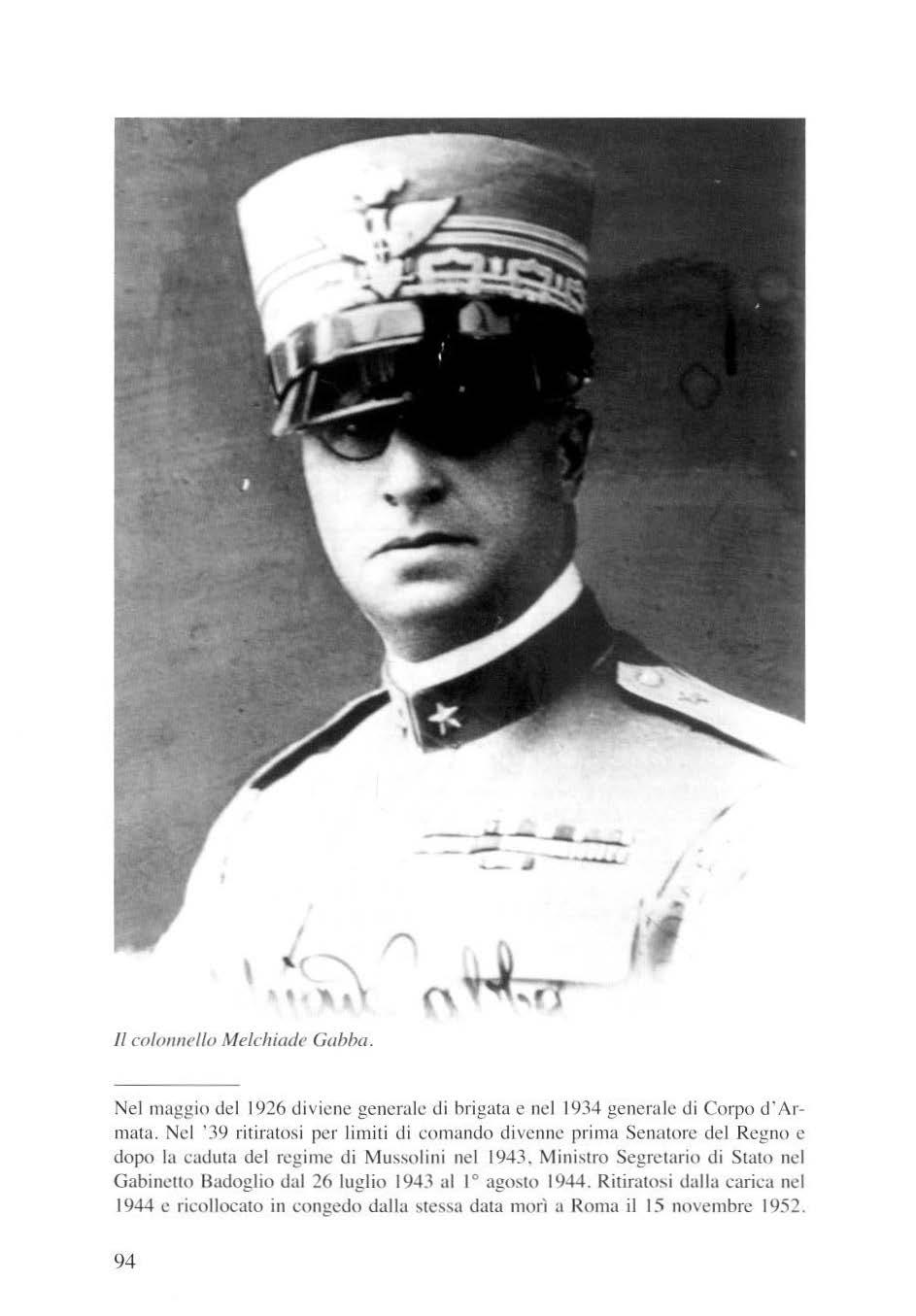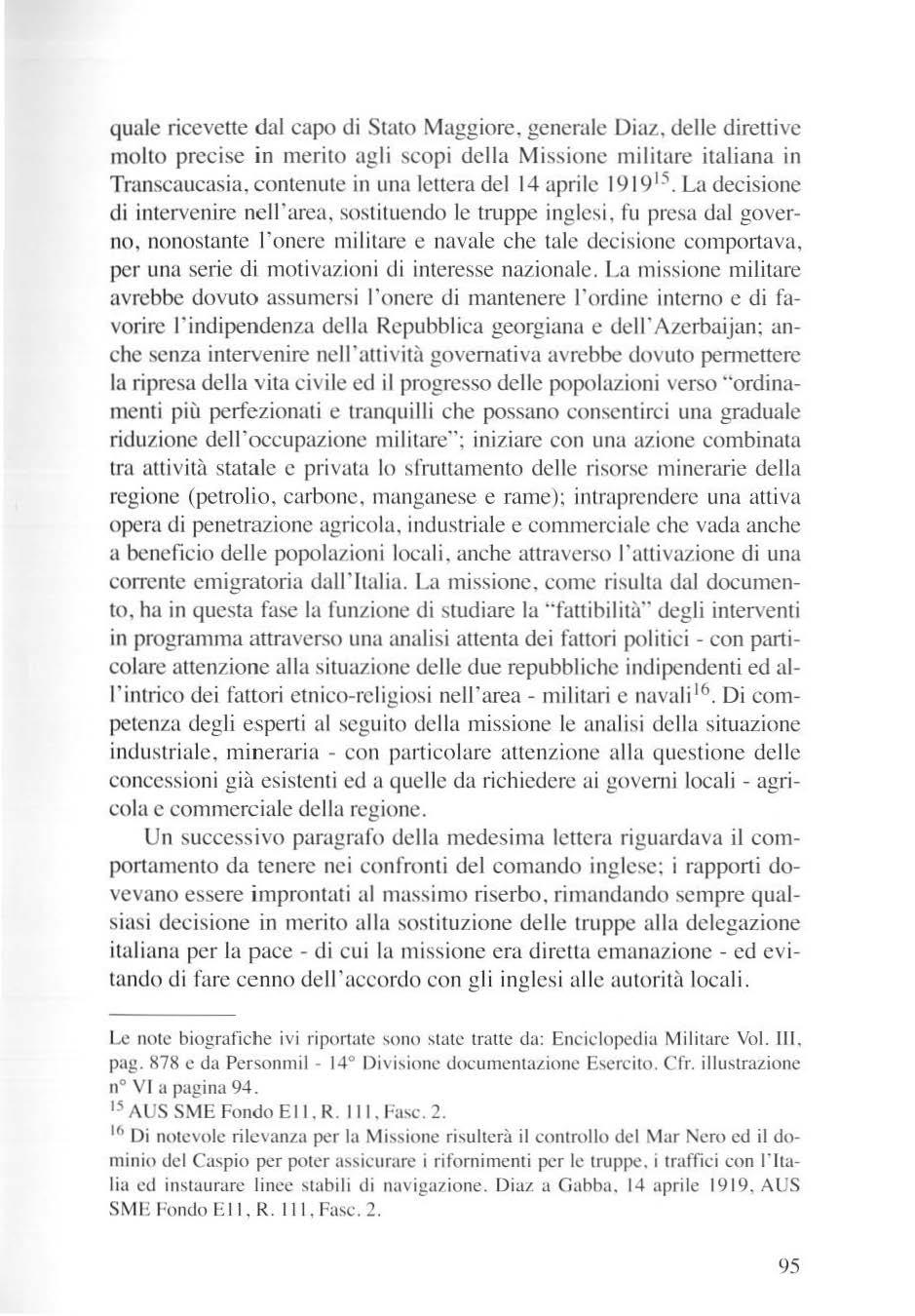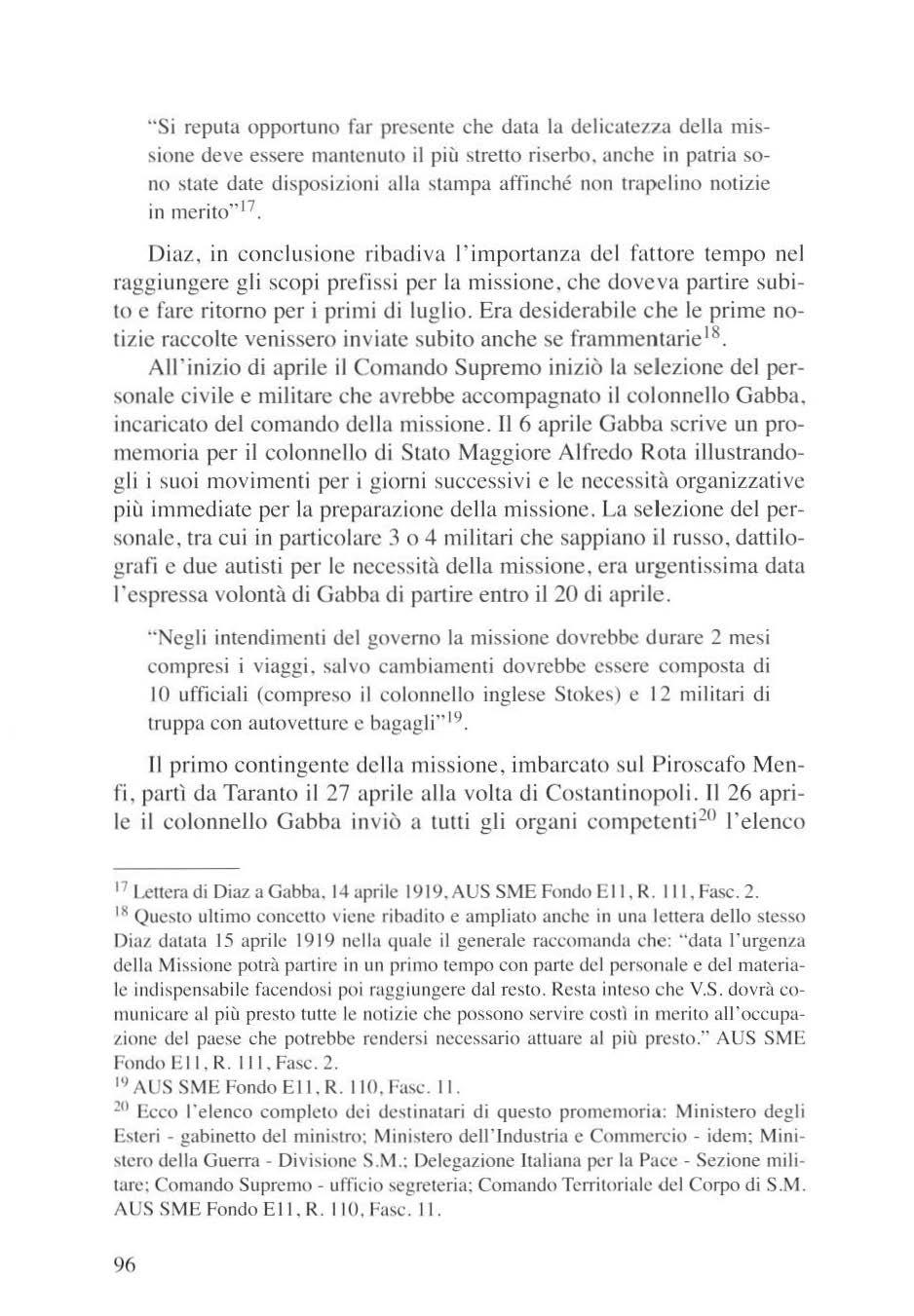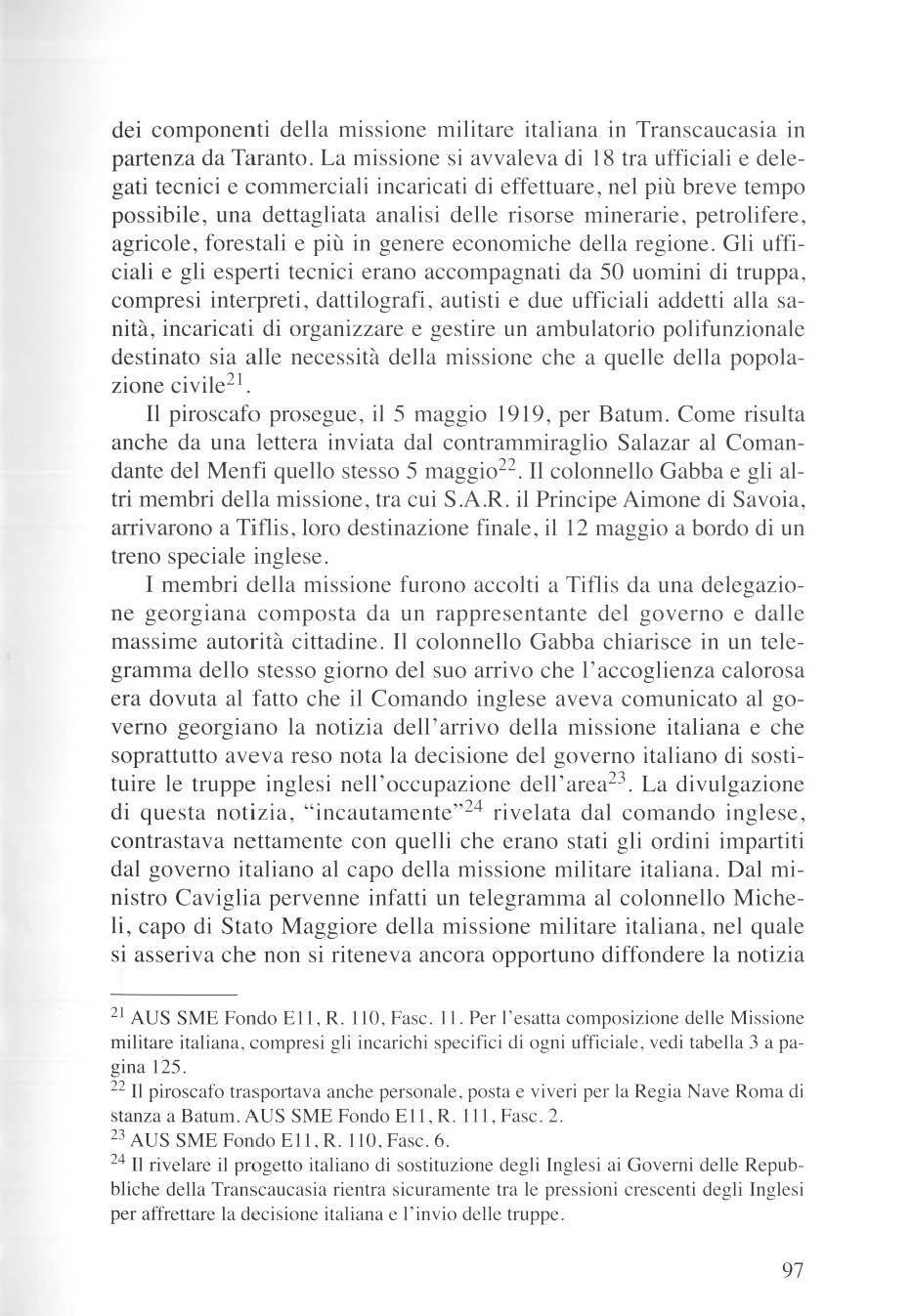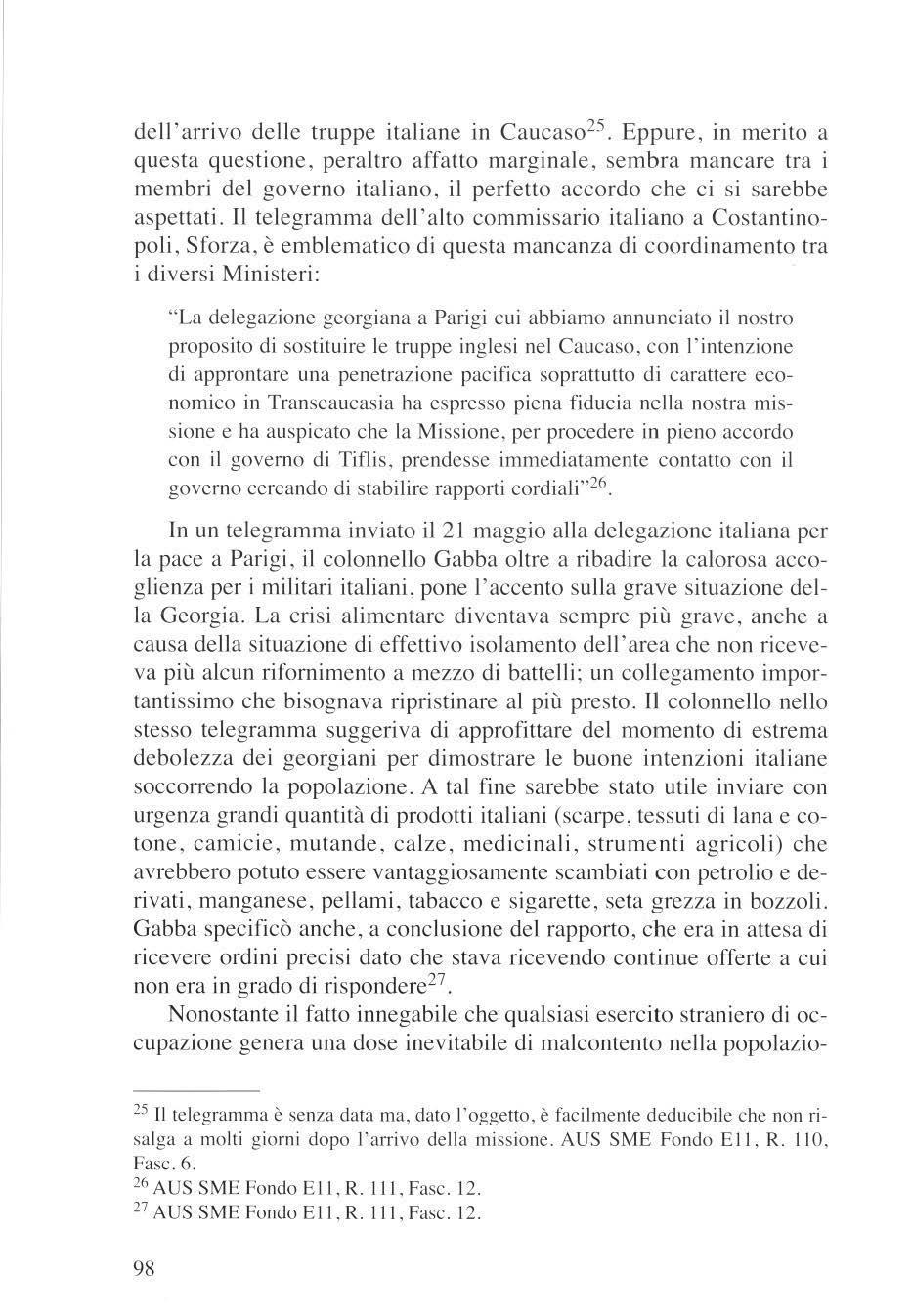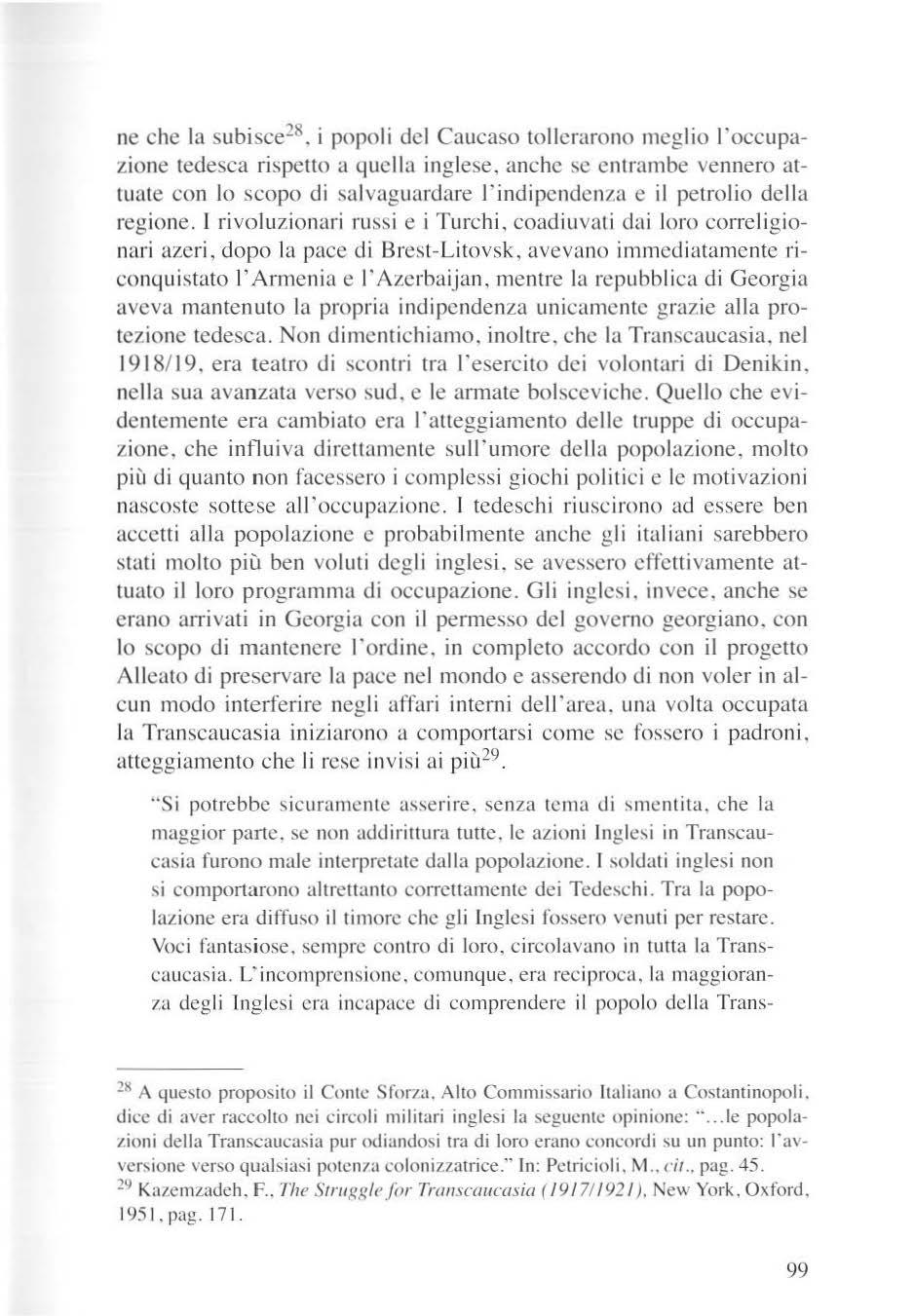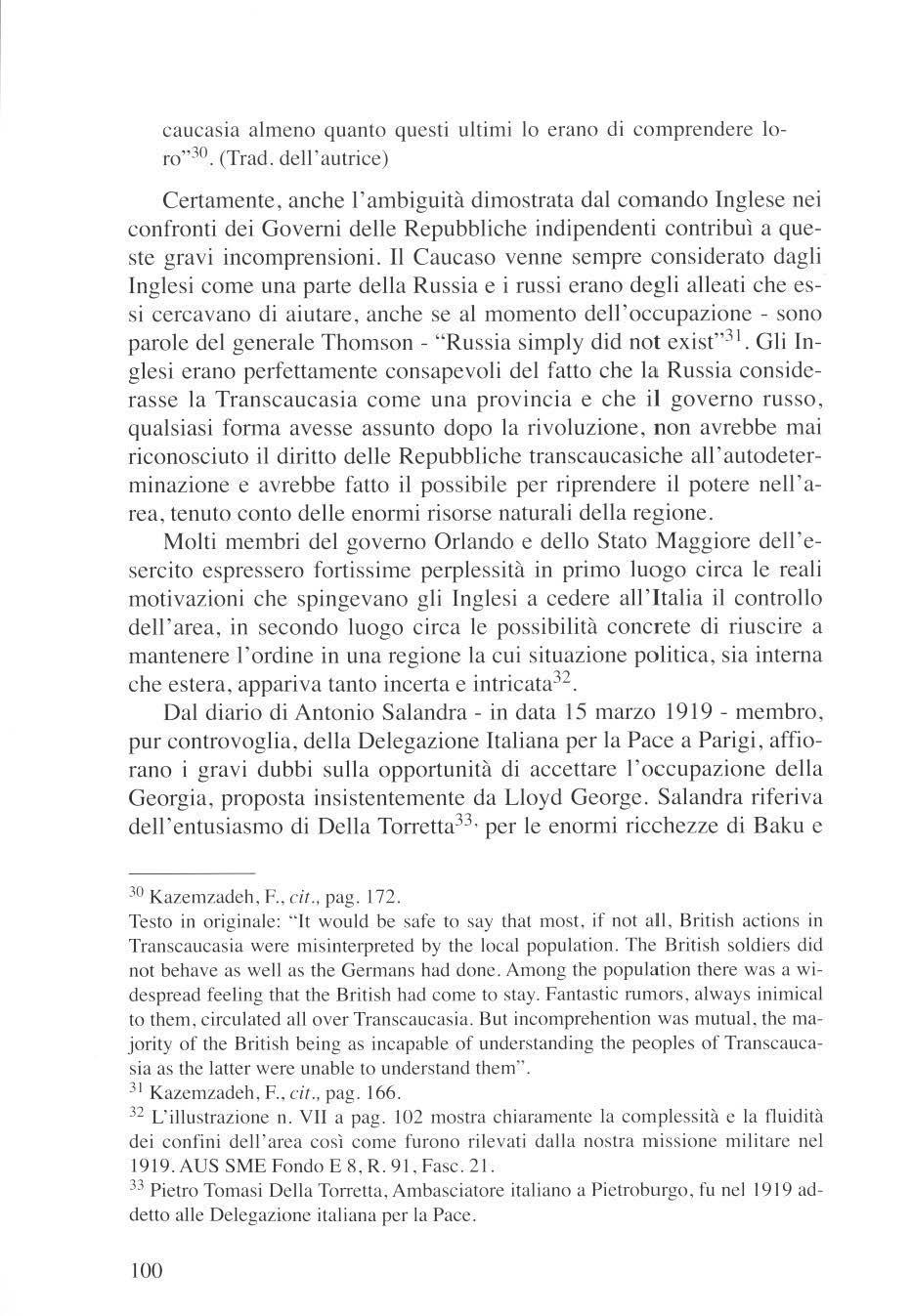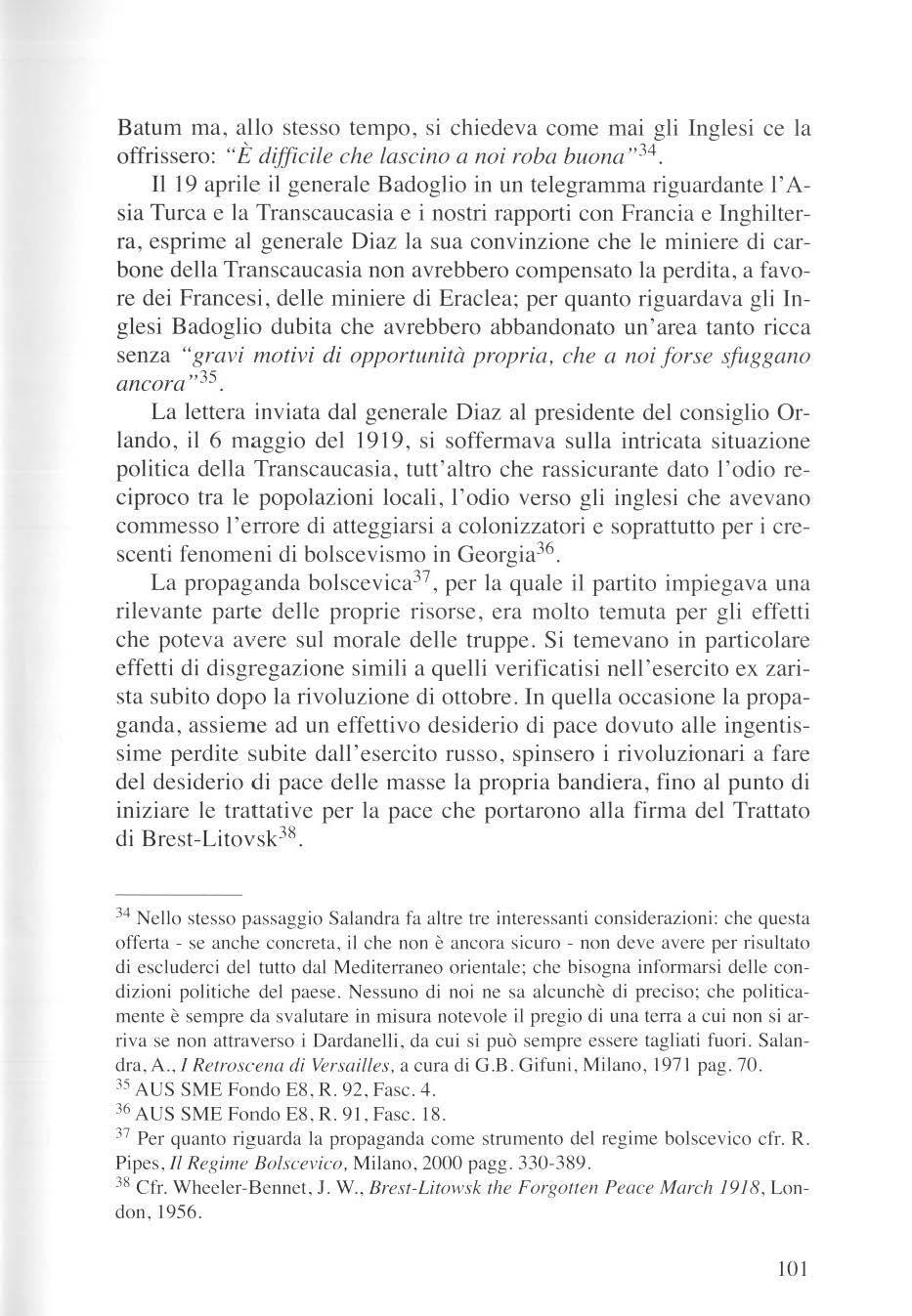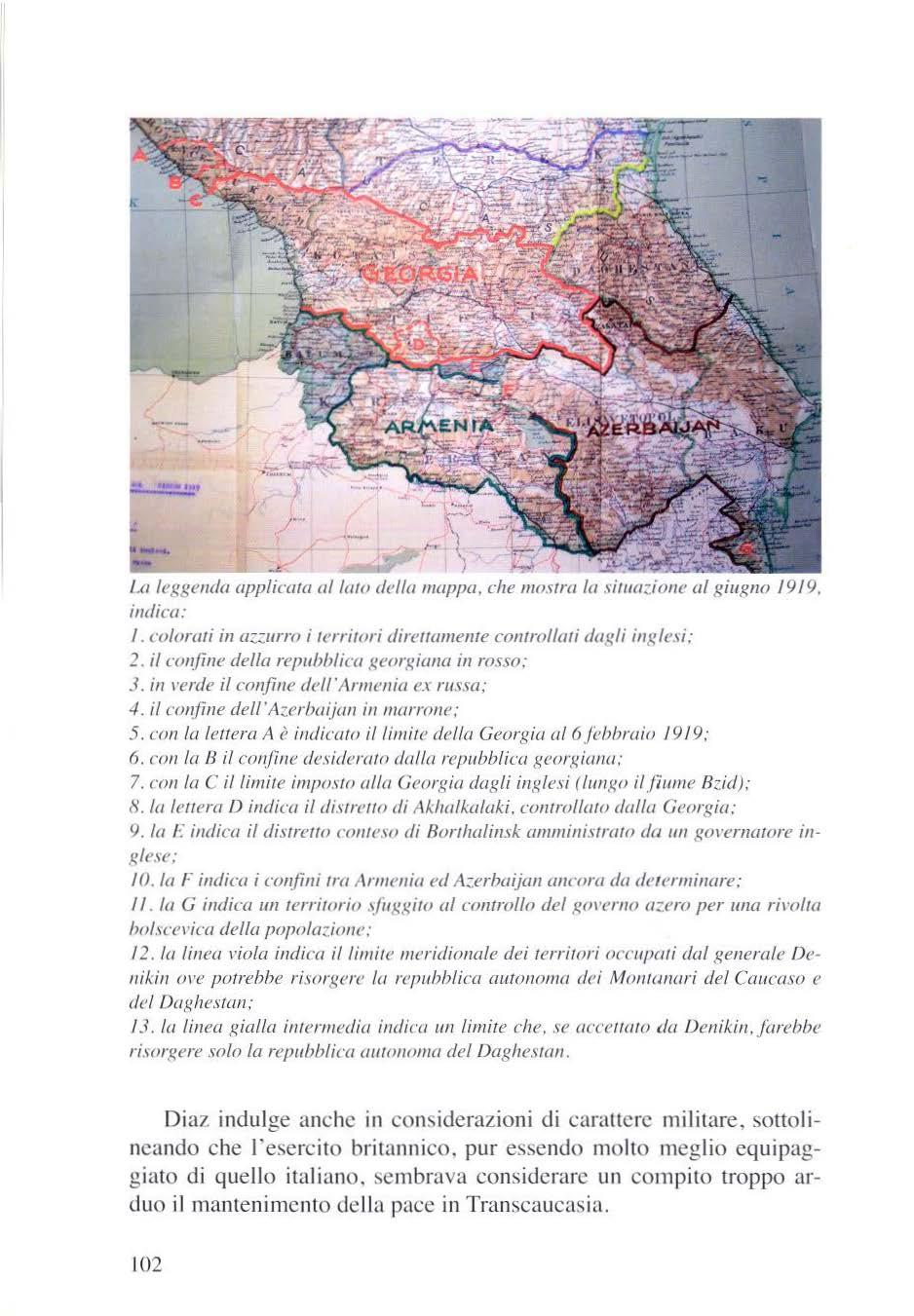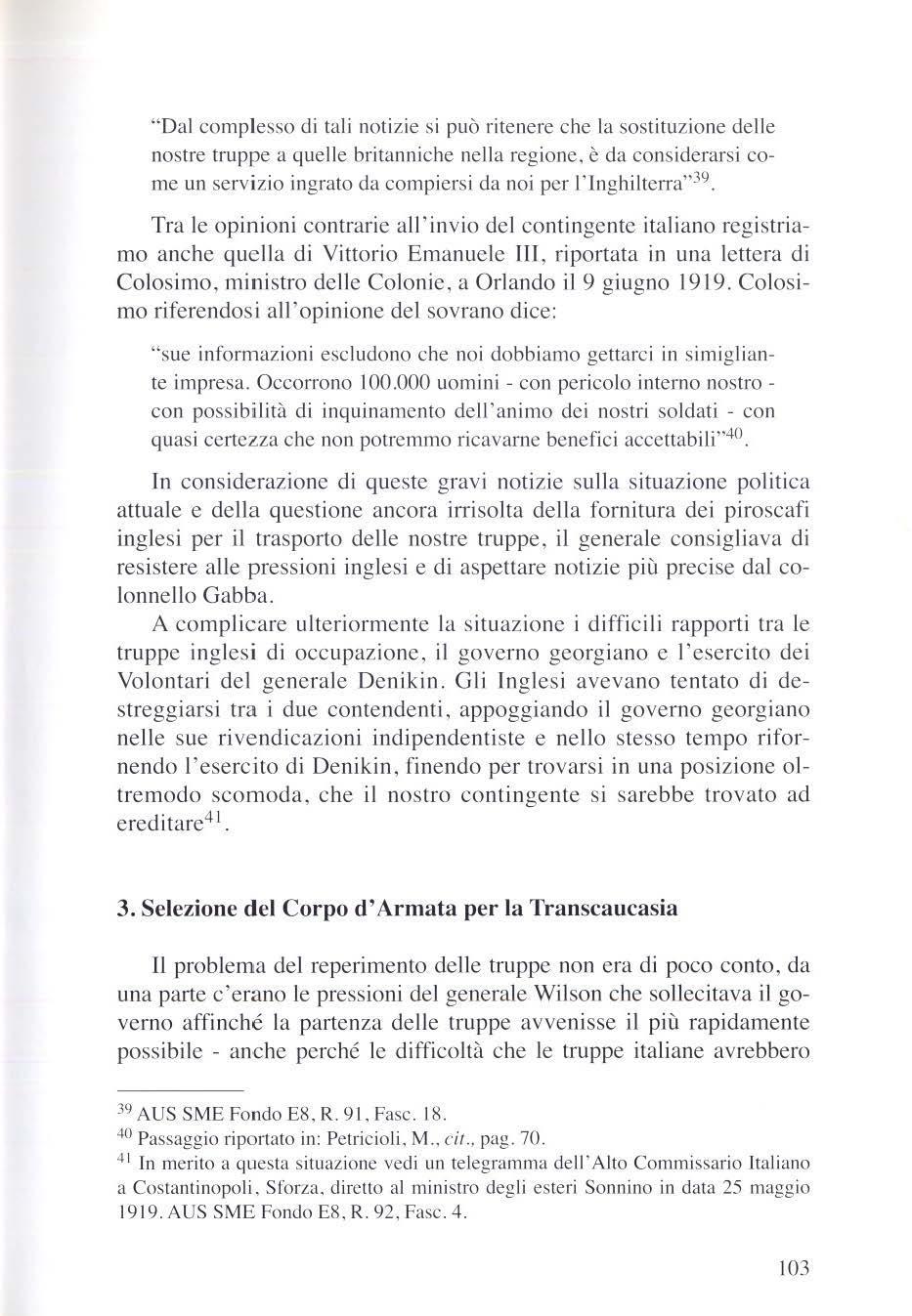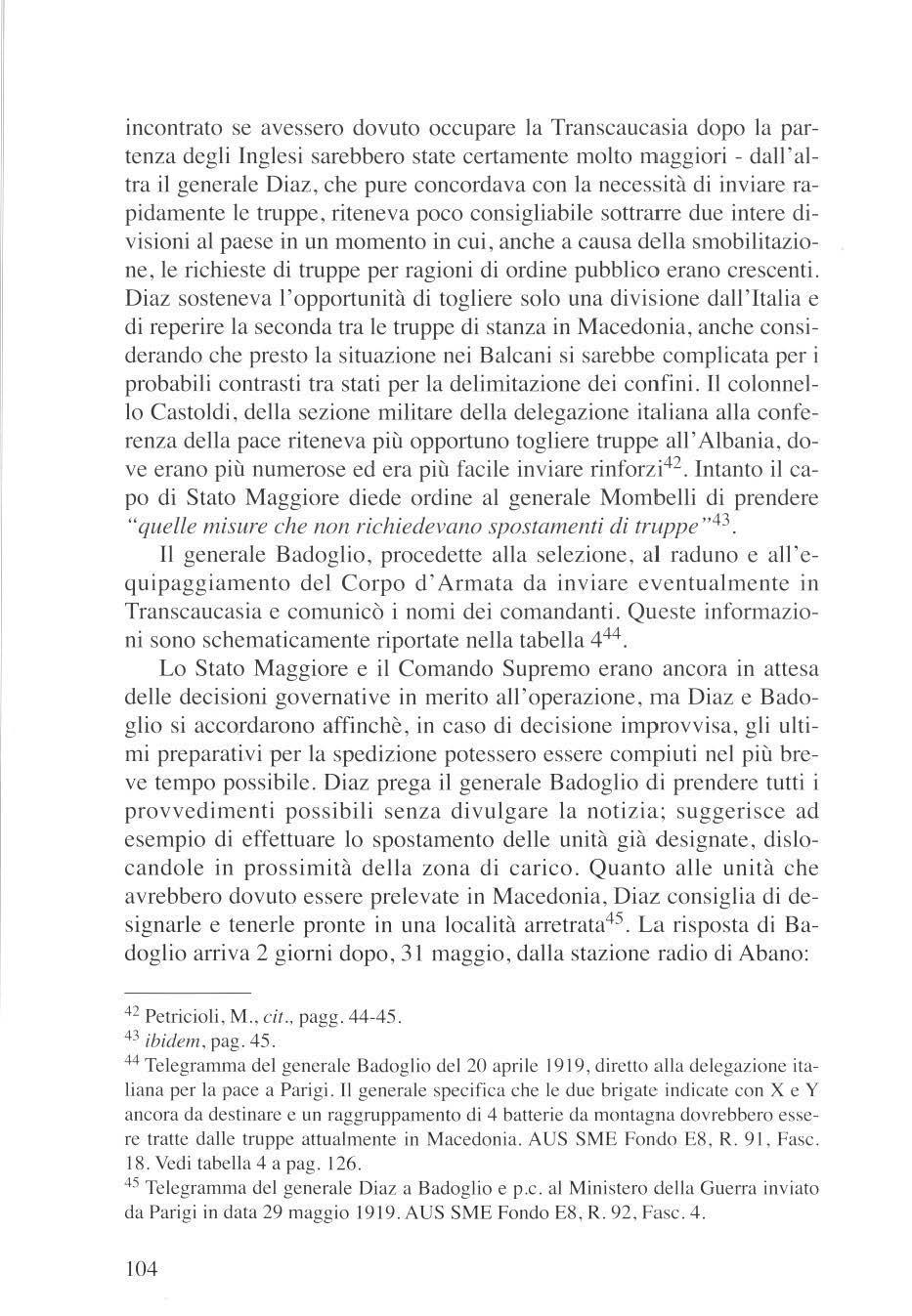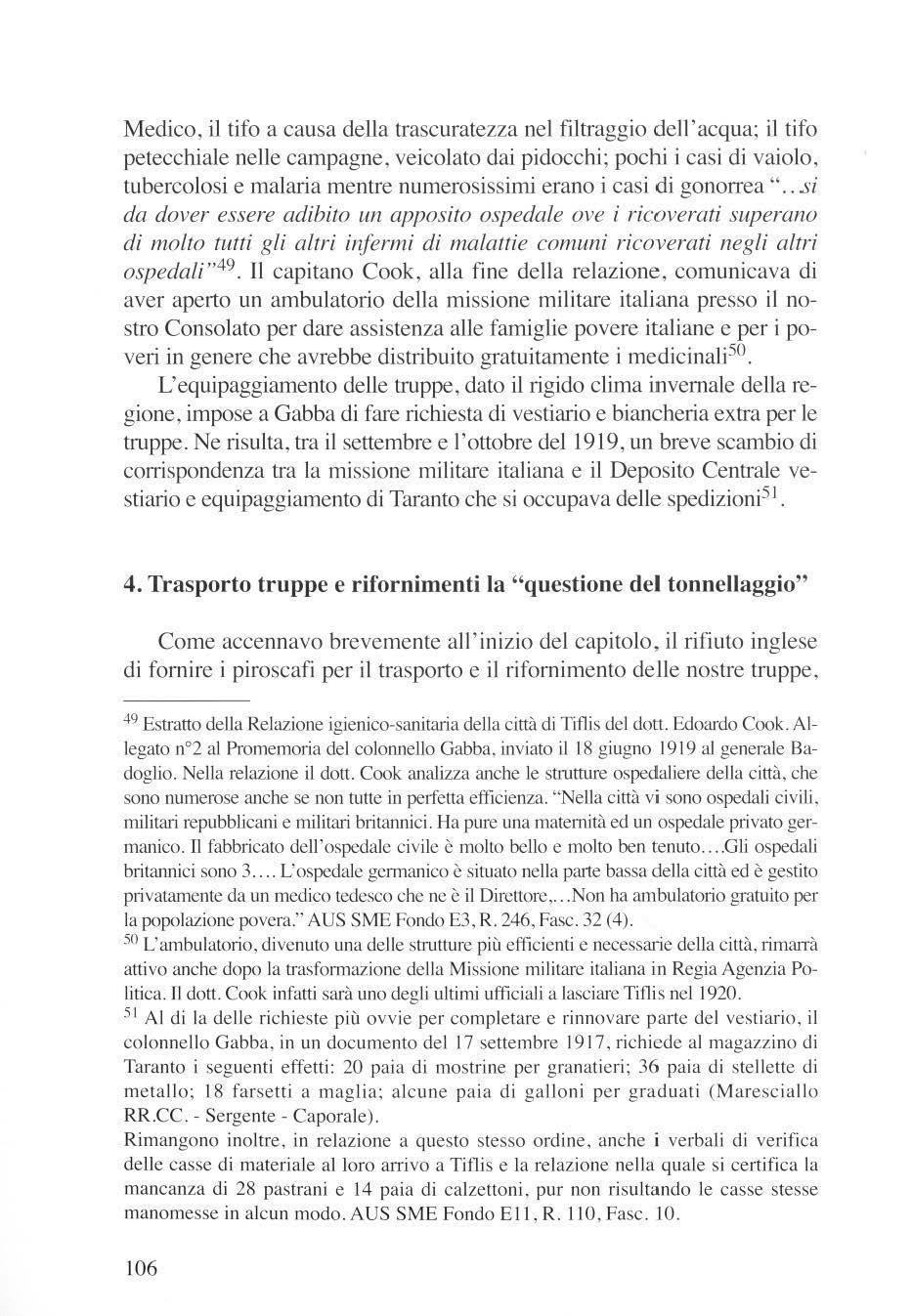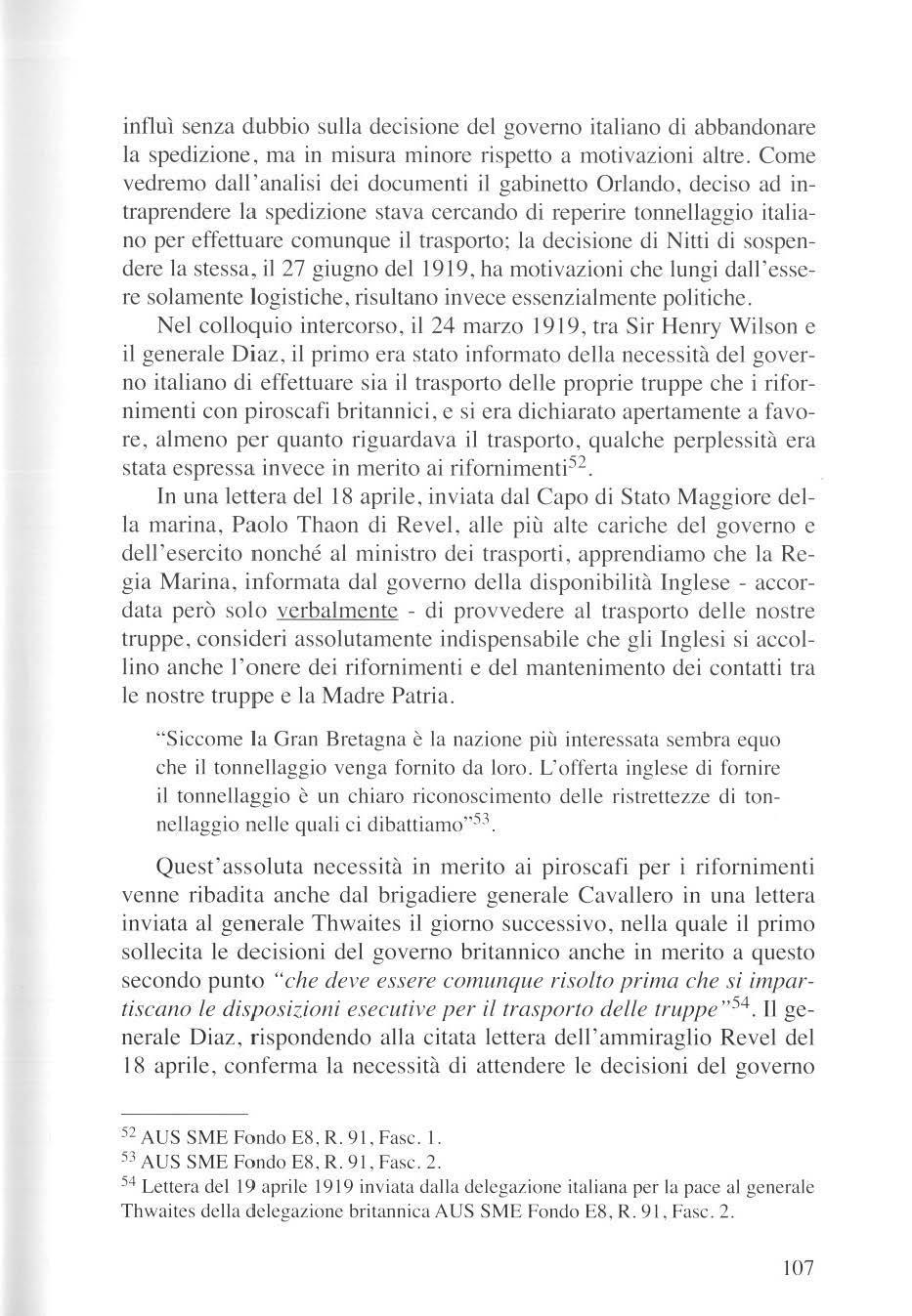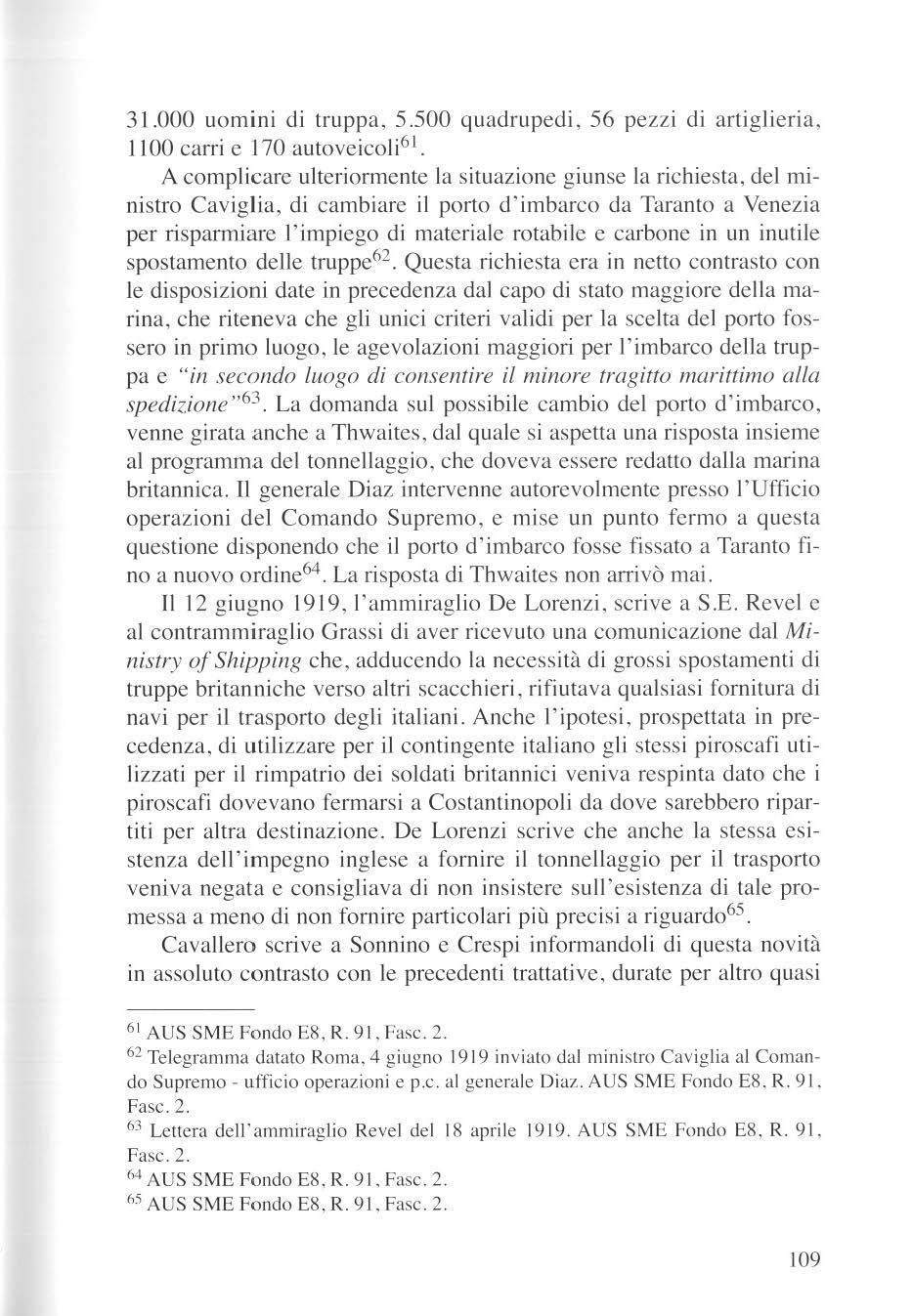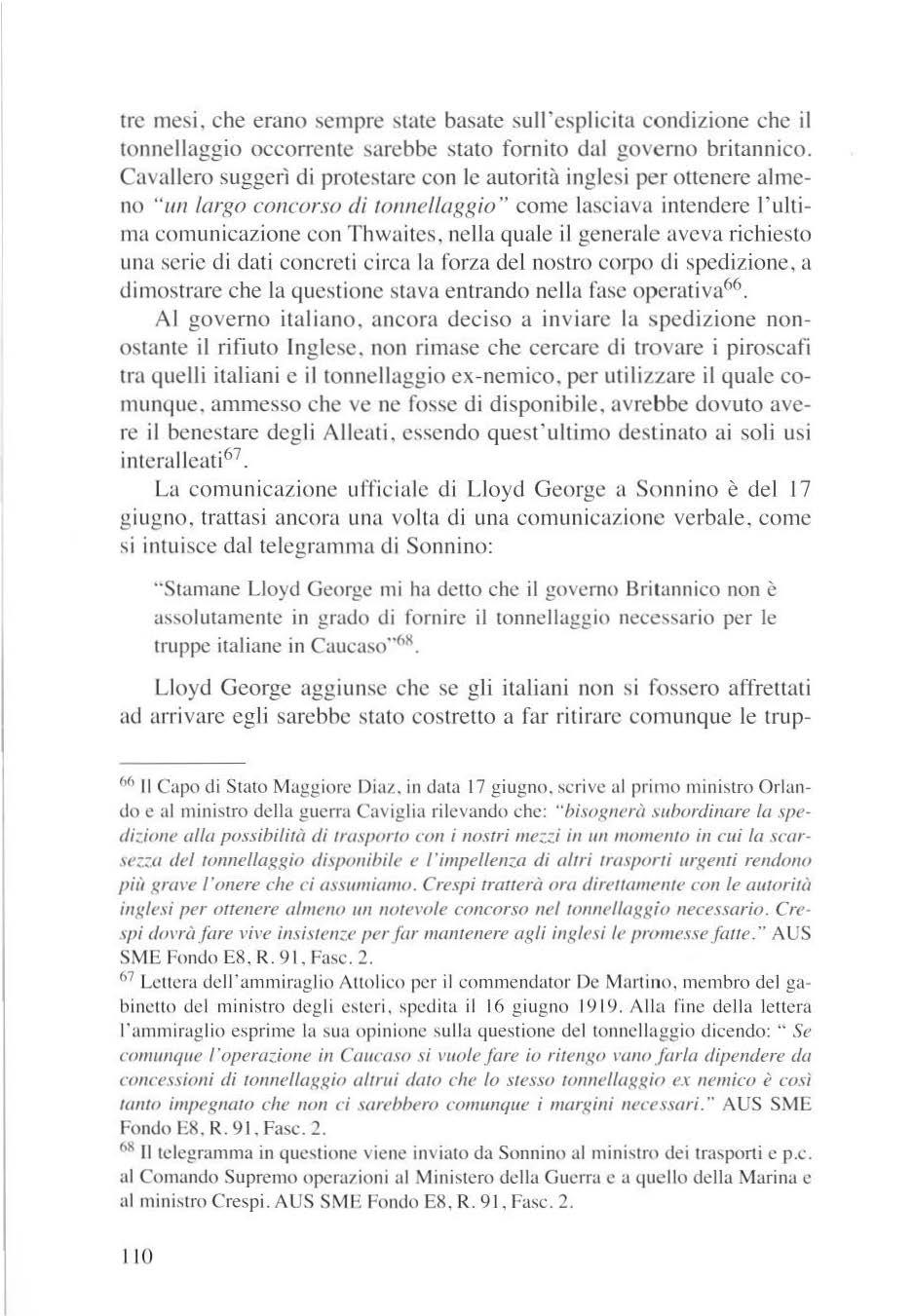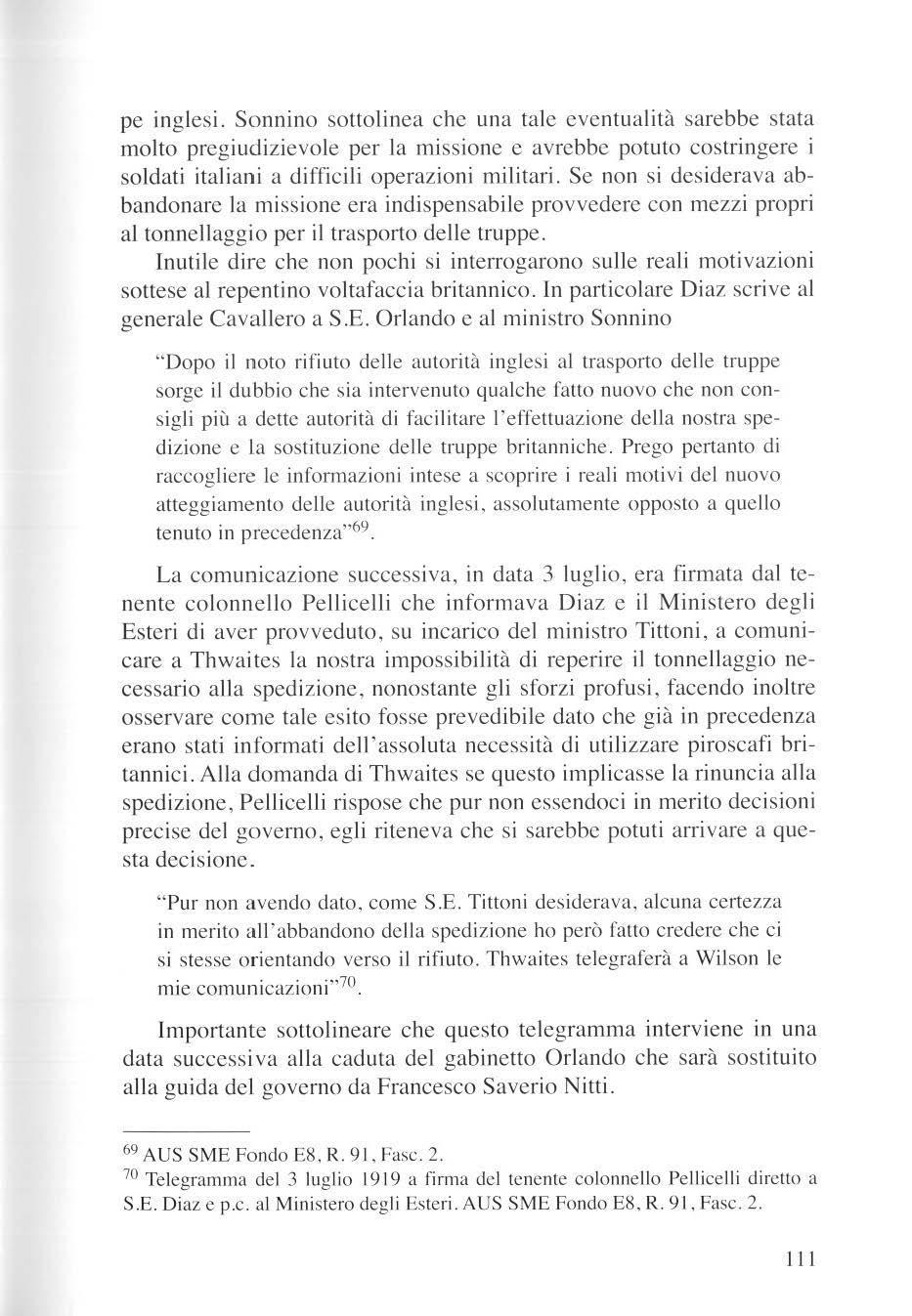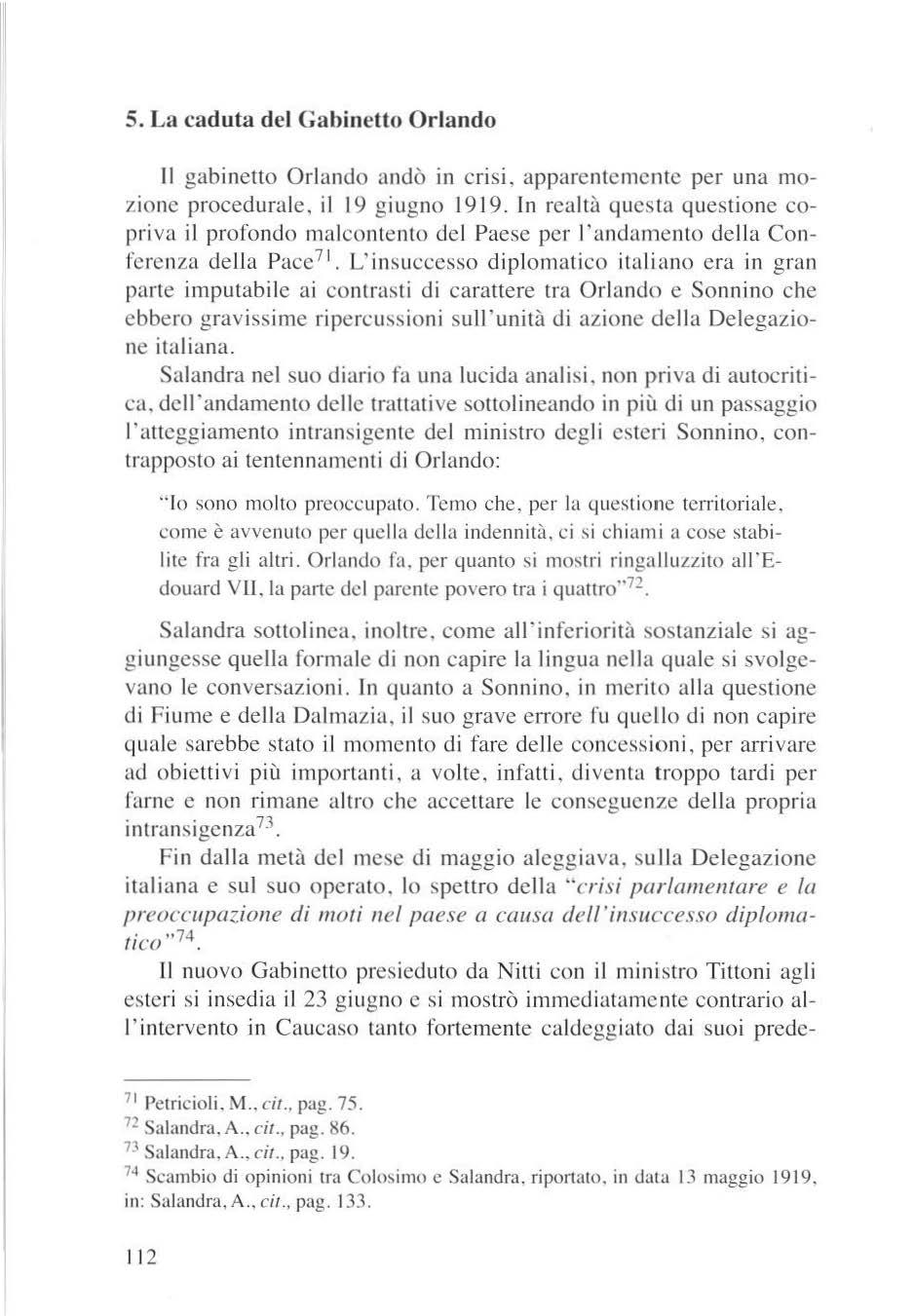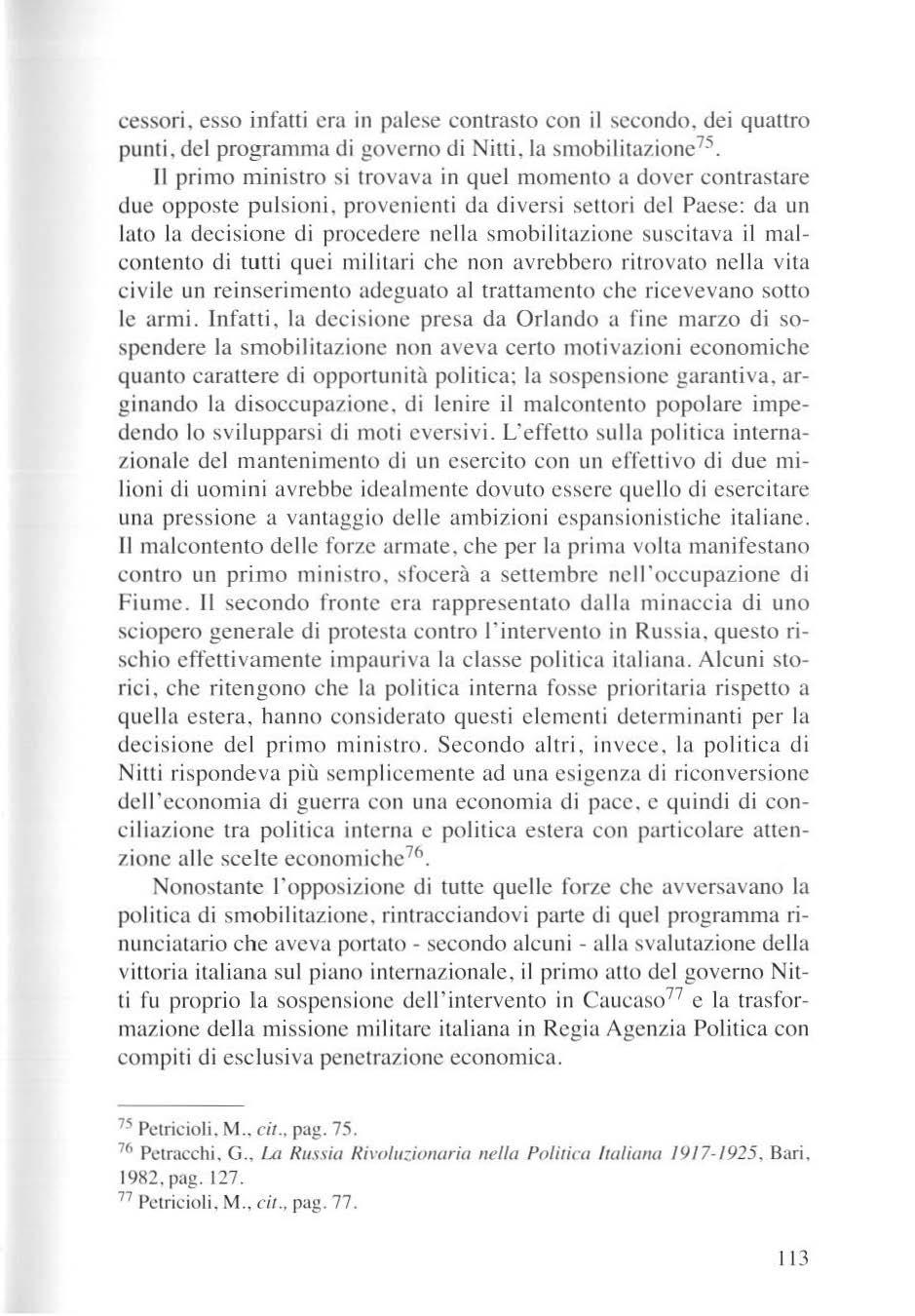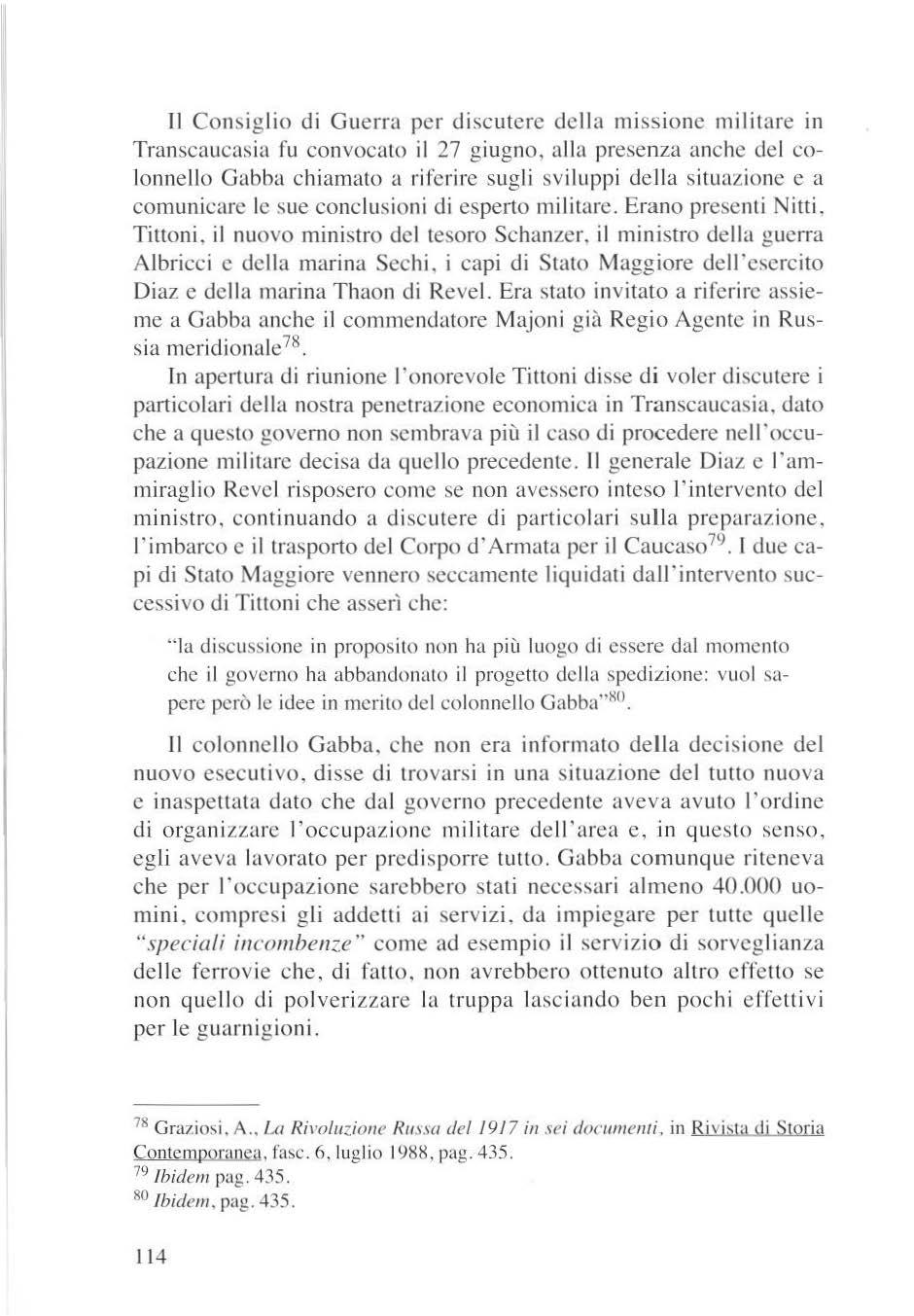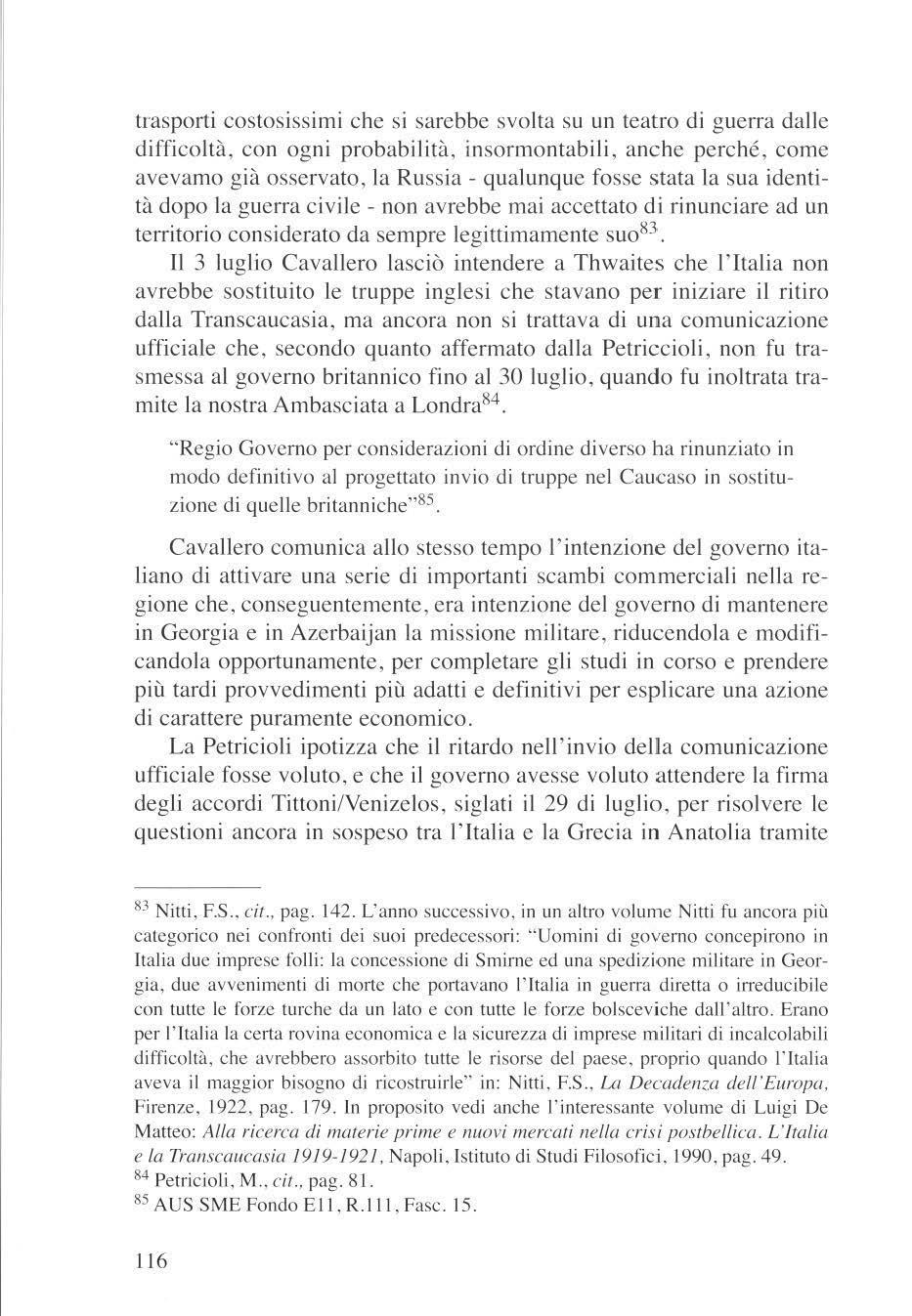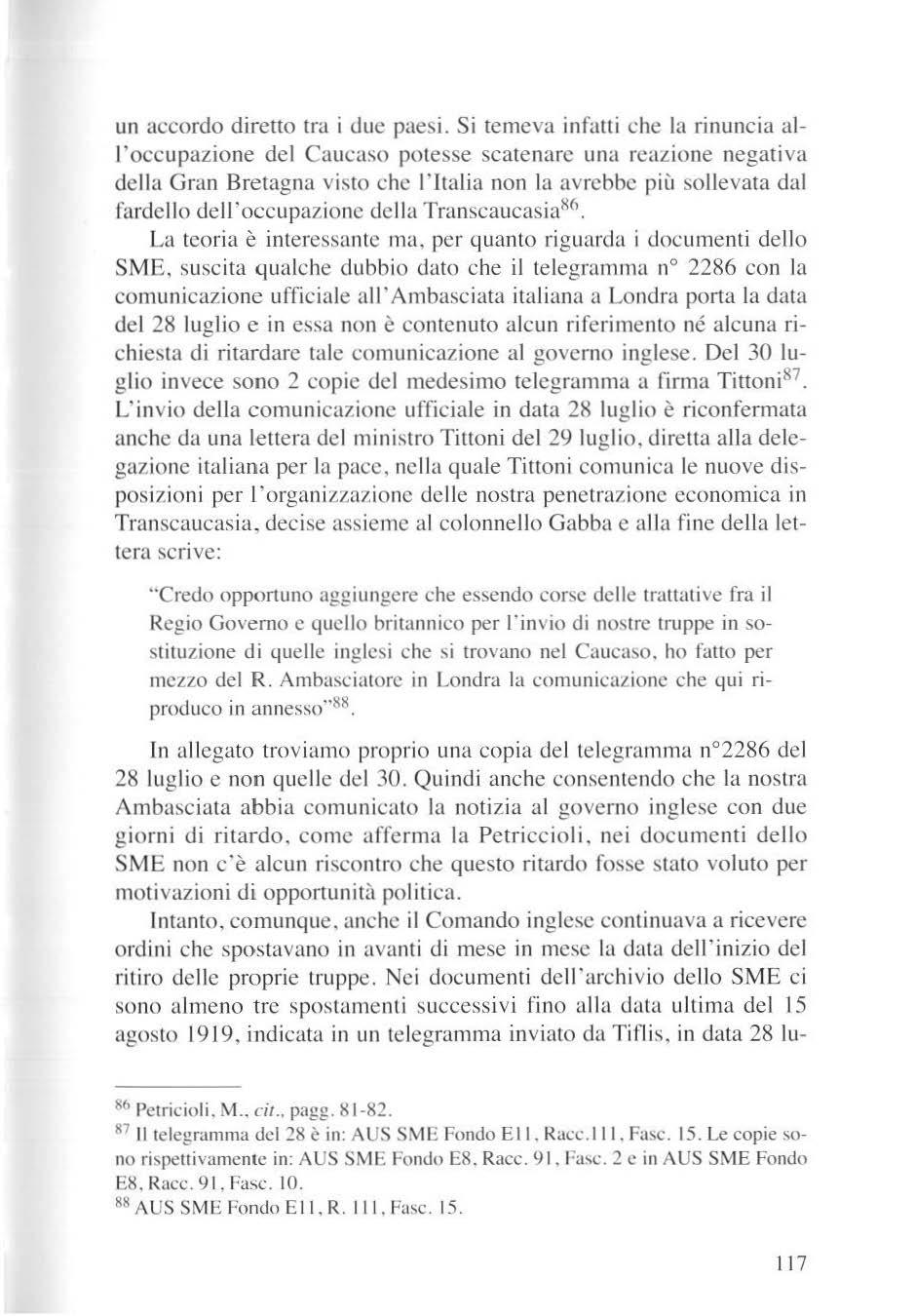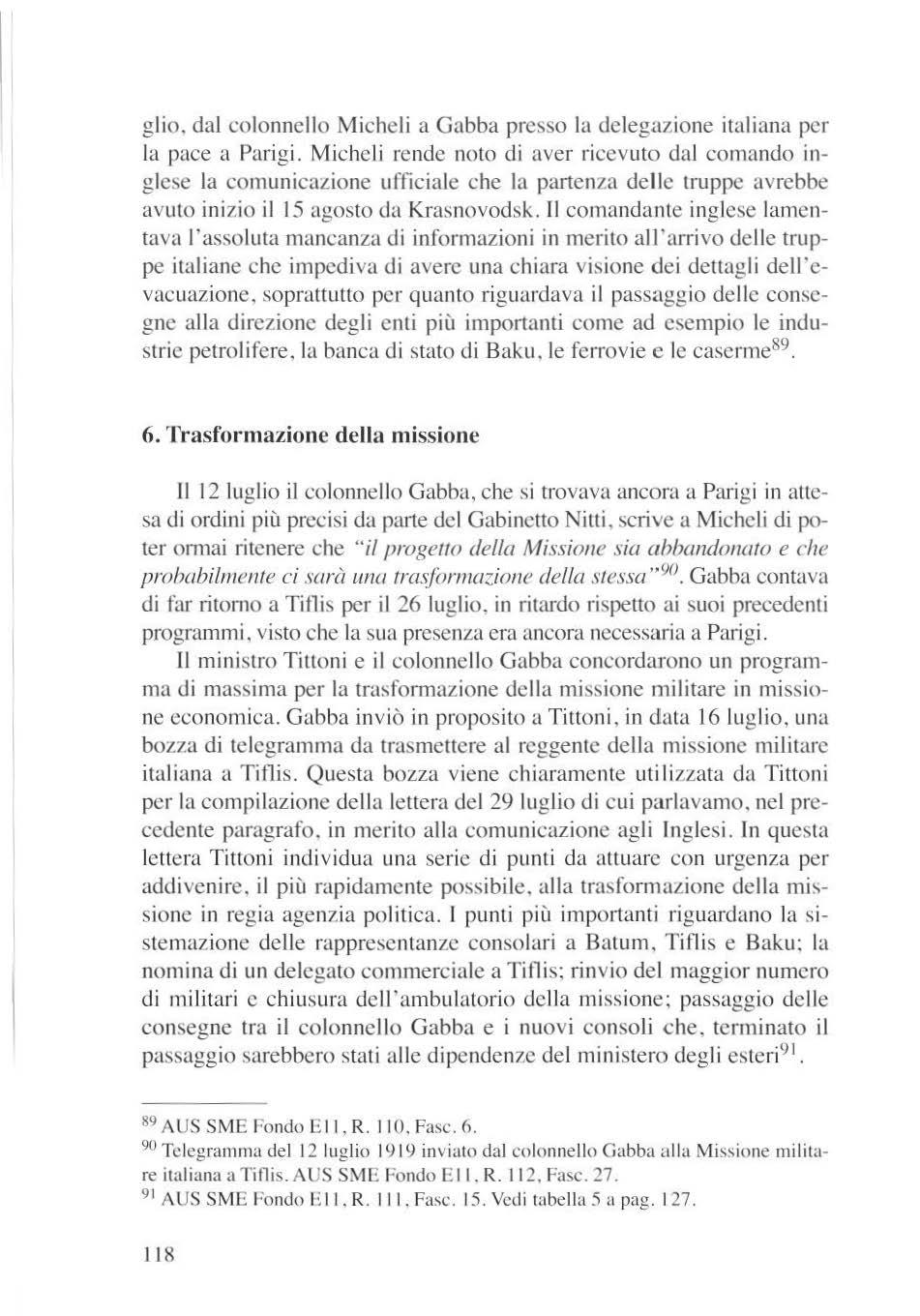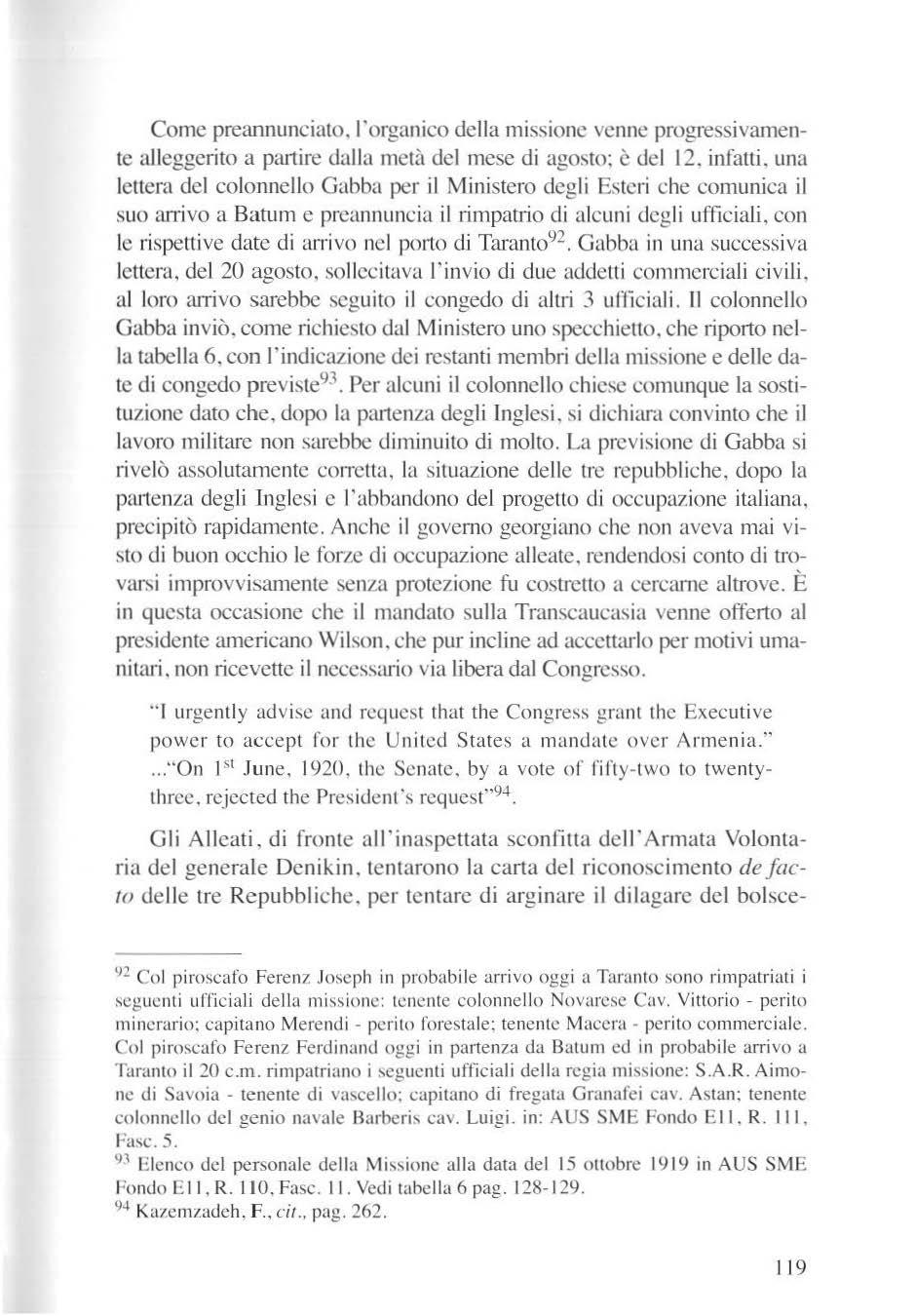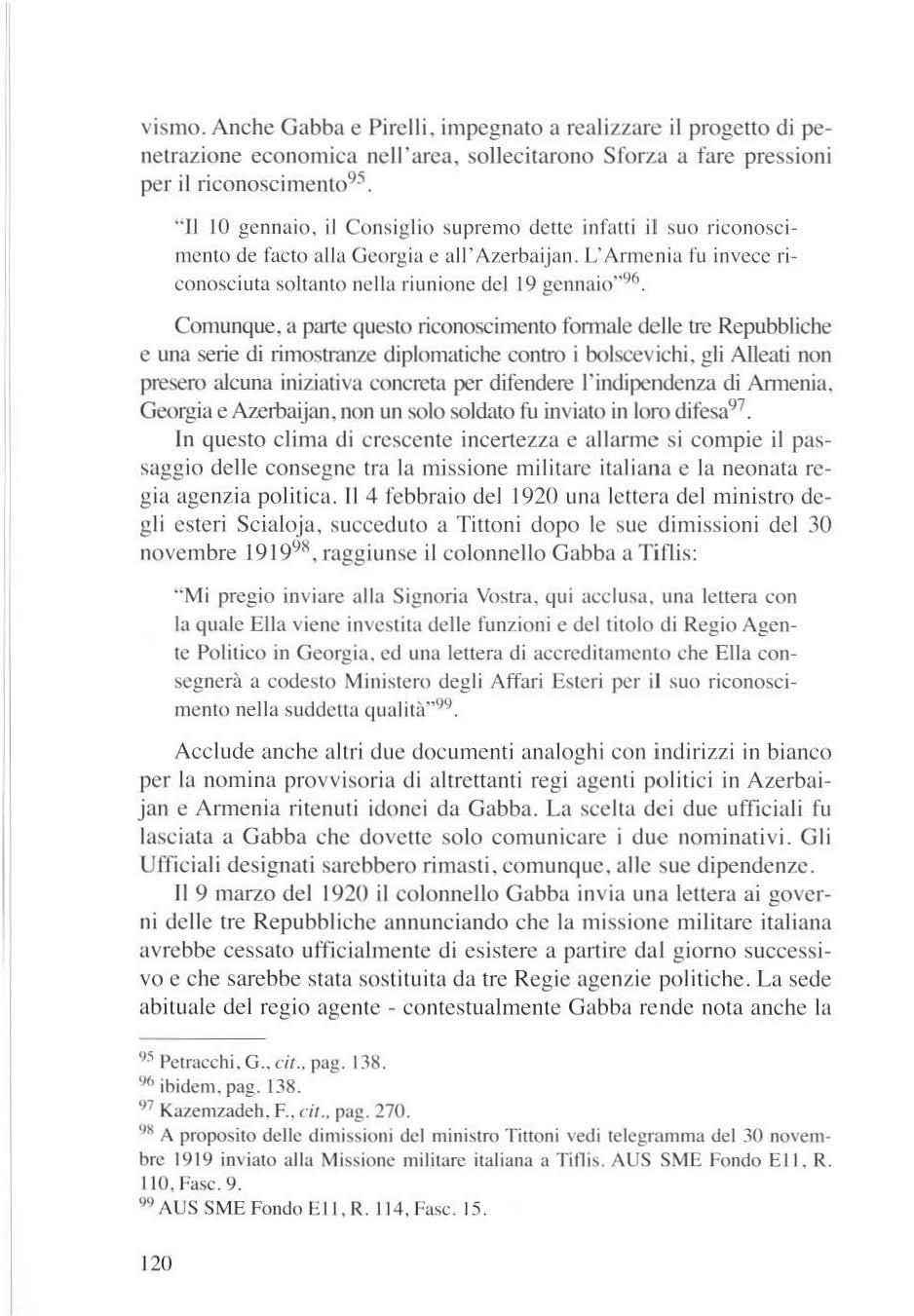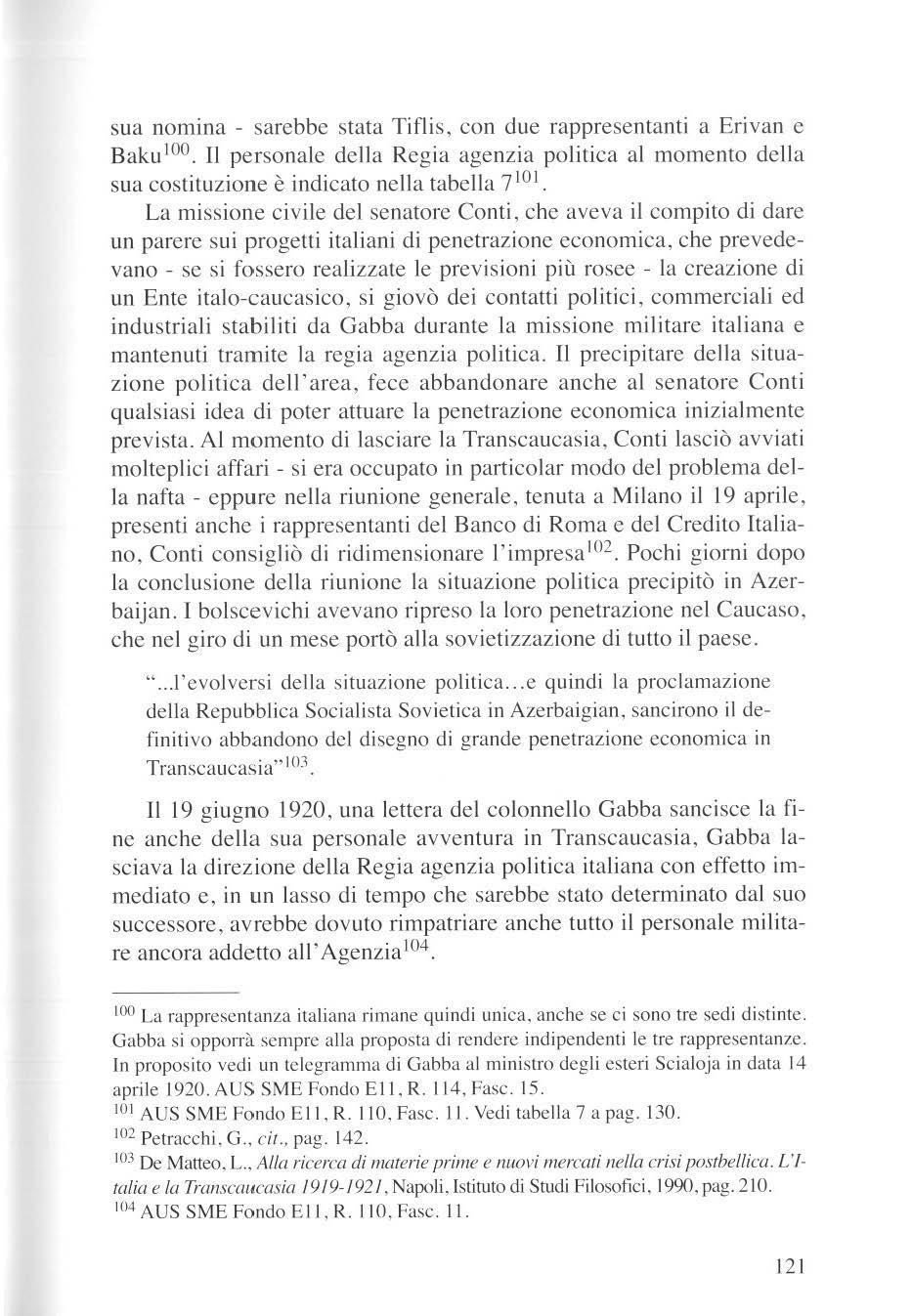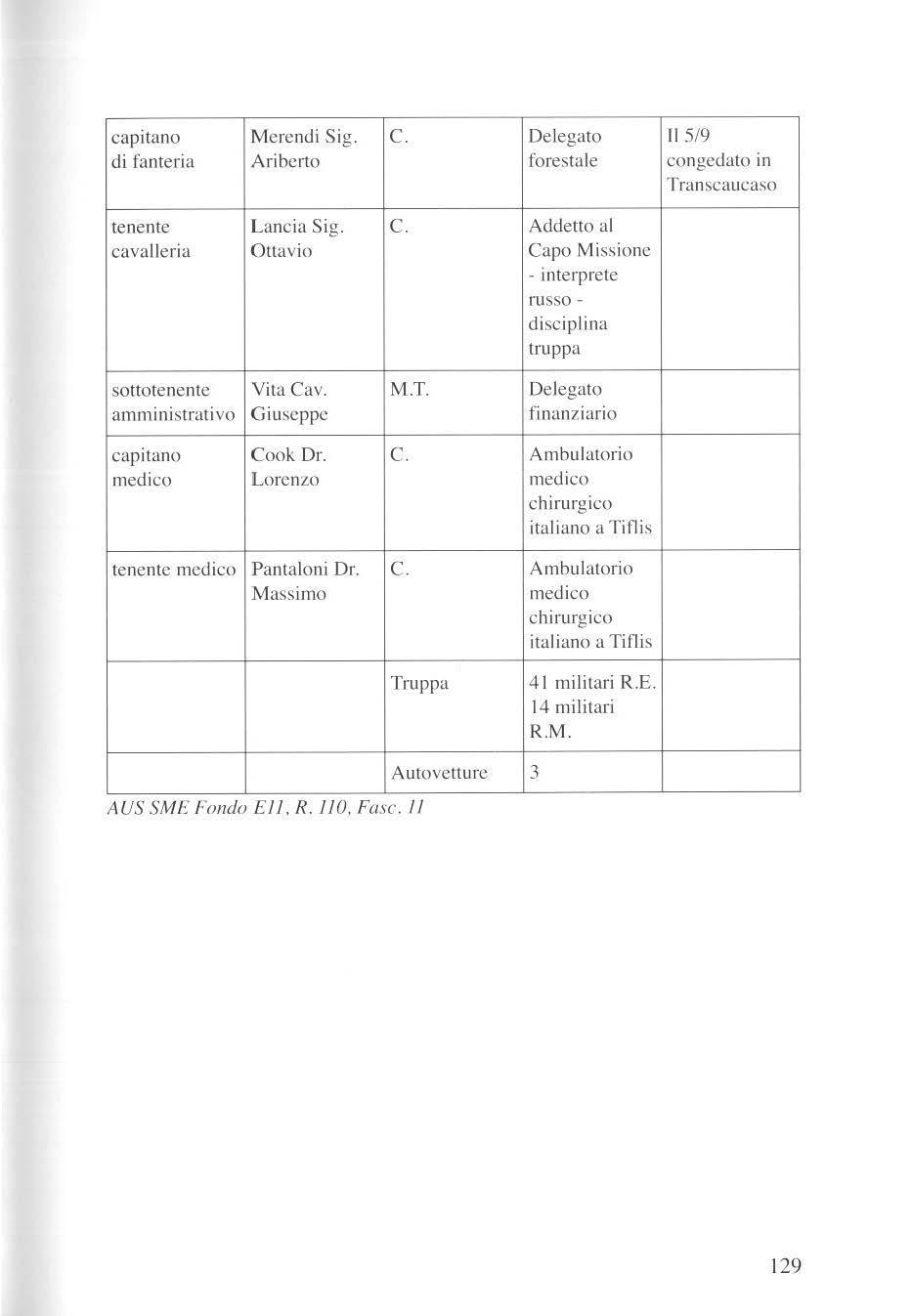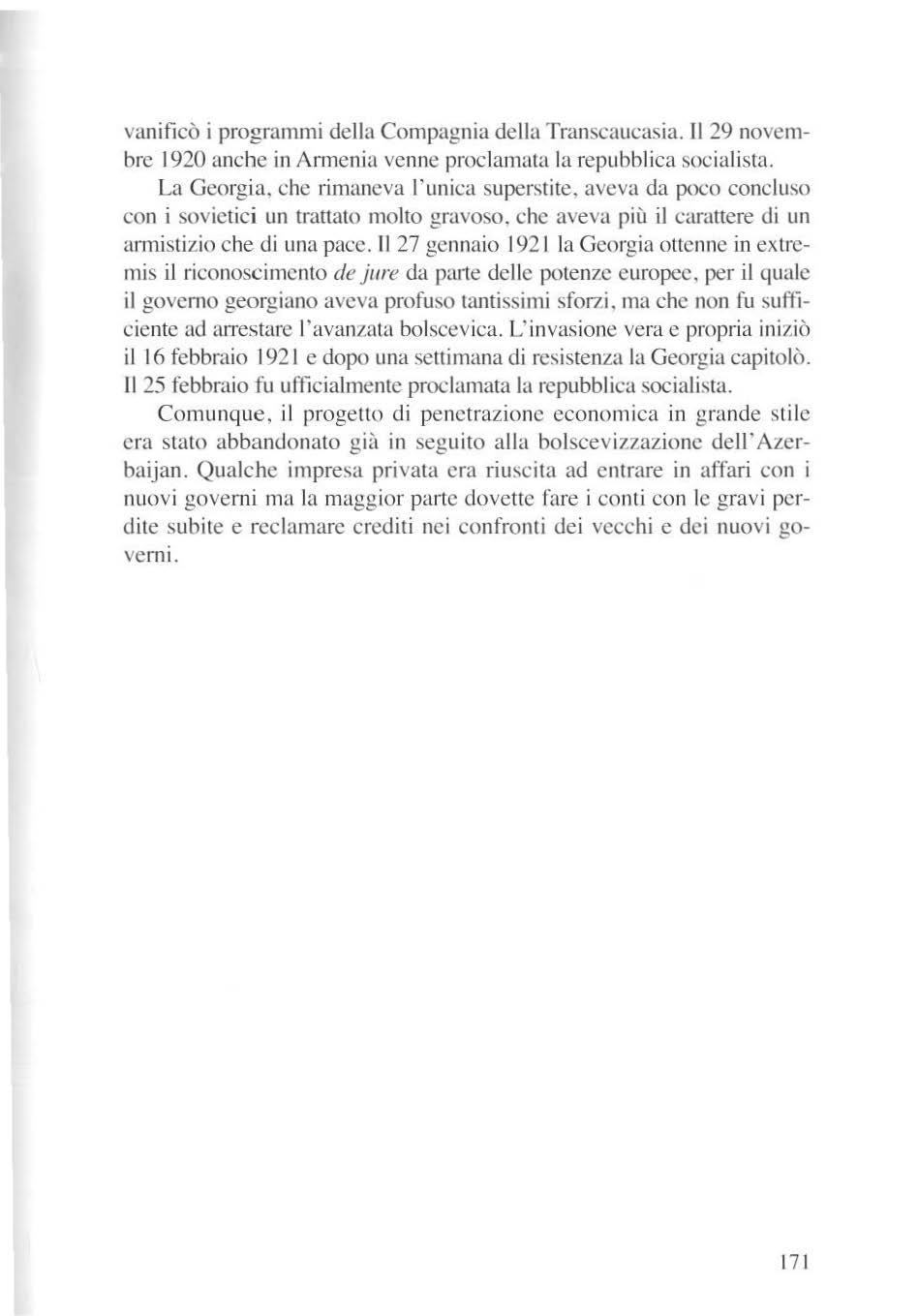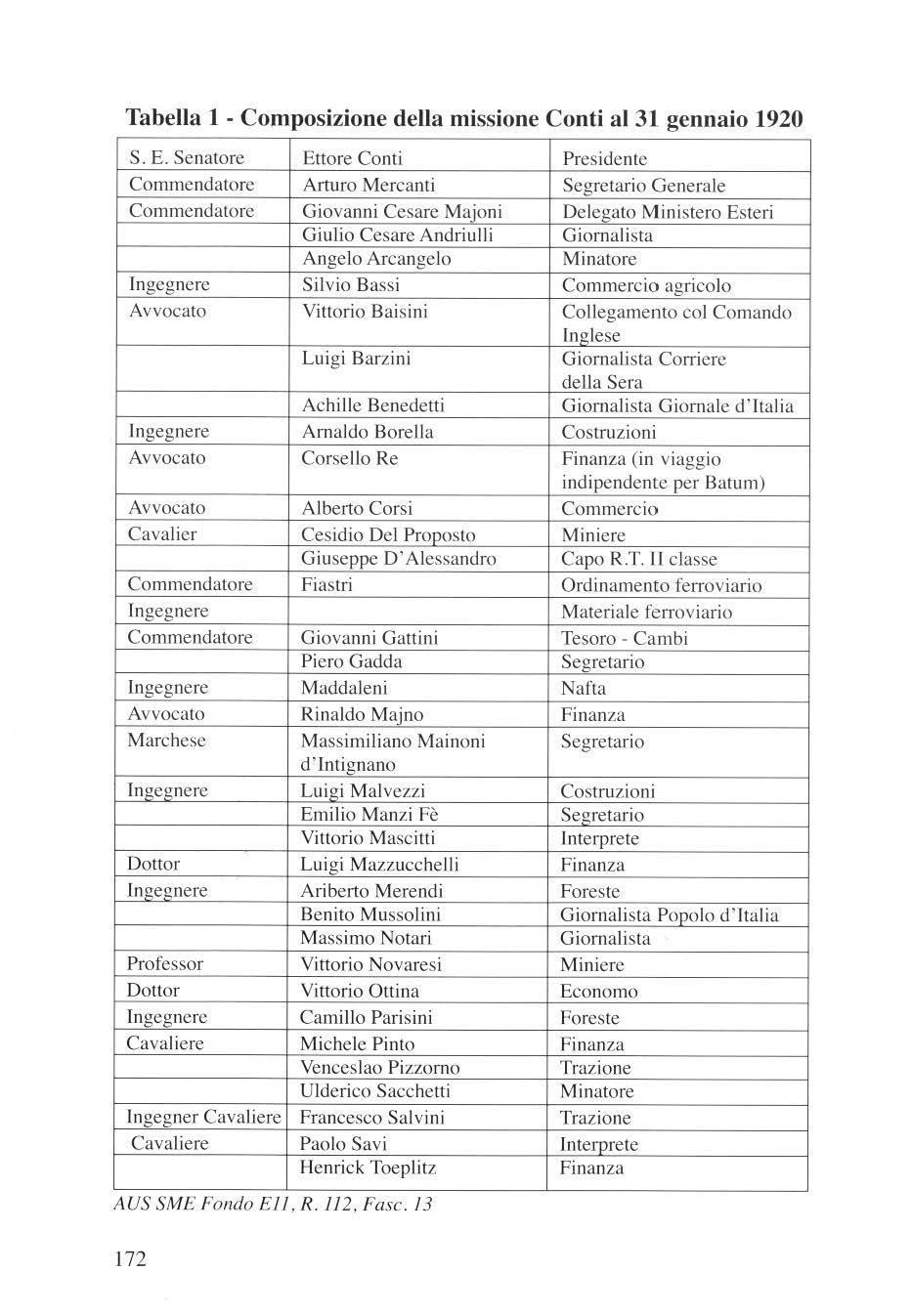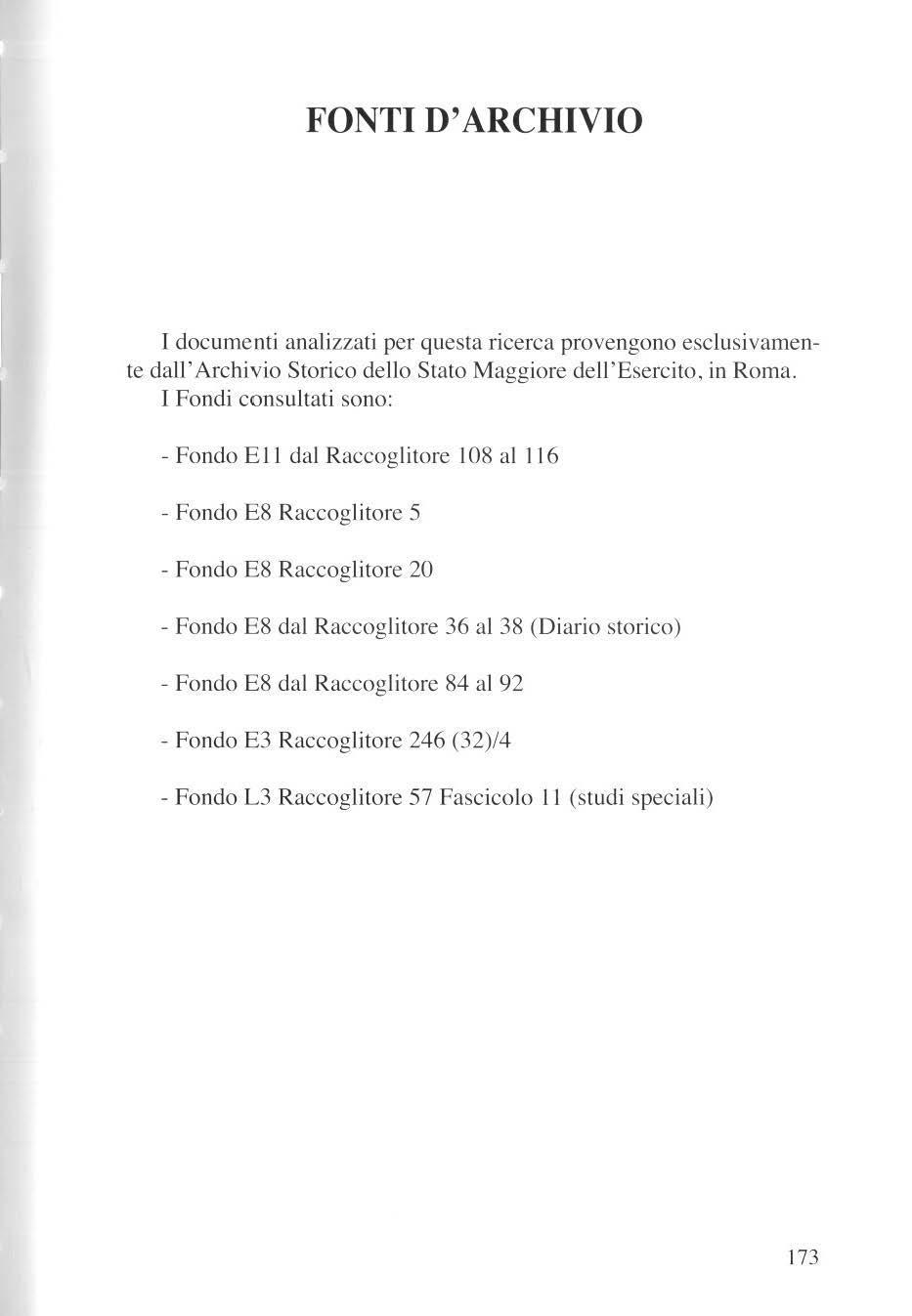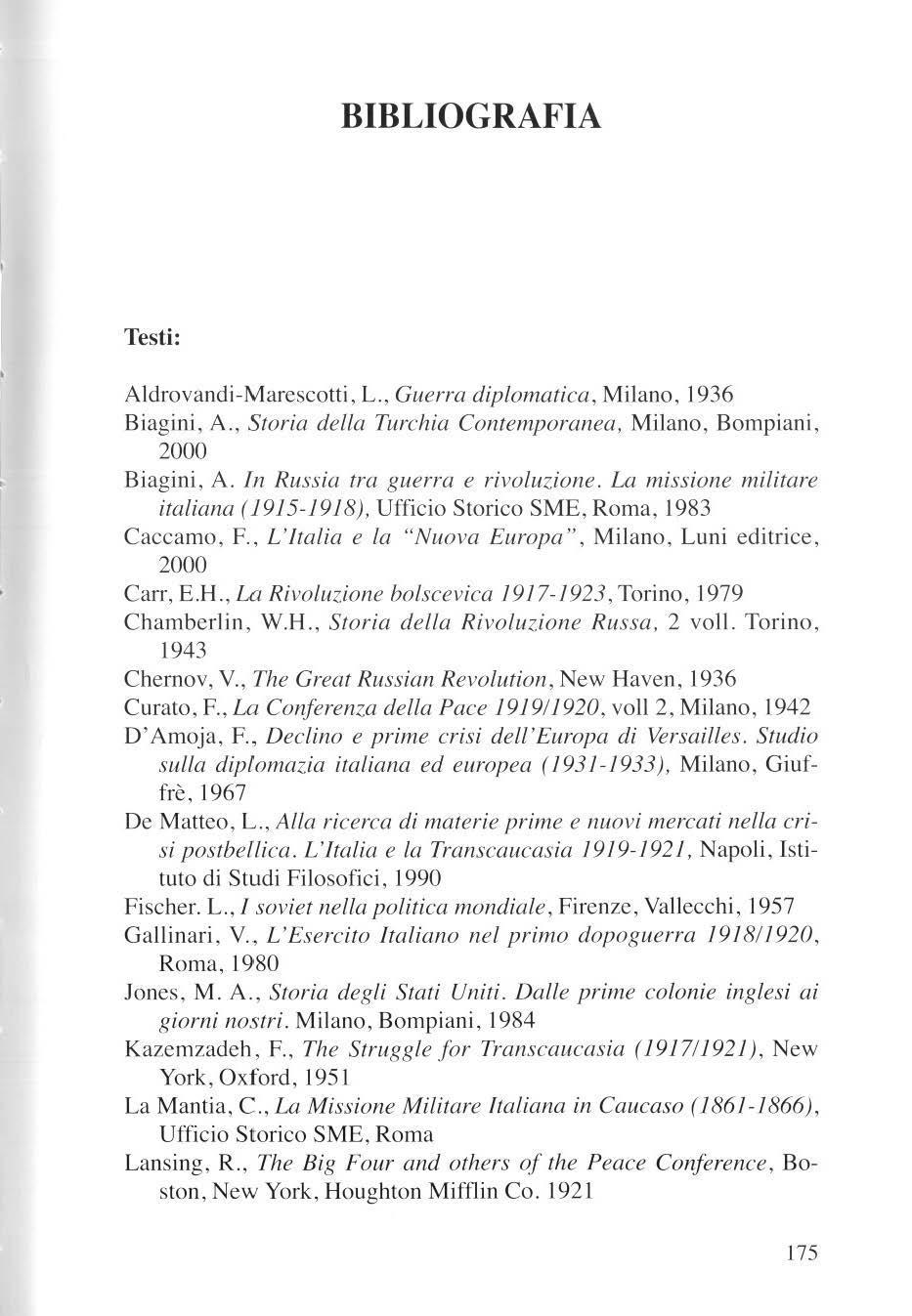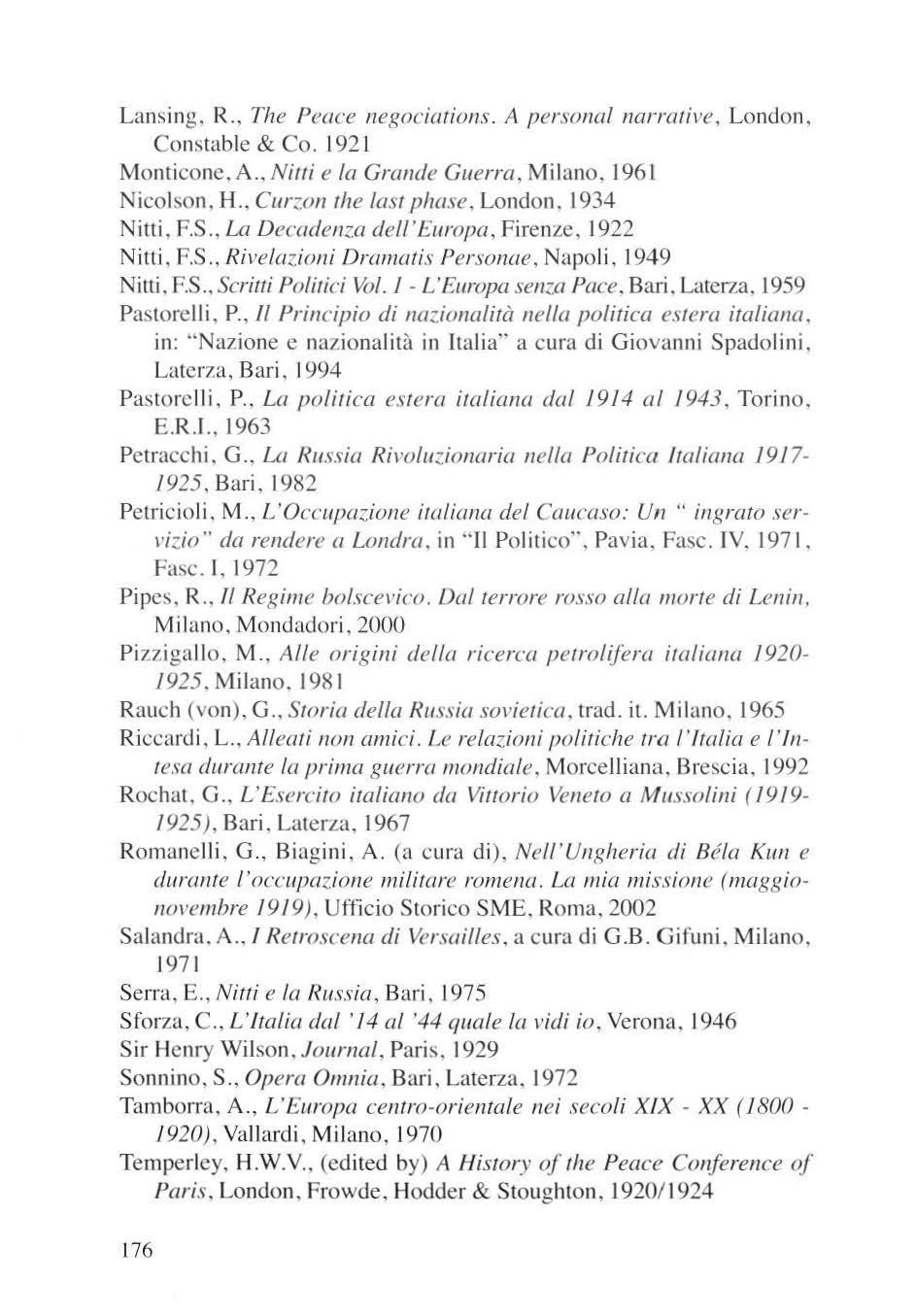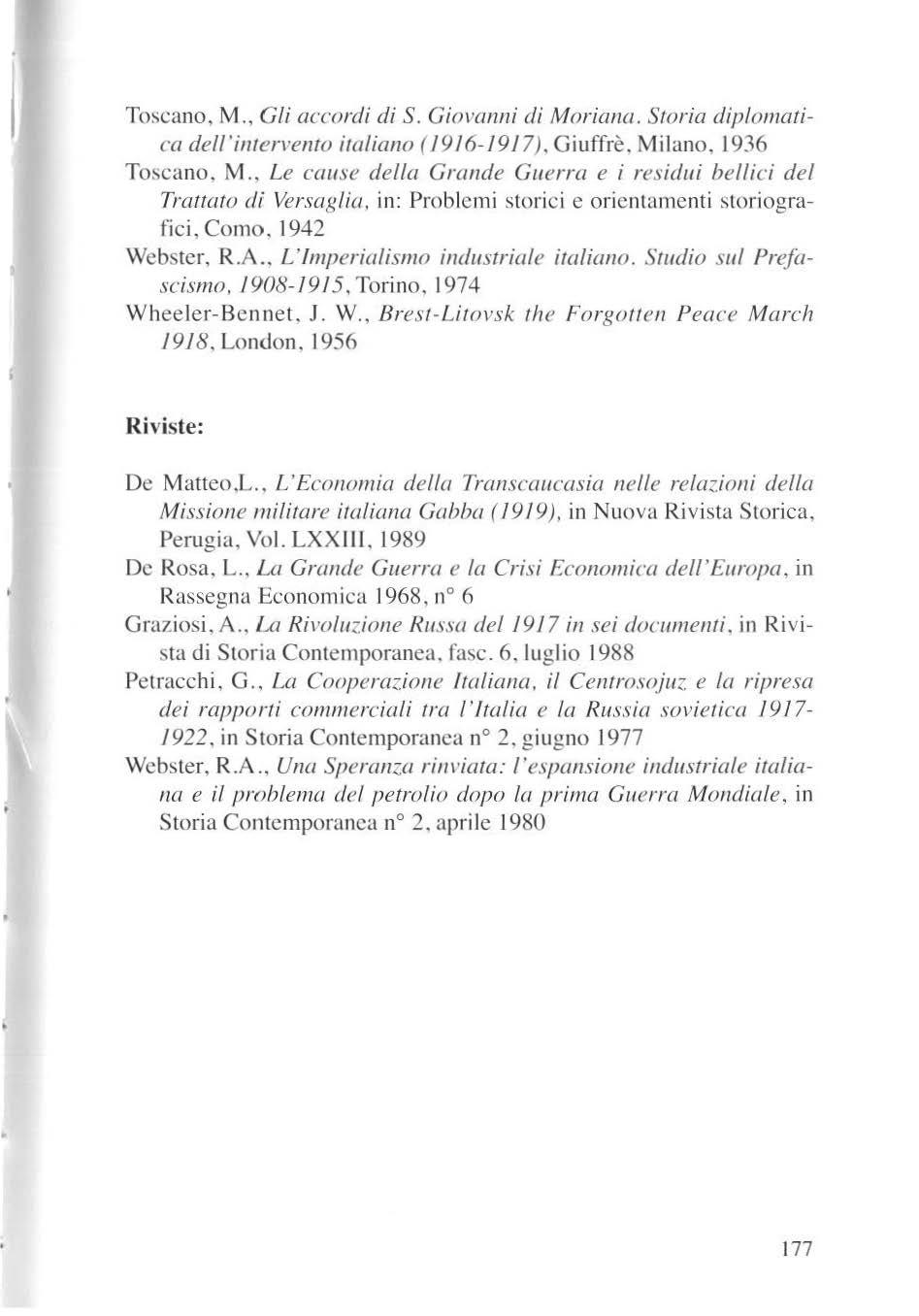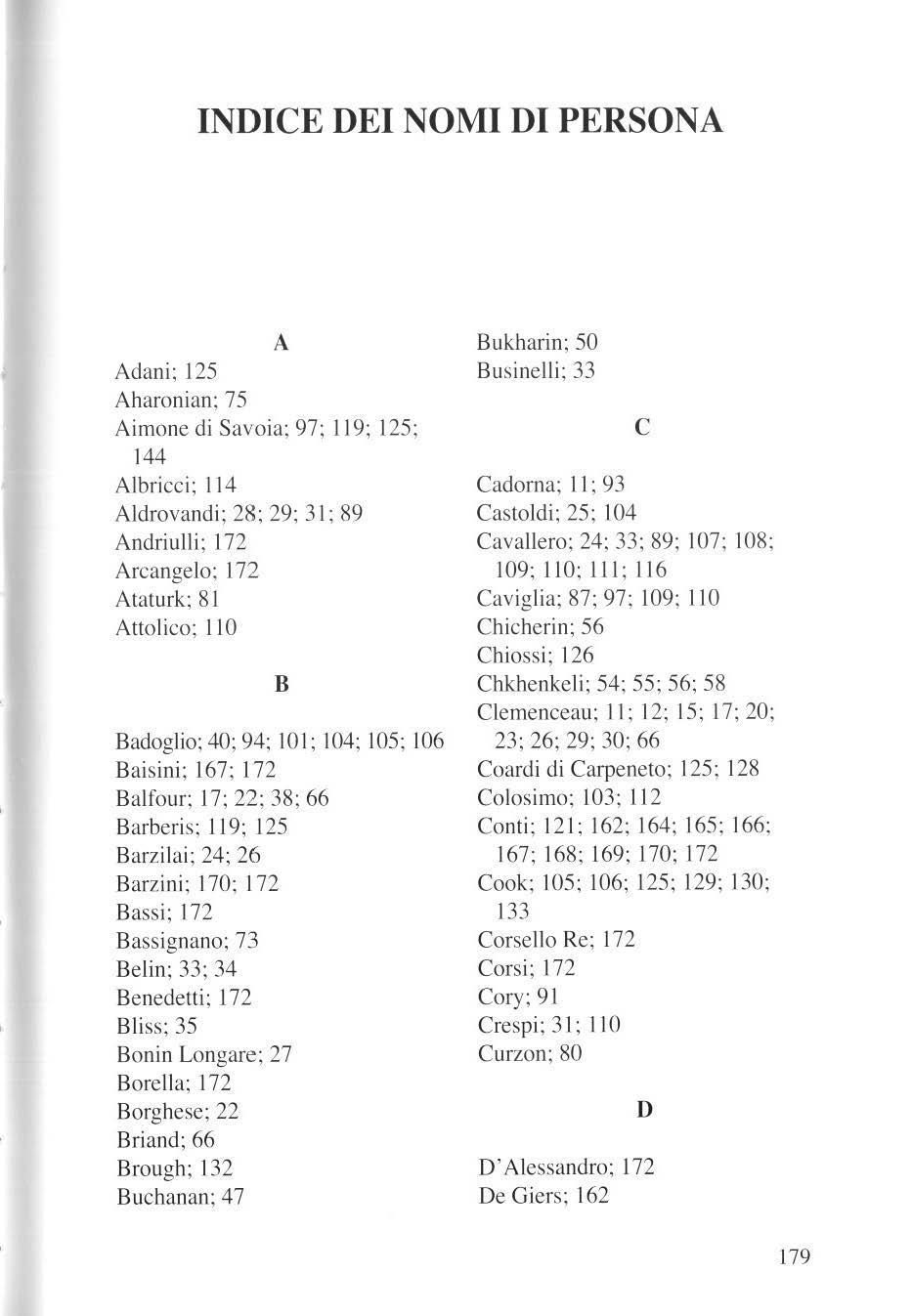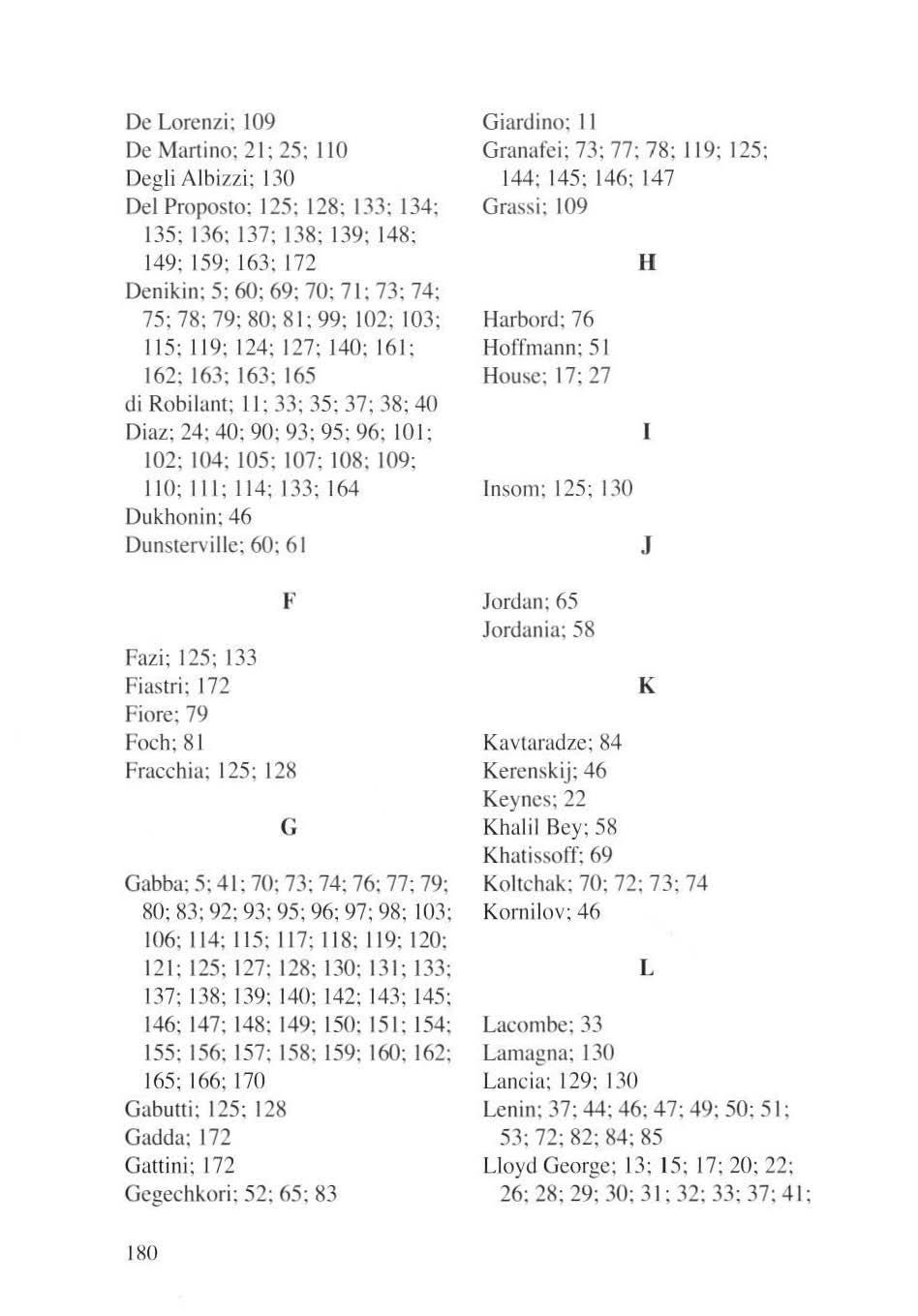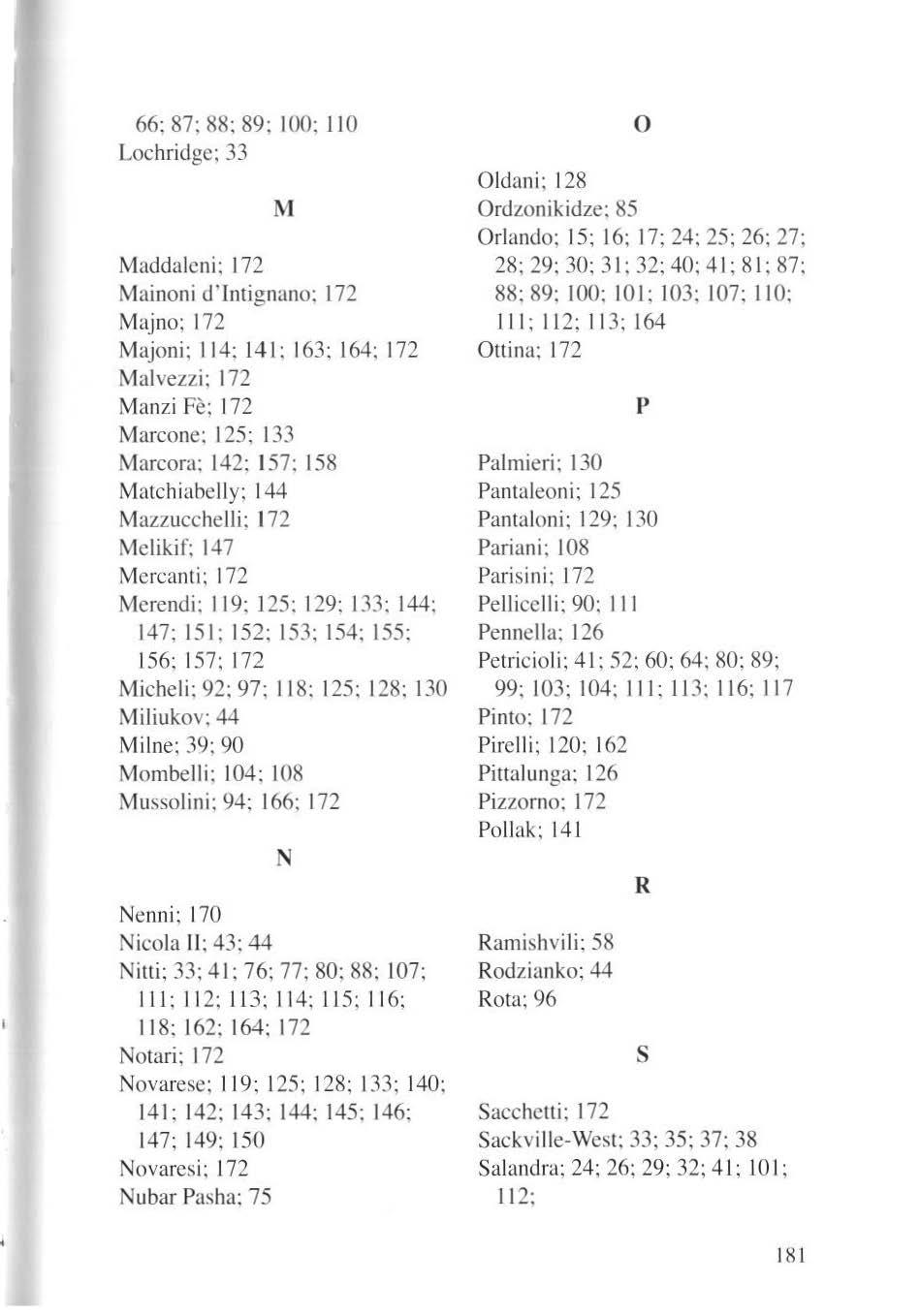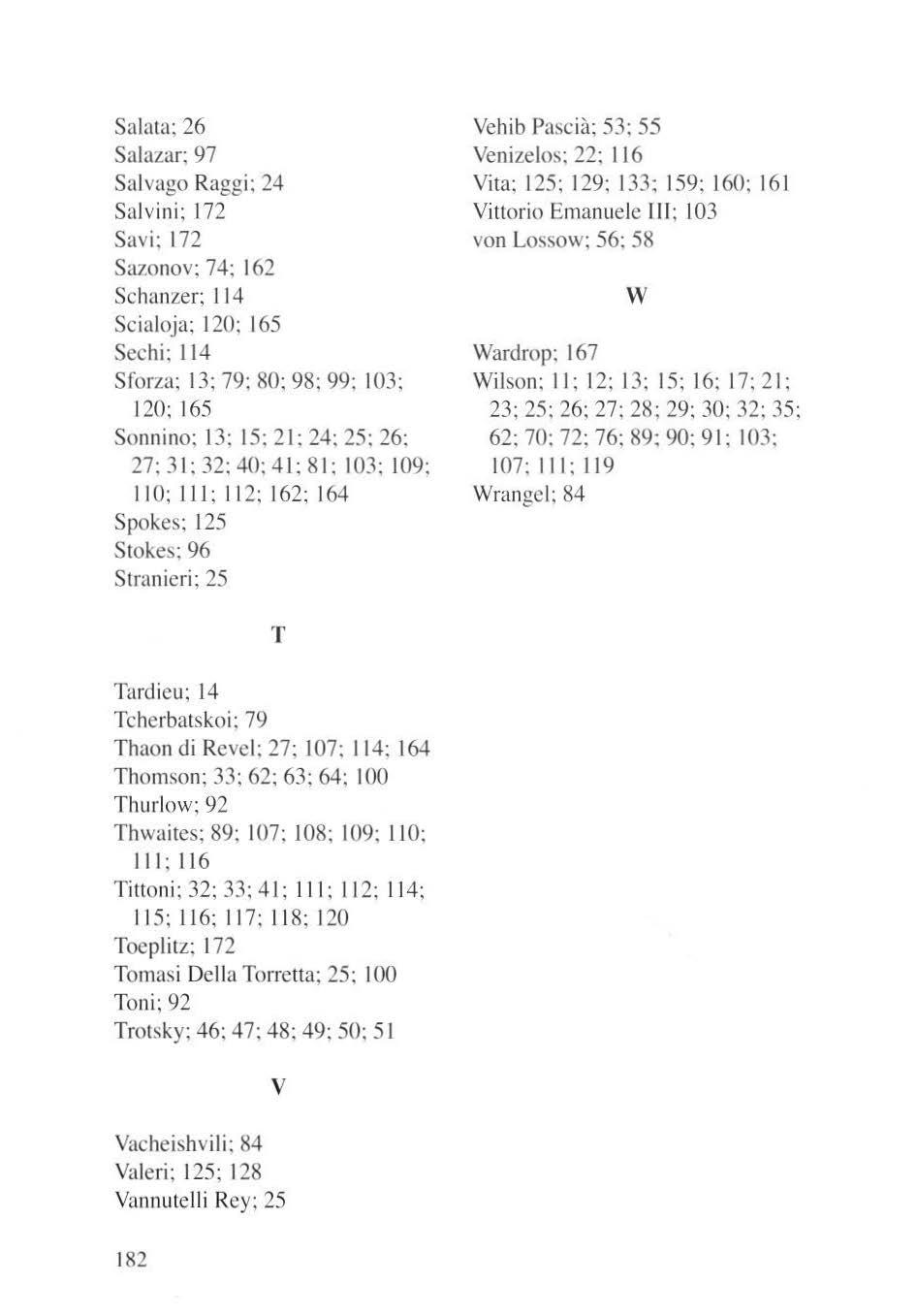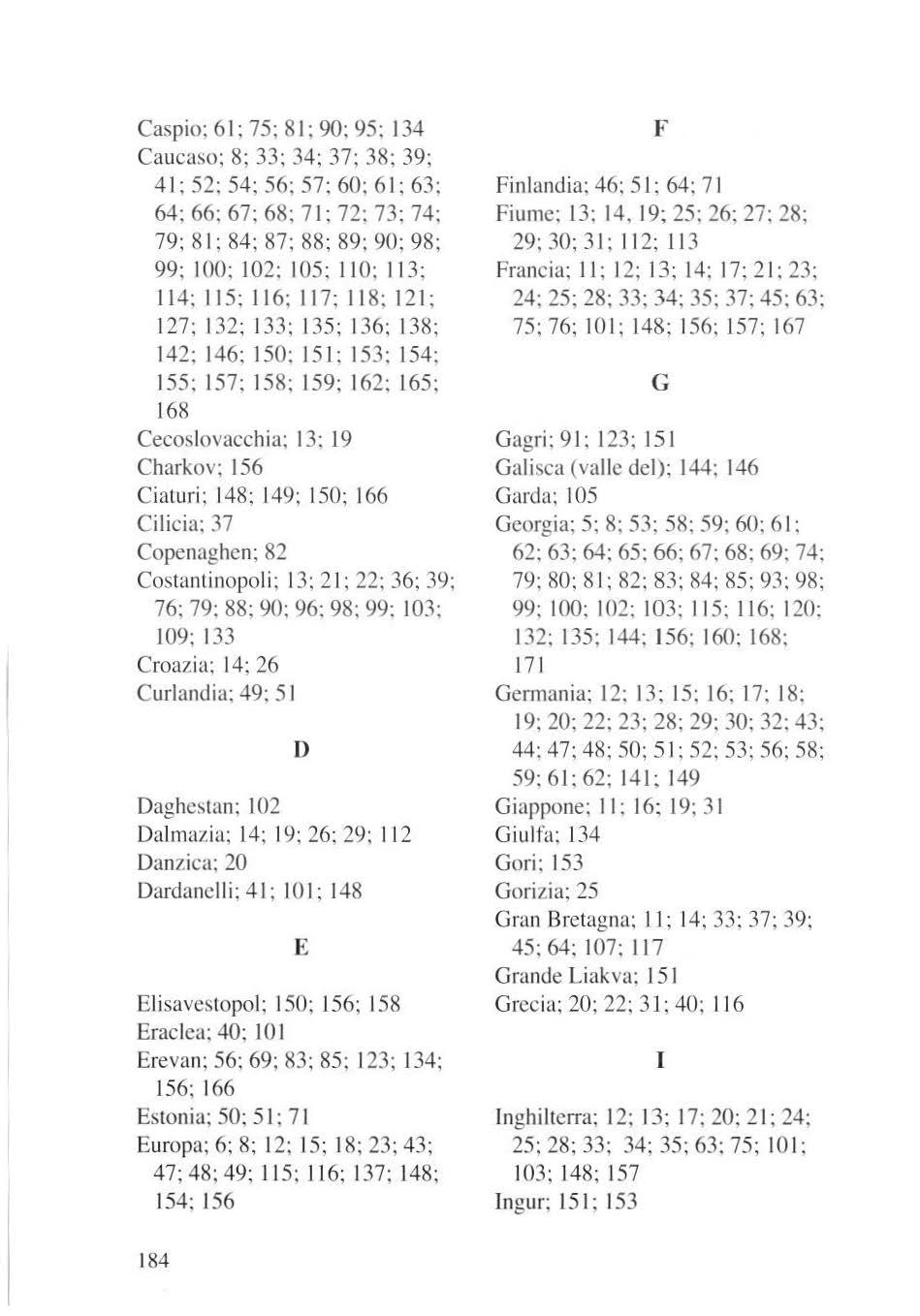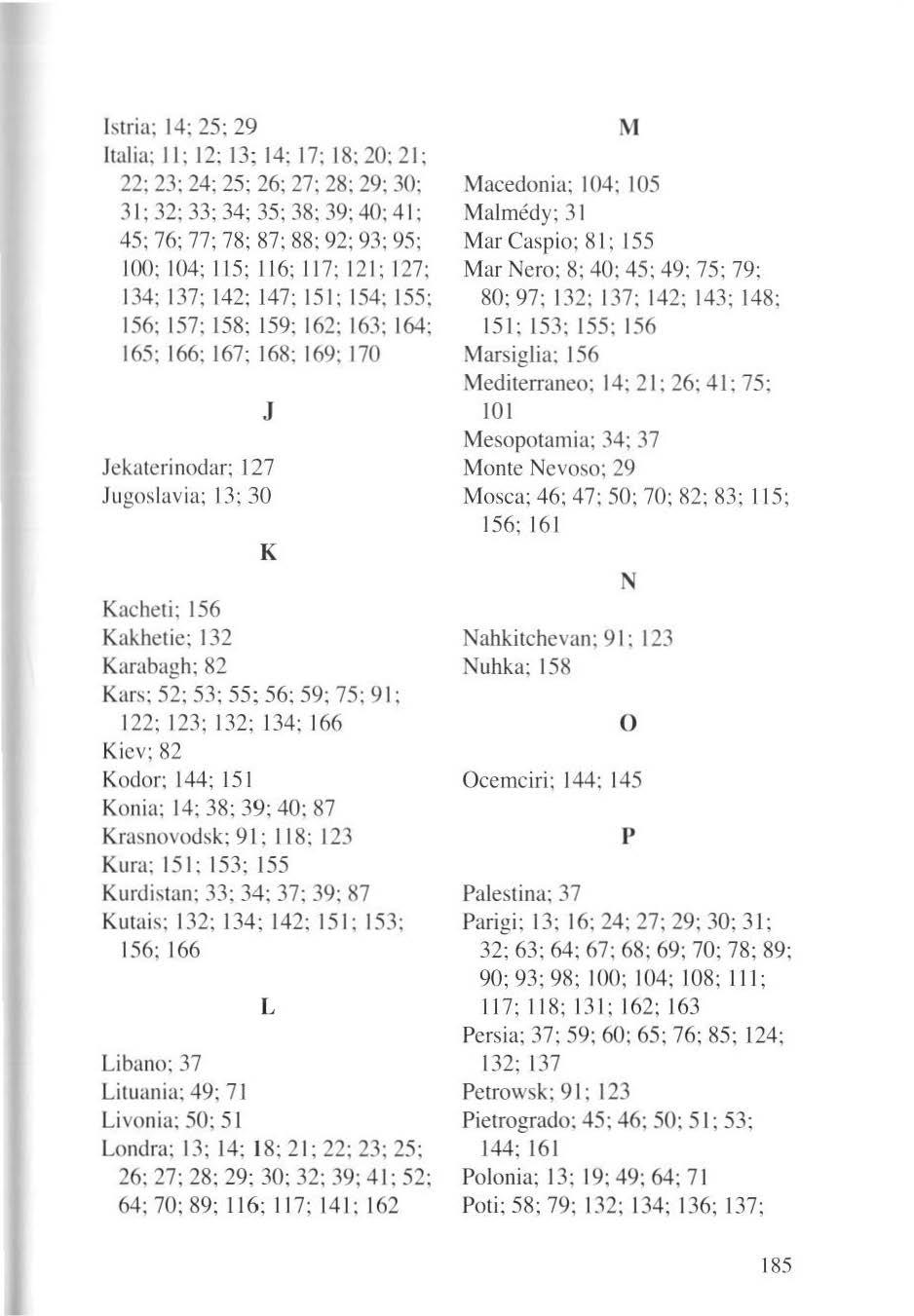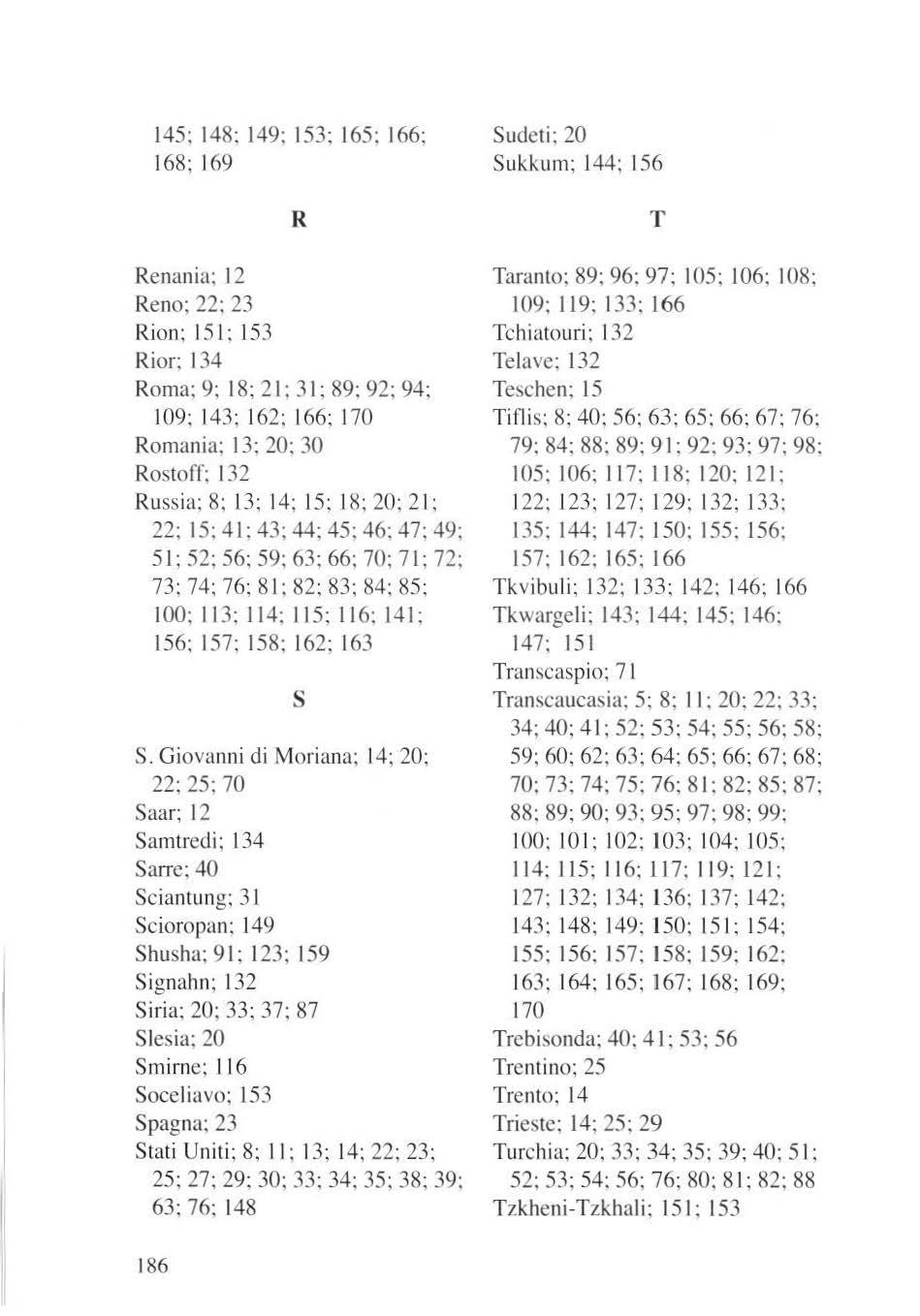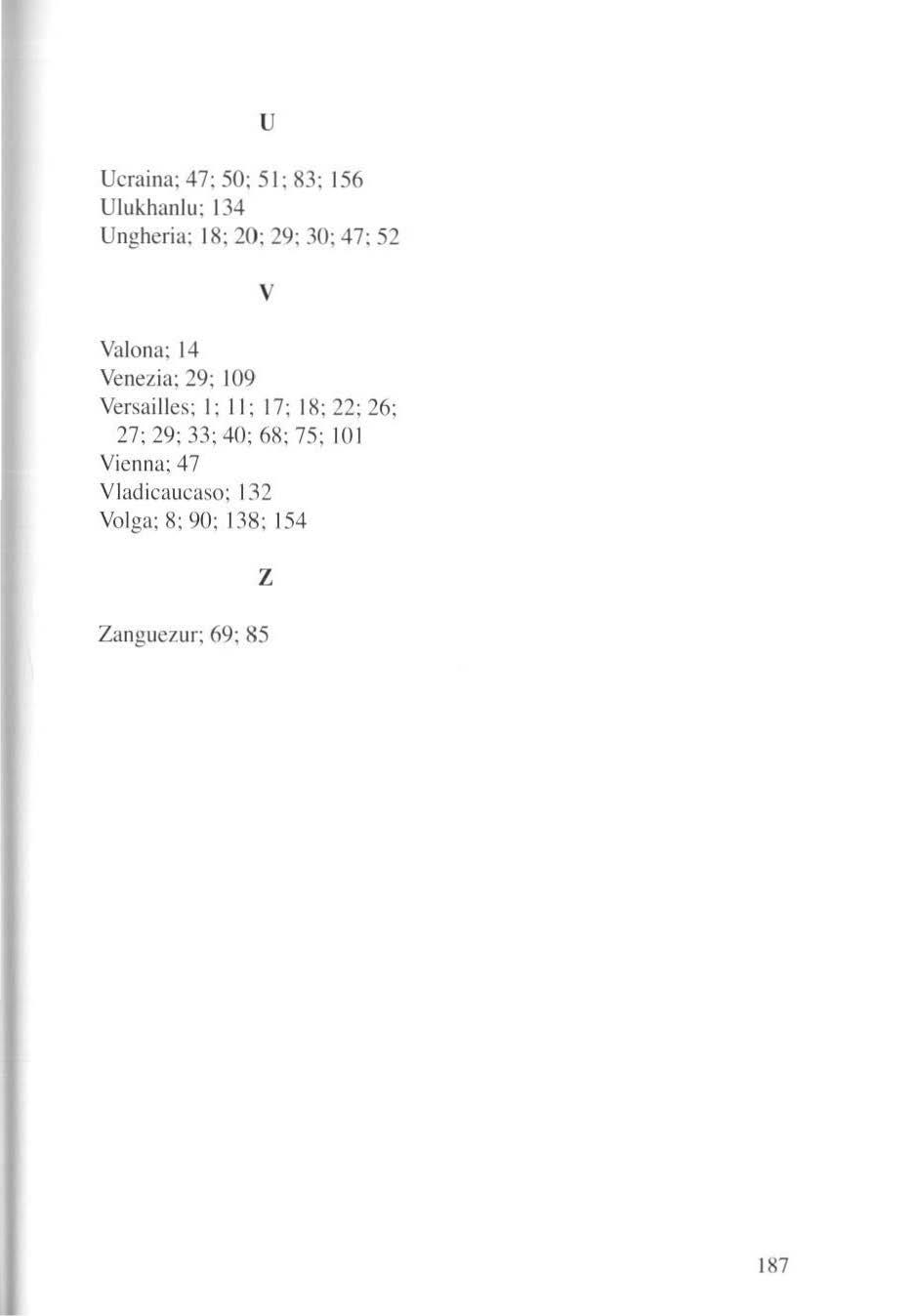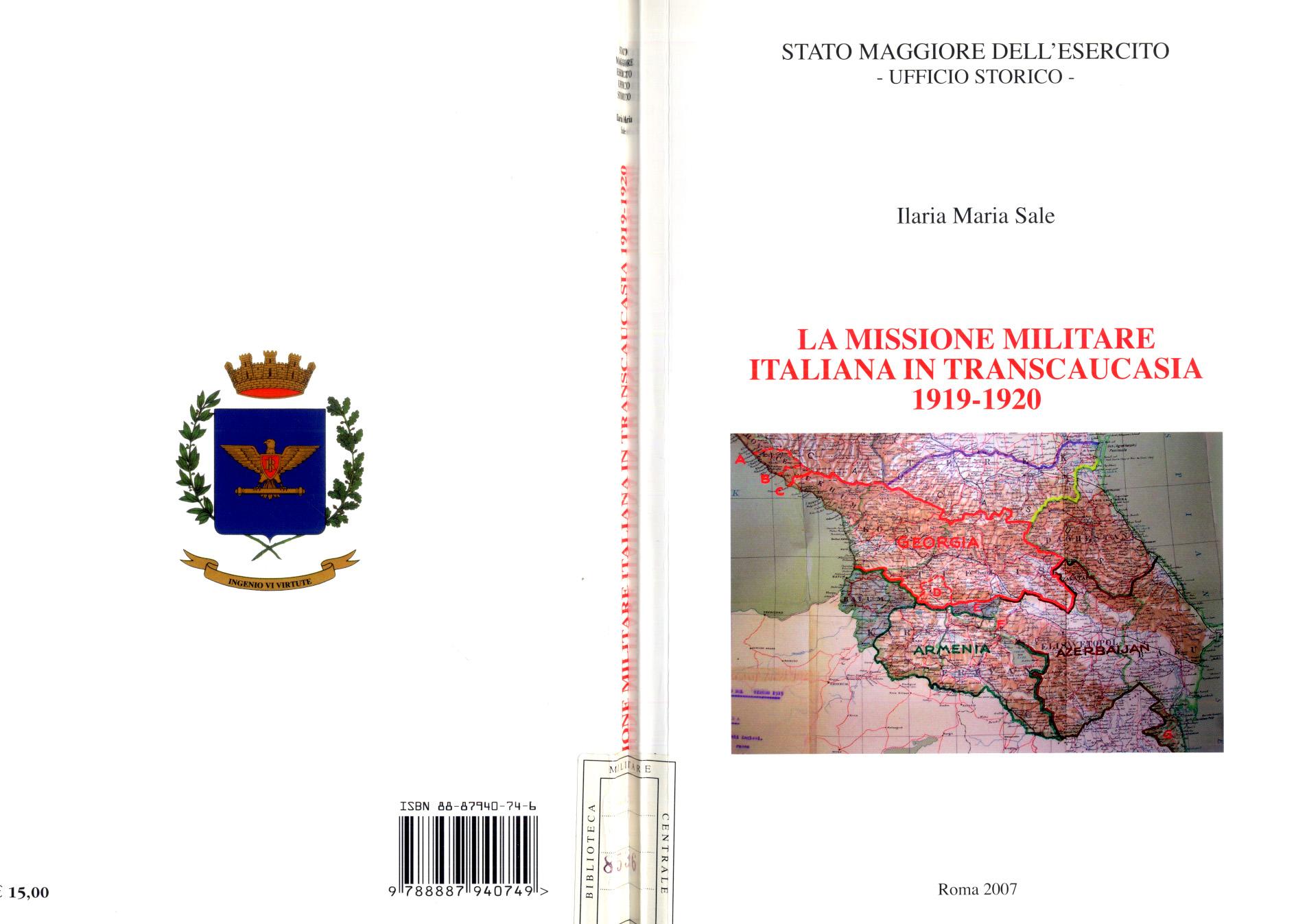
TI presente s tudi o, compiuto basandosi in gran parte su documentazione originale dell'Archivio Storico dello Sta to Maggiore de ll 'Eserc ito , affronta e ten ta eli far lu ce sulla comp lessa situazione delle Repubb li c h e Transcaucas iche alla fine del primo conflitto mondiale da l 1919 al 1920. Il periodo esam inato è volutame nt e molto breve, questa brev ità ha consentito di a rticolare lo stu di o su tre p ian i che scorrono in parallelo consentendo di ricomporre il mosaico della vicenda . La Missione Militare Italiana, comandata dal Co lonnello Gabba, s i svolge su l lo sfondo della Conferenza della Pace di Versailles , delle diverse occupaz ioni europee che si a ltemano nella regione , degli scon tri etnici in atto tra le diverse et ni e e della lotta tra i Bolscevichi e l'Esercito dei Volomari del Generale Denikin.
L'esito della Missione Ita li a n a , che rimarrà unicamente esplorativa, è una se ri e eli studi econom ici e logistici su lla possibilità di occupazione militare dell ' area e sulle risorse che sa rebbe stato possibi le sfruttare tramite la stipula eli convenzion i con i governi locali. Ta li convenz i oni , che av rebbe r o consenti t o al Governo Italiano una posizione el i monopolio, non furono mai firmate a causa del precipitare degli eve nti che portarono ad una rapida sovietizzazione del Transcaucaso.

In coperi ina: Siluazione dci terr itori transcaucasici al giugno 19 19.

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO -UFFICIO STORICOIlaria M aria Sale LA MISSIONE MILITARE ITALIANA IN TRANSCAUCASIA 1919-1920 R oma 2007

CA PITOLO I
La Conferenza della Pace, L'Italia e la Transcaucasia .. .
l. La Conferenza della Pace di Versai ll es
2. La posizione italiana ........................................................ .
3. Il Consiglio Supremo di Guerra- Sezione Militare e le questioni coloniali ....................................................... ..
CAPITOLO II
Le R epub blich e transcaucasiche dal1917 al 1920 ......... .
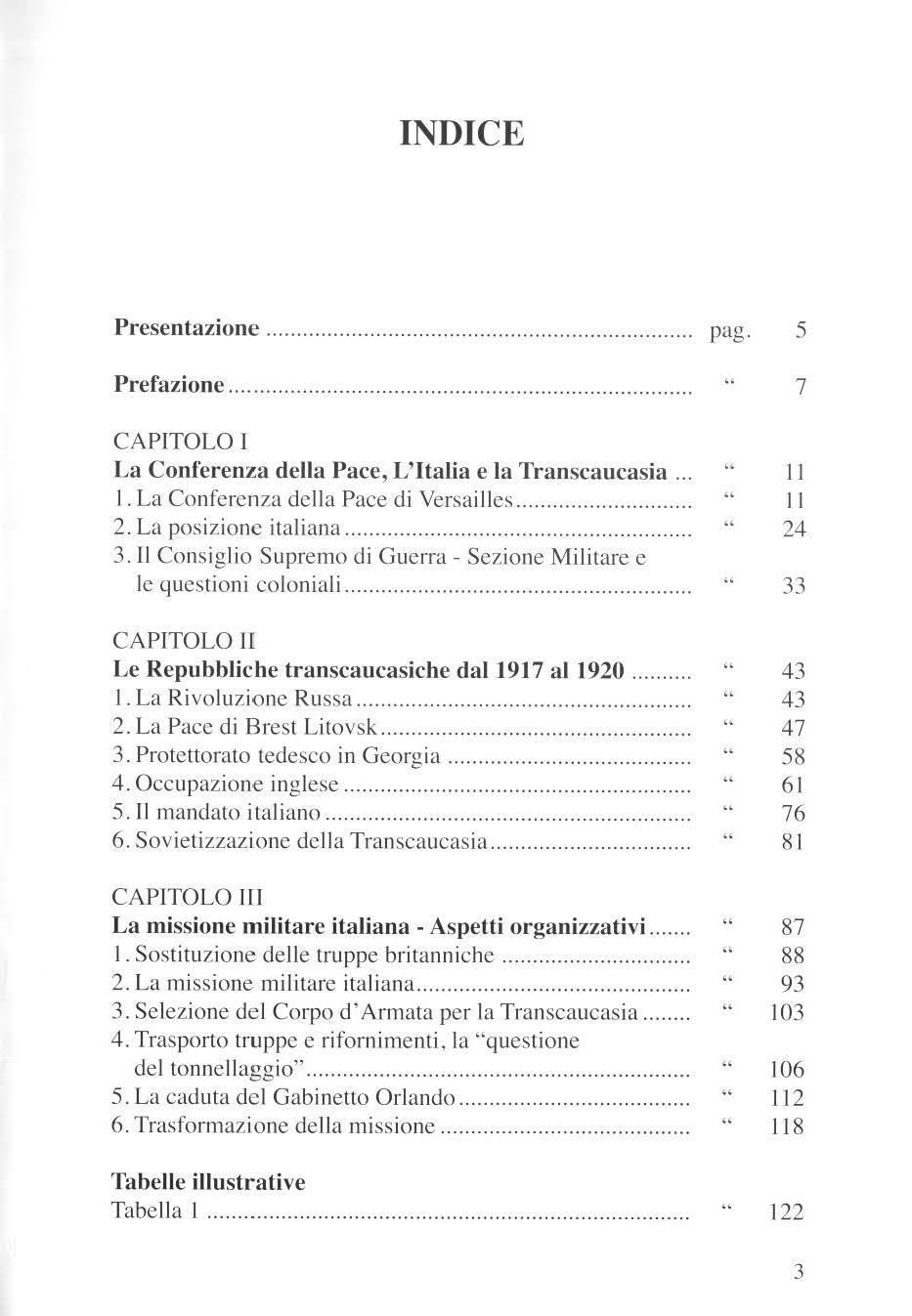
l. La Rivoluzione Ru ssa ...................................................... .
2. La Pace di Brest Litovsk .......... ........................................ .
3. Protettorato tedesco in Georgia ...................................... ..
4. Occupazione in g lese ....................................................... ..
5. Il mandato italiano ........................................................... .
6. Sovietizzazi.onc della Tran scaucasia
CAPITOLO TTT
3.
INDICE Presentazione ...................................................................... pag. 5
Prefazione ..................... . .................................................... ..
............................... ..
ss ione militare italiana
organizzati vi ..... ..
Sostituzione delle truppe britanniche
La missione militare italiana ........................................... ..
La mi
- Aspetti
l.
2.
Selezione del
...... ..
Corpo d'Annata per la Tr anscaucasia
............................................................. ..
cad uta del Gabinetto
....... ........ ..................... ..
Trasformazione della missione .. ................................... .. .. Tabelle illustrative " ,, ,, " ,, " " 7 11 Il 24 33 43 43 47 58 61 76 81 87 88 93 103 106 112 118 Tabell a l .... . .... ... . .... .... .... .... ... . ... . ... . .. .. . ... ... . ... . .. . ... ... . ... . ... . ... . 122 3
4. Tras potto truppe c rifomimenti, la "questione del tonnellaggio"
5. La
Orlando
6.
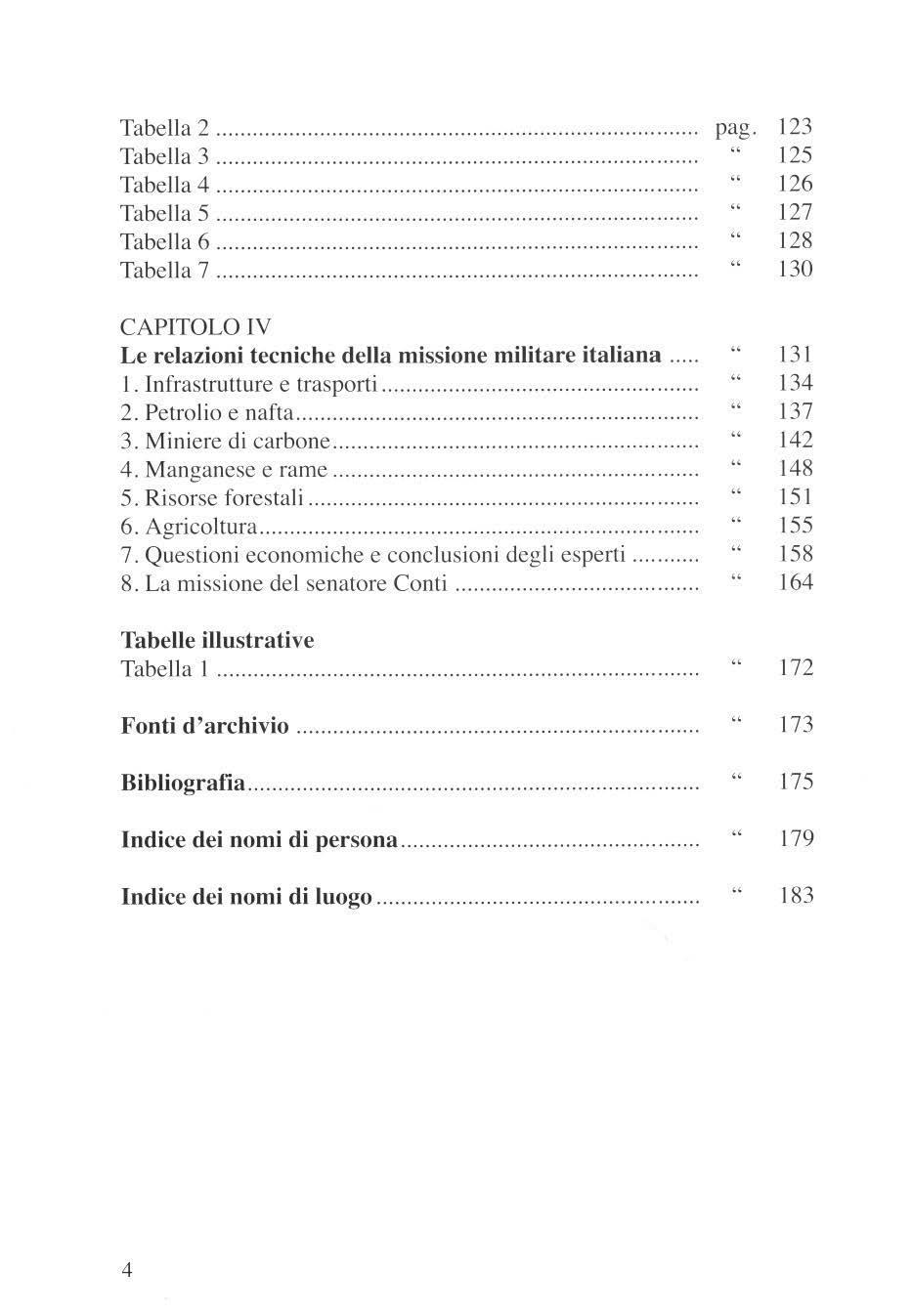
Tabella 2 .............................................................................. . Tabella 3 .............................................................................. . Tabella 4 Tabella 5 .............................................................................. . Tabella 6 Tabella 7 .............................................................................. . CAPITOLO IV Le re lazioni tecni c he dell a m iss ion e mi li tare i ta li ana .... . l. Infrastrutture e trasporti ................................................... . 2. Petrolio e nafta ................................................................. . 3. Miniere di carbone ........................................................... . 4. Manganese e rame 5. Risorse forestali ............................................................... . 6. Agricoltura 7. Questioni economiche e conclusioni degli esperti .......... . 8. La missione del senatore Conti ....................................... . Tab e ll e illu strati ve pag. " •' " " " " " " " " " 123 125 126 127 128 130 131 134 137 142 148 151 155 158 164 Tabella l ........................................................................ ....... 172 Fo nti d 'archi vio ........................................................... ....... 173 Bibliogra fi a ......................................................................... . ,, 175 Indi ce d e i n o mi di p e rs on a ................................................ . " 179 Indice d ei n o mi di luog o .................. . .................................. 183 4
Quest'opera analizza, attraverso la documentazione conservata pre sso l'Archivio Sto1ico dello Stato Maggiore del! 'Esercito, un episodio molto poco conosciuto della storia del nostro Paese alla fine del primo conflitto mondiale.
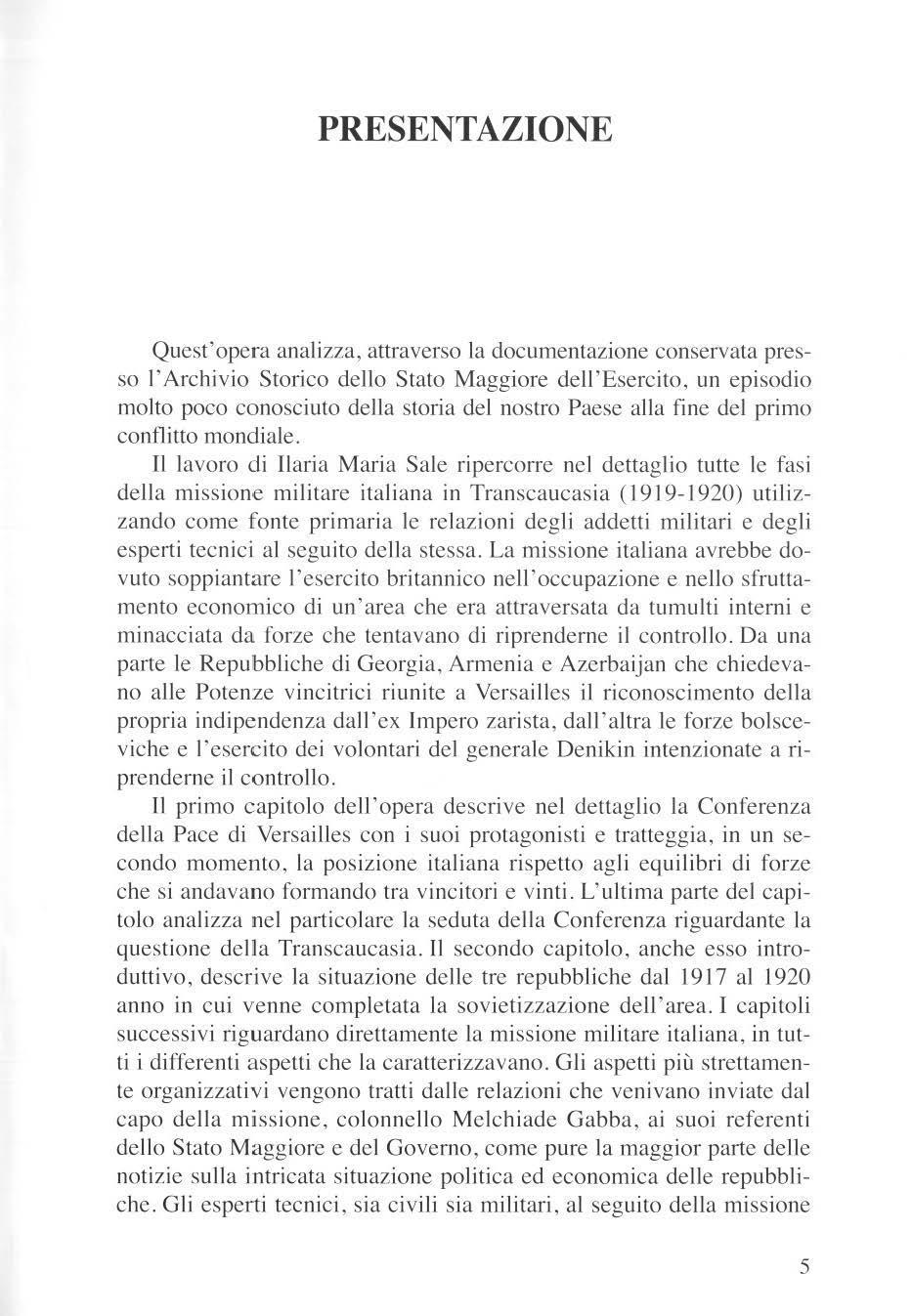
Il lavoro di Ilaria Maria Sale ripercorre nel dettaglio tutte le fa s i della mission e militare italiana in Transcaucasia (1919 - 1920) utilizzando come fonte primaria le relazioni degli addetti militari e degli esperti tecnici al seguito della stessa. La mis s ione italiana avrebbe dovuto soppiantare l'esercito britannico nell'occupazione e nello s fruttamento economico di un'area che era attraversata da tumulti interni e minacciata da forze che tentavano eli riprenderne il controllo. Da una parte le Repuibbliche di Georgia, Armenia e Azerbaijan che chiedevano alle Potenze vincitrici riunite a Yersaillcs il riconoscimento della propria indipendenza dall'ex Im pero zarista , dall ' altra le forze bol s ceviche e l ' esercito dci volontari del generale Denikin intenzionate ariprcnderne il controllo.
Il primo capitolo dell ' opera descrive nel dettaglio la Conferenza della Pace di Versailles con i suoi protagonisti e tratteggia, in un secondo momento, la posizione italiana rispetto agli equilibri di forze che si andavano formando tra vincitori e vinti. L'ultima parte del capitolo analizza nel pm1icolarc la seduta della Conferenza riguardante la questione dclaa Transcaucasia. Il secondo capitolo, anche esso introduttivo, descrive la situazione delle tre repubb li che dal 1917 al 1920 anno in cui venne completata la sovieti zzazione dell ' area. I capitoli successivi riguardano direttamente la missione militare italiana, in tutti ì differenti aspetti che la caratterizzavano. Gli aspetti più strettamente organizzativi vengono tratti dalle relazioni che venivano inviate dal capo della missione, colonnello Melchiade Gabba, ai suoi rcfercnti dello Stato Maggiore e del Governo, come pure la maggior parte delle notizie sulla intricata situazione politica ed economica delle repubbliche. Gli esperti tecnici , sia civili sia militari, a l seguito della missione
PRESENTAZIONE
5
produssero un a notevol e mole di rapporti sulle risorse dell'area, sulle possibilità di sfruttamento c sulle condizioni di infrastrutture e impianti. Le relazioni tecniche, sviluppate grazie ad una serie di missioni condotte nelle arce di maggiore interesse, riguardavano le risorse petrolifere , il carbone, il manganese ed il rame, le ri so rse forestali ed una attenta analisi della condizione delle f e rrovie e della pipeline.
Ringra z iamo sentitamente l ' Autrice di questo volume per il lavoro intenso ed approfondito svolto presso l 'A rchivio Storico dello S.M.E. e per avere esaminato e contribuito a chiarire alcuni aspetti eli un periodo complesso e delicato della storia dell'Europa orientale.

6
Col. Matte o PAESANO
PREFAZIONE
La fine della prima g uerra mondiale, la dissoluzione dci grandi Imperi plurinazionali (ottomano c asburgico) e la trasfonnazionc di quello Z<irista in nuovo sis tema politico e ist itu zionale ispirato alle teorie marxiste relative alla soppressione della proprietà e dell'economia di mercato- l'Unione delle Repubblich e Socialiste Sovietiche (U RSS )aprono scenari internazion a li nuovi e imprevisti. Le potenze vincitrici tentano, con la Conferenza della Pace di Versailles, di disegnare un nuovo assetto europeo e internazionale avente come obiettivo la costituzione di un nuovo sistema di relazioni internaziona li per dare concreta attuazione alle speranze e alle attese maturate nei popoli durante i difficili anni della guena. La dissoluzione dei grandi Imperi plurinaziona li - "le prigioni dei popoli" - avrebbe dovuto aprire una nuova epoca caratterizzata dalla presenza di quelle nazionalità finalmente libere di costituire un proprio Stato nazionale, sovrano, libero e indipendendente secondo la maturazione del pensiero politico avvenuta nel secolo XIX. Il Congresso di Vienna del 1815 , la Santa Alleanza e la Restaurazione post napoleonica rappresentano altrettanti momenti della risco ssa reazionaria finalizzata a venificare il portato modernizzatore della rivoluzione francese, della fine dell'assetto "no biliare" del sistema sociale e della borghesia come forza propulsiva di un cambiamento. questo sì, di pottata epocale. La tensione ideologica interna alle varie società produce effetti contrastanti aprendo un periodo di crisi e di instabilità lungo un ventennio.
Il successo della rivoluzione russa del 1917 , il mito di una palingenesì sociale e eli un riscatto soc iali delle classi oppresse diviene per molti un mito che finisce per oscurare i chiari e inequi vocabili segna li di un regime ideologico, politico ed economico assolutamente nuovo e difficilmente riconducibile alle "categorie" politiche occidentali relative all'autoritarismo e al totalitarismo: l ' Unione sovietica è qualco sa di più e di diverso potendosi rintracciare in quel sistema confusi elementi della cultura politica teocratico-religiosa-patrimoniale di tipo zarista

7
oppure modelli di assolutismo asiatico. In sintesi si può affem1are che g li europei , nei primi anni del Novecento, conoscono poco la Russia, sopra ttutto quella asiatica , e i meccanismi che ne regolano la vita politica c sociale interna. Gli zar, a partire da Ivan IV (1533-1584). avevano operato una politica di espansione verso sud e verso oriente che aveva portato alla conquista di Ka zan' nel 1522 e d[ Astrachan' nel 1566 per il controllo de li' intero corso del Volga c il passaggio degli Urali pone le basi per la conquista della Siberia. Come ha sottolineato recentemente Lapo Sesta n 1 è con Caterina TI (l 762-1796) che lo Stato russo conosce la sua massima espansione grazie alle guerre vittoriose contro l'Impero ottomano che le assicurano il contro ll o del Mar Nero e una presenza decisiva nel Caucaso. in particolare con l'annessione della Crimea (1783) e il protettorato russo sulla Transcaucasia.

È questa la regione di cui si occupa la ricerca di Ilaria Maria Sale in un contesto completamente diverso quale è quello successivo alla fine della prima guerra mondiale. L'idea di indip endenza, la possibilità di costituire un proprio Stato nazionale sovrano sembra praticabile anche alle nazionalità che abitano la regione soprattutto dopo il cro llo del sistema zarista. Nel 1917-1918 in T ran scaucas i a si costituiscono le repubbliche di Armenia, Azerba igia n e Georgia che nel marzo 1922 si uniscono in una federazione con capitale Tifli s . Il 30 dicembre dello stesso anno la federazione entra a far parte dell 'U RSS c nel 1936 viene sciolta. Per ritornare all'indipendenza bisognerà attendere gli anni Novanta del XX secolo e cioè l'implosione dell ' URSS e la fine dell'egemonia sov ietica in Europa e, in parte, in Asia. È eli questi anni il difficile e contrastato processo di formazione di un s istem a parlamentare democratico reso complesso non solo dal '"peso" della storia c dalla mancata modenizzazione ma per la collocazione strategica de li 'area che investe insieme problemi di carattere economico (il petrolio) e di carattere militare e strategico sia per la Ru ssia attuale che per gli Stati Uniti e l'Europa.
l documenti che l 'Autrice ha s tudiato danno un qu adro preciso di quella situazione e consentono anche di meglio comprendere gli avvenimenti del tempo presente. Non sfuggi rà al lettore attento l'alto livello professionale di co loro che quei documenti hanno prodotto- gli uf-
1 LAJ>O SESTAN, La Russia amminis1ra l'Oriente: la presen-::.a mss a nel Caucaso. in AA.VV.. La Ru ssia vers o Oriellle./1 croceFia del Caucaso. a cura di S ERGIO BERTOLJSSI e LUIGI MAGAROTrO. Napoli 2004.
8
ficiali italiani impegnati in quell'area- e la sensibilità per i temi di carattere economico che la Sale ha saputo magistralmcnte ricostruire grazie anche alla guida di uno specialista di Storia economica, la professoressa Giovanna Molla, componente del collegio dei docenti del dotlorato de ll'Università di Roma " La Sapienza" presso il quale l'Autrice di queste pagine s i è brillantemente addottorata.
Per quanto mi ri guarda non posso che riconfermarc la mia personale soddisfaz ione come coo rdinatore di quel dottorato ma anche per la costa nte conferma sulla validità di una documentazione - quella dei militari impegnati nell e Missioni alrestero - che posso dire di aver per primo alla comu nità scie ntifi ca nazionale e internazional e e che fin dai primi anni Setlanta ha costituito un punto di riferimento costante per la mia attività di studioso c per quella di molti giovani che con le tesi di laurea o di dottorato hanno preso consapevolezza di un se ttore non seconda rio di intervento dei nostri militari nella determinat.ione della politica estera del Pae se; tutto questo non sarebbe stato po ssibile senza la lungimiranL.a dei dirigenti che si sono avvicendati alla guida dell'Ufficio storico e la generosa del personale tutto.
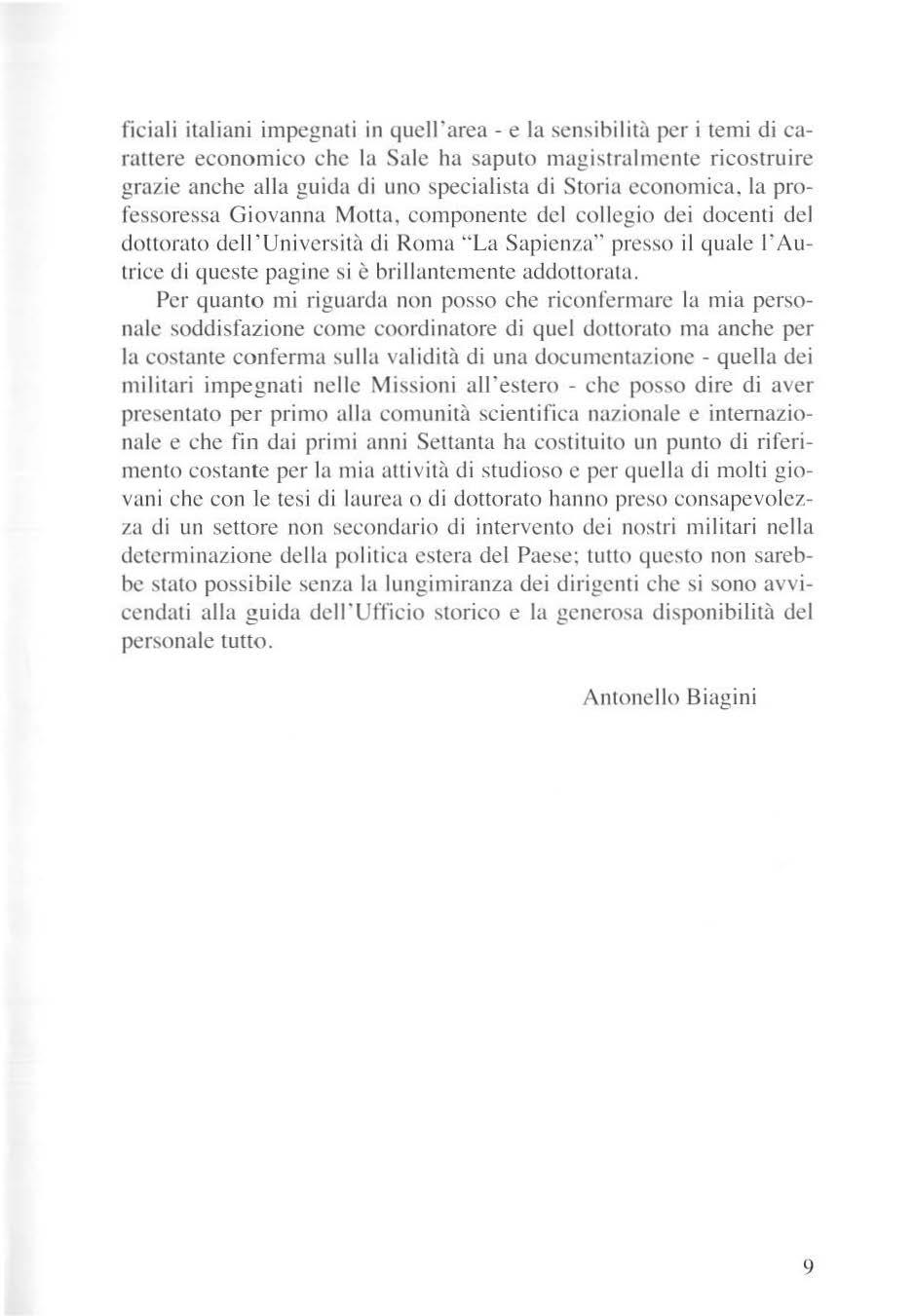 Antonello Biagini
Antonello Biagini
9

CAPITOLO I
La Conferenza della Pace, l 'Italia e la Transcaucasia
l. La Conferenza della Pace di Versailles
La Conferenza della pace venne formalmente inaugurata, nella reggia di Versaìllcs, il 18 gennaio 1919 in una riunione plenaria che vedeva la presenza delle grandi potenze alleate, dell'associata americana, c delle alleate minori.

fnizialmente la guida della conferenza fu assunta dal cosiddetto Consiglio dei Dieci, un organo composto dai capi di governo c dai ministri degli esteri delle grandi potenze: Gran Bretagna, Francia, Italia, Stati Uniti c Giappone - rappresentato da due ambasciatori. La presidenza della Conferenza fu affidata al primo ministro francese Clemenceau. capo di governo del paese ospitante la conferenza. Il consiglio altro non era se non la continuazione del Consiglio Supremo di Guerra, istituito nel novembre del 1917 per ottenere un migliore coordinamento nello sforzo bellico interalleato. Questo organo di coordinamento militare teneva conferenze periodiche, ai massimi livelli, nelle quali venivano decise le strategie generali dell'Intesa. l rappresentanti italiani furono il generale Cadoma , il generale Giardino cd il generale di Robilant. che rappresentò l ' Italia tino alla tìne del conflitto. Ai delegati delle potenze vincitrici si aggiungevano, quindi, i vertici delle forze annate riuniti nella Sezione Militare della conferenza, che ebbe molto peso nelle decisioni di politica estera.
Gli Stati Uniti, caso unico tra gli stati che prendevano parte alla conferenza, erano rappresentati dal presidente che. secondo la Costituzione americana era sia Capo di Governo che Capo dì Stato. La decisione di Wilson di recarsi personalmente a Ycrsailles suscitò non poche polemiche circa l'opportunità politica di tale scelta, fece sorgere problemi dinantra protocollare in fase di organizzazione preliminare della conferenza e provocò seri conflitti a causa della sua intTansigenza ed inesperienza 1 •
1 Il problema protocollare era dovuto al fatto che Wilson, nella sua veste di capo di Stato, sarebbe stato di rango superiore rispetto ai Primi Ministri che prendevano
l l
La conferenza - secondo il programma di Wilson, che si impegnò affinché vi fossero applicati i principi di giustizia, libertà, nazionalità ed autodeterminazione dei popoli, che sottendevano i suoi 14 puntiavrebbe dovuto disegnare una nuova Europa, nella quale una tragedia come la guen·a appena conclusa non avrebbe avuto più ragione di essere. Il presidente americano aveva spesso manife stato la propria diffidenza verso i metodi politici e dip l omatici adottati in Europa f in o a quel momento , esprimendo il p roprio desiderio di contrapporre alle alleanze ed ai trattati segreti una new diplomacy basata su ll a creazione di un sistema di sic ure zza mondiale imperniato su ll a Società delle Naz io ni 2. Wilson era consapevole che i suoi progetti avrebbero trovato l'oppo s izione dei capi di governo a ll eati che non condividevano il suo idealismo , ma pensava di poter contare sull'appoggio dell'opinione pubblica mondiale che - durante le sue visite in Francia, Italia e lnghiltena - lo aveva accolto come se in lui fossero riposte tutte le speranze dell ' umanità.
La politica francese e quella britannica erano orientate verso altri obiettivi c guardavano alla pace da prospettive differenti. La classe diri gente francese era determinata ad ottenere l'annichilimento della Gennania , s uo tradizionale nemico, mediante l. la sottrazione di tetTitori ad occidente - Alsazia- Lo rena, Saar, Renania; 2. l 'is tituzione di parte al l a conferenza si pensò , quindi, di dove r affidare a lui la presidenza anziché a Clcmcnccau cui spettava secondo consuetudine. Da più inoltre. si sco nsigliav a l'autore uci 14 punti, che come tale aveva assunto un ruolo di g uida moral e per gli altr i paesi. u i sede re a ll a conferenza ponendos i qu in di a ll o stesso live ll o degli altri de lega ti. Di questa opinione e ra ad esempio Robe1t Lansing, segretario di Stato agli Ester i deg li Stati Un iti. che sc r ive nel suo diario di temere i problemi che sarebbero scaturiti da ll a partecipazione diretta di W i lso n alle trattative di pac e, che avrebbe in ev itabilmente compo11 ato una perdita della posizione dominan t e che aveva occupato fino a quel momento. Lansing temeva. ino l tre . i l confronto diretto tra W il s on c gli a l tri ca pi di governo, assai più abili polit icamente del presidente amelicano che, in fa tti , s i rivelò impreparato di fronte alle questioni diplomatich e e politiche europee. Lan s ing, R., The Peace A personal narrative, London. Constab le & Co. 1921, pag. 22.
2 I 14 punti. che conteneva no il programma di pace del pre s idente, furono elencati da Wil so n in un d isco rso p ro nunc iato al Congresso 1'8 gennaio 1918. Il 14° che egli 1itencva il più impo rt ante riguardava la necessità di crear e una ge nera le de ll a Nazioni Un it e che av rebbe dovuto essere "fomwta in virtù di con venzio ni formali aventi p er Oftf?elto di fornire garan::.ie reciproche di indipenden za poli t ica e t erritoriale ai pi cco li co me ai grandi Stati ·•.

12
una barriére de l'Est costituita dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia ma anche dalla Romania c dalla nascente Jugo s lavia , che avrebbero costituito un valido baluardo contro la Russia bolscevica ed impedito ogni collegamento con la Germania; 3. 1'appoggio ad ogni eventuale spinta separatista. Il premier inglese David Lloyd George, dal canto suo, era ancora incline a considerare il riassetto europeo alla luce del tradizionale concetto di ba/ance ofpower, piuttosto che sulla base dei principi eli nazionalità ed autodetem1inazione dei popoli 3 . Le posizioni italiane erano, paradossalmente, quelle che più si avvicinavano all'utopia wilsoniana, pur o ri ginando da concetti tradizionali di democrazia, tanto che i delegati dei due paesi furono molto spesso dello stesso avviso per la soluzione di molti problemi politici.
l delegati francesi e britannici, posti di fronte alla detem1inazione dì Wilson ne l far applicare rigidamente il proprio programma, erano riusciti a manipolare i dati in loro possesso ingenerando nel presidente, che aveva scarsa preparazione nelle questioni di politica europea, la convinzione che rispecchiasscro appieno i principi espressi nei 14 punti. Perfino gli intenti imperialistici dei due alleati riu sc irono abilmente ad essere mascherati dalla finzione giuridica del mandato che nascondeva lo smembramento e la spartizione delle colonie tedesche. Il fallimento di Wilson alla conferenza dì Parigi è illustrato da Carlo Sforza , allora Alto Commissario italiano a Costantinopoli, con poche efficac i parole: il presidente "avrebbe dovuto scegliere tra due metodi: o non transigere mai su ciò che erano i suoi principi; o far della diplorna z ia ab itual e e transigere un po' da pertutto "4, egli in vece, dopo aver ceduto su quasi tutti i punti a lla volontà franco-britannica, di fronte al malcontento che le soluzion i della pace generavano negli Stati Un iti, cercò i l proprio successo personale opponendosi strenuamente alle richie ste italiane per Fiume. La risposta a ltrettanto ferma della delegazione e dell'opinione pubblica italiana diede o ri gi ne alla cris i diplom atica più grave di tutta la conferenza.
Alla base delle rivendicaz ion i territoriali italiane c'era innanzi tutto il Patto di Londra, del 26 aprile 1915 , stipulato in segreto con Inghil terra , Francia e Russia, che aveva sanci t o l'ingresso in guerra dell' I talia a fianco dell'Intesa. Il programma , definito da Sonnino con gli

13
3 Caccamo. F.,L'Ilalia e fa "Nuova Europa", Milano, Luni editrice, 2000, pagg. 22- 23. 4 SforLa, C.. L'ltafia dal ' 14 al '4-1 quale io la vidi. Verona, 1946. pagg. 53-54.
alleati, era incentrato su l completamento dell'unità nazionale e sul raggiungimento eli posizioni stra te g ich e ai conf ini sette nt riona li e orientali. In pa rticolare si sarebbe ro dovute o ttene re Trento e Trieste, l'a rc o alpino con il passo del Brennero, l'Istria, la parte settentrionale della D almazia comp rese numerose isole e Valona. L'a rticolo 4 del patto di Londra escludeva chiarame nte la c ittà di Fiume dalla zona di influenza italiana !asciandola di fatto alla Croazia, pur essendo il dest ino eli quest'ultima come Stato indipendente ancora piuttosto in certo . Il patto seg reto comprendeva anc he un riorganiaazione pitl generale del r Adriatico orie ntal e e dell'entroterra danubiano-balcani co. all'interno della quale si prometteva all'Italia una preminenza in Albania.
Dal patto di Londra erano rimaste le asp irazioni ita liane nelle co lonie ex tedesche e nel Mediterraneo. A questa carenza posero rimedio g li accordi di S. Giovanni di Moriana dell'aprile 1917, con i quali s i sanc i va la parte cipazio ne it aliana alla spartizio ne dell'impero ottomano ormai sconfitto. L'Italia ottenne, almeno cmta, notevoli vantaggi in Anatolia meridionale c nei , ·ilayet di Aydin c Konia. Gli Stati Uniti, che non erano firmatari di alcuno dei succitati trattati, si rifiutarono di riconosceme la va lidit à, anche perché la ne w diplomacy wilsoniana con dannava d ec isame nte i trattati segre ti cd ogni aspirazione che si discostasse dal principio di na zionalità o di etnia. La Gran Bretagna e la Francia tennero fede al Patto di Londra, senza mai rin negarlo. nonostante le pressioni s tatuni te nsi. mentre invece approfittando de l fatto che la Russia- a ca usa della rivoluzione- non aveva ra ti ficato gli accordi d i S. Giovanni di Moriana , li consideraro no nulli 5 Il patto del 1915 riman eva, dunqu e, l'unico punto fermo delle ri ve ndi caz ioni territori ali italiane, ricono sci uto c vi ncol ant e per g li alleati.
I Dieci furono affianca ti da una serie di organi tecnici - le cosiddette Commi ssioni, a loro vo lt a suddivise in una se ri e di ni - che avevano il compito di esaminar e, in via preliminare, le ques tioni più co ntroverse e di formulare proposte per la loro so lu zio né.

5 In merito cfr. Caccamo. F cii pagg. 25-27 e Curato. F La Conjeren:a dello Pace 191911920. volli. Milano. 1942. pagg . 7-9
6 Per un completo delle Commissioni e :-.ottocommissioni che co:-tituirono durante i lavori della conferen7a della pace . è utile consultare il prospetto Tardieu. riporta to in: Curato. F cit pagg. 12-t - 126. Tardieu suddivide gli organi dd l a conlcrenza in Organi generali (Segretariato generale, Comitato per l a verifica dci pareri c Comita to di redazi one) c Comrnb:.ioni. Le co mmi ssion i piLJ importanti - a loro vo lla suddivise in un numero var i abile di sollocommissioni - erano: l. La commissio-
14
Le commissioni istituite per studiare le questioni territoriali furono certamente tra le più importanti cd ebbero una influenza notevolissima s ulle questioni inerenti il nuovo assetto dell'Europa. Nei primi mesi l'attività delle commissioni territoriali si concentrò su questioni preliminari quali le procedure da adottare per i lavori della conferenza, oppure su questioni di particolare urgenza , come il rinnovo del l 'armistizio con la Germania e la strategia da adottare nei confronti della Rus- ' sia bolscevica. Le questioni territoriali dell'Europa orientale , data la loro complessità, non furono esamjnate fino alla fine del mese di gennaio quando, la crescente preoccupazione per i potenziali cont1itti che si stavano ingenerando nella regione ed il pericolo sempre più concreto dell'espansione del bolscevismo, spinsero i plenipotenziari a fare presente la necessità di iniziare ad en trare nel merito dei problemi territoriali. Clemenceau , il 23 gennaio, propose di e laborare una procedura per l'e same delle questioni ten·itoriali. Il ministro Sonnino propose di fissare un termine entro il quale tutte le potenze interessate avrebbero dovuto presentare le proprie rivendicazioni , sotto forma di una relazione scritta, rivolta al segretar io della conferenza 7 . Quando fu chiaro che le relazioni scritte non sarebbero state consegnate nei tempi stabiliti , cioè per la fine di gennaio, si decise di dare inizio a delle audizioni dei rappresentanti delle potenze minori nelle quali esprimere le proprie rivendicazioni. Questo secondo metodo rivelò immediatamente la propria inefficacia: il 29 gennaio i rappresentanti cechi e quelli polacchi avevano fornito versioni opposte s ulla questione di Teschcn; il 2 febbraio l 'audizio ne dci rappresentanti rumeni e jugoslavi in merito alla regione del Banato, evidenziò una inconcili abile divergenza di vedute. Su propos ta di Wilson e Lloyd George si decise dunque di delegare queste discussioni preliminari a degli esperti - due per ognuna delle grandi potenze - che avrebbero formulato delle propo ste da sot-
ne per le riparazioni (con tre sottocommi ssioni);
2. le commissioni territoriali; 3 . la commissione per le questioni finanziarie (con sci so ttocommiss ioni) ; la commissione per le questioni economiche (con nove sottocommissioni)
4. la Società delle Nazioni (con tre sot tocommiss ioni ) co n il comp i to di perseguire i crimini di guerTa.
7 Caccamo a questo proposito so ttolin ea come g ià in questa occasione iniziassero a manifestarsi i p1imi conflitti in se no alla del egaz ione italiana , in particolare tra Orl ando c Sonnino. Il primo ministro, infatti, in una lettera indirizzata a Vittorio Emanu e le, diede mostra di non aver gradito l a proposta formulata da Sonnino cd accettata da ll a co nfere nza, della quale temeva le possibi l i con segue nze. Caccamo, F., cit., pagg. 46-48.

15
topone, solo in seguito, al consiglio dei Dieci. Le proposte avrebbero dovuto essere formulate unicamente sulla scorta di dati territoriali e razzia l i, senza prendere in considerazione eventuali implicazioni di natura politica. Il primo ministro Orlando , in seguito a questa deliberazione, preoccupato per la definizione della situazione italiana, ottenne che le frontiere delle grandi potenze rappresentassero una eccezione a tale regola e fossero discusse solo in seno al Consiglio Supremo senza ingerenze da pa1te delle commissioni8
A seguito di una serie di indiscrezioni trapelate sugli organi di stampa dopo le riunioni dci Dieci, il consiglio si scisse in due organismi distinti, il consiglio dci Quattro e il consiglio dei Ministri degli Affari Esteri- meglio noto come consiglio dei Cinquc 9 Solo il primo aveva il potere di pronunciare le decisioni definitive mentre il secondo , che aveva soltanto funzioni consultive, svolse compiti molto 1ilevanti nella fase preliminare delle trattative. La via delle indiscrezioni era rimasta l'unica perconibile per la stampa che, giunta numerosissima a Parigi nell"erronea convinzione che le sedute sarebbero state pubbliche - basandosi sul primo dei 14 punti di Wilson inerente gli open covenants (accordi palesi) - rimase delusa nell'apprendere che le riunioni del consiglio dei dieci si sarebbero svolte strettamente a po1te chiuse. Le uniche aperte alla stampa sarebbero state le riunioni plenarie che, però, furono poche e scarsamente significative. Le indiscrezioni, nonostante le precauzioni adottate, furono comunque numerose con grande disappunto dei rappresentanti alleati 10 .
Le potenze minori, che avrebbero voluto prendere parte alle sedute del Consiglio, furono autorizzate a solo quando erano direttamente interessate agli argomenti in discussione. Questa decisione venne presa - almeno questa fu la motivazione ufficiale - per consent ire maggiore rapidità ai lavori del Consiglio ed evitare lungaggini. L'idea iniziale, infatti, era quella di tenere due conferenze distinte: una interalleata che avre bbe dovuto tracciare a grandi linee le proposte di pace da fare alla Germania e agli altri vinti; la seconda - durante la quale si sarebbero stabilite le condizioni definitive - avrebbe visto anche la partecipazione dei vinti e dei paesi neutrali. Di fatto, la seconda conferenza non ebbe
8 Curato, F.. cit., pag. 117.
9 La differenza nel numero dei membri dci due organi deriva dal fatto che il Giappone - essendo r appresentato solo da due ambasciat ori - prendeva parte solo alle sedute del Consiglio dci C inqu e.
1°Curato , F., cit., vol. l , pag. 128.

16
mai luogo per diversi motivi: innanzi tutto fu determinante il fattore tempo c h e s pin se i plcnipotenzim·i. dopo sei mesi dall'inizio delle consultazioni, ad accelerare c a concludere i lavori. D etermina nte fu, inoltre, la difficile situazione int erna nella quale si trovava Wilson. dopo le elezioni del 1919. Egli temev a di no n riu sc ire a far approvare in Senato due trattati di pace ed era preoccupato, inoltre, della possibile esc lu s ione dal trattato del patto preliminare per la fondazione della Società delle Nazioni. Il e ntimcnto era condiviso dagli altri alleati dato che il patto comprendeva una alleanza tripartita tra inglesi, francesi e americani. Per ovviare a queti problemi. si decise di considerare definitivo i l testo per la pace con la Germania stilato dalla conferenza interalleata. l rappresentanti tedeschi sarebbero stati convocati solo per la flrrna del trattato. escludendo di fatto ogni possibilità di trattativa o di replica, trasformando il trattato in un diktat11. l delegati italiani tentarono inizialmente di oppo rsi a lla stipula separa ta della pa ce con la Germania, rimarcando c h e il programma originario prevedeva che la firma dei trattati avve ni sse contestualmente con tutti i vinti. Orlando e Lloyd George in una conversazione privata avevano convenuto che sarebbe stato conveniente per l'Italia che le condizioni di pace, con r Austria e con la Germania, fossero considerate nel loro complesso in modo che potessero essere ugualmente compe nsati vi sia per In ghilterra c Francia sia per l'ltalia 12 • Roma sof-
11 L'ipotesi di agire in tal e maniera venne discussa da l colonnello Edward House ina 13alfour e Clcmt.:m:cau. in data 4 marzo 19 19. come dal diario dello House. c he scrive: "Nexli ultimi giorni ho pensmo che 11011 dorremmo com ·ocare la regolare ConfPren :.a d ella Pace. allo quale samnno presenti llllli i rallli dell'ultima guerra. çe non dopo che i Tedeschi m·ranno accettato le nostre condi;ioni ...Quando Gl'remo completato le nostre condi-::.ioni. t erremo una riunione plenaria degli Alleati al Quai d'Or my nella mattina e ci pronunceremo su/trattato come noi e xli Alleati lo abbia111o de.finito. A questa seduw plenaria sarà nominata una COIIlllli.lsione perché vada a Versailles a presentare il trallato ai plenipoten:.iari tedeschi. Essi a loro volta dol'rmmo andare a Berlino per co11.Witarsi co/loro Gol'erno. Quando essi ritomemnno, la nostra commissione li incomrerà a Versailles per la .firma del documento e 11011 per altro scopo.'' Clemenccau e Bai four approvarono, durante quella riunione, il metodo proposto da House che era il modo più sbrigativo per raggiungere un primo risultato. come risulta in: The illlimate papers of Colone/ 1/ouse arrangcd as a narrati\ C by Ch. Seymour. Boston, Houghton Mifflin Company. 1926-1928, I V, pagg. 355-356.
12 Mosca. R .. e .1i:.tema:.ione europea. La Conferen-::.a della pace. La questione adriatica. in P La politica estera iwliana dal 1914 al 1943. Torino . E.R.L, 1963, pag. 55.

17
f1iva evidentemente di un certo isolamento nei confron ti di tutte le altre potenze. imputabile al fallo che per gli anglo-francesi e per l'associata americana il nemico più pericoloso fosse sta t a la Germania, mentre per l'Italia il vero nemico era stata l'Austria-Ungheria. Gli italiani temevano c non a tol1o, che una volta stipulata la pace con i tedeschi. le questioni inerenti la sicurezza italiana c le nuove frontiere sarebbero state trascurate.
Senza entrare nel merito delle decisioni assunte dalle diverse commissioni territoriali, vista la necessità di concentrarsi - nei prossimi paragrafi -sulle questioni it aliane, si può affermare che il nuovo assetto dato all'Europa dalla conferenza di Yer costellato com'era di errori ed ingiustizie palesi, dovute agli interessi impcriali!>tici delle grandi potenze, lungi dall'eliminare ogni possibile conflitto. acuì quelli esistenti c ne c reò dei nuovi. Le prime deliberazioni della conferenza convinsero l' opinione pubblica mondiale che le regole della politica internazionale e le logiche che sottcndevano all'operato delle Potenze non erano affatto cambiate. l vincitori agirono durante la conferenza con lo spirito di crociata che li aveva spinti durante la guerra; gli sconfitti si trovarono, invece, ad affrontare un periodo di disgregazione soc iale e politic:::t lunga un ventc nnio ed aggravata dalle richieste eccess ive di riparazioni avanzate dai vincitori. Il periodo di crisi e di instabilità coinvol e anche i vincitori nella misura in cui i trattati - pensiamo al caso del Patto di Londra con il quale l'Italia diede la propria adesione all'Intesa - non regi travano con sufficie nt e chiarezza le aspirazioni e gl i interessi nazionali 13 . Durante il conflitto - che si estese progressi va mente a tutti i con tin e nti - la propaganda, c h e diffondeva principi id eo logici astra tti lont aniss imi dai reali programmi politici dei governi, impedì di accorgersi che i popoli alleati combattevano insieme ma non avevano obiettiv i comuni. Questo sdoppiamcnto tra g li ideali enunciati -ch e convi n sero i popoli be lli geranti di poter addive nire ad una s is temazione definitiva delle potenziali ragioni future di cont1itto -c g li interessi dei sin gol i governi, in ne-
lì Biagini. A Romanelli. G., Neii'UII!;heria di Bé/a Ku11 e durante l'ocntpa : io11e militare rome11a. Ul mia missio11e 1919}. Uftìcio Storit.:o SME. Roma. 2002. pagg. XV-XV II. Per approfondire ulteriormente l'argomento cfr. D'Amoja, F., /Jecli11o e prime crisi del/ 'Europa di Versai/le\. Studio sulla diplollw-;.ia italiana ed europea (/931-1933) Milano, Giuffrè. 1967 e Biagini, A., In l?ussia tra Ruerra e rivolu:ivlle. La missione militare iralia11a ( 1915 - 1918), Roma , Ufficio Storico Esercito, 1983.

18
scò reazioni tanto maggiori di fronte alle delusioni della pace , quanto più grandi erano state le illusioni diffuse dalla propaganda.
Gli eJTor i commessi dalla Conferenza nella redazione dei trattati eli pace superarono qualsiasi possibile previsione; il nuovo "equi librio '' cui diedero vita non aveva nulla a che vedere con gli ideali per cui i popoli avevano combattuto ed in nome dei quali i vinti avevano accettato la resa. Il carattere totalitario della guena moderna, che si era cercato in ogni modo di nascondere, si manifestò chiaramente durante le trattative di pace , quando ciascuna na zio ne tentò di far prevalere i propri interessi individuali sug li altri. Gli errori riguardarono in eguale mjsura sia le que stioni te1Titoriali che quelle di carattere gene rale, nelle quali l a conferenza agì con una durezza ed un rigore tali da annullare qualsiasi speranza di costituire il tanto atteso nuovo equi l ibrio internazionale.
Ai vinti - ai quali fu negata ogni possibilità di replica e contraddittorio- fu attribuita , mediante una sentenza, ogni responsabilità su lle origini della guetTa; i capi civili e militari delle nazioni avverse furono incriminati e perseguiti penalmente; le riparazioni richieste per i danni subiti furono astronomiche; le flotte militari e mercantili furono confiscate; per quanto 1iguarcla il disaiTilo le limitazioni degli armamenti imposte agli sconfitti erano tali da non poter garantire neanche la loro sicurezza in tema, con l'aggravante della unilateralità, dato che le Potenze v incitrici si limitarono di fatto a promesse future di limitazione degli armamenti. Uno squilibrio di forze tanto evidente tra vincitori e vinti rendeva impossibile qualsiasi dialogo costruttivo ed impediva ogni collaborazione internazionale atta ad assicurare il mantenimento della pace 14

Le questioni teiTitoriali furono affrontate con una miopia politica cd una s uperficialità paragonabile, in tutto e per tutto, a quella riscontrata per le questioni eli carattere generale. Le soluzioni che furono adottate ebbero il potere eli scontentare sia i v inti che i vincitori. Non venne prestata alcuna attenzione alla difficile situazione italiana ed al disagio del Giappone. Furono trascurate le esigenze eli giustizia e ignorati i veri sentimenti delle popolazioni interessate pur di tiuscire a realizzare l'accerchiamento della Gem1ania e di non soddisfare le 1i.chieste italiane in merito a Fiume ed alla Dalmazia . Si erano creati, in maniera frettolosa, una serie eli Stati autonomj - si pensi al caso della Polonia e della Cecoslo-
14 In merit o cfr. Toscano, M., Le cause della Grande Guerra e i residui bellici del 1ì·a llato di Versaglia. in: Prob lemi storic i e orientamenti stor iografici, Como, 1942, pagg. l l 54- l l 56.
19
vacchia -guidati da governi provvisori privi di esperienza che per la loro debolezza politica non sarebbero mai stati in grado di reggersi da soli e che infatti, all'inizio della guerra. non speravano di ottenere altro che una certa autonomia. Solo in segu ito venne prospettata l'ipotesi indipendentista c si pensò di rafforzare le deboli entità stata! i mediante l'ampliamento delle superfici tenitoriali delle nascenti repubbliche. L'effetto ottenuto fu l'opposto di quello desiderato, le strutture risultarono indebolite dagli ampliamenti territoriali indiscriminati che causarono una serie di conflitti interni ed esterni difficilissimi da sanare 15

Il trattamento riservato alla Germania, ali 'U ngheria ed a ll 'e x Impero ottomano dimostrava, anche nelle questioni territoriali, una assoluta mancanza di chiaroveggenza politica, g li errori compiuti furono di una grav ità tal e da pregiudicare ogni possibilità di riuscita del nuo vo ordine europeo. Basti pensare al veto posto a li' Anschluss, alla creazione del corridoio di Danzica, ai brogli nei plebisciti in Slesia, al rifiuto eli tenere conto delle aspettative dei Sudeti, all'i n asprimento delle condizioni di pace con l ' Un gheria che avrebbe condotto all'annientamento dell'unità economica danubiana e carpatica, a ll a soppress ion e di qualsivoglia indipend enza dello Stato turco.
Gli accordi interalleati per la spartizione dell'Asia Minore meritano una analisi più approfondita, data la loro rilevanza nel1e decisioni italiane inerenti a ll a Transcaucasia. Il Foreign Office britannico aveva manifestato la propria intenzione di cambiare radicalmente gli accordi presi con l ' Italia in merito all'Asia Minore. imm ediatame nt e dopo l'abbandono del conflitto da parte della Ru ss ia , che aveva modificato radicalmente g li equilibri futuri di Costantinopoli. La mancata ratifica russa agli accordi di S. Giovanni di Moriana e ra so ltanto un intoppo tecnico sfr uttato da Francia e Inghilterra per manifestare la propria convinzione che fossero necessari nuovi accordi territoriali per la pace con gli ottomani che non disgustassero la Turchia. Per attuare il nece ssario ridimen sio namento del programma di spartizioni concordato dag li alleati, Clemenceau s i dichiarò disposto a rinunciare alla Siria pur eli a rrivare ad una pace con Costantinopoli ed anche Lloyd George s i
ts Lo stesso fenomeno si verificò a l momento della dete1minazione dei confini della Grecia e della Romania, le legittime rivcndicazioni indipendentiste furono tra sformate in programmi co lossali che non corrispondevano alle es igenze interne c che avrebbero fatalmente teso a ricostituirsi in modo da avvicinarsi maggiormente alla realtà. Toscano, M .. cit . pag. 1160 .
20
dichiarò disposto a rinunce territoriali. La vera esclusa però s arebbe stata l'Italia per la quale si prevedeva una revisione non solo degli accordi sopraccitati, ma anche del patto di Londra al quale tuttavia, era ancora attribuita validità, almeno da parte degli alleati.
Il governo italiano temeva, in modo particolare, i possibili acco rdi sotterranei tra Francia e lnghiltena per escludere l' Italia dalla spartizione cd inse(.liarsi come potenze dominanti nel Mediterraneo orientale che erano più che probabili , dati i precedenti 16 . Il ministero degli Esteri italiano aveva tentato di sfruttare l'antagonismo esistente tra inglesi e francesi per il controllo della regione, il Foreign Officc a sua volta si era s·ervito delle ambizioni italiane per controbilanciare l'influenza francese, eppure non bisogna dimenticare che, per entrambi gli Alleati, l'Ital ia era l'ultima arrivata che tentava di prendere posi zio ne scalzando le potenze tradi zionali. Il segretario del ministero degli Esteri , De Martino , proponeva di scavalcare ogni possibile accordo franco-britannico cambiando strategia diplomatica ed agendo direttamente su Wilson , che sarebbe cettamente intervenuto per dirimere le questioni riguardanti l'ex Impero ottomano, badando che il futuro stato turco non faces se le spese eli una spartizione incontro !lata clell' Anatolia . Wilson si sa rebbe s icuramente opposto ad una spartiz ione imperialistica dell'Anatolia; nel suo programma Sonnino tentò, dunque. eli non discostarsi dal principio wilsoniano eli proporzionalità delle acquisizioni, che avrebbe dovuto condurre - secondo il presidente americano - acl una pace democrat ica. L'idea del ministro era paradossalmente quella eli schierarsi nel campo degli antimperialisti per difendere gli interessi espansionistici italiani , p u r sapendo che sarebbe stato necessario fare de lle rinunce 17
16 Francia ed Inghilterra avevano agito senza informare Roma in più di una occasione. si pensi ad esempio agli accordi con la Russia s u Costantinopoli. che non erano stati resi noti al momento della firma del Patto di Londra ma solo successivamente; il precedente più temuto erano però gli accord i Sykes-Picot, de l 19 16. Gli accord i in questione, che prendevano il nome dai p lenipotenziari che ne furono gl i autori, avrebbero dovuto ridi scgna re i nuo vi confini derivanti dalla spartizione delle provincie orientali dello sconfitto impero ottomano. Secondo queg li accordi all'lnghilten·a sarebbe s pettato l ' Iraq, mentre la Francia avrebbe avuto la Siria. A protezione dei confin i caucas ic i de ll a Russia sarebbero stati creati alcuni Stati sate llite arabi. G l i alleati Russi furono avvisat i degli accordi so lo un mese dopo la stipu la. mentre gli alleati ita l iani non furono mai messi aJ corrente. Riccardi. L., cit. pagg. 608-609. l 7 Riccardi, L cit. pagg . ol 0-612.

2 1
Il 14 ottobre 1918, Balfour confennò all'incaricato di affari italiano a Londra , Borghese, che gli accordi di S. Giovanni di Mori ana non potevano più essere ritenuti validi, essendo venuto a mancare il consenso della Russia. In l'eccezione britannica non era basata semplic eme nt e su questioni di carattere giuridico bensì sui profondi cambiamenti politici che e rano intervenuti dopo il crollo dell'Impero zarista. La defezione russa, l'incerta attribuzione di Costantinopoli, l'ing resso della Grecia di Venizelos nel campo alleato e la ferma intenzione statunitense di intervenire nella questione turca rendevano inattuabile il precedente programma alleato per l'Asia Minore. Questa decisione- come aveva previsto lo s tesso Balfour- contribuì, insieme con la questione da lm ata e fiumana, ad aprire un lungo periodo di conflitto tra l'Italia c gli Alleati causato dall'insoddisfazione dell'opinione pubblica italiana per l'insuffici enza delle acquisi7.ioni successive a ll a prima guerra mondiale.
Jl trattato di Versailles e quelli successivi. come era facile aspettarsi, furono accolti molto male dai vinti. in particolare dalla Gennania, cui rimase l'impressione che i 14 punti fossero stati solo un tranello per obbligarla a deporre le armi. ma che fossero poi rim asti lettera morta. Più significativo il fatto che i trattati vennero critica ti, piLI o meno aspramente e per diversi motivi, anche nei paesi neutrali e furono ritenuti troppo severi persino dai vincitori. Lloyd George, che ini?ialmente aveva cri ti cato aspramente il conte nuto dei trattati, ebbe in seguito un ripensamento cd affermò che i problemi maggiori derivavano dalla mancata applicazione dei trattati stess i , che prevedevano oltre alle cessioni territoriali ed alle criticatissime clausole economiche 1!l, la creaz ione di organismi internazionali - quale la Società della Nazioni -e l'esecuzion e di una serie di atti - il disarmo, il pagamento delle riparazioni, i plebisciti, l'occupaL.ione della riva si ni stra del R e no , la fine del regime dei mandati - a scadenLa più o meno ravvicinata che non ven nero realiaati correttamente. Il Senato degli Stati Uniti rifiutò di ratificare il trattato, non a causa delle condizioni imposte ai v in ti, ma degli ob-
Ili Le clau-;ole economiche furono criticate in maniera" iolen1a da KC) il mo economista. che si era dimesso dalla delega7.ione proprio perché giudicava troppo severe le condizioni l'inant iarie imposte ag li sconlìtti. Tn uno dei libri: Le conseguen-;.e eronomiche della pace tentò di convi ncere l'opinione pubblica mondia le- ovc fosse ancora del trattato ste!>SO. Curato, F.. cit. vol. l. pag. 672.

22
blighi che g li Usa sarebbero stati costretti ad assume re per il mantenimento del nuovo ordine internazionale. Il partito repubblicano, contrario a Wil so n , cr iti cava in particolare l'articolo X de ll' atto costitutivo de lla Società delle Na zion i, c he impon eva ag li stati membri di risp ettare e proteggere da eventuali aggressioni esterne l'int eg rità territoriale di c ia sc uno dei fi rmat ar i, un s imile obbligo era considerato una minaccia alla sov r anità nazionale cd era in o ltre da re spi nge re il principio delr automati cità delle sa nLio ni nei confronti di uno stato co lp evo le un atto di aggressio ne 19 Do po una prima bocciatura. nel novembre del 1919, l'a rgomento tornò all'ordine del gio rno del Senato il 19 marzo dell920 e ancora una volta la maggioranza dei due terzi. necessaria per la ratifica del trattato, mancò pe r una manciata di voti - sette per la precisioneg li Stati Uniti non ade rirono dunque alla Società delle Nazioni e conclusero una pac e se p ara ta co n la Germania , s ig lata ne l lu g lio del 1921.
La s tampa mondiale era vmia mcnte schierata ma in og ni paese vi erano voci contrari e ai trattati. ln Spag na ad esemp io - paese neut rale -il giornale El So/lo definiva "un trattato di guerra .fwura''; in Francia il tra ttato. approvato dal Parlamento. era sostenuto da coloro che erano vicini al presidente Clcmcnccau e criticato sia dai con<;crvatori (mo narchi ci. cattolici ed una parte dci repubblicani) che dai socialisti. seppu re per motivi diametralmente opposti. l co nse rvatori crit icava no il trattato perché aveva ri spettato l'unità della Germania invece di speu.arla e perché la riva s inistra del Reno era rim as ta in mani tedesche; i socia li s ti al contrari o lo c riti cava no perch é non corris pondeva alle aspirazioni delle masse che avevano sperato ne ll'i stitu Lione di una Lega di popoli piuttosto che di governi, nella fine della dip lomazia segreta e nell'introduzione dell'arbiu·ato obbligatorio affinché quella appe na combattut a fosse l'ultima delle guerre. ln Italia il tranato fu asp ram e nt e criticato dai socia li sti. in accordo con qu e lli d'oltralpe. e dai ncutralisti -cui dava voce il quotid iano La Srampa:
Do veva essere la guerra c he av r ebbe ucci so l a g uerra; e il Tr att ato eli pace che la co nchiude lasc ia l'Europa in ag ita z i o ni . in sco nvolgimenti. in l otte. Nessun problema nazionale europeo è ri so lto , perché tutti i problemi naLionali so no sta ti vio l ati nell'interesse supremo dell'egemonia anglo-franca .-<!0
19 Joncs. M. A .. Storia degli Swti Uniti. Dalle prime colonie ingle!Ji ai giorni nostri. Mil ano. Bompiani. 198-l, pagg. 3X7-389.
· 20 Art icolo pubblicato s ul 4uotidiano " La Stampa" in data 29-30 giug no 1919, intitolato Sulla sahh ia . Cfr. Curato. F.. ci t. vol. l , pag. 683.

23
Di diverso parere il partito nazionalista. fascista e liberai-nazionale che riten eva no positivi i risultati raggiunti con il co nflitto. L'Ideo Nazionale - organo del partito na z ionali sta - non aveva nulla da ridire s ulle condizioni imposte ai vinti. lamentando solo la mancata rcali.u:azionc delle aspiraLioni nazionali italiane: li Corriere della Sera che era il più accani to difensore del programma wilsoniano. era convinto che lo scopo principale della guerra, l'annientamento del pangcrmanismo. fosse stato raggiunto c che l ' I talia, pur non avendo ancora visto realizzate le proprie aspira7..ioni nazionali, avrebbe tratto dalla fine dell'oppressione tedesca i mede imi benefici della Francia. dell'Inghilterra e del Belgio. La lettura dei documenti diplomatici. economici. politici redatti d agi i esperti che parteciparono alla stesura dei tratt a ti. ha inge n erato in molti s tudio si la convinzione che il fallimento della Conferenza della pace sia da imputare al grave stato di impreparazione, alla s upe rlì cia l ità ed all'approssimazione con cu i g li esperti ed i plcnipotenà.u-i affrontarono i problemi che s i presentarono alla fine de lla guerra. Essi. guidati dal senso di rivalsa e privi di una visione politica e strategica non riuscirono a dipanare la matassa intricata delle nazionalità e delle etnie in maniera tale da ricostituire un equilibrio euro peo duraturo21
2. La posizione italiana
La delegazione italiana alla Conferenza di Parigi era composta da cinque plenipotenziari: a capo de ll a delega z ion e c'era il presiden te del co nsig l io Vittorio Emanuele Or lando accompagnato da l mini s tro degli Esteri Sonnino. dal deputato Sa l vatore Barzi lai, da ll 'ex pre side nte del consiglio Salandra e dall'ex ambasciatore a Pari gi Giu sep p e Salvago R aggi. Si trartava di stat is ti c di uomi ni politi c i che con il loro operato avevano contribuito a ll' entrata in guerra dell' Ita l ia ed al prosieguo della lotta dopo la sco nfitt a di Caporetto c che desideravano , pa rtec ipando alla co nfe renza , assic ur a re al proprio paese tutti i vantaggi c h e fosse stato possibile ottenere. Ai ve rti ci politici si agg iun gevano i ve rtici delle forLe armate. che si dedicar ono i n partico lar modo a ll a s istemazione delle que s tioni territoria li . A P arigi e ra presente l a Sezione Milita r e de ll a delegazione ita li ana per l a pace, guidata da l gene rale Cavallero, ma a nche il c ap o eli Stato Ma gg io re de li 'eserc ito ge neral e

21
24
Biagini. A Romanc lli. G cit. , pag. XV!l
Diaz seguiti da delegati tecnici cd esperti diplomatici e militari. Il mini stro Tomasi Della To rretta elabo rò il punto di v ista italian o s u lla sistemazione delle questioni russe e polacche; il consigliere Vannutelli Rey s i concentrò sulle questioni danubiane; le questioni balcaniche furono curate dal conso le Stranieri e dal colonnello Fortunato Castoldi22 Gli es pe rti tec ni c i avevano come referenti il ministro Sonnino oppure il segretario della Consulta, Giacomo D e M artino.
Le rivcndicazioni territoriali italiane si basavan o . dunque, sul pa tto di Londra del 191 5 - siglato in segreto con Francia ed In g hilterra - che però non impegnava l'associata americana c sug li accordi di S. Giovanni di Mori ana la c ui va lidità era. alla fine del conflitto, ne gata da tutti g li alleati Le motivazioni sottese a ll e ac qui s iz ioni territoriali era no di carattere etnico , geografico e strategico ; i nuovi confini ita li ani disegnati dal patto di Londra vennero in p:ute ritenuti confom1i ai principi espressi dai 14 punti dì Wil son e dunque accetta ti anche dagli Stati Uniti, ma le rivendicazioni s ulla cos ta dalmata c la successiva richi esta eli annessione della c ittà eli Fiume- non inclusa ne l patto- ve nnero violentemente avversate dal presidente america no . Già dal ge nnaio del 1919, il presidente sta tunitense aveva dato chiaramente ad intendere di tifiutare qualsiasi trattativa basa ta s ul p a tto eli Londra- sti pulato prima dell ' in g re sso degli USA ne l conflitto - e eli aver s tudi ato. per l'Italia, una linea eli confine alte rnativa , la cosiddetta "linea Wil s on" che riconosceva all'Italia l ' annessione del Trentine e dell 'A lto Adige e ricostituiva a se ttentrione il confine natural e delle Alpi, la migliore frontiera s trategica po ssi bileche era sta ta in prece de n za neg ata all' Italia dall ' Au s tria- mentre acl oriente comprendeva solo Trie s te. Gorizia e l ' l st ria occidentale23

Orlando e Sonnino s i trovarono davanti alla difficile scelta di pretendere l ' appl icazìone del patto eli Londr a - per il quale avevano la completa adesione degli alleati britannici e francesi - e rinunciare però a Fiume; oppure avviare un negoziato basandos i s ui dettami wi lsoniani tentando d i ottenere Fiume anche a costo eli consistenti rinunce in territorio dalmata. La questione italiana , comunque, non venne affrontata organicamente prima eli febbraio 24 , quando il presidente del consiglio italiano presentò un primo memorandum alla conferenza che può essere rias s unto con la nota fonnula del "patto di Londra più Fiume" .
22 Caccamo, F.. cit., pagg. 37-38.
23 Curato , F.. c it. vol. Il , pag. 59.
24 La data prec isa di prese ntazi o ne del me morandum è l o febbraio 1919.
25
l plcnipotenziari italiani erano consapevoli sin da quel momento della necessità di operare delle rinunce. Gli alleati c l'associata americana non avevano ra ggiunto alcun accordo circa la questione italiana e i contatti diplomatici, che si svo lgevano febbri l i . avevano evidenziato un totale disaccordo. Wil so n si era detto , fin dal principio, assolutamente contrario alle acquisizioni italiane in Dalm az ia ed alla annessione di Fiume; Lloyd Georgc aveva dichiarato in più occasioni di voler tenere fede al patto di Londra che lasciava la città di Fiume alla Croazia - o meglio al neonato regno serbo-croato-s loveno. che l'Italia non aveva alcuna intent.ionc di riconoscere dato che considerava croati e sloveni ancora come nemici; Clemenceau. invece, era possibilista riguardo a Fiume qualora gli italiani avessero acconsentito a rinunce sig nificative. La situazione era quanto mai intricata c il disaccordo che spesso si manifestava tra Orlando cd il suo ministro degli Esteri non sem plificava la situazione. L'errore più grave del memorandum itali ano25 - tenuto segreto fino al 12 marzo - fu quello di basare la maggior parte delle richieste su motivaL.ioni da carattere strategico. invise a Wilson che riteneva che, dopo la creazione della Società delle Nazioni, tali rivendicazioni non avrebbero avuto più alcuna ragione di esistere, dato che le controversie internazionali sarebbero state risolte pac ifi camente in seno alla Società.
Sonnino, in particolare, in s istette sempre sull'importanza st rate gica sia del confine delle Alpi s ia della costa e delle isole dalmate, per gara ntire il controllo italiano su ll'Adriatico. Secondo i l ministro. se nza il cont rollo della sponda dalmata. l'Italia sarebbe stata sempre soggetta a possibili attacchi provenienti da oricntc 26 . Si ribadivano insomma quei moventi stra tegici che il presidente Wilson si rifiutava di prende-
25 Il memorandum. benchè comunemente attribuito a Salvatore BarLilai. era in rea ltà stato stilato da uno dci consiglieri giuridici della dclcga7ione italiana, Francesco Salata. il documento cru molto preciso c dettagliato ma non era privo di difetti. Era troppo lungo , troppo basato su motivazioni di carattere st rate gico, trascurava completamente l'Albani a. le rivenclicaLioni nel M editerraneo non erano neppure accennate c neppure quelle nelle Colonie. Curato. F., cit. vol. li pag. 6-l.

26 Per quanto riguarda l"occupaLionc della costa dalmata e delle i!>olc si manifestarono dci forti contrasti anche nelle alte sfere militari, lo Stato Maggiore della marina. appoggiato da Sonnino. le riteneva indispensabili. mentre !"esercito sosteneva che per difendere tali basi sarehhe '\lato necessario fino ad un tcr7o degli uomini
Salandra, A.,/ Retroscena di Versailles. a cura di G.l3. Gifuni. Milano. 197 l , pag. 9.
26
re in considerazione. Il criterio delle linee di nazionalità, sul quale si basavano le proposte wilsoniane, era ritenuto da Sonnino assolutamente insufficiente a garantire la sicurezza italiana. Il ministro de g li Esteri era sem pre stato un fautore dell'applicazione integrale del patto di Londra - alla cui stesura aveva personalmente partecipato - egli infatti, non aveva mai voluto Iischiare di compromettere il governo italiano avanzando pretese , come quelle per l'annessione di Fiume, che fossero esterne al patto. Difendeva le proprie opinioni con le ragioni militari di cui sopra ed era appoggiato in questo dal capo di stato maggiore della marina ammiraglio Thaon di Rcvcl.

Orlando c Sonnino avevano due concezioni assolutamente antitetiche circa la sol uzione della questione adriatica ed anche circa il metodo di agire per realiz zarla. Orlando , che aveva fatto proprio il principio dì nazionalità come ispiratore della pace , avrebbe voluto in più occasioni dare comunicazione agli alleati delle richieste di annessione all'Italia provenienti dal Consiglio Nazionale di Fiume 27 Sonnino, che era intenzionato a basare le proprie rivcndicazioni esclusivamente sul Patto di Londra, negò sempre l 'opportu nità di tale scelta, rimandando il momento della presentazione delle rìvendicazioni italiane ed i l conseguente scontro con Wilson. Le posizioni di Orlando erano nella sostanza molto più v icine a quelle del presidente Wilson, rispetto agli altri capi eli governo, ma questo non fu sufficiente ad evitare lo scontro.
L a delegazione italiana giunse a ll a conferenza di Versailles senza una lin ea comune c senza a lcun accordo con g li Stati Uniti. L'opinione pubblica italiana era diventata semp re più esigente e si aspettava che i
27 Un episodio è uti le per chiar ire l 'opposto atteggiamento di Orlando e Son n ino. Il 7 novembre 1918. l'ambascia tore italiano a Parigi, Bonin Longare, te legrafò a Sonnino domandandogli la sua opin ione in merito alla possibil e partecipazion e ad un incontro organizzato a Parigi dalla Società italiana irredenta. al quale av rebbe partecipato il deputato Zanella di Fiume che certamente avrebbe rivendicato l 'annessione della sua cit tà a ll'It a li a. Sonnino "consiglia " all'ambasciatore eli astenersi dalla partecipazione per non compromettere il Regio governo.ll 13 novembre, appena 4 giorni dopo lo scambio di telegrammi tra Sonnino e l'ambasciato re, Orlando, che aveva ri cevuto la visita d i un de legato di Fiume che gli aveva consegnato la delibera della c ittà di Fiume di unirsi a ll a Madre Patria, scrive a Bo nin Longare eli effettuare la comunicazion e a l colonne llo House - fiduc iar io perso nale di Wilson- "Poiché è fuori di dubl>io la perfetta ilalianità di Fiume ... Sonnino si oppose c riuscì a fermare in tempo la comunicazione, ma gli episodi de llo stesso genere furono molli. Cfr. Mosca, R., cit .. in Pastorelli , P. , La politica estera italiana dal 191 4 al 1943. Torino, E .R.I.. 1963, pagg. 59-6 1
27
delegati ottenesse ro il risultato migliore possibile cioè "i l P atto di Lo n dra più Fiume" c he realisticame nte appa ri va co m e la so luzion e me no probabile. Fran c i a c I ng hilterra non potev a n o rifiutare rappli ca.lionc del patto di Londra ma erano unanimi nel rifiutar si di assegnare Fiume all'ltalia. La posi z ione di Wilson si irri g idì a poco a poco e l a sua intr ansigenza s i manifestò in maniera inequivocab il e dopo la defini z ione di tutte le clau so le da pre se ntare alla G e rmania.
Il 4 aprile, come ri su lt a da un telegramma di Orlando al Re. s icc ome il la voro s i era fermato in attesa delle re lazio ni d i alcune commisioni tec niche 'fu improl'\ 'isamente proposto di delibe rare sulle questioni italiane" 28 . Il dibattito non pote va avve nire in co ndizioni pegg iori. Llo y d Gcorge propos e c he fos se ro ascolta! i a n c he i rappre se ntanti jugoslavi. Orlando non s i oppose ma es presse la s ua intenzione di non partecipare all ' audi z ione, dato che non pot eva accettare il contr addittorio con un nemi co. J d e legati jugoslav i . non rimasero inattivi e co n seg narono agli esperti americani un memorandum , indiri zza to al presidente statunitense. n e l qual e s i soste n eva la necessità di dare Fiume a lla na sce nte federazione jugoslava c s i chiedeva. qualora fosse n ecessario a ttribuirl e lo sta tu s di città lib era. di salvagu ardare gli inte ress i dello Stato serbo-croato-slove no. appellandosi a Wil so n p er ottenere le necess ari e ga ra n z ie 29 Il rifiuto italian o d i intervenire all'inco ntro con i rappre se ntanti jugos lavi tolse a ll a riunione il carattere di ufficialità che avrebbe avuro una sed uta del Con s ig lio dci Quattro e l a trasformò in una riuni one privata.
L e consultazioni tra g li italiani c gli alleati co ntinuarono in forma privata. Il 14 aprile. in un co lloquio tra Orland o c Wilson. il presidente americano co n seg n ò a Orlando un memorandum rela ti vo a ll a s is te maz ion e della qu estione a dri at ica, in merito al qu a le il primo mini stro italiano espresse l a s u a più ferma contrarietà , rifiutandosi di pro segu ire i negoz iati su tale bas e 30 Il memorandum era il primo documento uffic iale nel quale Wil so n enunciava alla delega z ione ita li ana la propria posizione sui confini a nord, che venivano accettati in conformità al patto di Londra , m e ntre per quanto concerneva i co n f ini orientali, l 'opinione di Wil so n era c h e la lin ea fissata dal patto no n fosse più appli-
28 Mosca. R cit in Pa!;torelli. P La politica estera italiana dal /914 al 1943. Torino. E.R.l.. 1963 . pag. 68.
29 Cu rato. F.. ci t. vol. Il , pag.
3°Cfr. L.. Guerra diplomatica. Mil ano. 1936, pag. 215.

28
cabile. Egli proponeva che Fiume godesse di una notevole autonomia, indispensabile per compiere la propria funzione di porto internazionale per servire i nuovi Stati che si sare bbero formati dalla di ssoluzio ne dell ' impero austro-ungmico. I rapporti con questi nuovi stati, che non avevano più nulla a che vedere con l'Austria-Ungheria, sarebbero stati regolati per mezzo della nascente Società delle Nazioni 31 . La soluzione di compromesso, che anche Orlando sperava di raggiungere, risultava dunque impossibile dal momento che Fiume non era negoziabile oramai né per gh italiani che ne reclamavano l'annessione né per gli alleati che la rifiutavano.
La questione adriatica venne nuovamente abbandonata per completare le clausole da presen tare alla Germania c quando fu ripresa l ' Italia si ritrovò, se possibile, ancora più isolata , mentre gli alleati avevano una libertà di movimento molto maggiore. L'unica possibilità di fare pre sa su europei e americani contemporaneamente era il rifiuto italiano di firmare il trattato di pace con l a G ermania prima della definizione delle proprie questioni.
La discussione fu ripresa il 19 aprile con una esposizione dettagliata di Orlando delle richieste italiane, basate ora sul principio di nazionalità, ora su moti vi economici e strategici, evitando di proposito di appellarsi al patto di Londra, cui gli Stati Uniti non erano obbligati, per non indispettire il presidente Wil son.

Le richie s te italiane possono rias s umersi in tre punti principali: 1. il displuvio delle Alpi che costituiva la frontiera naturale dell'Italia , compresa l ' Istria che formava con la madre patria un unìcum e che sarebbe servita come baluardo per la difesa di Trieste; 2. annessione di Fiume: le ragioni per l 'a nnessione erano storiche - dato che il lìmes italicuJ dei romani arrivava fino al Monte Nevoso includendo Fiumee basate s ulla autodeterminazione dei popoli - data la richiesta di annessione avanzata dalla città di Fiume; 3. Dalmazia e isole: la prima motivazione era di ordine strategico ma la seconda era anch'essa di carattere storico visto che la Dalmazia era sempre stata legata ali' Italia , prima con i romani e poi con la Repubblica di Venezia fino a Campoformio32. Wilson fu irremovibile mentre Lloyd George e Clemenceau- dopo aver ribadito di essere intenzionati a tenere fede al patto di
31 Cfr. il te s to completo del Memorandum di Wilson in Salandra. A., l R etroscena di Versai/le.\. a c ura eli G .B. Gifuni. Milano, 1971, pagg. 143-145. 32 Aldrovandi-Marescotti, L.. Guerra diplomatica. Milano, l 936. pa gg. 221-230.
29
Londra - tentarono, nei giorni immediatamente successivi, di operare una mediazione per scongiurare la partenza della delegazione italiana da Pari gi.
Mentre. il 2 1 e 22 aprile, fervevano gli incontri tra gli alleati e si scambiavano proposte e controproposte. il presidente americano - non tenendo fede agli impegni presi con Lloyd George- fece pubblicare il 23 aprile sul Temps un manifesto nel quale si rivolgeva direttamente al popolo italiano, esortandolo a fare la pace segue ndo i principi indicati dal popolo americano per meuo dei 14 punti cd esautorando. di fatto, i rappresentanti del Re gio Governo. contrapponendo il loro operato alla volontà del Paese 33 Il manifesto, che era stato dato a ll e stampe senza consultare né gli In glesi né i Francesi, provocò un ge n erale moto di indignazione nell'opinione pubblica europea ed ebbe come immediata conseguenza la partenza della delegazione italiana, che lasciò Parigi pur sapendo che - qualora i de legati fossero stati assenti alla presentazione delle condiz ioni di pace alla Germania - le rivendicaLioni italiane non sa rebbero state prese in considcra7ionc. Orlando scrisse una lettera al presidente della conferenza Clcmcnceau nella quale annunciava il proprio ritiro, giustif icandolo con la necessità di consultare il Parlam ento cd avere la conferma della fiducia del popolo ital ia no verso il proprio operato. Ll oyd George tentò nuovamente la carta della conciliazione. temendo i disordini che potevano sc oppiare in Italia alla notizia della partenza della de legazione italiana o peggio della rottura tra l'Italia e gli Stati Uniti. Orlando acconsentì ad un ultimo tentativo
:n Nel suo mani resto Wilson ribadisce l'estraneità americana al pallo di Londra, sottolinea come la s ituazione europea sia profondamente mutata con la fine dell' Impero austro-ungarico. dal cui crollo na-;ccranno una serie di nuo\'i Stati indipendenti. che entreran no a far pane della Società delle patto di Londra non ha più ragione di e!>sere c quindi la pac e con questi nuovi stat i deve stilata in ba'>e agli stessi principi su cui si basa quella con la Germania.ln merito a Fiume Wil so n sp ie ga che assegnare un porto tanto impOJt<Jnte per l 'Ungheria. la Romania e la na!>eentc Jugoslavia all'Italia. sarebbe equivalso a co nsegnar lo ad una dominazione straniera ed avrebbe costituito un ostacolo alla co, truzione di una pace duratura. Le ragioni strategiche invocate per il possesso della costa dalmata erano egualme n te dato che le sarebbe ro tu !le risolte dalla Società delle Il compito dell'Italia alle altre grandi potenLe. era quello di agire con la magnanimità delle grandi potcnLe nei confronti degli Stati nascenti . in modo da tra s formare in amic i i popoli dell'altra s ponda dell'Adriatico. L'America che ha legami fortissimi, anche di con l 'Italia la esortava ad agire :,econclo i plincipi per i quali anche l'America :,i era balluta. Cfr. Curato, F.. cit vol.ll. pagg. 228-230.

30
di conciliazione da effettuarsi entro il pomeriggio. La riunione si tenne alle 16 presso Lloyd George e s ervì a chiarire che il primo ministro italiano, rientrando a Roma, non intendeva rompere i rapporti con gli alleati e con l 'associata ma solo consullare il Parlamento per s apere quale fosse la propria autorità alla Conferenza:

"Non sono sicuro. dopo quanto è a v venuto, se ho il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi cosa" 34
Orlando lasciò Parigi la sera del 24 aprile, s eguito il giorno seguente da Sonnino che par1ì senza incontrare nessuno dei rappresentanti delle altre nazioni scontente dell'andamento della conferenza- il Giappone per la questione dello Sciantung, la Grecia per la que s tione dell'Asia Minore e il Belgio per Malmédy e per le riparazioni - che avevano chiesto di vederlo. Se il ministro fosse stato meno intran s igente probabilmente s i s arebbe potuto dar voce al gruppo di "malcontenti'' e fare maggiore press ione sui Tre, minacciando di lasciare tutti insieme ParigL Crespi riporta nel s uo diario che Sonnino , alle pressioni che gli venivano da più parti per incontrarsi con gli ambasciatori dei succitati paesi , rispose adirato che egli non avrebbe fatto porcherie cd incaricò Alclrovandi , presente a quel colloquio insieme a Crespi, di comunicare la propria indisponibilità ad incontrarsi con chicchessia 35 .
Orlando convocò il Parlamento il 29 aprile cd il suo Gabinetto ottenne la riconferma della fiducia con una maggioranza schiacciante382 voti favorevoli alla Camera e solo 40 contrari; 191 favorevoli su 191 presenti a l Senato - sarebbe stato auspicabile, dunque, che la delegazione italiana rientrasse immediatamente a Parigi , invece Orlando e Sonnino rimasero a Roma con il proposito di farsi invitare dagli altri alleati e eli poter porre delle condizioni per accettare l'invito. Le ìnsistenze di Crespi, che vedeva la situazione complicarsi a causa della loro assenza , rimasero inascoltate. L'assenza prolungata oltre il 30 aprile si rivelò un errore dì enormi proporzioni. L'Italia, il 2 maggio , dopo il fallimento di un tentativo di mediazione francese per Fiume, fu messa eli fronte all'aut aut. Se la delegazione non avesse fatto ritorno a Parigi immediatamente, non sarebbe stata menzionata nelle clausole eli pace che sarebbero state sottoposte ai tedeschi ed inoltre Lloycl George fece sapere che l ' assenza della delegazione italiana avrebbe fatto automati-
31
3 4 Aldrovandi-Marcscotti. L., cit. , pag. 268. · ' 5 Curato, F. , l'it. vol. II, pagg. 249-250.
camente decadere il patto di Londra. La colpa sarebbe stata attribuita all'Italia che con il proprio comportamento non avrebbe rispettato la clauso la di non sig lare trallati di pace separata. Il 7 maggio gli italiani tornarono a Parigi a prendere parte ai lavori della Conferenza. appe n a in tempo per presenziare alla cerimonia di consegna del trattato di pace a lla Germania e per evitare che il patto di Londra f osse d ichiarato decaduto. La loro assenza aveva provocato solo danni: in particolare, le decisioni prese in merito all'Asia Minore, questione affrontata ex novo dopo il 24 aprile, furono sfavorevo li per l'Italia c non l'u possibile contestarle a po steriori.
Consegnate le condizioni di pace alla Germania, Wilson c Lloyd Georgc- come temevano i delegati italiani - avevano fretta di lasciare Pari gi, li tratteneva ancora so lo l a necessità di sape re se i plcnipotenziari tedeschi avrebbero accettato le proposte. Quindi, come previsto, dedicarono alla preparazione del trattato con l'Austria solo i ritagli di tempo; furono prese a modello le condizio ni già proposte alla Germania, salvo le attenuazioni suggerite dal caso specifico: i l crollo dell'Impero austro-ungarico e la volontà di non i nuovi Stati che si stavano formando dal suo smembramento. Il trattato da presentare ali' Austria venne ultimato in meno di run mese c presentato ai de legati austriaci i l 2 g iu gno. Lo stesso giorno venne presentata, all'ultimo momento, anche la clausola che assegnava a ll'It alia la linea delle Alpi c la frontiera de l Brennero, che aveva rischiato fino alla fine di rim a nere in sospeso.
In Itali a, intanto, crescevano le preoccupazioni per una possibile crisi parlam e ntare causata dall ' in so ddi sfaz ione per il modo in cui Orlando e Sonnino avevano condotto le trattative durante la conferenza della pace. Oltre all'insuccesso diplomatico pesava, come si riscontra dal diario di Salandra. l a possibilità che scoppiassero de i moti nel Paese. Fino dalla metà d i maggio si rincorrevano le voc i sulla imminente fine de l Gabinetto Orland o e si scate nava una ridda di ipot es i s ulla possibile success ionc 36 . [l gove rno Orlando andò in crisi pe r una que-
36 Le ipotc!'>i della prima ora riguardavano innanzi tutto un secondo Gabincllo Orlando con la del !->olo Sonnino. altre voci davano per possibile un gmemo di transiLionc Lunatti-Titloni-Ciuffelli che il paese alle elezioni. ma da più parti veniva già fatto il nome di Nilli, appoggiato dai socia li sti ed inviso ai nazionali sti. I capi na 7iona li st i, tra i qua l i Corrad ini e Federzon i preparavano comu nqu e una campagna stampa molto se rrat a che portasse il governo Or lando a ll a cris i Cfr. Salandra. A .. ci/., pagg. 133-135.

32
stione di carattere procedurale e venne sostituito da un Gabinetto Nitti-Tittoni che prese il potere il22 giugno 1919.
3. Il Consiglio Supremo di Guerra - Sezione Militare e le questioni coloniali
La Sezione Militare del Consiglio Supremo che aveva sede a Versailles svolse un ruolo di grande rilievo per l ' Italia, in particolare per quanto concerneva le questioni coloniali. I rappresentanti militari assegnati alla commissione erano: per la Francia il generale Bel in, per la Gran Bretagna il maggior generale Sackville-West, per l'Italia il generale di Robilante per gli Stati Uniti il generale Bliss . La commissione era integrata da membri che partecipavano a titolo consultivo: per la Francia il comandante Lacombe, per l'Inghilterra il brigadiere generale Thomson , per l 'Italia il generale Cavallero e il colonnello Businelli , per gli Stati Uniti il generale Lochridge 37

La questione del possibile affidamento all'Italia della Transcaucasia fu discussa ed approvata in quella sede. durante la 53° seduta della commissione, che ebbe luogo il4 c 5 febbraio 1919. L'argomento principale di quella riunione fu l a necessità di stabilire dei mandati provvisori sui territ01i del! 'ex Impero Ottomano. Il compito di deliberare sull'argomento era stato affidato ai rappresentanti militari dal Consiglio Supremo Alleato durante la riunione del 30 gennaio 1919. Essi avrebbero dovuto indicare nel dettaglio le forze necessarie per mantenere l'ordine nei terIitori occupati e il modo migliore di suddividere tali forze tra g li alleati. Durante la riunione del 30 gennaio. Lloyd George si era dichiarato contrario all'ipotesi , ventilata nelle riunioni precedenti, di mantenere lo status quo nei territor i occupati, in Africa e nella Turchi a asiatica, fino alla definizione di mandati definitivi. Egli ribadì che l ' In gh ilterra, che manteneva in Turchia un contingente di 1.084.000 uomini, non aveva intenzione di chiedere il mandato, né in via provvisoria né definitiva, su gran parte dei territori attua lm ente occupati , in particolar modo su Siria , Caucaso 38 e Kurdistan nonostante i ricchi giacimenti
37 Cfr. il resoconto della 53° seduta del 4 febbraio in AUS SME Fondo E8, R.S, Fase. 3.
38 ln merito a ll a si tuazione delle truppe britanniche in Caucaso cfr. il lu strazione l a pag. 34, in AUS SME Fondo ES. R. 91, Fase. l l.
33
petroliferi. Il primo ministro britannico propose di affidare qualche mandato agli Stati Uniti, che non avendo combattuto in Turchia non avrebbero avuto difficoltà con la popolazione. Il presidente statunitene rifiutò di assumere re ponsabilità in Asia. adducendo come motivaLio n e una imprepara;ione dell'opinione pubblica ame ri cana al mantenimento di truppe in quel quadrante. Da que s ta divergenza di opinioni nacque la necessità di interpellare g li esperti militHri.
Gli esper ti militari procedettero, per prima cosa, alla definizione delle questioni preliminari; d'accordo co n il Consig li o Supremo ve nn e sta bilito che: L. non ci sa rebbero state occupa;r,ioni interalleate nella Turchia asiatica; 2. la conferenza avrebbe preso in considerazione solo i territori attualmente occupati a meno c h e non fos c espressamente richiesto dai rappresentanti militari.

Il generale Belin che presiedeva la seduta, procedendo dal verbale della seduta dei Big Four del 30 gennaio, pre e nota della vo lont à ing le se di ritirare le proprie truppe dalla Siria. dalla Tran scaucasia e dal Kurdi s tan , che non era più in grado di gest ire a causa degli impegni supp le mentari nel quadrante africano. L'eserc it o britannico avrebbe mantenuto il mandato provvisorio sul la Mesopotamia che . per escluione, l' I nghilterra se mbrava voler accettare. Si trattava, dunque. di uddividcre gli altri territori tra la Francia. l'Italia e gli Stati Uniti 39
• 19 Resoconto della 53° sed uta del 4 febbraio in AUS SME Fondo E8, R.5. Fa se. 3, pag.5.
Dislocazione delle tmppe nel Caucaso al 21 maggio del 1919.
34
Per quanto riguarda la posiLione americana il generale Bliss sottoli n eava che ogni decisione in merito all'invio delle truppe non sarebbe spettata al presidente Wilson, come egli stesso avevn espresso nella seduta del 30 gennaio. bensì a l Governo americano. Ogni proposta, dunque, av rebbe dovuto essere sottoposta a l Cong r esso prima di poter p re n dere una qua l siasi decisione.
Il rappresentante ita l iano, considerata la pos izione americana, prop ose eli elaborare due piani di spartizione differenti uno che comprendcs e gli Stati Uniti c il secondo che prendesse in considerazione solo g l i altri alleati. La proposta venne bocc iata dal rappresentante americano che riteneva più importante stabilire il numero di divisioni necessarie a mantenere l'ordine nelle regioni in questione che avrebbero pot u to essere suddivise, in un secondo momento. tra i Quattro Grandi oppure so lo tra I nghi lter ra, F ra n cia e lt a li a. Il rapp resenta n te francese, a l contrario, pensava che fosse più importante stabilire le zone di influenza e lasciare libera ogni singola potenza di dccielcrc il numero eli effettivi necessari per mantcnervi l'ordine. Il generale Sackville-West suggerì di basare le va l utaLioni, in merito a l le truppe necessarie, sugli studi compiuti dall'esercito bri t annico. durante i quattro anni eli occupazione della Turchia asiatica.

Sulla base eli queste differenti opinioni. il generale di R obi l ant, prese n tò u n pi a n o nel qua le gli obiett i vi principali da raggiungere furono r iass un t i i n q u attro punti:
l . impedire la ripresa de lle osti l ità da parte dclresercito Ottomano;
2. mantenere l'ordine pubblico c impedire la penetra7ionc del bolscevismo;
3. mettere un freno ai connitt i rauiali ed alle incursioni delle tribù indipendenti:
-L avere forze armate per opporsi alle aggressioni che avrebbero pot u to provenire dali· este rn o 4o.
Per qu a nto rig u a rdava i te rrit o ri int e ress ati da ll e occ u paz ioni , g li esperti mi li tari conclusero che, pe r ass ic u rare la pace a ll ' in te rn o e garanti re le zo n e occupate da attacchi este rn i, sarebbe sta to necessario procedere all'occupazione anche dci territori limitrofi. L'occupazione
35
40 Resoconto della seduta del -l febbraio in AUS Fondo E8. R.S, Fase. 3. png.R.
di este n sio ni maggiori di terr it orio avre bb e diminuito il numero di effettivi n ecessari per il mantenimento dell'ordine, invece di aumentarli a patto di prendere tutte le misure n ecessarie: 1. smob ilitare le truppe turc he e occupare tutti i magazzini e le fabbriche di a rmi e muni z ioni ; 2 . pre ndere il cont ro ll o de ll e ferrovie; 3. rico s tituire le ge ndarmerie co n eleme nti indigeni co mandati da ufficiali e urop e i ; 4. affidare il se rv i:lio di polizia nei porti a ll e marine alleate; 5. occ upare tutti gli obi e ttivi strategici.

Qualora fossero state effe tti vame nte rispettate tutte queste mi sure preventive, l e possibilità che i Turchi riprendes ero le os tilità sarebbero state pressoché nul le c gli effett ivi necessar i s arebbero s tati circa 60.000 uomini e 3-4.000 ufficia li alleati. L e truppe in questo caso av re bb e ro av uto la funzione di coad iuvare le ge ndarm e rie nel mantenim e nto dell ' ordine inte rn o e eli difendere i te rri to ri da loro controllati da pos s ibili attacchi provenienti dall'estern o, in parti co lare lungo l a frontiera ru ssa e p ersiana. Le divisioni avrebbero dovuto esse re organi zzate in modo da avere il massimo della potenza con il minimo di uomini, inoltre. avrebbero dovuto essere di s locate lungo le coste. i porti e le fe rro vie per ottenere la massima mobilità.
Il pi a no italiano av r ebbe avuto bi sog n o di c irca tre o quattro mesi per e ntrare in vigore c il num e ro degli effe ttivi s i sa r eb b e potuto prog r ess ivamente diminuire O g ni potenza, una volta effe ttuata la ripartiz ione territoriale , avrebbe potuto organiz za re il se rvi z io di polizia a ll'interno della propria zo na, a suo piacimento. TI primo punto da definire secon do il rappresentante italiano era la s uddivi s ione dci territori . ogni potenza assegnataria poi sare bb e s t ata lib era di occupar] i con il num ero di effettiv i che av r ebbe ritenuto n ecessa ri o. La riparti zione in L.O n e rende va. in o ltre. inut il e la nomina di un comandante in ca p o com un e a tutte le forLe, dato che esse sarebbero state co mpletament e au tonomc 41
l rapprese ntanti militari co nco rdarono , al te rmin e della discussione preliminare, s ulla necessità di procedere per prima cos a alla ripartizione d e lle zone evacuate da ll e truppe britannich e- da c ontrollare iniz ialmente tramite le lo ca li fo rte di polizia. po s te so tto il co ntrollo dei coma ndi alleati, seguendo l'esempio del Comando bri t an ni co a Cos tantinopoli - per poter poi procedere a lla defini zio ne de ll e forze nec essar ie
Resoconto della 53° seduta del 4 febbraio in AUS SM E Fondo E8 . R. 5, Fase. 3, pugg. 9- 11.
36
alloro controllo, tralasciando per il momento l'occupazione dei renitori limitrofi 42
l territori occupati erano: 1. la Mesopotamia ed una parte del Kurdistan, il Caucaso ed il nord della Persia, da truppe britanniche; 2. la Siria, occupata da una divisione britannica e da elementi francesi. Le truppe britanniche stavano per ritirarsi dalla Siria, dal Caucaso e dal Kurdistan, come annunciato in precedenza da Lloyd Gcorgc.
La Francia avrebbe sostituito gli inglesi in Siria ma, per quel che concerneva la Palestina - che i britannici non avrebbero abbandonatoc'era bisogno eli una attenta delimitazione geografica tra la zona francese e inglese. l francesi reputavano che la Palestina fosse compresa nella Siria c chiedevano il controllo di entrambe le zone, mentre il generale britannko Sackville-West proponeva che la prute nord della Palestina fosse affidata al Regno Arabo 43 che, secondo le stime britanniche, sarebbe stato in grado eli mantenere l ' ordine ncll 'a rca e proponeva che alla Francia fosse affidato il controllo del Libano. l francesi, ovviamente , si opposero fermamente all ' ipotes i di autogoverno arabo in Palestina e reclamarono - oltre al Libano - la Siria e la Cilicia, lasciando la Palestina agli inglesi. La Francia aveva allo studio l'invio eli rinforzi nell'area che avrebbe portato il numero degli effettivi a 20.000 uomini. Le delimita z ioni geografiche precise vennero lasciate al Consig lio Supremo e la proposta venne accettata .
Gli inglesi mantenevano l'occupazione della Mc sopotamia e del Kurclistan, dove era prevista la presenza di due divisioni di fanteria c di una divisione di cavalleria.

Gli americani - cui era stato ripetutamente chiesto di interveniresi rifiutarono di procedere all'occupazione del Caucaso; il generale di
• 12 Questa mozione ottenne la maggioran za ma il genera le eli Robilant s i di sse contrario portando l'esempio dell" Armenia. li rappresentante italiano s i chiedeva co me sarebbe stato possibile far cessa re i ma ssacri in Almenia - Lona all'epoca non ancora occupata - senza assegnare il mandato ad uno degli a ll eati. Cfr. AUS SME Fondo
E8 R. 5. Fase. 3 pag. 13.
Gli In g les i proseg uivano nella politica ambigua nei confron ti de g li s tati ar a bi .. iniz iata prima deg li accordi Sykes - Picot del 1916. Da un lato la Gran Bretagna promi se !·indipendenza ag li arabi. in cambio del loro aiuto contro g li ottomani (carteggio MacMahon - Hu sse in 1915 -1916), dall'altro s i impegnò a sostenere la causa s ioni s ta ( dichiara z ione B.all'our 191 7). li testo degli accord i Sykes-PicotJimasc segreto agli arab i fino alla rivoluzione dì ottobre, quando Lcnin decise di pubblicare tutti gli accordi segre ti.
37
Robilant, a nome dell'Italia, si disse disposto ad inviare le proprie truppe. La proposta venne accettata ed il Caucaso venne assegnato all'ltalia che, però, avanzava pretese anche su Konia e Adana - che si trovava sotto il controllo francese - per stabil irvi una base per il rifornimento delle truppe. L'Italia, se la proposta fosse stata accolta, avrebbe inviato nell'area due divisioni.
Rimaneva in sospeso la questione armena; qualora fosse stato deciso di intervenire in Armenia l'occupazione sarebbe stata affidata agli Stati Uniti, sempre che avessero acconsentito a prendere su di se l'onere dell'occupazione. Se gli americani avessero deciso di non intervenire l'Armenia non sarebbe stata occupata da altre truppe alleate, visto che si era stabilito di non intervenire in territori che non fossero già stati occupati in precedenza.
La 53 ° seduta continua la mattina seguente alle dieci 44 la prima questione affrontata dai delegati militari è quella della quantificazione delle truppe da inviare nel Caucaso ed a Konia. Il generale di Robilant chiese che dal verbale- nella colonna in cui erano indicati gli effettivi necessari - fosse cancellato il battaglione previsto per Konia e che risultasse semplicemente che il Caucaso e Konia sarebbero stati occupati da due divisioni italiane , questo per consentire, in caso di necessità, l'invio a Konia di truppe supplementari. I francesi si opposero fermamente temendo che l'Italia volesse inviare nel l 'area di Konia una unità molto più numerosa di quella che era dislocata nell'area in quel momento, ritenuta necessaria e sufficiente per mantenere l'ordine.
Il generale inglese Sackville-West disse che non credeva fosse possibile mantenere l 'o rdine in Caucaso con meno di due divisioni e che quindi non sarebbe stato possibile allontanare tmppe dali 'area per inviarle a Konia. Il rappresentante italiano sottolineò nuovamente la nedi essere l iberi di poter disporre delle proprie truppe secondo il bisogno. Senza questa libertà di movimento l ' Italia non avrebbe accettato il mandato provvisorio sul Caucaso, tanto più che non si stava chiedendo di aumentare gli effettivi nell'arca ma solo di poterne disporre liberamente.
44 Per un errore d'm·chivio la seconda parte della 53° seduta era stata per errore catalogata come 54°. Rimane in proposito una lettera del Segretariato della Sezione francese a quello della sez ione italiana , datato 5 marzo 19 19, che chiede la restituzione delle copie inviate per poter effettuare la correzione del caso. AUS SME Fondo E8, R. 5, Fase. 3.

38
Il secondo nodo da affrontare era la concessione alJ 'Italia della base marittima ad Adana - in zona francese - tale concessione avrebbe, secondo il rappresentante inglese, violato il principio di non consentire occupazioni miste. Il rappresentante francese invece acconsentì a concedere una base marittima per il rifornimento delle truppe che sarebbe stata comunque sotto la responsabilità del generale Milne, comandante delle truppe i nteralleate nel! 'intera area, non dando lu ogo ad alcuna occupazione mista. In quanto a Konia l'italia avrebbe inviato in un primo momento un battaglione fermo restando che i governi alleati, in caso di necessità, avrebbero deliberato l'invio di truppe supplementari45. Il genera le italiano alla fine della discussione accettò la ripartizione delle truppe con riserva ed il rapporto completo venne inviato - tramite il scgrctariato - al Consig lio Supremo per le deliberazioni del caso.
Ne ll a relazione fina!e4 6 • inviata al Consiglio Supremo, gli esperti militari sconsigliavano qualsiasi riduzione delle forze impegnate a Costantinopoli e nel pattugliamento degli Stretti- 100.000 effettivi, di cui 40.000 combattenti- composti da una divisione britannica, una francese e distaccamenti italiani c g reci. Lo schema proposto dagli espelti militari prevedeva una riduzione del 50 % delle forze impegnate in Caucaso e nella Turchia asiatica ed una ripartizione su tre Potenze; la sola Gran Bretagna avrebbe avuto una riduzione dei propri effettivi di 500.000 uomini.

Qualora fosse stato deciso di dare applicazione a questo piano. si sarebbero dovuti tenere in considerazione due ulteriori elementi:
l. il ritiro delle truppe britanniche avrebbe necessitato la fornitura di piroscafi al1eati per il tra spo rto di uomini e mezzi, sarebbe stato necessar io , quindi, consultare il Consiglio Interalleato per i Trasporti Marittimi che aveva sede a Londra;
2. se gli Stati Uniti avessero deciso di collaborare a ll e occupazioni i rappresentanti militari indicavano come possibile zo na di influ enza americana l 'Armenia ed il Kurd istan
Le reazioni in It a li a alla proposta di occ upa zione del Caucaso furono di teno re alterno, a partire dalla relazione inviata dal genera le di
45 Re soco nto della 53° sed uta del 5 febbraio in AUS SME Fondo E8. R. 5. Fase. 3. pagg. 2-5.
46 La relazione fu inviata dai Rappresentanti Militari a l Consiglio Supremo nel pomer iggio del5 febbraio. Cfr. AUS SME Fondo E8. R. 5, Fase. 3.
39
Robilant ad Orlando e Sonnino ed al generale Di az, immediatamente dopo la conclusione della seduta del 5 febbraio. Nella s ua relazione il generale sottolinea l'impres s ione che l 'occ upazione italiana della Tran sca ucasia fosse sta ta accettata senza alcun problema dagli altri Allea ti che, anzi, speravano di assorbire nell'area tutto il contingente it aliano di occupazione, per allontanarli da aree politicamente pitl significative per l 'Italia. Il territorio, pur molto interessante per i ricchi giacimenti petroliferi, senza l'occupazione della zona di Konia sarebbe ris ultato troppo eccentrico rispetto agli interessi mediten a nei del Paese, dunque, il generale riferisce di aver subordinato l 'occ upazione della Transcaucasia al controllo di Konia.
L'occupazio ne di Konia avrebbe permesso, secondo i progetti italiani. di spingere dei distaccamenti verso Adal ia - che era stata lasciata fuori dal dibattimento del 4 e 5 febbraio per evitare possibili scontri con la Grecia - Angora e verso l'importantissima regione carbonifera di Eraclea ed i porti del Mar Nero. Se gli Alleati avessero seguito il principio dell'esclusione delle occupazioni miste questo progetto avrebbe potuto essere realizzato. Le dislocazioni successive di truppe sulle coste del Mar Nero - ad esempio a Trebisonda - avrebbero potuto essere giustificate con la necessità di istituire stazioni intennedie tra Konia e la Transcaucasia , dove comunque il progetto di occupazione s i limitava alla linea Batum-Tiflis-Baku per assicurare lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi 47 .
Il generale Badoglio espresse al generale Diaz le s ue perplessità circa le questioni inerenti la Turch ia asiatica e la Transcaucasia in un telegramma del 19 aprile 1919. Il parere negativo scaturisce dall'evidenza che le miniere di carbone della Tran scaucasia fossero state concesse all'Italia al posto di que ll e, ben più redditizie, di Eraclea occupate dai francesi. Badoglio contestava ai francesi il diritto di appropriarsi di Eraclea dopo aver occupato il bacino della Sane ed! esprimeva f01ti perplessità circa le motivazioni per le quali gli inglesi avrebbero deciso di abbandonare " quella ricca regione sen za gravi motivi di oppor-
47 11 rapporto del ge nerale di Robilant porta, evide ntemente per un errore di balli tura, la data del 5 gennaio 1919 invece di quella del 5 febbraio deducibile dal principio del documento c he dic e così: ''Conformemenre all'incarico datomi d a S.E. il Presidente del Consiglio ho panecipato alle riunioni dei Rappresenwnti Militari Pennanenti tenutesi a Versailles il 4 ed il 5 corrente, per trattare la questione int eressa nt e gli ex territori turchi della Asia , in AUS SME Fondo E8, R. 5, Fase. 3.

40
t unità propria. ch e a noi .forse sfuggono ancora." la neces s ità di inviare altrove le proprie truppe non sembrava convincente, anche alla luce della recente occupazione di Trebisonda48 .
I medesimi sospetti vennero espressi da Antonio Salandra nel s uo diario alla data del 15 aprile. Il delegato italiano, nel rip01tare il rinnovo dcii 'offerta di occupazione temporanea della Transcaucasia compiuto da Lloyd George - accolto con entusiasmo da Della Torretta ex ambasciatore in Russia - si chiedeva la motivazione di questa offe1ta degli inglesi che difficilmente avrebbero abbandonato un territorio redditizio. Salandra, inoltre, sottolineava che tale offerta non doveva avere l ' effetto eli tagliar fuori l'Italia dal Mediterraneo orientale; che bisognava infotmarsi attentamente sulle condizioni politiche del paese che erano ignorate dai più: che bisognava comunque valutare correttamente il pregio di un territorio il cui accesso passava per lo stretto dei Dardanelli, da cui si poteva rimanere tagliati fuori 49 .
Orlando in principio aveva appoggiato il progetto di pcnctrazione italiana ed aveva confermato a Lloyd George la volontà italiana di effettuare la sos tituzione del contingente britannico nonostante la po s sibilità di un urto con la Russia ed il rischio di contrasti interni con il partito socialista. La necessità di ottenere il maggior numero di informazioni nel minor tempo possibile, per poter decidere circa l'invio del contingente italiano, aveva fatto si che fosse inviata in Transcaucasia la mi s sione ·'esplorativa", comandata dal colonnello Gabba, oggetto di questo studio.
La situazione cambiò verso la metà di maggio quando i segnali di una possibile crisi del Gabinetto Orlando si fecero più udibili ed insistenti. Sonnino spingeva allora per una decisione affermativa, Orlando era titubante anche per le ripercussioni che la missione militare avrebbe potuto avere in Patria, qualora i socialisti la avessero interpretata come un intervento contro la Russia50 .
L'insediamento del nuovo Gabinetto Nitti- Tittoni, il 23 giugno 1919, pose fine alle indecisioni dci predecessmi mmullando i l progetto della missione in Transcaucasia, in nome della imminente smobilitazione51
48 AUS SM E Fondo E8, R. 20. Fase. 13.
49 Salandra , A., cir. , pagg. 70-7 1
50 Sala ndra. A., ci r., pag. 83.
51 Petrieiol i. M., L'Oc c upazione italiana del Caucaso: Un ' ingrato servi z io" da rendere a Londra , in " Il Po litico". Pavia, Fase IV. 1971, Fase. l. 1972 , pag. 75.

41
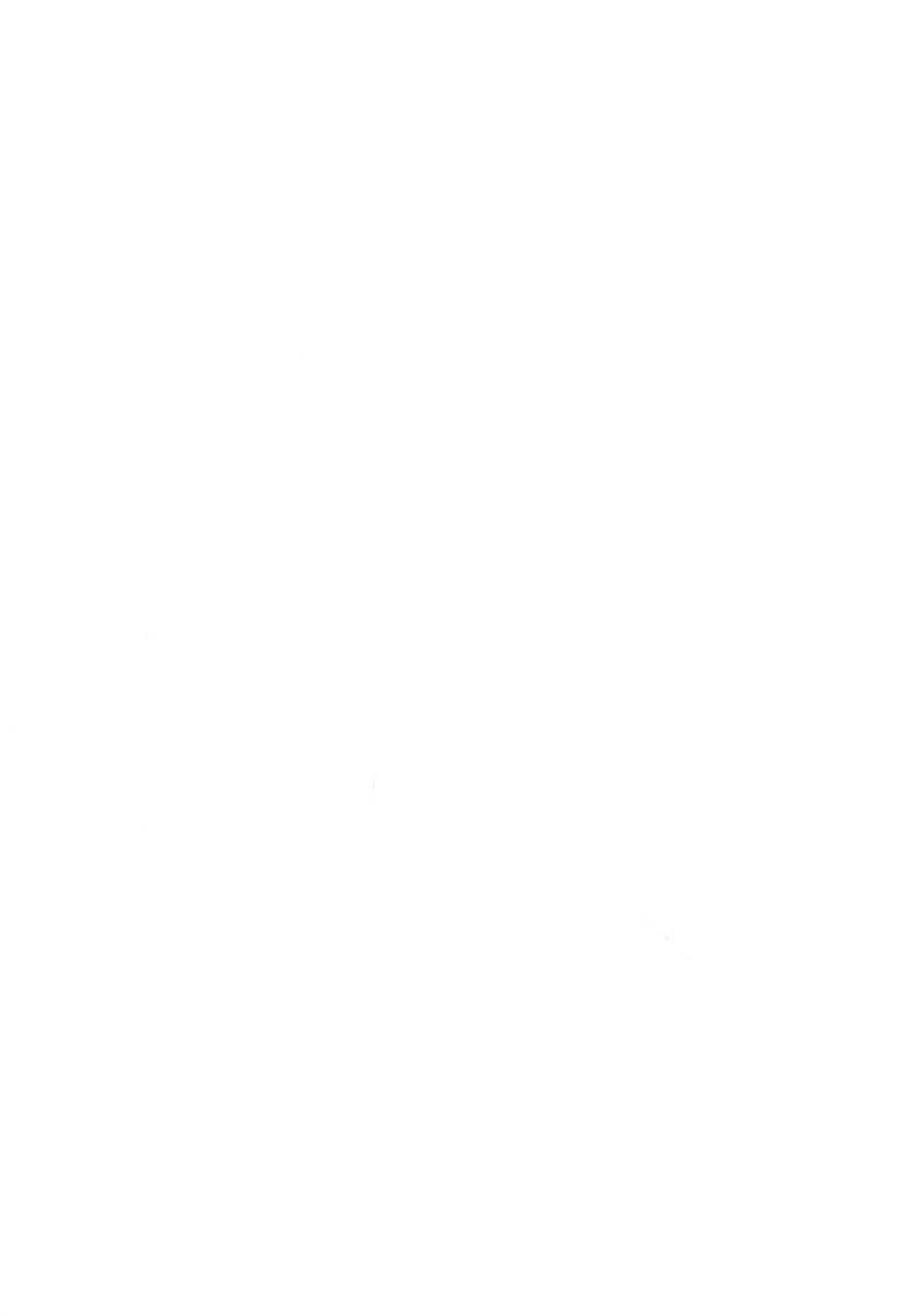
CAPITOLO II
Le Repubbliche Transcaucasiche dal1917 a11920
l. La Rivoluzione Rus sa
La R ussia di Nicola IL con i suoi 150 milioni di persone che stavano faticosamente emergendo da un passato di servaggio e sottosviluppo era - tra le potenze belligeranti - sicuramente quella meno pronta a sopportare le ulteriori sofferenze imposte da una lunga guerra. La pessima amministrazione imperiale e la crescente scarsità di cibo nei distretti urbani produssero, prima che negli altri stati. evidenti segni di cedimento ed un irrefrenabile desiderio di pace. Le frange più conservatrici del Governo e della Corte avevano manifestato, s in dal 1914, la loro contrarietà ad una guerra che, se anche fosse risultata vittoriosa per le truppe Alleate, avrebbe causato la fine dell'impero zar ista e l'affermazione della democrazia in tutta l'Europa Centrale 1 • Lo zar, fedele aii'impegno preso con l' In tesa, avrebbe dovuto tentare di recuperare il contatto con le masse per spingerlc a proseguire la guerra, questo sarebbe potuto accadere tramite dell e aperture verso gli elementi moderati del centro e della sinistra ma, vuoi per debolezza, vuoi per mancanza di polso politico, egli preferì ascoltare l 'estrema de st ra , della quale facevano parte anche la zarina e il suo entourage, p iut tosto che i riformatori. Il risu ltat o fu una serie di goffi tentativi di iniziare trattative per una pace separata con la Germania, condotti tramite agenzie commerciali e finanziarie, nobili comp iacenti e agenti tedeschi che seminavano tra i conservatori rus s i il ter rore di un a rivoluzione interna e d i un tradim ento dei propri impegni verso gli Alleati.
Nel 1916 le campagne dell'esercito russo furono segnate da una serie di vi ttor ie contro l'ese rcito aust.J.iaco. I russi combattevano coraggiosamente ma , essendo est remamente male armati, le perdite s ubite
1 Opinion e espressa dal conte Witte all'ambasc iatore francese in Ru ssia Mauric e Paléologue i l IO scucmbre 19 14. In Wheeler-Bennet, J. W ., Brest ·Li tovsk the Forgorten P eace Marc h 1918 , London, 1956. pag. 6.

43
sfio rarono il milione di e il d esiderio di "pace e pane·· diventò improcrastinabile.
Nel l 917 la parola d'ordine s ia dci conservatori sia dei riformi sti e ra Pa ce . L e motiva z ioni e ran o evidentemente op pos te, la pace dov eva se rvire seco ndo i primi a salvare il potere autocratico. per i secondi invece doveva accelerare la "d ittatura del proletariato". Entrambi i gruppi avevano in m en te la destituzione di Nicola Il . Nel mezzo rimanevano i moderati di Miliukov c R odLia nko che, fedeli a ll a causa dell'Intesa. voleva no che lo zar il p aese c il suo potere adotta nd o un a riforma cost itu z ional e prima che fosse troppo t ardi 2 . I loro co nsig li , ina co lt ati dal sovrano c hiu so nella propri a apatia. rimasero lettera morta. L e te s timonian L.e di co loro che rim asero v ic ini allo za r fino a l momento in cui, il 16 marzo 1917 , fu costretto ad ab di ca re , parlano di una ca lma g laciale quanto innaturale che contrastava con l'atmo s f e ra ge neral e di depre ssio n e, tanto da c hieders i se l'att egg iamento del sovrano fosse frutto di un in c redib il e ritegno- o tt e nuto g r azie a d una ferrea disciplina - di fede nella predestinazionc divina - co ntro la quale qualsiasi resistenza sarebbe s t a t a inutile - oppure di

L a Ri voluz ion e. co n la quale in Ru ssia venne via il regime Larista, portò a l potere. incredibilmente, propri o quel pattito liberale democratico c he favorì la prosecuzione della g ue rra per la democrat: ia , in netto contras to con la vo lontà popolare di pace, in nome della qual e la ri voluzione e ra sta ta co mpiuta. Sia i conservatori c he i bol scevichi. se fossero riusciti a prendere il potere, avrebbero immediatamente dato inizio alle trattative di pace con le Po te n ze ce ntrali. Il gove rn o provvisorio di s t am po liberai-soc iali sta era compos to da 10 liberali e da un so lo socia li sta.
Lc nin, cap o c ari smatico de l part ito bolscevico, rientrato in patria dal s uo es ilio e l ve ti co dopo lo sco ppio della ri voluz ione, graz ie all 'a iuto d e l Comando Supremo te de sc o, non si la sc iò sca ppare l'occas ione di capi taliz zare il d es iderio popolare di pa ce c d u ritorcerlo contro il neonato governo provvi s orio. Il Comando ted esc o si aspe ttava da Le nin che spingesse le ma sse a c hiedere di avviare le trattative di pac e se parata con la Germani a, teme ndo la 1ipresa. in primavera, d eg li at-
pagg. ll - 12.
3 Le parole che ho riportato, tradouc, sono del generale Danilov vicino al in quei giorni fatali. Jn Chernov, V., The Crear Russian Rei'O!ution, New Havcn. 1916, pag. IO
44
tacchi f ra n co-britannici combi n ati co n qu e lli dell'ese rc i to russo che si sareb b ero ce rt amente rivelati fata l i per g li Imperi centra li"'.
11 Soviet dei l avoratori, dci so ldati e dei contadin i di Pietro grado e ra l 'altro attore di prim o piano insieme al governo. Il sov iet era sicuramente più vici no d e l gove rno ai sentimenti d e ll e masse c soprattutto av eva rifiutato di collaborare co n il governo dopo c h e i liberali avevano manifes tato la propri a vo lon tà di pro seg uire la guerra al fianco deg li Alleati. Manifestazioni oceaniche per l a pace ri empirono le strade, si moltiplicarono g li scontri tra truppe e manifestanti. la p ropaganda bolscevica co ntinu ava ad a lim e nt arne la fiamma mentre risuonava per la prima vo lt a lo slogan ''tutto il potere ai Sovief'.
11 gove rno spi nt o dalle enormi manifestazioni popolari dichiarò, tramit e un documento ministeriale. la sua vo lont à di arrivare quanto prima a s ig lare un a pa ce ge nerale , basa ta su i principi eli non ann ess ione e di auto determinazione dci popoli. Ancora non si accenn ava nei documenti ufficiali ad una pace sepa rata, essendo il governo provvisorio ancora legato a li ' Acco rd o Tripartito del 191-f. con il quale la Gra n Bretag n a la Francia c la Ru ssia si impegnavano a non siglare accordi separati co n le p otenze ce ntr ali.
Int a nt o agenti bol scevichi si infiltra va no in ogni divisio ne ed iniziavano l a loro opera di propaganda. L'effetto fu reggimento dopo reggime nto, i so ld ati s i rivoltarono, u ccisero g li ufficiali c il fronte si paralizzò; l'avanzata tede sca fece il re sto. Il panico si diffu se all ' interno detresercito in di sso luzione, trasmettc nd os i anche a lle poche unità rimaste immuni dal "co ntagio' ' bol scev ico. Ogni te nta tivo di resis te n za fu inutile, i soldati iniziarono un a le nt a e disordinata ritirata.
L'atteggiamento degli A ll ea ti nei co nfronti del Governo provvisorio che in iz ialment e era s t ato benevolo. inizia a trasformarsi in irritazione e ri se ntiment o alla lu ce dei ripetuti falliment i n e ll'argin are il caos che andava diffond e ndo si. Ben pre s to apparve agli Alleati in tutta la sua ev idenza la total e imp ossibilità a pro seg uire la g uen·a su l front e orienta le 5

Un tentativo di pon·e un freno a ll a confu s io ne di lagante venne d a l coup d'étal di se tt e mbre del ge n erale Kornil ov, coma ndante in ca p o del l 'ese rcito, che p erò fallì per la med es im a disorganizzazione che
-' Whcclcr- B en n et. J . W., cit. pagg. 35 - 39. :; Ri ccanli L.. Alfecui 11011 amici. Le rela::Joni politid1e tra l'Italia e l'Intesa durante la prima gue rra mondiale. Morccll iana. Brescia. 1992. pag. 380.
45
avrebbe dovuto combattere, tanro c h e i Cosacchi di Ko rn ilov s i arresero facilmente a i battaglioni d e i lavorato ri di Pi ctrog rad o. Intanto il Governo provvisorio si ridusse ad un direttorato, composto di so lo c inqu e membri. con a ca po Kcrenskij.
Il partito bo lscev ico -che aveva sempre avuto una rilevanza pol iti ca assolutamente sp roporzionata a l n umero dei s uoi membr i - raggiunto in ottobre il control lo dei Sovict di M osca e di Pi e trogra do, con a capo Trotsky, annunciò l 'i nte n zio ne d i convocare a novembre un cong resso dei sov ie t di tutta la Rus s ia per prendere finalmente in mano il gove rno del paese. Il co ngresso era convoca t o per il 7 di novembre ma Lcnin, ritornato da poco da ll a Finl andia. era poco convimo di affidar si al voto popolare pe r la presa de l potere e preferì affidarsi alla forza. Il regime di Kerenskij ri ceve tte il co lp o defi niti vo propri o il 7 n ove mb rc6
11 problema d e lla pac e, richiesta dal popolo se n za ulteri o ri in dug i , d ive ntò ce ntr a le per il governo dci soviet come lo e ra s t ato pe r i lo ro predecessori. L a politica del partito era quella di una pace generale ·'sen za an nessioni e se n za riparaL ioni'' ma i tentativi diplomatici di innuenzare le potenLe dell' I ntesa falliro n o. l bolscevichi fo r mularono la loro prima proposta di pace, rivol t a a tutti i belligeranti. convinti c h e i gove rni n on la avrebbero accetta ta ma che v i sa re bbero s tati spint i dalle manifestazioni popolari. Ques ta co n vinLione s i basava s u un g rave errore eli giudizio, in prim o lu ogo una interpre t azione sbagliata del la psicologia occiden t ale. e secondo poi s u una erronea convinzione c he la rivoluzione prole t aTia fosse diet ro l 'a n golo anche in occide nte. Ne l pomeriggio dcll'8 novembre Lenin e r a atteso al Co ngresso dci sovie t. del qual e facevano pa rte anch e i me nscevichi c i soc iali s ti rivolu z io nari. per portare la s ua re lazione s ul co lpo eli s t ato c le propo ste bol scev ic h e per la pace. Il D ecreto. approvato all'unanimità dal Con gres o. era basa to s ul concetto di pace se n za anne ss ioni e se nza riparazio ni e s ul d iritt o all'autodeterminazio ne dci popoli.
Come Lcn in aveva s uppo sto, i gove mi a ll ea ti non riconobb ero l 'esis tenza del nu ovo regime c ne ig norarono i propositi di pac e d ecide ndo di non ri s pondere alla comunicazione. Appoggiarono inv ece il gen era le Du khonin che, co nf id ando ne ll 'a iuto a ll eato, faceva appello a la voratori e co nt adini per dare v ita ad un governo popolare. Gli Allea ti s i sp in sero fino al punto di schiera rsi decisam e nt e co ntro qu a lsiasi ip otesi di pac e se parat a, in v iola z io ne d e ll'ac co rdo del 5 settembre 1914 ,

46
6 Wh eelcr-Be nn ct, J . W .. ci t. pa g. 60.
e si dichiararono convinti che il Comando supremo russo avrebbe tenuto le truppe al fronte contro il comune nemico. Un errore di valutazione derivato dali 'ig noranza del fatto che, come dichiarato dallo stesso Trotsky , i russi non si ritenevano più legati in alcun modo ai trattati conclusi dallo zar. Resta il fatto che gli Alleati, in particolar modo gli Tnglesi , non avrebbero comunque potuto accettare che le rela z ioni tra Germania e Russia venissero consolidate da una pace separata. Una futura alleanza tra russi e tedeschi avrebbe costituito una seria minaccia per il futuro dell 'Eu ropa e, secondo Gcorge Buchanan ambasciatore inglese a Mosca, andava ostacolata a qualsiasi costo. Egli propose agli Alleati di liberare la Russia dalle proprie obbligazioni e di manteners i in buoni rappo11i con il governo sovietico. La propo sta non venne accettata ma. se lo fosse stata, molto probabilmente la storia del trattato di Brest-Litovsk sarebbe stata completamente diversa 7
2. La Pace di Brest-Litovsk
Dinanzi al rifiuto degli Alleati a prendere parte alle trattative per la pace generale, Lenin avrebbe avuto due distinte pos s ibilità: la prima era quella, assolutamente irrealizzabile, di continuare la guerra come gli veniva richiesto dai moderati, ma le possibilità di combattere con un esercito in disfacimento e ormai privo di qualsiasi disciplina si sarebbero rivelate certamente nulle; la seconda era quella di iniziare le trattative di pace con la Gem1ania e di siglare una pace separata che avrebbe concesso al bolscevismo il "respiro" necessario per consolidare la Rivoluzione russa contro gli sforzi di rovesciarla dal di dentro. Il 26 novembre 1917 , Trotsky fece formale domanda al Comando supremo tedesco per un armistizio immediato con lo scopo di siglare una pace senza indennità c annessioni. La Quadruplice Alleanza aveva ogni interesse a siglare una pace con la Russia che avrebbe consentito agli imperi centrali di concentrare i propri sforzi sul fronte occidentale e di dare respiro acl Austria e Ungheria i cui eserciti erano ormai allo stremo, dopo aver perduto più eli 1.800.000 uomini sul fronte russo. Inoltre , a Yicnna e Budapest, si anelava aggravando la crisi alimentare, c'era urgente bisogno di ingenti quantità eli grano che, una volta s iglato J'armisti7.io con l a Russia, sarebbero potute giungere elall'Ucraina.

47
7 Wheeler- Bennet. J. W. , ci t. pagg 75-77.
La Germania accettò la proposta russa di trattare, i negoziati si sarebbero dovuti aprire il 2 dicembre 1917x.
I tedeschi pensavano di risolvere la questione in poche ore ma la delegazione sovietica era atTivata a lle trattative con intenti anche di propaganda. J Russi erano intenzionati a far durare i negoziati il più a lungo possibile, per favorire lo scoppio della rivoluzione proletaria in tutto il re s to dell'Europa. Per prendere tempo, all'inizio, i delegati sovietici continuarono a parlare dell'intenzione di siglare una pace su tutti i fronti senza ave re in rea ltà alcun potere di negoziare a nome degli alleati dell'Intesa. Soltanto il 12 dicembre, dopo aver tentato ancora una volta invano di ottenere una risposta dai governi alleati in merito al loro desiderio di prendere parte ai negoziati, la delegazione fece ritorno a Brest -Litov sk dichiarandosi pronta a negoziare per un armistizio separato, scaricando la colpa del proprio comportamento sugli Alleati che non avevano voluto prendere in considerazione i ripetuti appelli alla pace. Il l 5 dicembre viene finalmente siglato l ' armistizio bilaterale , va lido fino al 14 gennaio, che sarebbe stato prolungato automaticamente a meno che non vi fosse, da parte di uno dei firmatari, la volontà di romperlo. Anche in questo caso si sarebbe dovuta co-
8 La scelta de ll a delegazione Russa da in viare a Brest-Litovsk non fu semplice. Essa doveva essere rappresentativa di tutti i gruppi rivoluzionari ma anche capace di negoz iare, una combinazione di difficile ottenimento nel primo periodo del governo s ovietico. ll capo della delegazione era Adolf Joffe un intellettuale rivoluzionalio. con lui Leo Kamenev il cognato di Trotsky, poi Leo Karakhan un armeno che aveva le funzioni di seg retario generale della delegazione e la famosa Mme. Anastas ia Bitsenko assassina social- ri vo lu zio nari a. La delegazione avrebbe dovuto essere completata da un membro di ognuna delle classi che avevano preso parte a lla rivoluzione. so ldati. marinai, lavoratori e contadini. La storia del rappresentante della classe contadina. Roman Stashkov , merita eli essere riportata. La delegazione si stava già recando alla stazione quando ci si rese con to che mancava un rappresentante proprio dei contadini. girato un angolo si imbattono in un vecchio con tadino con una borsa, la macchina s i ferma e con la sc usa eli un passaggio alla stazione il contadino viene fatto salire. Quando la delegazione arriva alla stazione Warsaw il co ntadino dice che non era la stazione giusta per lui che doveva andare verso est. a que l punto Joffe domanda al contadino a quale partito appmtenesse cd egli rispose al partito sociali sta rivolu zio nario. Non soddisfatti i delegati lo incalzano chiedendogli se appartenesse alla corrente di destra o eli sinistra ed il vecchio che aveva capito dal tono della domanda che sarebbe stato lischioso rispondere destra di sse che era cieli 'ala pii'• eli sinistra possibile. Soddisfatti della ri s po s ta Joffe e Kamenev "invitano" il contadino a recarsi con loro a Bres t-Litovsk per firmare la pace con i tedeschi. Wheeler-Bennet , J. W. , ci!. pagg. 85-86.

48
munque concedere una settimana di preavviso prima della ripresa delle ostilità. Tra le condizioni dcii 'armistizio rientrava una clausola sul ritiro delle truppe dal Baltico c dal Mar Nero che non sarebbe avvenuto comunque prima del 14 gennaio ed una c lauso la, per la verità piuttosto in ge nua da parte tedesca, che lasciava campo lib ero alla temibilc propaganda sovietica consentendo gli scambi di g iorn ali e materiali infonnativi. Ben presto divenne impossibile controllare le attività deg li agenti bolscevichi nei punti di fraternizzazione istituiti per le truppe9.
Trotsky scrive che, all"inizio dei negoziati per la pace, la speranza dci bolscevichi era che i partiti dei lavoratori tedeschi, austriaci e anche dei paesi dell'Intesa aderissero alla rivoluzione. A tal fine era necessario che i negoziati durassero il piLI a lungo possibile per co nsentire a i lavoratori di comprendere i punti salienti del programma bolscevico c in particolare il loro programma di pacc 10 . Per la mentalità bolscevica del tempo, infatti, le questioni territoriali avevano scarsissima rilevanza se paragonate alla lotta del proletariato contro il capitalismo, al punto di affermare che non era un vero socialista quello che non era pronto a sacri fi care la propria patria per il trionfo della rivoluzione. Inutil e dire che i lavoratori degli altri paesi europei non si assunsero il ruolo che Leni n aveva pensato per loro, c continuarono ad appoggiare i loro governi borghesi. Lenin stesso, che aveva condiv iso inizialmente la convi nz ione dci suo i compagni che la rivoluzione fosse prossima anche nel resto d'Europa, fu il primo a rendersi conto dell'errore di valutazione compiuto. Rim ane comunque il fa llim ento di Lenin nell' interpretare correttamente le reazioni delle classi lavoratrici europee, al contrario di quelle ru e che egli comprendeva e controllava alla perfezione.
Questa politica di procrastinazione indefinita era osteggiata da Lcnin. che era sicuro che, a lun go andare, s i sarebbe rivelata dannosa per la Russia. Egl] non era affatto convin to , come g li altri membri della delegazione, che i tede schi non avrebbero ripreso le os tilità se le loro co ndizioni non fossero sta te accettate dalla delegazione russa. Inutil e dire che l'accettazione della pace senza annessioni e indennità era so lo un a facciata e che il Comando tedesco stava cercando di far passare per autodeterminazione l'alienazione dal controllo russo di quasi di-

49
9 Wheeler-Benne t , J. W., cit. pag. 93. 10 Trotsky. L., Leni n. London, 1925. pag. 128.
ciotto provincie tra cui la Polonia russa, la Lituania, l a Curla n dia c parti dell'Estonia c della Livonia. Lenin decise comu nque di far proseg uire i n egoz iati a Trots ky c he a n ·ivò a Brest- Lit ovsk all'inizio di gc nnaio11. Trotsky dovette imm ed iatamen te confrontarsi con un ultimatum c h e las ciava come uni ca cel ta l 'acce tta zio ne di un a cattiva pace oppure la rip resa de ll e ostili t à. La replica di Trot ky, it giorno sivo12, la scia ancora spazio a l dialogo con la G e rmania. ma chiarisce c h e il governo bo lscevico, pur avendo come priorità assoluta il ragg iun g im en t o della pace , l o aveva inca1ic ato di accettare c s ig la re so lo una pace giusta c democratica. Il 18 ge nn aio, Trotsky tornò a Pietrog rado per rifer i re a ll 'Assemb lea Costituente, c he e ra s tata creata dopo il colpo d ì stat o che aveva fatto ca dere il governo provv i so rio. Leni n, intanto , stava pen sa ndo di e liminare a n che la costituente, dato c he i bol scevic hi avevano la maggioranza solo a M osca, Pi etrog r ado c in a lc une a lt re città, m e ntre la ma gg io ra nza assoluta dei vo ti era a nd a ta ai Soc ialist i Rivoluzionari. Quando l 'assemblea sì riunì il Consiglio dei Comm i ssari comunicò c h e sarebbe sta ta immediatame nte fatta sciog liere se n on fosse sta to ri co n osci u to il pot ere dci Sovie t e approvate tutte le misure decise durante il 2° Congresso dci Soviet.
L ' opinione di Trotsk y in me rito alla firma del tr at t a to di pace e r a c he s i dove sse fe rm are la g ue rra se n za firmare la pace. Di etro a questa d ich iarazione la co n vi n zione c he la Germania non avrebbe ripreso le os tilit à a c au sa delle proprie difficoltà intern e e c he, comunque, a n c he se avesse attaccato la situazio ne non sarebbe s tata peggiore di quella attuale. L enìn a l co ntrari o e ra convi nto c he i tedesch i av rebbero ripreso le ostilità c c he a quel punto l 'ese rcito ru sso non s arebb e stato in g r a do di res iste re, era contrario alla t eo ria di Trot s ky e l o era a nco r a di più a Bu kharin che s tava ra ccog liendo consensi attorno a ll a ripresa della guerra. 1 due uomini po liti c i non avevano a ncora capito c h e la fi rma del tra u ato era indi spe nsab ile, dato che le rruppe non e rano più in g rado di co mb atte re e che le co ndi z ioni di pace s arebbero s lélte ancora pegg iori se i te d esc hi avessero ripreso l 'a vanzata 13 . La proposta
11 Egli non fu l'unica nuova prel>enLa all a conferenza. avevano fatto la loro comparsa anche i rappre)>entanti polacchi e quelli della Rada Ucraina. Gli Ucraini ave"ano auuato immediatamente il principio di autodeterminazione enu ncia to dai bobccvichi c aveva no dichiara t o la propria indipendenza imm ed i atamcmc dopo il golpe bo l scevico. Cfr. Wh ee l c r- Bcnnet, J. W., ci ! pa g. 154

12 TI g iorno i n qu es tion e è il 10 gen naio 19 18.
13 Wh eeler- Bcnncl. J. W. , cit. pa gg. 187- 19 1
50
di Trotsky fu accettata dal Comitato centrale con una maggioranza molto ristretta. ma pur sempre sufficiente per dargli carta bianca nel proseguimento delle sue tattiche per prolungare i negoziati.

Intanto, il Comando Supremo tede sco era deci so a proseguire la guerra se i bolscevichi avessero proseguito nella politica di procrastinazione; il loro regime sarebbe caduto in brevissimo tempo sotto i colpi delle truppe tedesche ed i successori dei sovietici avrebbero accettato qualsiasi condizione di pace.
Nonostante la minaccia di una avanzata su Pietrogrado che avrebbe certamente causato la caduta del regime bolscevico , Trotsky il lO febbraio, con un vero e proprio colpo di teatro , annunciò la decisione deJJa Rus s ia di tirarsi fuori dal conflitto senza firmare una pace ritenuta inaccettabile. Il Comando tedesco, considerò il discorso di Trotsky come una rottura dell 'a rmistizio e si preparò a riprendere l'avanzata entro una set timana, come stabilito nei patti 14
L'armistizio avrebbe avuto termine il 18 febbraio a mezzogiorno. le ostilità sarebbero tiprese quello stesso giorno. Il 19 febbraio il quartier generale tedesco ricevette un telegramma firmato da Lenin e Trotsky con il quale venivano accettate le condizioni di pace poste a Brest. I tedeschi però adesso non avevano fretta e impiegarono le stesse tattiche dilatorie utilizzate dai russi, chiedendo confem1a sc ritta del telegramma al comandante tedesco di Dunaburg. L 'a vanzata tedesca, come previsto da Lenin, travolse ciò che rimaneva dell'esercito russo anche se non fu rapida come Hoffmann aveva sperato. L'ultimatum tedesco raggiunse Lenin il 23 febbraio mentre l'avanzata tedesca procedeva, il 24 i bolscevichi accettarono le condizioni tedesche, ma l'avanzata non si fermò e sembrava che non dovesse arrestarsi, se non dopo aver raggiunto Pietrogrado. I termini della pace erano, ovviamente, molto più duri di que ll i che erano stati rifiutati a Brest ma bisognava
14 Wheelcr-Bennet, J. W .. cit. pag. 229.
15 I tem1ini proposti dai tedeschi erano durissimi, comprendevano un ulteriore spos tamento della linea eli confine verso est fino ad includere la città di Dvinsk ed arrivare alla frontiera orientale della Curlandia, la Germania dopo la firma del trattato si ritirerà da tutti i tenitori più ad est eli que s ta nuova linea; la Livonia e l 'Estonia dovranno essere immediatamente evacuate dai Russi per consentire r occupazione da parte di una forza d i polizia tedesca che si incaricherà eli Jistabi l i_re l'ordine; la Ru ss ia dovrà conc ludere immediatamente la pace con I'Ucraina e ritirars i immediatamente da Ucraina e Finlandia: le p rovincie dell'Anatolia orienta le dovranno tornare sotto il contro Ji o de ll a Turchia e la Russia dovrà fare tutto il possibile per sem plifica -
5 1
accettarli o firmare la condanna a morte del governo sovietico 15. Dato che la Bulgaria non aveva mai confinato direttamente con la Russia e che grazie all'avanzata tedesca dell'ultimo periodo l'Austia-Ungheria si trovava a non essere più confinante con la Russia , solo Germania e Turchia beneficiarono delle cessioni territoriali derivanti dal trattato.
Tra il momento dell'accettazione dell'ultimatum e la firma del trattato, le ostilità continuarono per volontà del Comando supremo tedesco. l Turchi avanzarono nuove pretese per ottenere il controllo dei distretti di Ardahan, Kars e Batum. Fu chiesto ai sovietici di lasciare che i l destino dei distretti in questione fosse deciso secondo il principio di autodeterminazione, dato che i Turchi volevano recuperare il controllo di quelle aree, che erano passate sotto il controllo russo nel 1878. L'importanza di questa tardiva aggiunta al trattato risiedeva non tanto nella riconquista della Fortezza di Kars, la Verdun del Caucaso, quanto nel fatto che Batum era la chiave d'accesso ai giacimenti di petrolio di Baku e dell'Azerbaijan, le cui risorse in questo modo sarebbero state aperte allo sfruttamento delle Potenze Centrali. In Transcaucasia intanto , il 28 novembre 1917 , era stato creato un Commissariato, presieduto dal georgiano Gegechkori. per far fronte sia alla minaccia bolscevica, sia ali' avanzata turca. Il Commissariato ebbe la funzione di organizzare la difesa dell'arca contro i turchi, in attesa della sconfitta dei bolscevichi. I Turchi avanzavano, travolgendo le deboli difese del Commissariato mentre , contro tutte le previsio-
re 4uesto proce ss o; completa smobilitazione de ll'es ercito russo comprese le unità di nuova formazione: le navi da guerra russe che si trovano nel Mar Baltico, nell'Artico e nel Mar Nero devono immediatamente rientrare in un porto russ o oppure essere disarmate. Lo stes s o dicasi per le navi dell'Intesa che si trovano sotto il controllo russo: il trattato commerciale russo-tedesco de l 1904 deve tornare in vigore: gli affari politico - legali dovranno essere regolat i sulla ba s e della prima Convenzione Legale Russo -Tedesca che regolamentava ques tioni quali le indennità per i danni ai civili e quelle per i prigionieri di guerra. A questo proposito la Russia si doveva impegnare ad assicurare la protezione dei prigionie1i di guerra e dei prigion ieri civi li e di tutti quelli che rientrano alle loro ca s e; la Ru s sia s i doveva impegnare a cessare qual s ia s i attività di propaganda o agitazione organizzata contro le Potenze Centrali. anche nei ten itori da essi occupati; le condizioni succitatc dovevano essere accettate entro 48 ore. i l Trattato di pace doveva essere f irmato entro tre giorni e ratificato entro le due settimane success ive alla firma stessa. Whee ler-Bennet, J . W. , ci t. pagg. 255 -256
16 Petricio l i, M L'Occupa z ione italiana del Cauca so: Un ''ingrato servizio'· da rendere a Londra, in "Il Politico''. Pavia. Fase . lV. 1971, Fase. l, 1972, pagg . 11-12.

52
ni, il governo bolscevico sopravviveva 16 L'errore diplomatico più grave del Commissariato fu sicuramente quello di non dichiarare l'indipendenza della Transcaucasia subito dopo la rivoluzione bolscevica, in base al principio di autonomia delle nazionalità enunciato da Lenin, in attesa dell'Assemblea Costituente di Pi etrogrado.
Il 2 marzo, la delegazione della Transcaucasia era in attesa di partire per Trebisonda dove si sarebbero dovuti tenere i negoziati con i Turchi, quando un telegramma avvisa il Commissariato dell ' avvenuta firma del trattato di Brest-Litovsk da parte dei bolscevichi.
La firma della pace di Brest -Litovsk, i l 3 marzo 1918, da parte del governo bolscevico comportava pe r le repubbliche transcaucasichc di ri entrare nell'orbita dell'impe ro ottomanoi 7 Le tre repubbliche rifiutarono di riconoscere la validità del trattato, che venne considerato un tradimento da prute di tutti i popoli della Transcaucasia ed in particolare dagli Armen i che, da sempre perseguitati dai mussulmani, si sentirono abbandonati e beffati da l decreto con il quale , solo due mesi prima. i bolscevichi avevano riconosciuto all'Armenia turca il diritto all ' autodeterminazione; decreto che sarebbe dovuto servire a garantire la sicurezza della popolazione contro i massacri perpetrati dai mussulmani. Il 12 marzo 191 8, la delegazione transcaucasica 18 e quella turca tennero un incontro pre limin are a Trebisonda dove. due giorn i dopo, si aprì la Conferenza per negoziare la pace. Le possibilità di manovra de lla clele-
l 7 La re s titu z ione del!" Anato li a Orientale alla Turchia e dei di s tretti di Ardahan. Kars e Batum e l ' immediata evacuazio ne delle truppe rus s e s i trovano nell'Articolo IV del Trattato eli Pace di Brest-Litovsk. Cfr. Biagini, A., Storia della Turchia Comemporanea.Milano. Bornpiani, 2000. Gli Articoli 13 e 14 del Trattato supplementare firmato a Berlino il 27 agosto 1918 sanciscono l' indipenden za de ll a Georgia. La Germania si impegna a proteggere l'indipendenza della Georgia da qual s iasi attacco di una terLa potenza e a non permettere ad ak:uno l'attravers amento delle lin ee tracciate che in cl ud evano il contìne nord de l distretto di Baku fino al mare. In cambio i Ru ss i si impegnavano n potenziare l a produzione pe trol ifera e a fornire alla Ger mania un q uarto d ella produzione di greggio e derivati. Cfr. Whee1er- Bennet, J. W., c it., Appendice V TT , pag. 433.
l 8 La delegazione della Tran s caucasia era mo lt o numerosa. A questo proposito viene riportato i l commento di un soldato turco che dice: "Se questa è tutta la popolazio ne della Transcaucasia sono mo lto pochi ma se in vece è un a d elegazione rni sembra che s ia molto num erosa''. L a de legazione in realtà e ra cos tituit a da l O membr i . in rappresentanza dci dive rs i partiti politici e delle diverse etnie e religioni. Kazemz.adeh, E, The Struggle for Transcaucasia (191711921 ) , Ncw York. Oxford . 1951, pag. 93 .

53
gazione transcaucasica erano praticamente nulle. Ancora prima di aprire ufficialmente la Conferenza, Vehib Pascià chiese ai delegati della Transcaucasia di far evacuare i territori ceduti a lla Turchia dal trattato di Brest-Litovsk. La mancata dichiarazione di indipendenza rese vane le proteste di illegittimità del trattato d i Brest-Litovsk avanzate dalla Transcaucasia, che al momento della fim1a del trattato. risultava a tutti gli effetti come una parte dell'ex impero russo. I diplomatici turchi ebbero gioco facile nel sotto lin eare come, nonostante il fatto che nella reg ione fosse stato organizzato un governo indipendente quando quello russo aveva cessato di funzionare, la Transcaucasia non potesse comunque essere considerata uno stato indipendente dal momento che non esisteva alcuna dichiarazione di indipende n za. Quindi essa non aveva alcun diritto di non riconoscere la validità del trattato di Brest-Litovsk.
Le trupp e ottoma ne , mentre i negoziati andavano a vanti, continuarono la loro avanzata e con essa si inasprirono le vio lenze contro la popolaLione Armena. Le violenze perpetrate dai turchi spim.ero il Commissariato a prendere una decisione chiara dichiarando l' indipendenza e uscendo dal vicolo cieco in cui la diploma?ia li aveva cacciati. Prima di prendere una decisione definitiva, il governo decise di tentare a ncora una volta di chiedere aiuto agli Alleati contro i turchi. Solo dopo aver costata to a ncora una volta l 'indisponibi lit à di In glesi, Francesi c Americani a supportare con uomini o mezzi le operazioni militari in Caucaso. la dieta transcaucasica si decise a trattare, co ntinu ando tuttavia a rifiutare il riconoscimento di Brest-Litovsk.
Ma il tempo dei negoziati, per quanto riguardava l 'Impero ottomano, era finito. Il 5 aprile 191 8 co nseg narono il lo ro ultimatum a ll a delegazione transcaucasica nel quale s i ribadiva che solo il trattato di Brest -Lit ovsk avrebbe potuto servire come ba e per ulteriori negoziati c intimava di rispondere entro 48 ore. pena la rip resa delle o tilità. Il ministro degli esteri Chkhenkeli chiese alla dieta il permesso di accettare le condizioni imposte dai turchi e di proclamare l'indip endenza ma, ali' interno della dieta le opinioni erano co ntr as t a nti, in particolare il partito Mu ssavat, r a ppresentante dei mussulmani azeri, dichiarò per bocca di uno dei propri membri che 1· Azerbaijan non avrebbe mai combattuto contro i correligionari turchi, nonostante il fatto che gli sci iti azeri avessero combattuto per secoli co ntro i turchi sunniti. L a questione religiosa in e ra so lo una scusa che nascond eva un concreto int eresse. Gli azeri speravano, con l 'a rrivo d e i Turc hi, di s trappare Baku a l controllo sov iet ico e di riappropriarsene.

54
Il 14 aprile, un membro menscevico del Commissariato decise di mettere ai voti una dichiarazione di guerra contro l'Impero ottomano. Mentre gli altri partiti appoggiarono la mozione il portavoce del partito Mussavat, con un capo l avoro di doppiezza, dichiarò che l' Azerbaijan non avrebbe combattuto attivamente contro i turchi tuttavia, il Mussavat , non si sarebbe opposto alla dichiarazione di guerra e avrebbe fatto di tutto per appoggiare la parte "giusta", omettendo appositamente di specificare quale delle due fosse ritenuta quella giusta. Quando si anivò al voto la dichiarazione risultò unanime, ma questa unanimità non era sostenuta da alcuna unità di propositi 19 . La guena si rivelò immediatamente disastrosa per la Transcaucasia, il 15 aprile venne presa la città di Batum e il porto , alcuni forti caddero in mano turca senza opporre resistenza mentre la fortezza di Kars , considerata inespugnabi le, resistette effettivamente agli attacchi.

TI 22 apri le gli ottomani si offrirono di riprendere i negoziati interrotti, a detta di Vehib Pascià , per colpa della dieta transcaucasica.
Il Seim accettò l'offerta c allo stesso tempo si concentrò su lla questione dell ' indipenden za che ritornava in primo piano. Alla fine del dibattito, che mise in luce le profonde differenze tra i membri dei diversi partiti, fu costituita la Repubblica democratica federativa di Transcaucasia, il cui primo alto fu quello di accettare tutte le condizioni di pace poste dai turchi 20 . Il compito di formare il governo fu affidato a Chkhcnkcli che assunse la carica di primo ministro e mantenne quella di ministro degli esteri 21 . Il 28 aprile 1918, l'Impero Ot-
I<J Ka zemzade h , F., ci r., pag. IO l.
20 Tra le condizioni per la pace ricordiamo che le truppe della Tran sca ucasia avrebbero dovuto evacuare la forte zza di Kars e consegnarla in mano turca. Appena la notizia della resa della città raggiunse g li abitanti la prima reaLione fu un esodo in ma ssa della popo lazione cristiana c he temeva rappresaglie da parte dei mussulrnani . Cfr. Kazcmzacleh, F., cit pag. 106.
2 1 La lista dci ministri eli questo primo govemo de lla Transcaucasia tif1ette appieno gli equilibri di forze tra le tre etnie più numeros e della regione i Georgiani. gli Azerba ijan i e gli A rmeni. Tutte e tre le nazionalità occupano posizioni ministeriali in egual numero, quattro per ognuno, eppure i mini s teri più importanti sono tutti nell e mani di Georgian i e Aze rb aijan i (Affari Esteri, Guerra , Tras por1i , Interni, Giustizia e Contro ll o dello S ta to) mentre l'unico minis t ero importante concesso agli Am1cni fu quello delle F in anze, g li Armeni erano universa lmente riconosciuti come i piì:r abi li nelle que s tioni finanziarie. Per il resto dovettero accontentarsi di ministeri di secondo piano come quello degli Approvvigionamenti e degli Affari Sociali. Kazemzacleh.
F.,cil.,pagg. 107-10 8 .
55
tornano riconobbe la neonata Repubblica Democratica Federale di Transcaucasia.
Le trattative ripresero l'li maggio 1918 quando ebbe luogo la prima e unica seduta della Conferenza di Batum22 Dalla Turchia arrivaremo nuove pretese territoriali che scatenarono le proteste del primo ministro Chkhenkeli che aveva avuto già abbastanza difficoltà a far accettare agli altri membri del governo le condizioni d i Brest-Litovsk. Accettare il "Trattato di pace e amicizia tra l'Impero Ottomano e la Repubblica Confederata di Transcaucasia" 23 avrebbe comportato la cessione di quasi tutto il tenitorio armeno agli ottomani. In questa occasione era però presente un osservatore tedesco, il generale von Lossow, che ascoltate le richieste ottomane si fece consegnare una copia del testo del trattato ottomano, per poterlo studiare e poter tutelare gli inte ressi tedeschi nel!' area.

Nonostante l'armistizio le truppe turche continuavano l'offensiva nel distretto di Erevan, mentre a nord-est altri battaglioni cercavano eli prendere contatto con le bande azerbaijane 24 L'Armenia era completamente circondata, i georgiani avevano subito un duro colpo con la perdita di Batum, solo gli azeri non avevano nulla da ridire sulle condizioni poste alla conferenza di Batum. Il generale von Lossow propose, a nome del Reich, la mediazione tedesca per risolvere la crisi in atto. Intanto rimaneva da risolvere un 'altra questione diplomatica, quella sollevata dalle relazioni tra la Transcaucasia e la Russia. Il commissario per gli affari esteri russo, Chicherin, chiese all'ambasciatore tedesco in Russia di poter partecipare alla Conferenza di Baturn. Subito dopo, i gravi problemi eli politica interna del regime sovietico, spinsero il governo ad accettare la mediazione tedesca, non avendo forze a sufficienza da contrapporre alla Germania né tantomeno da inviare in Transcaucasia per riprendere il controllo dell'area. Le
22 La delegazione della Transcaucasia, numerosissima come a Trebisonda, era composta da 45 uomini. Kazemzadeh , F., cit., pag. 109.
23 Il Trattato in questione era composto di dodici articoli c tre appendici e da un trattato separato riguardante solo le questioni mi litari. La sezione p iù corposa riguardava le richieste tenitoria l i ottomane che comprendevano i d istretti di Akhaltsikh e Akhalkalaki controllate dal governo d i Titlis, la c ittà ed il distretto di Alessandropoli, la maggio parte del distretto d i Echnùadzin e la ferrovia Kars-Alessandropoli -Julfa. Kazemzadeh, F.. cit., pag. I l O.
24 l n me1ito cfr. illustrazione Il a pag. 57 che mostra la situazione delle forze be ll igeranti in Caucaso a l 1° maggio 1918, in AUS SME Fondo ES. R. 91, Fase. 23.
56
rela z ioni tra R u ss ia c Transcauca ia non avranno più alcuna rilevanza fi no alla fi ne dell919.

Di fronte al p iano eli mediazione tedesco si esplicitarono le radicali SIE (C ro quis)
Situa:;ione dellefor:.e belliRemnti in Caucaso all 0 d e l/9/8.
E .R A B - 1 E - U9 ende_ o :_ , e c..;, • .,.""O <w... o .. ..... l --·· ......... ----o-. ..... .....,.,.. w. •• Jo .,.._ ;-..:;...-:::.
.. o o !!! 57
differenze tra le tre anime della Repubblica federale. Gli Armeni appoggiavano fermamente il progetto tedesco come pure i georgiani, 1' A ze rbaijan si dichiarava invece assolutamente contrario a ll ' interferen za tedesca nei negoziati con gli ottomani. L' atteggiamento azero distrusse l ' unità della delegazione transcaucasica minacciando l 'esis tenza dell 'i ntera Repubblica che avrebbe potuto non superare questa crisi . Essi proposero ai georgiani un accordo a due. La Georgia rifiutò la proposta e dichiarò che se il trattato con gli ottomani fosse stato siglato, evenienza tragica per la Transcaucasia , la Georgia si s arebbe sentita libera di agire unicamente nel proprio interesse. L ' unica sa l vezza per la Georgia era rappresentata dalla protezione tedesca , che la Georgia avrebbe potuto invocare soltanto dopo aver dichiarato la propria indipendenza, i delegati georgiani iniziarono trattative segrete con von Lossow durante la Conferenza di Batum.
Il 24 maggio 1918, von Lossow inviò un telegramma alla delegazione transcaucasica nel quale dichiarava di aver offerto i suoi servigi di mediatore a Khalil Bey che però aveva rifiutato il suo aiuto. Il giorno s uccessivo sc risse di aver avuto notizie dell'imminente dissolu z ione della Repubblica federale di Transcaucasia con la quale era incaricato di negoziare e che quindi si accingeva a rientrare in patria per ricevere nuove istruzioni dai propri superiori. La partenza del rappresentante Ledesco fece precipitare la crisi, mentre i turchi proseg uivano le manovre militari la Georgia dichiarò la propria indipendenza e ufficializzò la fine della Repubb lica federale, appena un mese dopo la fondazione.
3. Protettorato tedesco in Georgia
Noi Jordani a, portavoce del Consiglio nazionale Georgia , il 26 maggio 1918 lesse l ' Atto di Indipenden za della Repubbli ca Democratica di Georgia e portò a termine la manovra diplomatica volta ad assicurare alla Georgia la protezione della Germania contro qualsiasi nuova pretesa ottomana, in cambio di petrolio e materie prime. Gli accordi preliminari tra Georgia e Germania furono firmati lo stesso giorno da Noi Ramishvili, primo ministro della Georgia, e Chkhenkeli nuova-
25 L'accordo conteneva cinque articoli o capi toli. 11 primo dice va che la Georgia riconosceva il trattato di Brest- Lito vsk come base per le proprie relazioni con la Germania: il seco ndo concedeva alla Germania l'u so de ll e ferrovie c del p<>•1<> di Poti

58
mente ministro degli esteri, con essi la Germania mise pesantemente le mani sull'economia della neonata repubblica georgiana 25
L'Armenia, dopo la dissoluzione della Transcaucasia, rimase completamente isolata e priva di qualsiasi sostegno. Il 28 maggio 1918 dichiarò la propria indipendenza ma, al contrario di quello che era successo per la Georgia, l'assoluta mancanza di risorse naturali e la povertà genera li zzata non la rendevano appetibile per nessun governo straniero. La Germania si limitò ad alcune dichiarazioni umanitarie sulla necessità di salvare la popolazione civile dai massacri , la Ru ssia protestò per le violenze subite dalla popolazione. La Georgia offrì la propria ospitalità ai profughi, ma nessuno alzò un dito per fennare le vio lenze ottomane. Quando la resistenza contro i turchi non fu più possibile perché le casse dello Stato erano vuote e l'esercito allo stremo. i delegati armeni si recarono nuovamente a Batum per firmare la pace con i turchi.
La pace con gli ottomani, sig lata il4 giugno 1918 , fu durissima per l'Armenia, che fu mutilata dal punto di vista territoriale, perdendo Kars , Ardahan, il distretto di Borchalo e parte dei distretti di Echmiadzin e Sharur e ridotta all'impotenza. Dovette inoltre cedere completamente il controllo della ferrovia Alessanclropoli-Julfa che la collegava alla Persia. Soltanto la vittoria del! ' Inte sa riportò l'Armenia acl un livello simi le a quello delle altre due repubbliche. La Repubblica georgiana, protetta dalla Germania , se la cavò con poche concessioni tra le quali, la più significativa, fu la concessione ai turchi dell'uso delle ferrovie nazionali, peraltro congiunto con i tedeschi. Nel caso dell'Azerbaijan, che era da tempo alleato degli ottomani, la fin11a del trattato avvenne solo pro forma. Il governo non perse nulla e anzi si aspettava che i turchi gli dessero man f011e per la conquista di Baku. Gli abitanti della città erano divisi in per il trasp011o di uomini e mezzi a que s to sco po le ferrovie e i l porto sarebbero stati occupati da truppe tedesche, la gestione di entrambi sarebbe s tata affidata ad una Commissione congiunta georgiana c tedesca: l 'articolo tre riguardava lo scambio di rappresentanti diplomatici: il quarto riguardava le relazioni conso l a1i; l'ultimo dichiarava che l ' accordo dalla validità immediata sarebbe stato sostituito al piLJ presto da uno più dettagliato . Infatti, nello stesso giorno, furono firmati altri tre accordi supplementari Jl primo. ant icipando !"arrivo de ll e truppe tedesche, regolamentava la libera circolazione della moneta tedesca: il secondo riguardava lo scambio dei prigionieri di gue1n: il terzo metteva a disposizione della Germania tutte le navi che si trovavano nei po11i georgiani. L'articolo due . in patticolare, is tituiva una compagnia minera1ia congiunta con il monopolio sullo s fruttamento de ll e ricchezze georgiane. Kazemzadch,F.,cit .. pagg.l22 - l23.

59
quattro gruppi etnici e politici ben distinti che avevano atteggiamenti diversissimi circa la possibilità che la città finisse in mano ai turchi. Gli A7eri che erano il gruppo più numeroso non volevano difendere Baku. dato che nelle altre province i Turchi erano loro alleati; gli An11eni che era no il secondo gruppo erano decisi a difendere la città ad ogni costo da turchi c azeri; il terzo gruppo era costituito dai Ru ssi non bolscevichi (monarchici, menscevichi. cadetti c soc iali sti rivoluzionari di destra) tutti temevano i turchi. simpatizzavano con l'Intesa e avevano una visione dci problemi del Caucaso vicina a quella europea: gli ultimi c meno numerosi erano i bolscevichi, essi volevano conservare il controllo della città il più a lungo possibile ma preferivano comunque !asciarla in mano ai turchi piuttosto che agli Inglesi dato che in futuro sarebbe stato molto più facile liberarsi dci primi piuttosto che dci secondi. È ovvio che in tali ci rcostanze ogni gruppo lavorasse per proprio co nto al raggiungimcnto dci propri scopi difTidando l'un o dcii' altro 26.
Il protettorato tedesco in Georgia durò pochi mesi. di relativa stabilità poi, con la fine della Prima Guen·a mondiale c la sconfitta degli Im peri Centrali, i presidi militari turchi e tedeschi furono sostituiti dalle truppe inglesi. L a fine della gueiTa ebbe come effetto in Transcaucaia quello di riaccendere i conflitti etnici, religiosi c politici. Gli armeni, neutralizzata la minaccia turca, diedero apertamente il loro consenso a Dcnikin e ai ge nera li controrivoluzionari; gli azeri che durante l 'occupazione turca s i e rano alleati con la Georgia mcnscevica contro i bolscevichi e i bianchi, dopo l'armi stiz io di Mudros cambiarono fronte cd il Mussavat, partito nazionalista azero di ispirazione mussulmana ed i socialisti ripresero il loro ruolo nel paesc 27 .
La dittatum centro-caspiana. un gruppo organinato dai social isti ri voluzionari di destra c sostenut o dai nazionali sti armeni. che prese il potere a Baku dopo la caduta del Sovnarkom bolscevico, invitò gli In g lesi ad assiste rli nella difesa di Baku. Il ge nerale Dun stcrvil lc, di stanLa in Persia, orga ni zzò una forza di poco pill eli un migUaio di uomini che s i imbarcò , dal porto di Enzeli, alla volta della Transcaucasia. Nel suo diario di viaggio il ge nerale annota le sue impressioni in un passaggio che, brillante esempio eli humor britannico, esemplifica alla perfezione la situazione di assoluta confusio ne regnante in Caucaso in quel difficile momento di transizione:

26 KaLcm7adeh. F., ci t pag. l :n. 27 Pctricioli, M. , ci r., pag. 20. 60
·'a British Generai on the Caspian. the only sea unploughed before by British keels, on board a ship named after a Souù1 African presidcnt and whilom e nemy, sailing from a Persian port, under ù1e Serbian flag. to rclieve from the Turks a body of Almenians in a revolutiomuy Ru ssian town"28
n generale a Baku si trovò di fronte ad una situazio ne davvero disperata, la città aveva resistito fino a quel momento solo grazie alla debolezza de l nemico, i membri della dittatura al governo, che si aspettavano uno sbarco in forze delle truppe inglesi. s i dimostrarono molto delusi dall'esiguità delle forze di Dunsterville. n 14 settembre 1918 inizia l'avanzata turca sulla città c, fin dali' inizio , appare chiaro che la città non ha speranze di resistere. Il generale Dunsterville durante la notte fa imbarcare i suoi uomini e lascia la città. La ritirata che era l ' unica mossa po ss ibile dal punto di vista della strategia militare, venne però vista come un tTadimento nei confronti di un alleato. li generale ignorava di essere stato a sua volta tradito dato che, in quello stesso momento, erano in atto trattative tra la dittatura ccntro-caspiana e i Tedeschi, affinché questi ultimi facessero da mediatori con l'alleato turco per mantenere l'indipendenza della città. I tedeschi infatti temevano che, alla presa del potere da parte dei turchi, corrispondesse un calo nella produzione del petrolio del quale la Germania aveva assolutamente bisogno e che, fino a quel momento, era stata garantita dai sovietici in ottemperanza al Trattato di Brest-Litovsk. La mediazione fallì, anche perché i turchi consideravano di per se un affronto la stessa presenza dei tedeschi in Georgja, in palese violazione degli accordi di Brest. n 15 settembre , le tmppc azere fecero in·uzione in città, massac rando in tre giorni più di 5000 cittadini armeni oltre a circa 1500 rifugiati provenienti da tutto il Caucaso , mentre il grosso delle truppe turche staz ionava appena fuori città.
4. Occ upazi o ne ing lese
La crisi della Germania su l fronte occidentale, nell'ottobre del 1918, fece crol lare l'illusione della vittoria del Reich e produ sse un
28 La nave in questione è il President Kruger. la migliore delle navi tUsse requisite nel po1to di Enzcli. Dun stervil le. L. C., The Adventures Dun\"tefjorce, London. 1932, pag. 2 l 9. Traduzione: ·'un generale britannico su l Caspio. l'unico mare mai so lcato prima da una chiglia Inglese. a bordo di una nave battezzata con il nome di un presidente Sud Africano. quindi nemico, che salpa da un porto persiano, battendo bandiera Serba, per sa lvare dai Turchj un gruppo di Armeni in una città Russa rivolu z ionaria".

61
enorme cambiamento nell'atteggiamento degli ottomani verso Georgia c Armenia. Gli ottomani si dichiararono pronti ad evacuare immediatamente i territori occupati in Transcaucasia e ad avviare rapporti amichevoli sulla base di comuni interessi. Nel novembre del 1918 la Transcaucasia, ed in particolare la Georgia, assistette alla sconfitta della Germania e dei suoi alJeati e realizzò che il proprio destino era ormai legato alle nazioni dell'Intesa. La ritirata delle truppe tedesche era stata ordinata, al contTario di quella dell'esercito russo nel J9J7J8, eppure scatenò in tutta la Transcaucasia lo spirito rivoluzionario che era rimasto sopito durante l'occupazione tedesca. La Georgia fu costretta, ancora una vo lta , ad un rapido cambiamento di fronte, per effettuarlo inviò in Svizzera un rappresentante diplomatico, per presentare agli ambasciatori dell'Intesa un memorandum riguardante la lotta dei georgiani contro i Turchi, il rifiuto di accettare le condizioni imposte dal Trattato di Brest-Litovsk, la proclamazione della propria indipendenza e la necessità dell'alleanza con i tedeschi per evitare l'invasione turca 29 Con il memorandum il governo auspicava di stabilire al più presto relazioni dirette con le potenze dell 'Intesa 30 Il 16 novembre 19 J 8 quindici battaglioni dell'esercito britannico comandati dal generale Thomson sostituirono in Transcaucasia l'occupazione tedesca.
I più preoccupati per le future relazioni con i paesi dell'Intesa erano gli azeri, alleati dei turchi, che non sapevano cosa aspettarsi dall'atTivo delle truppe britanniche. l rappresentanti del governo dell'Azerbaijan si appellarono al presidente Wilson in persona, citando i J4 punti, nella speranza di ottenere aiuto e riconoscimento da co lui che si era definito difensore dei popoli oppressi e delle minoranze. L'Azerbaijan chiese a Wilson di poter mantenere la prop1ia indipendenza ed espresse la convinzio ne che l'occupazione inglese non avrebbe in alcun modo minacciato l'integrità
29 L'occupaz ione tedesca, comunque. era stata molto pos itiva per la Georgia come testimonia una dichiarazione dci mcnscevichi georgiani a l Bureau Internazionale dci Socia listi. Dopo la sconfitta della Germania ritennero che fosse doveroso testimoniare la correttezza del comportamento delle trup pe di occupazione tedesche che non si erano mai macchiate eli alcuna violenza approfittando del proprio potere. Kazemzadeh. F.. cii .. pag. 160.
30 Kazemzadeh, F., ci t pag. 161.
31 l dati precisi su ll a dislocazione delle truppe inglesi e su l loro alloggiamento vengono fomiti a pani re dal maggio del 1919 alla Missione militare ita li ana in previ -

62
territoriale e l'indipendenza della loro patria. li governo si impegnava anc he a fornire dei congmi a ll oggiame nti per le truppe britannichc 31
li generale Thomson, dinanzi alla delegazione aL:era inviata ad Enzcli per incontrare il comandante delle truppe inglesi, fece una dichiarazione ne ll a qua le illustrava min u z iosa mcntc quali fossero le intenzioni inglesi in m e rito al le quest ioni più impo rtanti s ul tappeto. Inn anzi tutto clùese che Baku fosse evacuata dalle truppe turche e da quelle az.erbaijan e entro le l O del 17 novembre cd annunciò roccupazione della città c dci vicini pozzi di pe trolio, mentre il resto del paese sarebbe rimasto sorto il controllo del governo e delle truppe azere. L. Azerbaijan non avrebbe ottenuto il riconoscimento de jure ma Jn ghiltcn·a, Fran cia e Stati Uniti avrebbero stabi lito n o rm a li relazioni con il governo de .facto . Tutte le istitu.lioni stata li avrebbero co ntinu a to a funzionare con alcuni cambiamenti: Thomson avrebbe ass unto il ruolo di governatore ge nerale di B aku, un ufficiale inglese av rebbe assunto il comando della polizia, la Duma cittadina avrebbe continuato il prop1io operato liberamente . L'Azerbaijan, come pure l'Armenia e la Georgia, sarebbe stato ammesso alla ConferenLa per la Pace di P ruigi in base al principio dell'autodeterminazione dei popoli, nessun soldato armeno sarebbe s tato ammesso a Baku per evitare possibi l i incidenti 32
L'appello che il ge n erale rivolse alla popolazione di Baku il 17 n ovembre la sc iò perplessi e preoccupati i membri del governo e il partito Mu ssava t, in esso Thom son evitò acc uratamente di pronun ciare la parola Azerbaijan c si ri fe rì a l Caucaso come ad una provincia russa ed a ll a Ru ssia come ad un a ll eato da aiutare in un momento di difficoltà. Per qu a nt o concerneva i russi, infatti il C aucaso era a tutti g li effe tti
!>ione della sostituzione dei britannici ncll"occupazione della Tran'>caucasia. Da essi per quanto riguarda !"arca di 13a!...u. che era occupata dalla 39° Brigata di fanteria che alcuni edifici erano stati occupati mentre per ahri le truppe inglesi pagavano un affilio ai rispeuivi proprietari. In una lettera databile alla fine de l giug no del 19 19, dato che in essa si fa ri ferìmcmo a lcucre del 2 1 giugno inviate dal quartier generale della J9° brigata lo sc ri ven te. probabilmente il te nen te co lonnello del ge nio nava le Barberi. prende acco rdi per quanto ri g uard a g l i ed iri c i che le truppe ita l iane avrebbero utilizzato non appena fosse Mata presa una decisione definitiva in merito a lla missione. Nell'inventario di Barberi risulta che a Baku era possibile alloggiare in totale 287 ufficiali. l l 581 soldati e 2500 quadrupedi, di!>locali in 79 tra edifici. scuderie. cortili forniti di rcuoie c magazzini. AUS SME l ondo El l. R. 112. Fase.
16 Resoconti altrettanto deuagliari riguardo alralloggiamento delle truppe inglesi a Tillis e Barum possono e!>serc rispettivameme in: AUS SME Fondo Eli. R. l l l. Fase. l l ed AUS SME Fondo Eli. R. t 11. Fase. l. .n Kazcmzadeh. F.. cit .. pag. 164.

63
una loro provincia ed in ne ssu n caso avrebbero riconosciuto il diritto azero ali ' autodeterminazione.

Comunque , la politica inglese in Transcaucasia , nonostante i fortissimi interessi economici derivanti dalle risorse dell'area , rientrava nel più vasto ambito della politica russa della Gran Bretagna. Ogni decisio ne era condizionata dalla risoluzione della crisi ru ssa che sembrava ancora di la da venire. Ai confini del Caucaso non operavano i bolscevichi ma le forze controrivoluzionarie dei generali bianchi che si dichiaravano credi dell'Impero za rista , ciononostante Londra decise di mantenere il controllo dell ' intera zona anche quando, a causa delle tensioni in frlanda e India, le truppe di occupazione dovettero essere ridotte di numero e il fronte accorciato. Il controllo del Caucaso e lo sfruttamento delle risorse di quest'area ricchi ss ima facevano parte di un progetto politico ben preciso , già applicato in altre aree periferiche dell'ex Impero zarista, Finlandia, Paesi Baltici e Polonia, che mirava a minare lo sviluppo futuro dello stato ru ss o. bianco o rosso che fosse, per eliminare il più pericoloso avversario dell'imperialismo britannico in Asia33 . Tanto meglio poi se il baluardo difensivo delle vie imperiali era costituito da paesi ricchi di materie prime che tentavano di affermare la propria identità na zionale e che, pe11anto , necessitavano dell' appoggio degli A ll eati.
Dopo le elezioni tenute il 7 dicembre 1918 , le prime a suffragio universale in un paese mussulmano, il primo atto del neo e letto governo azerbaijano fu il tentativo , duramente osteggiato dai russi, di ottenere il riconoscimento della loro nazione dagli In glesi . Quello che ottennero fu una dichiarazione di Th omson che, il 28 dicembre, riconosceva il suddetto governo come unica autorità le gale all' interno dei confini dell' Azerbaijan 34
Mentre la delegazione georg iana a Londra raccoglieva la promessa del governo britannico di adoperarsi per vedere riconosciuta l ' indipendenza della Repubb lica transcaucasica presso la Conferenza di Pari gi, l'accoglienza delle truppe inglesi in Georgia non fu entusias tic a, a causa delle dichiarazioni del gene ra le Thomson che rifiutava di riconoscere qualsiasi fo rma zione indipendente in territorio russo e per l'e-
33 Pctricioli , M ., cir., pagg. 23-24.
34 Kazemzadeh . F.. ci r pag. 167.
35 Il programma illu strato da Thomson comprendeva sei punti , tutti in accettabili per il gove rno georgiano che tuttavia non era in grado ui opporv isi. l. re s taurare il potere in Caucaso a nome delle autorità russe: 2. lib erare il Caucaso da Tedeschi e
64
vidente ostilità inglese nei confronti del governo menscevico al potere in quel moment.o35
Batum, nel dicembre del 1918, era ancora in mano ai Turchi e soltanto alla fine del mese Thomson fu in grado di radunare un sufficiente numero di uomini da far partire da Baku per l'occupazione della Georgia. Il 22 dicembre il ministro degli esteri georgiano GegechkoJÌ scrisse al colonnello Jordan, capo della missione militare inglese a Tiflis, che il governo georgiano non riteneva affatto necessaria la presenza di truppe straniere ali 'interno dei propri confini per mantenere l'ordine ma, se gli A ll eati avessero ritenuto comunque necessaria una presenza militare in Georgia, non sarebbero stati autorizzati ad interferire in alcun modo negli affari interni della nazione. Il colonnello Jordan assicurò che , lo spirito che animava gli Alleati era in assoluto accordo con le richieste del govemo ed era rivolto semplicemente al ristabilimento della pace mondiale e della sicurezza. Avuta questa assicurazione il governo diede il proprio benestare all'ingresso delle truppe britanniche, atto quest'ultimo puramente formale dato che comunque la Georgia non avrebbe po-
bolscevichi; 3. ristabilire l'ordine senza però interferire negli affari interni della nazione; 4. ristabilire le tradizionali rotte commerciali con la Persia e con tutte le zone non occupate dai bolscevichi; 5. consentire la libera circolazione del personale militare alleato sulle fcnovie della Transcaucasia; 6. aiutare le truppe armene a rimpatriare. Kazemzadeh. F., cit pagg. 169- 170.
36 Riguardo a l governo georgiano vi è un interessante rapporto stilato dall'Ufficio informazion i dello Stato Maggiore, purtroppo senza data c senza firma ma che certamente non può essere antecedente al 1919 dato che il ministro degli Esteri è già Gegechkori. nel qua le o lt re ad una l ista completa dei membri del governo. delle loro cariche istituziona l i e dei loro partiti di appartenenza trova spazio una efficace definizione del l 'or ientamento generale de l governo che si definisce democratico ma che in realtà è di orientamento spiccatamente socialista. Il governo godeva eli una enorme popolarità tra le classi operaie e i contadini anche grazie a lla nazionalizzazione delle terre appena compiuta e da quella prossima de ll e ferrovie e delle pubbliche istituzioni. Nel documento in questione il governo georgiano sosteneva che: l. la Georgia aveva già formato uno stato indipendente; 2. nessuna decisione de ll e potenze a lleate alla conferenza della pace avrebbe potuto alterare la loro indipendenza;
3. le frontiere georgiane erano stabilite dalla storia della loro nazione (la questione territoria le di fatto creò moltissimi contrasti tra i georgiani ed i popoli confinanti); 4. tutto ciò che si trovava in tenitorio georgiano era da considerarsi eli proprietà dello stato (le dispute più accese in questo caso erano quelle con la Russia per le feiTovie ed i depositi eli mater ia le bel l ico);
5. il governo era perfellamentc in grado di mantenere l 'ordine all'intemo dci propli confini c che non necessitava, a tal fine, eli alcun aiuto es terno.AUSSMEFondoEl l .R.l l 4,Fasc.l.

65
tuto in alcun modo fermare una avanzata delle truppe britanniche se pure lo avesse voluto 36 Batum fu occupata dagli Ingle si immediatamente dopo l 'ev acuazione delle truppe turche e, nono sta nte le ripetute richieste da pa1te del governo, non fu mai restituita al controllo georgiano. La città era perennemente in preda a disordini, causati dai molti gruppi politici , fazioni e gang che contribuivano a mantenere la città in uno stato di continua agitazione. Gli omicidi erano all'ordine del giorno per motivi politici, religiosi o se mplicemente per rapina. La città era anche uno dei centri di diffusione del bolscevi s mo in Tr a nsca uca s ia e in questo si discostava enormemente dal resto della Georgia che era saldamente in mano ad un governo mcnsccvico 37

L'Armenia fu l ' unico deglì stati tran sca uca s ici ad accogliere le truppe britanniche a bracci a aperte, s perando che la vittoria alleata portasse con se la fine dei problemi per il paese , anche perché sia Balfour- durante una seduta alla Camera dei Comuni - che Clemenceauin una lettera acl un uomo politico armeno - avevano assicurato che la questione armena sarebbe st ata risolta in base al principio de li ' autodeterminazione c ai va l ori supremi di umanità c giustizia. Altre dichiarazioni s imili erano state pronunciate da Lloyd George c da Briand e da molti altri eminenti statisti, eppure, la realtà non corrispose alle aspettative del popolo armeno.
L'occupa z ione britannica38 , che pure si limitava a[ controllo delle zone s trategicamente ed economicamente più importanti quali l'oleodotto c la ferrovia Batum-Tiflis-Baku, si rivelò più gravosa del previsto a causa dei continui disordini intern i: scontri tra armen i c azeri , rivolte bolsceviche , lotte tra georgiani e truppe contro-rivo lu zionarie, guena tra Armenia e Georgia (dicembre 1918 - gennaio 1919) per il
37 La proporzione tra me nscevichi e bol scev ic hi in Georgia è opposta a quella Ru ssa. ln Georgia i Men scev ichi raccoglievano nel febbraio 19 19 il 72% dei voti nelle aree urbane e addirittura 1'82 % nelle aree rurali. li movimento soc ial-democratico in Georgia acquista un a tale rilevanza da discostarsi da que ll o russo e formare un partito totalmente se parato da quello russo. l menscevichi avevano costruito il loro partito dalla base , al contrario elci mcn sccv ichi e anche dei bol scev ichi russi c he li avevano st rutturati dall"al!o in maniera pirarniclale. Questa formazione democratica aveva fatto s i che i mensccvichi georg iani avessero un fortissimo appoggio dalle classi lavoratrici c contadine. Kazernzadeh, F., ci r. , pag. l 98.
38 Vedi in proposito !"illustrazione Hl a pag 67 che mostra l a dislocaz ione delle truppe inglesi in Caucaso a l 23 apri le 1919. A US S M E Fondo E9, R. 9 l , Fase. l l .
39 A propo s ito de ll a gue rra tra Georgia e Armenia è bene ricordare che la Georgia aveva convocato il 27 ottobre 19l8 una co nferenza a Tiflis tra tutt i gl i stati della
66
Transca ucas ia per atTi v are uni ti al l a fin e del contlillo c co nco rda re una l inea di azione co mun e in v i sta dell a Con fc ren7a el i Pa rigi . l punti p i ù imrorta nt i ali" ordin e d el gi orn o era no i seg uenti : l mu tu o r iconosc i mento d c ll" i ndipc nde nza deg l i st at i: 2. <>O i u;ione di t utte le comp re!>e quelle el i confi ne: di non st i pulare accordi dannosi per le altre Repubbliche transcauca!>iche: 4. -.olidarietà alla co n fcrcrJLa della pace per difendere gli intcrcs!>i comuni del Caucaso. li 31 ottobre r Armenia accetta di partecipare alla co n fcrcnLa co n Georgia. A;crbaijan c Montanari del Caucaso m a il IO novembre i de lega t i arm en i non sono prc-,e nt i a né arr iva alc una no ta da l governo ar me no. D opo un 'a ttesa di tre giorni l a co n fe renza di T ifl is apre il 14 nove mbre se n La !"Armen i a e qu es ta asse nza l a rend eva pr ati ca mente inutile. L ' Arm enia in realtà avrebbe pre ferit o prima chi ar i re bi l ater almente i p ropri contc n; ios i c on la G eorgia. non acce tt and o di f atto !"arbitrato di due paes i mu ss u l mani intrin seco nell a part ec i pazione all a Co n fe renza ed in seco nd o l uogo l ' Arm e ni a era co n vin ta che all oro arri vo g l i A ll eati avrebbero preso l e loro difese co ntro G eorg i a e A;erbaijan. L a guerra vera c propria \'enne sca tenata da un trucco deg l i Onomani che mandarono ai go,crni armeno e georgiano l a comunica7ione dell'ini7io dell'evacuaLio ne delle proprie truppe ma due date diver-;e. Comunicarono all' Arme n ia la da ta del 6 dice mbre e alla Georgia quell a de l 4 dicemb re così che quando le tru p pe arm ene av an7a ro no ver!>O l a Lo na co nte sa di Horc halo trovar ono le t ru p pe geo rgiane a sb arrargl i il Ka Le m zadc h , F., r ir pagg. 175 - 177.

l'
M l ... N O R ..
Siturdone delle truppe h1Kle.\i in Caucaso al 23 aprile 1919.
67
controllo dei distretti di Lori e Borchalo al momento del ritiro delle truppe ottomane39.
Il 21 dicembre gli inglesi intervennero nel conflitto armeno-georgiano ordinando un cessate il fuoco c he venne disatteso. Il giorno successivo il governo georgiano si dichiarò pronto ad accettarlo a due condizioni: l. che nel distretto di Borchalo fosse ristabilito lo status quo ante bellurn; 2. che il cessate il fuoco fosse ordinato, almeno formalmente, dal governo geo rg iano a lle proprie truppe. Una commissione mista, formata da ufficiali francesi e inglesi e da rappresentanti del governo georgiano , sarebbe andata al fronte per controllare che l'ordine fosse rispettato. I termini deJl'armistizio , stabiliti senza consultare gli armeni, prevedevano che Akhalkalaki rimanesse sotto il controllo geo rg iano e che il distretto di Borchalo fosse neutralizzato e occupato da truppe britanniche. Tali deliberazioni furono viste come un tradimento dagli armeni che avevano riposto tante speranze nell'aiuto degli Alleati. Il 31 dicembre l'Armenia accetta eli fermare il conflitto. Gli inglesi erano riusciti ad impedire che la violenza dilagasse in tutto il Caucaso dato che , appena ottenuta una fragile indipendenza, gli stati tran sca uc asici erano stati contagiati dal germe clell ' imperia! ismo. L'a ntica rivalità tra Georgia e Armenia, che raggiunse in qu esto periodo punte altissime, impedì l ' azione comune alla Conferenza della Pace di Parigi, causando enormi danni alla causa dell'indipendenza della Transcaucasia e rend endo i due contendenti assolutamente inaffidabili ag li occhi dei governi alleati.
l due Stati, per tutta la durata della Conferenza di Versailles, continuarono a lanciarsi accuse reciproche di violenze e ma ssacri, provocati ora dali' una ora clall' altra parte; accuse contenute in una serie di documenti inviati a tutte le delegazioni alleate alla Conferenza della Pace. Tali documenti per la loro contraddittorietà non fecero che aumentare il senso di sfiducia nei confronti dei deboli governi transcaucasici. La stessa trafila si ripeteva per il conflitto tra Armenia e Azerbaijan in tutti i distretti contesi, come ad ese mpio in quello di Nakhitchevan e nel Karabak dai quali, nel dicembre del 1919 , arrivavano notizie di
40 l documenti che denunciano le vio le nze, perpetrate dal!" una e dall'altra parte, so no numeros issirnj e molto dettagliati tra le ca1te de ll' archivio dello Stato Maggiore. Ques to testimonia ulteriormente che, i massacri conti nuarono anche nel 19 l 9 e nel 1920 e che i govemi transcaucasici furono se mpre attivissimi nel denunciare i mi sfa tti al trui . Ad esempio in un documento del 3 dicembre J9 19 . i l ministro degli esteri azerbaijano

68
sco ntri e massacri perpetrati a vo lte dagli armeni altre dagli azeri con l'aiuto delle truppe ottomanc40 .
L'Armenia, assediata ad ovest dalla presen.ta delle truppe turche pronte a riprendere l 'avanzata in qualsiasi momento c confinante ad est co n l 'Aze rbaijan mussulmano, dopo l a guerra co n la Georgia s iritrova com pletame nt e isola ta. il proprio territori o ridotto a l J .000 crulom et ri quadrati affollato da 600.000 profughi. Il governo armeno. in mano al partito Dashnak, ulla carta una repubblica democratica, era in realtà una dittatura ma cherata nella qua l e era no il partito ed i suoi organ i a detenere tutto i l potere. Il partito bo l cevico armeno nel 191819 19 era praticamente inesistente, a nche perché la maggior parte della popolazione viveva in aree rurali cd il proletariato non esisteva a parte a lcu ne cenri naia di lavoratori delle ferrovie. Il Comitato Centrale de l partito bol scev ico armeno si s tabilì nel 19 l 9 a Ercvan ma senza interferire con le attività del gove rno D ash nak c he. non se ntendosi minacciato. tollerava le attività dei bo lscevic hi 41 La situalione del paese era ta lm ente disperata che probabilmente nessun governo sarebbe riuscito a fare meglio, l'unico che il partito al potere poteva prefissarsi era la so prav vive nza del popolo armeno. In questo periodo di isolamen to l 'Arm e ni a ebbe come unica a ll eata l'Armata dci Volo ntari del ge ne ra le Denikin, che occupava il s ud dell'ex i mpero R usso ed era in lo tt a sia co n la Georgia s ia con l'Azerbaijan.
denuncia la rottura de l trattato di pace stipulato i l 23 novembre con il gove mo amleno. che prevedeva l'immediata ccs!>atio nc degli scontri annati c la <.la parte delle tmppe am1ene di villaggi mussulmani nel distretto di Zanguctur con centinaia di morti e prigionieri. Un documento dcl30 dicembre 1919. imiato dal ministro degli esteri armeno KhatissofT alla Conferenza per la Pa ce di Parigi. denuncia al contrario l'avanzata delle lntppc atcre verso la regione dell'Alto Akouli!. con uno sterminio quasi totale della popolaLionc <.Ici paesi attraversati dalle; truppe e la violazione evidente ddlo trallato de l 23 novembre menLi<lllato nel documento del gove rn o azero. AUS SME Fondo E li R 109, Fase. 9.
4 1 Que s ta co n vive n za conti nu a apparentemen te se n za scosse fino al maggio de l J920 quando. i l Partito Comunista Armeno rafforzatosi anche graz ie alla presa del dci bo l scevichi in A1.erbaijan. decide di mostrare la propria forn organizLan<.Io una serie d i dimostrazioni per la festa del l o maggio che culminano in scontri con i cortei del partito DashnaJ.... Il Comitato Rivoluzi onario \tabilito:.i ad Alessandropoli il 7 maggio si proclama suprema autorità in Armenia e propone al govemo di rinunciare al potere pacificamen te. l Dashnak lanciano una campagna di propaganda anti -bo lscevica che in poco più di una settimana li porta a il potere forti di una enorme partecipaLione Kazcmzadeh. F cii pagg. 2 19-220.

69
La situazione in cui si trovarono prima gli Inglesi e poi gli Italiani nei confronti di Denikin , dei bolscev ichi e delle repubbliche transcaucasiche è quanto mai intricata. Gli Alleati presero una posizione chiara, fin dal principio, solo per quanto riguardava il bolscevismo che minacciava l 'unità della Ru ss ia e aveva ormai inimediabilmente compromesso il potenziale bellico dell'esercito ex-zarista. Il generale D enikin42 venne appoggiato in quanto antagonista dei bolscevichi e favorevole ad una Grande Russia riunificata, come risulta da un rapporto sulla sit uazione della Transcaucasia del colonnello Gabba del 24 ottobre 191943 . Le potenze alleate e associate, nel maggio del 1919, avevano tentato di stabilire una politica unitaria da tenere nei confronti della Ru ssia e s i e rano rivolte all'ammiraglio Koltchak , tranùte un telegramma che portava la finna dei Quattro Grandi. promettendo il loro appoggio, qualora le intenzioni di Koltchak e dei s uoi avessero corrisposto agli ideali che li ispiravano nella soluzione delle controversie internazionali, ideali incarnati dai 14 punti di Wil so n44. Lo scopo della politica alleata in Russia era quello di riportarvi la pace e di consentire al popolo russo di riprendere il controllo dei propri affari mediante una assemblea costituente liberam e nte eletta e di rimettere pace lungo le frontiere risolvendo le dispute con i confinanti mediante l 'ar bitrato della lega delle nazioni. Accortesi che questo progetto sare bbe stato irrealizzabile trattando con il governo sov ietico, le potenze alleate si dichiararono disposte a soccorrere l 'ammiraglio Koltchak c i suoi associati. Prima di decidere qual s iasi intervento vollero assicurarsi che l'ammiraglio intendesse realizzare alcuni punti ritenuti assolutamente irrinunciabili. In primo luogo volevano che Koltchak , non appena giunto a Mosca , proclamasse un'assemblea costituente, democratica-
42 L'illu strazione 11 ° lV a pag. 71 riporta. ev iden z iata in ro sso, l a linea dì demarcazione tra le truppe britanniche e quelle del ge ne rale Denikin al 18 giugno 1919. AUS SME Fondo Eli. R. IlO, Fase. l l.
43 AUS SME Fondo El l. R. 109. Fase. 8.
44 Quello fondamentale per lo sv iluppo della politica delle nazionalità è il quattordicesimo , c he prevedeva la creazione di una Società della Nazioni "allo sropo di promuovere a tllfti gli stati, grandi e piccoli indislintamen/e. mutue garanzie d'indipenden za e di integrità territoriale. , Politica sv iluppata , con alterne fortune, durante la conferenza della pace di Parigi dato che cozzava vio lenteme nte co n le as pirazioni annessionistiche deg li Alleati. sancite dai Lrattati segreti intera lleati di Londra e S. Giovanni di Moriana, alle quali nessuno degli alleati era disposto a rinunciare. Cfr. Riccardi. L. , cit.

70
mente eletta, per governare la Russia fino a nuove elezioni; che permettesse libere e lezioni nei territori attualmen te ono il suo controllo: che non in tendesse ristabilire i privilegi di determinate classi sociali i n Russia, vale a dire che non intendesse restaurare il sistema di governo precedente alla rivoluzione; che volesse garantire l'indipendenza della Finlandia e della Polonia; che inte ndesse accettare l'autonomia di ter-
 Lo mappa mos1ra, tratteggiola in rosso, la linea di demarca-;.ione tra le truppe hri/(lllniche e quelle del generale Denikin al 18 f?Ìugno 1919.
Lo mappa mos1ra, tratteggiola in rosso, la linea di demarca-;.ione tra le truppe hri/(lllniche e quelle del generale Denikin al 18 f?Ìugno 1919.
71
ritori quali l'Estonia, la Lituania, il Caucaso c il Tran scaspio e la validità delle relazioni esistenti tra i loro attuali govern i e g li Alleati fino a che non si fosse raggiunta una soluz ione definitiva in merito ai rapporti con la Russia; che riconoscesse il diritto della Conferenza della Pace a decidere il nuovo assetto della parte rumena della Bessarabia; che facesse entrare la Rus s ia a far parte della Lega delle Nazioni; che riconosces se il debito pubblico della Ru ssia verso g li alleati accumulato durante il periodo zarista45.
La risposta di Koltchak è affidata ad un telegramma del 4 g iu g no 1919 nel quale l'ammiraglio garantì l'unità di intenti tra il proprio programma politico e le richieste degli Alleati, accettandole di fatto tutte con qualche riserva per l'indipendenza della Finlandia. P er quanto rig uardava l'autonomia del Caucaso e delle altre zone menzionate dagli alleati, Koltchak s i dichiarò disposto a preparare una sol uzione della questione che tenesse conto dell'autonomia de lle singo le nazionalità ma chiarì pure che vi sare bbero stati limiti e modalità differenti per ogni s ingolo caso. L'ammiraglio si dichiarò anche pronto ad accettare l 'arbitrato della Società delle Nazioni qu alora fossero sorte delle difficoltà. Koltchak però evitò di entrare nel dettaglio dei suoi progetti per ogni si ngola zona lasciando, di fatto, delle zone d 'om br a che ingenerarono nel presidente Wilson una mancanza di fiducia tale da impedire il riconoscimento diplomatico del potere di Koltchak , caldeggiato dallo s tato maggiore britannico46 . Alla fine di giugno, nonostante l 'ai uto ricevuto dai britannici che avevano fornito mezzi e volontari per la campagna di Koltchak, le armate dell 'a mmiraglio erano state respinte dalla controffensiva bolscevica iniziata il 28 aprile che aveva reso impossibi-
45 AUS SME Fondo Eli. R. 112, Fase. 29.
46 Pipes , R. , Il R eJtime bolscevico. Dal terrore rosso alla morte di Le n in. Milano, Mondadori. 2000, pag. 93.
47 li mancato ricon gi un girne nto dei due tronconi dell'armata bianca. coma nd at i rispettivamente da Koltchak e Denikin. e ra stato causato anche da un errore tattico del ge nera le Denikin che, davanti alla possibilità di riunir s i alle truppe di Koltchak presso Caricyn abba ndonando però la zona del Donbass e l ' armata dci cosacch i del Don al loro destino s celse di inviare solo una piccola palte della propria armata a Ca ricyn riman endo con il grosso delle truppe nel Donbass. Alrinizio la strategia sem bra dar ragione a Denikin, anche perché l'armata rossa era s tata concentrata per sco nfi ggere Koltchak lasciando sguarnito il fronte meridionale. ma alla lun ga l a separazio ne dell ' armata bianca si rivelò fatale per la vittoria della guerra contro i bolscevichi. Pipes. R cil pagg. 95 - 99.

72
le il ricongiungimento dei due tronconi dell'annata L'atteggiamento britannico riguardo all'intervento, in seguito alle sco nfitte di Koltchak , cambiò completamente. Il 12 agosto, con una mozione di Austen Chamberlain cancelliere dello scacchiere, era stato deciso di non inviare più alcun aiuto militare ali" ammiraglio e di riesaminare nel complesso la politica tenuta fino a quel momento nei confronti della Ru ssia . Il primo ministro riuscì a mediare l'antinterventismo assoluto di Chamberlain e a stabilire che, gli aiuti sarebbero continuati anche se in quantità ben definita e solo in cambio di merci o contanti 4 x.
L'ambiguità dei programmi di Denikin nasceva, invece , dalla convinzione che una compagine tanto eterogenea potesse essere tenuta assieme soltanto grazie ad espliciti appelli patriottici per liberare la Ru ssia dalla minaccia del bol scev ismo. Il consenso attorno al loro programma nasceva , secondo Denikin, dall'ideale di una Russia unica e inclivisibile, mentre nessuno avrebbe rischiato la vita per una Russia confederata. 11 rifiuto di riconoscere l'indipenden za degli stati secessionisti trae origine da questa convinzione, unita alla necessità che le questioni inerenti ai confini della Russia fos sero decise dall'assemblea costituente 49 ll generale bianco e i bolscevichi avevano in comune soltanto questo assoluto rifiuto a concedere a qualsivoglia nazionalità, che fosse stata parte della Rus s ia , l 'indipendenza.
Denikin considerava l 'occ upazione britannica della Transcaucasia come un ostacolo ai suoi progetti eli ligenerazione della Grande Russia , mentre le repubbliche transcaucasiche consideravano l'appoggio dato al genera le dagli Alleati, in particolar modo dagli Inglesi, un tradimento nei confronti delle loro aspirazioni all'autodeterminazione ed una dimostrazione della tendenza britannica al ritorno del vecchio regime in Russia . Gli Inglesi durante la loro occupazione avevano ottenuto il non invidiabile ri su ltato di attirarsi i sospetti di entrambe le parti e di scontentru·le entrambe pur avendo dispiegato notevoli forze nell'area50 . Questa, a gra ndi linee , era la non facil e situazione che la missione mjlitare italiana sarebbe andata ad ereditare sostituendosi all'occupazione b1itannica.
In una lettera datata 19 novembre J 919 il brigadiere generale Bas-
4R Pipcs. R., cit., pag. 115.
4 9Pipcs. R .,cit.,pag. 103.
50 Notizie su lla s ituazion e del Caucaso del 30 maggio 1919 a firma del capitano di fregata Granafci indirizzate al co lonn e ll o Gabba. AUS SME Fondo E li , R . l 12, Fase. 3

73
signano scrive al colonnello Gabba in merito all'opinione di Denikin sul separatismo e afferma che:
"i l Governo di Denikin non ammette altro che la Rus sia, grande, unica ed indivisibile per la quale si combatte la rude lotta contro il bolscevismo: ogni elemento che nutra sentimen ti separat isti è considerato come nemico della Grande Rus sia" 51 .
Di conseguenza venivano considerati nemici gli stati della Tran scaucasia che aspiravano all'indipendenza e tutti coloro, nella fattispecie i governi alleati, che aiutavano con forniture di materiale bellico i separatisti. Bassignano riferisce a Gabba que sta dichiarazione di Denikin a titolo puramente informativo , convinto che la missione militare italiana non fosse direttamente coinvolta in alcuna fornitura eli armi ai governi transcaucasici. n fatto di considerare le repubbliche transcaucasiche nemiche della Grande Ru ssia portava con se anche un'altra grave conseguenza per i governi alleati, esp licitata in un tele gramma di Dcnikin a Sazonov -ministro degli esteri di Koltchak - che vennero scoraggiati dallo stipulare , con i govemi del Caucaso, convenzioni per lo sfruttamento delle risorse dell'ru·ea che, venendo a ledere gli interessi della Ru ssia, non sru·ebbero mai state ratificate dali' Alto Comando di Denikin né riconosciute dal governo della Rus sia unificata52 .
Intanto per tentare di arginare il dilagare d e ll ' Armata Volontaria , la Georgia e l 'Azerba ijan il 16 giugno del 1919 firmarono un trattato, di natura strettamente difensiva, che prevedeva che, in caso di attacco ad una delle due repubbliche , l 'altra andasse in s uo soccorso con lulte le proprie forze armate53 Il trattato avrebbe avuto una durata triennale, fatta salva la poss ibilità di prorogarla oppure di rifiutru·la, propria di entrambi gli stat i contraenti. I due contraenti, nell 'articolo 6, si obbligavano a procedere eli comune accordo nei negoziati dip lomatici per la
5 1 AUS SME Fondo Eli , R. 110, Fase 6.
52 Il telegramma in questione porta la data de l 23 dicembre 1919 c viene trasmesso dal co lonn e llo Gabba al mini s tro degli ester i italian o in a llegato ad un a lettera del IO ge nnaio 1920. AUS SME Fondo E l i , R. Ili , Fase . 15.
53 A questa prima clauso la venne aggiunta una po s tilla per s pec ificare c he tale obbligo escludeva i conflitti di frontiera tuttora i11 atto tra le repubblic he transcaucasiche per la d efiniz ione de i propri confini. Impegnandosi però nell 'a rtico l o 4 a cercare di risolvere le pos s ib ili questio ni di confi ne insorge nti tra i due contraenti o per mezzo di reciproco consenso o per mezzo di arbitrato. AUS SME Fondo El l, R.liO , Fase. 6

74
difesa d eli' indipendenza e della sovranità di entrambi gli Stati54 . All' Armenia era concesso il diritto di notificare il proprio desiderio di aderire a l trattato entro due settimane dal giorno della firma. L'Armenia ovviamente non aderì al trattato dato che, considerandosi ormai una alleata di Francia e Inghilterra, si aspettava che fossero gli Alleati a risolvere i suoi problemi e a proteggerla dai possibili nemici, tra cui comunque non rientrava il generale Denikin che era sempre stato considerato un amico dagli armeni55.
Le Repubbliche transcaucasiche erano molto attente a ciò che accadeva alla Conferenza di Versai lies e attraverso le loro delegazioni, che avevano avuto l 'autorizzazione a partecipare alla Conferenza in quanto nazionalità oppresse, chiedevano insistentemente protezione e il riconoscimento della propria indipendenza e sovranità. La fiducia degli armeni negli Alleati era così tanta che inviarono a Versailles non una ma due delegazioni, una era la delegazione della Repubblica Armena, l'altra rappresentava gli interessi degli armeni turchi 56 Entrambe le delegazioni cedettero alle domande eccessive dei membri più estremisti sia dal punto di vista delle acquisizioni territoriali sia delle richieste esorbitanti di 1iparazioni 57 , so ltanto alcune voci si levarono fuori dal coro per protestare contro la politica dissennata del partito Dashnak e il nascente imperialismo armeno. La loro sicurezza nel benvolere degli alleati rese i delegati armeni inopportuni con le loro continue richieste e gli alienò molte simpatie. Intanto , gli Inglesi si stavano preparando ad evacuare la Tran scaucasia c la questione della s icurezza dell'Armenia che era garantita dalla presenza britannica, sarebbe stata materia di discussione aVersailles. I contingenti britannici non potevano rimanere nell'area fino a pacificazione avvenuta. visto che i tempi semb ravano allu ngar si indefi-
54 Cfr. AUS SME Fondo El L R. IlO , Fase. 6.
55 Kazemzadeh. F., cit pag. 246 .
56 I capi delle due delegazioni. Nubar Pasha e Avetis Aharonian, avevano id ee completamente divergenti e l'inevitabile conflitto che ne risultò rischiava di annullare qualsiasi risultato che avessero potuto ottenere. l due iniziarono a collaborare spinti dai capi della chiesa annena che avevano compreso i rischi di questa politica dissennata. Kazcmzadch, F. , cit., pag. 253.
57 Le richie ste te rritoriali anelavano dal Caspio a l Mar Nero e al Mediterraneo comprendendole città di Ardahan, Kars, Nakhjavan, Maku, Van, Bitlis, Aclana e Alessandretta li t otale delle richieste di riparaz ione delle due delegazioni ammontava a ben 19 miliardi di franchi e per quanto incredib ili fossero q ueste richieste. gli Armeni speravano veramente di poterne otte nere la maggior parte. Kazemzadeh, F., cir., pagg. 255 -257.

75
nitamentc. Il governo armeno, resosi conto che gli In g lesi si sarebbero effettivamente ritirati !asciandoli in balia di vicini tutt'altro che amichevoli, iniziò a cercare una potenza straniera a cui affidare il mandato per la protezione del proprio tetTitolio. La Francia non voleva alcun coinvolgimento, l'Italia di Nitti si era appena tirata fuori dall'avve n tura transcaucasica, l 'unica potenza rimasta erano gli Stati Uniti che in passato s i erano dimostrati benevoli nei confronti dell'Armenia. Il presidente Wilson, che non era contrario all'idea, inviò il generale H arbord in missione in Turchia e Transcaucasia per farsi una opinione sulla fattibilità dell'impresa. L'opinio ne del generale fu decisamente contraria per due distinte ragioni: la prima era l 'elevato numero di uomini e mezzi da i n viare nell'area per mantenere l'ordine, dai due ai quattro reggimenti come minimo 58 ; l a seconda ragione riguardava le vie d'accesso al l a Transcaucasia, essenz ia l mente tre Persia, Russia e Turchia, dato che le prime due erano al momento assolutamente impraticabili una eventuale potenza manda taria, per non rimanere priva di vie d'accesso, avrebbe dovuto controllare anche Costantinopoli senza la quale sarebbe rimasta completamente tagliata fuori dall'occidente e priva di aiuti. Nonostante il parere negati v o di Harb ord, i l presidente Wilson , n eli' aprile del 1920, decide di accettare il mandato. La sua decisione avrebbe dovuto essere ratificata dal Se na to degli Stati Uniti che però 1ifiutò la proposta del presidente e quindi il progetto fu definitivamente abbandonato 59 Le Iichieste a rm ene vennero liquidate co n una ce11a freddezza collegandole alla soluz ione del prob lema russo nel complesso .
S. Il mandato italiano
l membri della mi ssione militare italiana, giunti a Tifl is il 12 magg io 1919 , dopo un a co n citata fase preparat01ia che è ili ustrata in maniera particolareggiata nel terzo capito lo , ve nnero acco lti calorosamente dall e autorità locali, che erano state messe a l co rrente dalla miss ione militare ing lese della pross ima sost itu zio ne delle loro truppe con co ntingenti italiani . Così facendo gli In glesi avevano contravve nuto all'e-

58 L a stima appare corretta dato che corrisponde anche a quella sti l ata in precedenza dalla missione del co lonnello Gabba che aveva effettua to indagini e ricerche accuratissime in previsione dell'occupazione italiana dell'area.
59 Kazemzadeh. F., cit., pagg. 261 - 263.
76
s pli cita vo lontà di riserbo espressa dal Comando sup remo italiano per il quale la missione in atto, compiuta da un ristretto numero di uomini, aveva ancora solo una funzio ne esplorativa della fattibilità dell'impresa dal punto di vista militare c della possibilità di ottenere concessioni, po ss ibilm e nte monopoli st ic hc , per l o sfruttamento del le ri so rse minerari e e petrolifere de ll 'area60 . La palte più cospicua de l lavoro compiuto dalla mi ss ione del colonnello Gabba. che rimanà, di fatto, una missione esp l orativa, è costituita da una palte dali' intenso lavoro diplomatico per prendere contatto e stabilire relazioni cordiali con i governi delle repubbliche transcaucasiche. dall'altra dalle numcrosissime relazioni mine rarie. econom iche c industriali stilate in brevissimo tempo dagli cspclt i di settore a l seguito della missione. II progetto di occupazione mi lit are rimarrà so lo s ull a ca rta per deci s ion e del gabinetto Nitti, ma l 'ott im o lavoro diplomati co svo lto in previsione eli uno sfruttamento eco nomico e commerciale cie li 'arca, fu ricono sc iuto anche dal nuovo gabinetto intenzionato a sfrull are i contatti con le autorità locali per una penetrazione economica indipenden te dall'occupazione militare. Per tale scopo la mis ione non venne annullata ma trasfo rm ata in R egia agenzia politica sotto la guida dello stesso Gabba.
Imm edia tame nt e dopo il loro arrivo, il colonnello Gabba e gli altri ufficiali incaricati della missione presero con tatti con i govern i delle tre rep ubbliche per illustrare g li scopi dell 'eve ntual e occupaz ione italiana. Interessan te a questo p roposito il p ro memo ri a s til ato dal capi tan o di f rega ta Granafei , capo de ll a missione navale , c h e rip or ta il resoconto dell'incontro avu to co n il m ini stro presidente dell'Aze r baijan. Granafei illustra lo sco po della missione it aliana, che era principalmente il mantenimento dell'ordine e la protez ione de ll e repubbliche da poss ibili att acc hi es terni c h e min acciassero il libero sviluppo del paese. Prim a di decidere in merito all'invio delle truppe il governo ita l iano vo le va sincerarsi del fatto che sarebbero s tate ben accette dalla popolazione e che vi sare bbe stata una reciproca conve ni e n za; re c iproca conve ni enza sig nificava per l'It a li a li be rt à di poter otte nere co n cess ion i per lo sfrutt amento delle risorse e libertà di comme rcio ; per l ' Azcrbaij <ln, come per le altre repubbliche. s ig ni f icava invece protezione c rico n oscimento della propria indipend enza. Granafei non aveva ancora pronunciato l a parola indipe n denza e quando, spi nto dal s uo int e rlo cuto rc , s i vide co-
60 AUS SME Fo nd o E Il , R .I II. Fase. 2 Le questioni inerenti l"organinazione della missione in ogni s uo aspetto trattate diffusamente nel capitolo lll.

77
stretto a farlo dichiarò che la decisione in merito non spettava solo all'Italia ma alle quattro potenze alleate e che Ja decisione arebbe arrivata dalla Confere n za di Parigi ma aggiunse che, a suo parere, non avrebbe avuto senso per l'Italia inviare truppe in un paese del quale non si vo lesse riconoscere l'indipendenza. Soddisfatto dalle risposte politiche, il ministro presidente assicurò il cap itano circa la possibilità di ottenere concessioni petrolifere c accordi minerari "purchè siano specificate e non siano compresi in termini vaghi" c contestualmente chiese aiuti per la rimessa in efficienza delle ferrovie e per la que t ione agraria 61
Questa conversazione all"apparcnza assolutamente favorevole all'Italia sia dal punto di v ista politico che economico nasconde diverse ambiguità da entrambe le parti. Come sottolinea lo stesso Granafci, alcune esp ressioni "ingenue e sincere si .frammischiano ad altre che potrebbero essere tendenziose". Le assicurazioni in merito alle co ncessio ni si rivelarono tendenziose anche a causa dei dazi ai quali il ministro accennò nella conversazione, che venivano app li cati sulle esportazioni e non sul le importazioni, tanto da rendere i l prezzo preteso per le materie pri mc tutt'altro che competitivo. Come riferito dal m ini stro presidente la situazione de ll e esportazioni petrolife re era molto grave dato che prima della rivoluzione la maggior patte della produzione veniva assorbita dall'ex Impero russo mentre adesso giaceva nei depositi invcnduta anche a causa delle enorm i difficoltà per il trasporto del petrolio tìno al Mar Nero. Questo accen no potrebbe essere una vaga anticipazione per preparare g li italiani agli nltissimi prezzi del gregg io c della nafta di Baku . Da parte italiana vi so n o nella medesima conversaz ion e. almeno due grosse ambiguità, la prima riguarda la questione della funzione difensiva delle truppe italiane contro gli attacchi estern i , intc i dagli azeri come provenienti da Denikin o dalle truppe bolsceviche. la ri po ta di Granafei alla domanda diretta del ministro è un capolavoro eli doppiezza: " H o de!fo da attacchi che l'enisse ro da fuori" 62 . Ma non ci è dato eli sapere se un attacco dei volontari di Denikin, piuttosto che uno bolscevico, non sarebbero invece stati conside rati in temi, trattandosi di una g uerra civile. Il seco ndo punto controverso ri g uarda invece proprio il riconoscimento d e ll'indipendenza delle tre repubbliche; Granafci non mente riferendo che la decisione spetta a tutti gli AJleati riuniti a Pari gi ma omette ovviamente di accennare che g li A ll eati, che speravano ancora in una vittoria di D enik in , avevano tutte le

6 1
62
78
AUS SME Fondo Eli, R. Ili. 18.
AUS SME Fondo El l . R. Ili. Fase. 18 pag. 5.
intenzioni di temporeggiare per vedere se il generale fosse riuscito a sconfiggere i bolscevichi. Illiconoscimento arrivò quando onnai la sconfitta dell'Armata volontaria era palese e gli Alleati vi Iicorsero per tentare in extremis di bloccare l'avanzata bolscevica.
L' ottima accoglienza 1iservata alla mi ss ione militare italiana dalle autorità locali, oltre che alle capacità diplomatiche di Gabba e dei s uoi collaboratori, è senza dubbio dovuta alla consapevolezza dei governanti della propria incapacità di fronteggiare possibili attacchi esterni provenienti dai loro innumerevoli nemici, fo ss ero essi bolscevichi , turchi oppure i volontari di Denik:in. Anche la mis s ione italiana, come era accaduto in precedenza agli Inglesi , s i trovò ben pres to invi schiata in una rete di richieste di aiuti militari e protezione, diffide e minacce provenienti ora dali 'una, ora dall ' altra parte. Il Govemo italiano, considerata la posizione di Denikin che avrebbe considerato qualsiasi aiuto militare ai governi caucasici come atto non amichevole nei confronti del! ' Armata Volontaria , decise di non iniziare alcuna azione impegnativa che fidasse solo s ulla s tabilità dei governi provvisori, sospendendo qualsiasi domanda per ottenere concessioni, né si impegnò a rifornirli di armi ma si limitò all'invio eli biancheria , automobili e aeroplani da trasporto come risulta da un telegramma inviato dall ' allo commissario Sforza alla missione militare italiana a Tiflis in data 3 novembre 19196 3 .
Allo stesso Sforza pervennero lettere di protesta da parte del generale Agopaiew, rappresentante di Denikin a Costantinopoli, riguardo a presunte forniture di armi italiane a lla Georgia, puntualmente smentite dopo accurata indagine dall'alto comm issariat o stesso. Le armi in questione risultavano imbarcate nel porto di Genova al la volta eli Poti su un piroscafo, l ' Anatolio FeiTero, che ad un successivo controllo della capitaneria italiana, a firma del capitano Fiore , non risultava essere entrato nel M ar Nero dopo l 'a rmistizio. Il capitano a questo proposito ipotizza che potesse trattarsi di altro piroscafo che si fosse fatto sc udo del nome e della nazionalità italiana per e ludere le ricerche 64 P er quanto riguarda l'atteggiamento del Governo italiano, esso aveva opposto un netto rifiuto alla fornitura di armamenti ai gove rni del Cauca-

63 AUS SME 1-'ondo E l l , R. 11 4, r:asc. 4 .
64 AUS SME Fondo El l. R. 114, Fase 4.
65 Ri s pos t a dell'Alto Comm iss ario italiano alla richiesta di informazioni in rnc1ito alle presunte conseg ne di materiale be llico alla Georg ia rivoltag li dal capo della mj ss ione russa a Costantinopoli. s ignor Tcherbatskoi. AUS SME Fondo E l l , R . 114 , Fase. 4.
79
so e si atteneva alle disposizioni del Consiglio supremo che aveva interdetto l'invio di materiale beJlico ai porti deJ Mar Nero 65
Le relazioni della missione militare italiana concedono tantissimo spaz io agli scontri con D enikin ed a ll e difficoltà delle repubbliche sia interne che nei rapporti tra di esse, mentre si occupano pochissimo del pericolo rappresentato dai bolscevichi alme no fino a ll'inizio del 1920. Evidentemente le ge rarchi e militari italiane non riteneva no probabile una affermazione dell'armata rossa che guardavano co n un certo disprezzo; intluenzati in questo anche dai governi caucasic .i che erano molto più preoccupati dall'avanzata dì Denikin che rappresentava, ai loro occhi, la secolare oppressione degli zar 66 .
Il fallimento del generale Denikin aleggia dietro l'improvviso riconoscimento de facto dell'indipendenza delle repubbliche Transcaucasiche. La Georgia e l'Azerbaijan ottengono il riconoscimento nella seduta del Consiglio s up remo del l O gennaio 1920, la notizia, viene accolta nelle repubbliche con enorme entusiasmo, le città sono imbandierate a festa e dimostraz ioni di giubilo , popolari e militari, animano le stradé7 L'Armenia russa ottenne lo stesso riconoscimento nella seduta del 19 gennaio, con la riserva però di deciderne il definitivo assetto assieme al trattato con la Turchia68 L a notizia del riconoscimento, divulgata in maniera errata da fonti britanniche, ingenerò una certa dose di imbarazzo nelle delegazioni americana, francese e italiana come venne sotto lin eato dal co lon nello Gabba, che chiese un intervento del consiglio supremo per dirimere l'equivoco. Ad ingenerare tale confusione era stata la dichiarazione dell'alto commissario britannico Lord Curzon che non accennava affatto a li 'indipendenza ma unicamente al riconoscimento de facto dei gove rni , m ent re la stampa e la popolazione avevano interpretato la notizia come relativa all'indipendenza 69 . Riman eva no ancora da discutere le questioni
66 Petricioli, M., ci t .. pag. 60.

67 Telegramma del colo nnell o Gabba, datato 13 gennaio 1920, per il ministro degli es teri. AUS SME Fondo El i , R. 108, Fase . 4.
68 Telegramma del presidente del co ns iglio Nitti di retto all'alto commissario Sforza, datato20gcnnaio 1920.AUSSMEFondoEJI,R.lJ4,Fasc . ll.
69 Telegramma del co lo nn ello Gabba, datato 19 gennaio 1920 , per il ministro degli esteri. AUS SME Fo ndo El l, R. 10g, Fase. 4.
80
dei confini né era stato compiuto ancora alcuno scambio di rappresentanze diplomatiche.

11 12 gennaio del 1920, alla prima riunione del Comitato militare alleato, presieduta dal maresciallo Foch 70 , si discutono gli aiuti da inviare alle repubbliche di Georgia e Azerbaijan contro l'avanzata delle truppe bolsceviche. 11 comitato, oltre al riconoscimento di Georgia e Azerbaijan già compiuto, propose di deviare verso le repubbliche tutto il materiale, attualmente in viaggio, diretto a Denikin; di concedere alle repubbliche aiuti finanziari, materiale bellico c approvvigionamenti di derrate; di inviare i necessari soccorsi militari per impedire ai bolscevichi di ottenere il controllo del Mar Caspio. Al tem1ine della discussione il comitato decise di continuare ad inviare gli aiuti militari ai cosacchi del generale Denikin. che ancora opponevano una buona resistenza all'avanzata bolscevica , per poter contemporaneamente organizzare un solido sbarTamento in Caucaso. Gli aiuti alle repubbliche per il momento non dovevano , per alcun motivo, andare a detrimento delle truppe cosacche 71 . In ogni caso divenne ben presto chiaro che gli Alleati ormai guardavano al problema della difesa della Transcaucasia solo come parte del problema russo nel suo complesso, che era a sua volta adombrato dai problemi interni dei singoli stati, dalle rivalità tra gli alleati e dai problemi inerenti la costituzione della Lega delle Nazioni 72
La riconquista della Transcaucasia, alle cui risorse la Russia non aveva mai accennato di vo ler rinunciare, fu compiuta dai bolscevichi con un attacco in due fasi. All'attacco dall'esterno si combinava, come e ra tradizione della propaganda comunista, la sovversione interna . L'az ione dip lomatica nei confronti della Turchja di Kemal Ataturk, volta ad
70 I l maresciallo F och, rappresentante francese presso il Consiglio Supremo di Guerra. creato dagli Alleati nel 1918 come organismo di coordinamento tra g li Stati Maggiori , aveva il compito di presiedere l 'esecutivo che coordinava l'invio delle truppe di r iserva su i vari i fronti a seconda delle necessità. Questa risoluzione che di fatto a lterava g li equilibri tra gli Alleati t og li endo potere decisionale agli Stati Maggiori era stata forteme n te os t eggiata da Orlando e Son n ino. Riccardi. L, cii., pag. 587
7 1 Promemoria d ella prima riunione de l Com itato Mi litare Alleato. tenutasi il 12 ge n naio 1920.AUS SME Fondo ES, R. 91, Fase. 5. 72 K azern7 adeh, F., ci r., pag. 273.
6. S ov ieti zz azi on e de ll a Tran sca ucas ia
81
assicurarne una benevola neutralità, consentì alla Russia sovietica di riaffermare il proprio dominio sul Caucaso senza sco ntri. In cambio Kemal ottenne l 'im pegno di Mo sca di astenersi dalla propaganda comu nista in Turchi a e la garanzia di un appoggio contro le potenze allcatc 73
I preparativi per l a ca mpa gna vera e propria iniziarono dopo il 17 marzo del 1920, quando L enin ordinò di procedere aJia riconquista dell'Aze rbaij an c della Georgia. Per la conqu is ta del potere nelle tre repubbliche era previsto l 'impiego dell'XI Armata rossa, eli distaccamenti partigiani e della sovversio ne interna. In fatt i, in una comunicazione del mini tero degli esteri italiano alla regia agenzia politica, si affermava che un membro della delegazione bolscevica a Copenaghen aveva dichiarato, in data 27 aprile, che appena avessero assicurato la pace sul fronte polacco i sovietici avrebbero rivolto tutte le loro forLe con tro Georgia c Azerbaijan c h e erano assolutamente indispensabili alla Rus sia74 L a prima delle repubbliche a cadere, il 27 aprile 1920, fu l'Azerbaijan. La truppe dell'Xl Armata rossa entrarono a Baku scnLa incontrare re is tenza. dato che i l grosso dell'esercito azero s i trovava in Karabagh impegnato in una guerra fratricida contro l'Armenia. Ordzonikidze introdusse un regime di t errore e so ffocò ogni sacca eli resistenza nel sa n gue. L'avanzata dell'XI Armata fu frenata dallo sco ppio del confl itto russo-polacco. Le truppe. che era n o appena penetrate in territorio georgiano, furono ritirate dalla Transcaucas ia e inviate a difendere Ki ev minacciata dai polacchi. La Georgia e l'Armenia ebbero così l ' illu s ione di un periodo di tregua.

Non potendo procedere immediatamente alla conquista della Georg ia i bolscevic hi prepararono un trattato, sig lato dal gove rno geo rg iano il 7 maggio , con il quale riconoscevano l'indip endenza della Georgia e rinunciavano a qual iasi interferenza negli affari interni del paese, a l prezzo però di un asservimento preoccupante a lla Ru ssia in politica es tera, nonostante le assicurazioni del governo georgiano di non vole r accettare alcuna cla uso la che potesse limitare la propria sovranità c minare i buoni rapporti con le potenze dell'l n te sa. l l nodo del contendere era l'articolo V del trattato , con il quale la Georgia semb rava aver assunto l'obbligo di intervenire contro la presenza s ul proprio territorio e
73 Pipcs , R .,cil.,pag.185.
74 AUSSMF.FondoEII.R.II5,Fa sc. l 3.
75 Nota collettiva elci rapprese ntanti de ll e potenze alleate al gover no georgiano, durata 15giugno 1920.AUSSMEFondoEII,R.III.Fasc l2.
82
nelle acque nazionali di navi, persona le e rappresentanti di "pae s i alleati con La Russia " 75 Il ministro degli esteri georg iano ass icurò che il trattato, c he doveva ancora essere ratificato dali' Assemblea Costituente, sarebbe stato modificato in ogni c l ausola che potesse minare il rappOito di amici z ia con l ' Intesa e soprattutto chiarì che con l'espressione "paesi alleati con la Russia" dovevano intendersi le repubbliche forma tes i dalla disso luzi one d eli ' Imp ero Ru sso come l 'Ucraina76 Nonos ta nte le rassicurazioni del ministro georgiano i commenti dei commi ssari a ll ea ti e ra n o allarmati dall'ambiguità delle clausole che avrebbero potuto cos trin gere l a Georgia a intraprendere qualche az ione contro g li alleati ed a chiedere l'aiuto dei sovietici 77 Il trattato conteneva inoltre una clausola segreta con la quale l a G eorgia si impegnava a rico n oscere il d iritto ali' esistenza del partito comuni sta e la sua libertà di azione . Senza dubbio la concessione più grande fatta ai sovietici78 .
Il mese successivo , Mosca ri conobbe anche l ' indi pendenza dell' Armenia la c ui soviet izzazione avvenne invece a causa di una contesa territoriale con i Tu rchi in Anatolia centrale. Gli armeni ebbero l a peggio e furono costrett i ad invocare la pace. Durante lo svo l gimento, in novembre, delle trattative con i Turchi l'Armata rossa entrò in Armenia ma l'invasione fu interpretata come difesa contro le pretese turche79 Il 29 novembre l 920 ve nn e proclama ta l a R epu bbli ca socialista di Ar me ni a, il govemo Dashnak co ntinu ò a funzionare a Erevan fino alla c reaz ion e del governo sov iet ico di coa li zio ne tra com uni s ti e Das hnak Ro c h e però durò so lo pochi gio rni prima di esse re tra sforma to in un governo puramente bolscevico. L a sov ie ti zzazio n e procedeva con passo sempre più s p edito ma i mezzi utilizzati dai bolscevichi, epurazioni, a rresti, requi sizio ni di derrate produssero una rea z ion e forte tra la popol azio n e che si e r a p receden t eme n te piegata se n za oppo1Te re s i s tenza. La scintilla che fece esplodere la ri vol t a anche in Armenia fu la g uerra ru sso - geo rg i a na del 192 1.
76 Ri sposta di Gegechko1i alla nota collettiva dei rappre s enta nti delle potenze al lea te al governo georgiano, datat a 15 gi ugno 1920. AUS SMEFondo El l. R. Ili, Fase. 12.

77 Teleg ram ma del colonne llo Gabba. da t a to 9 giugno 1920. per il m in is t ro degli es ter i AUS SME Fondo Eli. R. 11 5, Fase. 13
78 Kazemzadeh. r., cit .. pag. 299.
79 In m e rito cfr. Pipes. R., cit pag. l R7 e K azcrnzade h , F., cit., pagg. 287-289.
80 La composizione del nu ovo gove rn o prevedeva 5 comu ni st i e d ue espo nenti del part ito Dashnak. K azemzade h , F. cit , pag. 290.
83
rl governo georgiano, che di per se non temeva il debole partito comunista georgiano se n on per la sua associazione con quello sovietico, non poteva in alcun modo accettare c he i suoi membri operassero per rovesciare il governo e per in citare la popolazione alla rivolta 81 . Le motivazioni dello sco ntro possono essere riassunte in cinque punti fondamenta l i: l). le relazioni del governo menscevico geo rgiano con WrangeiR 2 ; 2) la questione di Batum , riguardante le voci di una possibile cessione di Batum agli In glesi, che sarebbe stata considerata da Lenin come una flagrante vio lazi one del trattato del 7 maggio; 3) tran ito dei tre ni ru ssi diretti in Arme nia; 4) i diritti del p artito comunista geo rgiano, riconosciuti dalla clausola segreta de l trattato del 7 maggio; 5) dispute di fron ti era8 3
La Georgia era circondata cd all'interno i comun is ti stava no preparando un'insurre zione armata, bloccata in extremis da un ordine dello s tesso Lcnin che, a suo dire. p e r seguiva nel Caucaso una politica di pacificazione. Ormai il governo georgiano aveva perso qualsiasi speranza in un co ncreto aiuto militare da parte clegl i alleati. L'uni co gesto concreto fu il ri co n oscime nt o de jure della Georgia da parte del Consiglio supremo degli alleati. avvenuto il 27 gen n aio 1921. Il 7 febbraio. durante il banchetto per i festeggiamenti di rito, alla presenza dei rappresentanti degli alleati. il delegato russo Ka vtaraùzc dichiarò che la Ru ss ia era felicissima del riconoscimento alleato cd es presse la sua convinzione che anche i rapporti con la Russia , vicino s torico della Georgia, non avrebbero potuto che trarne giovamento. Tn quello stesso momento la XI Armata rossa s tava preparando l ' inv asio ne in forze della G eorgia .
Per prima cosa ci fu una ribellione della popolalione scon te nta , sobillata dal partito comu ni sta georgiano. L'invasione vera c propria iniz iò i l 16 febbraio 192 1, quando alcune unità della X l Armata penetrarono in Georgia dalla frontiera dell'Azerbaijan puntando direttamente
!Il Ka ze mzadeh. F. , cii .. pa g. 308.
82 li gove rno georgia no sost iene che le uniche relazioni esistenti con Vacheishvili, emissario di Wrangel. erano state di carattere economico per acqu istare grano e frumento. Kazemzadeh. F.. cit pag. 303.
83 Pare che ci fosse stato un epi-;odio di scambio reciproco di fuoco tra i soldati georgiani e quelli russi alla frontiera. Dopo una attenta investiga7ione del caso si scoprì che l'incidente era nato da una incomprensione e che la colpa era da imputarsi adentrambi e non come era stato detto ad una volontà dell'esercito georgiano di attaccare l'Armata rossa. Kazem zadeh. F.. cit., pag. 3 11 .

84
verso Tiflis; l'esercito georgiano resistette per una settimana ma il 25 febbraio dovette arrendersi alla superiorità numerica dell'Armata rossa che entrò nella capitale prendendone possesso84 . Subito dopo Lenin inviò a Ordzonikidze ordine di armare i contadini più poveri e di formare una Armata rossa georgiana, di non compiere atti di violenza contro l'intellighenzia e i mercanti e di cercare di venire a patti con i membri menscevichi del governo che, in passato , non si erano dichiarati contrari ad un regime sovietico , questo a dimostrazione della scarsa fiducia nutrita da Lenin verso il nascente partito comunista georgiano, considerato ancora troppo debole per poter reggere da solo il paesé5 L' attacco sovietico alla Georgia produsse anche un effetto inaspettato in Armenia dove scoppiò una rivolta contro i bolscevichi, per le condizion.i inumane nelle quali avevano costretto la popolazione.
Il 18 marzo 1921 fu fim1ato il trattato tra la Russia e la Georgia. I termini del trattato furono abbastanza blandi ; fu concessa una amnistia generale ai membri menscevichi del governo e anche le truppe furono reinserite nei ranghi dell'Armata rossa. Termini tanto blandi furono giustificati dalla necessità di conquistare la fiducia dei georgiani che consideravano i sovietici degli invasori a tutti gli effetti. Il governo menscevico, molto amato nel paese, non sarebbe ce11amente caduto solo per mezzo della propaganda comunista senza un intervento armato.
Il governo sconfitto lasciò Batum , nella notte del 17 marzo, a bordo di una nave italiana dopo essersi rifiutato di entrare in un governo di coalizione con i bo lscevichi. Conquistata la Georgia i sovietici si volsero contro l'Armenia per soffocare la rivolta, 1ipresero il potere a Erevan il 2 aprile, mentre proseguivano i combattimenti nella regione montuosa eli Zanguezur. Le sacche di resistenza furono piegate dalla enorme superiorità sovietica e ai sopravvissuti non restò altro che passare il confine e rifugiarsi in Persia.
La Lega delle Nazioni levò delle inutili proteste che non ebbero alcun effetto, per il resto il mondo rimase indifferente alla sorte della Georgia e di tutta la Transcaucasia ormai stabilmente in mano ai sovietici.

84 Pipes , R., rit. , pag. 190. 85 Kazemzadeh, F., cit. , pagg. 323-325. 85

La mis sione militare italiana . As petti organizzati vi
Il ritiro delle truppe inglesi da Siria, Caucaso e Kurdistan, annunciato da Lloyd Georgc al Consiglio dei Dieci fin dal 30 gennaio, viene discusso, esclusivamente nei suoi particolari tecnico - militari, nel corso della 53° seduta del Consiglio Superiore di Guerra - Sezione Militare (4 e 5 febbraio 1919) e definito ormai imminente. l rappresentanti militari delle Potenze Alleate alla fine della seduta del 5 febbraio l 919, già illustrata diffusamente nel primo capitolo, affidano ali' Ital ia il mandato su Caucaso c Konia che dovrebbero essere occupate da due divisioni di fanteria 1 •
Il gabinetto Orlando caldeggiò vivamente l'occupazione militare italiana della Transcaucasia e spinse per affrettare la preparazione di una missione esplorativa, composta da esperti militari e civili, da inviare nell'area per raccogliere, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni necessarie alla quantificazione delle truppe necessarie all'occupazione e per vagliare la disponibilità dei governi locali a stipulare concessioni per lo sfruttamento delle risorse, in particolare petrolifere e minerarie dell'area2 Il Caucaso era visto dal governo italiano, prima di tutto, come un territorio da sfruttare per tentare di soddisfare la "fame" di materie prime scoppiata nel paese all'indomani dell'armistizio; materie prime che sarebbe stato possibile ottenere mediante uno
1 Le fonti uti l izzate provengono dall'Archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito (da ora in avanti AUS SME). Da molti anni in seno alla storiografia intemazionalc tali documenti sono stati valutati come valide fonti. Cfr. in merito l'intera produzione di A. Biagini.
2 Vedi in merito una lettera a firma Orlando del30 marzo 1919, indirizzata al ministro Caviglia. Orlando asserisce che: "La prima operazione da compiere per quanto riguarda la questione Caucaso consiste nell'inviare una Missione militare che avrà l 'incarico eli studiare, insieme con il comando Inglese, la dislocazione, l'alloggiamento e il vettovagliamento per le ns. truppe; a ll o stesso tempo dovrà inviare notizie sul la situazione politica in loco e tutte le a ltre indicazioni economiche e commerciali che possano essere utili." AUS SME Fondo E8, Raccog litore 91, Fascicolo 20.
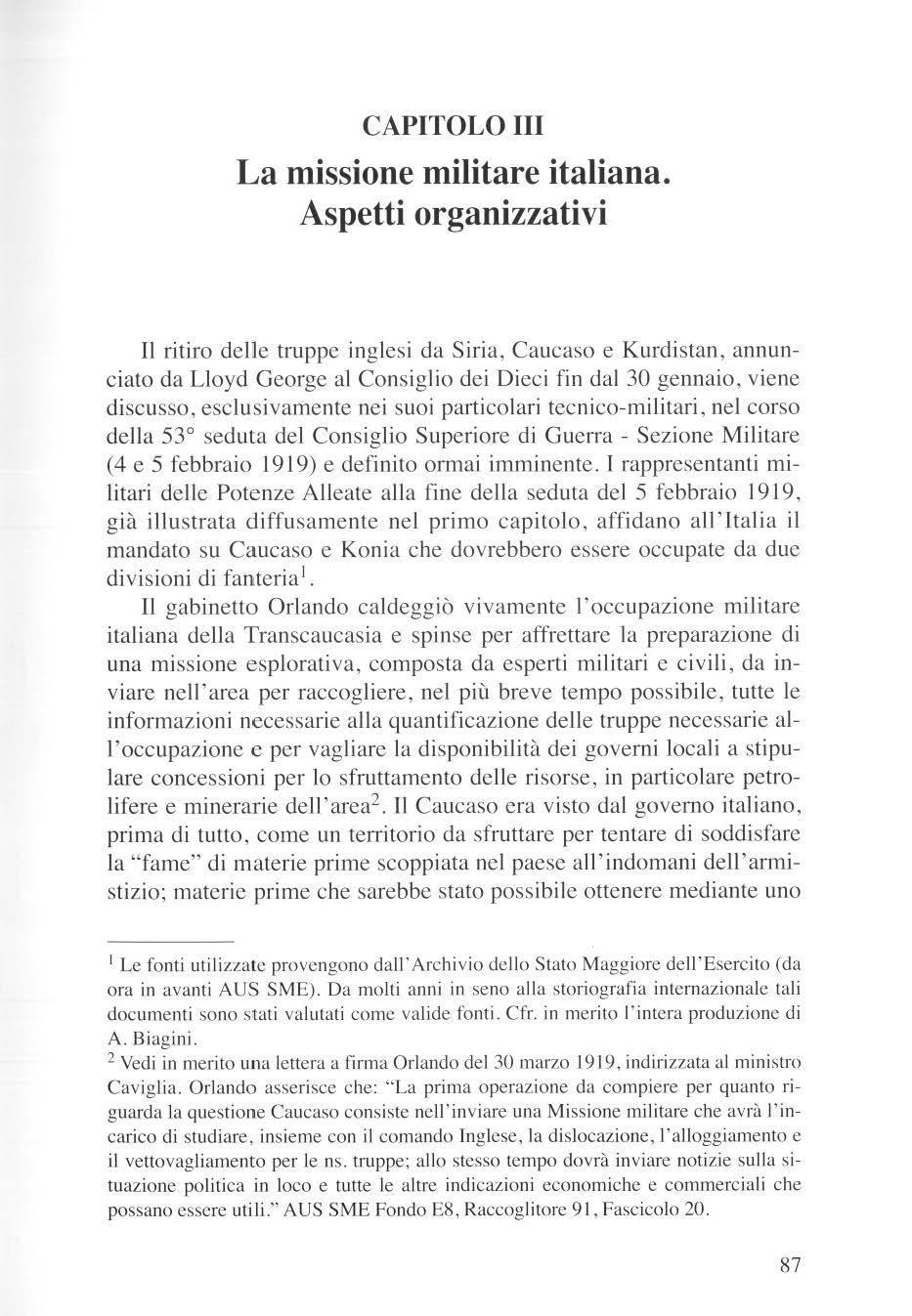
CA PI TOLO III
87
scambio con mezzi e servizi che rendeva supert1ua la mediazione di una moneta forte, di difficile reperibilità per il governo. In olt re, era stata avanzata l ' ipotesi di poter trasferire in Transcaucasia patte della produzione ag ric o la it aliana, mediante una colonizzazione dell'area. Il progetto semb rava anche di facile realizzazione data, l a relativa vicinanza dell'area da colonizzare alla Madre Patria c l 'es istenza eli una rete di collegamenti marittimi diretti e abbastanza efficienti 3
La fase organ i zzativa della missioné si svolge in un periodo limitatissimo di tempo , eppure la con·ispondenza è fittissima; copre molteplici aspetti, pone molti interrogativi e presenta diverse chiavi di lettura, pur senza addentrarsi ancora nella complessità dei r a pporti che presentano un amp io contenuto politico ed economico .
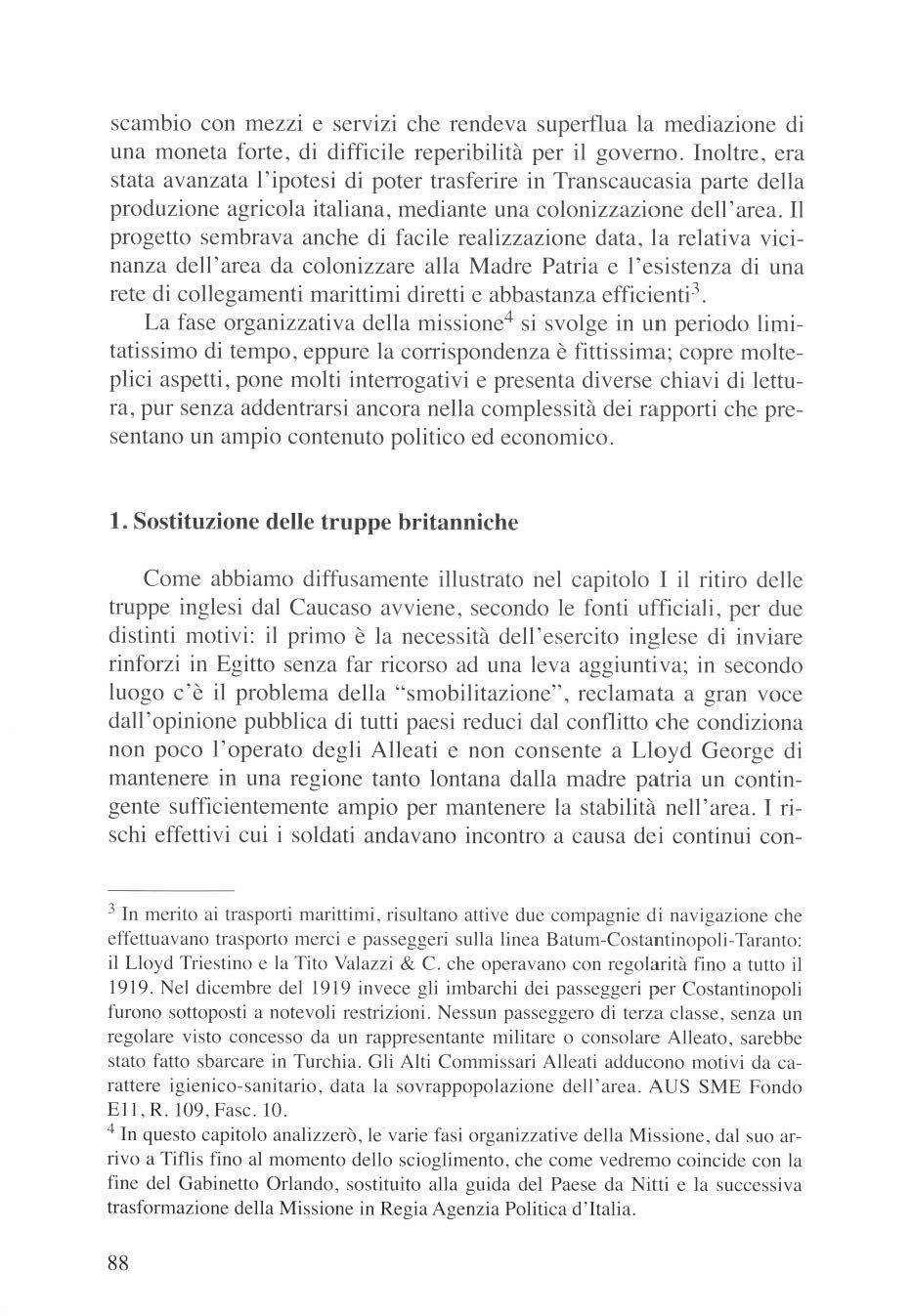
l. Sostituzione delle truppe britanniche
Come abbiamo diffusamente illustrato nel capitolo I il ritiro delle truppe ing lesi dal Caucaso avviene, secondo le fonti ufficiali, per due distinti motivi: il primo è la necessità de ll 'esercito inglese di inviare rinforzi in Egitto senza far ricorso ad una leva aggiunti va; in secondo luogo c'è il problema della ''smobilitazionc", reclamata a gran voce dali 'op inione pubblica di tutti paesi reduci da l conflitto che condiziona non poco l'operato degli Alleati e non consente a Lloyd George di mantenere in una regione tanto lontana dalla madre patria un contingente sufficientemente ampio per mantenere la stabilità nell'area. T rischi effettivi cui i soldati andavano incontro a ca us a dei cont inu i con-
3 In me1ito ai trasporti marittimi. risultano attive due compagnie d i navigazione che effe ttu avano trasporto merci e passeggeri sulla linea Batum-Costantinopoli -Tara nto: il Llo yd Triest in o c la Tito Yalazzi & C. che operavano con r egola rit à fino a tutto il 19 l 9. Nel dicembre de l l 919 invece g l i imbarchi dei passeggeri per Costan ti nopo l i furono sottoposti a notevoli res tri zion i. Nessun passeggero di terza classe, se nza un r egola re v isto concesso da un rappresentante militare o conso lare A lleato, sarebbe stat o fatto s barcare in Turch ia. G li Alt i Commissari A ll eat i adducono mo ti vi da car attere igienico-sanitario, data l a sov r appopolazione d e li" area. A US SME Fondo El l , R. 109, Fase. 10.
4 ln questo capitolo analizzerò , le va ri e fasi o rganizzative della Missione , dal s uo arIivo a Titlis fino al momento dello sciog lim ento, che come vedremo coincide con la fine d el Gabinetto Or la nd o, sostit uito alla guida del Paese da Nitti e l a successiva trasformazione della Missione in R egia Agenzia Politica d.ltalia.
88
tlitti inter etnici. degli scon tri co n i bolschcvichi e delle tensioni a carattere religioso non e rano da so tto va lutare. L' occupazione inglese ormai si limitava solo alle zone di maggiore interesse economico e stra teg ico, come ad esempio il tronco ferroviario Baku - Tiflis - Batum e l'oleodotto5 . 11 22 m a r zo del 19 19 il governo itali a n o accettò di s o s tituire le truppe britanniche nel Caucaso, co me risulta da una le ttera diretta al Mini stero degli Esteri a Roma. nella quale Aldrovandi asserisce di aver com uni cato al co lo nn ello H ankey la decisione del pre side nte del co n sig lio Orlando affinché fosse riferita al Signor Ll oyd Georgé.
I l ge n erale Cavallero do vrà a s uo vol t a contattare il generale Wilso n per avere un generico orie nt ame nto su ll a situazio ne mi lit are del Caucaso c discutere le modali t à di sostituz ion e delle tru ppe inglesi. A p artire da quel mom ento, i co nt att i tra il W a r Offi cc c la Sezione Militare d e ll a Delega z ion e It a li ana si susseguono, g li in g les i fornisco n o ne Il ' april e de l 1919 un prom e moria dettagliato co n l'esatta dislocazione delle loro truppe nel Caucaso e la composizione de ll e stesse 7 . l particolari ve n gono discussi dal generale Cava ll ero e dal generale Thwaitcs (ca po di Stato Ma gg iore de l generale Wil so n ). R imangono numerosi promemoria e r esoconti deg li incontri tra Cavalle r o e Th waite avvenut i per tale scopo. Tra questi molto significativo mi sembra quello st il ato dallo s tesso genera le Cavallero. c h e riferisce del rischio, r eso manifesto da Thwait es. c he le truppe ingle s i s i vedano costrette ad ini z iare il dtiro dalla Transcaucasia prima d e ll 'a rrivo delle truppe ita li a n e a causa d e ll e esigenze che s i andavano m a nifes tando in altri scacc hi er i Esigenze tanto pressanti che, n e ll'arco di due mesi, a detta d el gener al e Wilson. l 'occ upazione inglese av rebbe pot uto essere rido tta ad una test a di s barco a Batu m. D ue me s i erano preve nti vati da ll o stesso Wilson p er lo vo lgime nto della missio n e esplorat iva it ali a n a che doveva aver luogo prima di in iziare i movimenti di truppe verso l a Transcaucas ia. La com unicazione di Th wa ites rivestiva carattere di ufficialità , dato che lo s te sso ge nerale Wil so n lo aveva in carica-
5 Pctricioli. M . L'Occ upa -:,ion e italiana del Caucaso: Un "ingrmo servi-:.io" da rendere a Londra. in " Il Politico". Pavia. Fase. IV. 1971. Fa se. l , IIJ 72. pag. 25.
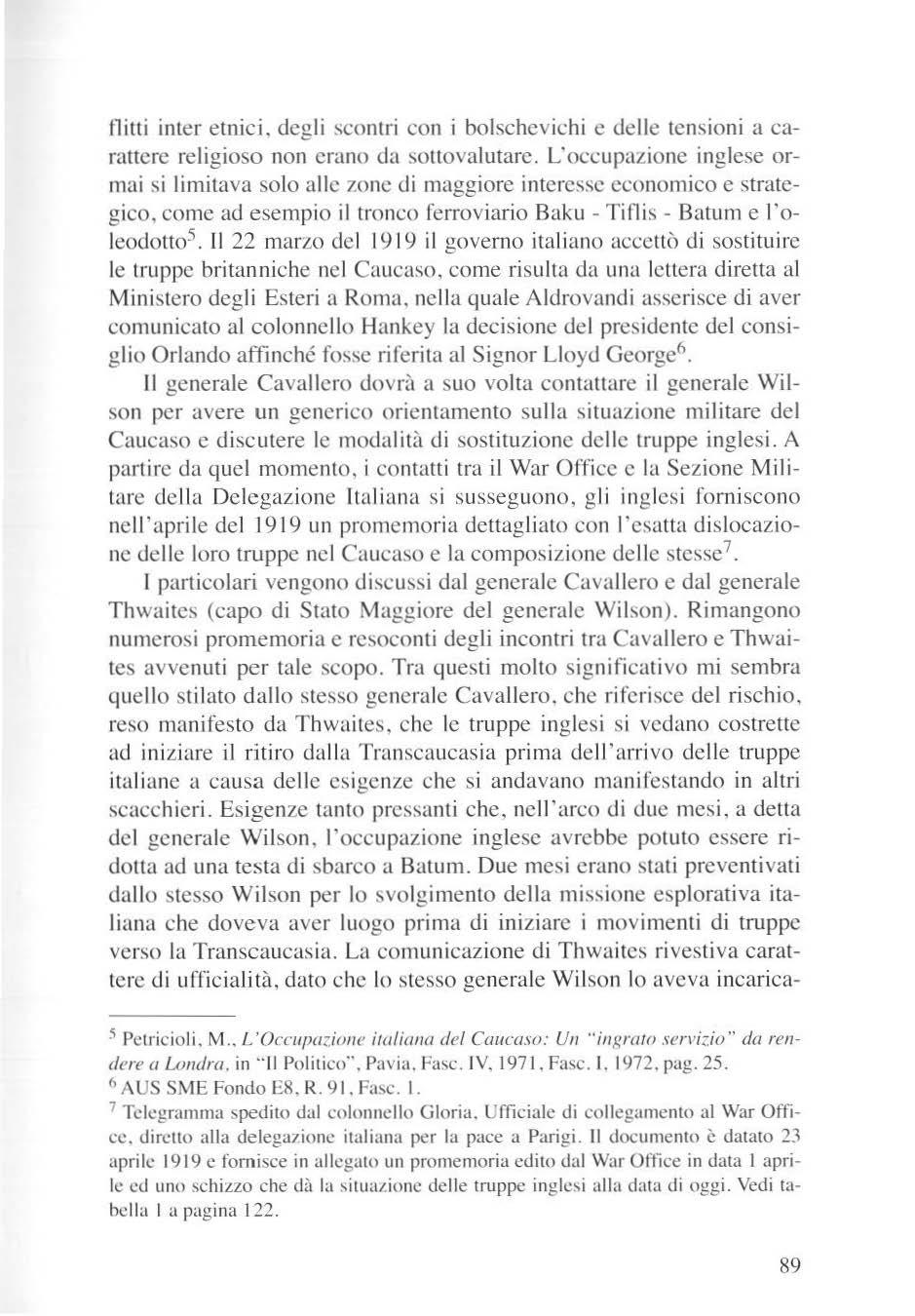
6 AUS SME Fondo ES. R . 91, Fa\C. l.
7 Telegramma spedito dal colonnello Gloria. Ufficiale di collegamento al War Office. diretto alla delegazione italiana per la pace a Pari gi. Il documento è datato 23 aprile 1919 e fornisce in allegato un promemoria edito dal War Oftice in data l aprile cd uno sch izzo che dà la situat.ione delle truppe inglesi alla data d i oggi. Vedi tabe ll a l a pagina 122.
89
todi illustrare a Cavallero la nuova situazio ne affinché il governo italiano potesse esa minare la nuova situazione e comu nicare al comando inglese le proprie decisioni8.
La notizia non lasciò ce1to indifferente il generale Diaz, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. che in un documento di appena due giorni dopo sottolineava l'importanza di arrivare con le truppe nel Caucaso prima che g li inglesi iniziassero a ritirarsi e prospettava due po ssib ili scemu·i. Nella più rosea delle previsioni era possibile che la rioccupazione dei territori lasciati liberi dagli inglesi non presentasse difficoltà soverchi e ma sarebbe stato più prudente, secondo Oia z, prevedere che arrivando tardi sarebbe stato possibile occupare, senn contrasti. solo il tenitorio ancora sotto il controllo inglese. Se il governo era ancora interessato all'occupaLionc dell'area. o almeno a garantirsi il con trollo del porto di Batum e delle vicine miniere di carbone, il capo di Stato Magg iore co nsigliava di inviare le truppe prima che gli ingle si terminassero l a smobi litazione9 .

Durante un colloquio tra Oiaz c il generale Wilson. avvenuto il 24 aprile 1919 a Parigi, vengono molti dci nodi sottesi alla zione delle truppe inglesi in Transcaucasia e all'arrivo del contingente italiano. Le truppe Britannich e, suddiv ise in una quindicina di battaglioni, vennero riunite dal generale Milne , comandante della mission e militare inglese. in due divisioni organiche per pe•metlere un migliore controllo del tetTi torio. Tuttavia. l'occupazione terrestre avrebbe dovuto essere integrata dal co ntro llo marittimo sul Caspio, per il quale gli disponevano di un certo numero di battelli armati sottratti ai Ru ssi. Il pericolo sareb be potuto a rrivare dalla netta bolscevica, atrualmente bloccata dai ghiacci alle bocche del Volga, c he con il disgelo avrebbe potuto riprendere l'attività.
Il generale Milne ve nn e incaricato dal generale Wilson di accogliere la missione militare italiana a Costantinopoli, eli organizzare il proseg uiment o del viaggio c di agevo larli ne llo svo lgime nto del loro compito. cioè quello di rendersi conto sul po sto della situazione e delle misure occorrenti per la sostituzione delle truppe 10
x Resoconto del 14 aprile del 1919 che ha per oggetto. del Caucaso"
AUS SME Fondo E8. R. 91. Fase. 2.
9 AUS SME Fondo E8 R. 92. Fa se. 4.
10 Resoconto della conversazione tra il generale Diat. c il generale Wih.on del 24 marzo 1919 alle ore 18. Jl documento è firmato dal co lo nn ello eli Stato M nggio re Pellicelli e indiri a.ato al la Presidcnt.a del Consiglio uci Ministri in data 28 marzo
1919. AUS SME Fondo E8 R. 91 l.
90
Anche la "questione del tonnellaggio" per il trasporto delle truppe ita lian e vie ne affrontata c i due gradua ti convengono sulla necessità che i piroscafi che avrebbero riportato le truppe inglesi sarebbero dovuti se rvire a trasportare anche quelle italiane, mentre il genera le Wilson si ri servò di attendere istruzioni, dal Ministero della M a rin a, per quanto riguardava la possibilità di effe ttuare il trasporto dei rifornimenti per g li italiani con tonnellaggio britannico, almeno per i primi tempi. Il rifiuto inglese di fornire suddetto tonnellaggio è uno dci motivi dell'abbandono della missione da parte degli italiani. Il quadro che risulta dall'analis i dei documenti. come vedremo. è molto più articolato. Ferma restando la disponibilità del tonnellaggio britannico. condizione necessaria per poter effettuare la sostitulionc delle truppe inglesi con i contingenti italiani, le modalità dello sgombero inglese vengono ana linatc dal War Officc ne i minimi particolari per ottimizzare i mezzi ed i tempi di trasfer im ento non lasciando assolutamente nulla al caso, come risulta da un promemoria stilato dal maggiore generale Cory, comandante della 27° divisione dell'e se rcito inglese 11 . Il progetto per il ritiro completo indicava tutti i movimenti di truppe, inglesi che si ritiravano e italiane che arrivavano. nell'ordine esatto in cui avrebbero dovuto essere compiuti per ouimjzzare i tempi. consentire la rioccupazione e la stabi li zzaz ione dci tenitori e sfruttare al meglio sia i piroscafi. utilizzati sia per lo sgombe ro delle truppe inglesi che per il trasporto degli italiani, che le ferrovie. l soldati. c he av rebbero dovuto essere imbarcati in scag lioni di 1100 uomini dal porto dì Batum, avrebbero inìLiato la fase eli sgombero a partire da Baku. Prima eli iniziare tale sgombero si sarebbe dov ut o attendere l'arrivo del primo distaccamento di truppe italiane. D opo aver completato la sostitu.lione a Baku e nelle .lOnc circostanti si sarebbe potuto procedere con le sostituzioni dei distaccamenti di Kra snovoclsk, Pctrowsk e Shusha, che avrebbero dovuto essere conclusi prima che fosse conclusa la sostituzione nell'area di Baku. Successivamente le truppe avrebbero dovuto lasciare Tìfli s, Kars, Erivan, Nahkitchevan c Akhalkalab. Per ultim e sarebbero sta te sostituite le truppe a Batum c Gagri. Siccome le truppe it aliane avreb bero dovuto essere più num erose di quelle inglesi, Cory aveva previsto che i piroscafi rimanessero nel porto di Batum per 4 giorni prima di poter ripartire ed anche l'ipotesi
11 Promemoria del maggiore generale Cory. inviato alla militare italiana a Tiflb c datato 28 maggio 1919 .AUS SME Fondo Eli. R. 112. Fa-;c. 19. Vedi tabella 2 pag. 123- 124.
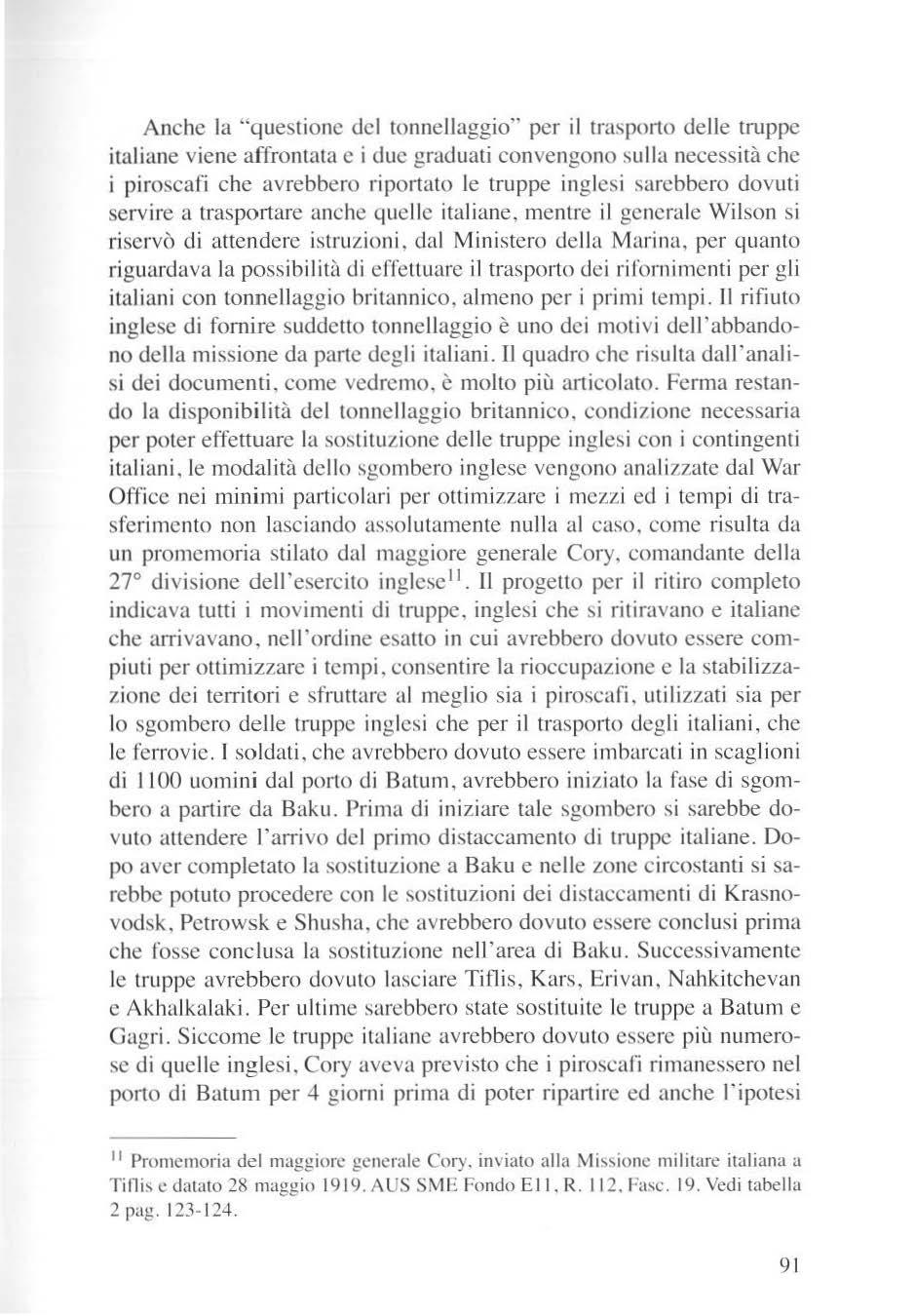
91
che i piroscafi tornassero indietro so lo parzialmente pi e ni. Tra g li innume revoli punti da ten e re in co ns id e razion e a i fi ni della più corretta gestio ne dei convogli feJTOviari e dci piroscafi , il maggiore generale Cory, sotto linea l'importanza di co no sce re esattamente la quantità d e l material e in glese c he sarebbe s tato ril eva to dag li italiani 12 Il comando britannico aveva fornito inoltre elenchi e piantin e che illu s travano nel det-
Pianta d ella ci ll à di Tiflis che mostra !"esatta col/oca-:.ion e deRii alloggiamenti per le truppe britanniche. i e gli edifici di sen·i :_ io di rario
12 In merito alla lettera a) del punto 7 . cioè all a ione di materiale all'Italia rimangono una serie di documenti del giugno c del luglio 1919 che fomil>cono dati precisi riguardo a quadrupedi. riforn im enti c carreggio . Inte ressa nte un documento inviato dal co lonnello Toni in data 7 giugno 19 19 , che t rasmette un doc umento in v iato dall' Uffic iale di Co llegamento al War Offi cc colonnello T hurlo w: " l soldati italiani che daranno il cambio alle truppe britanniche potranno probabilmente rilevare il <;eguente materiale, quadrupedi c vet tovaglie: Muli 663: Cavalli ?26: Vetture 153 con finimenti; Quad rup edi. ca rreggio c finimenti per lu formaLionc di una co lonna salm eri c; 150 ca va lli da sella co n se lle: Ra7ioni per 30 gio rni per 24.000 uomini : RaLioni per 30 giorni pe r 10.000 quadrupedi: 3 tonnellate di medicinali; l inl>tallaLione radio - telegrafica: 50 ca mi on ford con laboratori c vcllure attrcai
Il numero dei cava lli ri sulta illeg ibil e nel docum ent o inglese c il co lonn ello Toni si ri se rva di chiarirlo. AUS SME Jiondo E li R. Ili. 5.
Ci so no delle dil>crcpanze piuttos t o rilevanti tra le concessioni di giugno e quelle di luglio inviate dal tenente colonnello Michcli al colonnello Gabba. presso il Ministero della Guem a Roma. in data 2 lu glio 1919. AUS SME Fondo Eli. Ra cc. IlO, Fas e. 2. I n que sto documento Mich c li comunica c he salvo ulteri o ri ag giunte il Comando Ingl ese potrà cedere per ora ill>cguente materiale: 2 colonne carreggio di circa I SO carri ; 690 quadrupedi: materiale del genio (quantità imprecisabile): 60 autocarri Ford: officine di ripara7.ione: ma gaZ? ini d i comm i ssaria t o: installazioni radiotel eg rafiche; caval li per uno squadrone di cava ller i a.
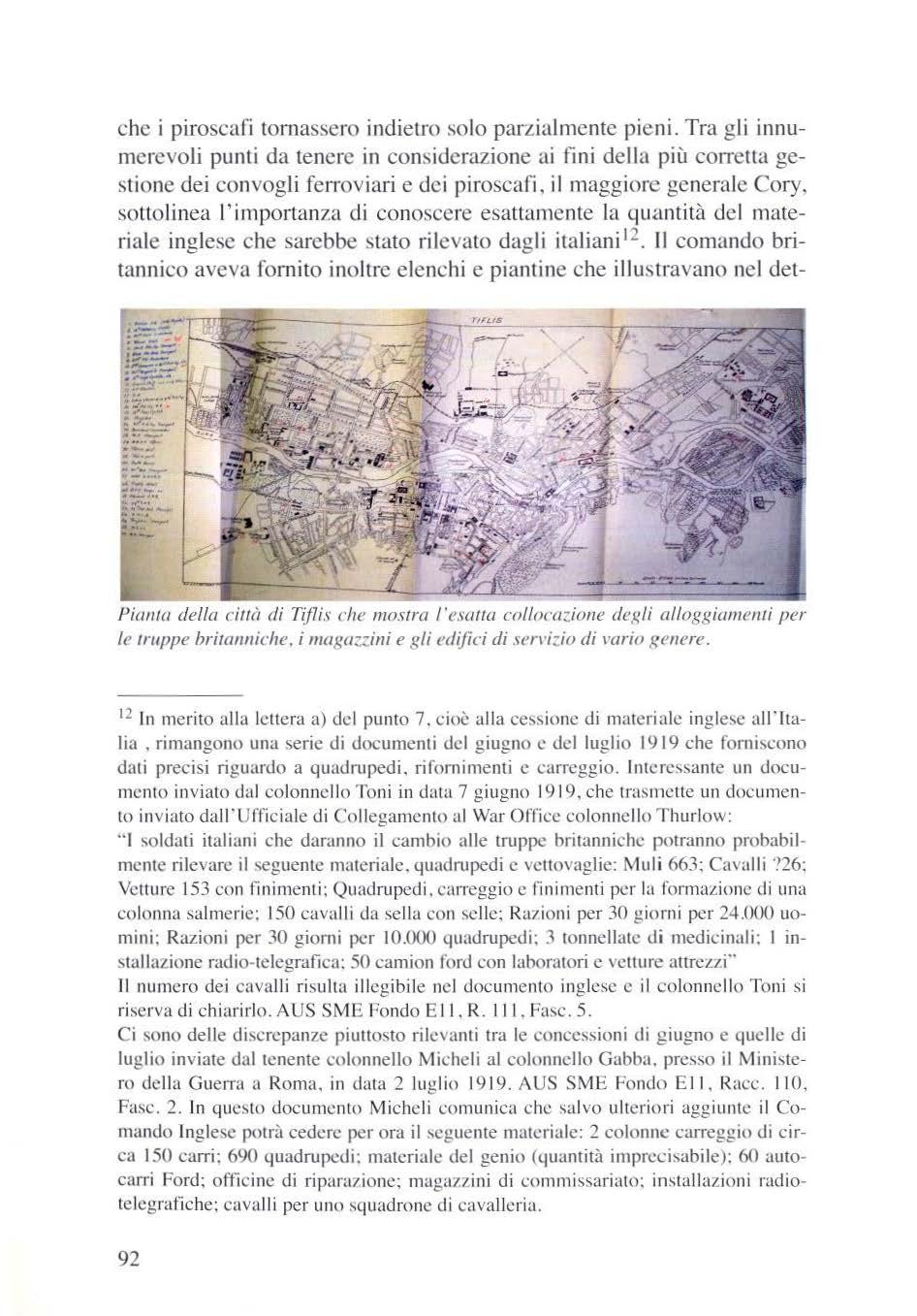
92
tag lio il numero de ll e degli alloggiamenti per gli ufficiali, delle sc uderie, dei depositi di materiali. dei magazzini per lo stoccaggio del le de rrate , ecc. c he g li italiani avrebbero potuto rilevare in base alle proprie necessità 13
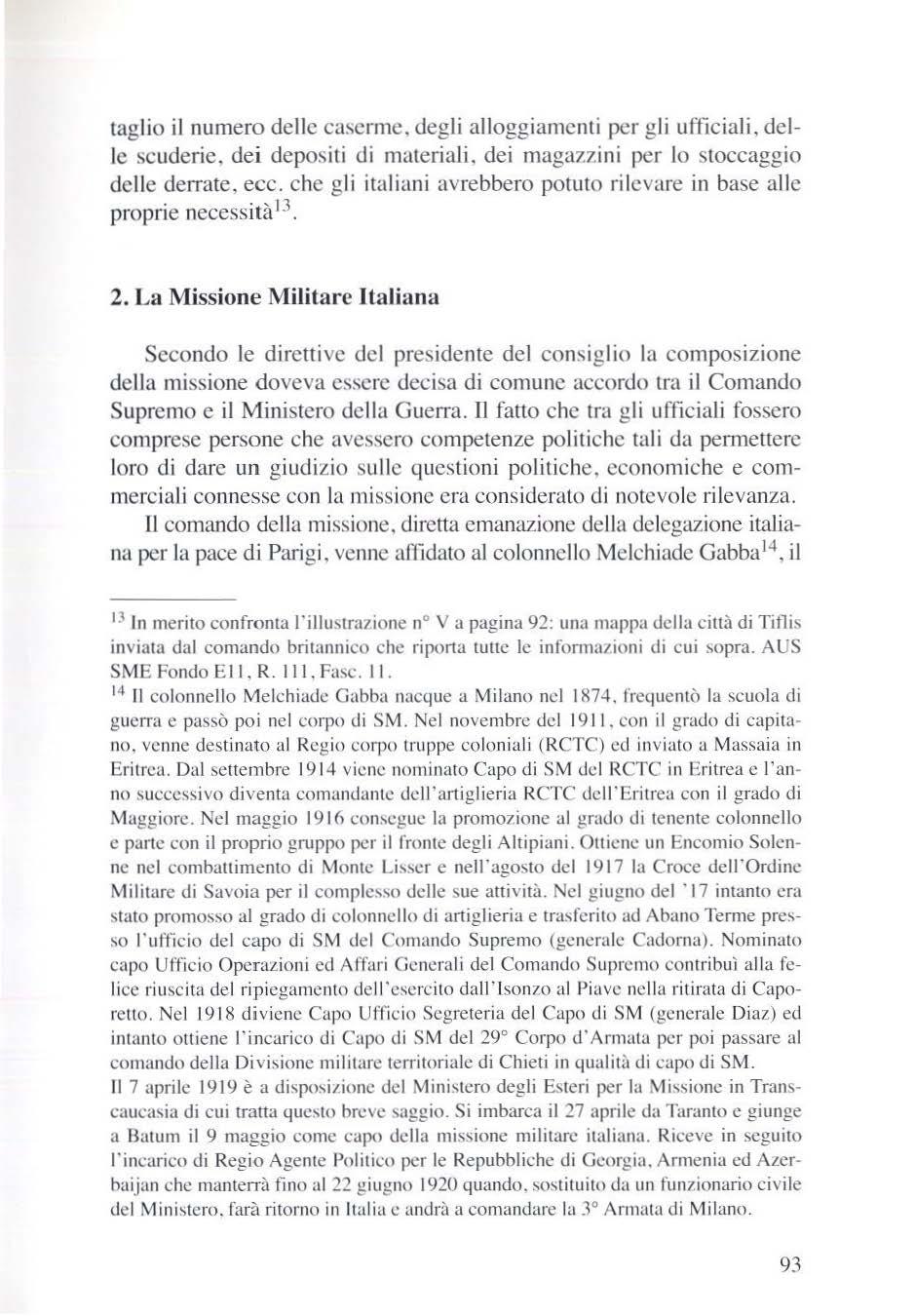
2. La Miss ion e M ili ta re Itali a na
Secondo le direttive del preside nte del consiglio la com posizio ne della mi ssione do veva esse re decisa di comu ne accordo tra il Comando Supremo e il Mini s tero della Guerra. D fatto c he tra gli ufficiali fossero co mprese persone che avessero competenze politiche tali da permettere loro di dare un giudizio ull e questioni politi c he, eco nomi c he e comme rciali connesse con la mi ss ione era co nsiderato di notevo le ril e van za. n comando della missione, diretta emanazione della delegazione italiana per la pace di Pari g i, ve nn e affidato al colonnello Melch iade Gabba 14 • il
13 In merito confronta l'illuS!ra7i o ne n° V a pagina 92: una mappa della città di Tiflis inviata dal comando britannico che riporta tutte le informa1ioni di cui l>Opra. AUS SME Fondo El l. R. III, Fase. Il. 14 li colonnello Melchiade Gabba nacque a Milano nel 1874. frequentò la scuola di g uerra e passò poi nel corpo di SM. Nel nove mbre del 19 11 con il grado di capitano, venne destinato a l Reg io corpo truppe colonia li (RCTC) cd a Massaia in Er itrea. Da l se ttembre 19 14 vie ne nomi na to Capo di SM d e l RCTC in E ritrea c l 'a nno successivo diventa comandante dell'artiglieria RCTC dell'Eritrea co n il g rad o di M aggiore. Nel maggio 1916 la promozione al grado di tenente co lonnello c parte con il proprio gruppo per il fronte degli Altipiani. Ottiene un Encomio Solenne nel combattimento di Monte Lil>l>er e nell'agosto del 1917 la Croce dell'Ordine Militare di Savoia per il compiC!'>l>O delle sue attività. cl giugno del ·n intanto era stato promosso al grado di colonnello di artiglieria e trasferito ad Abano Terme presso l'ufficio del capo di S M del Comando Supremo (generale Caclorna). Nominato capo Uftìcio Operazioni ed Affa ri Generali d el Comando Supremo contribuì alla feli ce riuscita d e l r ip icgamcnto dell'esercito dall' lso nzo al Pi ave ne ll a ritirata di Ca pore tt o. Ne l l 918 diviene Capo Uffic io Sl:greteria del Capo di S M (genera le Dia z) ed intanto ottiene l' in ca ri co d i Capo di S M del 29° Corpo d'Armata per poi passare al comando della Divisione militare territoriale di Chieti in qualità di capo di SM.
TI 7 aprile 1919 è a dispo!-titionc del Ministe ro degli Esteri per la in Tran scaucasia di cui tratta questo breve Si i mbarca il 27 aprile da Taranto c giunge a Batum il 9 maggio come capo della missione militare italiana. Riceve in seguito l'incarico di Regio Agente Politico per le Repubbliche di Georgia . Armenia cd ALerbaijan che manterrà fi no a l 22 giugno 1920 quando. sostituito da un funzionario civile de l Ministero. farà ritorno in Italia c and rà a coma nd are la 3° Am1ata di Mil ano.
93
el maggio del 1926 diviene generale di brigata e nel 1934 genera l e di Corpo <.l'Armata. Ne l '39 ri t iratosi per l im i ti di comando divenne pri ma Senatore del Regno c dopo la caduta del regime di Mu!>solini nel 1943. Ministro Segretario di Stato nel Gabincuo Badoglio dal 26 luglio 1943 al l o agosto 1944. Ritirato), i dalla carica nel l 944 c ricollocalO in congedo dalla data morì a Roma il 15 novembre 1952.
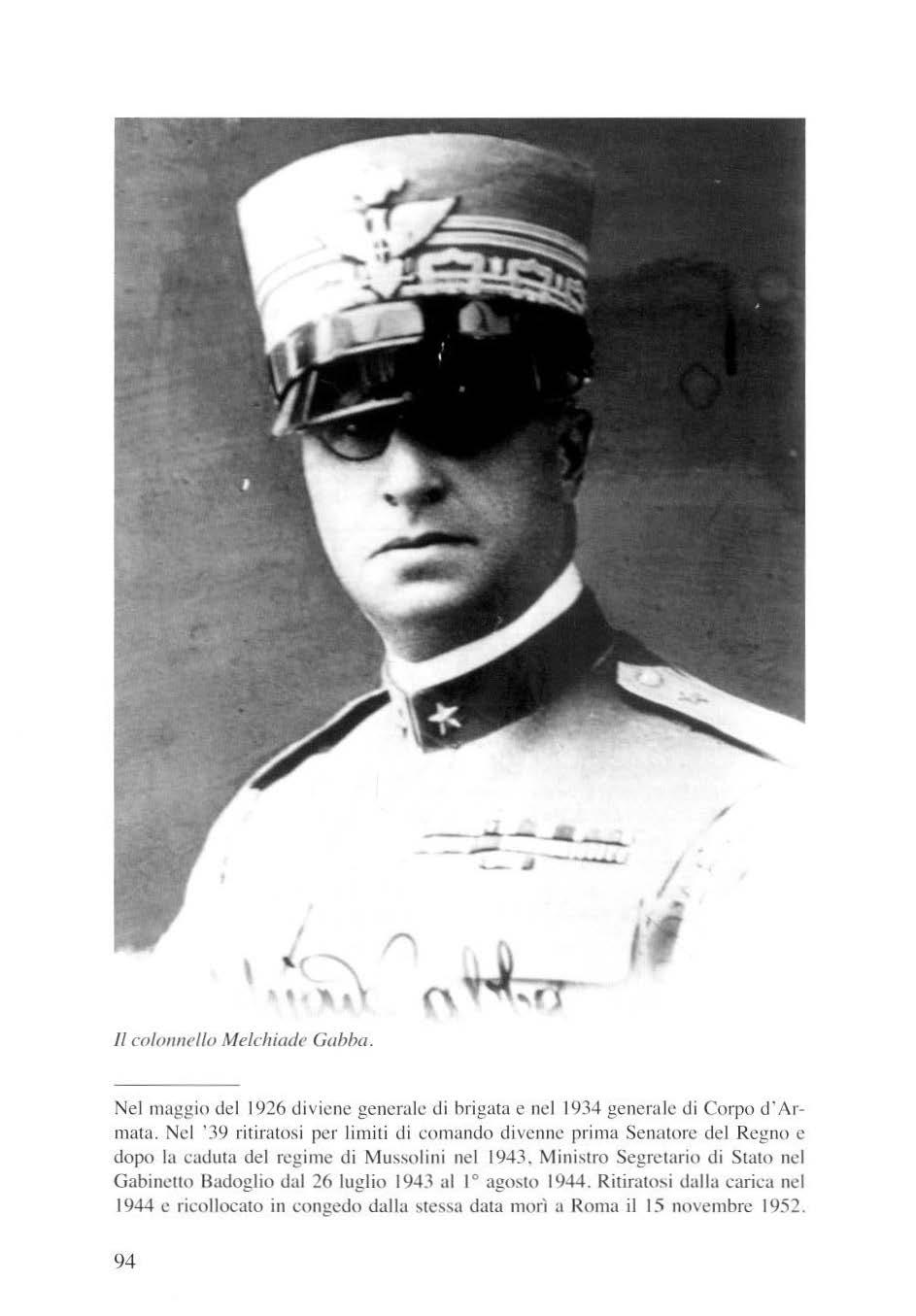
/ - ------;l------...
Il colonnello Melchiade Gabba.
94
quale ricevette dal capo di Stato Maggiore. generale DiaL., deUe direttive molto precise i n merito agli scopi della Missione militare italiana in Tran scaucasia, contenute in una lettera del 14 aprile 1919 15 La decisione di interveni re nell'area, sos titu endo le truppe inglesi, fu presa dal governo , nonostante l 'onere militare e navale che tale decisione com portava, per una se1ie di motivazioni di interesse nazionale. La missione militare avrebbe dovuto assumersi l'onere di mantenere l'ordine interno e eli favorire l' indipendenza de ll a Repubblica georgiana e dell'Azerbaijan; anche se n za intervenire nell'attività governativa avrebbe dovuto permettere la ripresa della vita civi le ed il progresso delle popolazioni verso "ordinamenti più perfezionati e tranquilli che possano consentirci una graduale riduzione dell'occupazione militare": iniziare con una azione combinata tra attività statale c privata lo sfruttamento delle risorse minerarie della regione (petrolio, carbone, manganese e rame); intraprendere una attiva opera di penetrazione agricola, industriale e commerciale che vada anche a beneficio delle popola;ioni locali, anche attraverso l'attivalione di una con·ente emigratoria dall'Italia. La missione. come risulla dal documento, ha in questa fase la funt.ione di studiare la "fattibilità" degli interventi in programma attraverso una analisi attenta dei fattori politici -con partico lare attenzione alla situazione deUe due repubbliche indipe nd enti ed all'intiico dei fattori etn ico-re li giosi nell'area- militari e navali 16 Di competenza degli esperti al seguito della missione le ana li si della s ituazion e industria le, mineraria - con partico lare attenzione alla questione delle co ncessio ni già esistenti ed a quel le da richied ere ai govemi locali -agrico la c commerciale della regione.
U n successivo paragrafo della medesima lettera rigumdava il comportamento da tenere nei confronti del comando inglese; i rapporti dovevano essere impront ati al massimo ri serbo. rimandando sempre quaJiasi decisione in merito alla delle truppe alla delegazione it a liana per la pace- di cui la missione era diretta emanazione -cd evit a ndo di fare cenno dell'accordo con g li in glesi a ll e autorità locali.
Le note ivi riportutc sono state tratte da: Enciclopediu Militare Vol. III. pag. 878 c da Personmil - l.f 0 Divisione tlocumcntaLionc Esercito. Cfr. illustrazione n° VI a pagina 9-f.
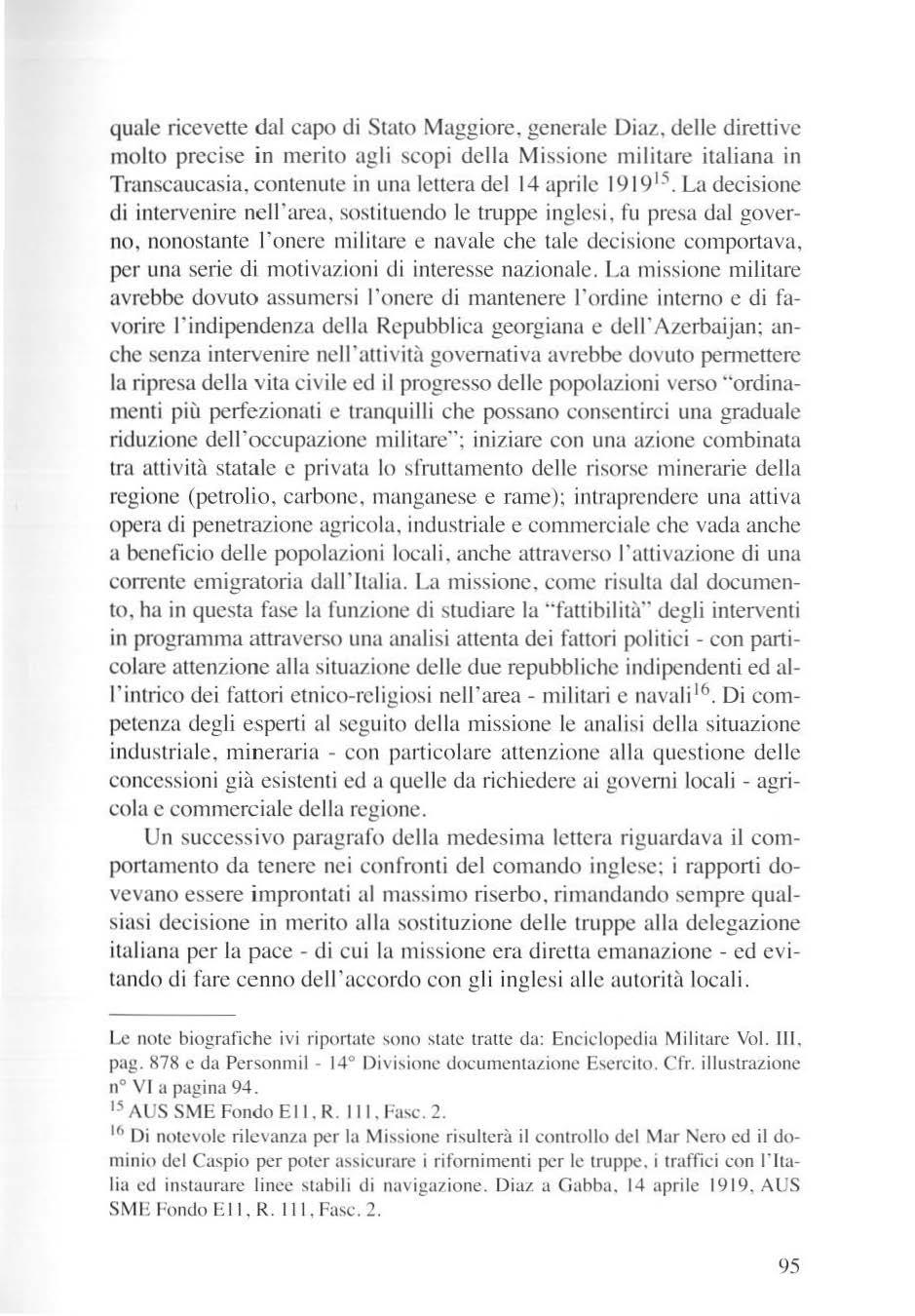
15 AUS SME Fondo Eli. R. Ili. Pa\c. 2.
16 Di notevole rilc\'aOL:"I per la M ione risulterà il controllo del Mar Nero cd il dominio tlel Caspio per poter i rifornimenti per le truppe. i traffici con l'Itali a eu instaurare linee stabili di naviga7ione. Diaz a Gabba. 14 aprile 1919. AUS SME 1-'ondo Eli. R. Ili, Fase. 2.
95
··si reputa opportuno far presente che data la delicatena della missione deve essere mantenuto il più stretto riserbo. anche in patria sono state date disposit.ioni alla stampa affinché non trapelino notizie in merito'' 17 .
Diaz, in co nclu sione ribadiva l ' importanza del fattore tempo nel ragg iungere gli scopi prefissi per la missione. che doveva partire subito e fare ritorno per i primi di luglio. Era desiderabile c h e le prime notizie raccolte venissero inviate subito anche se frammentarie 18 .
All'inizio di aprile il Comando Supremo iniliò la se lezione del perciv ile e militare che avrebbe accompagnato il co lonn ello Gabba. incaricato del comando della missione. Il 6 aprile Gabba scrive un promemoria per il colonnello di Stato Maggiore Alfredo Rota illustrandog li i suoi movimenti per i g iorni successivi c le nccc ss i.tà organizzative più immediate per la preparazione della mission e. La se lezione del perso nal e, tra cui in particolare 3 o 4 militari che sappia no i l ru sso, dattilografi c due autisti per le necessità della missione, era urgentissima data l'espressa volo ntà di Gabba di partir e e ntro il 20 di aprile
.. Negli intendimenti del governo la mi ss ione dovrebbe durare 2 mesi comp re si i viaggi. salvo cambiamcnri dovrebbe essere composta di l O ufficiali (compreso il colonnello inglese Stokes) e 12 militari di truppa con autovetture c bagagli" 19.
Il primo conti n gente de ll a missione, imbarcato s ul Piroscafo Menfi, partì da Taranto il 27 aprile alla volta di Costantinopoli. Jl 26 aprile il co lonnello Gabba in viò a tutti gli organi competenti 20 l ' elenco
17 LeneradiDiazaGabba.l4aprile 1919.AUSSME FondoEII,R.lll,Fasc.2.
18 Que sto ultimo concetto v iene ribadito e ampliato anche in una tenera dello stesso Di aL datata 15 aprile 1919 nclb qua le il generale raccomanda che: "da t a l'urgenza della Missione potrà partire in un primo tempo con parte tlcl personale e del material e indispensabile facentlosi poi raggiungere dal resto. Resta inteso c he V.S. dovrà conlllnicare al più presto tutte l e noticie che possono serv ire costì in merito all'occupaàmc del paese che potrebbe rendersi necessario attuare al più pre sto.'' AUS SME
Fondo El i , R. Ili. Fase . 2.
t') AUS SME Fondo El l. R. IlO. Fase. Il. 20 Ec co l'elenco completo dci destinatari di questo promemoria: Ministero degli
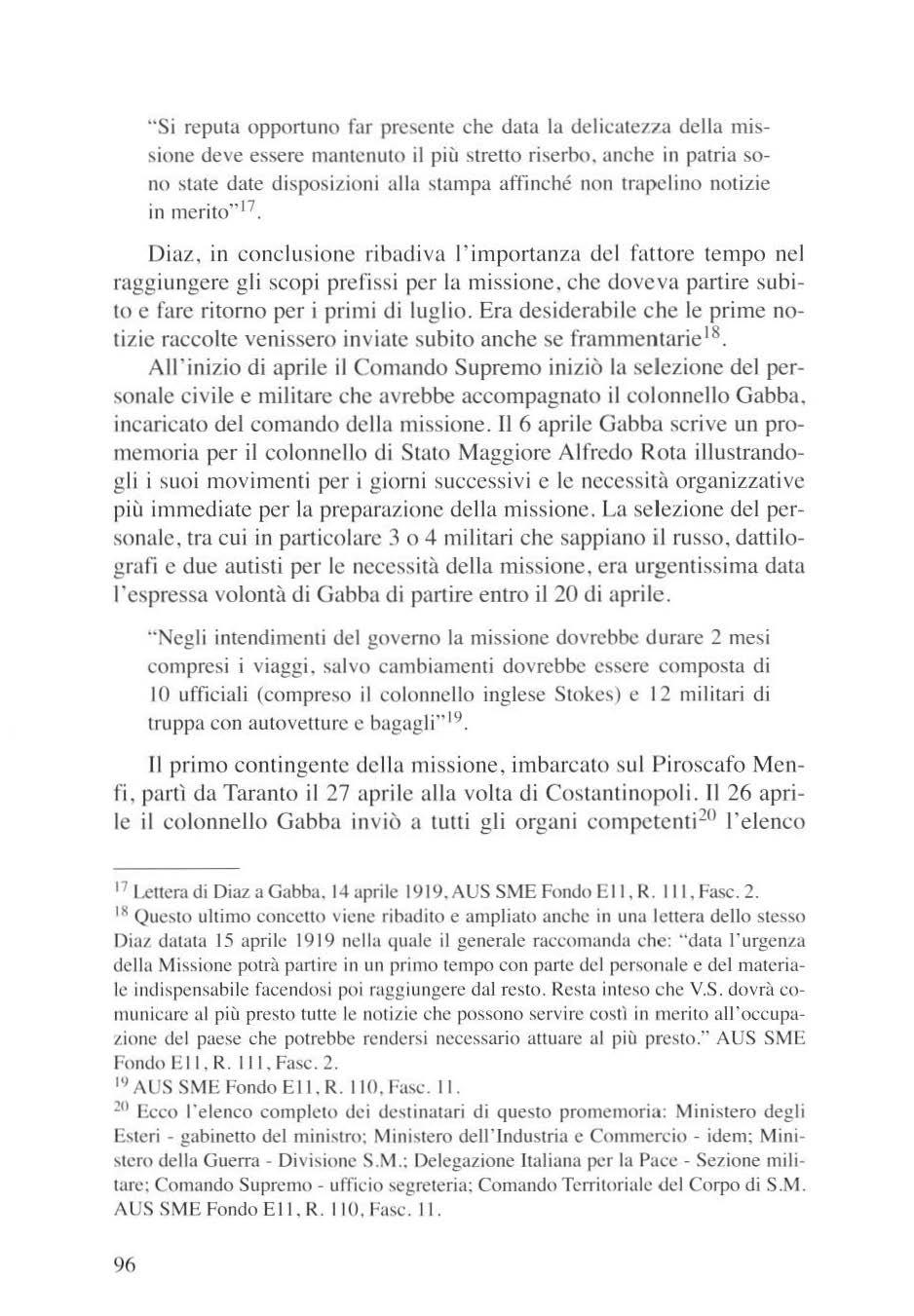
Esteri - gabineno del ministro; Mini c; tero delrlndustria e Commercio - idem: Minil>tero della Guerra - Divi!>ionc S.M.; Delegazione Italiana per la Pace- Sezione mjJitare: Comando Supremo - uffici o Comando Territoriale del Corpo di S.M.
AUS SME Fondo Eli. R. IlO , Fa se. li.
96
dei componenti della missione militare italiana in Tran sca uca sia in parten za da Taranto. La missione si avvaleva di 18 tra ufficiali e delegati tecnici e commerciali incaricati di effe ttuare , nel più bre ve tempo possibile, una dettagliata analisi de ll e risorse minerarie, petrolifere, agricole, forestali e più in genere economiche della regione. Gli ufficiali e gli esperti tecnici erano accompagnati da 50 uomini di truppa , compresi interpreti , dattilografi. autisti e due ufficiali addetti alla sanità , incaricati di organizzare e gestire un ambulatorio polifunzionale destinato sia alle necessità della missione che a quelle della popolazione civile 21
Il piroscafo prosegue, il 5 maggio 1919. per Batum. Come risulta anche da una lettera inviata dal contrammiraglio Salazar al Comandante del Menfi quello stesso 5 maggio22 . Il colonnello Gabba e gli a ltri membri della missione, tra cui S.A.R. il Principe Aimone di Savoia, arrivarono a T ifl is, loro destinazione finale. il 12 maggio a bordo di un treno speciale inglese
I membri della missione furono accolti a Tiflis da una delegazione georgiana composta da un rappresentante del gov erno e dalle massime autorità cittadine. Il colonnello Gabba chiarisce in un tel egramma dello stesso giorno del suo arrivo che l'accoglienza calorosa era dovuta al fatto che il Comando inglese aveva comunicato al governo georgiano la notizia dell'arrivo della missione italiana e che soprattutto aveva reso nota la decisione del governo italiano di sostituire le truppe inglesi nell'occupazione dell'area 2 3 La divulgazione di questa notizia, "incautamentc" 24 rivelata dal comando inglese, contrastava nettamente con quelli che erano stati gli ordini impartiti dal governo italiano al capo della missione militare italiana. Dal ministro Caviglia pervenne infatti un telegramma al colonnello Michel i, capo di Stato Maggiore della missione militare italiana, nel quale si asseriva che non si riteneva ancora opportuno diffondere la noti z ia
21 AUS SME Fondo Eli, R. 110. Fase. Il. Per l'esatta composizione delle Mis s ion e militare italiana. compresi gli incarichi specifici di ogni ufficial e vedi tabel la 3 a pagina 125.
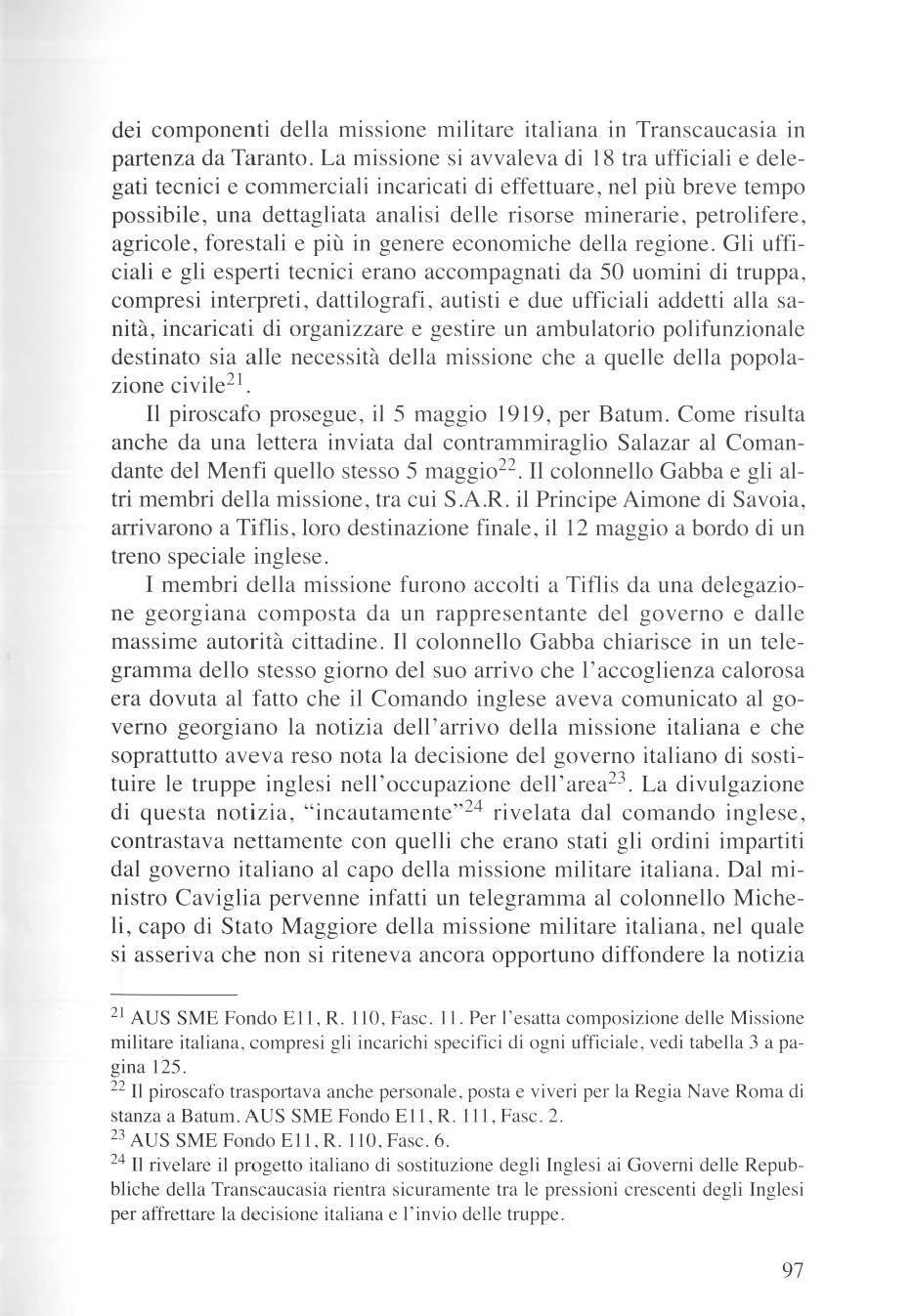
22 Il piroscafo tra s port ava anche perso nal e. po s ta e viveri per la Regia Nave Roma di stanza a Batum. AUS SME Fondo El J , R. Il l. Fase. 2.
23 AUS SME Fo ndo El l. R. IlO, Fase. 6.
24 li rivelare il progetto italiano eli sos titu zio ne degli Ingles i ai Gove rni dell e Repubbliche della Transcaucasia rientra sic urament e tra le pressioni crescenti degli fngle si per affrettare la decisione italiana c l'invio delle truppe.
97
dell'arrivo delle truppe italiane in Caucaso 25 • Eppure, in merito a questa questione , peraltro affatto marginale, sembra mancare tra i membri del governo italiano, il perfetto accordo che ci si sarebbe aspettati. Il telegramma de li ' alto commissario italiano a Costantinopoli, Sforza , è emb l ematico di questa mancanza di coordinamento tra i diversi Ministeri:
"La delegazione georg iana a Pm·igi cui abbiamo annunciato il nostro proposito di sos tituire le truppe inglesi nel Caucaso , con l ' intenzione di approntare una penetrazione pacifica so prattutto di carattere economico in Transcaucasia ha espresso piena fiducia nella nostra missione e ha auspicato che la Missione. per procedere in pieno accordo con il governo di Tiflis, prendesse immediatamente contatto con il governo cercando di stabilire rapporti cordiali" 26
ln un telegramma inviato il 21 maggio alla delegazione italiana per la pace a Parigi , il colonnello Gabba oltre a ribadire la calorosa accog li enza per i militari italiani, pone l'accento sulla grave situazione dell a Georgia. La crisi alimentare diventava sempre più grave, anche a causa della situazione di effettivo isolamento del l 'a rea che non riceveva più alcun rifornimento a mezzo di battelli; un collegamento importantissimo che bisognava ripri s tinare al più presto. 11 colonnello neJlo stesso telegramma suggeriva di approfittare del momento di estrema debolezza dei georgiani per dimo strare le buone intenzioni italiane soccorre nd o la popolazione. A tal fine sarebbe stato utile inviare con urgenza grand i quantità di prodotti italiani (sca rp e, tessuti di lana c cotone, cam ici e, mutande, calze, medicinali, st rum e nti agricoli) che avrebbero potuto essere vantagg io same nte scamb iati con petrolio e derivati, manganese, pellami , tabacco c s igare tt e, seta grezza in bozzoli. Gabba s pecificò anche, a conclusione del rapporto , c h e era in attesa eli ricevere ordini precisi dato che stava ricevendo continue offerte a c ui non e ra in g rado di rispondere27
Nonostante il fatto innegabile che qualsiasi eserc ito st ran iero di occupazione genera una dose inevitabile di malcontento nella popolazio-
25 TI telegramma è senza data ma. dato l'oggetto è facilmente deducibi le c he non risa lga a molti giorn i dopo l'arri vo della missione. AUS SME Fondo E li , R. IlO. Fase. 6.
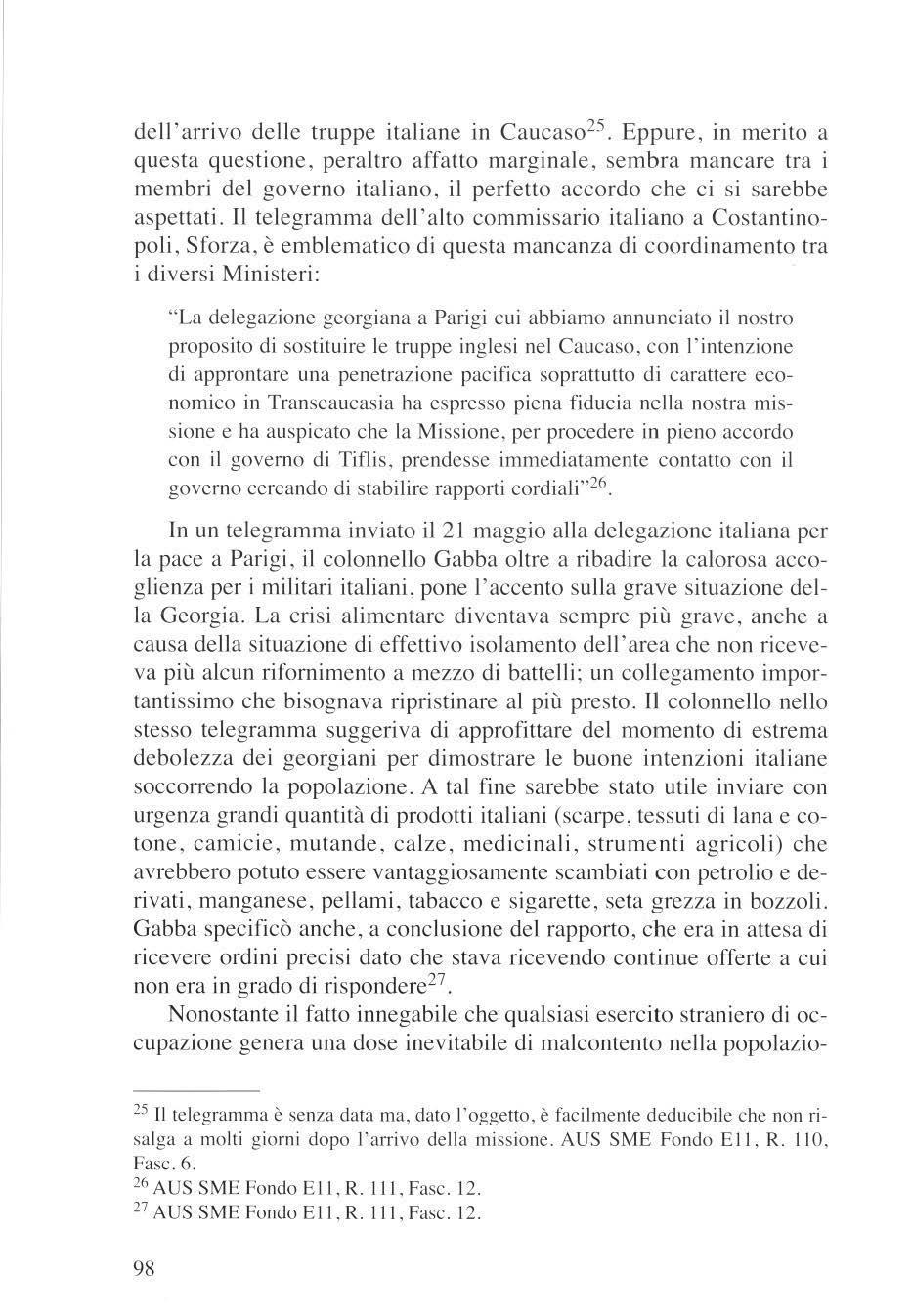
2 6 AUS SME Fondo E l l. R. l li. Fase. 12.
27 AUS SME Fondo Eli, R. Ili . Fase. 12.
98
n e che la subisce 28 i popoli del Caucaso tollerarono meglio l'occupazione tedesca rispetto a quella inglese, anche entrambe vennero attuate con lo scopo di salvaguardare J"indipcndcnJ.a e il petrolio della regione. I rivoluzionari russi e i Turchi, coadiuvati dai loro correligionari azeri, dopo la pace eli Bres t-Litovsk, avevano immediatamente riconq u istato l'Arm enia e 1· Azerbaijan, mentre la repubblica di Georgia aveva mantenuto la propria indipendenza unicamente grazie alla protc7.ionc tedesca. Non dimentichiamo. inoltre. c h e la Transcaucasia. nel 1918/19, era teatro di scontri tra l'esercito dci volontari di Denikin. n ella sua ava n zata verso e le armate bolsceviche. Quello che evidentemente era cambiato era l'alleggiamcnto delle truppe di occu paz ione, che influiva direttamente sull'umore della popolazione, molto pitl di quanto non facessero i compless i g io chi politici c le motivazioni nascoste so tte se all'occupazione. l tede schi riuscirono acl essere ben accetti alla popolazione c probabilmente anche gli ita liani sarebbero stati molto più ben voluti degli inglesi. se avessero effettivamente attuato il loro programma di occupazione. Gli inglesi. invece. anche se erano arrivati in Georgia con il permesso del governo georgiano. con lo scopo di mantenere l'ordine, in completo accordo con il progetto Alleato di preservare la pace nel mondo c asserendo di non voler in alcun modo interferire negli affari interni dell'area. una volta occupata la Transcaucasia ini z iarono a comportar si come se fossero i padroni , atteggiamento che li rese invi s i ai più 29
··si potrebbe sicuramente asserire. senza tema tli che la maggior parte. se non addirittura tutte. le azioni In glesi in Transcaucasia furono male interpretate dalla popol at.ione. I soldati inglesi non si comp011arono altrettan to corTettamente dei Tedeschi. Tra la popolat.ione era diffuso il timore che gli In gles i fossero venuti per restare. Voci fantas iose, sempre con tro di loro, circo la vano in tutta la Transca u cas ia . L'incomprensione, co munque, e ra recipro ca, la maggioranza degli In g le si era incapace di comprendere il popolo della Trans-
211 A questo proposito il Conte Sfom1. Alto Commissario Italiano a Costantinopoli. dice di aver raccolto nei circoli militari inglesi la seguente opinione: ·· le popolat ioni della Transcauca1>ia pur odiando:, i tra di loro erano concordi -;u un punto: r avvcr:o.ione verso quabiasi potcn7a colonizzatrice." In: Pctricioli, M., cii .. pag. 45.
2ll Kat:emLadch, F. The Slrttf?f: ll'.fàr Transcoucasia ( 191 71 1921 ). Ne w York, Oxford. 195J,pag. 171.
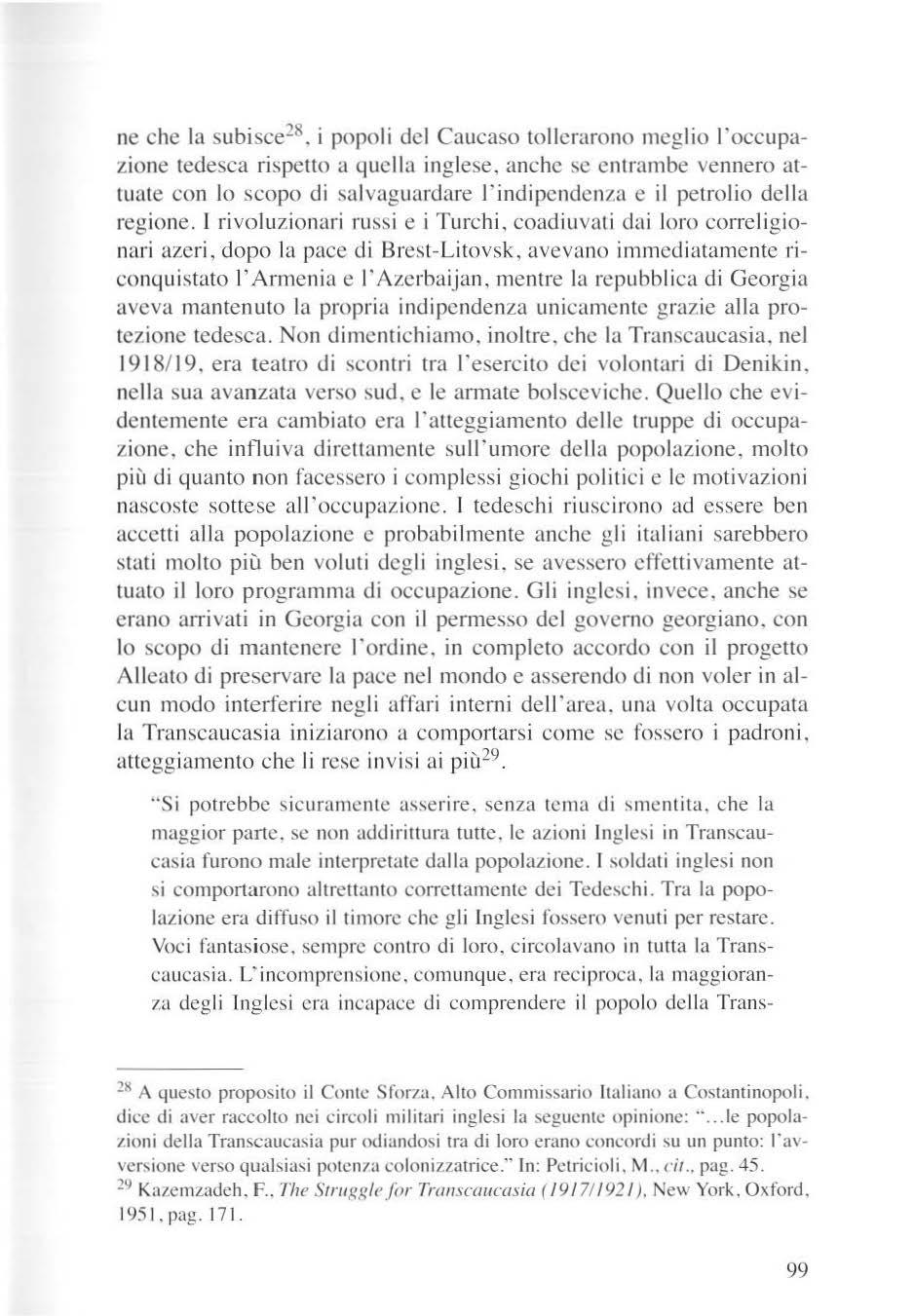
99
caucasia almeno quanto questi ultimi lo erano di comprendere loro"30. (Trad. dell'autrice)
Certamente, anche l'ambiguità dimostrata dal comando Inglese nei confronti dei Governi delle Repubbliche indipendenti contribuì a queste gravi incomprensioni. Il C aucaso venne se mpre considerato dagli In glesi come una patte della Russia e i russi erano degli alleati che ess i cercavano di aiutare, anche se al momento dell'occupazione- sono parole del generale Thomson - "Russia simply di d not exist" 31 . Gli Inglesi erano perfettamente consapevoli del fatto che la Russia considerasse la Transcaucasia come una provincia e che il governo russo, qualsiasi forma avesse assunto dopo la rivoluzione, non avrebbe mai ricono sciuto il diritto delle Repubbliche transcaucasiche all' autodeterminazione e avrebbe fatto il possibile per riprendere il potere nell'area, tenuto conto delle enormi risorse naturali della regione.
Molti membri del governo Orlando e dello Stato Maggiore del! 'ese rcito espressero fortissime perplessi tà in primo luogo circa le reali motivazioni che spingevano gl i In g lesi a cedere all'Italia il controllo dell'area, in seco ndo luogo circa le possibilità concrete di riuscire a mantenere l'ordine in una regione la cui situazione politica, s ia interna che estera, appariva tanto incerta e intricata 32 .
Dal diario di Antonio Salandra - in data 15 marzo 1919 - membro , pur controvoglia, della Delegazione Italiana per la Pace a Parigi, affiorano i gravi dubbi sulla opportunità di accettare l'occupazione della Georgia , proposta insistentemente da Lloycl Georgc. Salandra riferiva dell'entusiasmo di Della Torretta33 • per le enormi ricche zze di Baku c
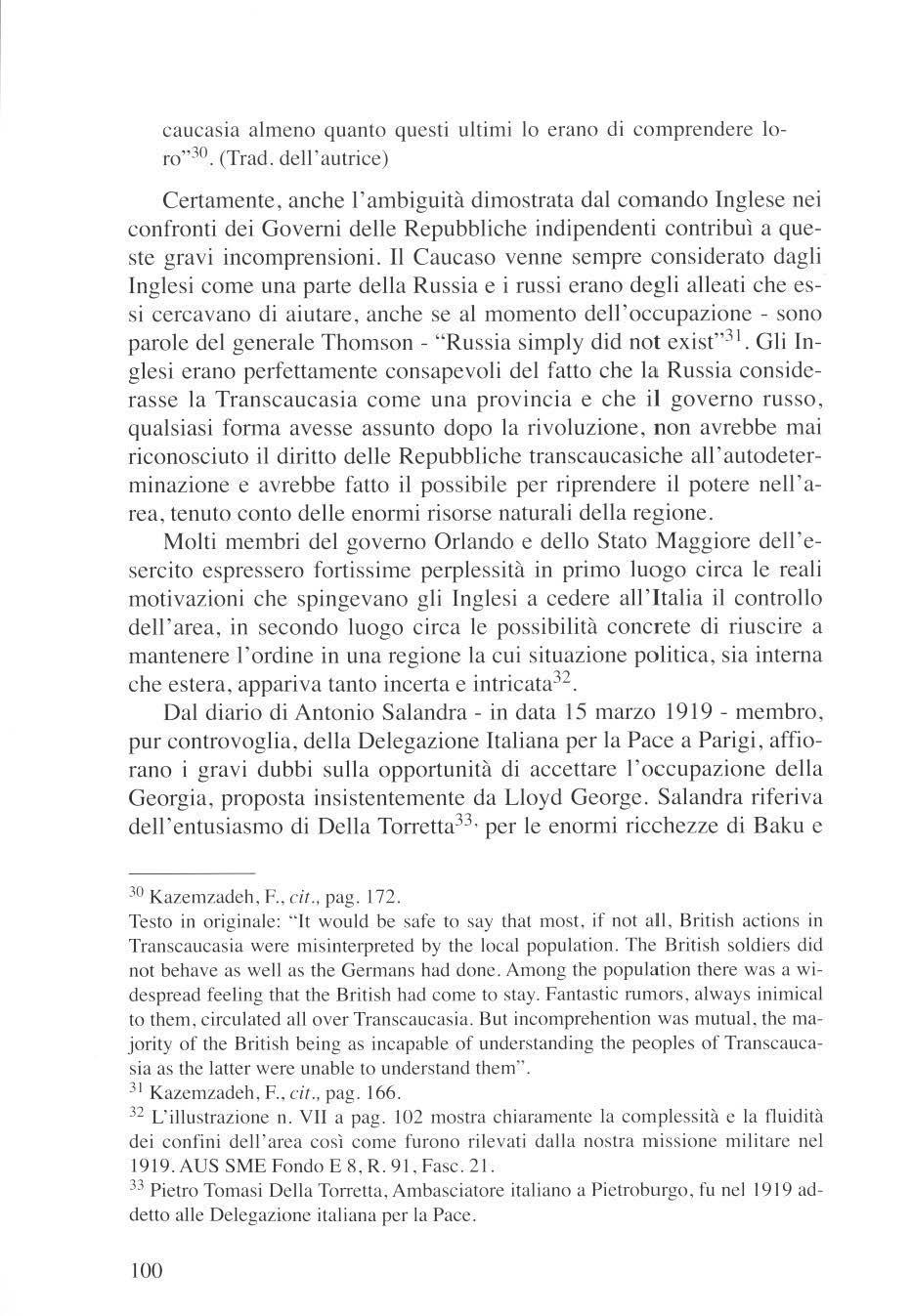
30 Kazemzadeh. F., cir .. pag. 172.
Testo in originale: " lt would b e safe to say that most, if not ali, Britis h actions in Transcaucasia were mi si nterpreted by the local population. The British soldiers did not behave as well as the Gennans had donc. Among the popu la tion th ere was a widespread feeling that the British had co me t o stay. Fantastic rumors, always inimicai to them, circulated a il over Tran scaucasia. But incomprehention was mutuai. the majority of the British being as incapable of understanding the peoples of Transcaucasia as tbc latter were unabl e to undcrstand them''.
31 Kazemzadeh, F cir., pag. 166.
32 L' illu strazione n. Vli a pag. 102 mostra chia ram en te l a complessità c la fluidità dei confin i dell'area così come furono rilevati dalla nostra missione militare nel 1919. AUS SME Fondo E 8, R. 91. Fase. 21.
33 Pietro Tomasi Della TorTctta, Ambasciatore italiano a Pictroburgo. fu nel 1919 addetto alle Delegazione italiana per la Pace ..
100
Batum ma, allo stesso tempo , si chiedeva come mai gli Inglesi ce la offr issero: "È difficiLe che lascino a noi roba buona"3 4 .
Il 19 aprile il generale Badoglio in un telegramma riguardante J' Asia Turca e la Transcaucasia e i nostri rapporti con Francia e Inghilterra, esprime al generale Diaz la sua convinzione che le miniere di carbone della Transcaucasia non avrebbero compensato la perdita, a favore dei Francesi, delle miniere di Eraclea; per quanto riguardava gli Inglesi Badoglio dubita che avrebbero abbandonato un 'area tanto ricca senza "gravi motivi di opportunità propria, che a noi forse sfuggano ancora" 35
La lettera inviata dal generale Diaz al presidente del consiglio Orlando, il 6 maggio del 191 9 , si soffermava sulla intricata situazione politica della Transcaucasia, tutt'altro che rassicura nte dato l'odio reciproco tra le popolazioni locali, l'odio verso g li inglesi che avevano commesso l'errore di atteggiarsi a colonizzatori c soprattutto per i crescenti fenomeni di bolscevismo in Georgia 36 .
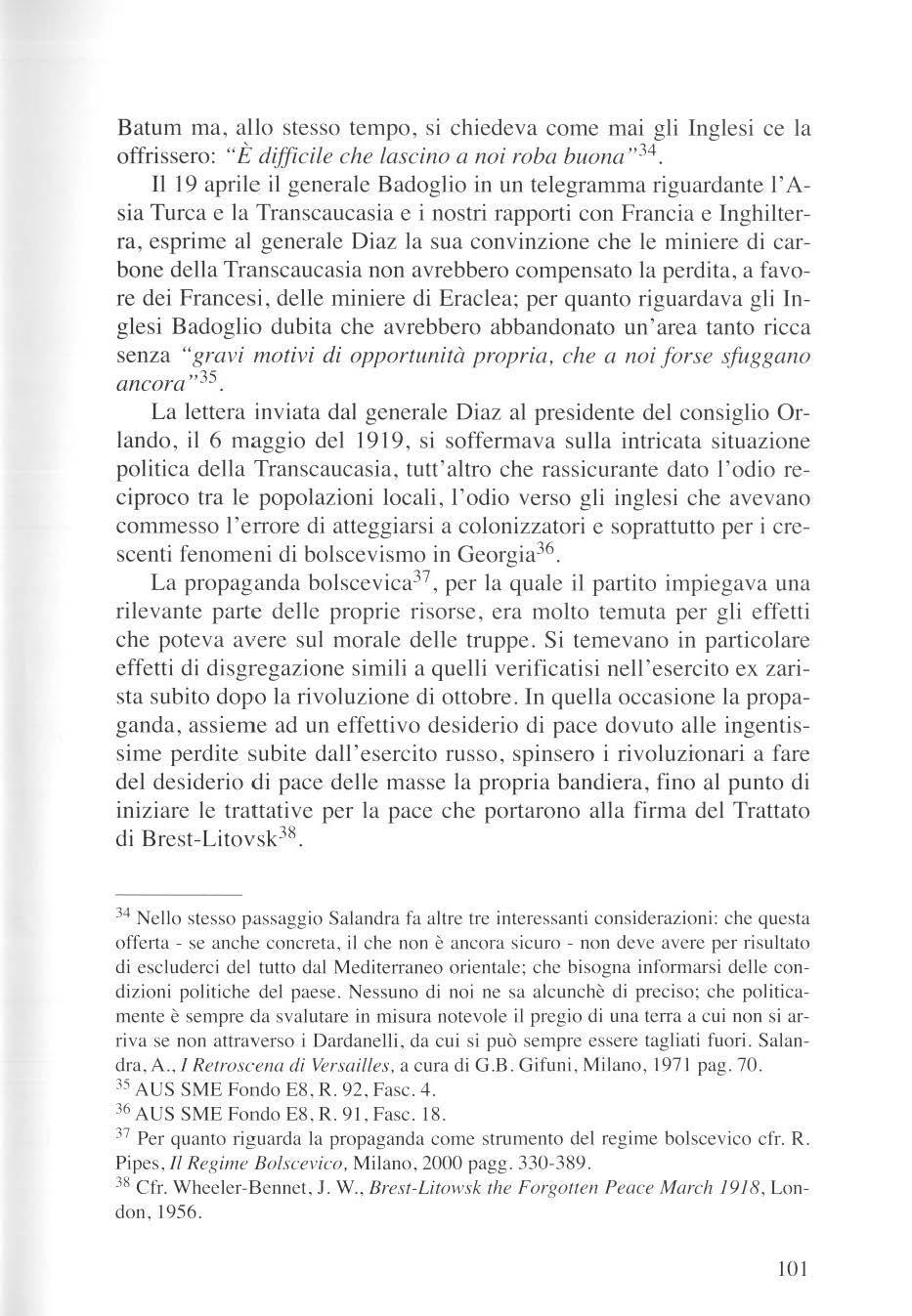
La propaganda bolscevica 37 , per la quale il partito impiegava una rilevante parte delle proprie risorse, era molto temuta per gli effetti che poteva avere sul morale delle truppe. Si temevano in particolare effetti di disgregazione simili a quelli verificatisi nell'esercito ex zaris ta subito dopo la rivoluzione di ottobre. In quella occasione la propaganda, assieme acl un effetti vo desiderio eli pace dovuto alle ingentissime perdite subite clalresercito russo, spinsero i rivoluzionari a fare del desiderio di pace delle masse la propria bandiera, fino al punto di iniziare le trattative per la pace c he portarono alla firma del Trattato di Brest -Litovsk38.
34 Ne ll o stesso passaggio Salandra fa altre tre interessant i considerazioni: che questa offerta- se anche concreta, il che non è ancora sicuro- non deve avere per ri:;ultato d i escluderci del tutto dal Mediterraneo orienta le; che bisogna infom1arsi clcllc condiz ioni polit iche del paese . Nessuno di noi ne sa alcunchè di preciso; che polit icamente è sempre da sva lut are in misura notevole il pregio di una terra a cu i non si arriva se non attraverso i Dardanelli. da cui s i può sempre essere tag li ati fuori. Salandra. A., I Retro:;ceno di Versai l/es, a cura di G .B. Gifun i. M il ano, 1971 pag. 70
:;s AUS SME Fondo E8, R. 92. Fa s e. 4.
3 6 AUS SME Fondo E8, R. 91. Fase. 18.
37 Per quan t o riguarda la propaganda come s trumento del regime bolscevico cfr. R. Pipes, [{Regime Bolscevico, Milano, 2000 pagg. 330 -389.
38 Cti·. Wheclcr-Bcnncl, J. W., Brest- Litowsk the Forgo/len Peace March 1918, Lonclon. 1956.
lO!
l.t1 leg[.:eltda applicata a/lato della mappa. che mostra la situa:ione al g iugno 1919, indica:
l. colormi in a:_:_urm i territori direllameme comrollati ingleJi;
2. il confine della repubblica georgiana in rosso:
3. in ''erde il cm!fìne dell'Armenia ex russa;
4. il COJ!fì ne dell'k:.erbaijan in marrone;
5. co n la lelfera A è indicaw il limit e della Georgia a16febbraio 1919;
6. co n la B il deside rato dalla repubblica georgiana:
7. con la C il limil e impos10 alla Georgia dagli ing lesi ( htngo iljìume B::.id):
8./a leuera D indica il dislrel/o di Aklwlkalaki. comrollaw dalla Georgia:
9. la E indica il dis1re1to cm11eso di Bonhalimk amministrmo da 1111 gol'ernatore inglese:
10./a F indica i confini 1m Armenia ed A:_erbaijan anrora da dnerminare :
Il. la G indica 1111 terriwrio 1./itggiw al colllrollo del gm •erno a:.ero per 11110 ril olta bol.1·cel'ica della popola:.ione;
12 . la linea viola indim il limite m eridionale dei territori OCC IIlWii dal genem l e D enikin o1•e potrebhe riso rge re la repubblica autonoma dei Montwwri del Cauca so e del Daghestan:
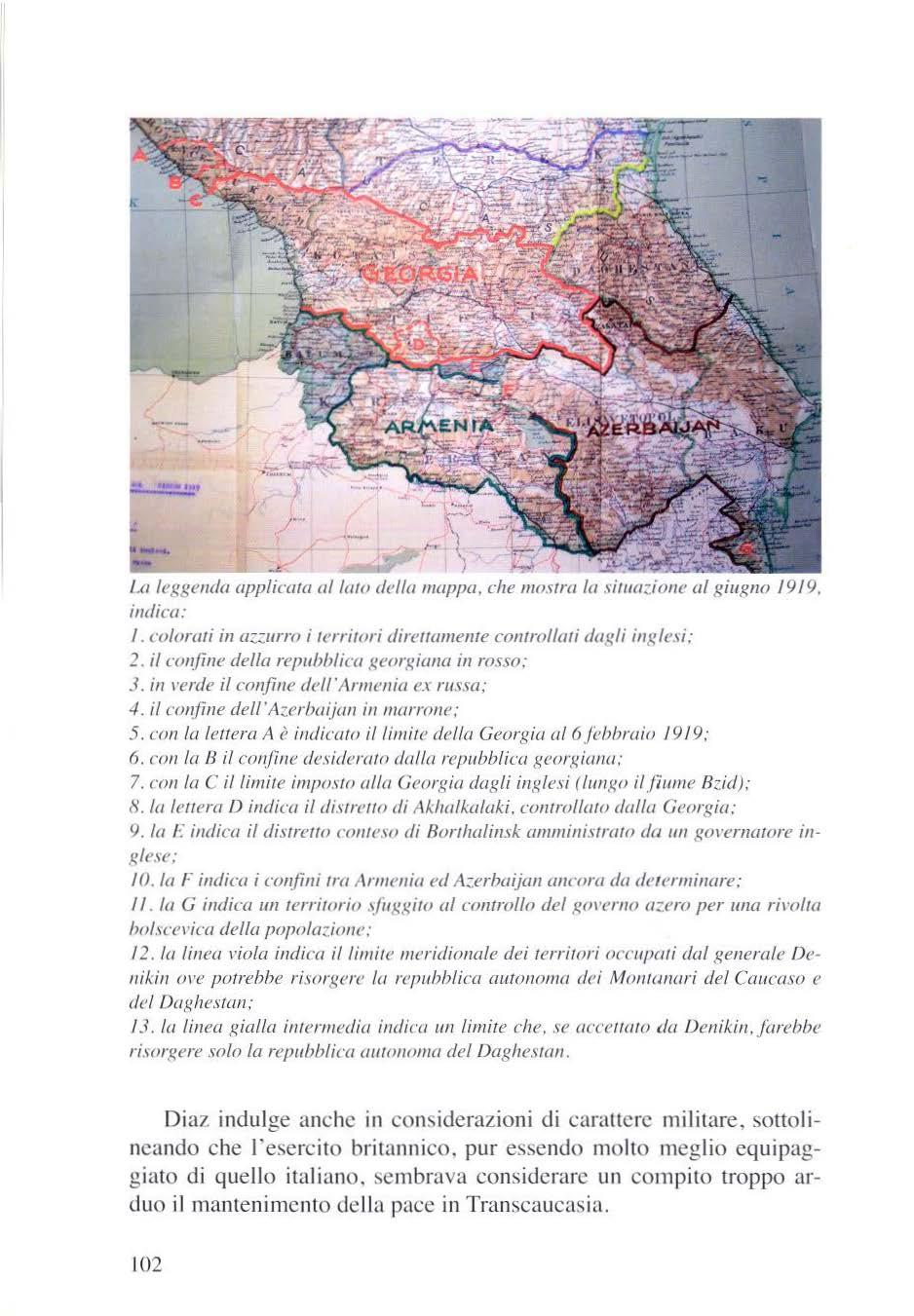
13. la linea gialla interm edia indica un limite che, se acce/W/o da Denikin. farebbe ri.\Orgere solo la repubblica a/1/0IW/1/a del Daghestan.
Di az indulge anc h e in co ns iderazioni di carallerc militare. sottolineando che l'esercito britann ico. pur esse n do mo lto meglio eq uip aggiato di quello itali ano, se mbrava co nsiderare un compito troppo arduo il mantenime n to della pace in Transcaucasia.
102
"Dal complesso di tali notizie si può ritenere che la sostituzione delle nostre truppe a quelle britanniche nella regione, è da considerarsi come un servizio ingrato da compiersi da noi per l'lnghilterra " 39 .
Tra le opinioni contrarie all'invio del contingente italiano registriamo anche quella di Vittorio Emanuele IIT, riportata in una lettera di Colosimo, ministro delle Colonie, a Orlando il 9 giugno 1919. Colosimo riferendosi all'opinione del sovrano dice:
"sue informazioni escludono che noi dobbiamo gettarci in simigliante impresa. Occorrono 100.000 uomini- con pericolo interno nostrocon possibilità di inquinamento dell'animo dci nostri soldati - con quasi certezza che non potremmo ricavarne benefici acccttabili"40
In considerazione di queste gravi notizie sulla situazione politica attuale e della questione ancora irrisolta della fornitura dei piroscafi inglesi per il trasporto delle nostre truppe, il generale consigliava di resistere alle pressioni inglesi e di aspettare notizie più precise dal colonnello Gabba.
A complicare ulteriormente la situazione i difficili rapporti tra le truppe ingles i di occupazione, il governo georgiano c l'esercito dei Vo l ontari del generale Denikin. G l i f nglesi avevano tentato di destreggiarsi tra i due contendenti, appoggiando il governo georgiano nelle sue rivendicazioni indipendentiste e nello stesso tempo rifornendo l'esercito di Denikin, finendo per trovarsi in una posizione oltremodo scomoda, che i l nostro contingente si sarebbe trovato ad ered itare 41 .
3 . Se lez ion e d e l C orpo d ' Armata per la Tran s ca uca s ia
Il problema ciel reperimento delle truppe non era d i poco conto, da una parte c'erano le pressioni del generale Wilson che so ll ecitava i l governo affi nché la partenza delle truppe avvenisse il più rapidamente possibile - anche perché le difficoltà che le truppe italiane avrebbero
39 AUS SME Fondo E8. R. 9 L Fa s e. 18.
4 0 Passaggio riportato in: Petricioli. M., cir pag. 70
4 1 In merito a questa situazione vedi un telegramma dell'Alto Commissario Ita l iano a Costantinopol i , SforLa. diretto al ministro degli esteri Sonnino in data 25 maggio 1919. AUS SME Fondo E8. R . 92, Fase. 4.
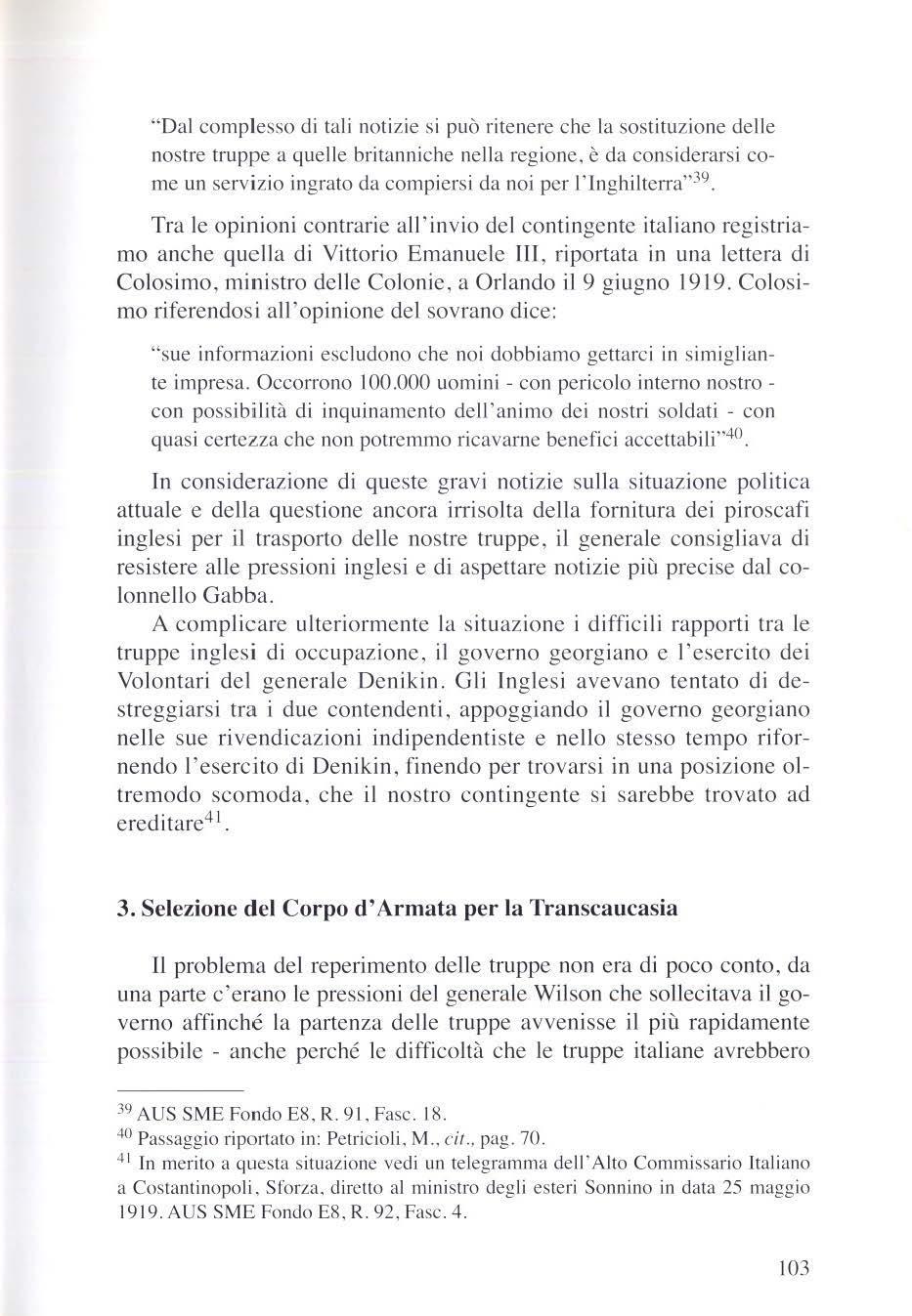
103
incontrato se avessero dovuto occupare la Transcaucasia dopo la partenza degli Inglesi sarebbero state certamente molto maggiori- dall'altra il generale Diaz , che pure concordava con la necessità di inviare rapidamente le truppe, riteneva poco consigliabile sottrarre due intere divisioni al paese in un momento in cui, anche a causa della smobilitazione, le richieste di truppe per ragioni di ordine pubblico erano crescenti. Di az sosteneva l 'o pportunità di togliere solo una divisione dall'Italia e di reperire la seco nda tra le truppe di stanza in Macedoni a, anche considerando che presto la situazione nei Balcani s i sarebbe complicata per i probabili contrasti tra stati per la delimitazione dci confini. Il colonnello Castoldi, della sezione militare della delegazione italiana alla conterenza della pace riteneva più opportuno togliere truppe all'Albania, dove erano più numerose ed era più facile inviare rinforzi42 Intanto il capo di Stato Maggiore diede ordine al generale Mombelli di prendere "quelle misure che non richiedevano spostamenti di truppe" 43
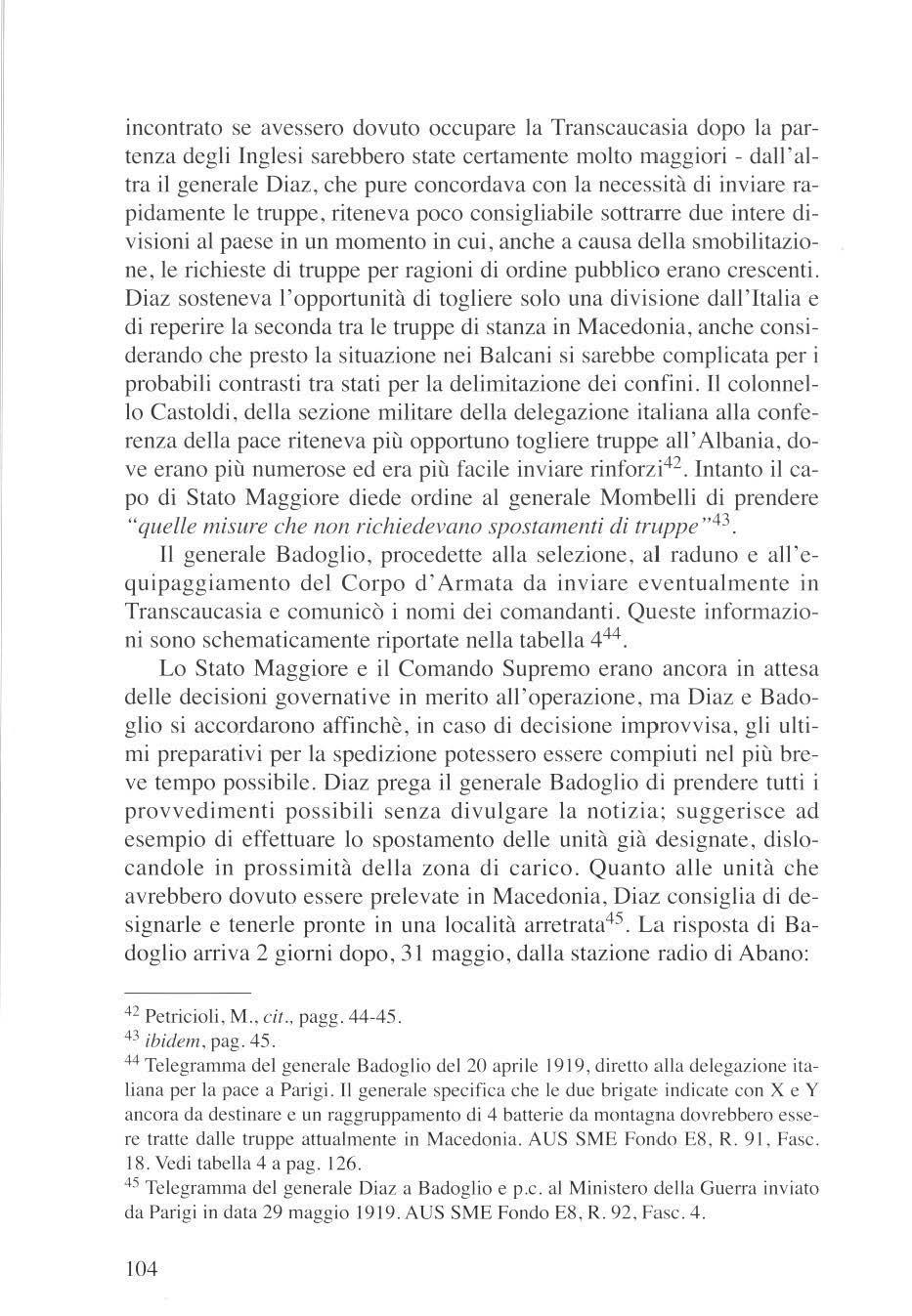
Il generale B adoglio, procedette alla se lezion e, al raduno e all'equipaggiamento del Corpo d'Armata da inviare eventualmente in Tran scaucasia c comunicò i nomi dei comandanti. Queste informazioni sono sc hematicamente riportate nella tabella 444
Lo Stato Maggiore e il Comando Supremo erano ancora in attesa delle decisioni governative in merito a ll 'o perazione , ma Diaz e Badoglio si accordarono affinchè, in caso di decisione improvvisa, gli ultimi preparativi per la spedizione potessero essere compiuti nel piì:1 breve tempo possibile. Diaz prega il generale Badoglio di prendere tutti i provvedimenti possibili senza divulgare la noti z ia; suggerisce ad esempio di effettuare lo spos tamento delle unità già designate, dislocandole in prossimità della zona di carico. Quanto aJie unità che av rebbero dovuto essere prelevate in Macedonia , Diaz consiglia di designarle e teneri e pronte in una località arretrata45 La risposta di Badoglio arriva 2 giorni dopo, 31 maggio, dalla stazione radio di Abano:
42 Petticioli, M cit pagg. 44 -45.
43 ibidem, pag. 45.
44 Telegranuna del generale Badoglio del 20 aprile 1919, diretto al la delegazione italiana per la pace a Parigi. li ge nerale specifica c he le due brigate indicate co n X e Y ancora da destinare c un raggruppamento di 4 batterie da montagna dovrebbero essere lrallc dalle truppe attualmente in Macedonia. AUS SME Fo ndo E8, R. 91. Fase.
18. Vedi tabella 4 a pag. 126.
45 Telegramma del ge neral e Diaz a Badoglio e p.c. al Mini stero della Guerra inviato da Parigi in data 29 maggio 1919.AUS SME Fondo E8, R. 92. Fase . 4.
104
"Le Unità già designate per la Missione militare italiana in Transcaucasia sono radunate a sud del lago di Garda in zona conveniente per emico fen-oviario. Esse sono: Comando XII corpo d'armata: Divisione 22° (brigate Firenze e Roma);Divisione 7SO (brigata Calabria e 6° raggruppamento alpini)" 46.
I primi scaglioni pronti per l'imbarco avrebbero potuto essere a Taranto dopo 19 giorni e i piroscafi per il trasporto avrebbero dovuto trovarsi a Taranto dopo circa 20 giorni.
Di questa fase organizzativa del Corpo d'Armata per il Caucaso rimangono un folto numero di documenti, riguardanti l'equipaggiamento per le truppe, i provvedimenti di carattere sanitario ed un intero fascicolo riguardante gli automezzi da assegnare al XII Corpo d'Armata per la Transcaucasia47
I provvedimenti in questione vennero disposti in seguito al ricevimento di una relazione del colonnello Gabba del 18 giugno 1919 sulla situazione nel Caucaso, contenente in allegato anche una relazione sanitaria sulla città di Tiflis de1l'ufficiale medico, capitano Edoardo Cook. l rischi maggiori per le nostre truppe dirette nell'area, per le quali intanto lo Stato Maggiore aveva disposto una campagna di vaccinazioni contro il colera e la profilassi antimalarica4R, riguardavano a detta dell'Ufficiale
46 Questo telegramma del generale Badoglio del 3 1 maggio 1919 a tutte le tlomantle che Di az aveva posto circa i tempi eli approntamento de ll e divisioni c la loro co ll ocazione in zone convenienti per il carico. Da un nome alle due brigate che nello specchietto de l 20 apri le erano state individuate con X e Y (alla X corrisponde la brigata Roma, alla Y la brigata Calabria). Questo documento non fornisce chiarimenti in merito ad un altro punto individuato da Diaz: le truppe in Macedonia. AUS SME Fondo E8. R. 92, Fase. 4. 4 7 11 fascicolo in questione contiene buona parte dci dati sugli autome zz i, cope1ti c scoperti, le motociclette e le motocarrozzettc assegnate agli autoclrappelli del Xll Corpo d'Armata e al l a 75 ° e 22 ° divisione. Si parla in uno eli questi documenti , un fonogramma s pedito il 17 giugno 19 19 dal Comando Supremo - Ufficio Serviz i al la Sezione auto di Padova a fiTma del colonnello Lazzi, di 300 autocarri, 10 autofrigoriferi e una decina di autobonze per il traspo1to dell'acqua (non essendoci disponibilità di autobotti). Sono segnalati anche tutti gli aumenti e i cambiamenti apportati nella composizione degli autodrappelli . Da segnalare in pruticolare l a scelta di sos tituire i carri per il trasporto dei feriti con autoambulanze oppure con autocarri attrezzati. AUS SME Fondo E3, R. 246, Fase. 32 (4).
4 8 Telegramma del generale Badoglio datato 13 giugno 1919, diretto al Comando Supremo - Ufficio Ordinamento e Mobilitazione. AUS SME Fondo E3, R. 246, Fase . 32 (4).

105
Medico, H tifo a causa della trascuratezza nel filtraggio dell'acqua; il tifo petecchiale nelle campagne , veicolato dai pidocchi; pochi i casi di vaiolo, tubercolosi e malaria mentre numerosissimi erano i casi di gonorrea " .. si da dover essere adibito un apposito ospedale ove i ricoverati superano di molto tutti gli altri infenni di malalfie comuni ricoverati negli altri ospedali" 49 11 capitano Cook , alla fine della relazione, comunicava di aver aperto un ambulatorio della missione militare italiana presso il nostro Consolato per dare as sistenza alle famiglie povere italiane c per i poveri in genere che avrebbe distribuito gratuitamente i medicinali 50 .
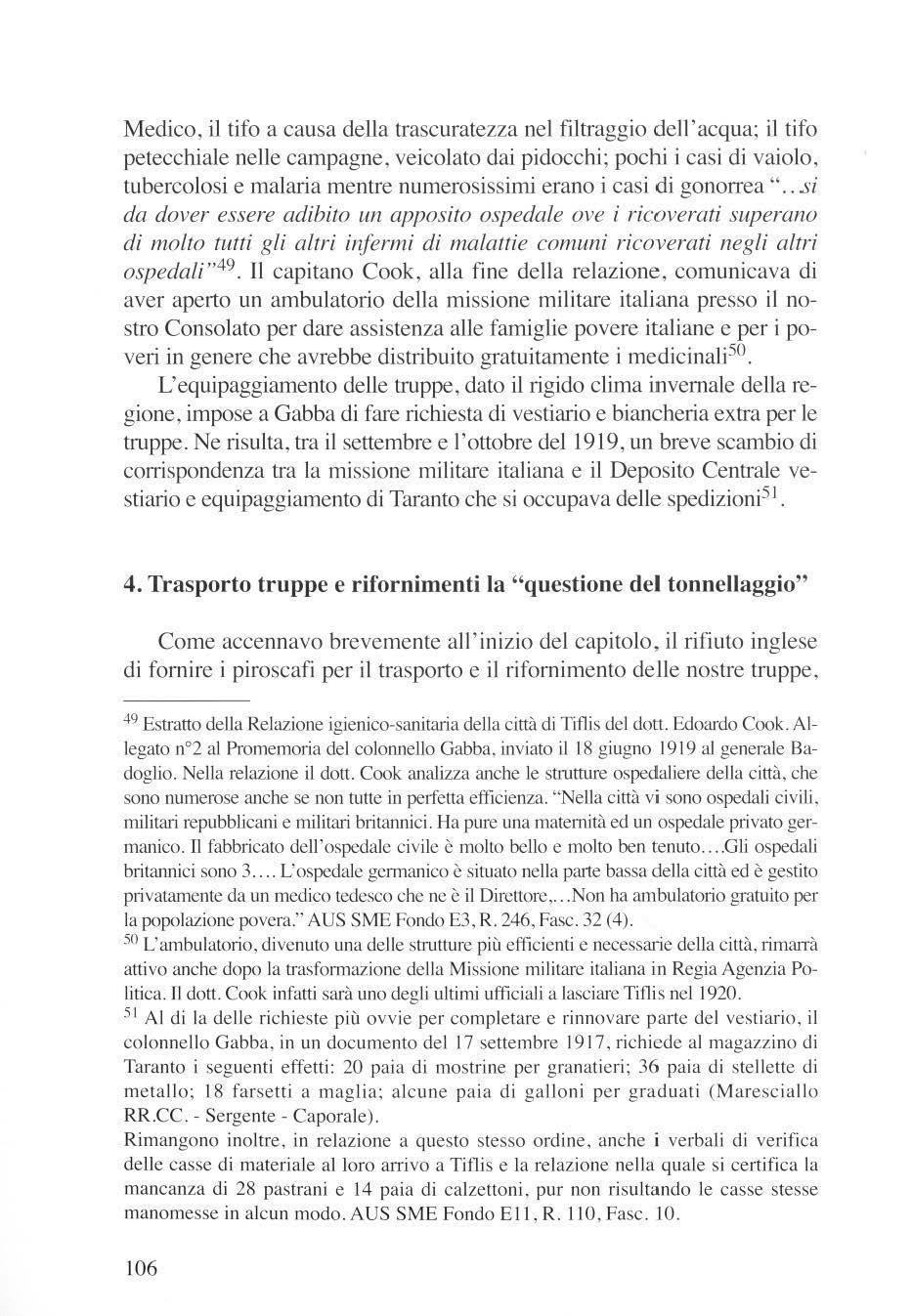
L'equipaggiamento delle truppe, dato il rigido clima invernale della regione, impose a Gabba di fare richiesta di vestiru.io e biancheria extra per le truppe. Ne risulta, tra il settembre e l'ottobre del 1919, un breve scambio di corrispondenza tra la missione militare italiana e il Deposito Centr·ale vestiario c equipaggiamento di Taranto che si occupava delle spedizioni 51
4. Trasporto truppe e rifornimenti la "questione del tonnellaggio"
Come accennavo brevemente all'inizio del capitolo, il rifiuto inglese di fornire i piroscafi per il trasporto e il rifornimento delle nostre truppe,
49 Estratto della Relazione igieni c o -s anita ria della città di Tiflis del dott. Edoardo Cook. Allegato n° 2 a l Promemoria del colonnello Gabba. inviato il 18 g iug no 1919 al generale Badoglio. Nella relazione il dott. Cook anali z za anche le s trutture o s peclaliere della città , che s ono numerose anche se non tutte in pe1fetta efficienz a. " Nella città vi sono ospedali civili militari repubblicani e militari britannici. Ha pure una matemità ed un ospedale privato germanico. n fabbricato dell'ospedale civile è molto bello e molto ben tenuto Gli ospedali britannici sono 3 L'ospcclale gem1anico è situato nella parte ba s sa della città ed è gestito p1ivatan1ente da un medico tedesco che ne è il Direttore, Non ha ambulatOiio gratuito per la popolazione povera." AUS SME Fondo E3, R. 246, Fase. 32 (4) .
50 L' <m1bulatorio, divenuto una delle strutture pii:1 efficienti e necess arie della città, 1imarrà attivo anche dopo la trasformazione della Missione militare italiana in Regia Agenzia Politica. n dott. Cook infatti s arà uno deg li ultimi uftìciali a lasciare Tinis nel1920.
51 Al di la de ll e richieste più ovvie per completare e rinnovare parte del vestiario, il colonne llo Gabba. in un documento de l 17 settembre 1917, richiede al magazzino di Taranto i seguenti effetti: 20 paia di mostrine per granatier i ; 3 6 paia di stel lette di metallo; 18 farsetti a maglia; alcune paia di galloni per graduati (Maresciallo RR.CC.- Sergente- Caporale).
Rimangono inoltre , in relazione a questo s te ss o ordine, anche i verba li d i verifica delle casse di materia le al loro anivo a Titlis e la relazione nella quale si certifica la mancanza di 28 pastrani e 14 paia di calzettoni. pur non risu.ltando le casse stesse manomesse in alcun modo. AUS SME Fondo El l, R. 110. Fase. lO.
106
influì senza dubbio sulla decis ion e del governo it aliano di abbandonare la s ped izione, ma in misura minore rispetto a motivazioni altre. Come vedremo dali 'ana li si dci documenti il gabinetto Orlando, deciso ad intraprendere la spedi zione stava cercando di reperire tonne ll agg io italiano per effe ttu a re co munqu e il trasporto; l a dec isione di Nitti di sospendere la s tessa, il 27 giugno dell919 , ha motivazioni che !ungi dall'essere so lamente log istiche.1isu lt ano i nvece esse nzia lm ente politiche.
Nel co lloqui o intercorso, il 24 marzo 1919, tra Sir Henry Wilson e il genera le Di az, il primo era s tato informato della necessità del governo italiano di effettuare s ia il trasporto delle proprie truppe che i rifornim e nti co n piroscafi britannici , e s i era dichiarato apertamente a favore, almeno per quanto ri guardava il trasporto, qualche perplessità era s tata esp re ssa in vece in merito ai rifornimenti 52 .
Tn una lettera dell8 aprile, inviata dal Capo di Stato M agg io re dell a marina, Paolo Thaon di Revel. alle più alte cariche del governo c del! 'esercito nonché a l ministro dei trasporti , apprendiamo che la Regia Marina, informata dal governo della disponibilità Inglese - accordata però solo ver balmente - di provvedere a l trasporto delle nostre truppe, consideri assolutamente indi spensabile c he gli In glesi si accollino a nch e l'onere dei rifornimenti e del mantenimento dei contatti tra le no stre trup pe e l a Madre Patria.
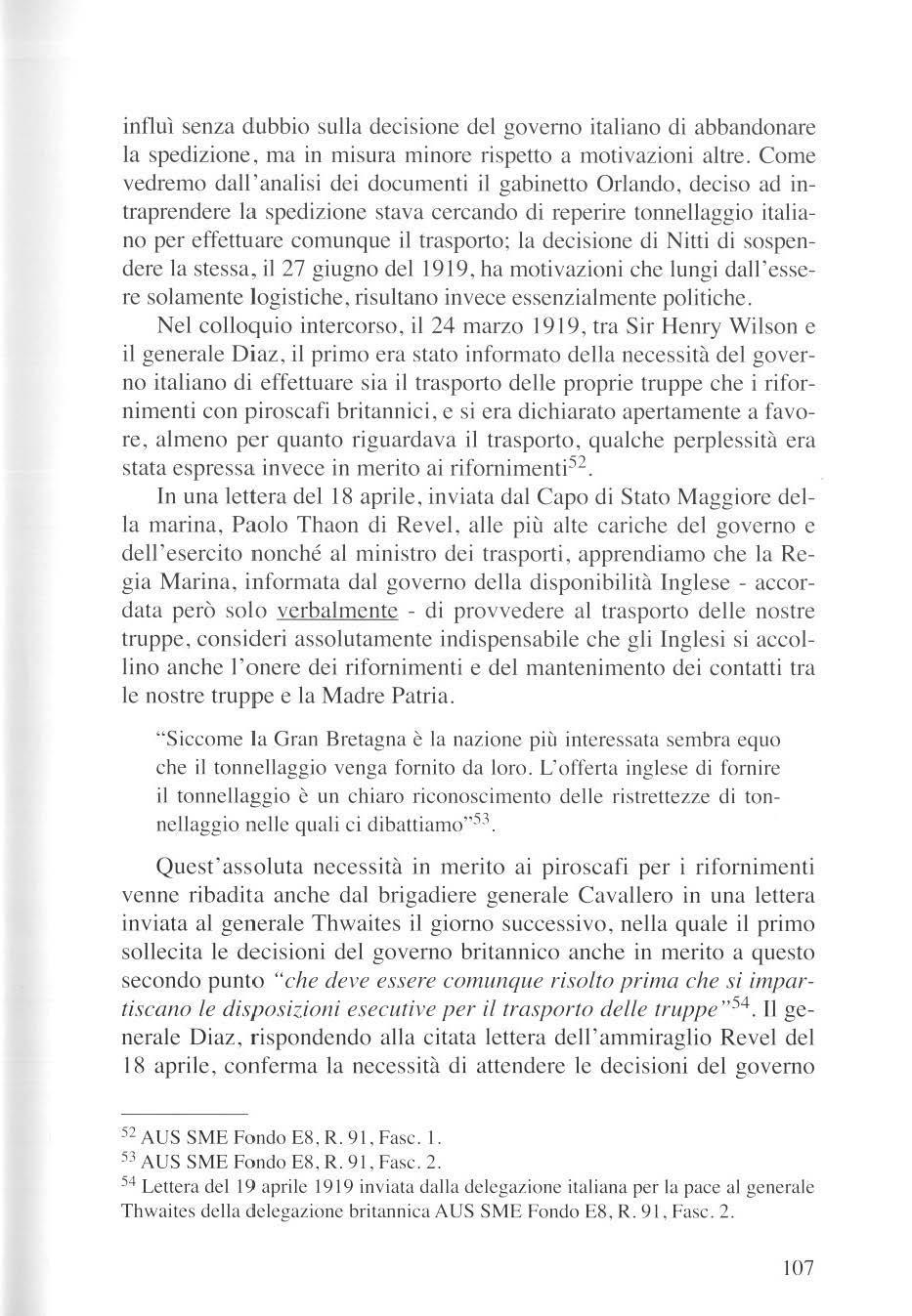
"S icco m e la Gran Bretagna è la nazione più interessata sembra eq uo c he il tonnellaggio ve nga fornito da loro. L 'offerta inglese di fornire il tonnellaggio è un ch iaro riconosc im ento delle ristrettezze di tonnell aggio nelle quali ci dib a tti amo"53 .
Quest'asso lut a nec ess ità in merito a i piro scafi pe r i rifornimenti ve nn e ribadit a anche dal brigadiere generale C av allero in una le tte ra inviata al generale Thwaites il giorno s uc cess ivo , nella quale il primo so llecit a le d ecis ioni del governo britannico a nch e in merito a que sto seco ndo punto "che deve essere comunque risolto prima che s i imparti sca no le disposi zioni esecutive per il trasporto dell e truppe" 54 Il gene rale Diaz, rispondendo alla citata lettera dell'ammiraglio Rev e l del 18 apri le , conferma la nec ess ità di attendere le d ecis ioni del governo
52 AUS SME Fondo E8, R. 91. Fase. l.
53 AU S SME Fondo E8, R. 9 1 . Fase. 2 .
54 L ettera del\9 apri le 19\9 inviata dalla delegazione italiana per la pace al ge nera le Thwait es della dclcgaL ionc britannica AUS SME Fo ndo E8. R. 9 1. 2 .
107
inglese 55 . A causa della mancanza di tonnellaggio, infatti, circa 8500 soldati italiani, che avrebbero già dovuto essere rimpatriati per i motivi più svariati , non potevano fare ritorno in Patria56 .
Da questo momento, scorrendo la documentazione d'archivio, si assiste a quella che potremmo definire una vera c propria escalation dì disinformazione, omissioni e rifiuti da parte degli Inglesi.
Il 10 maggio del 1919 arriva una prima risposta, peraltro piuttosto interlocutoria, del generale Thwaites diretta al colonnello Pariani della delegazione italiana57 , missiva nella quale il generale britannico comunica di aver interessato il Ministero della Marina per reperire il tonnellaggio richiesto, fino a quel momento senza successo; Thwaitesche garantisce di aver sottoposto il Ministero a nuove pressioni per reperire i piroscafi - si impegnava inoltre ad informare la Delegazione sulle decisioni conclusive58.

La cotTispondenza successiva del 29 e 30 maggio, tra Cavallero e Thwaites , segna un ulteriore punto di svolta nei contatti tra i due Alleati. Cavallero ridimensiona le richieste italiane, informando Thwaites di aver preso le misure necessarie per effettuare i rifornimenti con tonnellaggio proprio rimaneva, quindi, solo la necessità dì effettuare il trasporto delle truppe con piroscafi inglesi. Cavallero pregò Thwaites dì dare istruzioni alle autorità competenti affinché prendessero gli accordi necessari con il rappresentante italiano per i trasporti marittimi 59
Thwaites prese tempo adducendo la necessità di ottenere alcune informazioni, di carattere logistìco (data dì partenza delle truppe, porto d'imbarco. numero delle unità da trasportare), prima di fare formale richiesta alle autorità britanniche di Marina60 Il giorno successivo (31 maggio) Cavallero comunica a Thwaites che la data di partenza delle truppe italiane sarà fissata in funzione dell'arrivo dei piroscafi britannici nel porto d'imbarco che dovrebbe essere quello di Taranto. La forza da trasportare avrebbe dovuto essere la seguente: 1000 ufficiali,
5 5 AUS SME Fondo E8, Racc. 91, Fase. 2.
56 Questo dato viene fornito dal generale Mombelli al brigadiere generale CavaJJero in una lettera del 22 aprile 1919. AUS SME Fondo E8, R. 87, Fase. 54.
57 Interessante notare come Pariani non sia l'interlocutore cui il generale Thwaites s i rivolge abitualmente. I contatti, in precedenza, erano stati tenuti direttamente da Diaz c Cavallero.
5K AUS SME Fondo E8 , R. 91, Fase. 2.
5 9 AUS SME Fondo E8. R. 91 , Fase. 2.
60 Lettera datata Parigi 30 maggio 19 19. AUS SME Fondo E8, R. 91. Fase. 2.
108
31 .000 uomini di truppa, 5.500 quadrupedi, 56 pezzi di artiglieria. 1100 carri e J70 autoveicoli 61 .
A complicare ulteriormente la situazione giunse la richiesta, del ministro Caviglia, di cambiare il porto d'imbarco da Taranto a Venezia per risparmiare l'impiego di materiale rotabile c carbone in un inutile spostamento delle truppe62 Questa richiesta era in netto contrasto con le disposizioni date in precedenza dal capo di stato maggiore della marina, che riteneva che gli unici criteri validi per la scelta del porto fossero in primo luogo, le agevolazioni maggiori per l'imbarco della truppa c "in secondo Luogo di consentire il minore tragitto marittimo alla spediz.ione" 63 La domanda sul possibile cambio del porto d'imbarco, venne girata anche a Thwaites, dal quale si aspetta una risposta insieme al programma del tonnellaggio. che doveva essere redatto dalla marina britannica. Il generale Diaz intervenne autorevolmente presso l'Ufficio operazioni del Comando Supremo , e mise un punto fermo a questa questione disponendo che il porto d'imbarco fosse fissato a Taranto fino a nuovo ordine64 . La risposta di Thwaites non arrivò mai.
Il 12 giugno 1919, l'ammiraglio De Lorenzi, scrive a S.E. Revcl c al con trammiragl io Grassi di aver ricevuto una comunicazione dal Ministry of Shipping che, adducendo la necessità di grossi spostamenti dì truppe britanniche verso altri scacchicr i , rifiutava qualsiasi fornitura di navi per il trasporto degli italiani. Anche l'ipotesi, prospettata in precedenza, eli utili zzare per il contingente italiano g li stess i piroscafi uti1izzati per il rimpatrio dei soldati britannici veniva respinta dato che i piroscafi dovevano fermarsi a Costantinopoli da dove sarebbe ro ripartiti per altra destinazione. D e Lorenzi scrive che anche la stessa esistenza dell ' impegno inglese a fo rnire il tonnellaggio per il trasporto veniva negata e consigliava di non insistere sull'esistenza di tale promessa a meno eli non fornire particolari più precisi a riguarclo 65 Cavallero scrive a Sonnino e Crespi informandoli di questa novità in assoluto contrasto con le precedenti trattative, durate per altro quasi
6 I AUS SME Fondo ES. R. 91 . Fase. 2.
62 Telegramma datato Roma. 4 giugno 19 19 inviato dal ministro Caviglia al Comando Supremo - ufficio operazioni e p.c. a l generale Diaz. AUS SME Fondo E8. R. 91. Fase. 2.
63 Lettera dell'ammiraglio Revel del 18 apr il e 1919. AUS SME Fondo E8, R. 91. Fase. 2.
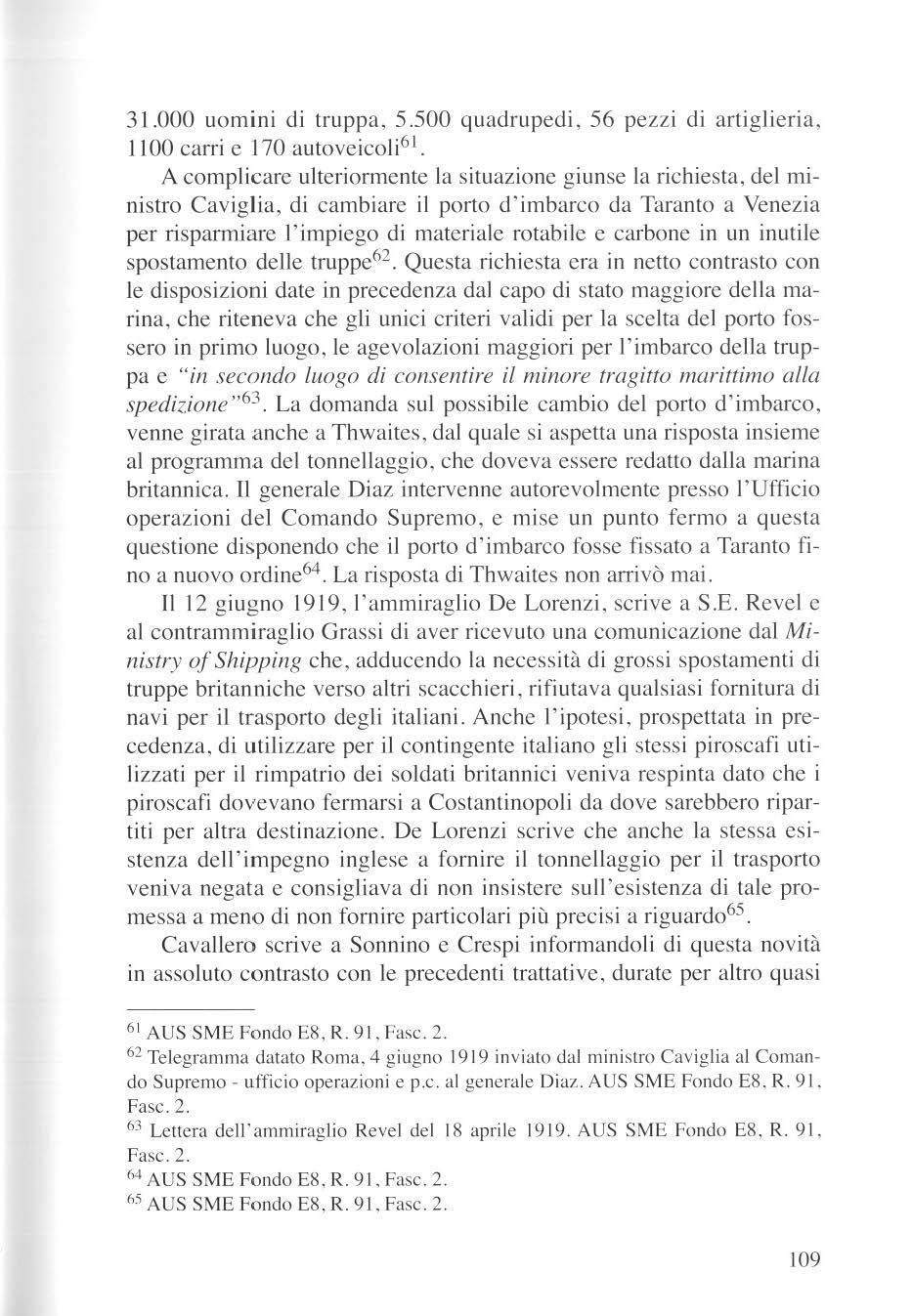
64 AUS SME Fondo E8. R. 91. Fa se 2.
65 AUS SME Fondo E8. R. 91. Fa se . 2.
109
tre mesi, che erano sempre state basate sull'esplicita condiLione che il tonnellaggio occorrente sa rebbe stato fornito dal governo britannico. Cavallero suggerì di protestare co n le autorità inglc i per ottenere almeno ''un largo concorso di tonnellaggio" come lasciava intendere l'ultima comu ni caz ione con Thwaites, nella quale il generale aveva richiesto una serie di dati concreti ci rca la forza del nostro corpo di sped izione, a dimostrare che la questione s tava entrando nella fase operativa66 .
Al governo italiano. ancora deciso a inviare l a spedizione nono . tante il rifiuto In glese. non rimase c h e ce rcare di trovare i piroscafi tra quelli italiani c il tonnellaggio ex -n emico, per uriliuare il quale comunque, ammesso che ve ne fosse di disponibile, avrebbe dovuto avere il benestare degli Alleati, essendo quest'ultimo destinato ai soli usi interallcati 67 .
La co municazione ufficiale di Lloyd George a So nnino è del 17 giug no. trattasi anco ra una volta di una comunicazione verba le, come si intuisce dal telegramma eli Sonnino:
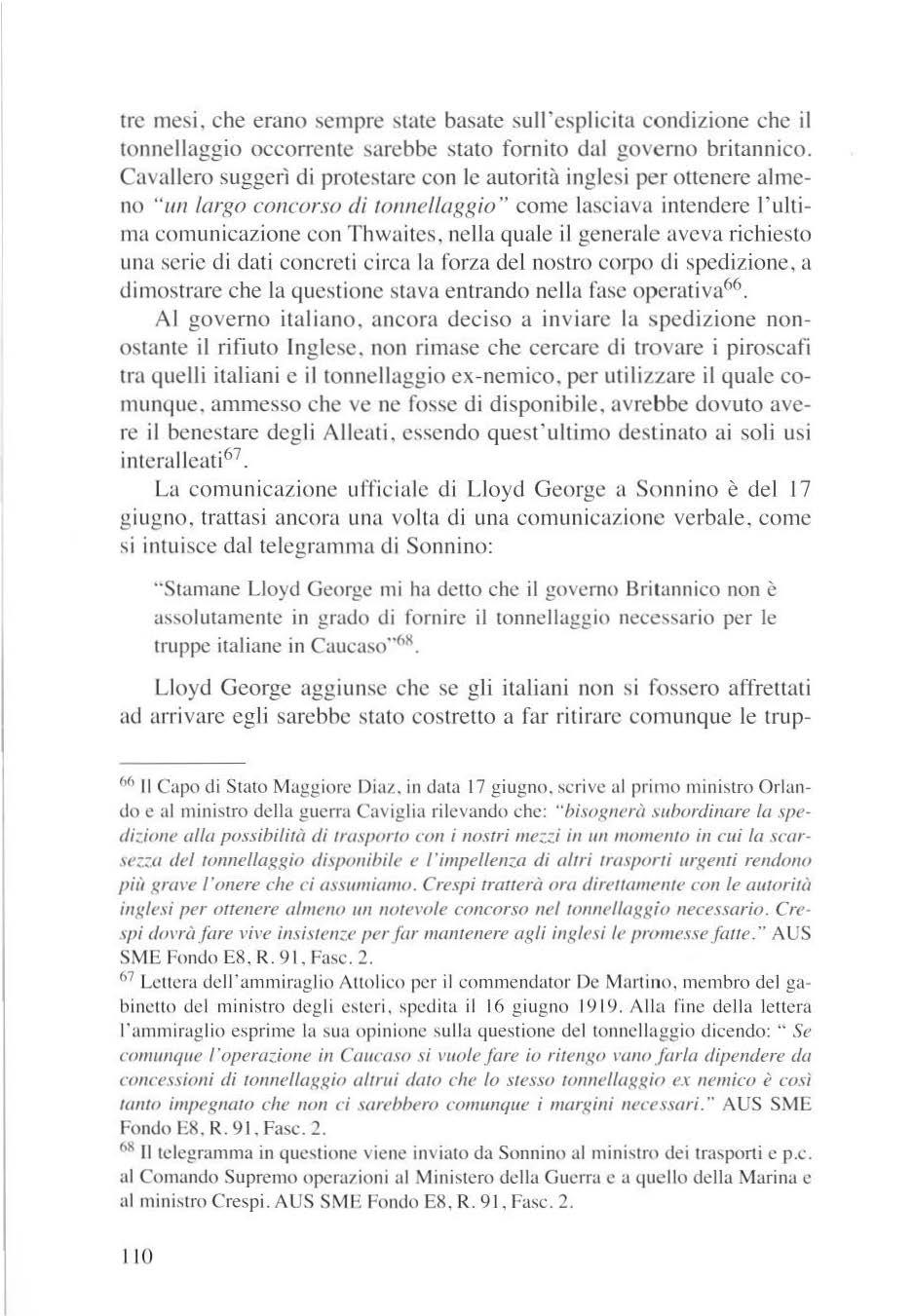
·'Stamane Uoyd George mi ha detto che il governo Bri t annico non è assolutamente in grado di fornire il tonnellaggio necesc;,ario per le truppe italiane in
Lloycl George aggiunse che se gli italiani non si fossero affrettati ad arrivare eg li sarebbe stato costretto a far ritirare comunque le trup-
M Il Capo di Stato Maggiore Dia;.. in data 17 giugno. scr ive a l primo ministro Orlando e al ministro della guerra Caviglia rilevando che: "bisof?l/eNÌ subordinare la spedi:;ione alla possibilità di trasporto co11 i 11ostri me-:_::.i in 1111 mome1110 in cui la scar\e:;:;a del 101/ne//aggio disponibile e l'impellew: a di altri trasporti urgemi rendono pitì grm·e l'onere che ci assumiamo. Crespi traTterà ora direl/alltellle con le autorità per ottenere almeno 1111 nmemle co11cnrso nel tomtella[.!gio necessario. Credmnìfare l'ive imisten::e per .far ma111enere agli i11gle\i le promesse fatte." AUS
SME Fondo E8, R. 9 1. Fase. 2.
67 Lcllera dell'ammiraglio Atto lico per il commendator De Martino, membro del gnbinctlo del ministro degli spedita il 16 giug no 19 19. Alla fine della lettera l 'ammiraglio esp rim e l a sua opinione sulla questione del tonnella gg io dicendo: Se COIII/ tllqu e f'opera:.ione in Cauwso si l'uole fare io ritengo l'W/O farla dipendere da concessioni di tonnellaggio altrui dmo che lo stesso tonnellaggio ex nemico è co.\Ì tallln impegnato che non ci sarebbero comwu1ue i margini necessari ... AUS SME
Fondo E8. R. 9 1. Fa se. 2.
6!-. Il telegramma in questione viene inviato da Sonnino al dei trasporti c p.c. al Comando Supremo opera7ioni al Ministero della Guerra c a quello della Marina c al minis tro Crespi. AUS SM E Fondo E8. R. 91. Fase. 2.
IlO
pe inglesi. Sonnino so ttolinea che una tale eventualità sa rebbe stata molto pregiuclizievole per la missione e avrebbe potuto costringere i soldati italiani a difficili opera z ioni militari. Se non si desiderava abbandonare la missione era indispensabile provvedere con mezzi propri al tonnellaggio per il trasp011o delle truppe.
Inutile dire che non pochi si interrogarono sulle reali motivazioni sottese al repentino vo ltafa ccia britannico. In particolare Diaz scrive al generale Cavallero a S.E. Orlando c al ministro Sonnino
" Dopo il noto rifiuto delle autorità ingl es i a l tr asporto delle trupp e sorge il dubbio che sia intervenuto qualche fatto nuovo che non consigli più a dette autorità di facilitare reffettuazion e della no s tra s pedizione e La sostituzione delle truppe britanniche. Prego pertanto di raccogliere le informazioni inte se a scoprire i reali moti v i del nuovo atteggiam e nto delle autorità ingle s i. assolutamente opposto a quello tenuto in precedenza " 69 .
La comunicazione successiva, in data 3 luglio, era firmata dal tenente colonnello Pellicelli che informava Diaz e il Ministero degli Esteri di aver provveduto, s u incarico del ministro Tittoni, a comunicare a Thwaitcs la nostra impossibilità di reperire il tonnellaggio necessario alla sped iz ione, nonostante gli sforzi profusi. facendo inoltre osservare come tale esito fosse prevedibile dato che già in precedenza erano stati informati dell'assoluta necessità di utilizzare piroscafi britannici. Alla domanda di Thwaitcs se questo implic asse la rinuncia alla spedizione, Pellicelli rispose che pur non essendoci in merito decisioni precise del governo, egli riteneva che si sarebbe potuti arri vare a questa decisione.
"Pur non avendo dato. come S.E. Tittoni desiderava. alcuna certezza in merito all"abbandono della spedizione ho però fatto credere che ci si stesse o ri e ntand o verso il rifiuto. Thwaites telegraferà a Wilson le mie comunicazioni·•70 .
Jmp011ante sottolineare che questo telegramma interviene in una data successiva alla caduta del gabinetto Orlando che sarà sostituito alla g uida del governo da Francesco Saverio Nitti.
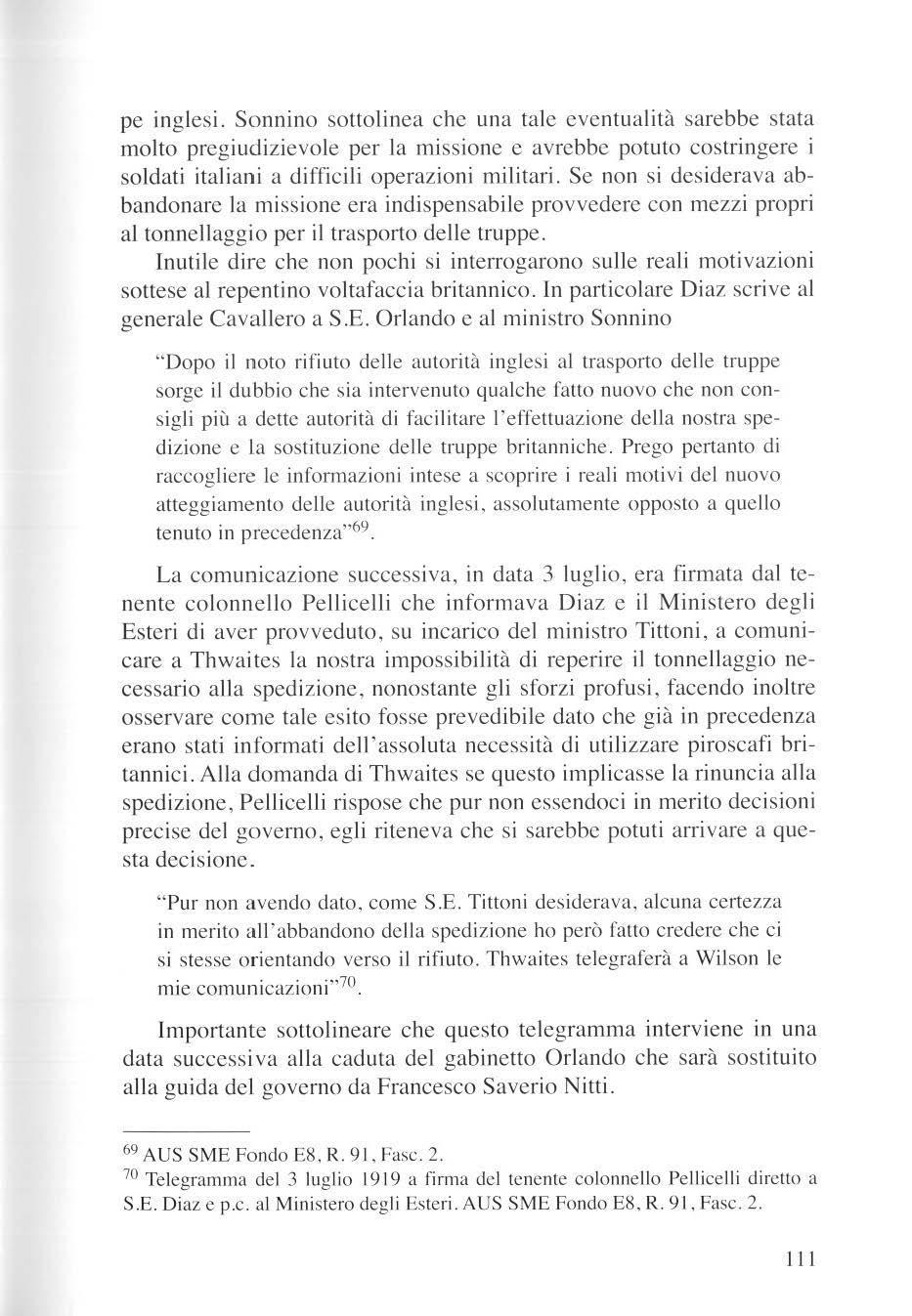
70
S.E.
az.
E8,
2. J Il
69 AUS SME Fondo E8, R. 9 1. Fase. 2.
Telegramma del 3 lug l io 1919 a fi rma de l tenente colonnello Pellicelli diretto a
Di
e p.c. al Minist ero degli Esteri. AUS SME Fondo
R. 91, Fase.
5 . La caduta d el Gab in etto Orlando
l l gab inetto Orland o andò in crisi, apparentemente per una mozione procedurale, il 19 g iu g no 1919. In realt à qu esta questione copriva ìl profondo malcont e nto del Pa ese per l'andamento della Conferenza de ll a Pacc 71 L'insuccesso diplomatico it a li ano era in gran parte imputabile ai cont rasti di carattere tra Orlando e Sonnino che ebbero grav iss ime ripercussioni sull'u nit à di azione della Delegazione italiana.
Salandra nel suo diario fa una lucida a nali s i , non pr iva di autocritica, dell'andamento delle tratta ti ve so ttolin ea nd o in più di un passagg io l'atteggiamento intransigente del ministro degli esteri Sonnino, contr a ppo sto ai tentennamen ti di Orlando:
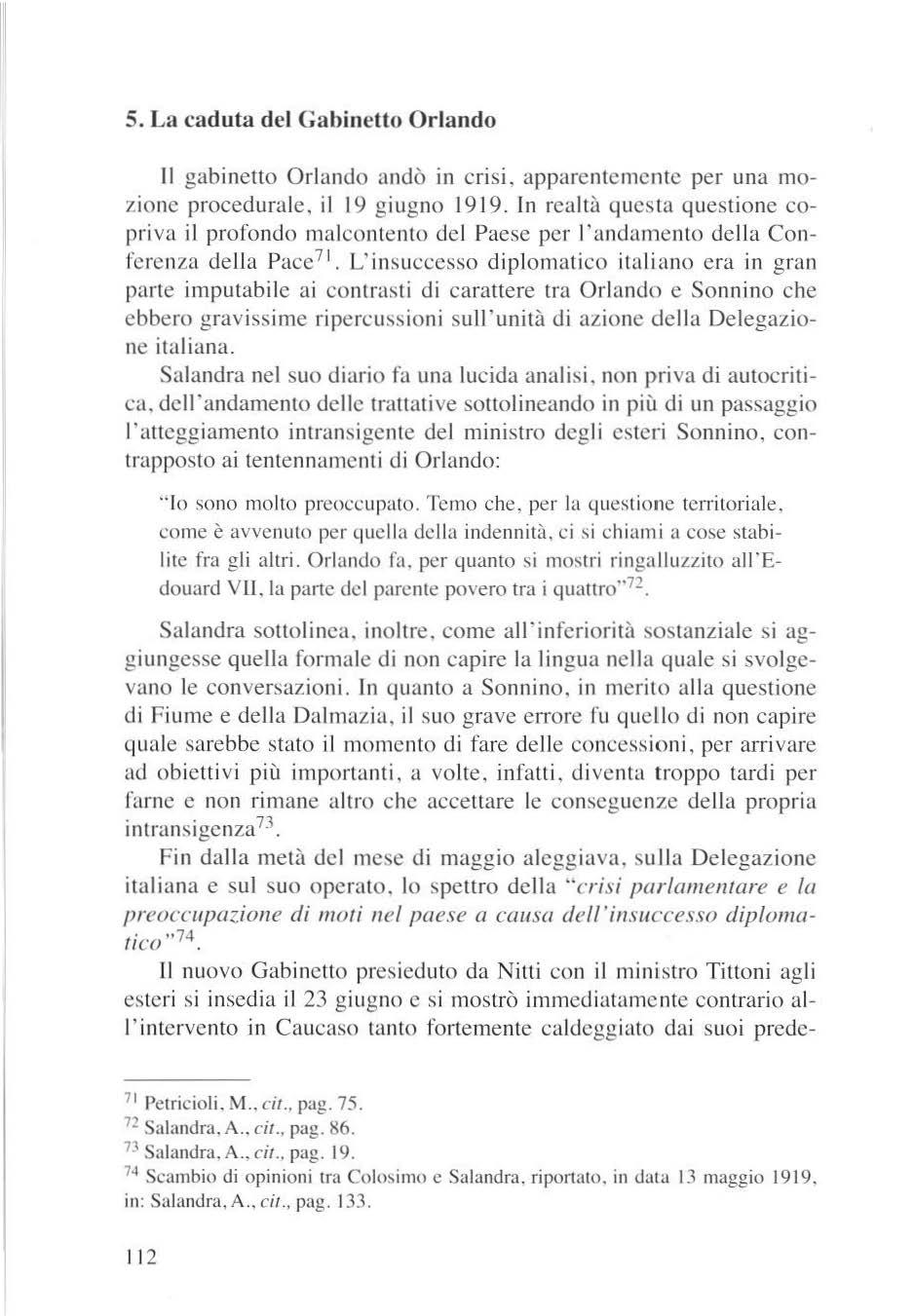
··[o so no molto preoccupato. Temo che, per la questione tenitoriale, come è avvenuto per quella delta indennitù, ci si ch i ami a cose stab ilite fra gli altri. Orlando fa. per quanto si mostri ringalluzL.ito att'Edouard Yl L la parte del parente povero tra i quattro"72 .
Salandra sono l inca, inoltre. come all"infcriorità sos tanLiale si aggiungesse quell a formale di non ca pire la lingua nella quale si svo lgevano le conversazio ni. l n quanto a Sonnino, in merito a lla questione di F ium e e della DalmaLia, il suo g r ave e1rore fu quello di non capire qual e s arebbe stato il momento di fare delle co ncess ioni , per arri vare acl ob ie tti v i più importanti, a vo l te, infatti , div e nta troppo tardi pe r rarnc c non rim ane a ltro che acce ttare le co nseguenze della propria intransigenza73
Fin dalla metà del mc e di maggio aleggiava. ulla De legazio ne italiana e sul suo opera to, lo s pe ttro de ll a ' · crisi parlamentare e la preoccupa:_ione di moti nel paese a causa del/' insuccesso diplomatico" 74 .
Il nuo vo Gabinetto pres ieduto da Ni tti con il mini s tro Titto ni ag li es te ri si in se dia il 23 gi ug no c s i mostrò imm ediatam e nte con tr ario a ll ' inte rve nto in Caucaso tanto forteme n te ca ld eggiato d a i s uoi prede-
71 Petricioli. M .. cit., pag. 75.
72 Salandra. A ci t pag. 86.
73 Salandra. A .. cit pag. 19.
74 Scambio di opi ni oni tra Colosimo e Salandra. riportato. in data 13 maggio 1919, in: Sala ndra ,A ,cit ., pag. 133.
Ili
11 2
ce ori, esso in fatti era in palese contrasto con il secondo. dei quattro punti , del programma di governo d i Nitti.la smobilita7.ione75
Il primo ministro si trovava in quel momento a dover contrastare due oppos t e pul sion i , provenienti da di versi se tt ori de l Paese: da un la to la decisione di pr ocede re nella smobilitazione susci t ava il malco ntento di tutti qu ei militari c h e non avrebbero ritrovato n e lla vita c i vile un rei n scrimento adeguato a l trattamento c h e ricevevano sotto le armi. In fatti, la decisione presa da Orlando a fine marzo di sospe nd ere la smobilitazionc non aveva certo motivazio n i economiche qua nt o carattere di opportunità politica: la so pensione garantiva, argi n ando la disoccupazione, di le n ire il malcontento popolare impedendo lo svilupparsi eli moti eversivi. L 'effetto sulla politica internaz io n a le del mant enimento di un ese rcit o con un efl"ettivo di due mili o ni di uomini avrebbe id ea l mente dovuto esse re quello di eserc itare un a pressione a va nt aggio delle ambizion i espansionis t iche italiane. rJ malcontento delle forze armate, che per la prima volta manifestano co n tro un primo ministro, sfocerà a settembre nell'occupazione di Fiume. Il secondo fronte era rappresentato dal l a minaccia di uno sciopero ge nerale di protesta co nt ro J"intervento in Russia. questo rischio effe tti vame nt e impauriva la classe politica italia n a. Alcu n i storici, che ritengono che la politica interna fosse prioritaria rispetto a quella es t era, hanno conside rato questi clementi determinanti per la decisione d e l primo mini s tr o. Secondo altri, in vece, la politica di Nitti ri s pond eva più semp l icemente ad una es igenza di riconversionc dell'economia di guerra con una economia di pace. c quindi di conci li azio ne tra politica interna c politica este ra con particolare attenzione a ll e scelte economiche 76
No nostante l'opposiLione di tutte quelle forze che avversavano la politica di smob ilit az io n e. ri ntr accia ndo vi parte di quel programma rinun ciatario che aveva portato - secondo alcuni - a ll a va lutazione della vittor ia italiana s ul pian o int e m az ionale , il primo a tt o de l gove rno Nitti fu proprio ]a sospe n s io ne d e ll 'in terve nto in Caucaso 77 e l a tra s forma z ion e della mi ssio ne mi li tare italiana in R eg ia Agenzia Politica con comp iti di esclusiva penetrazionc eco nomi ca.
75 Pctricioli. M cit.. p ag. 75.
76 Pctracchi. G .. La Russia nella Politira lwliana l 917-1925. Bari. 1982, pag. 127.
77 Pctricioli. M .. cit .. pag. 77.
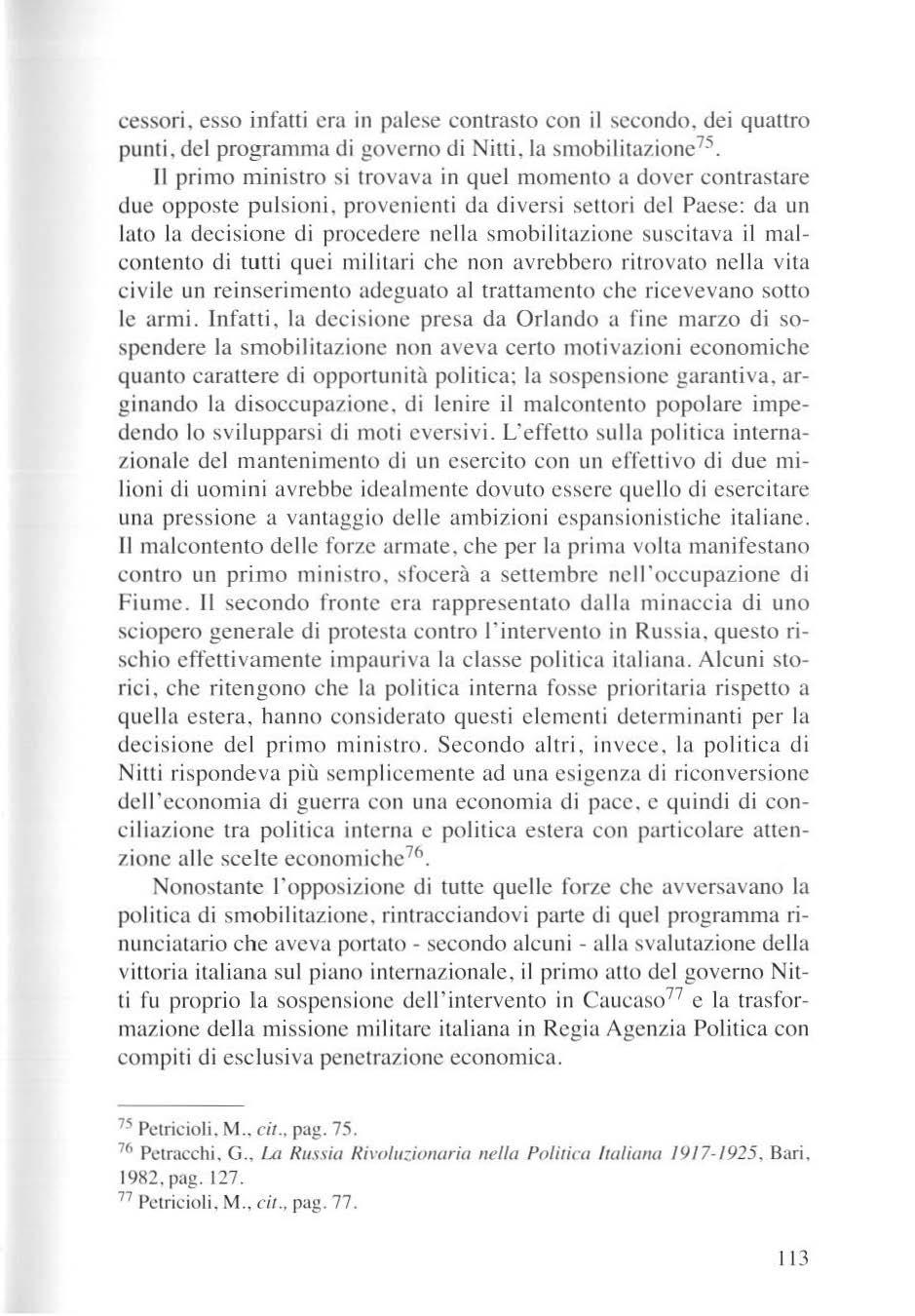
11 3
Il Consiglio di Guerra per discutere della missione militare in Transcaucasia fu convocato il 27 giugno, a ll a presenza anche del colonnello Gabba chiamato a riferire sugli svi luppi della s ituazione e a comunicare le sue conclusioni di esperto militare. Erano prese nti Nitti. Tittoni. il nuovo ministro del tesoro Schanzer, il ministro della guerra Albri cci c della marina Sechi, i capi di Stato Maggiore dell'esercito Diaz c della marina Thaon di Revel. Era stato invitato a riferire assieme a Gabba anche il commendatore Majoni già Regio Agente in Ru ss ia meridionale 78 _
In apertura di riunione l'onorevole Tittoni di sse di voler di eutere i particolari della nostra pen e tra zio ne economica in Transcauca ia. dato che a que s to governo non sembrava più il caso di procedere nell'occupazione militare decisa da quello precedente. Il generale Diaz c l'ammiraglio Rcvcl risposero come se non avessero inteso l'intervento del ministro. continua ndo a di sc utere di particolari sulla prcparar.ione. l'imbarco e il trasporto del Corpo d'Armata per il Caucaso7 \l. l due capi di Stato Maggiore vennero seccamente liquidati dall'intervento s uccessivo di Tittoni che asserì che:
'·Ja discuss ione in propo sito non ha più luogo di essere dal momento che il governo ha abbandonato il progetto della spedizione: vuoi sapere però le idee in merito del colonnello Gabba "Ho .
Il colonnello Gabba. che non era informato de lla deci s ione del nuovo esecutivo, disse di trovarsi in una s ituaL.ione del tutto nuova c inaspettata dato che dal governo precedente aveva avuto l 'ord in e di organia.arc l'occupazion e militare dell'area e, in questo se nso, egli aveva lavorato per predisporre tutto. Gabba comunque riteneva che per l'occupazione sarebbero stati nec essa ri almeno 40.000 uomini. compresi gli addetti ai se r vizi . da impiegare per tutte quelle "speciali incombenze" come ad esempio il servizio di sorveg li anza delle ferrovie che, di fatto, non avrebbero ottenuto altro effetto se non quello di polverizzare la truppa la sc iando ben pochi e ffe ttivi per le guarnigioni.
78 Graziosi. A La Rii'O!tdon e Ru ua del 191 7 in st>i documenti, in Rivi:.ta dj Storia Contcmporao e.n . fase. 6, luglio 1988, pag. 435.
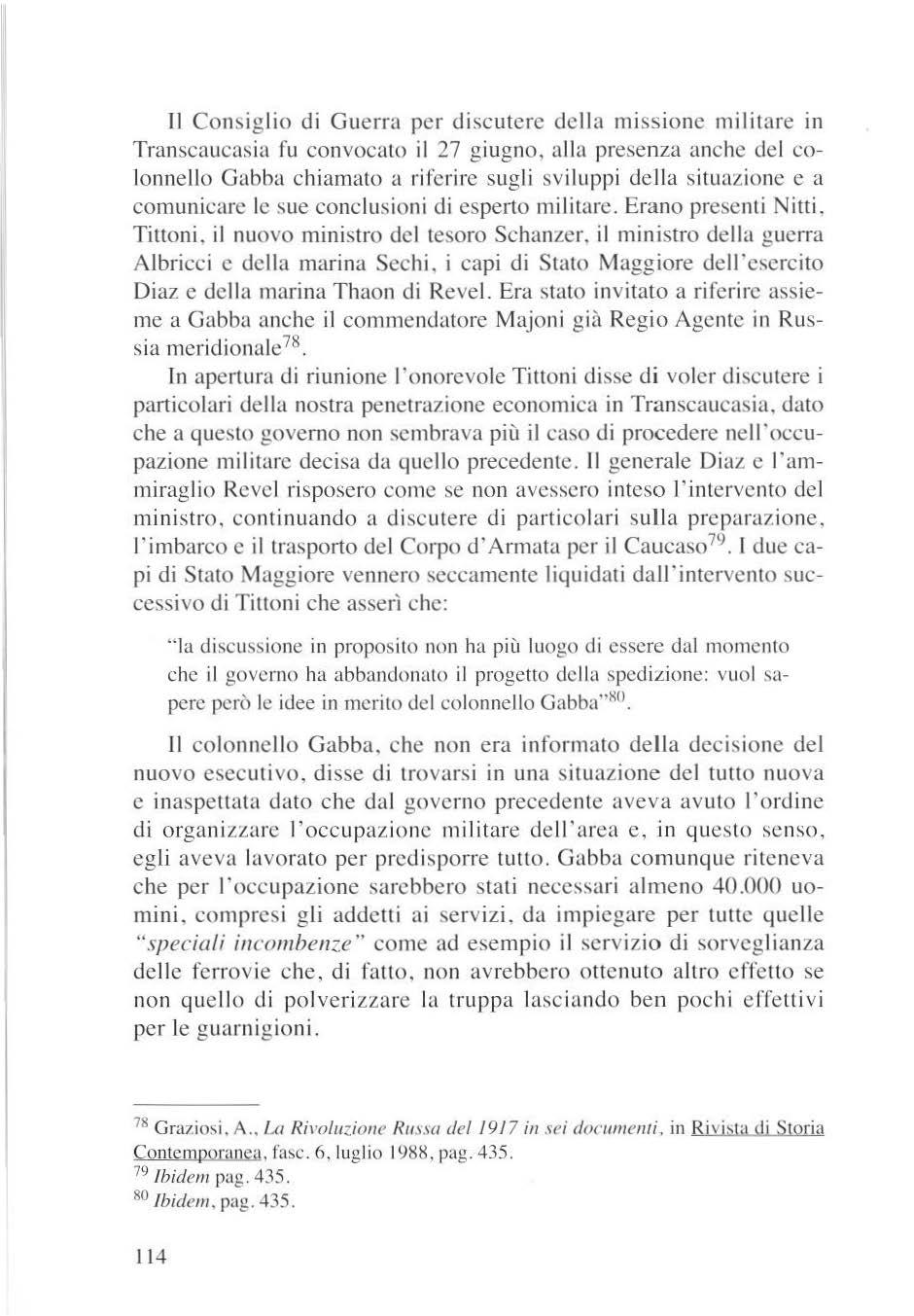
79 Ibidem pa g 435.
80 Ibidem. pa g. 435.
114
Gabba prospetta, inoltre, i rischi di diffusione dell'anarchia o del bolscevismo. conseguenti al prossimo ritiro delle truppe inglesi e sottolinea come Denikin e il suo esercito stessero puntando al Caucaso del sud. Il rischio di dover coinvolgere il nostro esercito negli scontri tra bolschevichi e Armata Bianca o di doversi schierare apertamente a favore dell'indipendenza delle Repubbliche transcaucasiche erano ambedue alternat i ve che il Gabinetto Nitti voleva evitare. Il governo italiano, prima di agire, aspettava en·oneamcnte che la situazione interna della Russia fosse più chiara , senza considerare che , venuto meno il rischio, anche le altre nazioni avrebbero avuto tutto l'interesse a tentare una penetrazione economica e commerciale nell'area.

La riunione sì chiuse con la proposta eli Tittoni eli considerare se fosse possibile dislocare nell'area solo quattro o cinque mila uomini sui vari punti della costa. li colonnello Gabba rispose che ciò sarebbe stato inutile, ma che in ogni caso avrebbe provato a studiare un piano che prevedesse un minore impiego di forze. Nitti e Tittoni alla fine dichiararono che l'occupazione militare. così come era stata progettata , non avrebbe p i ù avuto luogo , a causa delle difficoltà esposte e del grave onere finanziario per lo Stato, mentre invece si doveva procedere allo studio di un progetto capillare eli penetrazione economica, anche tramite l'appoggio logistico della Marina81 •
Lo stesso Nitti , due anni dopo, spiegò così la sua decisione di sospendere la missione in Transcaucasia:
"Quando io assunsi la direzione del governo in giugno era già pronta una spedizione militare in Georgia Era pronto già un numero rilevante di divisioni ed erano pronte perfino le navi per cominciare i trasporti Ciò che mi sorprese è che non solo uomini di governo. ma anche finanzieri in tel li genti ed uomini di idee molto avanzate erano sostenitori convinti di quella spedizione. lo volli invece affrontando molte avversioni. rinunziare sub it o a quella impresa e rinunziare in forma definitiva, !imitandomi a incoraggiare ogni intrapresa commercia le''82 .
Il primo ministro prosegue osservando che l'effetto di questa impresa sarebbe stato certamente catastrofico, ponendo l 'Italia in guerra contro il governo di Mosca. Una "spaventosa avventura militare" con
8 l Ibidem. pag. 436. 8 2 Nitti. F.S L ' Europa sen:::.a Pace. firenze. ! 921, pag. 141. 115
trasporti costosissimi che si sarebbe svolta su un teatro di guerra dalle diffico lt à, con ogni probabilità, insormontabili, anche perché, come avevamo già osservato, la Ru ssia- qualunque fosse stata la sua identità dopo la guerra civile- non avrebbe mai accettato d i rinunciare ad un tcrTitorio considerato da sempre legittimamente suoll 3
H 3 luglio Cavallero lasciò intendere a Thwaites che l'Italia non avrebbe sostituito le truppe inglesi che stavano per iniziare il ritiro dalla Transcaucasia, ma ancora non si trattava di una comunicazione ufficiale che, secondo guanto affermato dalla Petriccioli , non fu trasmessa al governo britannico fino al 30 luglio, quando fu inoltrata tramite la nostra Ambasciata a Londra 84
"Regio Governo p er considerazioni di ordine diverso ha rinunziato in modo definitivo a l progettato invio di truppe nel Caucaso in sostituzione eli quelle britanniche·•85.
Cavallero comunica allo stesso tempo l'intenzione del governo italiano di attivare una serie di importanti scambi commerciali nella regione che, conseguentemente, era intenzione del governo di mantenere in Georgia e in Azerbaijan la missione militare , riducendola e modificandola opportunamente, per completare gli studi in corso e prendere più tardi provvedimenti più adatti e definitivi per esplicare una azione di carattere puramente economico.
La Petricioli ipotizza che il ritardo nel! ' invio della comunicazione ufficiale fosse voluto, e che il governo avesse voluto attendere la firma degli accordi Tittoni/Venizelos, sig l ati il 29 di luglio, per risolvere le questioni ancora in sospeso tra l'Italia c la Grecia in Anatolia tramite
83 Nitti, F.S .. cit. , pag. 142. L'anno successivo, in un altro volume Nitti fu ancora pill categorico nei confronti dci s uoi predecessori: ''Uomini di govemo concepirono in Italia due imprese folli: la concessione di Smirne e d una spedizi<Jne m ili tare in Georgia, due avveniment i di morte che portavano l ' Italia in guerra diretta o irreducibile con tutte le forze turche da un lato e con tutte le forze bolsceviche dall'altro. Erano pe r l'Italia la ce11a rovina eco nomica e la sicurezza di imprese militari di incalcolabili diffico ltà, che avrebbero assorbito tutte le risorse del paese, proprio quando l 'ltalia aveva il maggior bisogno di ricostruirle'' in: Nitti, F.S., Ul Decadenza dell'Europa, F irenze. 1922. pag. 179. ln propos ito vedi anche l'interessante volume di Luigi De Matteo: Alla ricerca di mat e rie prime e nuovi mercati nella crisi postbellica. L'Italia e la Transcaucasia 1919 - 1921, Napoli. I stinllo eli Studi Filo sofici, 1990, pag. 49.
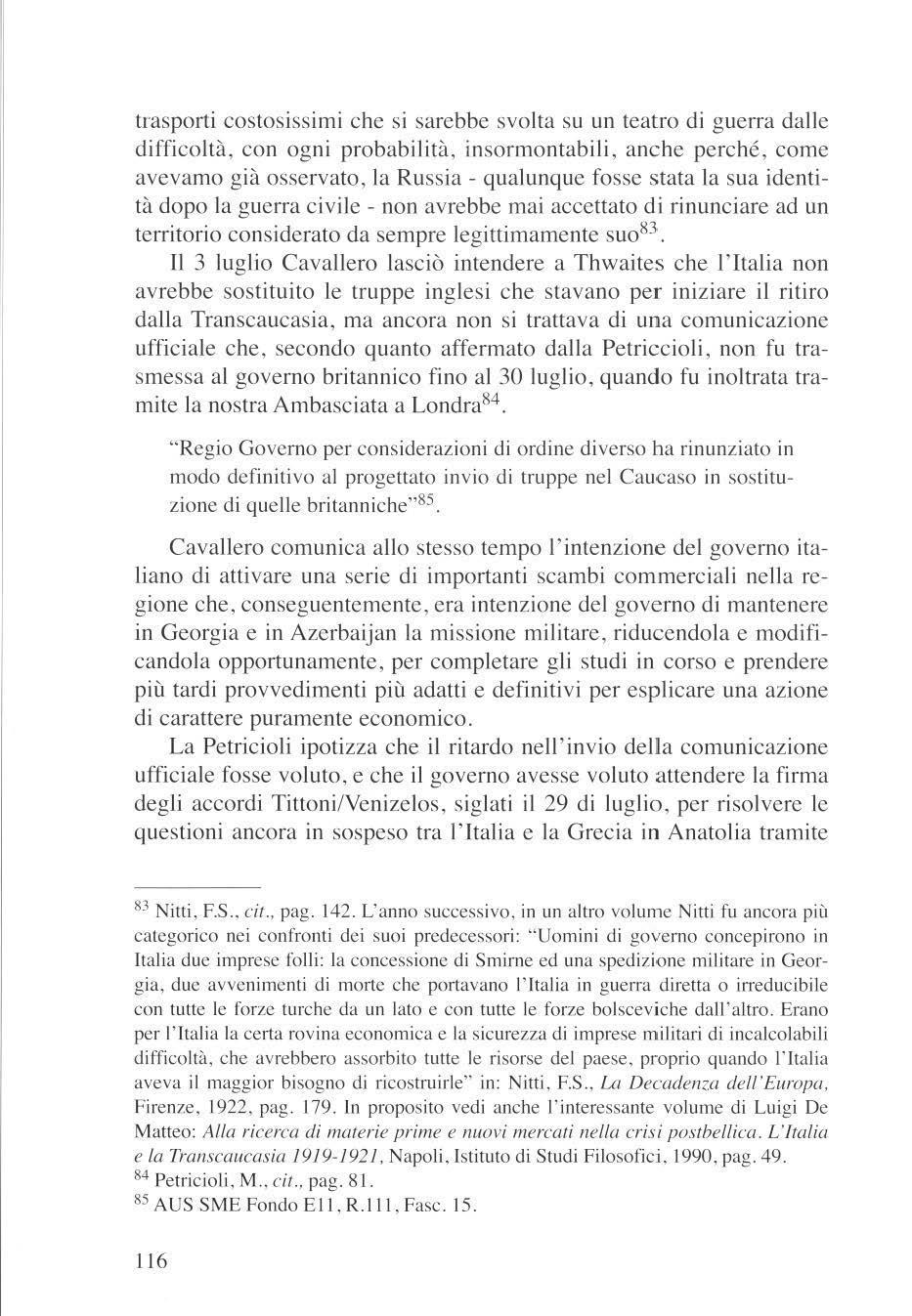
84 Petricioli. M ci t pag. 81.
85 AUS SME Fondo El l, R. l l l, Fase. 15.
116
un accordo diretto tra i due paesi. Si temeva infatti che la rinuncia all 'occ upazione del Caucaso potesse scatenare una reazione negati va della Gran Bretagna visto che ritalia non la avrebbe più sollevata dal fa rd ello dell'occupazione della TranscaucasiaR 6 .
La teoria è interessante ma, per qu a nto ri gua rd a i documenti dello SME, susc it a qualche dubbio dato che il telegramma n° 2286 con la comunicazione ufficiale a ll 'Ambasciata italiana a Londra porta la data del 28 luglio e in essa non è contenuto alcun riferimento né alc un a richiesta di ritardare tale comunicazio ne a l governo ingle e. Del 30 lug li o in vece so no 2 copie del medesimo telegramma a firma Tittoni 87 L'in vio della comunicazione ufficiale in data 28 luglio è riconfermata anche da una lettera de l ministro Tittoni de l 29 lu g lio. diretta alla delegaz ione italiana per la pace, nella quale Tittoni comun ica le nuove dispo s iz io ni per L'organizzazione delle no stra penetrazione eco n omica in Transcaucasia, decise assieme a l co lo nn ello Gabba e a ll a fine de ll a lettera scrive:
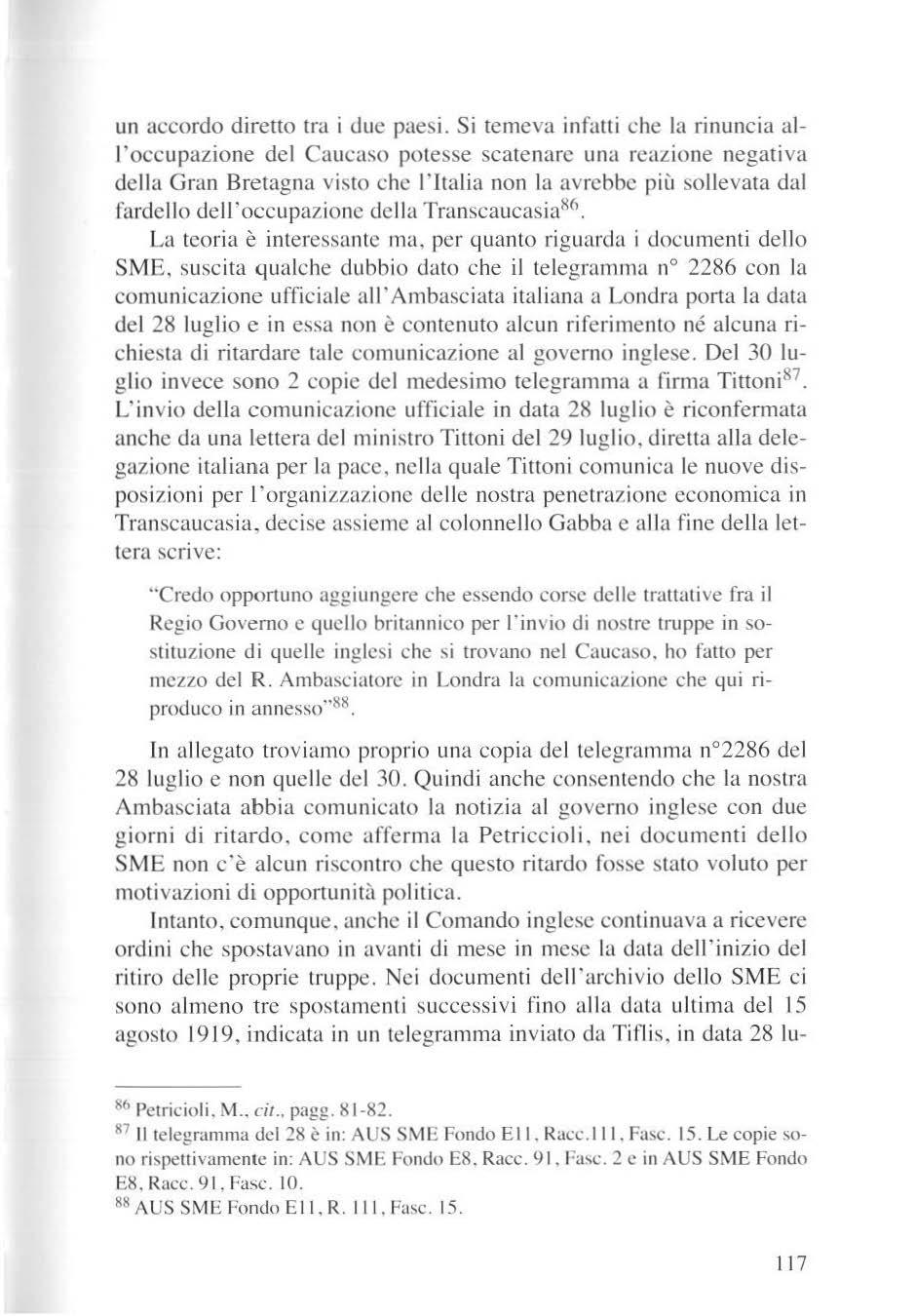
"Credo opportuno aggiungere che esse ndo corse delle trattative fra il Regio Govemo c quello britannico per l'im io di nostre truppe in sostituzione di quelle inglc::.i che si trovano nel Caucaso. ho fatto per mcuo del R. Ambasciatore in Londra la comunicazione che qui riproduco in annesso"8R.
In a ll ega to tro v iamo proprio una copia del telegram ma n°2286 del 28 luglio e non qu e ll e d e l 30. Quindi anche consen tendo c he la n ostra Ambasciata abbia comunicato la notizia a l governo ing lese con due giorni di ritardo, come afferma la Petriccioli. nei documenti dello SME n on c'è alcun r iscontro che questo ritardo s tato voluto per motivazioni di opportunità po li tica.
In tanto, comu n que. anche il Comando inglese continuava a ricevere o rdini che spos ta vano in avanti di mese in mese la data dell'inizio de l ritiro delle proprie trupp e . Nei documenti dell'archivio dello SME c i sono a lm eno tre spostament i s u ccess i vi fino alla data ultim a de l 15 agos to 1919 , indicata in un te legramma inviato da Tiflis, in data 28 lu -
Mll Petricioli. M., cit pagg. 81 - 82.
R? Il telegramma dcl28 è in: AUS SME Fondo El l. Racc.lll. Fase. 15. Le copie sono ri!:.pettivamentc in: AUS S ME Fondo E8. Racc. 91. 2 c in AUS SME F ondo
E8. Racc. 91. Fase. IO.
ss AUS SME Fondo Eli. R. Ili , Fase. 15.
l 17
glio, dal colonnello Mich e li a Gabba pre sso la delega7.ione italiana per la pace a Parigi. Michcli rende noto di aver ricevuto dal comando inglese la comunicazione ufficiale che la partenta de ll e truppe avrebbe avuto inizio il 15 agosto da Krasnovodsk. Il comandante ingle se lamentava l'assoluta mancanza di informazioni in m eri to all'arrivo delle truppe italian e che impediva di avere una chiara vis ione d e i detta g li dell 'evacuazione, soprattutto per quanto riguardava il passa gg io delle consegne alla direzione degli e nti più import a nti come ad esemp io le industrie petrolifere. la banca di stato di Baku.le ferrovie c le cascrme89
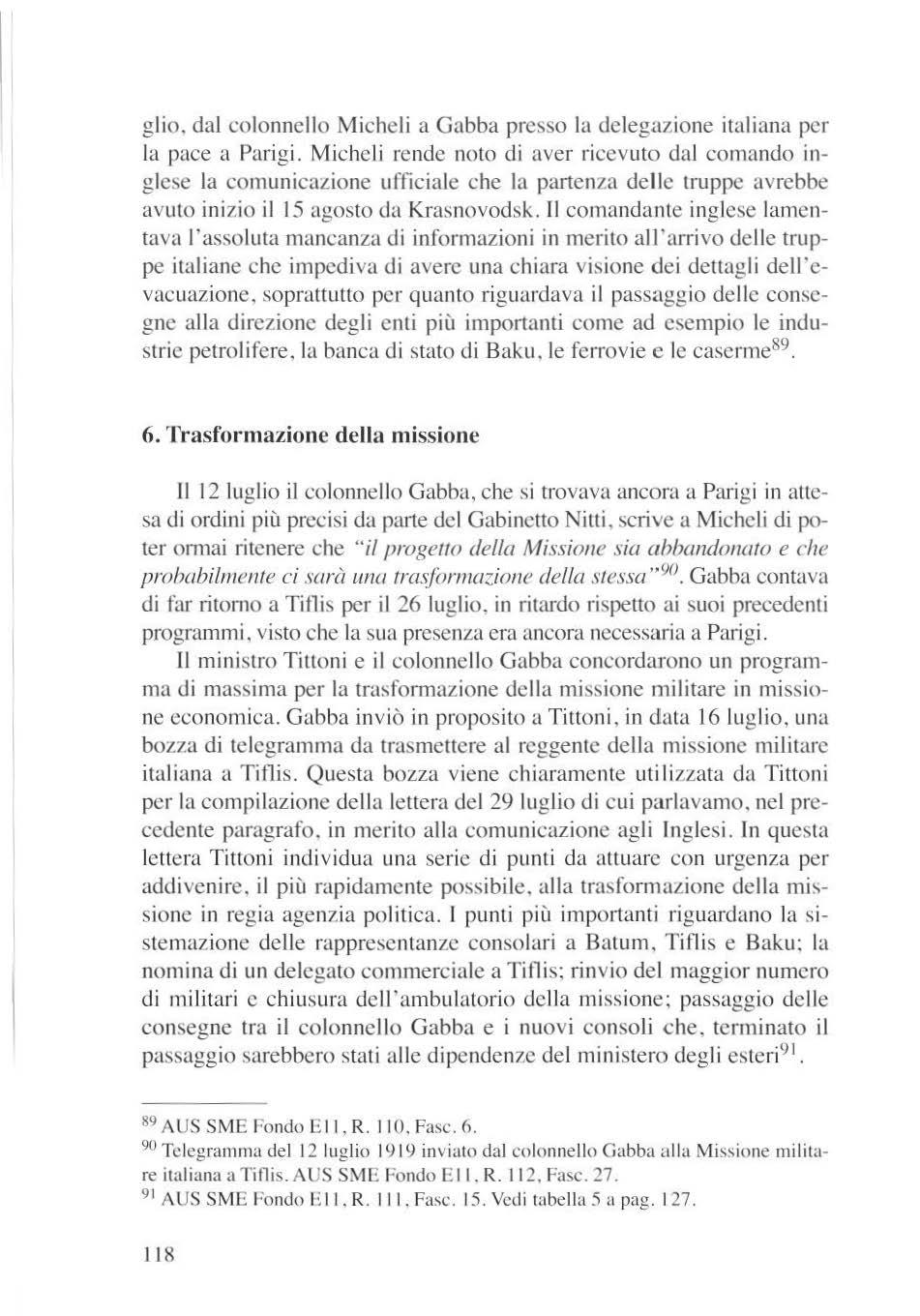
6. Tras formazion e della mi ssione
Il 12 luglio il colonnello Gabba, che si trovava ancora a Pari g i in attesa di ordini più prec isi da p a rte del Gabin etto Nitti, scrive a Mich e !i di poter ormai ritenere che "il progello della Missi one sia abbandonato e che pmhabibnente ci sa rà una trasformazion e della s tessa " 9f1 Gabba contava di far titomo a Titli s per il 26 lu g lio. in ritardo rispetto ai s uoi precedenti prog rammi, visto c he la sua pres e nza era ancora necess aria a Pari gi.
Il mini s tro Ti ttoni e il colonne ll o G a bba concordarono un programma di ma ss ima per la trasforma z ione della mi ssio ne militare in mis s ione econom ica. Gabba inviò in proposito a Tittoni , in dlata 16 luglio, una bo zza di t e legramma da trasmettere al reggente della mi ss ion e militare italiana a Tiflis. Questa bozza viene chiaramente utilizzata da Tittoni per la compilazione della le ttera del 29 lu g lio di c ui parlavam o . nel precedente paragrafo, in me rito all a comunicazione agli Ingle s i. (n que s ta lett e ra Titto ni individua una ser ie di punti da attuare co n urgenza p e r addivenire. il più rapidamente po ss ibile , alla tras form aL ione della missione in reg ia agenzia politica. l punti più importanti riguardano la s istemaz ion e delle rappresentanze consolari a Batum, Tiflis e Baku: la nomina di un delegato commerciale a Tifli s; rinvio del maggior numero di militari c c hiu s ura dell'ambulatorio della missione; passag g io delle con egne tra il colonnello Gabba e i nuo v i consoli che. terminat o il passaggio sa rebbero stati alle dipendenze del mini s tero degli es ter i9 1
89 AUS SM E Fondo E li , R. IlO. Fase. 6.
90 Te leg ramma del 12 luglio 1919 in v iato dal co lo nnello Gabba alla Mi ssione militare italiana a Tinis. A l.' S SME Eli. R. 112, Fase. 27.
9 1 AUS SM E Fondo Eli, R . Ili. Fase. 15 . Vedi tabella 5 a pag. 127 .
l l
118
Come preannunciato. l'organico della missione venne progressivamente alleggerito a partire dalla metà del mese di agosto; è del 12. infatti. una letlera del colonnello Gabba per il Ministero degli Esteri che comunica il suo an-ivo a Batum e prcannuncia il rimpatrio di alcu ni degli ufficiali, con le ri spe ttiv e date di arrivo nel porto di Taranto92 Gabba in una s uccessiva lettera, del 20 agosto, sollecitava l'invio di due adde tti comme rciali civili, al loro amvo sarebbe seguito il congedo di altri 3 urficiali. Il colonnello Gabba inviò. come richiesto dal Ministero uno specchietto, che riporto nella tabella 6. con l'indicaLionc dci restanti membri della missione e de11e date di congedo previste93 Per alcuni il colonnello chiese comunque la sostituzione dato che. dopo la partenLa degli In glesi, sì dichiara convinto che il lavoro militare non sarebbe diminuito di molto. La previsione di Gabba sì rivelò asso lutamente co1Tctta, la situazione delle tre repubbliche, dopo la partenza degli In glesi c l'abbandono del progetto eli occupaz ione italiana, precipitò rapidamente. Anche il governo georgi<U10 che non aveva mai visto di buon occhio le forLe di occupazione alleate, rendendosi conto di trovarsi improvvisamente sen:ta protezione fu costretto a cercarne altrove. È in questa occasione che il mandato sulla Transcaucasia venne offerto al presidente americano Wilson. che pur indine ad accettarlo per motivi umanitari, non ricevette il neccssm·io via libera dal Congresso.
y urgently advisc an<.l rcqucst that the Congress grant thc Executive power to accept for th c Unitcd States a mandate ovcr Armenia."
"On JS 1 June, 1920, thc Scnatc, by a vote of fifty-two to twentythrcc. rcjccted the President's rcqucst" 9-+.
Gli Alleati, di fronte all'inaspettata sco nfitt a de ll'A rmata Volontaria del generale Denikin. tentarono la carta del ri conoscimento de facto delle tre Repubbliche. per tentare di arginare il dilagare del bolsce-
92 Co l piroscafo Ferenz J oseph in probabile arrivo oggi a Taranlo sono rimpatriati i ufficiali della tenente colo nn e llo Novarese Cav. Vittorio - perito minerario; <.:apitano Merendi - perito forestale: tenente Macera - perito comme rcial e. C'ol piros<.:afo Ferenz Ferdinand oggi in partenza da Batum cd in probabile arrivo a Taranto il 20 c.m. rimpatriano i ufficiali della regia mi!>sione: S.A.R. A imone di Savoia - tenente di capitano di fregata Granafei cav. Astan; tenente colonnello del genio navale ca'. Luigi. in: AUS SME Fondo El l. R. l l l. Fase. 5.
•n Elenco del personale della alla data del 15 ottobre 1919 in AUS SME Fondo Eli, R. IlO. Fase. Il. Vedi tabella 6 pag. 128-129. 94 Kazcmzadeh. F. cii pag. 262.
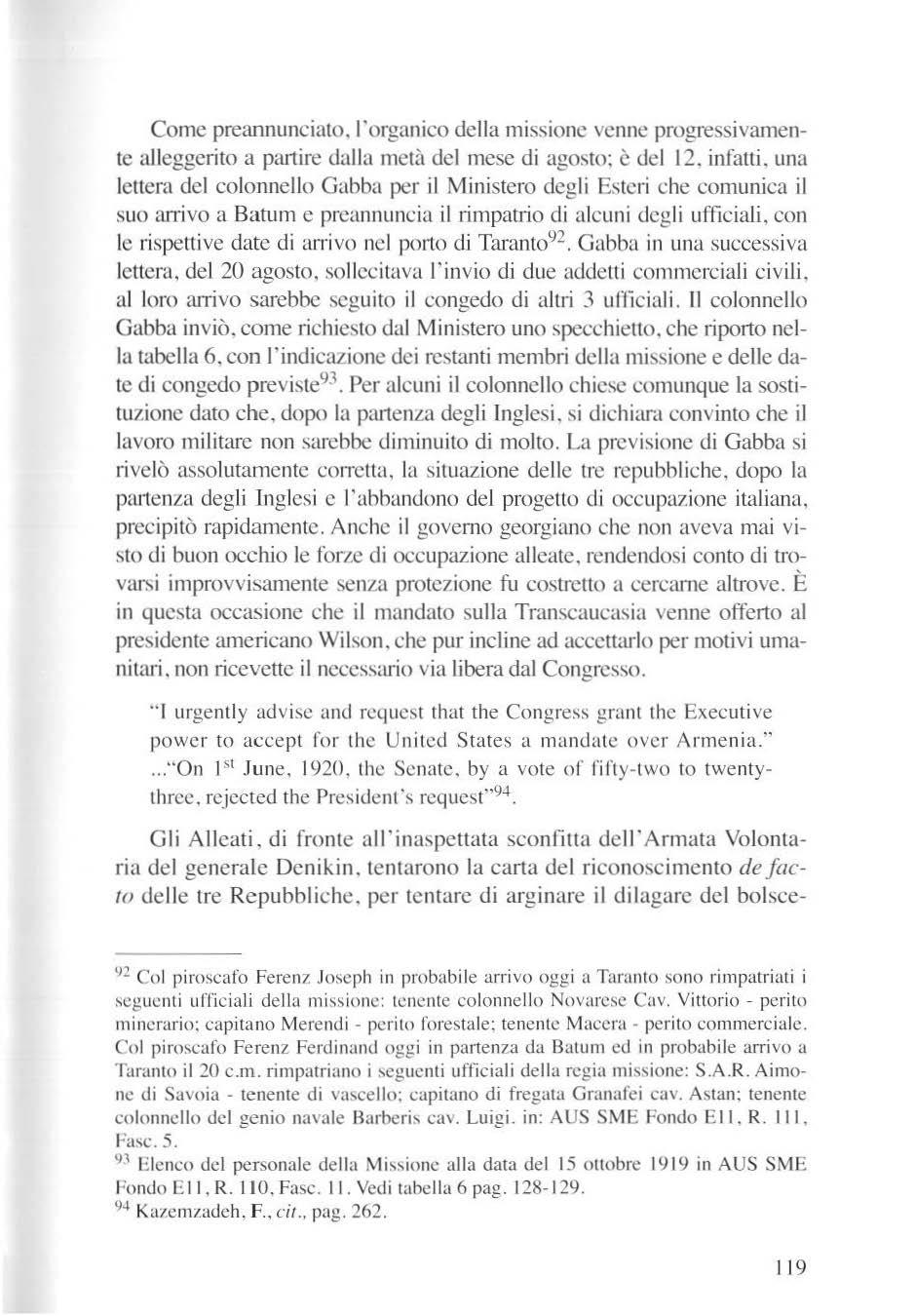
l 19
vismo. Anche Gabba e P irelli, impegnato a realizza re il progetto di penetrazione economica nell'arca, sollecitarono Sforza a fare pressio ni per il rico n oscimento9 5 .
.. Il IO gen n aio, il Consiglio s upremo dette infatti i l suo riconoscime nto de facto alla Georgia e a ll'Az erba ij an. L'Armenia fu in vece riconosc iuta soltanto nella riunione del J 9 gennaio" 96
Comunque. a pmte ques to riconoscimento formal e delle tre Repubbliche c una serie di rimostrarue diplomatiche contro i bot cevichi, g li Alleati non presero alcuna iniziati va concreta per difendere l'indipendenza di Armenia. Georgia e Azerbaijan. non un solo soldato fu inviato in loro difesa97 .
In questo clima di crescente incertezza e allarme s i compie il passagg io delle consegne tra la missione militare italiana e la neonata regia agenzia politica. Il 4 febbraio del 1920 una lettera del ministro deg li esteri Scialoja, succeduto a Tittoni dopo le sue dimissioni del 30 novembre 191998 , ra gg iunse il colonnello Gabba a Tiflis:
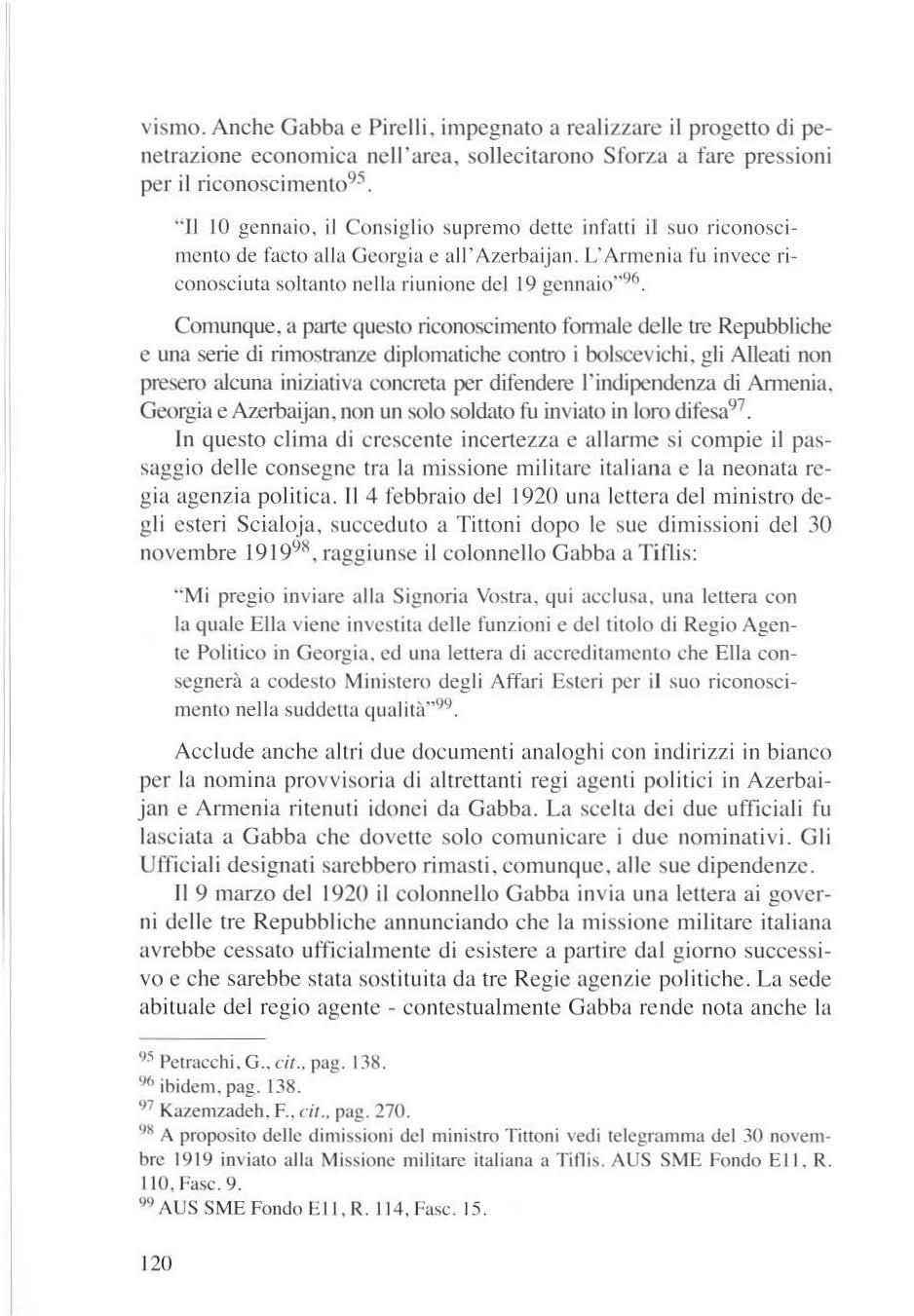
.. Mi pregio inviare alla Signoria Vostra. qui acclusa. una lettera con la quale Ella v iene investita delle funzioni e del titolo di Regio Agente Politico in Georgia. cd una lettera di accreditamento che Ella conseg nerà a codesto Ministero degli Affari Esteri per il suo riconoscimento nella suddetta qualità" 99.
Acclude a n c he a llri d ue documenti analoghi con i ndirizzi in bianco per la nomina provvisoria di altrettanti regi agen ti po liti ci in Azerbaijan e Armenia ritenuti idonei da Gabba. La scel ta dci due ufficiali fu lasciata a Gabba che dovette so lo comunicare i due nominativi. Gli Ufficia l i designat i sarebbero rimasti. comu nqu e. alle sue dipendenze.
Il 9 marzo del 1920 il co lonnello Gabba invia una leuera ai governi delle tre R epubbliche annuncia n do che la missione militare italiana avrebbe cessato ufficialmente eli esistere a partire dal giorno successivo e che sarebbe stata sos tituita da tre R egie agenz ie politiche. La seue ab ituale del re gio agente - co nte stualmente Gabba re nd e nota anche la
95Petracchi.G .. cit.,pag.l38.
96 ibidem. pag. 138.
97 Kazemzadeh. F cit., pag. 270.
911 A proposito delle dimis s ioni del ministro Tittoni vedi telegramma del 30 novembre 1919 inviato alla Mil>sione militare italiana a Titlis. AUS SME Fondo El l. R. IlO, Fase. 9.
99 AUSS M EFondoEIJ.R.II4,Fasc. l 5.
120
sua nomi na - sarebbe stata Tiflis, con due rappre sen tanti a Erivan c B aku IOO. I1 personale della Regia agenzia politica al momento della sua costituzione è indicato nella tabella 7 101
L a missione civile del senatore Conti, che aveva il compito di dare un parere sui progetti italiani di penetrazionc economica, che prevedevano - se si fossero realizzate le previs io ni più rosee - la creazione di un Ente italo-caucasico, s i giovò dei contatti po liti ci, commerciali ed industriali st abiliti da Gabba durante la missione milita re italiana e mantenuti tramite la regia agenzia politica. I1 precip itare della situazione politica de li' area, fece abbandonare anche al se natore Conti q u alsiasi idea di poter attuare la pcnetraz ione economica inizialmente prevista. A l momento di lasciare l a Transcaucasia. Conti lasciò avviati mol teplici affari - si era occupato in particolar modo del problema della nafta - eppure nella riunione genera le, te nuta a Milano il 19 aprile, presenti anche i rapprese ntanti del Banco di Roma c del Credito It a li ano , Conti consigliò di ridimensionare l'impresa 102 P ochi giorni dopo l a conclusione della riunione la situazione politica precipitò in Azerbaijan. I bol scev ichi avevano ripre so la loro penetrazione nel Caucaso, che nel giro di un mese portò alla sovietizzaz ione di tutto il paese.
" .l'evolversi de ll a situazio ne politica e quindi la proclamazione d e lla Repu bblica Socialis ta Sov ietica in Azerbaigian, sanciro no il definitivo abbandono del diseg no di gra nd e pen e trazione economica in Transcaucas ia" 103 .
Il 19 giugno 1920, una lettera del colo nn ello Gabba sa nci sce l a fine anche della s ua personale avventura in Transcaucas ia , Gabba lasciava la direzione della Regia agenzia politica italiana con effetto immed iato c, in un lasso di tempo che sa rebbe stato determinato dal s uo successo re, avrebbe dovuto rimpatria re a nch e tutto il personale militare ancora addetto ali ' Agenzia 104 .
IOO La rappresentanza italiana rimane qu in di uni ca. anche se ci so no tre sedi dist in te. Gabba si o pporrà sempre all a propo sta di rendere indipendenti le tre rappresentanze. In propos ito vedi un telegramma di Gabba a l ministro degli esteri Scialoj a in data 14 apri le 1920.AUSSMEFondoEll .R.Il4,Fasc.l5.
IO I AUS SME Pondo Eli, R. IlO, Fase. I l. Ved i tabe ll a 7 a pag. 130.
102 Petracchi. G., ci1., pag. 142.
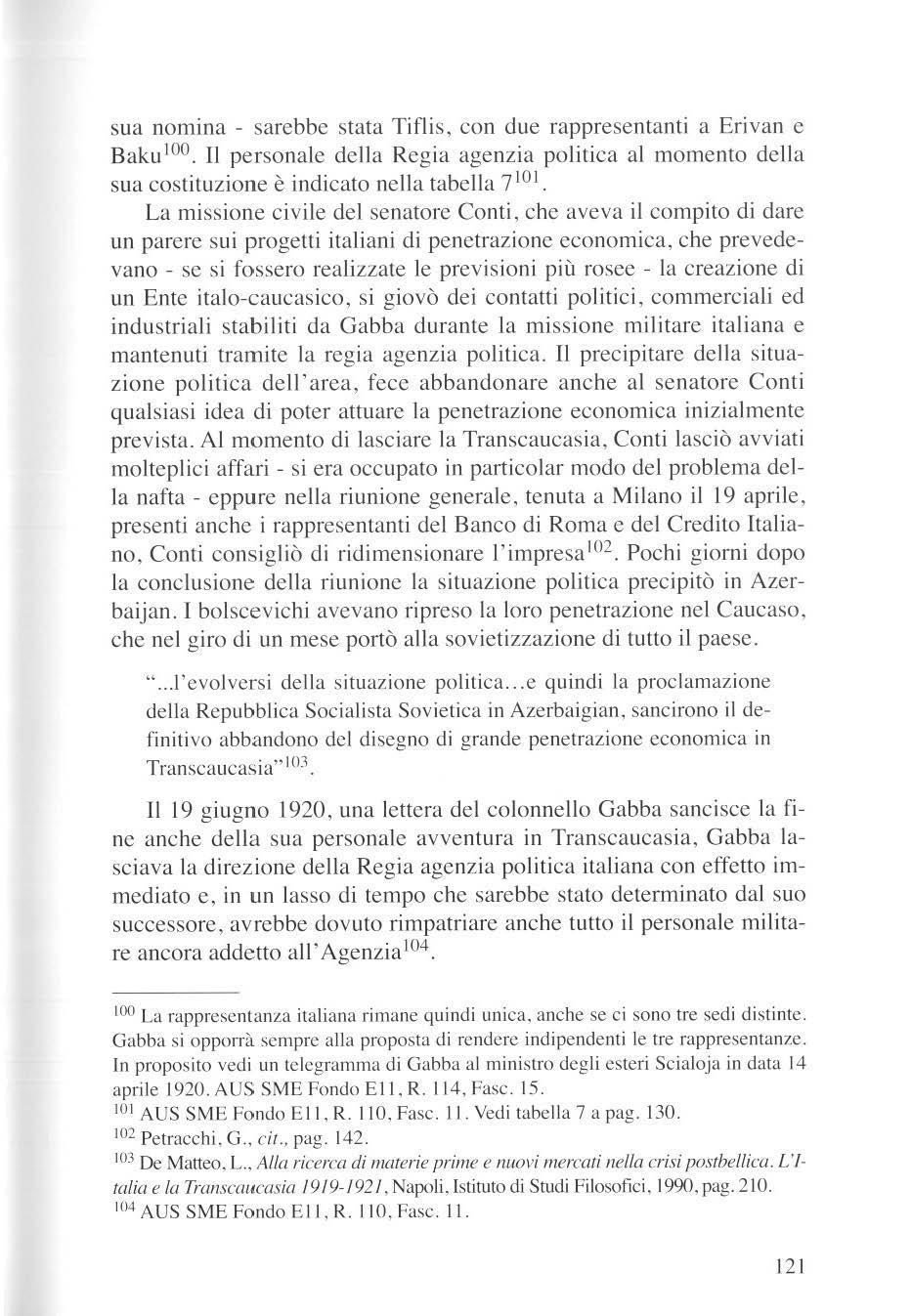
IO.> De Ma neo. L., Afla ricerca di materie prime e nuovi mereali nella crisi postbellica. L'Italia e la Tramcauca s ia /919-1921. Napoli. Istituto di Studi Filoso fici. 1990. pag 210.
104 AUS SME Fondo E li . R. IlO , Fase . I l.
121
Ta be lla l - Situa zion e truppe in g les i al 23/ 4/ 1919
BATUM 80° Br igata Comando
l o Battaglione de11'80° Fanteria Comando
2° Battaglione dell"82 ° Brigata ( l/ 67 ° Punjabis:
24 Punjabi s)
l/l 0 ° Battaglione Jats
23 ° Battaglione Zappatori Sikh
T I FLIS
8 l o Brigata Comando
2 ° Battaglione dell'8 l 0 Brigata
l 3/ 4 Battaglione 82 ° Brigata
l Battaglione de11'80 ° Brigata
KARS l Battaglione dell'80 ° Brigata (2/6 Gurkhas)
ERl VAN 82 ° Brigata Comando
AKHALKALAKI Distaccamento delr82 ° Brigata
AKALTlSIII ' Distaccamento dcll"82 ° Bri gata

BAKU
39° Brigata (meno l Battaglione)
4 SeL. Artiglieria da campagna
13atter ia Au t o -campa le
PETROVSK dell'!:l0 ° Brigata
l Squadriglia A\'iatori
FIUME BZIB Distaccamento
GARGZI l Compagnia 26 ° Regg imento Middlcscx
SAMSUN Distaccamento del 95 ° Fanteria
KRASNOVODSK l SeL. Artiglieria campagna ( in positione fissa)
l Se7. Mitragliatri ci
3 Comp. del 1/ 9 Roya l Warwicks
l Battagl ione dell'S I 0 Brig. (2 / 4 Gurk.has)
P ET ROVSK JEWLAK l Battagl ione dcll'80 ° Brig. (84°
S H OSIIA
FERROV IA TIFLTS / l Battaglione delr81 ° Brig.
MIKAILLEVO / BATUM
TIFLJS/DAVALLU / 1 / 2 Battaglione Rajputs
NAK l CEVAN
A US SM E Fo11do E Il R. l Il
5 122
Fc11c.
Ta b ell a 2- Pro ge tt o di sgomb e ro d e ll e trupp e In gles i da l Tr an scau caso
l ) Il seguente progetto per il ritiro completo indica i movimenti ncll"ordine in cui verranno compiuti:
l bri gnta e 2 brigate arti g li er ia tla campag na ora a Batum e un brigata ora a Tifli s sgomb reran no con g li s tessi che portano i primi tlistm;camenti eli truppe italiane; il l o di:-.taccamento di truppe itulianc partirà in fetTovia per Baku c tale movimento continuerà fino a completa dcii" area di BaJ..u: poi tlmrà cominciare la '>O'>titu7ione di Krasnovodsk e di Pctrow:-.k. F inchc non ultimate queste ultime sostituzioni la guarnigione di Baku soffrirà una diminu7ione di forza. La del distaccamento Di Shusha dovrà a\ venire prima che sia ultimata la totale sost ituLi o n..: dell'arca di Baku
Poi procederì:t alla sostituzione nell'area di Tinis (compresi d istacca me nti di Kars, Erevan, Nahk itche va n c Ak ha lkalaki Infin e ve tT anno sos t ituit e le trupp e a Batum e Ga g ri
2) Poiché non è prudente impoveri re seriamente la guarnigione di Baku ptima dell'an ivo delle truppe italiane. bi5ognerà regolare con la ma'>sima accura teLLa gli spostarnenti. seguono le da adottare:
a) devono passare almeno IO gg. Fra J"arri\·o dei primi distaccamenti italiani a Baturn e l'arrivo a Batum delle truppe inglesi da Baku . Per ottenere il minor ritardo possibile le truppe it. dovranno sbarcare a Batum per un periodo di lO gg. prima che le truppe ing. Pr ovenienti da Baku sia no pronte a Bmurn per imbarcarsi. (scag lioni di 1100 uomini );
b) sc hema del movim e nto elci piroscafi per scag li oni di 1100 uo min i eli truppa per tra s po r1o . 3300 uomini, o ltre a quelli provenienti da Baku , devono trovarsi pronti per l'imbarco a Batum prima di iniziare l'i mbarco di q ue lli di BaJ..u:
c) i :non uomini dovrebbero così l htg. indiano da Rat um : 2 bgt a11. camp. Da Batum;l btg. indiani da T itlis:
d) le predisposizioni \Opra compo11ano che un piro..,cafo rimanga a Batum
4 gg. prima che le truppe che ritornano possano essere imbarcate. ques to non puè> evitato a meno di non ritirare le truppe da Titlis scnLa !>Ostituzione .
3) Se le truppe italiane anivnno in num ero maggiore o co n inte r va lli p iLr bre v i di qu e lli so pra acce nnati , sarà necessa rio clilationare i pirosca fi a Batum prima che po ssa no tornare. Dopo che la dell'area d i I3aku sarà co mpletata si potrfr procedere a quella di Tifli !-. attendere la sost itu:rion c ed ev itare inutil i attese dei piroscafi a Ba tum .
4) si deve accettare come principio che si possa presentare una della segue nti situationi a cambiare il piano del pun to ::!: ritardare la pa11cnLa dei traspo11i da Batum: :,pedire traspo11i da Batum solo parzialmente pieni: spedire traspol1i da Balllm :,olo parzialmente pieni di materiali o provviste. Siccome arriveran no più truppe it. rispetto a ll e truppì.! ing. che a ndranno via in alc uni periodi i tra s pol1i re -

123
canti le truppe it. dovranno tornare vuoti. I punti b) c c) non sono importanti purc hè le tr uppe ing. abbiano sgombrato a ll 'arrivo de ll e truppe it .
5) Dopo una accurata ricognizione di Batum si è vi'>to che la città è in grado di ospitare contemporaneamente 300 ing e 3000 il. purchè i prig i onieri di g uerra siano trasferiti c sgo mberati l brigata e 2 brigate artiglieria da campagna. Rimane spaLi o anche per una sistema7ione s traordinaria in di ritardo nei trasporti. I no l tre si sta provvedendo alla costruzione di un maganino derrate per gli il. li no a c he no n pr e nderanno possesso del no:-.tro.
6) I punti sono importanti per decidere le disposizioni da darsi circa l'esecuzione del cambio:
a) se gli it. rileveranno anche quadrupedi. bardature c carreggio. maga7zini e laboratori:
b) accettazione da parte degl i it. che il movimento ferroviario debba regolare le o perazion i di cambio:
c) da to chL: ci sono so lo 2 t ren i al giorno da Bat u m g li it. devo n o accettare che per farl i viaggiare a pieno carico debbano separare a volte delle unità organiche:
d) di illuminare i m o li c i pontili di sbarco per continuare le operazioni anche di notte (fa lla richiesta di 3000 fari):
c) quale '\ia la disponibilità di munitioni di Baku e quale quantità di munitioni. derrate e generi di magazzino s i debba mandare in Pe rsia;
f) la de legazione tras porti ha bisog no di 3 set t im a ne per prepar a re il piano che po i deve essere approvato dai governi locali della cui collaborazio ne abbiamo bisog no:
g) fornire a Batum notizie circa la quantit ìt di truppe e materiali it. in arrivo con ogni trasporto.
7) sono in corso gli studi per le sanitarie per il cambio ma certamente ci sarà b isogno di navi-ospedale per permettere lo sgombero degli di Barum da lasciarL: ag li italiani.
8) si r ichiede una pr o nta dec isio ne circa la cessione ag l i ita li a n i del contro ll o de l rifornimento c dello sgombero del materiale russo per il generale DeniJ...in.
AUS SME Fondo El l , R. l 12 , Fas e. 19

124
Tabella 3- Compos izione d ella mis sio ne a l 27 aprile 1919
te nen te di vascel lo S.A.R. A im one di Savoia Aosta
colonnello di Swto Gabba Ca'. M clchiadc Capo Missione Maggiore
te ne nt e co lo nndl o Michcli Cav. Carlo Capo di S.M. di Stato Magg io re
maggiore di fan teria Coardi d i Carpeneto ServiLio di S.M. Cav. Carlo
maggiore di fanteria Gabutti Ca>v. Walter Uff. a disposizione
capitano di fanteria Fra cchia S ig. Valentino Uff. a disposizione
capita no eli fanteria Adan i Sig. Giulio Uff. a disposizione
capitano di fregata Granaf'ci Cav. Astan Delegato Regia Marina
tenente colonne Ilo Barberi-; Cav. Delegato Regia Marina di Genio navale
t e nente di vasce Il o Im.om Cav. E nrico Deleg ato Reg ia Marina
tenente colonne Ilo Comm. Vittorio Delegato Min erario assim il ato
maggiore del genio Del Proposto Cav Cesid io Delegato Jndu striale
maggiore ass im ilato Valcri Cav. Lorenz o Co nso le Genera le ma gg iore di a rt igl ier ia Fa7i Cav. Francesco De lega t o Agricolo

capita no di fan teria Mercndi Sig. Aribeno Delegato F ores1alc
Vita Cav. Giuseppe De le ga t o FinanLiario anun in is trazionc
so ttufficial e artiglieria Marco ne Sig. Melchi De lega to Commercia le capitano medico Cook Don. Edoardo Delegato Sanitario -
tenente medico Pantaleoni Dort. Maflì Addetto Sa n itario
accompagna la Mi ss ione co lonne ll o hritannico milita re itali ana
AUS SME Fondo /lO. Fase. Il
,_
125
Tabella 4- Composizione del Co rpo d'Armata

Corpo d ' Armata Co mandant e
XII Corpo d·Armata generale Pennella
22° Di' generale Chiossi
Brigata Fircn7e
Brigata X
29° A rtiglieria da campagna
l Battaglione Genio
75° Divisione generale Pittalunga
6° Raggruppam e nto Alpin i
Brigata Y
2 raggruppamenti 4 Batterie montagna
l B attaglione Genio
AUS SME Fondo E8. R. 92, Fase .f
126
Ta be lla 5 - Programma p e r la trasformazion e de lla M iss ione in Reg ia age n zia politica
l. Si Me mare rap idamente la R. Rappresemanza Consolare nei tre porti di Batum. Til1b e Baku i più importanti della regione.
2. Nominare un De legato Commerciale a Tiflis. sce lta da fare t:on particolare c ura perché deve essere in grado di iniLiare e poi sviluppare intensi rapporti economici tra Italia e Transcaucasia.
3. Il Col Gabba si reca nuovamente nel Caucaso con i -;eguenti compiti:
a. rinvio del maggior numero di ufficiali con mansioni di indole esclusivamente militari:. dato che la sostitu7ionc delle truppe britanniche non avverrà:
b. rin\'io della delegazione de ll a R. Marina. escluso un ufficia le:
c. chiusura dell'ambulatorio de ll a Mi ssione a Tillis c rinvio de i due ufficiali medici:
d. rinvio, appena ultim ati g li studi in co rso. degli ufficiali esplica nti le funzioni di adde tto minerario. fore sta le comme rciale:

c. rinvio della maggior pan e dei militari aggregati alla m i:-.1>io ne. sostituendo !i con italiani residenti in loco.
4. Il colonnello Gabba resta ancora qualche tempo a Tilli-. a capo della missione. almeno tìno a q u ando il R Con-.olato di Tiflis e i consolati dipendenti non saranno organizzati e potranno funLionare. Si studierà poi ropporlllnità della permanenLa di qualc h e militare per tenere i contatti con g li ingle!>i. !>C l'occupazione britannica continuerà.
5. OccotTe nominare un funzionario a Jckate rin odar il genera le De nikin per le que s ti on i po litiche c economiche e un militare per le questioni strategic he.
6. La per ora continuerà a dipendere dalla Dcl cgaLione Italiana al Con-
della Pace che ne <;oppona le Quando la nuova organiuazione sarà tradotta in pratica il tullo rientrerà la competen7a del Min. degli Esteri.
1\US SME Fondo Eli. R . 111./·asc. 15
t-
f-
1
127
Tabella 6- Composizione della Mis s ione al15 ottobre 1919
Grado Cas ato C at e goria In c arico Data part e nza e Nome Ba tu m
colonnello di G abba C a'v. S.A.P. Capo Mis!.ione Stato Maggiore Melc hi ade
tenente Miche li Cav. S.A.P. Ca po S.M. 3/8/ 19 l 9 colo n nello di Cur io della Mis s io ne Stato Magg iore
tenente Novarese De legato Il 5/9 colo nn ello Com m. minerario congedato in ass imil ato Vittorio Transcaucaso
maggio re De l Proposto M.T. Perito Il 5/ l 0 / 19 l 9 del genio Cav. Ce s idio indu s triale

maggiore Coardi di 3 an ni Lavori 11 26/5/ 1919 fanteria Carpeneto di guerra di carattere a disposi7ionc Cav. Carlo politicomi l ilare co llegamento co mando inglese
maggiore Valeri Cav. Delegato Il 5/ l 0/ 1919 assimilato Lorenzo co nso lare
maggiore Gab utti Cav. S.A.P. Lavor i eli I l 12/ l 0 / l 9 19 di fanteria Wa lter c arattere a tec ni comilitare collega me n to autorità locali
capi tano F racchia Cav. M.T. Lavor i 1124N/ 1919 Va le nti no interprete lin g ua inglese. amminist razion
c
cap itano O ldan i s ig. S.A.P. Lavori var i - Il 3/8/ 19 19 di fa nte ri a G iuli o co ll egamen t o au torità loca li
128
capitano Mercndi Sig. c. Delegato Il 5/9 di fanteria Ariberto forestale congedato in Transcaucaso
tenente Lancia Sig. c. Addetto al cavalleria Ottavi o Capo Mi ss ione - interprete
russodi sci p lina truppa
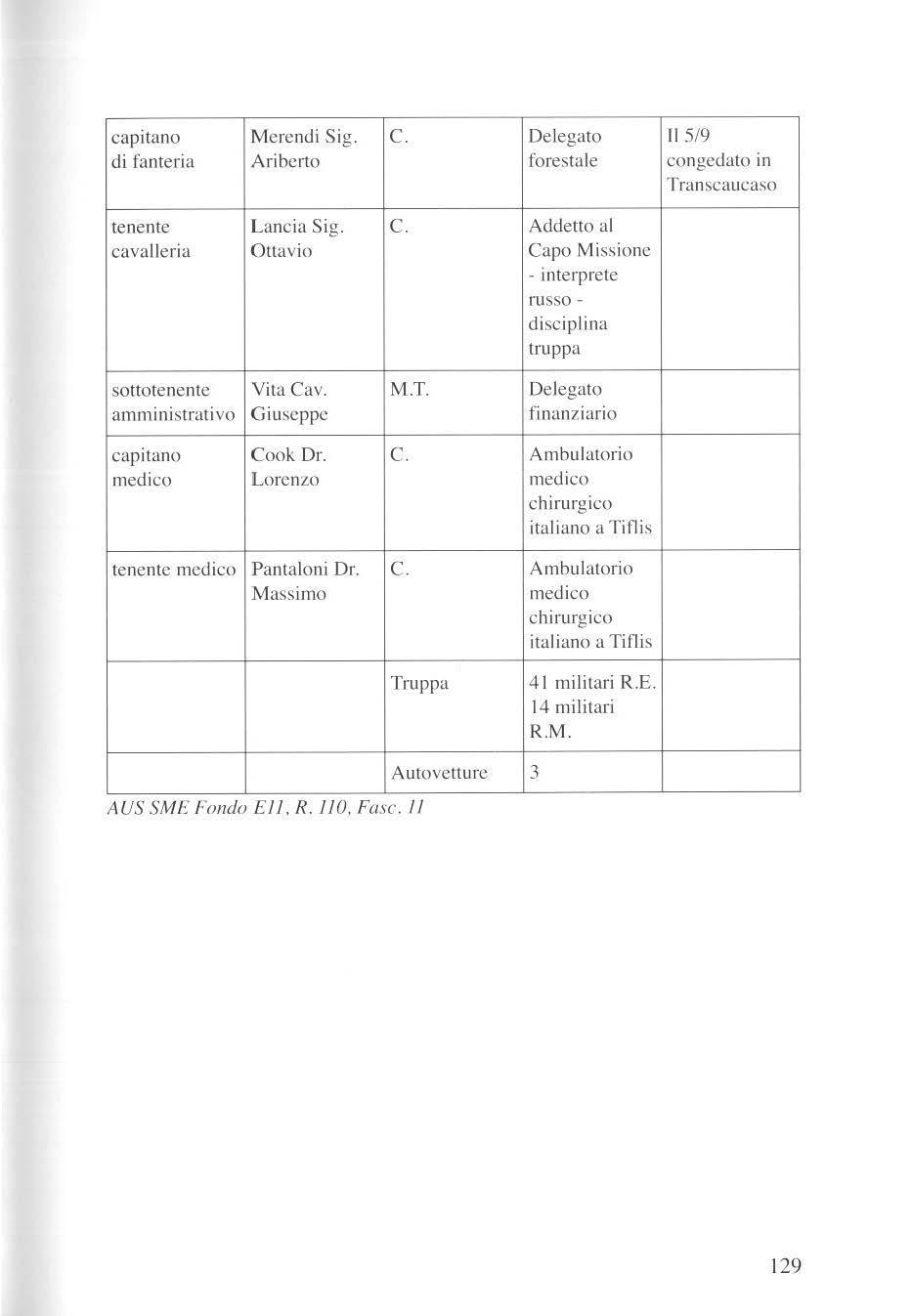
sottotenente Vita Cav. M.T. Delegato amministrativo Giuseppe finanziario
capitano Cook Dr. C. Ambulatorio medico IL.orenzo medico chirurgico
italiano a Tiflis
tenente medico Pantaloni Dr. c. Ambulatorio Ma ss imo medico chirurgico
italiano a Tinis
Truppa
41 militari R .E.
14 militari
R.M.
Autovetture 3
AUS SME Fondo E/l. R.llO. Fase. Il
129
Tabe
ll a
7 - Perso nale della Regia Age n z ia Politica
Grado Casa t o e In cari co Amministrazione da c ui dipende
co lonne llo Ji S.M. Gabba Cav. Agente Politi co Ministero della Me lc hiade Guerra -
tenente colonnello Mi c he li Cav. Carlo Aòdetto a ll' Ager17in Mini stero della di S.\1. Guerra
magg. fanteria Lamagna Cav. Addetto ali" Agen7ia Ministero della Guido Gu e rra
capitano ge nio Palmi cri Cav. Gino Addetto Ministero della seL. Commaciale Guerra
tenente di vasce ll o Cav. Enrico Rapp. de l reg io Ministero Marina agente politico in Azerbaijan

tenente di e<t\ alleria Deg li Albiui Sig. Rapp. del regio Mini<>tero della Nicola age nt e politico Guerra in Annenia
te nente di Lancia Sig. Ottavio Addetto a li·Agenti a Ministero della interpre te Guerra
capi tano medico Cook Dr. Lorenzo Direttore M in istero della Ambulatori o Guerra medico italiano
te nente medi co Pantal o ni Dr. Chirurgo Ministe ro della Massimo delr Ambulat orio Gu e rra
PERSO ALE MILITAR L:
2 sottufficiali Stazione radio di ascolto Mini stero Marina
l maresciallo RR. CC. Corriere postale M in istero G ucrra
] RR. CC . Corr ier i postali Min is tero Gucna
2 atte ndenti Min is tero Guerra
l chauffer Min is tero Guerra
PERSO;-..TALL: CIVILE ED l ' SL:.RYIENT I
l datti lografolarc h ivistalprOtocoll ista
3 seri va ni inte rpre ti
4 uscieri interpre ti
AUS SMt." Fondo F;t l. R. IlO. Fase Il
2 cha uffeurs ci \ ili
3 inferm ieri a ll"ambulat o ri o
l inserviente
·-
130
CAPITOLO IV
Le relazioni tecniche della missione militare italiana
Le notizie in possesso del governo italiano riguardo alla Transcaucasia, prima dell'invio della missione Gabba, erano frammentarie c in molti casi contraddittorie dato che derivavano da due fonti che avevano interessi opposti, la missione militare inglese da una parte e le relazioni che i governi transcaucasici inviavano alla conferenza della pace di Parigi dall'altra. I documenti inglesi erano sicuramente più realistici nell'illustrare la situazione e più puntuali nel sottolineare i molteplici problemi dell'area, essendo stati compilati essenzialmente ad uso della propria missione militare che non poteva giungervi impreparata. Al contrario, le relazioni stilate dai governi transcaucasici tendevano a sottolineare i punti di forza e le immense ricchezze disponibili per tentare di attrarre possibili investitori stranier i e spingere i governi alleati ad impegnarsi nel mantenimento dell'ordine nella zona. Per chiru·ire questa differenza possiamo prendere ad esempio i dati forniti riguardo alle ferrovie ed alle infrastrutture, che erano di notevole importanza strateg ica nel caso d i una eventuale occupazione, sia per il trasporto di truppe e materia) i, sia per i successivi rifomimenti alle stesse. Le due relazioni in oggetto si riferiscono entrambe al gen nai o del 1919, in modo da non poter imputare a lla distanza temporale le sostanziali differenze che vi si riscontrano.
Nella relazione inglese, che esamina lo stato delle ferrovie del Transcaucaso dal momento in cui le tre repubbliche dichiararono la propria indipendenza il 26 maggio 1918 e affermarono il loro possesso s ull e linee ferroviarie c sug li stock.c; compresi nel proprio territorio, viene sottol in eata in primo luogo la mancanza di locomotive e materiale rotabile, che non hanno fa tt o ritorno dopo il ritiro delle truppe russe dalla zona di Rostoff nonch é i l pessimo stato del materiale c ircolante. Le ferrovie lav o ra vano in costante perdita c i governi non avevano fondi da stanzia re per la riparazione delle lin ee. In Azerbaijan nel 1919 era in funzione so lo una delle linee ferroviarie e il transito sui ponti doveva avvenire a ve lo cità ridotta. L e offic in e ferroviarie, non

131
adeguate ad eseguire riparazioni dì grossa entità, erano dislocate quas i interamente nella zona di Tìflìs per cui spesso gli imerventi urgenti su carrozze e locomotive venivano compiuti nelle staz ioni di transito con risultati non soddisfacenti.
Il traffico tra Baku e Batum era limitato da una forte penuria di locomotive a causa della quale moltissimi vagoni giacevano inutilizzati fuori dalle stazioni. Gran pat1e del materiale migliore era stato inviato a Kars per l 'evac uazione delle truppe turche e se ne erano perse le tracce. Per questo motivo il comando inglese decise di inviare un ufficiale a compiere delle indagini e riferire. Secondo il brigadiere generale Brough l ' unica sol uzione per questi problemi sarebbe stata l'istituzione di un Controllo Generale sull'intera rete ferroviaria che sì occupasse del traffico generale e dì fissare le linee per il funzionamento e la distribuzione del materiale rotabile sull'intera rete e delle riparazioni, lasciando ai governi locali so ltanto il controllo del traffico all'interno delle proprie frontiere. L'ufficio principale sarebbe stato istituito a Tifli s c tre distretti con tre comandi separati a Baku , Tif1i s e Batum. Con questo dettagliato resoconto Brough chiede il pennesso di poter propon·e ufficialmente questa soluzione ai governi locali, dai quali aveva già ricevuto un assenso ufficioso 1 • Nel rapporto sulla situazione economica della Georgia presentato dal Bureau georgiano ai governi alleati, la situazione delle ferrovie è dipinta in maniera diametralmente opposta: la principale linea georgiana va da Tiflis a Baku e collega i due principali porti della Georgia , Batum c Poti, cd ha dei rami seco ndari che la collegano con i più importanti centri di produzione e commercio 2 Al momento in cui viene redatto il rapporto in questione la lunghezza totale de Ue ferrovie georgiane era di 325 Km ma la costruzione della linea litoranea del Mar Nero , che avrebbe collegato la Georgia con il Caucaso del nord fino ad Atmavir, e della linea montana che avrebbe collegato Tiflis con Vladicaucaso, attualmente collegate dalla "strada militare georgiana", avrebbe

1 AUSSME FondoEII,R.II2 ,Fasc. I8.
2 La relazione georgiana elenca tutte le linee ferroviarie secondarie compresi i eh i lometri. I rami secondari conducono ai pozzi di petrolio di Tkvibuli - 42 Km da Kutais - ai giacime nti di mangan e se di lchiatouri -SO Km - alle fonti di acque minerali ed a lle foreste di Borjorn e alla s ta zio n e te rmale di Bakouriani - 65 Krn - ai vigneti di Kakhctic, Tclave e Signahn - 180 Km -arrivando a collegare la Georgia con la Persia - 515 Km- e con l'Armenia attraverso Alexandropol e Kars- 141 Km . AUS SME Fo ndo E li , R. I lO, Fase. 2.
132
portato la lunghezza totale della ferrovia georgiana a 2000 Km tutti in buono stato. Affe rmazione, quest'ultima , in palese contrasto con le relazioni coeve de ll a missione mi l itare inglese citate poc'anzi.
La m issione "espl orativa" italiana , che partì da Taranto il 27 aprile alla volta di Costantinopoli, vide la partecipazione di un elevato numero di esperti tecnici che accompagnavano i militari. Gli esperti avevano in questa prima fase , che secondo l e indicazioni del generale Diaz 3 avrebbe dovuto ave re una durata di non p iù d i due mesi, spostamenti compresi, una funzione di analisi della sit u azione industriale, mineraria - con particolare attenzione alla questione delle concessioni g ià esistenti cd a que ll e da ric h iedere ai governi locali - agrico l a c commerciale della regione 4
La missione. composta da 18 membri- tra ufficiali ed esperti tecnici - giunse a Tiflis, sua destinazione finale il 12 maggio 1919 , e gli esperti iniziarono immediatamente la loro attività di analisi e relazione. Spesso, data la fame eli notizie manifestata dalle più alte cariche governative, i rapporti degli esperti venivano inviati anche se ancora parziali pur di soddisfarla, riservandosi s ucces sive modificazioni.

Tab e lla l Esp erti tecnici della mission e a l 27 april e 19195 tenente colo nn e llo assimilato Novarese Comm. Vittorio De legato Min erario
ma gg iore del genio Del Proposto Cav. Cesidio Delegato l ndu st rial e maggiore di artiglieri a Fazi Cav. Francesco Delegato Agricolo
capitano di fanteria
Mereodi Sig. Ariberto Delegato Fore stale
sou ufficiale amministrazione Vita Cav. Giuseppe Delegato Finanziario
sott ufficialc a11 iglicria
Marcone Sig. Melchi De legato Commerciale capitano med ico
Cook Dott. Edoardo Delegato Sanitario
3 Diaz a Gabba, 14 aprile 19 19,/\US SME fondo El l, Rll. fase., 2.
4 Cfr. in mer ito l' ill ustrazione n° VIII a pag . 135 che riporta ne l dettag li o le principali r isorse del Caucaso c le zone di reperimento delle stesse. AUS SME Fondo El l. R. I II .Fasc.7.
5 G li esperti de lla M issione sono e lencati nel dcuaglio in questa tabella tratta da AUS SME Fondo E l i, R. IlO. Fase. I l.
133
La situazione delle infrastrutture e dei trasporti era fondamentale per valutare le possibilità di instaurare traffici commerciali redditizi tra la Transcaucasia e l 'Italia ed infatti tutti i resoconti degli esper1i vi accennavano, in maniera più o meno ampia, in relazione aUe proprie necessità. Lo stesso dicasi anche per la possibilità di controllo del Caspio indispensabile per assicurare i rifornimenti per l e truppe, i traffici con l'Italia ed instaurare linee stabili di navigazione.
l. Infrastrutture e trasporti
La relazione sullo stato delle Ferrovie, datata giugno 1919, è del delegato industriale lng. Del Proposto c comprende anche una dettagliata analisi sullo stato del l a pipeline che confermava ancora una volta lo strettissimo legame tra le risorse naturali dell'area e le infrastrutture che ne consentivano lo sfruttamento.

La rete feJToviaria della Transcaucasia, secondo quanto si evince dallo studio di Del Proposto, si estendeva per una lunghezza di 1642,50 verste (J versta equivale a l 065 metri) con binari singoli a scartamento normale russo, tranne c he per un breve tratto sulla linea Poti-Baku che era a doppio binario. Le linee principali erano sei6 a cui si dovevano sommare altre 84.77 verste a scartamento ridotto e alcuni raccordi industriali e portuali che portavano la lunghezza totale de ll a linea ferrata transcaucasica a circa 2000 verste. Il maggiore però sottolinea che di questa estens ion e solo la metà era "a facile profilo", cioè con pendenze inferiori al 1O per mille, mentre la restante estensione era a carattere pre va lentemente montuoso, con pendenze massime del 28 per mille ne ll e linee a scartamento nonnale e del 45 per mille in quelle a scattamento ridotto. La trazione era a vapore e i combustibi li utilizzati era no la nafta greggia o ppure il mazut, che ve ni vano imma-
<>Le lince princ i pali sono riassunte in questo specchietto:
Ricordiamo che 1 versta equivaleva a 1065 metri (n.d.a.) AUS
Poti - Baku 894.91 verste
- Batum
Kars
- Giulfa Rior - Kutais- Tkvibuli 98.41 verste 278. 38 verste 144.40 vcrstc 178.00 vcrstc 48.40 verstc
Samtredi
Tiflis-
Alexandropo l- Erevan Ulukhan l u
Fondo
28. 134
SME
Eli. R. 112, Fase.
La m app a 1/l OS /ra l e prin c ipali risorse petrol(f'e re . min era rie ed arv ico le de l Ca ucaso e le re lat i ve :ame di reperim ento
La legg('llda rip o rta in vio la l e minie re di m an[l,a nese d i f e rro: in azz urro i g iacim enti d i naji a; in ner.o le miniere di carhon .fiJ ss ile; le aree con col ora-;, io ne verde ind icano le aree bosc hive : in rosso l e mini ere di ram e : in g ia llo le -;.o n e ce rea li co l e e q ue lle in cui s i produ ce mno i hn zzo li di se t a
gazzinati in s erbatoi posti lungo la linea fe rroviaria che avevano la capacità complessiva eli 3 milioni di pudi. Per quanto riguardava le officine per la riparazione delle locomotive e del materiale rotabile, Del Proposto conferma il rapporto britannico, citato all ' inizio del capitolo, che collocava l ' officina principale a Tiflis e con officine secondarie lungo la linea.
Il rapporto italiano conferma sostanzialmente il parere dell'alleato britannico anche per quanto riguarda le condizioni post belliche della rete ferroviaria, gravemente danneggiata dalla mancanza eli manutenzione durante la guerra e nel periodo rivoluzionario e dalle truppe ru sse che , durante la ritirata , guas tarono buona parte del materiale rotabile e ne sottrassero una quantità altrettanto considerevole. li blocco economico cui la z ona era sottoposta aveva impedito alle amministraz ioni fenoviarie eli procurarsi i materiali necessari per le riparazioni , quindi gran parte del materiale rimaneva inutilizzabile. Inoltre , la ripartizione della gestione della rete ferroviaria fra le tre RepubblicheGeorgia, Armenia e Azerbaijan - av e va moltiplicato in modo iperboli -

135
co i costi di gestione 7 tanto che, nonostante le tariffe ferroviarie fossero elevatissime, le fenovie erano in passivo.
L'esperto sottolineava che "la ridotta potenzialità della rete ferroviaria impedisce la ripresa delle esportazioni" e di conseguenza ostacola il risorgimento economico della regione. La ripresa poteva essere stimolata solo attraverso il corretto funzionamento delle ferrovie, per le quali egli propose una serie di soluzioni, la più immediata delle quali era l'invio di nuove locomotive e dei materiali indispensabili per le riparazioni. In seguito sarebbe stata utile la costruzione di un secondo binario, presente come abbiamo visto solo per 270 verste sulla linea Poti-Baku, che era già stato previsto nei progetti Russi che avevano costruito tutti tunnel adatti ad accogliere il secondo binario; provvedere alla elettrificazione della linea - ottenendo l'energia necessaria sfruttando l'energia idroelettrica dei numerosi fiumi del Caucaso- soprattutto nei tratti montuosi che si prestavano a questo tipo di trazione; procedere alla sostituzione del le rotaie esistenti con altre più pesanti; ampliare le stazioni esistenti e le officine per le riparazioni oltre a costruirne di nuove basandosi sull'aumento del traffico. In pratica quella proposta dal maggiore era una vera e propria ricostruzione dell'intera rete fen·oviaria che doveva essere accompagnata dalla costruzione clelIa seconda condotta petrolifera, per il trasporto di nafta e mazut, tra Baku e Batum 8
La condotta petrolifera, che si estendeva per 479.4 verste lungo la ferrovia Batum-Baku, aveva subito durante la guerra e il periodo rivoluzionario danni molto minori rispetto alla fenovia, anche se la portata delle pipeline, che in condizioni normali sarebbe potuta arri vare a trasportare l milione di tonnellate di petrolio l ampante, risulta dimezzata nel periodo che va dal 1907 al 19 11 , preso in esame da Del Proposto con conseguente perdita di utili dovuta, come vedremo tra poco, ad una se ri e di concause. La so lu zione sugger ita dal maggiore per rendere funzionale l'oleodotto della Tr anscaucasia e ripo rt are il prezzo del
7 La gestione separata aveva dato lavoro ad un gran numero di persone che era necessario collocare ma questo. ass ieme a ll a moltiplicazione degli organi direttivi, aveva contribuito ad aumentare il deficit delle ferrovie che si trovavano ad impiegare circa il doppio del personale strettamente necessario per l'eserciz io regolare. AUS SME Fondo E li , R. 112, Fase. 28.
8 Jn proposito vedi la relazione sulle ferrovie del magg. De l Proposto in AUS SME Fondo El l. R. J 12. Fase. 28 e confronta anche la relazione sul problema economico della Transcaucasia in AUS SME Fondo E8. R. 91. Fase. 9.

136
petrolio ai valori prebellici, così da renderlo appetibile su l mercato internazionale, prevedeva che l 'o leodotto esisten te funzionasse a pieno regime e quindi trasportas se l milione di tonnellate annue, portando il prezzo del petrolio a 7,45 lire per tonnellata. Per abbattere ulteriormente i costi, fino a 5 lire per tonnellata egli avanzava l'ipotesi di costruire una seconda condotta. per nafta greggia e mazut, che collegasse le aree di produzione con i porti del Mar Nero per le esportazioni. La seconda condotta avrebbe avuto minori costi di gestione, g razie alla modernità degli impianti e una portata doppia rispetto al vecchio oleodotto9. Del Proposto specificava pure che que ste conclusioni s i riferivano al prezzo, alle condizioni cd al valore effettivo della nostra moneta prima della guen·a come pure alle condizioni prebelliche dell'oleodotto e quindi erano passibili di variazioni. Nel caso in cui questo progetto di ampliamento dell'oleodotto si fos se realizzato, facendo assumere alla linea Baku-Batum-Poti la funzione di arteria commerciale tra Europa, Persia e Asia Centrale, sarebbe stato necessario provvedere anche all'ampliamento ed all'ammodernamento delle stru tture portuali che sarebbero stati assolutamente in suffici enti ad accogliere tal e mole di traffico 10
2. Pe tr oli o e nafta
Sul petrolio e l ' industria petrolifera di Baku vi sono due relazioni una del tenente colonnello Novarese c la seconda del maggiore Del Proposto 11 en t rambe individuano la causa della situazione di ristagno della principale industria della Transcaucasia nella chiusura di ogni sbocco per lo sme rcio della produ z ione giornaliera e dello stock accu-
9 Il vecchio oleodotto era composto da tubi di acciaio eli 200 mm eli diametro con una pre ss ione intema , a regime. eli 45 atmosfere, la nuova condotta avrebbe. secondo i l progetto di Del Proposto , un diametro di 350 mm cd una portata di 2 mi l ioni di tonnellate annue. AUS SME Fondo Eli, R . 112 , rase. 28.
10 De Matteo, L., Alla ricerca di materie prim e e nuovi mercati nella c risi postbe llica. L'Italia e la Tran.scaucasia 1919 -1921, Napoli. Istituto di Studi Filosofici, 1990. pag. 38.
11 Entrambe le relazioni sono inc l use ne lle " Relazioni ci rca le questioni economiche - commerciali - industria li rela t ive al ptimo periodo d i attività della mi ss ione" curato da l colonnello Gabba c pubb licato nel 1920 dallo Stabilimento Poligrafico. In AUS SME Fondo E l i, R. 11 2, Fase. 28.

137
mulatosi principalmente dal settembre 1918 dopo la presa turca di Baku. Il mercato Russo che , prima dell ' occupaz ione Inglese , era stato lo sbocco quasi esclusivo della produzione di nafta e mazut, con l'arrivo dell'esercito britannico , era stato chiuso alle esportazioni.
Il mercato del Volga assorbiva nel periodo prebellico il 90 % di tale produzione, tanto che l'oleodotto veniva utilizzato prima della guerra solo per il tras porto del petrolio lampante, del quale vi era un margine di s ovrapproduzione che ve n iva desti nato all'esportazione. Il maggiore sollievo, dunque , sarebbe stato dato dalla riape r tura del mercato russo e dalla ripresa delle esportazioni da Batum, limitate dal pessimo stato di funzionamento della fenovia e dalla riduzione della capacità dcii ' oleodotto al 50 % a causa dell'immissione di nafta al posto del petrolio lampante. Novarese sottolinea , a questo proposito, gli sforzi compiuti dall ' o il contro/ inglese per rimettere in efficienza la linea ferroviaria e per procedere al lavaggio della pipe/ in e , indispensabile per poter riprendere il pompaggio di petrolio 12 . Questa operazione eraritenuta necessaria sia dagli indu s triali di Baku che dai governi locali, che appoggiavano l 'iniziativa del comando Inglese. Gli industriali, con la ripresa dell ' utilizzo della condotta per il trasporto a Batum del petrolio lampante , ad una media di 2000 tonnellate al giorno, avrebbero avuto un introito mensile di circa 50 milioni di rubli, sufficiente a coprire le s pese di esercizio c ad affrancarsi dagli aiuti economici del Governo dell'Azerbaijan l3.

Per evitare i gravi conflitti sociali e di ordine pubblico che sarebbero derivati dalla chiusura degli impianti di estrazione, che avrebbe gettato sul lastrico tra i trenta e i quarantamila operai, il Governo azero intervenne per pagare il personale delle industrie. Gli anticipi, che ammontavano a circa 300 milioni di rubli locali in buoni del Caucaso al giugno del 1919, erano garantiti sug li stock 14 di petrolio accumulati
12 ln merito alle operazioni di lavaggio c'è un breve scambio di note tra il comando inglese e la Missione italiana. In un te legramma del 26 maggio 1919 inviato dal colonnello Gabba al generale Broughl , il comandante italiano "esprime parere favorevole all'immediato inizio dell'operazione di lavaggio della pipe lin e per pomparvi ll kerosene ' '. AUS SME Fondo E Il, R. 111, Fase. 3.
13 Gabba , M., a cura di ''Relaz ioni circa le questioni economiche- commerciali - industriali relative a l primo periodo d i attività della missione··, Stabilimento Poligrafico,l920. AUS SME Fondo Eli , R. 112 , Fase. 28, pag 50
14 Del Proposto tiporta nella sua relazione un breve specchietto proprio riguardo ag l i stock accumulati che risu ltano i seguenti: Petrolio greggio 82 milioni d i pudi, pari a
138
che, a loro volta, erano aumentati in maniera vertiginosa a causa della stagnazione del mercato. Gli industriali avrebbero avuto bisogno di 70 milioni di rubi i al mese per le spese correnti, mentre, il governo ne concedeva circa la metà, alimentando i sospetti degli industriali che il governo puntasse ad impadronirsi dei loro affari , mettendoli a mal pattito.
La produzione del bacino di Baku si era ridotta, nel 1919 , a meno della metà di quella ante-guetTa c dato il permanere della chiusura del mercato russo si sarebbe dovuta ulterionnente tidmTe anche perché cominciavano a scarseggiare i mezzi per l'immagazzinamento dei prodotti. La trivellazione di nuovi pozzi stava diminuendo progressivamente, come tisulta dai dati che mostrano come dai 66.770 pozzi dell914 si fosse passati nel 1918 a 5.000. Considerando che la trivellazione eli nuovi pozzi e l'approfondimento dci vecchi è il principale segno della vitalità eli un bacino petrolifero, se le condizioni riscontrate da Del Proposto fossero continuate ancora a lungo il bacino di Baku sarebbe stato conclannato 15
U lteriore motivo eli crisi era rappresentato dal vertiginoso aumento dci prezzi dei prodotti petroliferi, compresi quelli grezzi come nafta e mazut, che avevano raggiunto cifre esorbitanti. I prezz i, fissati dall 'associazione degli industriali , erano però largamente influenzati anche dalle imposte elevatissime che il governo azero esigeva sulle esportazioni eli nafta e derivati. L'unica soluzione possibile per questo problema avrebbe dovuto essere politica; tramite accordi tra il governo ita1iano e quello de!J' Azerbaijan i dazi avrebbero potuto essere ridotti o nella migliore delle ipotesi cancellati. Le spese di trasporto erano altrettanto esagerate ma, le necessarie riduzioni non sarebbero state possibili se non dopo aver ripottato l'esercizio delle ferrovie in attivo e l'oleodotto al ma ss imo del proprio potenziale.
Gli esperti italiani suggeri rono di abbandonare l 'idea eli trattare l 'acqu i sto di tali prodotti in contanti a causa delle esagerate richieste

1.342.000 tonneJiate; mazut 62 milioni di pudi. pari a 1.015.000 tonnellate; petrolio lampante 17 milioni di pudi , pari a 279.000 tonnellate ; olio solare l milione di pudi, pa1i a 164.000 tonnellate; olii lubrificanti 5 milioni d i pudi, pari a 82.000 tonnellate; benzina 0.5 milioni di pudi. pari a 8200 tonnellate: gasolina 1.5 milioni di pudi. pari a 25.600 tonnellate; prodotti var i l milione di pucli , pari a 16 .400 tonnellate. Il totale raggiunge i 170 milioni eli pudi, pari a 2.932.200 tonnellate. Rip orto lo specchie tt o pur non potendo fare a meno eli rilevare delle inesattezzc nella misurazione delle quantità, rife rendomi in particolare all"olio solare e ai prodotti vari. ( l pudo equivale a 16 K g c 363 grammi). Gabba, M., cir , pag 46.
lS Gabba, M. , c it .. pag 47.
139
e di considerarli "trattabili invece con scambio merci manifatture e anche viveri" 16 Gli industriali di Baku per poter riprendere la trivellazione e l'estrazione avevano bisogno di ingenti quantità di materiali, impossibili da reperire in loco o comunque a prezzi elevatissimi che sarebbero ulteriormente aumentati se il blocco del mercato russo si fosse protratto. Il governo italiano, approfittando di questa necessità, avrebbe potuto ottenere le forniture di prodotti petroliferi, dei quali aveva assoluto bisogno, tramite questo scambio con merci c manifatture.
La fornitura dei prodotti petroliferi, ai numerosi governi c soggetti industriali che ne facevano richiesta- tra i quali ricordiamo oltre al governo italiano, quello inglese, una missione americana, l'esercito dei volontari di Denikin e la Srandard oil- era ostacolata non solo dai problemi inerenti all'insufficienza dei trasporti ma soprattutto dai diritti che il governo dell'Azerbaijan accampava a vario titolo sullo stock di Baku, che come abbiamo visto ammontava a circa 170 milioni di pudi tra nafta e derivati. Per prima cosa il permesso di effettuare tali esportazioni dipendeva dal governo , secondo poi una parte dello stock gli spettava in qualità di successore della corona russa c come canone, parte in contanti e pat1e in natura, delle concessioni di sfruttamento concesse. La nafta, inoltre, era stata concessa dagli stessi industriali come garanzia dei prestiti per l'esercizio delle industrie accordati dal governo. Alle motivazioni elencate si doveva aggiungere la convinzione del governo di aver diritto anche a tutta la nafta prodottasi dal l giugno al 18 ottobre 1918, periodo durante il quale il soviet di Baku aveva nazionalizzato le industrie 17
Dopo il breve periodo di nazionalizzazione il governo aveva restituito gli impianti ai precedenti proprietari che operavano per mezzo di concessioni governative. Le concessioni avevano termini molto !un-

16 Telegramma del colonnello Gabba, diretto a l la Delegazione italiana per la Pace- Sezione Militare. datato 19 maggio 1919. AUS SME Fondo Ell. R. 111, Fa s e. 3.
17 Nella s ua relazione il tenente colonnello Novarese dichiara di non avere dati certi riguardo agli accadimenti a Baku dall'istituzione del governo bolscevico nel marzo 1918, l'unico dato cc1to è che con il decreto de l di nazionali z zazione delle industrie petrolifere del l giugno 1918, il governo azerbaijano aveva s tanziato l 00 milioni di rubli per la loro gestione. Ovviamente Novarese non è a conoscenza di quanti ne siano effettivamente stati spesi né tantomeno da quale cas sa siano usciti. ln merito cfr. relazione del tenente colonnello Novarese in Gabba, M., cit., pag 88.
140
ghi. spesso fino all'esaurimento del giacimen t o. che consentivano di rifarsi degli investimenti necessari per lo sfruuamento. Le società che operavano nel settore della produzione e del commercio erano moltissime ma. in realtà, il mercato era dominato da quattro grandi gruppi indu s triali stranieri ai quali facevano capo le soc ietà più piccole. Novarese sottoli neava anche come questi grossi g ruppi fossero consociati tra loro. tramite accordi c cointeresse n ze.

L a relazione dell'ex console e regio agente in Russia meridionale Majoni, aveva in allegato un elenco di tutte le società petrolifere esitenti a Baku al 19 aprile 1919. anche alla luce di possibili interaLioni con le società italiane interessate. La più importante di esse era la Nobel una consociata svedese-russo-tedesca con la quale non era possibile a lcun accordo. Veniva poi il gruppo, comunemente noto con il nome di Mazut, che comprende la Kaspisko-Ciornomorie, la Pietro Baku, la K avkas. la Scibaicff, la Balakanskoie Neft, la Pollak della quale faceva parte il signor Pollak con il quale la missione militare italiana aveva avuto contatti. Il gruppo aveva capitali inglesi cd olandesi. in particolare della Shell di Londra. Pollak aveva suggerito che fosse possibile una compartecipazione italiana. sia mediante una cessione azionaria, sia mediante un apporto di capitale. e si era offerto di fare da mediatore. Altro importante gruppo era quello comunemente noto con il nome di Lianozof formato da tre società a capitale russo-asiatico poi ril eva te interamente da capitali francesi tramite la banca Loui s Dreifus. Majoni segna lav a anche che erano molte le società. in particolare quelle a capitale russo che. versando in cattive acque, sarebbero state disposte a ceder e le proprie concessioni anche se il Majoni non era in grado al momento d i indicarle nominalmente 1x.
Le difficili condiLioni del momento imponevano agli industriali un atteggiamen to deferente nei confronti del governo c dei corpi di occupazione stra nieri c di conseguenza si dimostravano favorevoli allo smerc io del loro prodotto verso occidente ma, sarebbe stato illusorio crede re che non spe ra ssero nel ristabilimento int egra le del mercato russo che avrebbe riaperto le correnti c0mmerciali anche co n la G ermania c con i paesi del Baltico. loro acquirenti abitual i.
I K Secondo la relazione del con.,ole !lajoni. che le elenca tullc. le società petrolifere di Bat..u erano 50. variamente con:-.ociate come abbiamo 'i\tO. con una produzione complessiva al novemhre 1918 di 11.6'1.2.727 di pucli. (Ricordiamo che l puclo equivale a 16 Kg e 363 grammi)./\US SME Fondo Eli. R. Ili. Fase. 3.
141
3. Miniere di carbo ne
Nel 1919, quando g li espert i minerari itali a ni esaminaro no le risorse della Transcaucasia. il carbone foss il e era l 'u lt imo dej minerali pe r imp ortanza, dopo il manganese ed il rame, co n una so l a miniera attiva a Tkvibuli. La produz ione era modestissima, circa 70.000 tonnellate negli anni più floridi, ed una qualità assimi labile a l tipo importato in It alia con il nome di Scozia . con un potere ca lorifi co di 6 .500 calo rie. Il s u o utili zzo ne ll 'a rca avev a sempre trovato un fortissimo ostacolo nella co ncorrenza della n a ft a, utilizzata in quasi tutti gl i im pia nti industriali de l Caucaso c per le ferrovie g razie ai bassi cost i ed alla facile reperibilità.
L a concorrenza dei prodotti p e troliferi aveva a n che impedito lo sv ilupp o di fo nti di e n ergia alte rn ativa come quella idroelettrica, c he sa rebb e s tata o ltre modo abbondante per la ri cc h eaa di co rsi d'acqua. L'unica reale possibilità di sv iluppo per l 'indust ria carbonifera geo rgia n a sarebbe sta t a quella di riuscire a produrre un coke metallurgico eli buona qualità per e po11arlo dai port i del Mar Nero. o p pure la cost ru zione di ce ntral i a carbo ne che dessero e nergia a costi minori di quelle a lim en ta te a nafta 19.
Per la v is ita a Tkvibuli il gove rno geo rg ia no mise a disposizione della missione italiana due tecn ic i del dip a rtim e nto dell a miniere, un in geg n ere e lettricista c un ingegnere geo logo, c h e partirono da Kut ais alla volta della miniera assieme a Novare e ed al tenente Marcora. Una feiTovia a scart ame nto normale di 50 chi lometr i collegava Kut ais alla miniera. Le pendenze erano fort iss ime , fino a l 42 per mill e . per su p e rare un di s li ve llo che dai 162 m el i Kutais arriv a ai 537 di Tkvibuli.
La s ta L. io nc era dotata di gra ndi piani p er il ca ricamento d e l carbon e. D a s i dipartiva un binario di collegamento co n le miniere che p oi si biforcava p er raggiungere i var i ca nti eri.

L a miniera aveva una este n sio ne accertata di 5 verste 20 e lo spesso re deg li strati di ca rbon e ragg iungeva i 10- 12 metri , que st i dati facevano riten e re ce rto ch e vi fosse una riserva di almeno 50 milioni di tonnellate c h e però avrebbe potu to essere anche molto ma ggiore.
P rima della guerra le miniere erano sfru ttate dalla soc ietà Takshira c h e l e aveva in co n cess io n e in p arte d a lla corona ru ss a in parte da pro-
19 Relazion e periodica min erari a del tene nte co lonnello Novarese. darata 2 gi ug no 1919 in AUS SME Fo nd o El! , R. I lO Fase. 2. pubbli cata ino lt n.: in Gabba. M. cit. 20 Ri cordiamo che una versta equivale a 1065 metri.
142
prietari privati. Durante la guerra a causa di alteme vicende e requisizioni la società sospese lo sfruttamento del giacimento che adesso veniva compiuto direttamente dal governo georgiano. Oltre a quegli appezzamenti ve ne erano altri appar1enenti ad una banca russa anch'essi requisiti dal governo georgiano che, comunque, lavorava soltanto nelle parti già in possesso della Takshira. Le decisioni che il governo georgiano doveva prendere in materia di legislazione mineraria21 erano della massima importanza dato che le leggi russe, ancora in vigore, avevano causato un eccessivo sminuzzamento delle aree minerarie facendo dipendere la proprietà del sottosuolo da quella dell'ipersuolo. L'attuale direzione della miniera si stava orientando alla diffusione del carbone per il riscaldamento domestico. Lo smercio per tale uso avrebbe dovuto essere ampio dati gli inverni lunghi c rigidi della regione.
Il compito più importante della missione del tenente colonnello Novarese fu l'esplorazione dei giacimenti carboniferi di Tkwargeli. Questi giacimenti erano stati segnalati alla missione prima della partenza da Roma, per ''/'abbo!ldanza del minerale, per la qualità di questo e per la vicinan z a al Mar Nero" 22 ; tale giudizio. non suffragato da dati certi non essendo il giacimento in questione mai stato sfruttato, era il riflesso di una opinione diffusissima in Transcaucasia dove il giacimento era nominato e celebrato in numerose pubblicazioni, di carattere per lo più popolare, con una efficace azione di propaganda che aveva avuto il merito di non farlo finire nel dimenticatoio.
Per prima cosa Novarese tentò di procurarsi. per preparare adeguatamente la visita esplorativa, il maggior numero di informazioni che fosse possibile ottenere in merito ai luoghi, alle vie di accesso, ai mezzi di comunicazùone, alla stagione più propizia per effettuare la visita ed agli studi compiuti sul giacimento. La ricerca fu notevolmente compii-
21 In merito alle concessioni è utile fare un breve accenno alla legislazione mineraria dell'area, riportata dallo stesso Novarese. per chiari mc il funzionamento. La legislazione tuttora in vigore. in quanto mai sostituita da una propria del governo georgiano. è ancora quella dell'Impero russo, nel quale vigeva il principio che le miniere fossero di pertinenza del proprietario del suolo. Dopo la proclamazione dell' indipendenza è stat.o so l amente affermato che del sottosuolo minerario possa disporre solo lo Stato in attesa di regolamentare la materia. Pertanto. le concessioni emanate dal governo russo rimangono valide a tutt i g l i effetti senza modificazione alcuna. Gabba. M ., cir., pag. 36.
22 Relazione dell'ing. Prof. Vittorio Novarese datata 14 lug lio 19 19, in Gabba, M ci1 .. pag.l l 8.

143
cata dagli esiti della guerra e della 1ivoluz ione che avevano interrotto ogni comunicazione con Pietrogrado dove , come sede dell'amministrazione centra le del l ' impero e della società che aveva la concessione per lo sfruttamento del bacino di Tkwargeli, si conservavano tutti gli archivi amministrativi e tecnici23 Con qualche difficoltà Novarese riuscì a radunare i documenti rimasti in Georgia in mano a privati o ad impiegati della società. dato che il dipartimento delle miniere del governo aveva potuto fornire solo dati frammentari e incompleti.

Per s incerarsi della veridicità dei rapporti e delle pubblicazioni era indispensabile effettuare un sopralluogo sul posto per verificare lo spessore degli affioramenti e raccogliere dei campioni di carbone da esaminare. Occorreva inoltre verificare quali fossero al momento le difficoltà di accesso al giacimento e quelle per il trasporto del materiale estrattivo fino al mare. La spedizione, organizzata con l'appoggio del governo georgiano e di quello della regione di Sukkum, era composta dal tenente colonnello Novarese, che aveva il compito di verificare la parte geologica e mineraria, da S.A.R. il principe Aimone di Savoia, dal capitano di fregata Granafei e dal capitano di fanteria Merendi, che aveva il compito di studiare le risorse foresta l i dell'area, dato che il bacino di Tkwargeli si trovava nel mezzo di una vasta area boschiva; accompagnava la spedizione, come ufficiale di collegamento, il tenente Matchiabelly dell'esercito georgiano 24
La spedizione parte da Tifli s il 27 giugno alla volta di Batum dove, il primo luglio , si imbarcò sulla regia nave "Poerio", il giorno s uccessivo sbarcarono il bagaglio della missione e due militari di guardia nel porto di Ocemciri. Dopo aver eseguito i convenevoli di rito con il governo locale a Sukkum, i memb1i della spediz ion e rientrarono ad Ocemcui da dove la sped izione partì il 3 luglio alla volta del bacino. Gli uomini procedevano a cavallo e tutto il bagaglio su carri trainati da bufali.
Il giacimento si trova nella valle montana del fiume Galisca che attraversa il massiccio montuoso tra l'Ungar e il Kodor. Il Gal isca sfoc ia poco a sud di Occmciri dopo circa 60 Km; nonostante questa vicinanza al mare la valle è elevatissima, s upera ndo nel suo punto culmina nte i 3100 metri c presenta ghiacciai sul versante settentrionale. Il corso
23 Jbidem, pag. 119.
24 Promemoria del capitano Granafei indirizzato al capo di stato maggio re della Marina riguardante l 'esplorazione dei giacimenti di Tkwargeli. AUS SME Fondo E l l, R. 112, Fase. 26
144
del Gal isca. che si doveva risalire e attraversare per tre volte- due delle quali a guado - per arrivare alla miniera, era piuttosto largo e impetuoso. Le sue acque, non regolate in alcuna maniera, avevano distrutto in breve tempo la strada c tutte le infrastrutture
Solo le carrette lo cali trainate dai bovini erano in grado di transitare s u quel che restava della strada però, Granafci sottolinea nella sua relazione la facilità di ripristino della strada che si svolgeva per la maggior parte in zona pianeggiante, attraversando terreni agricoli c tratti di boscaglia. Anche la costruz ion e di un tronco ferroviario che collegasse il giacimento con il mare, presso Ocemciri, non sarebbe stata. secondo Granafei. troppo difficoltosa 25 . La società che aveva avuto in concessione le miniere nel 1912 - concessione ormai decaduta- aveva costmito due fabbricati il primo, che avrebbe dovuto ospitare g li uffici della miniera, era posto ad una distanza di 33 vc r st e da Occmciri; il secondo - una costruz ione di legno dove si progettava di porre l'estrema stazione della ferrovia- si trovava 3 vcrste più a monte ad una altezza di 550 metri sul livello del mare. Quindi la ferrovia che sarebbe stato necessario costruire avrebbe dovuto avere una lun ghezza complessiva di 36 verste.
li giudizio di Novarese in merito alla creazione delle infrastrutture necessarie al trasporto del carbone da Tkwargcli al porto prescelto per l'imbarco era meno ottimistico di quello esp resso da Granafei. Per prima cosa sarebbe stato necessario costruire una ferrovia di circa 40 Km dalle miniere ad O cemciri c poi s i sarebbe dovuto decidere se costruire un porto ad Ocemciri oppure una fen·ovia costiera di altri 60 K m che collegasse suddetta località con il porto di Poti. La soluzione prescelta sarebbe stata quella di costruire il nuovo porto ad Ocemciri ma. nella migliore delle ipotesi ci sarebbero voluti non meno di tre anni per poter far entrare in produzione la miniera e rientrare delle ingenti spese. Anche dopo aver effettuato le analisi elci campio ni il tenente colonnello Novarese si c hiedeva se la conoscenza del giacimento rosse tale da autoriu.are una spesa tanto cospicua 26
Per atTivare dal primo ed ificio al secondo era necessario abbandonare i cani e trasportare tutte le attrezzature su cavalli da soma, la strada si riduceva in alcuni punti ad un sem pli ce sentiero difficilmente praticabile. La mulatticra che attraversava un fitto bosco. aveva un an-

25 AUS SME Fondo Eli, R. 112, 26. 26Cfr.Gabba.M.,cit.,pagg.l21 - 124. 145
damento di legge r a sa lita ma il terreno era piuttos to accidentato. In questo seco ndo tr a tto, la cost ru zio n e della st rada ordinaria c della ferrovia avrebbe certamente richiesto un notevo le la voro I l bosco era tanto fitto da non consentire alcu n tip o di orien t ame n to per cu i era imp ossibi le per Gr a nafei dare qualsivog l ia suggerime nto circa il tracciato migliore da utilizzarsi sia p er l'una che per l'altra. In questa seconda tappa il fiume Galisca si doveva attraversare due volte. a valle su un ponte di leg no , a monte invece c'era un gua do piuttosto malsicuro a causa d e ll'impeto delle acq ue 27
L a parte del giacimento che era stata precedentemente esplo rata era tutta com presa a ll'i n terno della foresta deman i a le d i Tk wargel i. che occupava la maggior parte della valle del G a li sca. Le aree carboni fere indi vidua te nella foresta era no tre, disposte da va ll e a sali re verso il monte, la prima di c irca 6 vcrste qu ad rat e; la seconda, di c irca 8 verstc quadrate, era detta d e l Khili guara ed e ra co nsiderata la migliore sia per la qualità del carbone, sia per le favo revo li condizioni topografiche che ne avrebbero consenr it o una rapida messa in valore: la terza. di circa 30 vc rs te qu adrate, era situata nella parte superiore de ll a va ll e con a ltitu d ini fi no a 2400 metri. La parte dci giacime nt i v isitata dalla mi ss ion e it a li a na corrisponde, a ppunto , a ll a seco nda zona2 8. geo lo g ica dei t erre ni non è quella d e l carbonifero c lassico bensì del g iurese medio, molto più recente 29. l banchi di ca r bone sfruttabil i risultavano, negli s tu di precedenti. essere tre o quattro con spessore variabile tra mezzo c nove metri. Il banco inferiore, più es teso di tutti , aveva dato in tre tri vellaL ioni s uc cessive uno spessore va riabile tra i 5 e i 9 metri. La visita d e i g iacimenti non aveva perm esso di ver i-
27 AUS SME Fondo El i. R 112. Fase. 26.
28
Secondo i computi dci vari geologi cd ingegneri che si erano occupati dci giacimenti di Tkwarge l i . il quantitativo di carbone presente ne l sottos uolo avn.:bbe dovuto esse re di ci rca 220 milioni di to nn e ll ate. ripartite dell e tre arce nd modo seg uente: area l to nnellate 43.000.000; area U tonne ll ate 72.0 00.000 : arca Ili tonnellate 109.000.000. Quest a quantitìt era solamente quella comp resa nei li miti della prodemaniale. il bacino geologico i cui confini erano ancora sconosciuti ne comprendeva un quantitativo sicuramente maggi ore. Cfr. rclatione del tenente colonnello Novarese in Gabba M cit pag. 123.

29
L a presenta di ca rbone nelle stratificazioni del giurese medio non è un caso ma una costante in tutto il Cau<.:aso, anc he la miniera di Tkvihul i. della quale avevo parlato in precede nt a, era stata aperta nell e stesse strat i ficazioni. Cfr. rc la7ione ci el tenente co lon nello Novarese in Gabba. M cit .. pag. 120.
146
ficare tutti i dati precedentemente raccolti, a causa dello stato dì totale abbandono del! ' area e della presenza di un bosco di faggi e castagni con un fitto sottobosco che impediva qualsiasi tentativo di verifica visiva dell'estensione delle arce carbonifere.

Lo scopo della missione comunque era quello di accertare la qualità del carbone di Tkwargeli, a questo scopo furono raccolti dei campioni da ogni affioramento, per essere esaminati. A questo proposito, sia Novarese che Granafei sottolinearono il fatto che i campioni erano stati prelevati dalla superficie e che quindi si trattava eli carbone che era stato sottoposto per lungo tempo alle intemperie. I saggi raccolti furono sei, prelevati da tutti gli affioramenti per essere in un secondo momento esaminati in Italia. Due eli essi, scelti a caso, furono esaminati da Novarese nellaboratmio del ministero dell'agricoltura di Tiflìs, messogli a disposizione dal direttore Prof. Melikif. Entrambi i campioni esaminati diedero un coke ben agglomeralO, con superficie unif01me e argentina. Il rendimento ottenuto fu tra il 66 e il 69% di coke con un tenore di cenere fra 1'8 e 1' 8,5 % ed una umidità di appena il 2%, nonostante i campioni in questione fossero stati per lungo tempo sottoposti alle intemperie che ne avevano sicuramente compromesso, anche se parzialmente, le qualità plirnitive 30 .
Dopo aver effettuato queste prime analisi, che confermavano gli studi compiuti in precedenza dai tecnici del ministero delle finanze russo, Novarese concluse che il carbone di T kwargcli era un coke di buona qualità acl alto potere calorifico, simile alle qualità impo1tate in [tali a con il nome di Card(ff e Newcastle e che dunque il giacimento in questione era "degno eh uno studio ponderato ed esauriente" 31 Ricordiamo, però, le forti perplessità espresse in merito alle infrastrutture necessarie per il trasporto del carbone fino a ll 'eventuale porto dì imbarco. che facevano ritenere di non poter mettere a profitto la miniera prima eli tre anni con un notevole dispendio di risorse umane -carenti nella regione tanto da far stimare la necessità di una immigrazione di 4000-6000 operai per le esigenze della miniera- e mezzi economici. Per l 'analisi delle possibilità eli sfruttamento delle risorse foresta li di Tkw arge l i, Novarese rimandava alla relazione del cap it ano Merencli, sottolinea nd o che la costruzione della ferrovia le avrebbe fatto acquistare un ingente valore.
30 Per i dati completi sulle analisi effettuate da Novarese sui camp ioni, cfr. l 'allegato a lla relazione dello stesso in: Gabba . M .. ci t . . pagg. 125- l 26. :li Gabba, M., cit., pag. 122.
147
4. Ma nganese e rame
Le miniere di manganese c di rame in Transcaucasia tivestono una impOttanza molto maggiore di quelle di carbo n e che abbiamo lun gamente descritto in pre cede n za, ma, essendo univer salme nte note, hanno richiesto minori sforz i di analisi ai tecnici della missione militare italiana che quindi hanno prodotto solo brevi rela z ion i in merito.

La miniera di manganese di Ciaturi era universalmente nota già prima della guerra. basti pensare che da sola provvedeva al del fabbisogno mondiale di manganese. L'estensione del giacimento era di 140 chilometri quadrati c conteneva una riserva di minerale stimata in 6 miliardi di pudi 32 . Il minerale estratto nei 22 anni di attività della miniera, che co nteneva in media il 50% di manganese metallico, veniva esportato in Francia, Germania, Inghilterra c Stati Uniti. Lo sfruttamento del giac imento , come pure le esportazioni, erano cresciute costan temen te, fino allo scoppio della guerra in Europa. La chiusura dello Stretto dei Dardanelli e la soppressione di ogni comun icazione con il M ar Nero fecero arrestare completamente la produzione. portando le imprese. che vedevano la compartecipazione di capital i locali cd esteri. operanti n el giacimento alla crisi. I capitali esteri impiegati all'epoca n e llo sfruttamento di Ciaturi e rano di provenienza in g lese. tedesca. francese c belga. Del Propos to s ottolineò la nece ss ità di creare dci forti int eress i italiani nello s frutlamento del manganese di Ciaturi, evidenliando che tale compito sarebbe stato assai pitl semplice in un momento di crisi come quello che si stava attraversando.
Lo stock accumulato dalle imprese. che a detta di D el Proposto avreb be dovuto essere sufficien te per circa due anni dati i bisogni ridotti del mercato mondiale c la scarsi tà di navi per effe ttuare il tra s porto del minerale in Europa , era di 5 milioni di pudi, g ià pronti all'imbarco nei porti di Batum c Poti; altri 7 milioni di pudi era no a Ciaturi pronti per essere caricati s ui vagoni fcJToviari e, per finire , 60 milioni di pudi eli minerale erano s tati estratti c dovevano so lo essere lavati. nelle 27 installazioni di arricchimento, mediante la vagg io. della miniera.
n Un pudo corrisponde a 16.38 chilogrammi. Cfr. relationc del maggiore Del Proposto in: Gabba. M .. a cura di ··RclaLi<mi circa le economiche- commer ciali · industriali relative al primo periodo di attività de ll a Stabilimento Poligrafico,l920. AUS S M E Fondo Eli. R. \12. 28. pag. -li.
148
Il prezzo medio di un pudo di minerale pronto per la spedizione. secondo le tariffe del 1913. era di 7 copechi. Nel 1913 le entrate degli industriali furono di circa 4.600.000 rubi i. Le spese per il trasporto del m inerale fino a i porti di imbarco superarono notevolmente il prezzo del m ine rale, arrivando a costare 6.497.818 rubli. Il t rasporto veniva effettuato prima mediante una ferrovia a scartamento r idotto di circa 50 verste che collegava Ciaturi a Scioropan. poi il minerale veniva trasbordato sui vagoni della ferrovia a scartamento normale che atTivavano rispettivamente a Poti. con un perco rso di 173 verstc. oppure a Barum con un percorso di 210 ver te. La linea ferroviaria, che seguiva il corso del fiume K irvula, aveva pendenze molto forti e presentava una serie di curve e controcurve a raggio molto piccolo; nonostante ciò, prima della guen·a, la portata giornaliera della ferrovia era di 4000 tonnellate al g iorno 33 . Il mjnerale, arrivato nei porti di imbarco, doveva essere successivamente caricato sulle navi per il trasporto a destinazione.
Le spese fenoviaric. assolutamente sproporzionate alla distanza percorsa che non superava i 180 chilometri. avrebbero dovuto essere ridotte non appena fossero state ristabilite le condi1ioni economiche normali, dato che esse risultavano determinanti per la concorrenzialità del manganese di Ciaturi sul mercato mondiale. Il maggiore D el Proposto suggeriva le seguenti misure per ridurre i l costo eli trasporto:
a) ridutTe la tariffa eccezionalmente elevata che ve n i va app l icata da l governo russo alla fer rovia a scartamen to ridotto. come forma di tassazio n e, e uniformarla alla tariffa della ferrovia a scartamento normale, pari a l ,63 copechi per pudo su una distanza di 150 Km:

b) perfezionare i meui di trasbordo del manganese a Scioropan, dalla ferrovia a scartamento ridotto alla linea normale cd, in seguito. eliminare la necessità stessa del trasbordo sostituendo la ferrovia a scartamento ridotto con una normale:
c.:) perfezionare i mezzi di scaricamento dei vagon i a Poti c Batum
c que l! i di caricamento a bordo de i piroscafi 34
D a i dati so p ra esposti, vie ne a ncora una vo lt a riconfermato che lo sviluppo de ll e mi ni ere di manganese in Transcaucas ia, come di tutte le principali imprese commerciali ed industriali, dipendeva in larghissima parte
" RelaLione del tenente colonnello o varese. datata 2 giugno 1919. che descri, ·c brevemente la visita degli italiani alla miniera di Ciaturi. AliS SME Fondo
Eli, R. IlO. Fase. 2.
'"' Rch.t1.ionc del maggiore Del Proposto in: Gabba, M .. cit .. pagg. 43 -44.
149
dal co ntrollo dei mezzi di tra porto della regione. Per questo uno dei primi com piti della missione italiana avrebbe dovuto esse re quello di ass um ere il co ntrollo di fen·ov ic c poni e di provvede re ad un adegua to sv ilupp o che li re ndesse competitivi s ul mercato internazionale post-bellico.
Visti gli esorbitanti cos ti di tra sporto s i era a n c h e fatta l ' ipotes i di pot e r p arzialment e tr a ttare il materiale in lo co, tra s formando il minerale grezzo in g hi sa a l manganese o in fen·o manganese mediant e l 'uso della corrente ele uri ca. Tale progetto. anc h e vo le nd o esu l are d alle consi d e razioni di caratte re economico . doveva confrontarsi con la r ea lt à d e lla T ranscaucasia dove, fin o a quel momento, non era stato cos truito alcu n impiant o idroelettrico. Pe r attuare il proge tto sarebbe dunqu e occo rso un tempo notevo le, quindi, era le cito suppo rre c he non avrebbe avuto alcun effe tto benefico s ulla ri so luzion e dell"attuale crisi del se ttore. che sa rebb e s t a t a sicuramente già s up era ta quando g li impi a nti idroelettrici av essero comi n c iato ad operare 35 .
La missione. composta dal tenente colonnello Nova rese . dal fotografo c da du e so ld a ti di scorta ed accompagnata da due fu n z io n ari geo rgiani e dall'int erp ret e. ven ne accolta a Ciaturi dal sindaco e da tre italiani residenti in l oco che vollero ospi t a re la missione. L e escavazion i di manganese, cui s i da il nome di miniere, 1iscontra te da Novarese erano c irca 3000. un numero ve ram e nte eccessivo c he era do v uto essenzialme nte a due fattori: il primo era la suddivisione d e ll a proplietà s up e rfic ial e in piccoli lotti ; il seco ndo era rappresentato dalla es trema facilità di attacca re il giacim e nt o c he. s i sv iluppa per decin e eli c hilometri con andamento qua si orizzonta le quasi seg ui sse un a lin ea di li ve llo. Tale facilit à eli raggiun ge re il g iacime nto aveva dato lu ogo ad e normi sprechi di minerale che al 50 % si pe rd eva, spesso in maniera irre parabile36 .
P e r quanto ri g uard a le miniere di rame, c h e è il te rzo minerale per importanza nel Caucaso dopo nafta e man ga n ese. e rano situate ai marg ini dell'altopiano armeno, a cavallo dei governatorati di Batum , Tiflis cd Elisavestopol. L a produzione di rame ant e b ellum si aggirava attorno alle 8000 tonnellat e annue, per un controvalore tra i 12 e i I 5 milioni di franchi 37 .
.1 s Relazione del tenente colonnello t\ovarese. AUS SME r ondo Eli. R . IlO. Fase. 2.
36 R e lazio ne Novarese. AUS SME Fondo Eli. R . IlO. ra)>c. 2 .
n R e laz io ne periodica se ttim a nale mineraria del te nente colon nello Novar ese in : Ga hba M.,cit. , pa g. 35.

150
I giacimenti di rame non furono oggetto di alcuna indagine diretta da parte della Missione Italiana, come pure quelli di fc1To che- nonostante si stimassero abbondanti - non erano mai stati sfruttati a causa degli elevati costi della manodopera38.
5. Ris orse fores ta li
Le relazioni del capitano Mercndi sulle risorse agricole e boschive della Transcaucasia sono frutto di una attenta raccolta di dati e di una ser ie di missioni esplorative nelle aree boschive ritenute adatte allo sfruttamento da prute di capitali italiani. Le aree boschive esaminate erano situate nelle vallate dei fiumi defluenti verso il Mar Nero. in particolare la valle della Grande Liakva , quella dello Tzkheni-Tzkhali, del Rion , del Kodor , dell'lngur, del Galiska - studiata in occasione della missione al giacimento carbonifero di Tkwargeli - insieme con il territorio circostante Gagii, per finire la valle del Kura cd il te1Titorio circostante Kutai s .
I boschi che interessavano l 'ltalia erano soprattutto quelli di resinose , che nel Caucaso si incontravano tra i 1.500 e i 2.000 metri di quota, mentre tra i 1.000 e i 1.300 i boschi erano formati prevalentemente da fustaie miste di Jatifoglie e resinose che avrebbero potu to essere prese in cons iderazione in un secondo momento con abbattimenti selettivi-w. La superficie boscata annualmente utilizzabile si aggirava attorno ai 20.000 ettari, con una produzione approssimativa di 700800 .000 metri cubi di legname tondo da opera, conisponden t e a circa u n qu into del fabbisogno italiano.
Il problema de l trasporto dei tondami -a valle, alle seghe rie pe r la lavorazione cd s uccessivamente ai porti d'imbarco- era di grande r ile-
38 L'unico giacimento di ferro di cui s i ha notizia si trovava nel dist retto di E lisavcstopo l ed era in concessione, prima de lla guerra. ai fra telli Siemens . De Matteo, L. , L'Economia della Ti-anscaucasia nelle relazioni della Missione militare italiana Gabba ( 1919), in Nuova Rivista S t orica, Perugia , Vol. LXXIII. 1989 , pag. 343.
39 Le s pecie legnose che si riscontravano più facilmente nei bo sc hi del Caucaso erano la picea orientalis, f'ahies nordemanniana e il pitws silvestris, soprattutto lepr ime due s pecie forn isco no un o tti mo legname da costruzione, s imile a que ll o che in Italia si trovava i n Ca rn ia , in Cadore c su li 'appennino toscano Lo studio el i Merencli aveva volu t amen t e omesso d i p rendere in considerazio ne i boschi di latifoglie, ma accenna comunque a ll a prese nza di mag n ifici esemplari d i quercia, noce. frass i no, faggio, acero, tig l io e ca r pino. Gabba, M .. ci t .. pagg. 60-6 1.

15 1
vant:a e pertanto fu oggetto di attenta riflessione da parte del capitano Merendi. L'orografia del t erreno -con fa ld e montane piuttosto ripideda un lato rendeva più complesso l'abbattimento dali 'altro facilitava l 'avvallamento dei tronchi tondi, che durante i giorni umidi potevano essere fatti scivo lare sino a fondo valle. Quando il pendio era minore potevano essere impiegate slitte tirate da bufali, le risinc- a secco o ad acqua - oppure le teleferiche. Una volta arrivati a valle i tronchi venivano immessi nei cor i d'acqua per la fluitazione, che poteva essere effe ttuata lasciando i tronchi liberi oppure lcgandoli in zattere di varie dimensioni. fino alle Nei fiumi con maggiore portata d·acqua la fluitazione non presenta grandi difficoltà, una volta effettuata una opera preventiva di spictramento del fondale. Se la fluitazione fosse stata ben condotta c si fosse riusciti, con una val ida sorveglianza, ad evitare i furti le perdite non avrebbero potuto superare il 10 %. Nei corsi d'acqua secondari e negli affluenti sarebbe stata necessaria la costruzione delle cosiddette stue - un tipo di diga - nella cui costruzione i tecnici italiani erano molto abili. Il periodo utile per la fluitaL.ione andava gene ralmente da aprile a luglio ma, nei corsi d·acqua più gra ndi, era possibile effett uarla tutto l'anno.

Gli operai specializzati italiani sarebbero sta ti comunque indispensabi l i, dato che la manodopera locale era carente in tutti i lavori che richiedessero una certa dose di compete n za tecnica. Anche nei la vori più semplici eli taglio cd est ru s ion e, Mcr endi riteneva fondamentale l a supervisio ne di un capo s quadra italiano. Comunque, dopo un periodo di affiancamento la manodopera locale avrebbe dovuto raggiungere circa il 70% della fort.a lavoro impiegata. comente nd o alle impre se di abbattere i costi, v is to che le pretese degli operai georgiani erano alquanto inferiori a quelle degli italiani.
Merendi segnalava, inoltre, l'assoluta nece ss ità di ridurre il legname in assortimenti egati in loc o . La sce lta delle località in cui impiantare le segherie avrebbe dovuto essere molto ragionata per limitare al minimo , e ne i cas i specifici presi in esame da queste relazioni per escludere in via assoluta, il trasporto su ferrovia del tondamc. In genere bisognava tentare di installarle sulle rive dei fiumi ad immediato con t atto con la fe rr ovia, per rendere semplice e poco costoso il carico dei segati s ui vagoni. Qu a lora fosse ri s ultato necessari o sceg li e re l oca! ità di tanti dalla linea ferroviaria, si sarebbe dovuto provvedere a costruire un breve allacciamento ferrov iario alla linea principal e .
'l
152
Le macchine da impiegare erano le seghe alternative multilame da g rande produzione, con un telaio variabile dai 50 agli 85 ce ntimetri. Nel caso si vo le ssero lavorare i sottoprodotti per a ll estire cassette da imballaggio sarebbe stato necessario aggiungere una sega a pendolo c qualche rifendino. Ci sa rebbe stato bisogno di dotare le segher ie di intestatrici dato che i tronchi, dopo la tluitazionc, arrivavano alle segherie con le testate corrose. L'utilizzo delle intcstatrici conse nti va di e liminare le testate, di tagliare i tronchi a misura c di eliminare i sassi che fossero eventualmente penetrati nel legno e che avrebbero potuto intaccare le lame. Per eliminare i rifiuti della lavorazione - rifilatura. segatura e intestaturc- Mcrcndi consigliava l'utilizzo di fo rni semifissi per la combustione. Per finire, ogni segheria avrebbe dovuto essere munita di una piccola officina per le riparazioni dei macchinari e l'affi la tura delle lame40.
Per il legname della valle dello Tzkheni-Tzkh ali esisteva già una segheria a Soccliavo, che avrebbe dovuto essere comunque potenziata qualora si fosse deciso di prm:edere ad uno sfruttamento più intensivo dell'area: i prodotti della valle del Rion potranno essere lavorati a Kutais o a R ion: i tronchi della valle del Kura e de l Liavka avre bbero potuto essere trasportati a Gori, dove avrebbe dovuto essere costruita una grande segheria: i legnami provenienti dalla va ll e de ll'ln gur, invece, avrebbero dovuto essere lavorati nel punto in cui il fiume incontrava la fenovia litoranea de l Mar Nero, oppure pres so Anakla41 .
Al fine di contenere il pre:ao dei segati sul mercato italiano sare bbe stato indispensabile ridurre al minimo le spese di trasporto via mare. Prima della guena il costo da Poti ad Ancona era di 8 lire al metro cubo, una cifra abba tanza modesta da non influire eccessivamente su l costo del prodotto segato, anche tenendo conto che il costo del macchiatico - costo della pianta in piedi - in Caucaso era molto inferiore a quello italiano42 . Purtroppo. a causa della mancanza di utilizzazioni
40 Relazione del capitano Mercndi sullo sfruttamento dci transcaucasici. AUS
SMEFondoEI I.R .ll2,Fasc.9.
-l t A detta dello stesso capitano Merendi sono solo indicalioni di carattere generale che dovranno essere approfondite e completate qualora decidesse di procedere allo sfruttamento dci bo-.chi del Transcaucaso. AGS SME Fondo Eli. R. 112, Fac;c.9 .
pret70 del macchiatico richiesto dal governo georgiano era di 5 lire al metro cubo. contro le 30 lire al metro cubo dei boschi italiani. A US SM E Fondo EJl. R. l l 2. Fasc.9.

153
boschive in corso al momento dello svolgimento della missione italiana, non fu possibile al capitano Merendi rnccoglicre infonna7.ioni aggiomate sul costo delle lavorazioni e quindi valutare il costo unitario degli assortimenti di segato da esportazionc 43 Le quota7.ioni del legname in Europa nell'immediato dopo guerra erano molto e levate a causa dell'enorme bisogno di legna di ogni tipo per la ricostruLionc e la ripre sa del l 'attività industriale. I prezzi sarebbero certamente andati progressivamente ca l ando. perciò sarebbe sta to fondamentale iniziare lo sfruttamento in Caucaso nel piì:1 breve tempo possibile. L'ini7.io delle esportazioni non sarebbe s tato comunque possibile prima di un anno e mezzo. periodo di tempo prcsumibilmentc utile per far sgonfia re i prezzi dci noli delle navi da trasporto arrivati a cifre proibiti ve.
Tutto considerato, M e rcndi riteneva che. a distanza di due anni, il cos to dci segati in Italia sarebbe stato di circa 100 lire al metro cubo. Supponendo che tale cifra - che comprendeva i costi di produzione e di tra s porto - non subisse variazio ni, se non quelle di carattere normale, il guadagno netto per metro cubo non avrebbe potuto esse re inferiore alle IO lire. Nella sua relazione riassuntiva. del 16Iuglio 1919, il capitano Merendi prospettava l· invio in Transcaucasia - non piì:t tardi dell'ottobre dello stesso anno - di una decina di tecnici foresta li con l 'incarico di studiare nel dettaglio le vallate da lui indicate nelle precedenti relazioni. L'esame di ogni vallata avrebbe dovuto includere: l. possibilità di fluitazione dci tronchi, entità dei lavori per l'adattamento dei letti dci fiumi; 2. scel ta dci mezzi più economici di esbosco; 3. condizioni della mano d'opera locale; 4. scelta della località per piazzare le segher ie; 5. determinazione del numero di operai s pecializzati italiani occorren te ; 6. ca lcolo dei costi dall'esbosco fino al carico sui piroscafi: 7. determinaz ione de i macchinari più adatti: 8. possibilità di vendere in Transcaucasia i so ttoprodotti non esport abili: 9. condizioni generali di ambiente e noti7ie varie.w.
La sce lta migliore per lo sfru tt amen to sarebbe stata, secondo Merendi, quella eli affidare la concessione di sfruttamento ad una socie tà che dispone sse di grandi capitai i e desse. qui ndi, affidamento sulla ri-

·H A dei legmu11i da Merendi. consigliava di mandare in Italia solo i prodotti di prima e seconda scelta e di vendere su l posto la parte più scadente. per vincere la concorrenza dei prodotti importati dal basso Vo l ga. AUS
SME Fondo E l l. R. l 12. Pa sc. 9.
44 RelaLionc rias!>untiva del capitano Merendi in: Gabba. M cit pag. S2.
154
uscita delle operazioni, visto che le imprese richiedono larghe anticipaLioni di denaro per la costruzione delle segherie. delle st ue, delle teleferiche e delle risine. Si raccomandava. inoltre. di fissare il prezzo del macchiatico, con il governo georgiano. in lire italiane per evitare che le fluttunioni del rublo caucasico s i rip erc uotes sero su ll 'a ndamento dei rapporti commerciali 45 Mercndi c hius e la sua relazione riaffennando la propria convinzione che lo sfruttame nto delle ri sorse boschive del Caucaso sarebbe stato conveniente per l'Italia comc per coloro che avrebbero assunto l'impresa. Tuttavia, data la mole dei la vo ri proposti. egli stes o chiese che le proprie conclusioni venisse ro atten tament e messe a l vaglio. per non lasciare una de<.:isione tanto imp ortante al giudizio di una persona.
6. Agricoltura
La vita economica della Transcaucasia - una regione con una superficie pari a circa la metà di quella italiana ed una popolazione di appena 7.509.000 persone pari a circa un quinto di quella italiana46e ra quasi escl usivamente basata sull'agricoltura. Il tipo di agrico l tura praticata era molto arretrata, condiz ionata com'era dalle caratteristiche montuose del territorio, che rendevano inutilizzabili i 2/3 del territorio. La zona più ferti le e ra quella del versante del Mar Nero e la valle del K ura fino a Tirtis e poco o ltre. c he avrebbe conse ntito una coltura molto più redditizia qualora fossero state applica te tecniche più moderne di col ti vazione; in tutto il versa nte del Mar Ca:,pio, invece, il clima era caldo e secco c la vegetazione assumeva un a petto s tepposo e e le coltivazioni erano stentate. Nelle zone attomo ai 1200 metri la fertilità del suo lo, la ricchezza di precipitaLioni e l'ampiezza del periodo vegetativo erano riscontrabili in pochi altri paesi al mondo. A questi positivi fattor i naturali si sarebbero dovute aggiungere solo tec nologie c cap it a li s ufficienti per ottenere ri s ultati eccez ionali.
Pare che il governo georgiano fo'>sc stato informato in merito a questo punto del problema c che avesse acceumo di fissare il prezzo in lire italiane. anche perché altrimenti sarebbe staro molto difticile che quabiasi impresa iwliann decidesse di im·ein Transcaucasia. Gabba. M cit pag. 84.
-1 6 De M alleo. L.. L Economia della Transcaucasia nelle rela -;.ioni della Missione miliwre italiana Gabba ( /919). in Nuova Ri\'ista Storica. Perugia, Vol. LXXIII. 1989. pag. 334.

155
I sistemi di coltivazione largamente estensiva che venivano praticati, senza operare, inoltre, alcuna rotazione delle coltivazioni e se nza utilizzare alcun tipo di concime né chimico né naturale, avevano effetti devastanti sulla fertilità del suolo, che sfmttato per anni sempre per la medesima coltivazione, perdeva rapidamente la propria capacità produttiva. Anche la superficie forestale veniva danneggiata dalla coltivazione di tipo estensivo, sottraendo al bosco sempre maggiore spazio da destinare a pascolo o a coltivo. I terreni erano lavorati con aratri rudimentali che non si spingevano mai oltre ai dieci centimetri. Il modesto strato di terreno che veniva lavorato si insteriliva rapidamente. La superficie coltivata era, al momento in cui il capitano Merendi scrive questa relazione, eccessiva rispetto al fabb isogno alimentare della popolazione, questo perché la produzione media per ettaro in Georgia raggiungeva appena i sei quintali. Tale quantità avrebbe potuto essere faci l mente raddoppiata affrancando la Georgia dall'importaz ione di grano dali 'Ucraina 47
Le produzioni più importanti della regione erano i cercai i - granturco, riso, grano e orzo -c he però non arrivavano a soddisfare il fabbisogno nazionale; il vino veniva prodotto nel distretto di Kacheti ed esportato in massima pru1e in Ru ssia meridionale ; il tabacco era coltivato sul Mar Nero nelle provincie di Sukkum e Batum era esportato in Europa tramite l'intermediazio ne tedesca della Deutsche Bank; il tè veniva prodotto nel distretto di Batum, le qualità migliori venivano vendute a Mosca e Charkov, mentre quelle più scadenti erano destinate alle truppe russe.
I prodotti più importanti per l 'es portazione erano la seta, il cotone e la lana. La sericolt ur a era molto fiorente in Transcaucasia , interessava i governatorati di Elisavestopol , Tiflis, Baku , Erevan e Kutais. La coltivazione dei ge lsi avveniva nelle z one alle pendici dei monti che risultavano particolarmente adatte. La produzione di! bozzoli secc hi arrivava ad una media annua di 1700-2000 tonnellate, che ven ivano esportate In Fr ancia meridiona le - il cent ro commerciale principalmente coinvolto era Marsiglia- e in It alia a rriva vano i 2/3 della produzione di Kutais , tutto il rimanente ad eccezione di un modesto quantitativo per il consumo locale, veniva inviato a Mosca4 8
Anche la col tur a del cotone si era sviluppata in Transcaucasia, nonostante i metodi primitivi e la mancanza di una adeguata irrigaz. io-

156
47 Relazione Merendi, datata 31 lugl io 19 l 9, in Gabba, M., ci t., pag. l 14. De Matteo , L., ci t., pagg. 336-337.
ne. l governatorati coinvolti erano, ancora una volta, quelli di Elisavestopol, Tiflis, Baku, Erevan e Kutais; la produzione nel 1915 raggiungeva i 300.000 quintali. Il cotone era di buona qualità ma di fibra corta e veniva inviato ai cotonifici russi che lo utilizzavano per la trama dei tessuti. Il tenente Marcora nella s ua relazione , datata 26 luglio 1919 , sottolinea come la produzione del cotone- trascurata negli anni precedenti dal governo russo che non aveva curato né l 'i rrigazione né le malattie della pianta - avrebbe potuto es se re migliorata curandone maggiormente l'organizzazione dato che i capitali non mancavano cd il terreno era adattissimo alla coltivazione di tale pianta49 .
La produzione della lana - legata alle numero se greggi di pecore che pascolavano nelle steppe del Caucaso - arrivava a circa 480 mila tonnellate atmue. La qualità nùgliore era la Tushin skaya, un tipo di lana merinos , che si produceva in massima parte nella zona di Tifli s . Nelle zone di Erevan, Baku ed Elisavestopol si produceva una qualità inferiore ma pur sempre discreta. Il consumo locale era forte dato che la produzione degli abiti tradizionali era essenzialmente casalinga , il grosso dell'esportazione era verso la Ru ss ia, il nord dell' Am1enia , la Francia c l'Inghilterra. T prezzi si aggiravano nel 1919 attorno ai 350-400 rubli per pudo, ma la tendenza era al rialzo. Inoltre, secondo Marcora, la disponibilità di lana grezza doveva essere piuttosto elevata, pur non essendo in grado di fornire dati precisi, dato il lungo blocco delle esportazioni50 .
Merendi , nella pa11e conclusiva della propria relazione , elencava gli strumenti agricoli 51 dci quali aveva rilevato un estremo bisogno durante i suoi sopralluoghi in Transcaucasia. Le numerose fabbriche italiane di materiale agricolo avrebbero potuto trovare nella regione un mercato ampio per collocare i propri prodotti, anche basandosi sulle rela zio ni che i tecnici agrari italiani avrebbero potuto stilare studiando i tipi di macchine più adatti alla natura di questi terreni e le eventuali modificazioni specifiche da apportare a quelle in uso in Italia.
Per attivare degli scambi commerciali proficui Marcora sottolineava, come aveva fatto Mercndi in precedenza, l'assoluta inaffidabilità del m-
Rela zio ne del t enen te Marcora Sul/ 'organi-;::a;:ione degli scambi comme rciali Fa f'lwlia e il Transcaucasu in Gabba, M. , cii., pag. 108.
50 Rela zio ne del tenente Marcora./bidem, pag. 107.
5 1 Me rcndi rife 1isce che in Transcaucasia c ·era assoluto e urgente bisogno dei seguenti s trumenti agrari : aratri con molti vomeri e coltelli di ricambio, falci fienaie, s trumenti da g iardina gg io, falciatrici , semi n atrici, erpici, trebbiattici , so lfato di rame. fi01i di zolfo. sc mcnti varie. Relazione Merendi. Ibide m. pag. 116.

157
bio locale c h e n on poteva a so lutamente essere adope rato come moneta di scambio. La soluzione prospettata era quella dello scambio di merceper lo più materie grezze o semilavo rati - con i prodotti finiti italiani. Qu es to tipo di scambio non presentava difficoltà particolari, ma ri chiedeva un te mpo magg iore per pia zzare la merce pres uppo ne ndo , inoltre , una co nosce nza piuttosto ap profondita d ei generi da ri ceve re in cambio del proprio prodotto. Aveva anche il vantaggio di poter guadag nare nella cessione della propria merce. se gli scambi fossero stati fa tt i oculatame n te. e di Tivendere in patria le merce ricevuta in pagamento. attenendone un secondo guadagno. Quc to tipo di comme rcio però pe r sv il upparsi su vasta sca la avrebbe avuto bi ogno di un forte appoggio. per sempli fi care i contatti tra le parti, il me:ao migliore c più immediato per fare c iò sarebbe sta to quello di s tabilire un Ufficio Commerciale presso la Banca Ita li ana c he avesse il compito di far in co ntrare la domanda e 1•offc1ta52 .
Gli an ni di g uerra c la rivoluzione aveva no avuto effetti devastanti s ulle poche industrie esisten ti in Transcaucasia. le fi la ture di seta e i cotonifici n o n facevano ecceL ione. l se tifi ci di Elisavcs topoL di Shusha c di Nuhka risultavano chiusi da vari <mni cd avevano ubito anche dci danneggiamenti nel 19 l 8 mentre il cotonificio Tagi ev. c h e era rimasto in funz ion e durante la guerra. malgrado la mancanza d i pezzi di ricambio per i macchinari, s i limit ava o nn a i all a produzione di articoli grossolania nche a cau sa d e lla qua lità del co ton e local e - c s i e ra speciali zza to ne ll a produ z ione eli cinghie eli tra s mi ss ione per g l i autoveicoli. Anche prim a della g uerra la po li tica della Ru ss ia nei confronti de l Caucaso era s tata di ri g id o protezionismo. che aveva impedito quas i comp le tame nte a ll e merci es tere di avere un mercato ne ll a regione e aveva reso la Transcaucasia tribu taria della Ru ssia per la quasi totalità dei be ni st rumentali e dei prodotti manifa tturi er i . Con l'interruzione delle n orma l i relazioni comme rcia li co n la Ru ssia dopo la rivoluzione ve nn ero a mancare praticame nte tutti i manufatti indi spe n ab ili per la popolazi o ne c per le indu s trie 53 .
7. Qu es tioni eco nomich e e conclusioni d eg li es perti
L' Itali a aveva pensa to di poter so pperire con i propri prodotti a tali carenze e di poter o ttenere a sua volta le co ncessio ni per lo fru ttamento del-
Relazione del tenente Marcora in Gabba, M .. ci t., pag. 109.
Dc M atteo, L .. ci t .. pag. }57.

! 58
le ingenti risorse naturali della Transcaucasia che ho a lungo descritto nei paragrafi precedenti. I tecnici della missione non avevano mai mancato dì sottolineare la necessità di creare al più presto interessi italiani nell'area, rilevando le concessioni delle imprese locali ed estere in difficoltà edottenendo dai Governi delle Repubbliche indipendenti tutte le agevolazioni possibili. Come sottolinea il maggiore Del Proposto le concessioni erano la pre-condiziorne indispensabile per decidere l'invio delle truppe italiane:
"è evidente che l'l tali a non può e non deve sobbarcarsi le spese inerenti al! ' occupazione stessa per proteggere interessi altrui " 54 .
Del Proposto riteneva che, data la crisi in atto, sarebbe stato piuttosto semplice ott enere le concessioni necessarie dai governi locali in ciascuno dei campi di interesse italiani - in particolare quelle sui terreni petroliferi, sul manganese, sui giacimenti carboniferi, sulle aree boscose ed il controllo delle ferrovie - cd assicurarsi un diritto di preferenza, rispetto alle altre nazioni, per tutte le nuove concessioni che i governi locali credessero di accordare. Il secondo impottantissimo passo da compiere era la stabilizzazione del rublo caucasico, soggetto ad enormi fluthtazioni, che poteva essere compiuto solo attraverso un controllo sulle banche che ne assicurasse il funzionamento regolare. La situazione monetaria nel 1919 era piuttosto intricata. sul tenitorio circolavano:
a) biglietti della Banca I mperiale russa (detti Nikolaiewski) retaggio del governo dello Zar;
b) biglietti stampati dal governo provvisorio di Kerenski (detti Kercnski);
c) buoni del Caucaso, divisi tra le tre Repubbliche, emessi inizialmente per un controvalore di 300 milioni di rubli 55 ;
d) buoni della Repubblica di Azerbaijan e della città di Baku per un totale di circa 1030 milioni di rubli 56
54 sul problema economico della Tramcaucasia del maggiore Del Proposto AUS SME Fondo ES. R. 91, Fase. 9 ed in: Gabba. M., cii., pag. 7.

55 Di comune accordo però le tre repubbliche emisero buoni il 20 luglio ed il 6 settembre 1918 per 280 milioni, il 15 novembre per 140 milioni. il30 gennaio 1919 per 320 milioni e nell'aprile del 1919 per 300 milioni. In totale J'em.i ssione di buoni del Caucaso raggiunse i 1360 milioni eli rubli. Relazione del tenente Vita Sulla questione monetaria bancaria in: Gabba, M., cii., pag. 17
Sf1 l Buoni de ll a repubblica di Azerbaijan ammontavano a circa 740 milioni di ruoli al 24 maggio 1919; la città eli Baku, per sopperire alla mancanza di bigliclli di Stato aveva emesso 172 milioni di mbli con a garanzia chèques di diverse società; circolavano inoltre circa l J 7 milioni di rubli emessi dai bolscevichi. Ibidem. pag. l 7.
159
Nonostante le emissioni totali avessero raggiunto complessivamente circa 2 miliardi e trecento milioni di rubli, sia la Georgia che l'Azerbaigian prevedevano un bilancio 1919-1920 i n deficit, rispettivamente per l'ammontare eli 250 milioni e 380 milioni eli rubli. In mancanza eli una ripresa delle esportazioni l'unico modo eli coprire tale deficit era l'emissione di nuovi buoni. Ma il ripetuto ricorso a questo strumento aveva come effetto il deprezzamento della moneta locale, tale deprezzamento non era in relazione alla capacità eli acquisto interna della moneta, ma solo al rapporto con le valute estere, data la scarsità di valuta prcgiata circolante. Le forti ondate speculative avevano portato le divise straniere ad aumenti di piLI del200% in un periodo che va dal novembre clel1918 ai primi di giugno del 191957 .
Il Governo italiano, secondo quanto suggerito dagli esperti , avrebbe dovuto procedere alla conversione della moneta locale con la lira italiana- il valore avrebbe dovuto essere fissato tra le 6 c le 8 lire per rublo - la sostituzione si sarebbe potuta effettuare tramite la Banca di Stato Italiana , oppure tramite la Banca di Stato Russa - succursale di Baku - gestita dallo Stato Italiano 5R. Prima di procedere alla conversione sarebbe stato necessario eliminare ogni eventuale quantitativo di moneta italiana giacente nel paese , come avevano fatto in precedenza gli Inglesi, per sostenere il corso della moneta e manteneme alto il va lore.

57 Il tenente Vita riporta un valore della ster lin a britannica di 80 rubli caucas ici nel novembre del 1918 che era arrivata nel giugno del "19 a 350 rubi i , anche la l ira italiana era passata dai quattro rubli del 1918 ai dieci rubli del l9J9./bidem. pag. IS.
5 8 La Banca di Stato Russa- succursale di Baku - aveva ripreso la propria attività nel genna io de l 19 19 sotto il controllo del comando Inglese. La Banca aveva provveduto, nel momento p ili grave della cri s i dell"industria petrolifera. acl anticipare agli industria l i il denaro per gli stipendi degli operai. Il Comando Inglese, ricevuto l'ordine di evacuazione il 26 luglio 19 J9, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione c chiusura della s uccursale di Baku portando con se i valori ru ss i che si trovavano in custodia. La Mi ss ione Italiana ricevuta l'informativa riconobbe la necessità di proseguire nell'e s ercizio della Banca per diversi motivi: l. Siccome la Banca di Stato esercitava un controllo su tutte le a ltre sarebbe stato il mezzo più efficace per conoscere a fondo tutta l 'organizzazione finanz iaria della regione; 2. Data la fiducia che viene riconosciuta alla Banca nella regione si potrà contare s u molti depo s iti; 3. Il control lo della Banca eli Stato era il solo mezzo per poter preparare la sostituzione della moneta attuale. Relazione de l tenente Vita sulla Ranca di Stato Russa su cc ursale di Baku in Gabba, M. , c it .. pagg . 22-24.
160
I Governi locali si sarebbero trovati inizialmente in grossa difficoltà non potendo più colmare il deficit con l'emissione di nuova moneta. Sarebbe stata cura del Governo italiano provvedere inizialmente al pareggio dei bilanci tramite prestiti, ottenendo in garanzia concessioni di ogni genere e in un secondo momento suggerendo opportune riforme di carattere economico e politico per ridurre la spesa pubblica c l'indebitamento. La conversione della moneta era indisp e n abile per dare al valore della moneta local e una stab ilità sufficiente per permettere laripre a regolare degli scambi commerci ali. Prima di procedere alla conversione sarebbe stato utili ssimo ottenere dal Go ve rno azerbaigiano la cessione dei propri crediti nei confronti delr industria petrolifera ottenendone in questo modo i l pieno controllo.
Il passo successivo sarebbe stato quello di prendere i l controllo delle succursali de ll e banche russe di Mosca e Pietrogrado che, rimas te se parate improvvi same nte dalle sedi centrali, si trovavano in grosse difficoltà. Una volta rilevate le s uccursali bancarie sarebbe s tato necessario creare un organismo finanziario che disponesse dei capitali suffic ie nti per lo sfruttamento delle concessioni esistent i e di quelle che "i Go,·erni lo cali sono dispostissimi ad accordare "59 .
La disponibilità dei Governi locali al rilascio di concessioni che avessero carattere monopoli stico, venne smentita in diverse occasioni dai rappresenta n ti de ll e tre Repubb li che transcaucasiche che non intendevano delegare in alcun modo ai propri poteri po l itici ed a ll a propria indipendenza, pur accettando la protezione militare italiana, che però avrebbe dovuto limitars i ad un'azione di polizia. Le repubbliche riconoscevano come inevitabile la propria partecipazione ad una eventuale futura confederazione russa ma vo levano ri ervarsi ogni iniziativa. Le perplessità italiane derivavano, inoltre. dalla carsa fiducia nella validità di co ncessioni concesse da Governi che non avevano ancora ottenuto alcun riconoscimento internaziona le - per il qua le si stavano a t tendendo le d e l ibe re de ll a Lega de ll e Nazio ni -o lt re ad incontrare la fe r ma op p osizione de l genera le Denikin. Siglare deg li acco rdi con le tre repubbliche avrebbe imp l icato un implicito riconoscimento della loro indipendenza che, anche a detta del Foreign Office britannico, avrebbe compl i cato i rapporti co n D enikin e ingarbugliato ulterio rmente la non facile s itua z ione politica. Denikin aveva infatti più volte manife s tato la propria contrarietà al riconoscimento d e li' indipendenza
5'> Relatione del tenente Vita. Ibidem. pag. 21.

161
del Transcaucaso ed era evidente che né gl i In g lesi né il governo italiano volevano urtare la s uscettibilità del generale ru sso 60
D e nikin , in un telegramma inviato a Sazonov e ripreso il 23 dicembre 1919 dal giorna le di T ifli s "Vo rsroc hd e ni e", aveva dichiarato che. sicco m e il compito del co m a ndant e in capo e ra quello eli p roteggere gli interess i dello Stato ru sso unitario dai nemic i interni ed estemi, l'alto comando non poteva asso lutamente permettere che i govemi provvisori , sta bili tisi per caso e se nza alcuna legittimazione l egale del proprio potere, s pe rp erassero le ricchezze della Gra nd e Ru ssia accordando co ncessio ni a gove rni stranieri . Tali erano probabilmente le inten zio ni dei gove rni del Caucaso. Denikin quindi informava tutti i govern i alleati che tutte l e co nv enz ioni c he avessero intaccato g li interessi della Gr ande Ru ss ia , concluse a ll'insaputa dell'alto co mand o, non sareb bero mai state ri conosciute dal gove rno della Ru ssia unificata. Il gene r ale invitava i circo l i commercia li e politici alleati ad astenersi dalla st ipul a di tali acco rdi c he av re bbero avuto so lamente co nsegue nze sfavo revo li , un a volta che la Russia fosse stata riunificata6 1• I1 comme nto d e l co lonnello Gabba , in via to a l Ministro degli Esteri in data IO ge nnai o 1920 con allegato i l s uccitato articolo, pol e mi zza co n il ge nera le De nik in che dovrebbe esse re g rato alle potenze alleate ed all ' Italia in p a rt icolare per l'opera s volta in Transcauca sia e s me nti sce la volontà dei governi local i eli disperdere le propri e ricchezze natu rali "che invece procurano di negoziare con profitto , a ciò spinti anche dalla svalutazione della moneta locale "62 . La reverenza degli al leati nei confronti di Denikin e ra g iu st ificata dalla convinzione che , adeguatamente s upportato, avrebbe potuto sconfigge re i bolscevichi e ripre nd e re il controllo della Ru ssia. Gli Ingles i avevano infatti fornito all'armata volontaria de l ge nerale moltissimo materiale be ll ico e merci di ogni generé 3 Evidentemente la presa del pote re
60 Qu esto s inte ti co ma efficace resoco nto vie ne redatto dal Si g. Alberto Pire lli, recatos i a Londra per discutere con le a utor ità finanziarie quale delegato de ll ' isti tu e nd o sind acato italiano per la penetrazione econom.lca in Tra nscaucas i a. Il telegramma è datato 23 ottobre 1919 ed è diretto alla Delegazione Italiana per la Pace a Pari g i, all'allora Presidente de l Consiglio Nitti, al Ministro de l Commercio ed al Se natore

Conti. AUS S M E Fo ndo E l l , R. 11 1, Fase. 3.
6 1 Telegramma di Denikin a Sazonoff in AUS SME Fon do Eli , R . Ili , Fase. 5.
62 Lettera del colo nn e llo Gabba per il Mini s tro deg li Esteti c he accompagna l'articol o di Deni kin in AUS SME Fondo El l. R. 111, Fase. S.
63 In un co ll oqui o , datato 9 giugno 1919, tra il mini stro So nnin o e l' ambasciatore russo a Roma De Giers, quest'ultimo si informa sulle inte nz io ni del nos tro governo
Il
162
da parte dei bol scevic hi - che prevedevano la nazionalizzazione di terTe ed imprese industriali - avrebbe fatto naufragare , come dì fatto avvenne nel 1920. qualsiasi progetto dì penetrazione eco nomica e finanziaria. Gli esperti della missione italiana giunsero a due conclusioni opposte in me1ito alla convenienza ed alla necessità dell'occupazione militare della Tran sca ucasia. Il maggiore D e l Proposto- come scrive nella rel az ione preparata pe r l a riunione del Consiglio di Guerra durante la quale si sarebbe discussa la questione transcaucasica - era co nv into che lo sfruttamento delle ri so rse della Transcaucasia avrebbe dato a ll ' Italia l' occasione di s upe rare una parte co nsiderevole dei propri problemi economjci. L'occupazione militare avrebbe dovuto proteggere gli interessi che dovevano essere creati al più presto approfittando del grave momento di crisi attraversato dalle industrie locali. Bisognava, ovviamente , evitare di impegnarsi in una onerosa occupazione militare per proteggere interessi a ltrui. Secondo il maggiore la preferenza accordata al capitale italiano in seguito a ll 'occupazione militare, sarebbe s ta ta sufficiente a metterlo in condizione di vincere l'eventuale concorrenza stra niera64
La relazione dell'ex conso le Majoni , regio agente in Ru ss ia meridionale, datata 24 giugno 1919 , che era s tata preparata per la mede s ima ri unione del Consiglio di Gu erra, alla qu a le avrebbe preso parte a nch'eg li , giungeva a co n cl usioni opposte. Majoni e r a co n vinto che l 'occu pa zio ne militare, no no s ta nt e le dichiarazioni dei rappresentanti georgiani a Par igi, no n sarebbe stata accol ta favo revo lm e nte dalla popolazione e d av rebbe costretto l ' Italia ad inte rve nire ne i co nflitti che dilaniavano la regione. Le tre e tni e e rano , da lungo tempo, in lotta tra di loro, per non parlare dei cont1i tt i con il generale Denikin e del pericolo rappresentato dai bolscevichi , che con la l oro p ropaganda avrebbero potuto co nt a min are a nche l 'ese rc ito it a li ano. T rovandosi nel mezzo di questa intricata situazione l ' Italia, co m e era successo ag li In g les i , si s are bbe inimicata g li uni e g li altri:
"non si può preten dere di occ upare reg ioni vital i per uno stato se nza provocare l ' asti o de i danneggiati"65.
in merito all e fo rniture di materiale a Denikin, nel caso fosse real mente avvenuta l a sost ituzi o ne de ll e trupp e brit annich e con quelle italiane. AUS S ME Fondo El l. R. 11 2,Fasc. l 4 .

64 Relazione del m agg iore De l Prop osto Sul problema economico in Transcaucasia. datata 23 g iu gno 19 19, in AUS SME Fondo E8, R. 91, Fase. 9.
65 Relaz ione Majo11i in AUS S ME Fondo El i R III, Fase. 3.
163
La soluzione proposta da Majoni per ottenere concessioni per lo sfruttamento delle risorse in Transcaucasia, prevedeva di agire tramite l'iniziativa privata e le Banche italiane, lasciando fuori l'iniziativa governativa e militare. Una penetrazione pacifica di puro carattere economico che sarebbe stata ben accetta e non avrebbe esposto l ' Italia ai rischi dell'impresa militare. ll console inoltre sottolinea più volte il pericolo rappresentato dallo sv ilupparsi del bolscevismo nella regione, specia lmente sotto la spinta del sentimento nazionale, pericolo che era stato largamente sottovalutato nelle relazioni degli altri esperti e liquidato come pericolo non molto grave
" in questo paese , formato di razze tanto ditlerenti; esso piuttosto che ispirato a ideali sociali, è stato accolto qui come mezzo per liberarsi dal dominio dei russi, e per conseguire l'indipendenza" 66.
Il neo eletto Presidente del Consiglio Nitti, durante la riunione del Consiglio di Guerra del 27 giugno, attestò il gove rno italiano su lle posizioni espresse da Majoni, annullando il progetto di occupazione militare italiana e, mediante la trasformazione della missione militare in regia agenzia politica, promuovendo un progetto di penetrazione economica in grande stile che sarà oggetto dell'azione degli esperti della missione Conti.
8. La missione del senatore Conti
La spedizione del senatore Ettore Conti, consigliere di amministrazione della Banca Commerciale Italiana e presidente della giunta esecutiva del Comitato interministeriale delle industrie di guena, avrebbe dovuto avviare concretamente la pcnetrazione economica che il governo Nitti e ra inten zio nato a promuovere. Tra la fine di dicembre del 1919 e il gennaio dell920 la situazione delle tre repubbliche transcaucasiche, in seguito alla sconfitta del generale Denikin , semb rava esse rsi chiarita e se mpli ficata e quindi il Ministero degli Esteri, n ella perso-
66 Relazione del comandante della regia nave "Roma", datata 29 maggio 1919, trasmessa dal Ca po eli Stato Maggiore della Marina. ammiraglio Thaon di Revcl, al Presidente del Consiglio Orlando, a Sonnino ed al Capo di Stato Ma gg iore dell'Esercito Di az. AUS SME Fondo E Il. R. 110, Fa se . 7 , pag. 8.

164
na di Sforza, ed il ministro Scialoja decisero che era anivato il momento propi zio per l'invio di una missione che non avrebbe più do vuto avere funzione di s tudio quanto il compito di prendere decisioni operative67 . Dalla corrispondenza tra il colonnello Gabba - c he erarimasto a Tiflis in veste di Regio Agente Politico- e Sforza si evi nce come questi non fosse d'accordo con le valutazioni di opportunità del ministero degli esteri ed avesse tentato di scoraggiare l'invio della spedizione del se natore Conti. Gabba aveva rilevato che l'instabilità politica in cui versava la Tran sca ucasia , accentuata dalla sconfitta di Denikin, escludeva ogni possibilità di penetrazione economica s u vasta sca la 68 La risposta di Sforza mi se a tacere con autorità qual sias i dubbio o ripen same nto circa la miss ione Conti. Sforza, in un telegramma del 17 gennaio del 1920, scrive:
"Essendo già s tati pres i tutti i nece ssari accordi e ultimati preparativi impossibi le prorogare partenza mi ss io ne . In v io della quale parmi oggi dopo riconoscimento di codesti govern i non solo opportuno ma urge nte e necessario"69
In Italia s i prevedeva che tra breve tutte le potenz e europee si sarebbero impegnate a prendere posiz ion e, la migliore poss ibil e, nella lotta per lo sfruttamento delle risorse del Caucaso. Sforza dunque confermò l ' invio della mi ss ione e delegò Gabba a preparare un favorevole accoglimento della stessa da parte delle autorità locali , che avrebbero dovuto essere informate dei vantaggi che sarebbero deri vati loro dalla penetrazion e economica italiana. Gabba, inoltre , er a stato incaricato di reperire gli alloggi per la missione a Tiflis e a Baku, di organizzare il trasporto dal porto di Poti alla capitale e di reperire d e lle vetture letto per g li spostarnenti ed i pernottamenti nelle località disagiate 70 . Un te-
6 7 D e Matteo, L., Alla ricerca di malerie prime e nuo vi mercati nelfa crisi poslbellica. L'Italia e la Tramcaucasia 1919- 1921 , Napoli. Is tituto di Studi Filo sofici . 1990, pagg. 11 7-!18.

68 Tele g ramma del colonnello Gabba indiri zzato al mini ste ro degli es teri in data l l ge nnaio 1920.AUSSMEFondo Ell,R.ll4.Fas c. ll.
69 Te leg ramma di Sforza diretto alla mission e ita li ana a Tiflis, datato 17 ge nnai o 1920.AUS SME F ondo El!. R. 113. Fase. 2.
70 Telegramma di Sforza per la mi ss ion e italia na a Tiflis, dell'8 ge nnaio 1920. AUS SME Fondo E l! , R. !! 3 , Fase. 2; telegramma del28 ge nnaio. identico mitte nte c dest inatario , in Telegramma di Sforza diretto all a missione italiana a Tiflis , datato 17 ge nn aio 1920. AUS SME Fo ndo E l! , R. 114 ,Fasc . 13.
165
legramma venne inviato il 28 di gennaio per informare brevemente Gabba s ugli scop i primari della missione, sulla composizione della stessa e sull'itinerario di massima che il g ruppo avrebbe seguito, rinnovando l'i nvito alla massima collaborazione71 .
La missione, che contava sull'appoggio delle quattro maggiori banche italiane, vale a dire il Banco di Roma , la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e la Banca di Sconto, sarebbe stata composta da 40 perso ne- espert i dell'industria, della finanza e dell'agricolturapiù altre 20 persone tra addetti ai servizi e autisti 72 La spedizione partì da Roma il 4 febbraio, sa lpò da Taranto il 6 febbraio a bordo del So/unto per approdare a Poti il 14. La scelta del porto di Poti rispondeva a ragioni di opportunità - nonostante la difficoltà d egh approdi, causata dalla scarsa profondità dei fondali - dato che il porto di Batum era ancora occupato rnilitarmente dagli inglesi e Conti temeva che essi avrebbero potuto intralciare le attività della missione. Il porto di Poti , inoltre, nei programmi del gove rno georgiano sarebbe dovuto diventare il porto più irnp01tante della nazione, data la vicinanza alla capitale, pur non intendendo rinunciare alle rivendicazioni su l porto di Baturn 73 .
Appena arrivato Conti si era preoccupato dei rapporti tra la missione italiana e gli alleati, per tenersi informato su lle loro valutazioni circa il
71 L'itinerario del gruppo di presidenza prevedeva: l. Sbarco a Poti c soggiorno di due gio mi ; 2. spos tamento da Poti a Tiflis in ferrovia c soggiomo di sei g iorni ; 3. t rasfer im e nto da Tifli s a Baku con la ferrovia e soggiorno di sei g iorni: 4. ritorno da Baku a Tifl is e imm ed iato trasferimento a Ereva n , sogg iomo di tre giorn i; 5. spostamento Ereva n-Ai exandropoi - Kars e soggiorno di due gio rni; 6. ritorno da Kars a Tiflis e soggio rno di cinque giorni per concludere affari eve ntu alm e nte iniziati; 7. visite a Kutais, Ciaturi e Tkvibuli. an·ivo a B aturn e soggiorno di tre giorni. l giorni di soggiorno vanno intesi escl ud endo il tempo necessario per gli spostamenti. Il sottogruppo ferToviario, minerario e foresta le svo lgeranno degli it.inerari spec iali. riunendosi co n il gruppo di presidenza a Tiflis, Baku oppure Batum. AUS SME Fondo
E li , R. 114 , Fase. 13.
72 Per la composizione dcllagliata della mi ssio ne vedi tabella ] pag. 172 AUS SME
Fondo El1. R. 112, Fase. 13. Per quanto ri guarda la partecipazione di Benito Mussolin i come inviato del " Popol o d'Ita li a", Mussolini rinunciò all' ultim o momento a prendere parte al la spedizio ne. Cfr. De Matteo, L. , ci t., pag. 123.
73 ln mer ito vedi telegramma del co lonn e ll o Gabba, datato 30 ge nnai o 1920, diretto alla missione militare a Baku. nel quale si informa dell'arrivo della missione Conti previsto per i l 15 febbraio e si chiede autori zzaz ione all'attracco del Sol unto a Poti "che intendiamo fare nostro porto principale··. AUS SME Fondo El l, R. 113, Fase.
2. Cfr. anc he De Matteo. L., cit., pag. 122.

166
futuro politico ed economico delle tre repubbliche e per comprendere l'atteggiamento nei confronti del progetto di penetrazione italiana74 GJj inglesi, durante la permanenza della missione , avevano dato l'impressione cii mal tollerare le attività italiane. Nonostante le assicurazioni formali cii non frapporre alcun ostacolo alla missione, il senato re Conti aveva accertato, anche grazie alla collaborazione dei governi locali, che non erano mancate p ressioni sul governo georgiano per impedire la conclusione delle trattat ive con l' It a lia, quando queste si erano fatte più stringenti. Gli Americani non avevano manifestato particolari attenzioni alle attività della mjssione Conti , anche perché non avendo fiducia nei governi della Transcaucasia non avevano alcun interesse nella regione, ma si limjtavano a tutelare i propri interessi economjci, concentrati soprattutto nelle industrie petrolifere cii Baku. La Francia, al contrario, aveva mostrato un interesse maggiore per la missione italiana che per lo sfruttamento della regione. C'erano, infatti , mo lte iniziative private francesi che non erano mai approdate dalla fase cii progettazione a quella cii realizzazione75 .
Gli aspetti economici, industriali, logistici, analizzati dalla missione Conti ricalcano quelli già trattati dagli esperti della mjssione militare e li approfondiscono, riportando in alcuni casi le variazioni intervenute nei sei mesi che intercorrono tra le due. In partico l are la missione Conti s i occupò de ll a ques tione economica e monetaria: di quella ferroviariarilevando un ulteriore peggioramento sia per le strade ferrate che per l 'usura ciel materiale rotabile- e delle comunicazion i strada l i, aeree, navali e telegrafiche; de ll e inclusuie petrolifere - notando una te nde nza alla concentrazione delle grandi imprese a capitale stranie ro76 ; de l pro -
74 Come si evince anche dalla tabella l l 'Avvocato Baisin i era stato incaricato di tenere i rapporti con il Comando ing lese di Batum e con l'Alto Commissar io Wardrop.
AUS SME Fondo E li , R. 114 , Fase 13.
75 De Manco, L, ci t., pagg. 126- 127.
76 La conce ntrazione de lle gra ndi ditte, in atto già dal 1917, serviva per difendere i propri invest ime n ti dag li ins id iosi rivolgimenti politici ed economici del per iodo. La Relazione Co nt i port a ad esempio la recente fus ione del gruppo Nobe l con il g r uppo Lianosoff che ins ieme si assicuravano il dominio della maggior parte della produzione Secondo Co n ti, comunque , le concentrazioni , dato il momento di crisi, non esc ludevano la possibilità di partecipazione di cap ita l i stranieri che avrebbero assicurato anche u lt eriore protezione diplomat ica contro i possibili rivolgimenti politici. La partecipazione italiana avrebbe dovuto , da una parte inserirsi in questo processo eli concentrazione, dall'altra acquistare da privati, piccoli proprieta1i e industriali minori le concessioni petro l ifere, vista l a grande d i fficoltà di ottenere concess ion i governative. De Matteo. L. cit. , pag. 146.

167
blema forestale ed agricolo - sottol ineando il possibile ruolo delle cooperative agricole per la riorganizzazione del settore - occupandosi in particolare della ripresa del settore cotoniero; del potenziamento del porto di Poti che necessitava di alcuni interventi urgenti - compreso il dragaggio dei fonda i i per render! o accessibile a navi di maggiore tonnellaggio - per poter essere utilizzato come porto principale per gli scambi con l'Italia , sostituendo quello di Batum occupato dagli Ingle s i. La missione affrontò anche la questione dell'opportunità di stabilire un regolare t1usso migratorio di lavoratori italiani verso il Caucaso. Una prima analisi era stata effettuata nell 'ottobre del 1919 da un commissario generale dell'emigrazione, che aveva espresso il convincimento che sussistessero larghi spazi per l'emig razione italiana, ma non prima di aver dato impulso alle industrie di ogni settore come lasciavano sperare i progetti e l'attività preparatoria degli enti italiani. Il commissario indicava come plausibile l'inizio del flusso migratorio in primavera. Conti giunse al contrario a conclusioni del tutto negative a riguardo. Innanzi tutto il rapporto tra popolazione e superficie coltivabile era assolutamente inattendibile, i 2/3 del territorio della Transcaucasia erano risultatiad una più attenta analisi - non adatti allo sfruttamento agricolo a causa dell'altitudine, perchè coperto da foreste o deputato allo sfruttamento minerario , oppure- era il caso dell'altipiano armeno- costituito da steppe sterminate. Le terre adatte allo sfruttamento agricolo, prevalentemente in Georgia , erano già saturate dalla manodopera locale che necessitava solo di assistenza tecnica e materiali. Dati anche i costi bassissimi della manodopera locale , sia agricola che industriale , con·isponclenti a 3 o 4 lire giornaliere, l ' Itali a avrebbe dovuto limitarsi all'invio eli tecnici specializzati per i s in goli settori, molto capaci e molto remunerati77
Nelle trattative della missione con i governi delle tre repubbliche per ottenere l e forniture di materie prim e per l ' Italia, Conti rilevava che i governi sembravano interessati ad ottenere i prestiti c le forniture che avrebbero consentito loro di sfruttare le proprie risorse, ma erano molto restii a rilasciare concess ioni rinunciando alle proprie prerogative statali ed, inoltre , avevano la tendenza a sopravvalutare il valore delle proprie materie prime, non valutando sufficientemente che, non avendo i mezzi per sfruttar le, le risorse erano di fatto solo potenziali; tale politica avrebbe portato unicamente ad un rialzo del prezzo dei manufatti e delle attrezzature fomite dalle imprese it a lian e.

168
77 De Matteo, L., ci r pagg. 133- 134.
La proposta della missione Conti era quella di creare un grande ente italiano che fosse finanziatore ed esecutore di tutti i programmi di sviluppo della regione. Avrebbe dovuto essere organizzato in molteplici rami autonomi coordinati da un organismo centrale che avrebbe dovuto garantire il massimo vantaggio economico per le imprese italiane ed il risanamento economico e industriale della Transcaucasia. L 'e nte avrebbe dovuto costituire fin dall'inizio un istituto bancario, che divenisse il finanziatore delle imprese in progetto; un ente commerciale che avrebbe dovuto incrementare gli scambi tra l ' Jtal ia e la Transcaucasia; un ente forestale per lo sfruttamento delle arce boschive acquistate dai privati oppure ottenute dai governi a garanzia d e i prestiti; un ente petrolifero per amministrare le concessioni ottenute dai governi e gestire i po zzi che fosse stato conveniente acquistare; un ente per sfruttare le miniere di carbone e di rame; un organismo per la gestione del se ttore dei trasporti c del porto di Poti 7 8
La costituzione dell'ente avrebbe richiesto, per la realizzazione del programma massimo di penetraz ion e economica, un capitale di 500 milioni di lire, 450 milioni sa rebbero sta ti destinati ai prestiti per le tre repubbliche che, comunque, s arebbero stati erogati in un las so piuttosto lungo eli tempo. La situazione politica e le incerte pros pettive future rendevano l'ipotesi eli massima penetra z ione alquanto improbabile, se le grandi potenze europee non si fossero impegnate a garantire la s tabilità dell'area. La proposta eli Conti eli cominciare con un programma di pcnetrazione economica limi tato acl 115 delle risorse, è la dimos trazione delle difficoltà incontrate dalla missione a li ve11o di trattativa e della necessità di procedere con gradualità c cautela. Il programma di penetrazione minima che, comunque, non sarebbe stato suffic ient e a garantire la supremazia italiana nella regione, avrebbe richiesto l'impiego di almeno 100 milioni di lire, per la creazione dell'ente con obiettivi inizialmente limitati , quali l'attuazione dei contratti eventualmente conclusi e l ' avvio degli scambi commerciali, per poi ampliare il raggio d'azione dell'istituzione fino al programma massimo di penetrazione. I prestiti sare bbero stati erogati direttamente dall'ente, mentre le relative operazioni bancarie sarebbero avvenute tTamite un 'unica banca che si sarebbe dovuta creare tramite la fusione dell e iniziative degli istituti bancari italiani che già operavano ne ll'area: Banca Commerci a le, Banco di Roma , Banca Italian a di Sconto e Credito Italia-

78 De Matteo , L. , cit., pagg. 158- 159. 169
no 79 .
Anche questo progetto non era unanim emente a ppreaato, l 'is tituto piLt contrario alla creazio ne de li·ente e della banca unica era la Banca Italiana di Sconto, che era la più attiva nella reg ione - tramite la Banca Italo-Caucasica - c che aveva meno da g uadagnare dalla creazione della nuova en tit à economico-finanziaria.

11 bilancio conclusivo de ll 'attività svolta dalla missione Conti, soprattutto se si considerano g li obiettivi operativi c he erano stati posti , fu comp letamente in sodd isface nte. Non a causa di scar so impegno da parte dei partecipanti ma della situaz ione nella quale si trovarono ad operare. Di fatto. inve ce che co ncludere trattative c prendere decisioni ope rati ve, si trovarono ancora una vo lta a dover proporre ai governi locali, peraltro come si è detto piuttosto restii a qualsiasi concessione, programmi e progetti che presupponevano condizioni politiche ed economiche ancora tutt e da realizzare. La prova più evidente del fa llim ento della missione era costitu ita dal drastico ridimensionamento dei pro getti italiani e dalla modestia delle iniziative effettivamente assunte dalle imprese italiane. Anche i giorna listi che accompagnavano la missione. in particolare Lui gi B arzini e P ietro Nenni, non mancarono di o ttolineare nei loro articoli. i ri sc hi e le difficoltà politi che delle tre repubb l iche che sconsig liavano qualsiasi tipo di inv estime nto.
I membri della missione rientrati in Italia, dopo circa 40 giorni eli permanenza in Transcau cas ia, non diedero seg ni di risposta alle sollecitaz ioni del co lonne ll o Gabba, c he attendeva direttive per riprendere le trattative con il governo dell'Azerbaijan e seg nalava una ripresa dell'attività economica in g lese e francese. Gabba , inoltre, riteneva utile l'invio di una missione di tecnici in Armenia per la riorganizzazione econom ica, finanziari a, ferroviaria e telegrafica per non correre il rischio di arrivare in ritardo rispetto ai concorrenti europei 80 . con i quali le imprese italiane - dopo l'abbandono de l pro ge tto di occupazione mi lit are - si trovavano a confrontars i ad armi pari invece che da una posizione di privilegio.
Il 27 a prile 1920 una rivoluzione a Baku portò a ll a proclcunazione della repubblica sovietica di Azerbaijan. il giorno s ucc ess ivo Baku fu occupata, su invito del governo, dalle truppe bolsceviche. Ques to nuovo rivol gime nto oltre a creare problemi alle ditte che operavano nella regione
79 l bidem. pagg. 167-168.
80 Telegramma del co lonnello Gabba al ministero degli esteri a Roma, datato 15 aprile 1920. AUS SME Fondo E Il, R. 114, Fase. 13.
170
vanificò i programmi della Compagnia della Transcaucasia. Il 29 novembre 1920 a nche in Armenia venne proclamata la repubblica social ista .
La Georgia. che rimaneva l'unica superstite. aveva da poco concluso con i sovietic i un trattato molto g ravoso. che aveva più il carattere di un a nnistizio che di una pace. Il 27 gennaio 1921 la Georgia ottenne in extremis il riconoscimento de jure da parte delle potenze europee, per il quale il governo georgiano aveva profuso tantissimi sfol7i, ma che non fu sufficie nte ad arrestare l 'ava n za ta bolscevica. L'invasione vera e propria iniziò il 16 febbraio 1921 e dopo una settimana di resistenza la Ge orgia capitolò. Il 25 febbraio fu ufficialmente proclamata la repubblica socialista. Comunque, il progetto di p e nctrazio n c economica in gra nde stile e ra stato abbandonato già in seguito alla bolscevizzazionc dell' ALcrbaijan. Qualche impresa privata era riuscita ad entrare in affari con i nuovi gove rni ma la ma ggio r parte dovette fare i co nti con le grav i perdite subite e reclamare crediti nei confronti dei vecchi e dci nuovi governr.
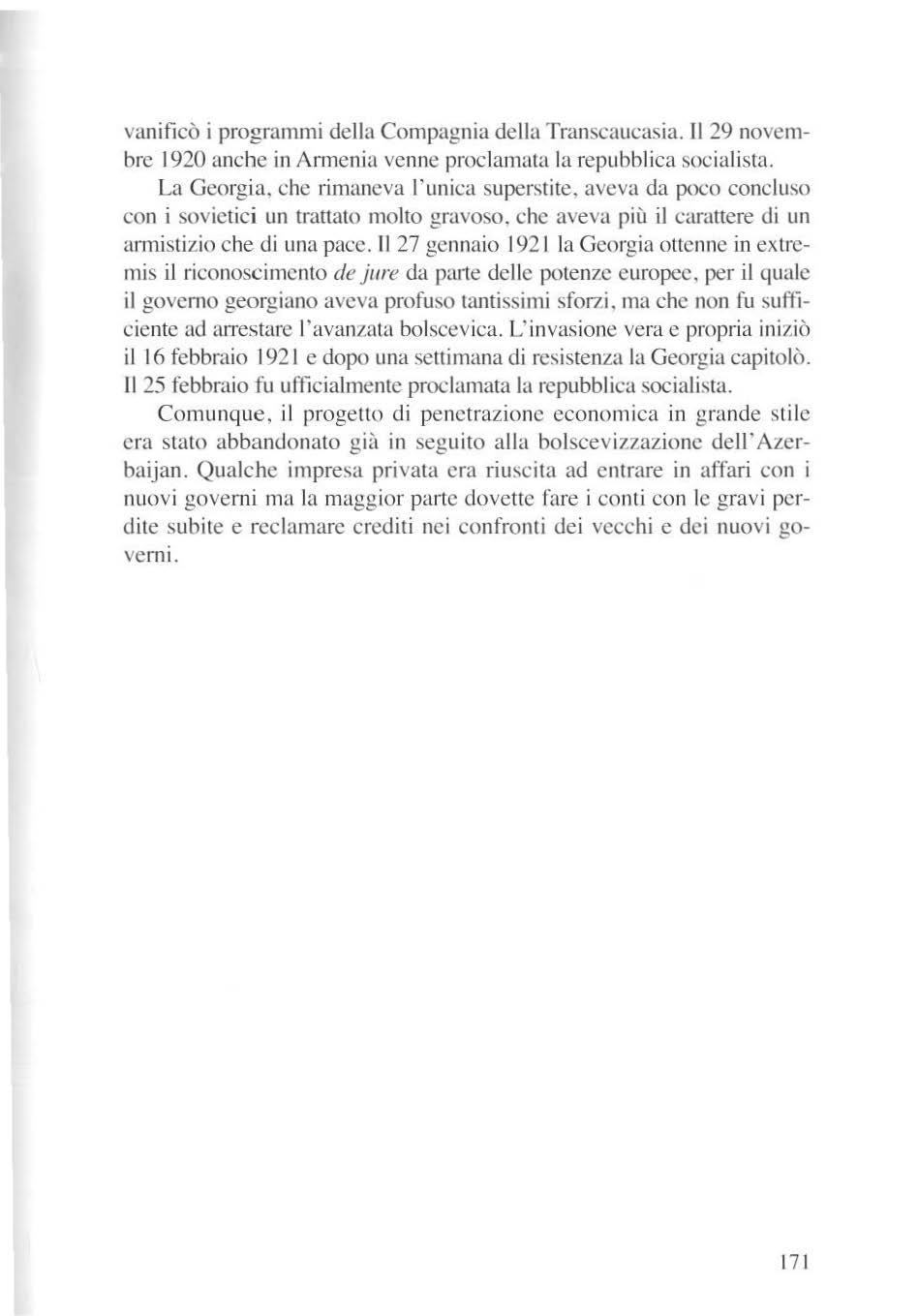
17 1
Tabella l- Composizione della missione Conti a l 31 gennaio 1920
S. E. Senatore Ettore Conti Presidente
Commendatore Arturo Mercanti Segretario Generale
Commendatore Giovanni Cesare Majon i Delegato Ministero Es teri
Giulio Cesare Andriull i G iornalista
Angelo Arcangelo Minatore
Ingegnere Silvio Bassi Commercio agricolo
Avvocato Vittorio Baisini Collegamento col Comando inglese
Luigi Barzini Giornalista Corriere della Sera
Achille Benedetti Giornalista Giornale d'Italia
Ingegnere Arnaldo BoreJJa Costruzioni
Avvocato Corsello Re Finanza (in v iagg io indipendente per Baturn)
Avvocato Albe1to Corsi Commerc io
Cavalier Cesidio Del Proposto Miniere
Giuseppe D'Alessandro Capo R .T. l l clas s e
Commendatore Fiastri Ordinamento ferroviario
Ingegnere Materiale fenoviario
Commendatore Giovanni Gattini Tesoro - Cambi
Piero Gadda Segretario
Ingegnere Maddaleni Nafta
Avvocato
Rinaldo Majno Finanza
Marchese Massimiliano Mainoni Segretario d'lntignano
Ingegnere Luioi Malvezzi Costruzioni
Emilio Manzi Fè Segretario
Vittorio Masc itti Interprete
Dottor Luigi Mazzucche ll i Finanza
in gegnere Ariberto Merendi Foreste
Ben ito Mussolini Giornalista Popolo d· !tal ia
Massimo Notari Giornalista
Professor Vittorio Novaresi Miniere
Dottor Vittorio Ottina Economo
In gegne re Camillo Parisini Foreste
Cavaliere Michele Pinto Finanza
Venceslao Pizzorno Trazione
Ulderico Sacchetti Minatore
ln geg ner Cavaliere Fran cesco Salvi n i Trazione
Cavaliere Pao lo Savi Interprete
Henrick Toeplitz Finanza
AUS SME Fondo Ell, R . ll2. Fase. /3
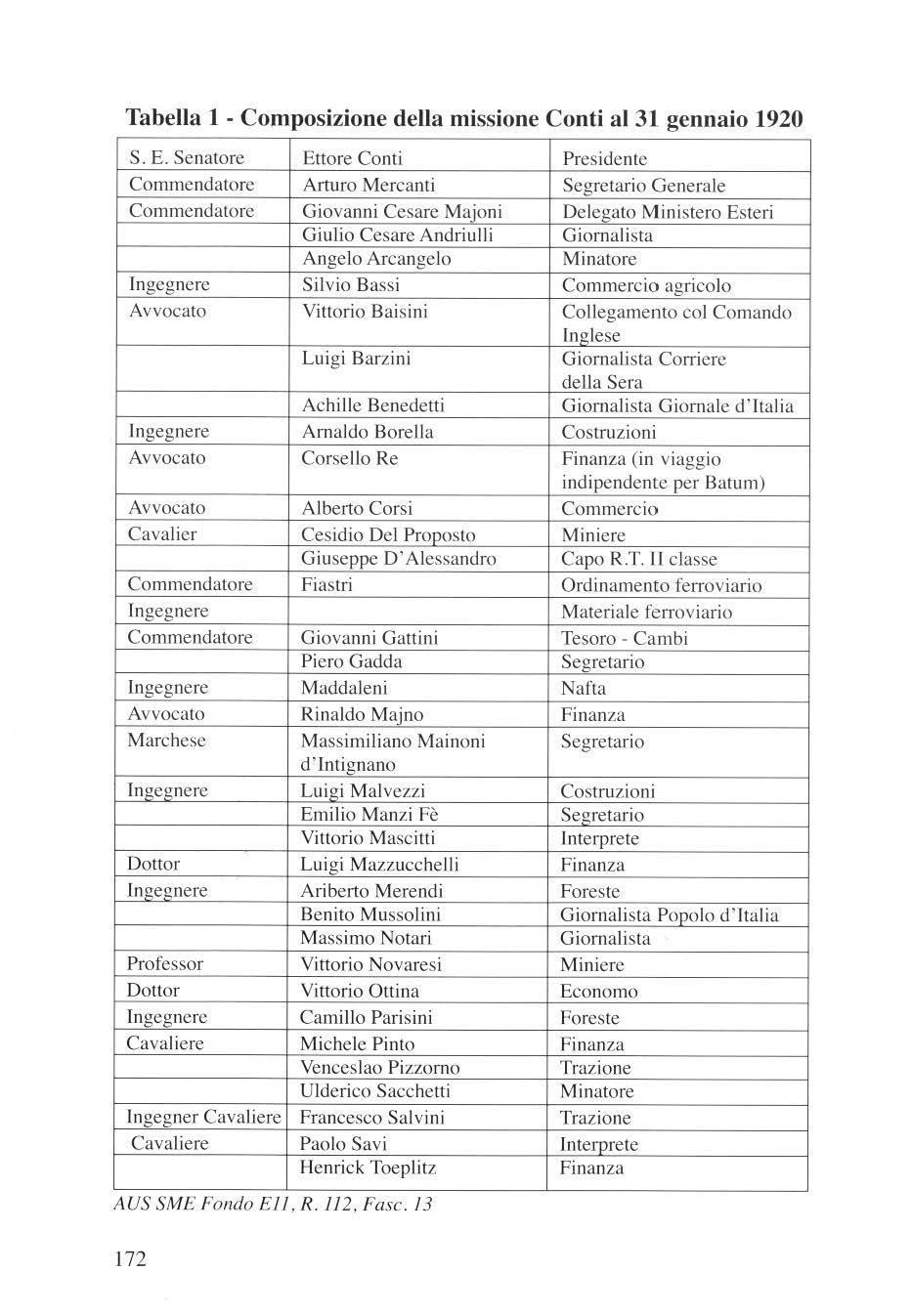
172
FONTI D ' ARCHI V IO
I documenti analizzati per que sta ricerca provengono esclusivamente dall'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, in Roma.
I Fondi consultati sono:
- Fondo E 11 dal Raccogli tore l 08 al 116
- Fondo E8 Racco g l itorc 5
- Fondo E8 Raccoglitore 20
-Fondo E8 dal Rac coglito re 36 al 38 (Diario sto ri co)
-Fondo E8 dal Raccoglitore 84 al 92
- Fondo E3 Raccoglitore 246 (32)/4
- Fondo L3 Raccoglitore 57 Fascicolo 11 (studi speciali)
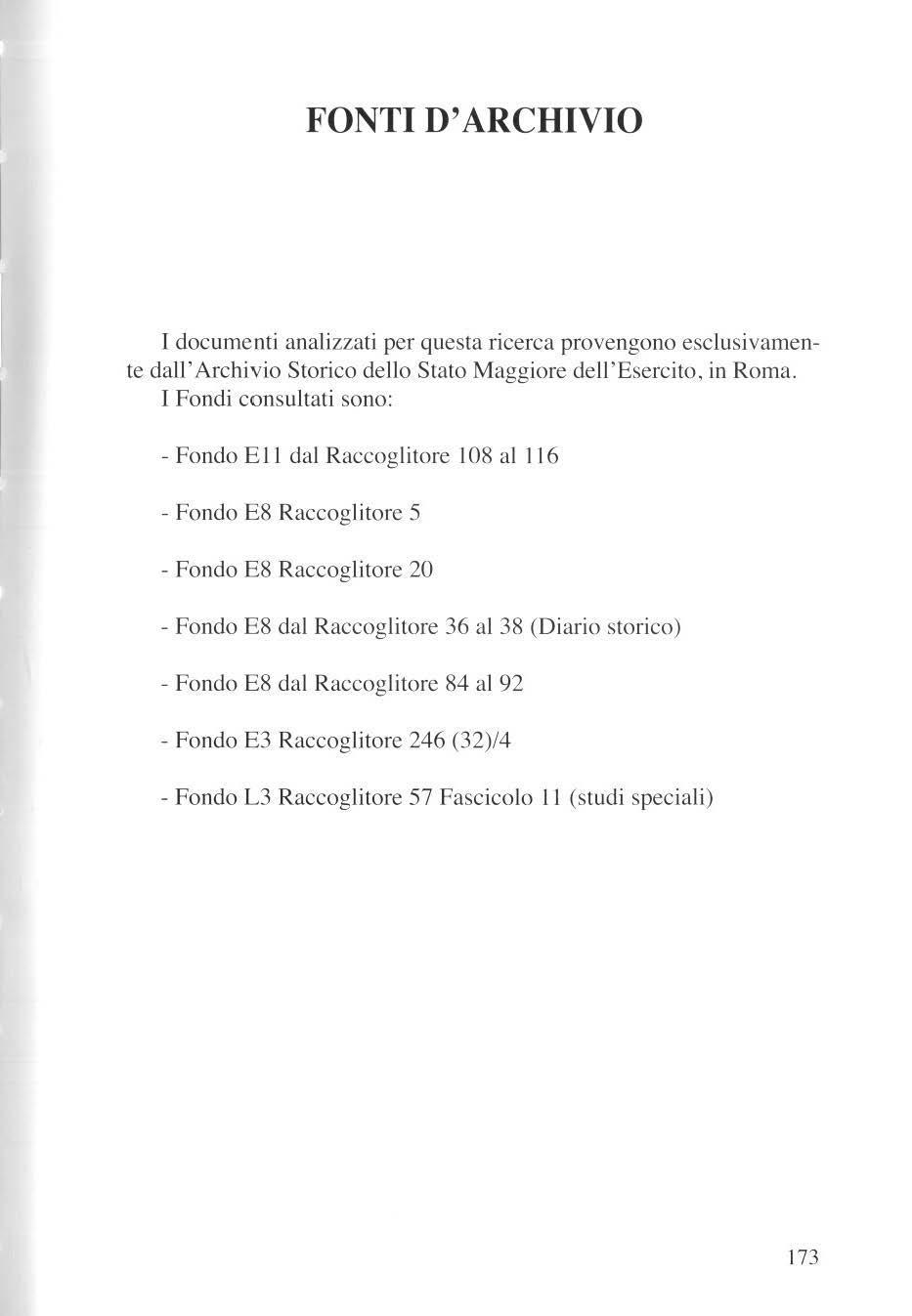
173

BIBLIOGRAFIA
Te st i:
Aldrovandi-Marcscotti, L., Guerra diplomatica, Milano, 1936
Biagini, A., Storia della Turc hia Contemporan ea, Milano , Bompiani, 2000
Biagini , A. In Rus.'iia tra guerra e rivolu zione . La missione militare italiana ( 1915-1918), Ufficio Storico SME, Roma , 1983
Caccamo , F., L'Italia e la "Nuova Europa ", Milano , Luni editrice, 2000
Carr, E. H , La Rivolu z ione bolsce vica 1917- 1923, Torino, 1979
Chamberlin, W. H. , Storia d e lla Rivolu zio n e Ru ssa, 2 voli. Torino, 1943
Chernov , V. , The Great Russian Revolution, New Haven, 1936
Curato, F., La Conferen z a della Pace 191911920, vo ll 2, Milano , 1942
D ' Amoja, F., Declino e prime crisi del!' Europa di Versailles. Studio sulla diplomazia italiana ed europea ( 7931-1933), Milano, Giuffrè, 1967
De Mattco , L., Alla ric e rca di materie prim e e nuovi mercati nella crisi postbellica. L'Italia e la Transcaucasia 1919 -1921, Napo li , Istituto di Studi Filosofici, 1990
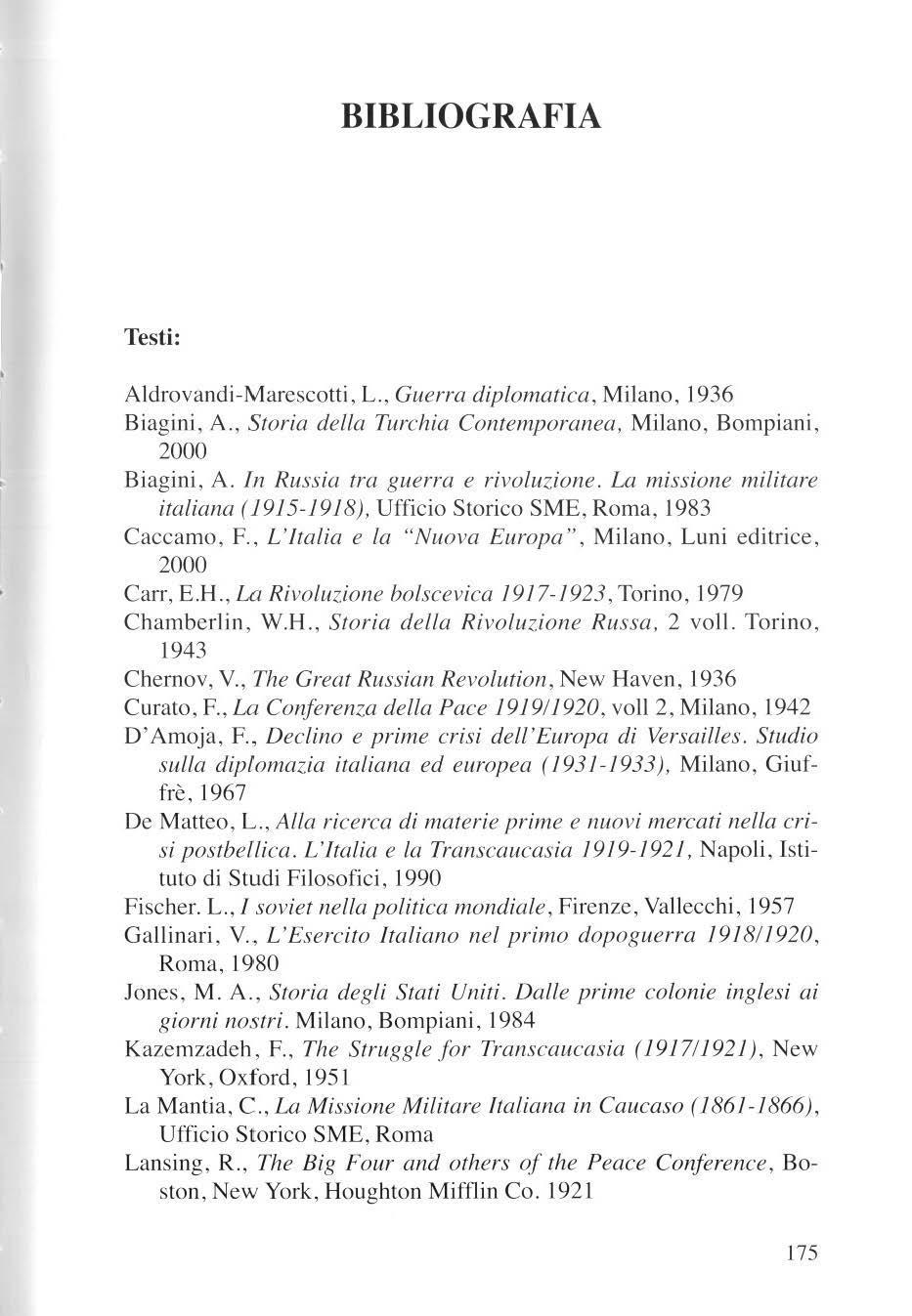
Fischer. L. , l soviet nella politica mondiale, Fi renze, Ya ll ecchi, 1957
Ga ll i n ari, V., L ' Esercito I taliano nel primo dopoguerra 1918/1920, R oma, 1980
J o nes, M . A., Storia degli Stati Uniti. Dalle prime colonie inglesi ai giorni nostri. M il a no, Bo mp ia ni , 1984
K azemzade h , F. , The Struggie far Transcaucasia (19171 1921), New York , O xf ord, 195 1
La M an ti a, C., La Missione Militare It aliana in Caucaso (186 1-1866), U ffi c i o Storico SME, R oma
L a ns in g, R. , The Big Four and others of the Peace Conference, Bosto n , New York, H o ug h to n Miffli n Co. 1921
175
Lan s in g, R ., The Peoce negociations. A personal narrative, London, Constable & Co. 1921
Monticone, A .. N i Ili e la Grande Guerra. Milano. 1961
Nicolson, H. , fast plwse, London, 1934
Nitti, F.S., La D ecaden-:.a dell'Europa, Firenze. 1922
Nitti, F.S., Rive la zioni Dramatis Personoe, Napoli, 1949
Nitti. F.S Scritti Politici Vo/.1- L'Europa Pace. B ari. Laterza. 1959
P astorelli, P., Il Principio di nella politica estera italiana. in: ··Nazione e nazionalità in Italia '· a cura di Gio vanni Spadolini, L ate rza. Bari , 1994
Pastorc lli. P., La politica estero italiana dal 1914 al 1943. Torin o. E.R.T., 1963
Pctracchi, G., La Russia nella Politica italiana 19171925, Bari, 1982
Petri cio li, M. , L'Occupa7.,ione iwliano del Caucaso: Un '' ingrato servi-;.io" da rendere o Londra. in "Il Poi itico", Pa via. Fase. IV. 1971. Fase. l , 1972
Pip cs, R., Il Regime bolscevico. Da/terrore rosso alla morte di Lenin, M i la no, Mondadori, 2000
Pi zzigallo, M., Alfe origini della ricerca petrolifera italiana 19201925, Milano, 1981
Rau ch (von), G., Storia della Russia sovietica, trad. il. Milano. 1965
Ricc ard i , L. , Alleati non amici. Le relazioni politiche tra l'Italia e l'Intesa durante la prima guerra mondiale, M orce lliana. Bresc ia , 1992
R ochat, G .. L'Esercito italiano da Viuorio Veneto a Mussolini ( 19191925), Bari, Laterza, 1967
Roman c lli, G., Biag ini, A. (a cura di), Nell'Ungheria eli Bé/a Kun e durante l'occupa z ione militare romena. La mia missione (maggionovernbre 1919), Ufficio Storico SME, R oma, 2002
Salandra. A., l Retroscena di Versailles, a cura di G.B. Gifuni, Milano, 197 1
Serra , E., Nitti e la Russia, Bari , 1975
Sforza, C., L' I talia dal ' 14 al '44 quale la vidi io, Verona. 1946
S ir Hc nry Wilson, Journal, Pari s, 1929
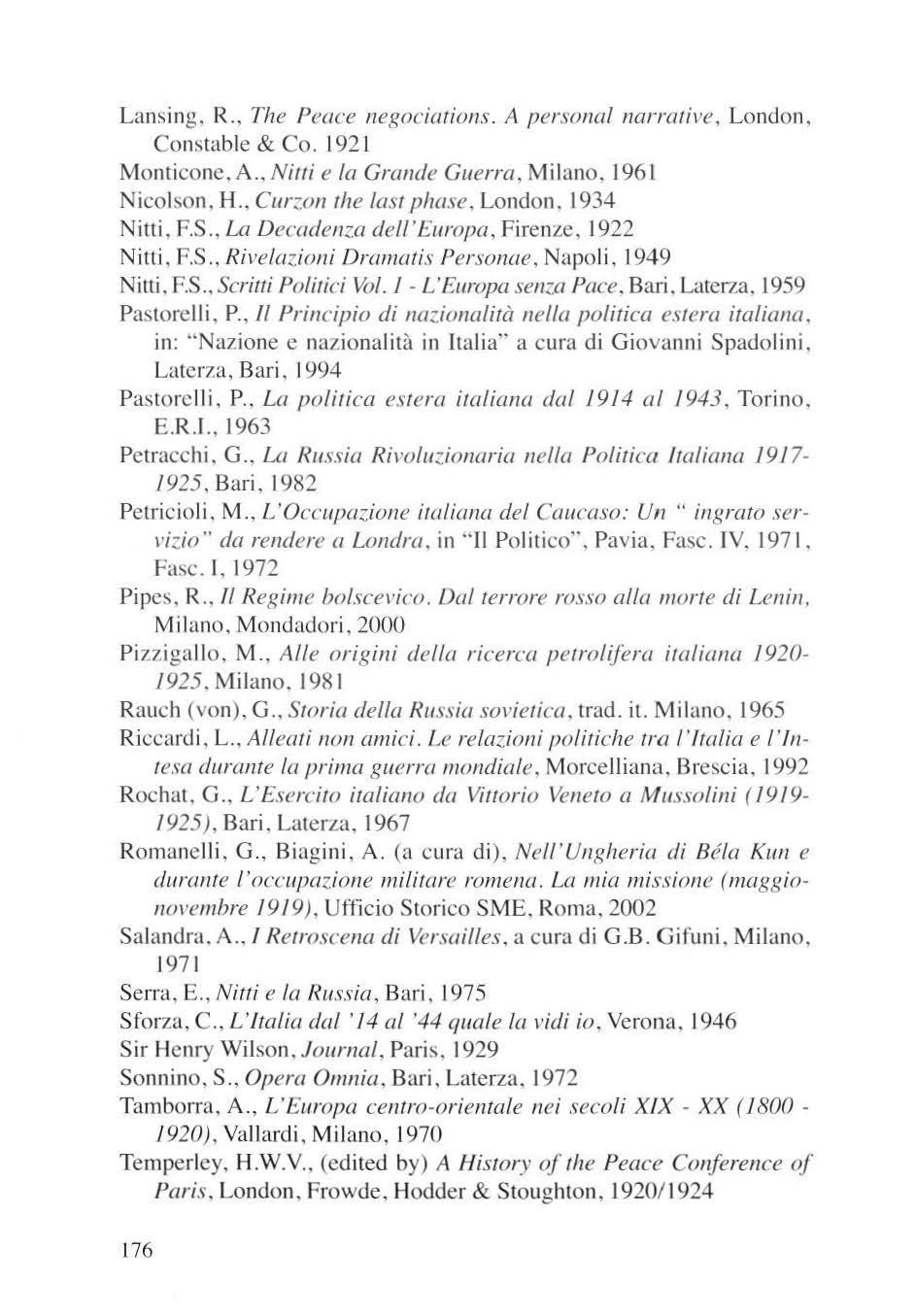
So n nino, S., Op era Omnia, Bari , Laterza, 1972
Tambon·a, A., L'Europa centro-orientale nei seco li XIX- XX (18001920), Vallardi , Mil ano, 1970
Temper ley, H.W.V., (ed ited by) A Hi story of the Pea ce Conference of Pari s, London , Frowde, H odder & Stoughton, 1920/ 1924
176
Toscano , M ., Gli accordi di S. Giovanni di Mariana. Storia dipl omatica dell 'intervento italiano ( 1916-1917), Giuffrè. Milan o. 1936
To sca no , M., Le cause d e lla Grande Gu er ra e i residui bellici del Trattat o di Versaglia, in: Prob le mi stori ci e orientamenti storiografici, Como. 1942
We bs tcr, R .A .. L'Imp erialis mo industriale italiano. Srudi o sul Prefascismo, 1908-191 5, Torino , 1974
Wh ee ler- Bc nnet. J. W .. Brest - Litovsk rh e Forgotl e n P eace March 1918,London. 1956
Rivi s te:
D e Matt eo,L., L ' Eco nmnia della Transcaucasia n elle rela z ioni della Mis s ion e militare italiana Gabba (1919), in Nuova Rivista Storica. P erug ia , Vo l. LXX III. 1989
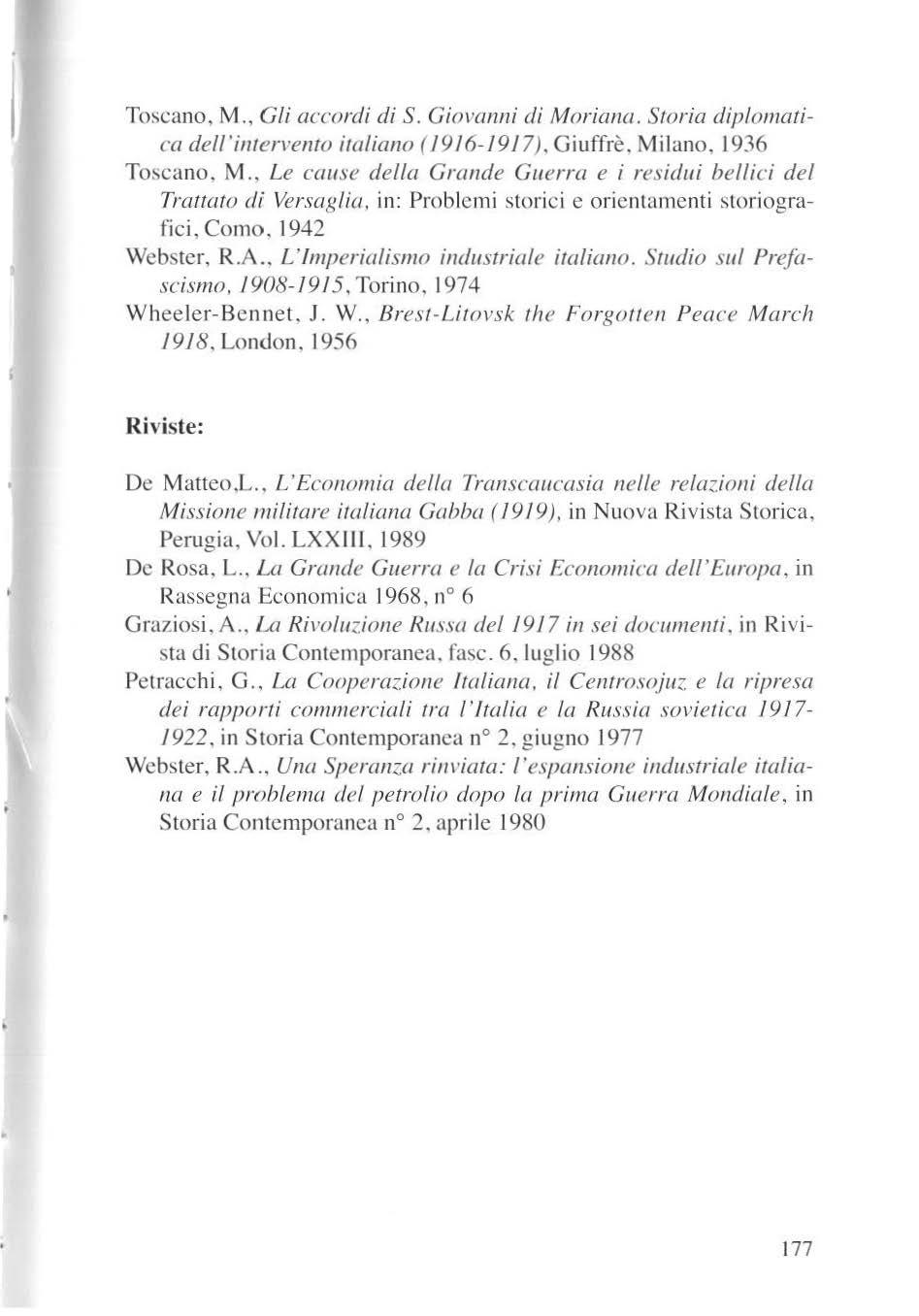
Dc Ro sa, L ., La Grande Guerra e la Crisi Economica dell'Europa, in Ra sseg na Economi c a 196 8, n° 6
Graz io s i. A ., La Ri vo lu :. i one Ru ssa del 191 7 in sei documenti, in Rivis ta di Storia Contemporanea. rase. 6, lu gl io 19 88
Pe tracchi , G., La Coop e ra zi one It aliana, il Centrosojuz e la ripresa dei rapporti commercia li tra l'italia e la Ru ssia sov i e ti ca 19171922, in Storia C o nt emporan ea no 2. g iu g no 19 77
Wcbs ter , R .A., Una Speranza rilll' iata: l'espansione industriale italiana e il problema del petroli o dopo la prima Gu e rra Mondiale , in Storia Contempor a nea no 2. ap rile 19 80
177

INDICE DEI NOMI DI PERSONA
Adani; 125
Aharonian; 75
A
Aimone di Savoia ; 97; 119; 125; 144
A1bricci; 11 4
Aldrova ndi ; 28; 29; 3 1; 89
Andriulli; 172
Arcange lo; 172
Atat urk ; 81
Atto1ico ; 110 B
Badoglio; 40 ; 94; 101; 104 ; 105; 106
Bais ini ; 167 ; 172
Bal fo ur ; 17; 22; 38; 66
Barberis; 119; 125
Barzilai ; 24; 26
Barzini ; 170; 172
Bass i; 172
Bass ignana; 73
Belin ; 33 ; 34
Be nedetti; 172
Bli ss; 35
Bonin Lo ngare; 27
Sore ll a; 172
Borghese; 22
Briand; 66
Brough ; 132
Buchanan ; 47
Bu kharin; 50
Bu s in ell i; 33 c
Cadorna ; 11; 93
Castoldi; 25; 104
Cavallero; 24; 33; 89; 107; 108 ; 109; JJO: 111; 116
Cavig li a; 87; 97; 109 ; 110
Ch icherin; 56
Chio ss i; 126
Chkhenkeli; 54; 55; 56; 58
Clemenceau; 11 ; 12; 15; 17; 20; 23:26;29;30;66
Coardi di Carp eneto; 125; 128
Co losi mo ; 103: 112
Conti; 12 1; 162; 164; 165 ; 166: 167: 168 ; 169; 170 ; 172
Cook ; 105; 106 ; 125; 129; 130; 133
Corsello Re; 172
Corsi; 172
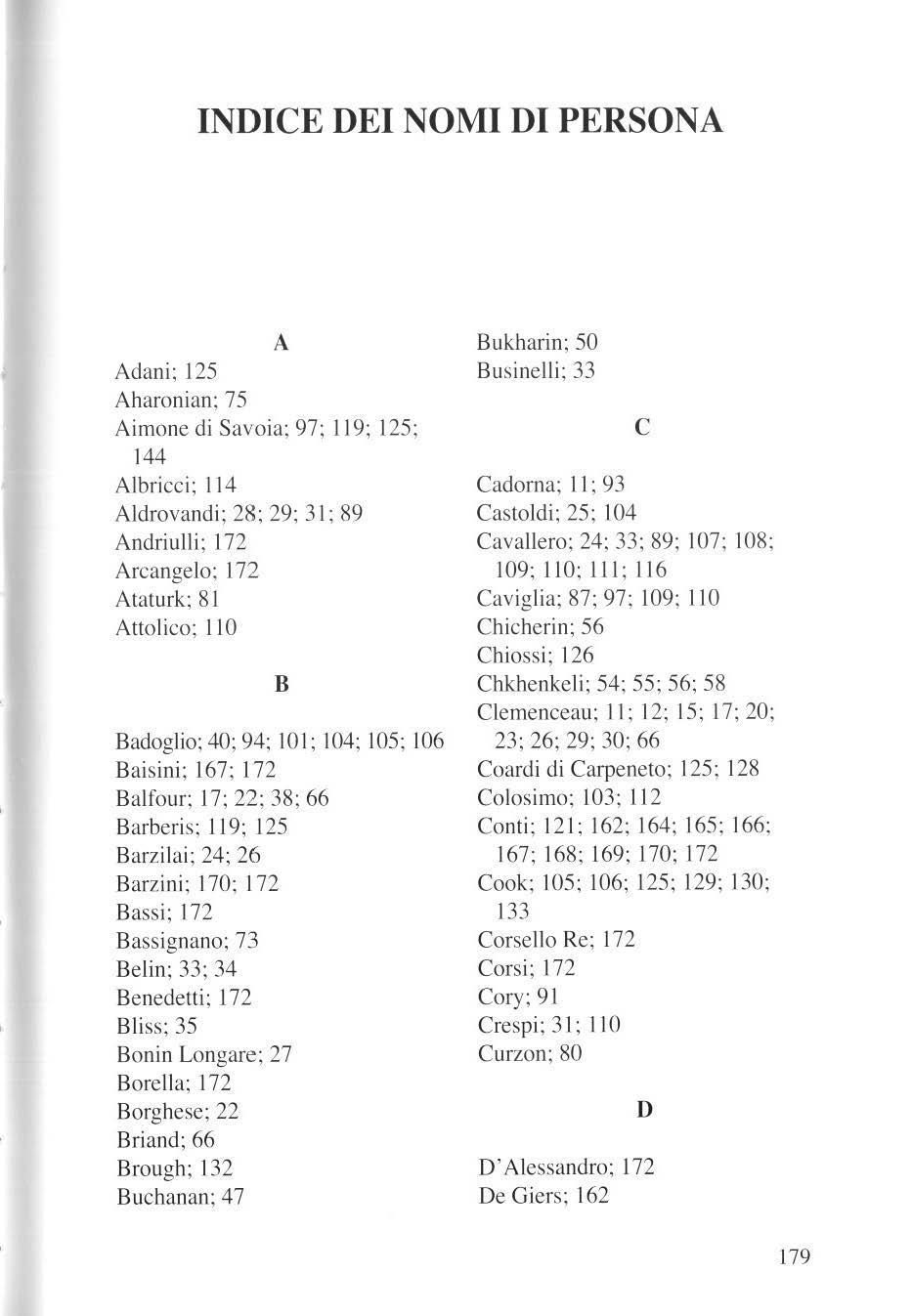
Cory; 91
Crespi; 3 l ; 11 O
Curzon; 80
D ' Al essa ndro ; 172
De Gi ers; 162
D
179
De Lore nzi; 109
De Martino; 21; 25; 110
Degli Albi zz i; l 30
Del Proposto : 125; 128; 133; 134; 135 ; 136; 137; 138; 139; 148 ; 149; 159; 163; 172
Denikin; 5; 60; 69; 70: 71; 73; 74:
75; 78; 79; 80; 8 1; 99; 102; 103; 115: 119; 124:1 27: 140; 161; 162: 163; 163; 165
di Robil a nt; 11; 33; 35 : 37; 38; 40
Diaz; 24: 40; 90: 93: 95; 96; 10 l ; 102: 104: 105; 107: 108: 109; 110; Ili ; 114 ; 133 ; 164
Dukhonin ; 46
Dun stervi ll e; 60; 61
G iardino; 11
Gra nafci; 73; 77: 78; 119; 125; 144; 145: 146: 147
Gra ssi: 109
Harbord; 76
Hoffmann; 51
Housc; 17: 27
ln som; 1.25; 130
Jordan; 65
J ordania: 58
Fazi; 125; 133
Fi as tri; 172
Fi ore; 79
Foch ;8 1
Fracchia; 125; 128
Kavtaradzc; 84
Kere ns kij: 46
Key ncs; 22
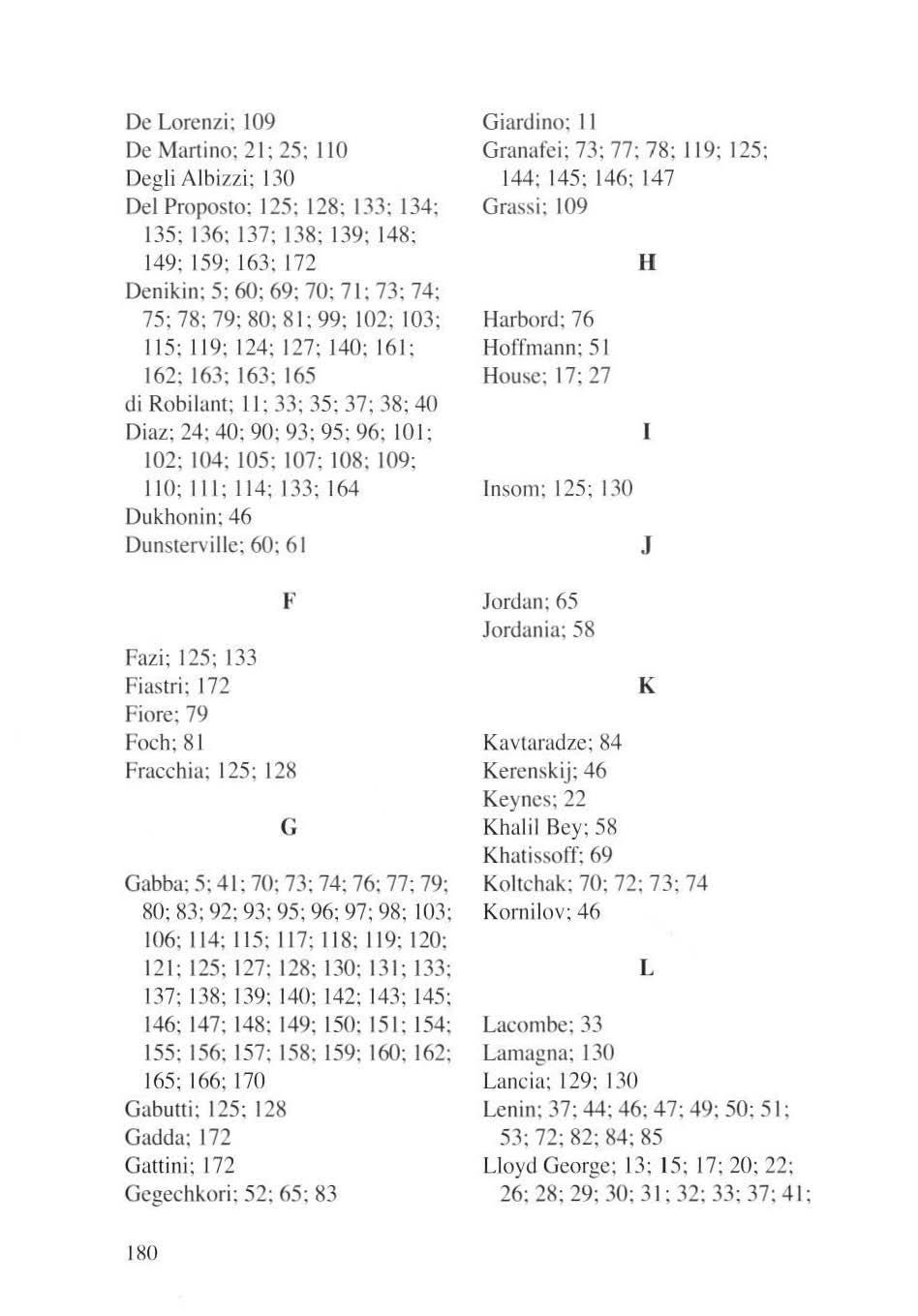
Khalil Bey; 58
Kh atissoff: 69
Gabba;5:41;70:73:74:76;77;79; 80;83;92;93;95;96;97;98; 103 ;
;
;
; 151: 154:
155: 156; 157; 158: 159: 160 ; 162; 165; 166; 170
Gab utt i: 125: 128
Gadda; 172
Ga ttini ; 172
Gcgechkori; 52: 65: 83
Ko1rehak:70;72;73;74
Korni lov; 46
L
Lac ombe: 33
Lam agna; 130
Lanci a; 129 ; 130
Le nin: 37 : 44:46: 47: 49: 50 : 51:
53;72;82;84;85
Lloycl Georg e; 13 : 15 ; 17; 20:22: 26:28;29:30;31:32:33;37:41;
F
G
106: 114
115: 11 7; 118
121;
137
138; 139;
; 11 9: 120 ;
125; 127; 128; 130; 13 1; 133;
140; 142; 143; 145; 146; 147; 148: 149: 150
180
H I .J K
66: 87; 88; 89; 100: 110
Lochridgc; 33 M
Maddalcni; 172
Mainoni d'lntignano: 172
Majno; 172
Majoni; 114: 141: 163; 164; 172
MalveZL.i; 172
Manz i Fè; 172
Marcone: 125; 133
Marcora: 142: 157: 158
Matchiabelly: 144
Mazzucchelli: 172
Melikif: 147
Mercanti; 172
Merendi: 119:125:129:133:144:
147: 151:152:153: 154: 155:
156; 157; 172
Miche1i: 92: 97: 118: 125: 128: 130
Miliukov: 44
Milne; 39: 90
Mombelli: 104: 108
Mussolini: 94: 166; 172
N
Nenni ; 170
Nicola Il ; 43:44
Nitti; 33; 41:76: 77; 80; 88; 107; 111: 112; 11 3; 11 4; 115; 11 6: 118: 162; 164: 172
Notari; 172
Novarese; 11 9; 125; 128; 133; 140;
141: 142: 143: 144: 145: 146:
147; 149; l 50
Nova resi; 172
Nubar Pasha: 75
O ldani; 128
Ordzonikidze: 85
o
Orlando; 15; 16; 17; 24: 25; 26; 27; 28;29:30;31:32;40;41;81;87; 88: 89: lOO; 101: 103: 107: 110: 111; 112; 113; 164
Ottina: 172 p
Palmieri; 130
Pantaleoni; 125
Panta loni: 129: 130
Pariani: 108
Parisini; 172
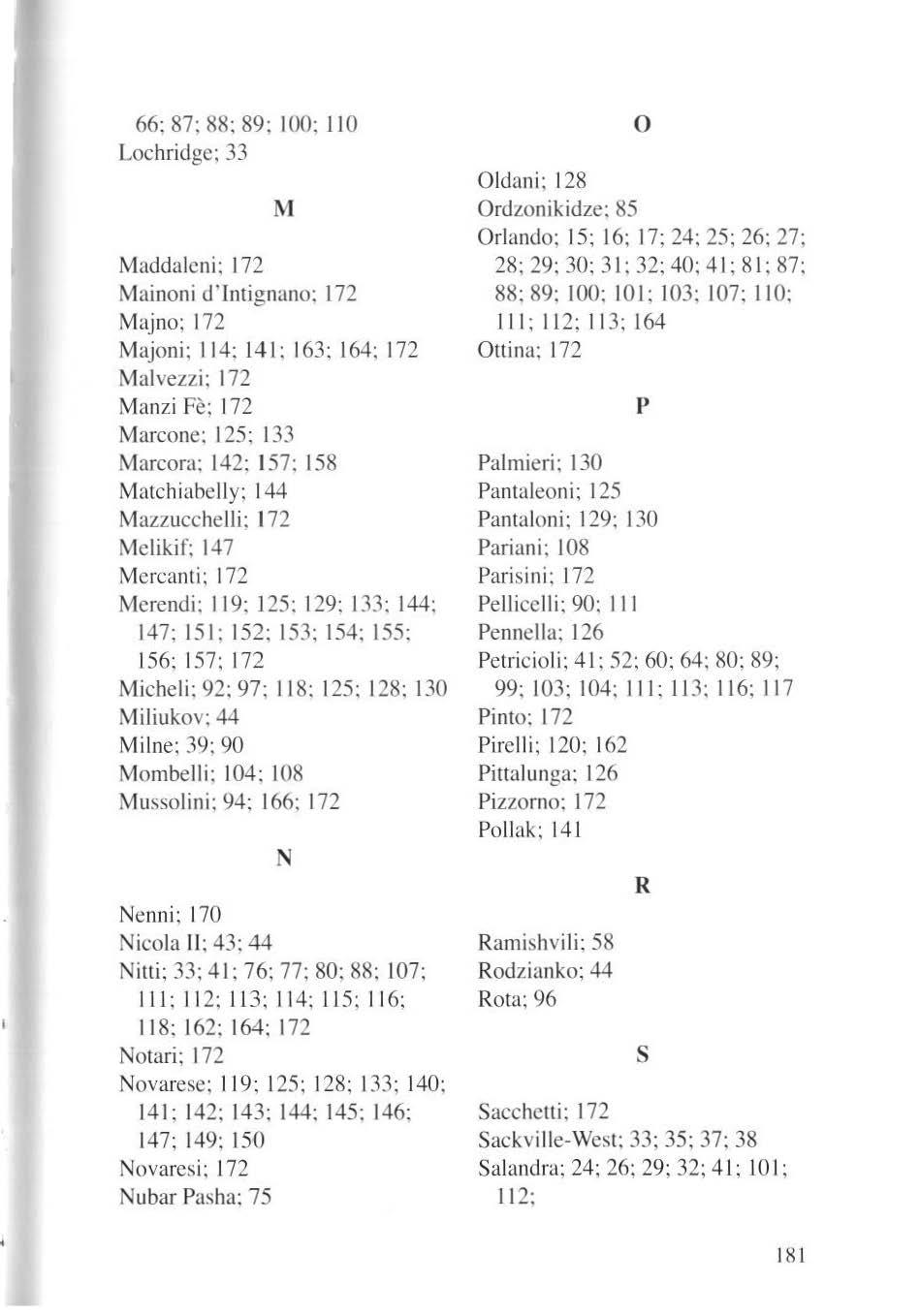
Pellicclli; 90: 111
Pennella: 126
Petr ic io li; 4 1; 52; 60; 64; 80; 89; 99; 103:104:111:113: 116; 117
Pinto: 172
Pircl 1i; 120; 162
Pitta1unga: 126
Pizzorno: 172
Po ll ak; 14 1
Rami s hvili; 58
Rodzianko; 44
Rota; 96
R s
Sacchetti; 172
Sackville-Wcst: 33; 35; 37:38
S al and ra: 24: 26; 29; 32; 4 1; 10 l ; 112:
181
Salata: 26
SalaLar: 97
Sal vago Raggi: 24
Salvini; 172
Savi: 172
Sazonov; 74: 162
Schanzer; 114
Scialoja; 120: 165
Sechi: 114
Sforza: 13; 79: 80; 98: 99: 103 : 120; 165
Sonnino: 13: 15:21:24:25:26:
27:31:32:40;41:81: 103:109:
Il O; 111; 11 2: 162; 164
Spokes: 125
Stokes: 96
Stranieri; 25
T
Tardieu; 14
Tch erb atskoi: 79
T haon di Revel: 27; 107: 114: 164
Thomson;33:62;63:64; 100
Thu rl ow: 92
Th waitcs: 89: l 07: 108: l09: 110:
Ili; 116
Titto ni ;32;33;4 1; 111 ; 112; 11 4; 115: 116; 117; 11 8; 120
Toepli tz ; 172
Tom as i Della Torretta; 25: 100
Toni; 92
Trotsky; 46: 47: 48: 49: 50: 51 v
Vehib Pascià; 53; 55
VeniLelos; 22: 116
Vita; 125: 129: 159; 160; 161
Vittorio Emanue le III : 103 von Lossow; 56: 58 w
Wardrop: 167
Wilson; Il; 12; 13; 15; 16: 17; 21; 23;25;26:27:28:29:30;32;35: 62:70:72:76:89:90:91: 103; l 07; l l l : 119
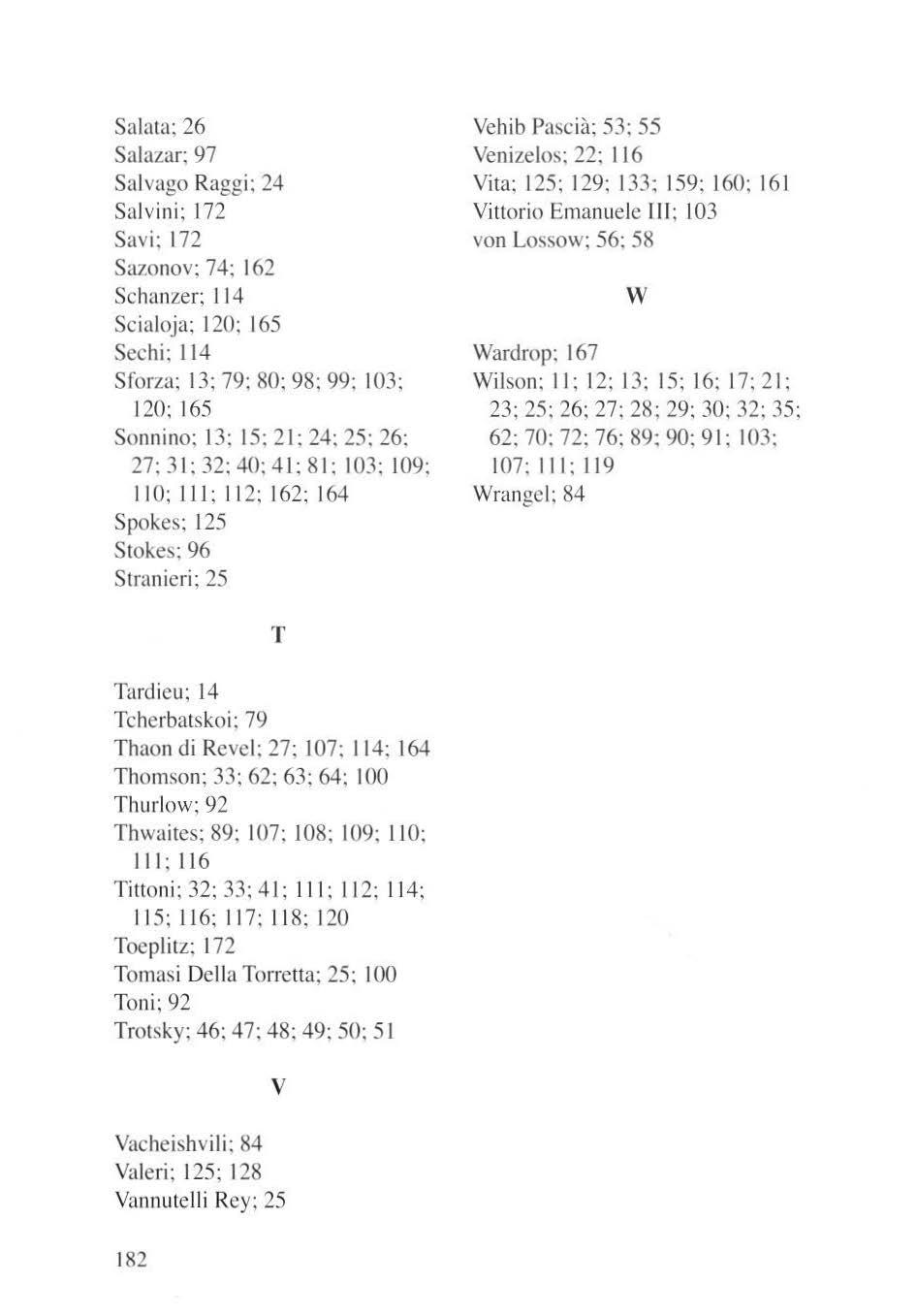
Wran ge l: 84
Vacheishvili: 84
Valeri; 125 ; 128
Vannut ell i Rey: 25
182
INDICE DEI NOMI DI LUOGO
A
Abano: 93: 104
Adalia: 40
Adana: 38: 39; 75
Adriatico; 14; 26; 30
Africa; 33
Akha lk alaki;56;68:91; 102: 122; 123
Albania; 14; 26: 10-t
A lexandropol: 132: 134: 166
Alpi; 25; 26: 29 : 32
AlsaL.ia-Lorena; 12
Alto Adige; 25
Anakla: 153
Anatolia; 14;21 ;5 1:5 3;83: 116
Angora: 40
Annavir: 132
Pulne nia:5:8;37;38;39:53;56:
59:62:63:66:67;68:69:74:75:
76:80;82;83; 84;86:93:99: 119:
120; 130: 132: 135: 157: 170: 172
Asia; 8; 20; 34; 40; 64; l Ol: 138
As ia Min ore; 20; 22; 3 1; 32
Au tria; 17; 18; 25; 29; 32: 47
Aydin; 14
AL.erbaijan: 5; 52; 54: 55; 58: 59:
62:63:64: 67:68;69: 74:77:
80:81;82:84:86:93;95;99:
102; 116: 120; 121:130:131:
135; 138; 139 ; 140 ; 15 9
Bakouriani; 132
Baku;40;52;54;59;60;61;63:
65; 66; 78; 82; 89: 9 1; 100 ; 118;
121; 122; 123: 124; 127; 132;
134 ; 136; 137: 138; 139; 140 ;
141; 156; 157: 159; 160; 166: 170
Balcani; 104

Baltico; 52: 141
Banato; 15
Batum; 40; 52: 50: 55; 56; 58; 59:
63;65;66;84:85;88;89;90;91; 93; 97; 101; 11 8: 119; 122; 123;
124: 127; 128; 132; 134; 136 ;
137; 138; 144; 148; 149 ; 150;
156; 166: 167: 168: 172
Belgio: 24; 31
Bessarabia: 72
Borjom: 132
Borthalinsk: 102
Brennero; 14 ; 32
Brest-L itov sk; 43; 47; 48; 50; 53;
54;56;58;6 1;62;99; 101
Budapest; 47
Bzid ; 102 c
Camp ofo rmi o; 29
Caporetto; 24; 93
B
183
Caspio: 61; 75; 81; 90; 95; 134
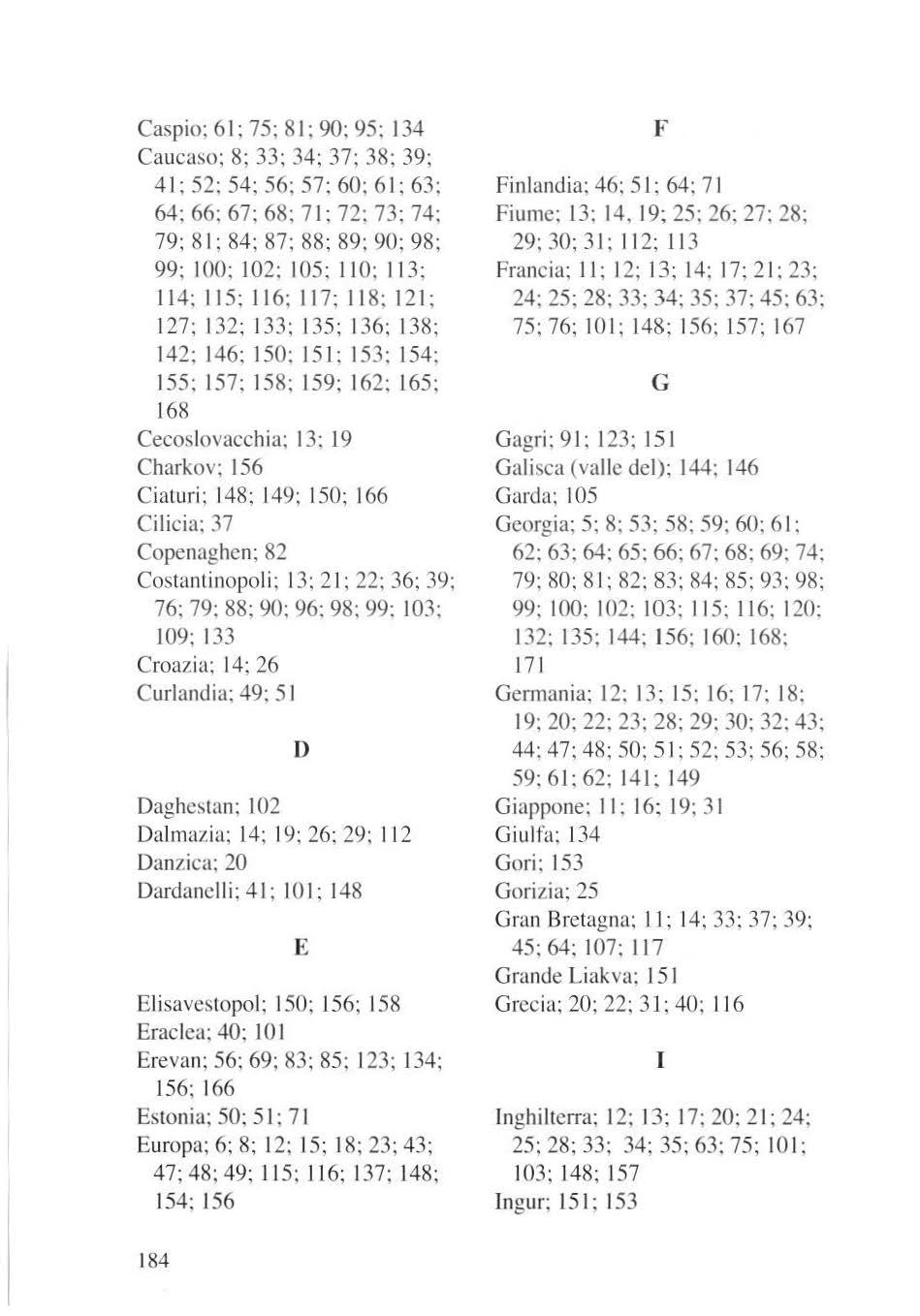
Caucaso;8;33;34;37;38;39; 41 ;52;54;56;57;60;6 1;63:
64;66:67;68: 71 : 72: 73:74;
79;8 1;84;87; 88;89;90;98; 99; 100; 102; 105; IlO; 113; 114: 115; 116: 117; 118; 121; 127 ; 132; 133; 135; 136; 138;
142; 146; 150; 151; 153: 154;
155: 157: 158: 159: 162: 165:
168
Cecoslovacchia; 13; 19
Charkov; 156
Cia tu ri; 148; 149; 150; 166
Cilicia: 37
Copenaghen;82
Costan t inopoli; 13; 21; 22; 36; 39; 76:79:88:90:96:98:99:103: 109; 133
Croazia; 14; 26
Curlandia: 49: 51
Finlandia: 46; 51; 64; 71
Fiume: 13: 1·+. 19; 25; 26: 2ì: 28; 29; 30; 31; 11 2; l 13
Francia; 11; 12; 13; 14; 17; 21; 23; 24;25;28;33;34;35:37:45:63:
75; 76; 101; 148; 156; 157; 167
Gagri: 91; 123: 151
Gali sca (valle del); 144: 146
Garda; 105
Georgia; 5; 8: 53; 58; 59: 60: 61: 62:63;64:65;66;67:68:69:74:
79;80;81;82;83;84;85;93;98; 99; 100:102:103: 115; 116:120:
132: 135; 144: 15 6: 160; 168:
171
Germania; 12: 13; 15; 16; 17: 18: 19;20;22:23:28:29:30;32:43; 44;47;48;50;51;52;53;56;58; 59; 61: 62; 141: 149
Dagh estan; 102
Dalma zia; 14; 19; 26; 29; 112
Danzica: 20
Dardan el li;41 ; 101; 148
Giappon e; Il: 16: 19; 31
Giu lfa: 134
Gori ; 153
Gori zia : 25
Gran Bretag na; Il ; 14; 33; 37; 39; 45: 64: 107; 117
Grande Liakva: 151
Elisavestopo l ; 150; 156; 158
Eraclea: 40: IO!
Erevan; 56; 69; 83; 85; 123; 134; 156; 166
Estonia ; 50; 51; 71
Europa ; 6; 8; 12; 15; 18 ; 23; 43;
47: 48; 49; 11 5: 116; 137; 148;
154: 156
Grec ia; 20; 22; 31; 40: 11 6
Inghilterra; 12: 13; 17:20: 21; 24: 25; 28; 33; 34; 35; 63; 75; 101; 103; 148; 157
ln gur: 151: 153
D
E
184
F
G
I
l stria; 14: 25: 29
Italia; Il; 12; 13; 14: 17; 18:20;21; 22;23:24:25;26;27;28;29;30;
31;32;33;34;35;38:39:40;4 1; 45;76;77; 78; 87:88:92;93;95; 100: 104 ; 115 ; 116 ; 117: 12 1; 127;
134; 137: 142; 147: 151; 154; 155:
156: 157: 158; 159: 162: 163: 164; 165: 166: 167; 168: 169; 170
Jeka tcrinodar; I 27
Ju gos lavia; 13; 30 K
Ka cheti; 156
Kakhetie; 132
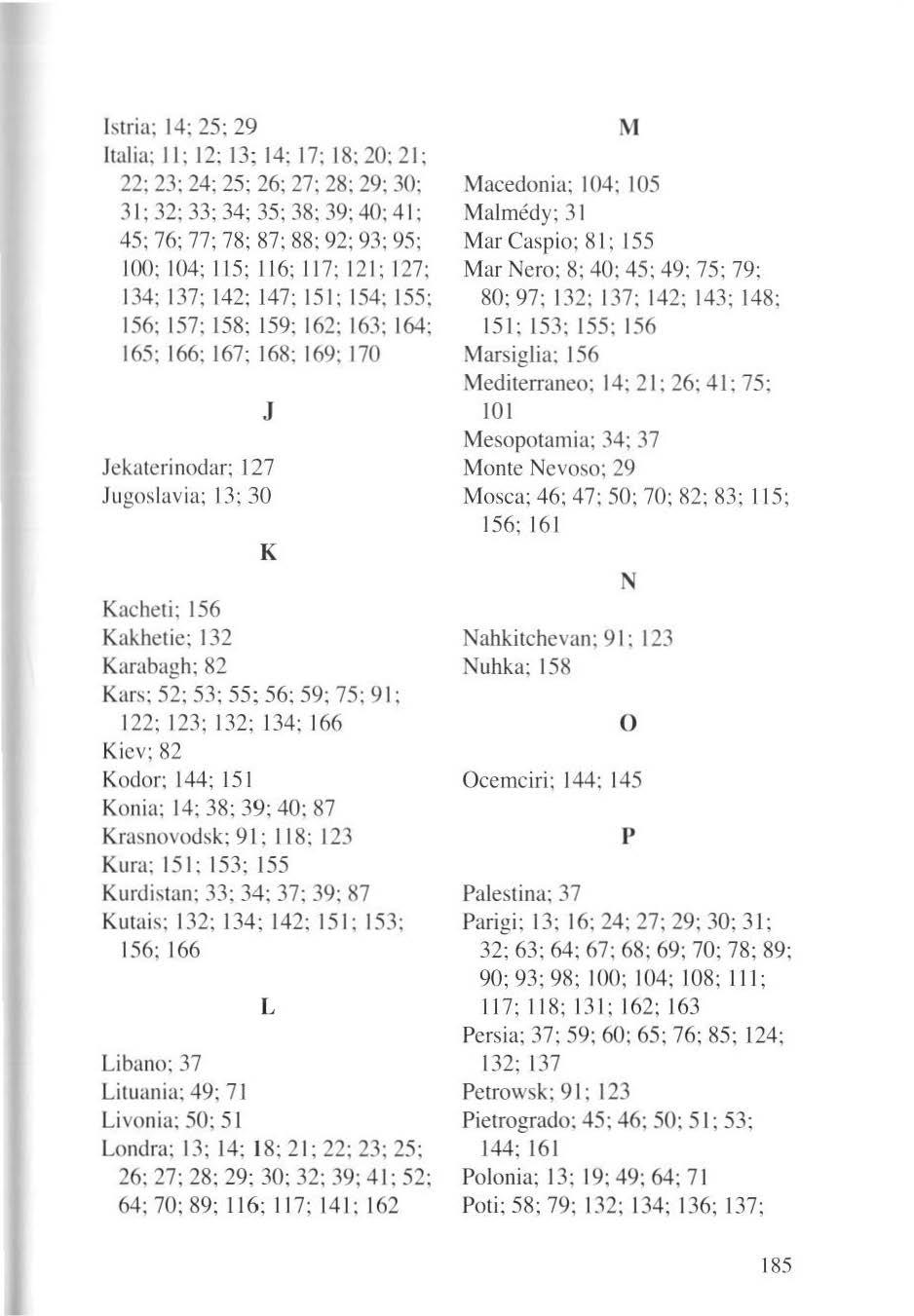
Karabagh; 82
122; 123; 132; 134; 166
Ki cv; 82
Koclor; 144; 151
Konia; 14: 38; 39: 40: 87
Kra s novodsk;91: 118:12 3
Kura; 151; 153:155
Kurdi s tan; 33: 34; 37; 39: 87
Kutai s: 132: 134; 142; 151; 153; 156; 166
L
Macedonia; l 04; l 05
Malmédy; 31
Mar Caspio; 8 1; 155
M ar Nero: 8; 40; 45; 49; 75; 79; 80; 97; 132; 137; 142: 143; 148: 151:153:155:156
M arsiglia: 156
Mediterraneo: 14; 21: 26: 41: 75: 101
Mesopotamia; 34; 37
M on te Nevoso; 29
Mosca;46;47 ;50;70;82;83; 11 5; 156: 161
Nahkitchevan; 9 1: 123
Nuhka; 158
O cemci ri ; l 44: 145
Palestina; 37
Parigi; 13; 16:24;27;29;30;31; 32;63;64;67;68;69; 70;78;89; 90; 93; 98; 100 ; 104 ; 108 ; 111; 117: 118 ; 13 1; 162; 163
Libano: 37
Lituania; 49; 71
Li vo nia; 50:5 1
Londra: 13; 14: 18; 21; 22; 23: 25; 26:27;28;29 : 30;32; 39;41:52; 64:70 : 89; 116; 117 ; 141:1 62
Pers ia; 37 : 59; 60; 65; 76; 85; 124; 132; 137
Petrowsk; 91: 123
P ietrogrado: 45: 46; 50; 5 1; 53; 144; 161
Polo ni a; l 3: 19; 49; 64; 7 1
Poti ; 58; 79; 132; 134; 136; 137;
J
M
N
o
p
185
145; 148: 149; 153: 165: 166: 168 ; 169
Renania; 12
Reno;22; 23
Rion; 151: 15 3
Ri or: 134
Roma: 9: 18; 21; 31; 89: 92; 94;
109: 143; l 62: 166; 17 0
R oma ni a; 13: 20: 30
Rostoff: 132
Rus s ia ; 8; 13: 14: 15; 18; 20: 21; 22; 15:41:43:44;45:46:47;49:
51;52;56;59:63;66; 70; 71;72:
73; 74;76;81:82;83;84:85:
100:113:114:115: 116; 141; 156; 157: 158: 162: 163
Sudeti: 20
Sukkum; 144; 156 T
Taranto; 89; 96: 97: 105: 106: 108: 109: 119: 133: 166
Tchiatouri; 132
Telavc: 132
Teschen; 15
Tifli
S. Giovanni di M or iana ; 14; 20; 22:25:70
Saar; 12
Samtredi; 134
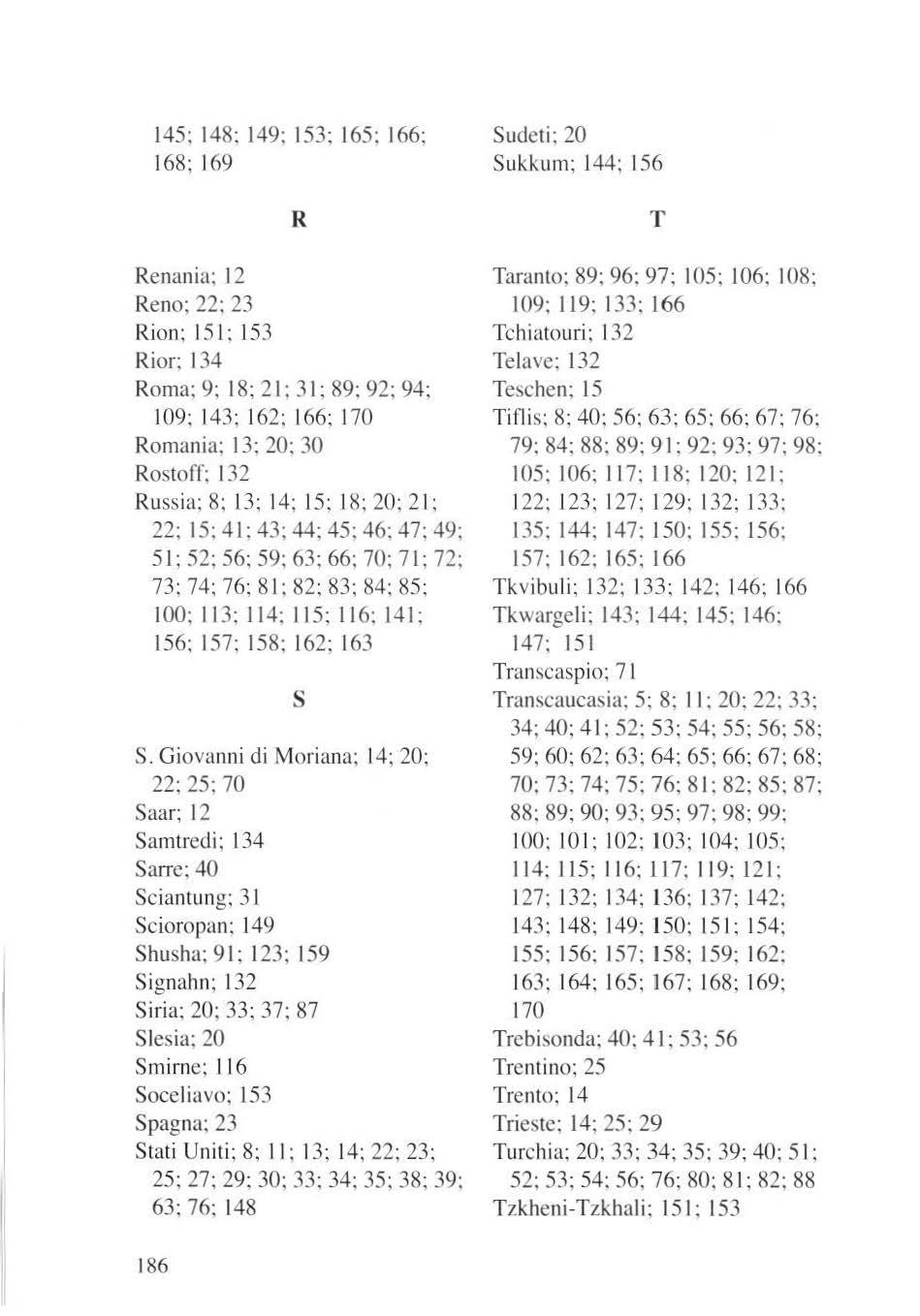
Sarre: 40
Sciantung; 31
Scioropan: 149
Shusha; 91: 123: 159
Signahn; 132
Siria;20:33;37;87
Slesia: 20
Smirnc; 116
Soceliavo; 153
Spagna:23
Stati Uniti; 8; Il ; 13; 14; 22; 23; 25;27:29;30;33;34:35;38;39; 63; 76; 148
Tkwargc1i; 143: 144; 145; 146: 147: 151
Transcaspio; 71
Tran scaucasia: 5; 8: Il: 20; 22: 33:
34;40;41:52:53:54;55;56;58;
59:60;62;63;64;65;66;67;68:
70:73:74:75: 76;81:82;85:87:
88:89;90;93;95:97:98:99;
100: 101; 102; 103; 104; 105 :
114: 115; 116: 117: 11 9: 121:
l 27: 132 ; 134; 136 ; 137; 142;
143; 148; 149 : 150; 151; 154 ;
155: 156: 157: 15 8: 159: 162:
163; 164; 165; 167: 168; 169 ;
170
Trcbisonda: 40: 41: 53; 56
Trcntino; 25
Tre nto: 14
Trie te: 14: 25: 29
Turchia ; 20; 33; 34: 35: 39; 40; 51:
52;53;54:56;76:80;81;82;88
Tzkh eni -Tzkhali: 151:153
R
s
186
105; 106; 117: 118: 120: 121; 122: 123: 127; 129; 132; 133; 135: 144: 147: 150: 155: 156: 157: 162: 165: 166
132; 133; 142; 146
s; 8; 40; 56: 63; 65; 66; 67; 76; 79:84;88;89:91:92:93:97:98:
Tkvibuli;
; 166
Ucraina; 47: 50; 51; 83: 156
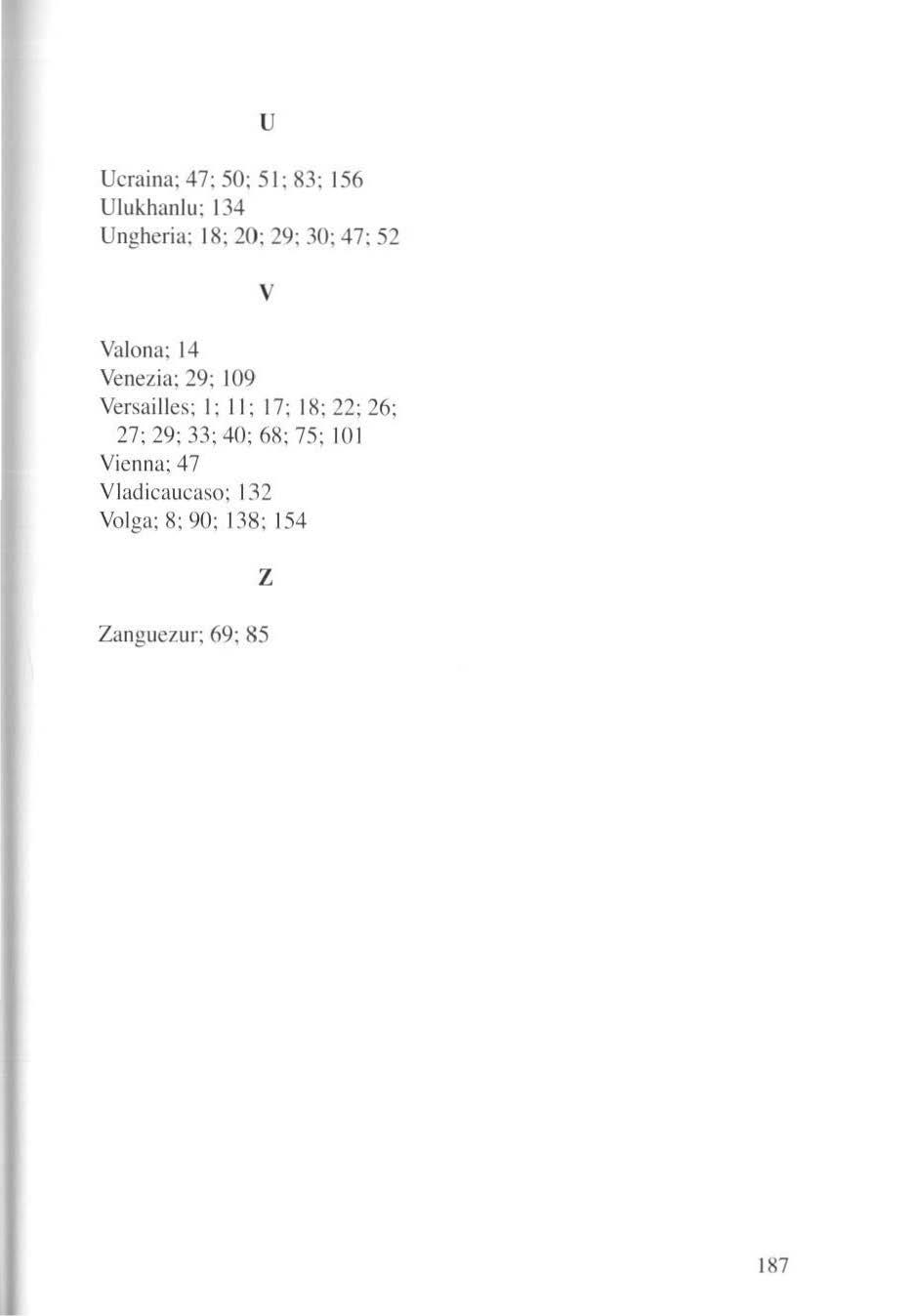
Ulukhan lu ; 134
Unghe ri a: 18:20:29:30:47:52
v
Valona: 14
Venezia: 29; l 09
Versailles: 1: Il: 17: IH: 22:26: 27; 29; 33; 40; 68; 75; l ol
Vi enna; 47
Vladicau caso; 132
Vol ga; 8; 90; 138; 154
Zanguczur; 69; 85
u
z
187
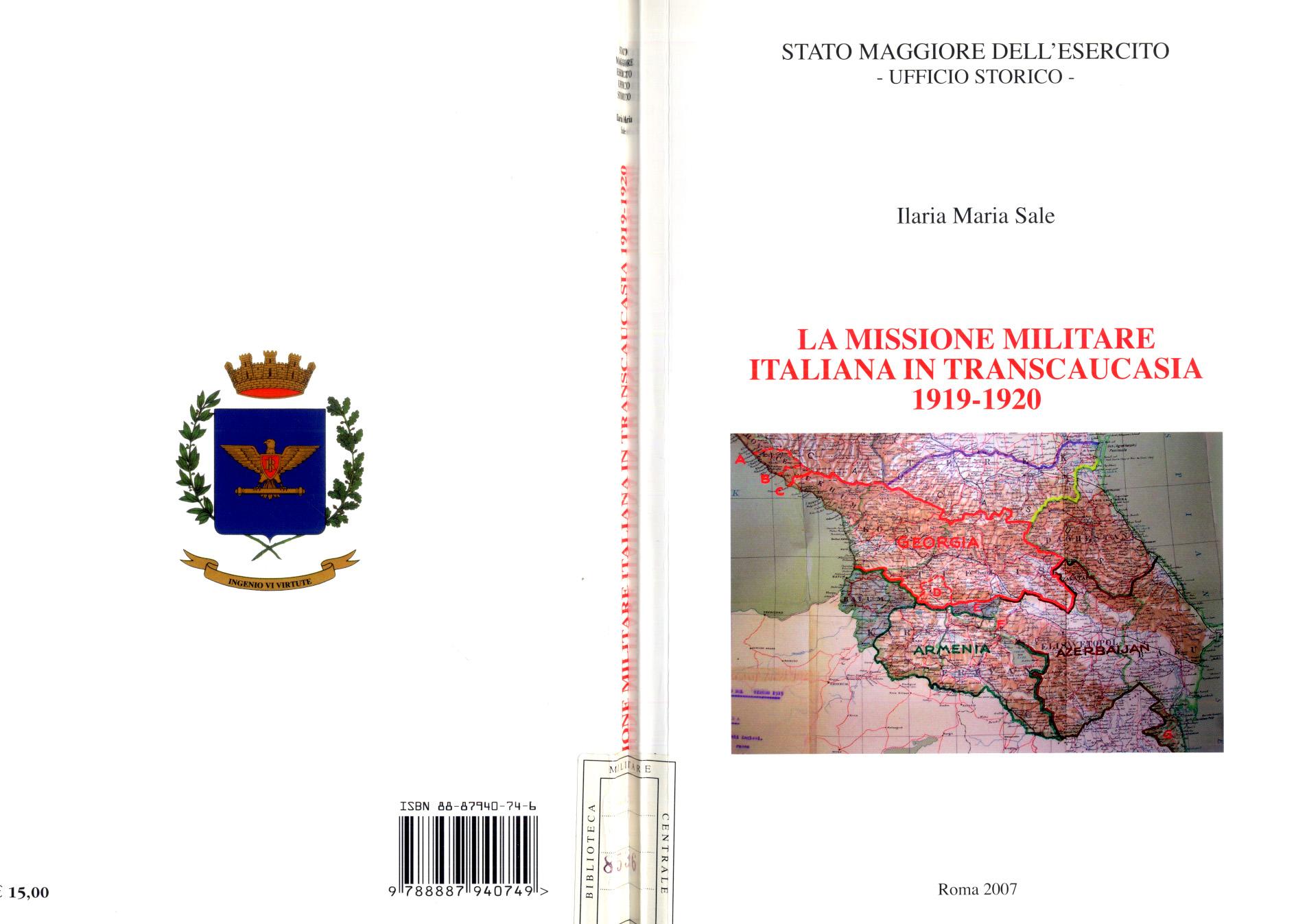



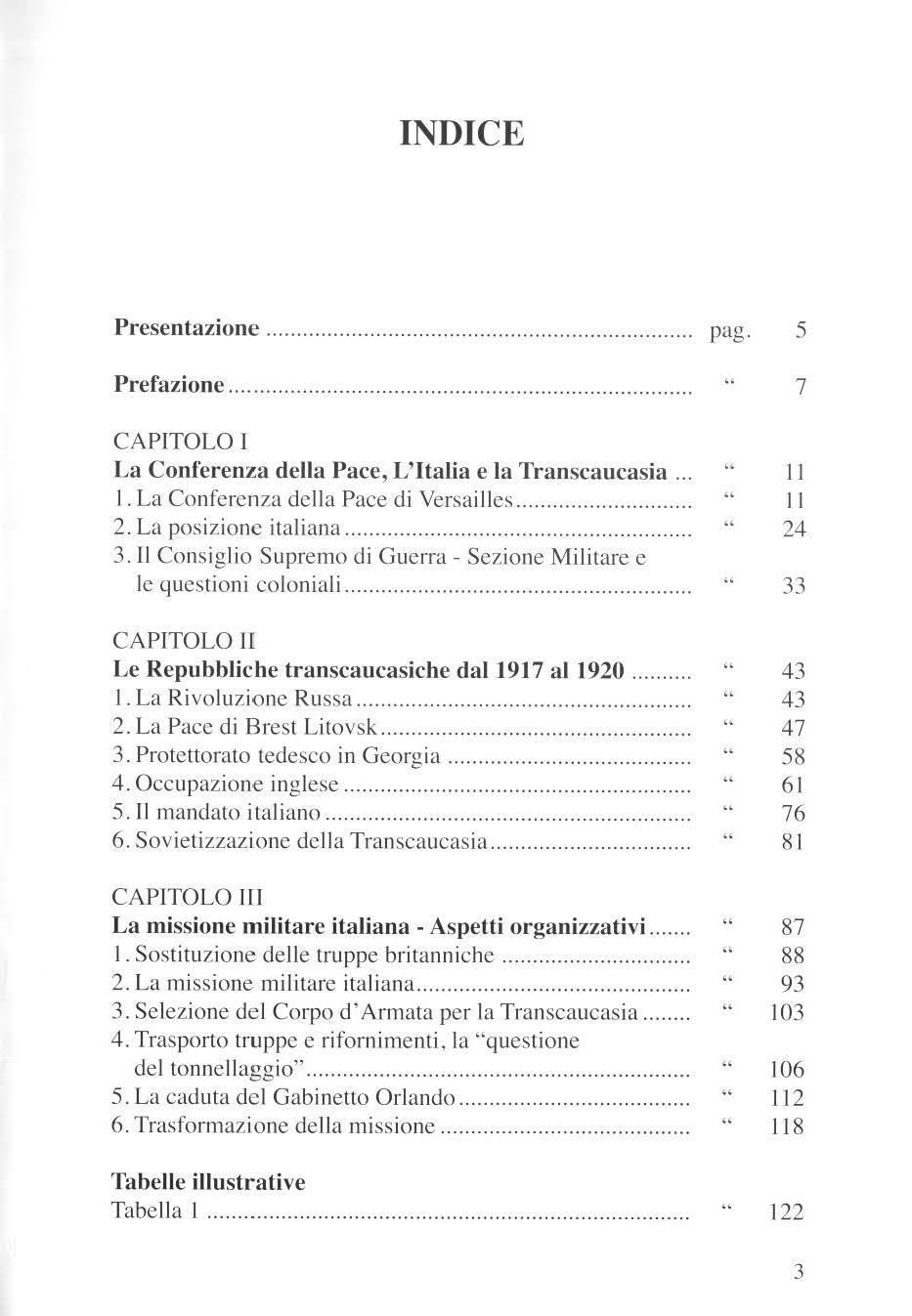
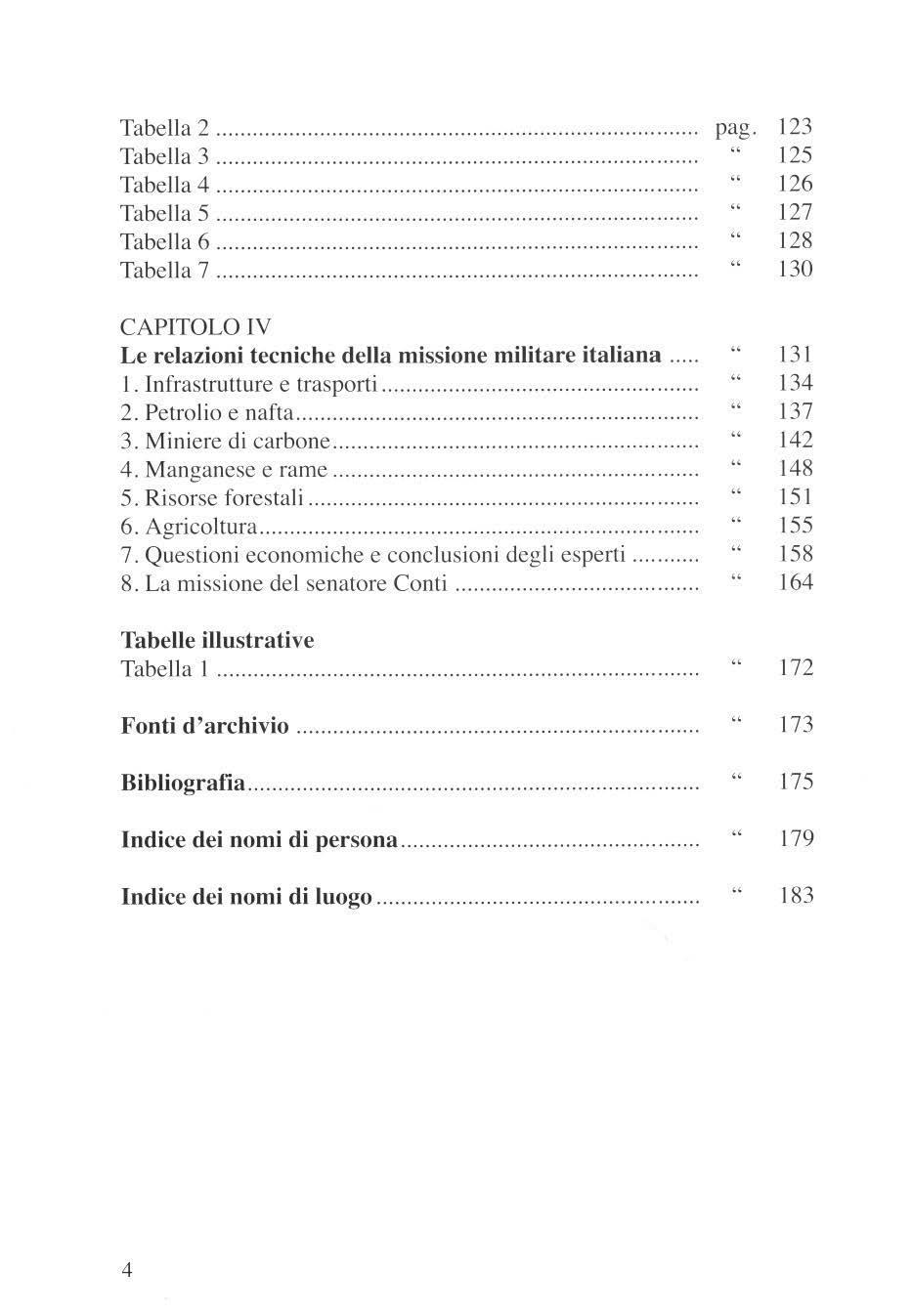
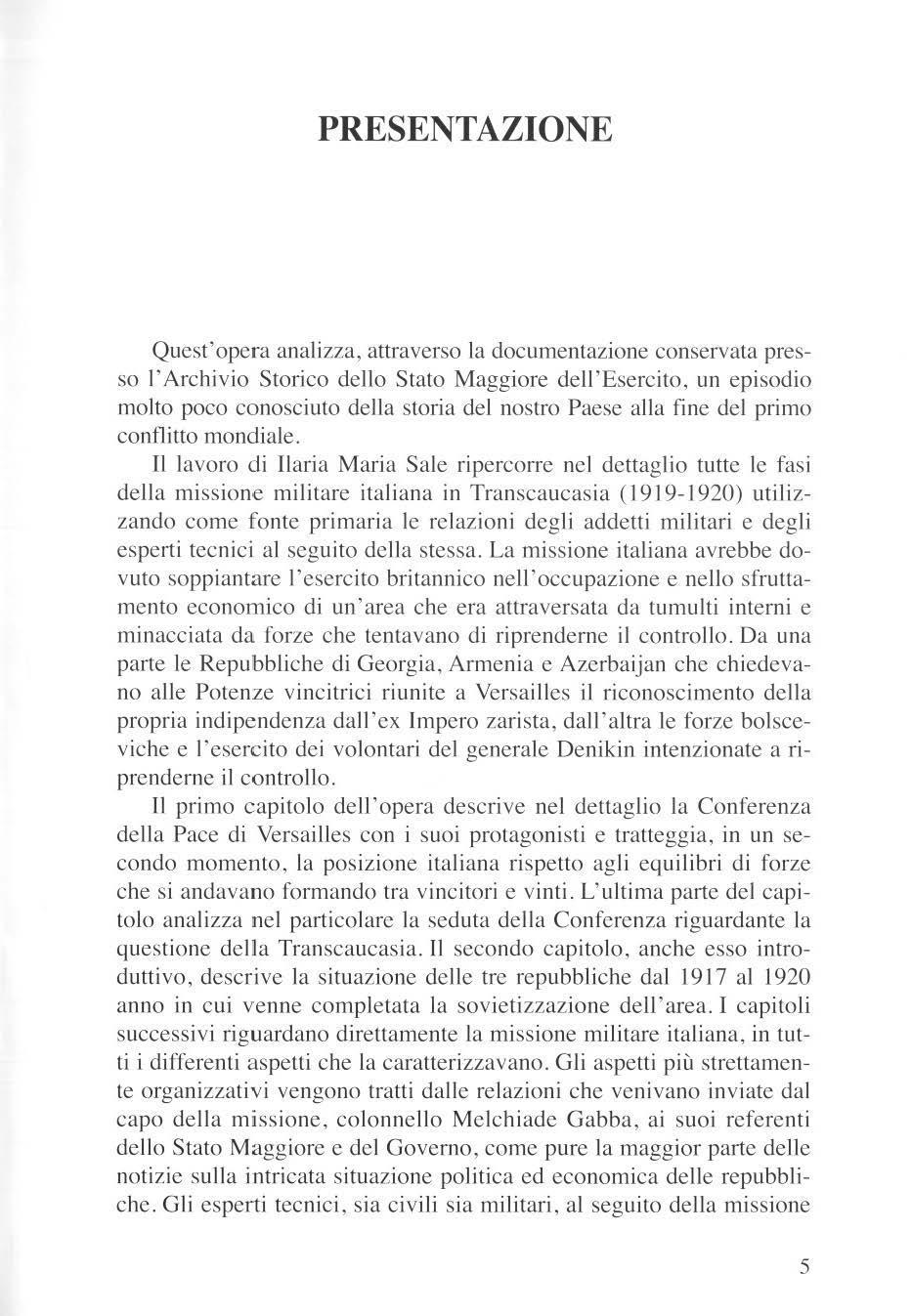




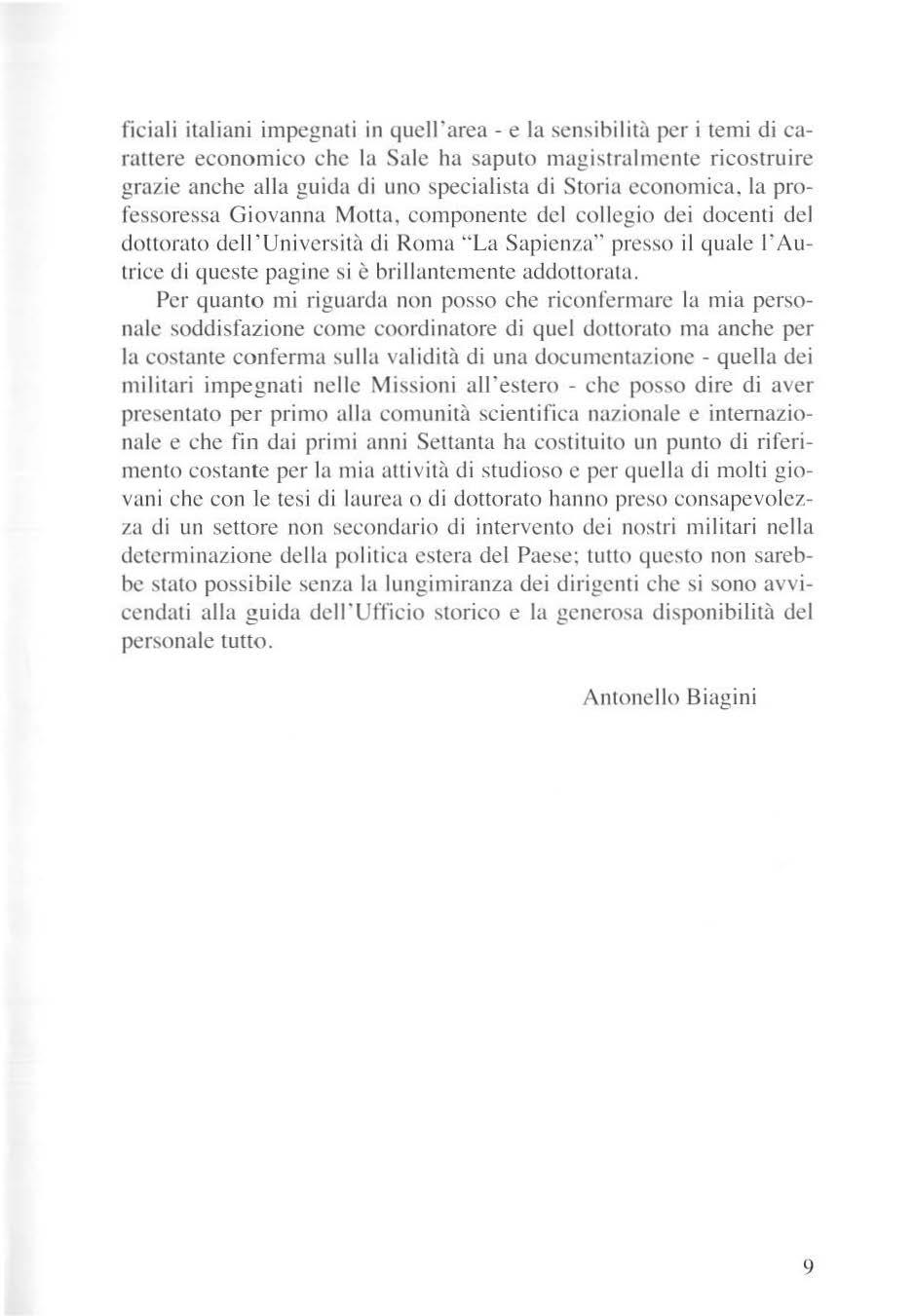 Antonello Biagini
Antonello Biagini
































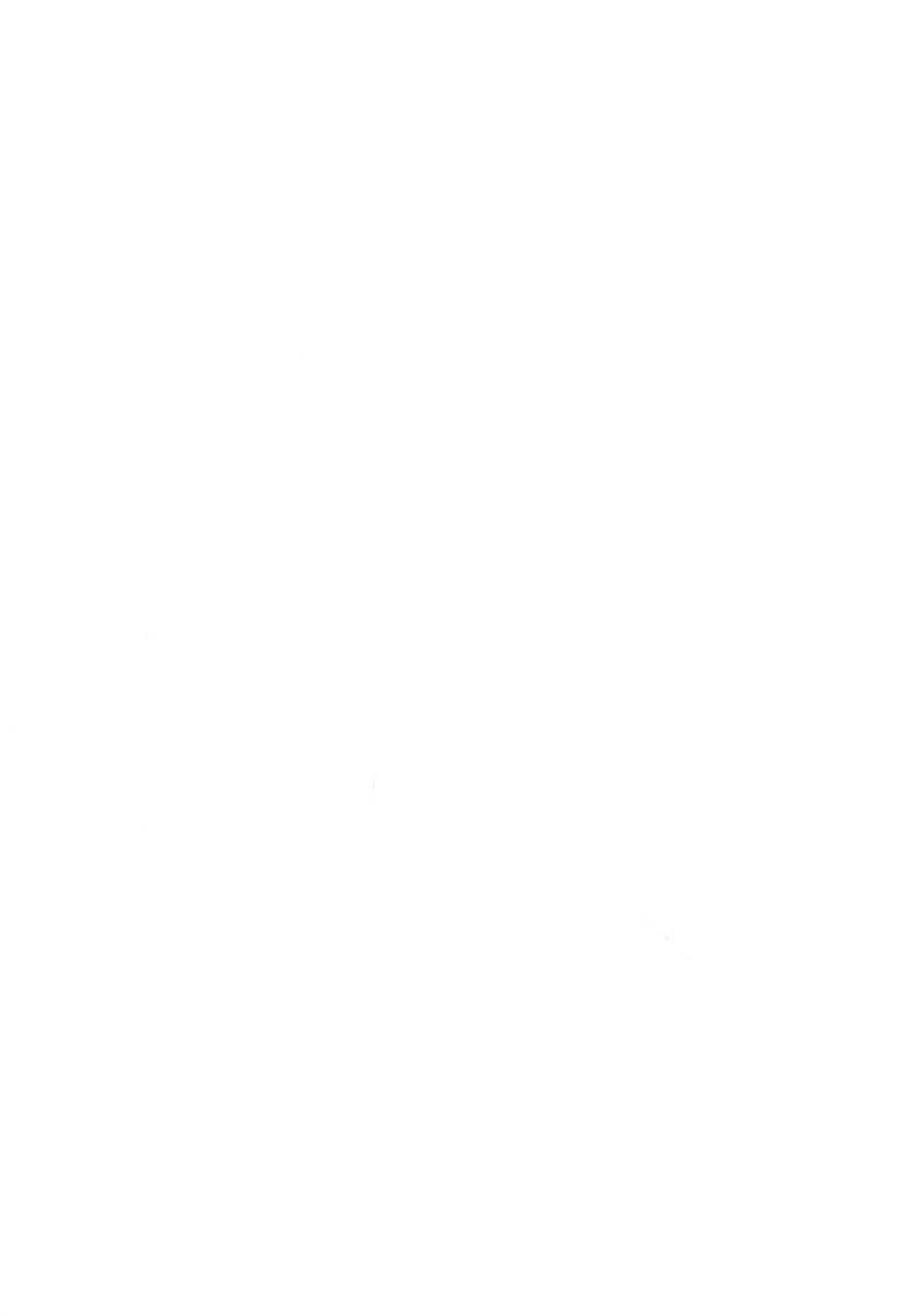




























 Lo mappa mos1ra, tratteggiola in rosso, la linea di demarca-;.ione tra le truppe hri/(lllniche e quelle del generale Denikin al 18 f?Ìugno 1919.
Lo mappa mos1ra, tratteggiola in rosso, la linea di demarca-;.ione tra le truppe hri/(lllniche e quelle del generale Denikin al 18 f?Ìugno 1919.