119 ioArch















NUOVA COLLEZIONE PIETRA EDITION
LE PIETRE ICONICHE DEL MEDITERRANEO DECODIFICATE DA DEKTON


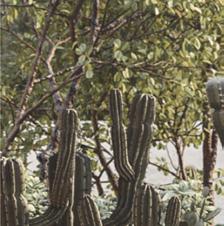
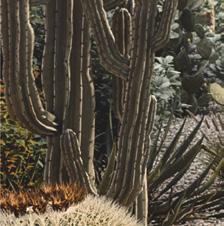









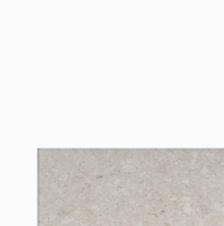












Meaningful Design to Inspire People’s Lives













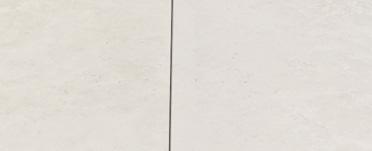












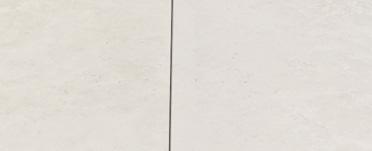


















































NUOVA COLLEZIONE PIETRA EDITION
LE PIETRE ICONICHE DEL MEDITERRANEO DECODIFICATE DA DEKTON


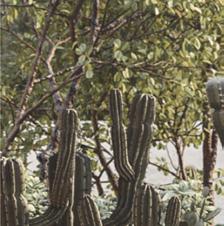
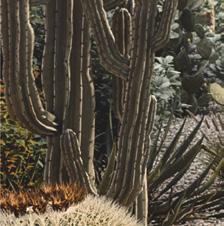









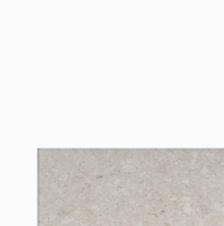

























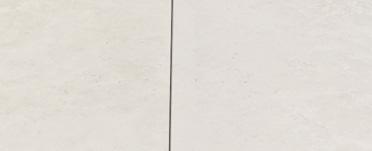












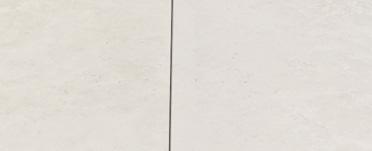


































12 Nel tempo del Déco. Albisola 1925 | MUSEO DELLA CERAMICA. SAVONA
14 Leggere architetture #6 | MATTEO PERICOLI
16 Vers une Architecture | PADIGLIONE LE CORBUSIER. ZURIGO
18 Prampolini Burri. Consonanze polimateriche | LUGANO
22 Richard Paul Lohse. L’arte come sistema etico | MASI. LUGANO
24 Robert Rauschenberg. Life Can’t Be Stopped | GUGGENHEIM NY
26 Ars Interpretandi. Riflessioni su Arte e Architettura | TREVI
28 La fotografia incontra l’Architettura | SIENA AWARD FESTIVAL
32 Anila Quayyum Agha. Geometry of Light | SEATTLE ASIAN ART MUSEUM
34 Catwalk. The Art of the Fashion Show | VITRA DESIGN MUSEUM
36 Madame Zaha Hadid | LE STORIE DI LPP
162 Mimmo Paladino. Antologica | GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA
148 Libri


REPORT
di Aldo Norsa
38 Retail Design | SBTT, LOMBARDINI22, DUCCIO GRASSI PROGETTO CMR, FORTEBIS, HYDEA
FOCUS
50 Una residenza in simbiosi con la natura | VIMAR
52 Serramenti per il Casello 104 di Morgano | EKU
54 Monoblocchi Presystem per City Pop | ALPAC
56 Camere con vista | ISOLCASA
58 Progettazione custom per Zuma Cannes | KE
60 Tre fontane per il Grand Hotel Dino | FORME D’ACQUA
62 Copertura ventilata per il Grand Hotel Menaggio | ISOTEC
WORK IN PROGRESS
64 Bergamo | C+S. IL GAMEC E LA PIAZZA
66 Venezia | MAFFEIS ENGINEERING E POPULOUS. LO STADIO
68 San Pio delle Camere | LAP. L’ASILO ORGANICO
70 Giarre | SCAU. LA SEDE DI LIFE ELECTRONICS
72 Hannover | HENN E C.F. MØLLER. AMPLIAMENTO OSPEDALE
74 Lione | OMA. IL PONTE SULLA SAÔNE
76 Vancouver | REVERY. L’ANFITEATRO IN LEGNO E ACCIAIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

78 Cambia il modo di fare architettura | LUIGI PRESTINENZA PUGLISI
80 Il mondo visto attraverso l’IA | CARLO RATTI
86 Intuizione e nuovi strumenti | MASSIMO ROJ
90 IA. Immaginare, ottimizzare, costruire | MASSIMO RUSSO
94 Il valore del dubbio | ANGELO MICHELI
96 L’irresistibile ascesa dell’IA nel progetto | ARCHITIZER E CHAOS
98 SONDAGGIO. STRUMENTO O TRASFORMAZIONE CULTURALE?
104 Another America | PHILLIP TOLEDANO
NETWORK SOCIETY
di Carlo Ezechieli
107 Instagram Architecture
108 Arturo Tedeschi. IA. Architettura e creatività
112 Arthur Mamou-Mani. Curatori di possibilità
114 Carlo Vanoni. Tutto si consuma in superficie


Direttore editoriale
Antonio Morlacchi
Direttore responsabile
Sonia Politi
Advisor
Giulia Floriani
Contributi
In copertina
Phillip Toledano Polite Extra Slim Fotografia generata con l’IA. Parte dalla mostra Another America.
Nadia Bakhtafrouz, Alessia Carrettini
Luisa Castiglioni, Carlo Ezechieli
Emmanuele Lo Giudice
Roberto Malfatti, Angelo Micheli
Aldo Norsa, Matteo Pericoli
Mario Pisani, Luigi Prestinenza Puglisi
Massimo Russo, Elena Riolo
Grafica e impaginazione
Alice Ceccherini
Marketing e Pubblicità Elena Riolo elenariolo@ioarch.it
Editore Font Srl Via Siusi 20/a 20132 Milano T. 02 2847274 redazione@ioarch.it www.ioarch.it
LPP ARCHITETTI ITALIANI
I profili di Luigi Prestinenza Puglisi
116 MDU. Misuratori del Differenziale Urbano
ARCHIWORKS
128 Grandi spazi aperti | DINTERNI ITALIAN INTERIOR DESIGN
132 Modello accademico innovativo | TRA
DOSSIER ACUSTICA
136 Ogni spazio ha una voce che ne determina l’identità
ELEMENTS
a cura di Elena Riolo
149 Contract

Fotolito e stampa Errestampa Prezzo di copertina euro 12,00 arretrati euro 18,00
Abbonamenti (6 numeri) Italia euro 72,00 - Europa euro 112,00 Resto del mondo euro 180,00 abbonamenti@ioarch.it
Reg. Tribunale di Milano n. 822 del 23/12/2004
Pagamento online su www.ioarch.it o bonifico a Font Srl - Unicredit Banca IBAN IT 68H02 008 01642 00000 4685386
Periodico iscritto al ROC Registro Operatori della Comunicazione n. 34540 Spedizione in abbonamento postale 45% D.L. 353/2003 (convertito in legge 27.02.2004 n.46) art. 1, comma 1 - DCB Milano ISSN 2531-9779


SISTEMA PARETI 30 ― 60 ― 90 ACUSTICA ― FLESSIBILITÀ ― MODULARITÀ ― ESTETICA
www.estel.com





Dall’alto in senso orario.
Baluba (serie Ottomani #8) 2016. Piatto posacenere. 1923-1929.
Centrotavola con decoro floreale.
Vaso con manici retti fine anni ’20. Brocca, metà anni Venti, in maiolica.
Il vibrante Furbo (serie Ottomani #5) 2016. Foto Luca Nostri.
Dal 23 ottobre 2025 al 1° marzo 2026, il Museo della Ceramica di Savona celebra il centenario dell’Art Déco con Nel tempo del Déco. Albisola 1925, la prima grande mostra dedicata allo stile ceramico delle Albisole nato negli anni Venti. Oltre 300 manufatti d’epoca, provenienti da collezioni pubbliche e private, dialogano con le opere contemporanee di Andrea Salvatori, in mostra anche come collezionista.
Queste opere definirono poi lo stile Albisola 1925, nato grazie a figure come Manlio Trucco, Ivos Pacetti e Tullio Mazzotti, che tradusse in ceramica le suggestioni del Déco internazionale. Le ceramiche si distinguono per decorazioni continue, soggetti naturalistici stilizzati e colori accesi, come giallo, bruno, nero e tocchi di rosso, verde o arancio. Il successo di que-
sto stile si affermò in tutta Italia a partire dalla Biennale di Monza del 1925, influenzando numerose manifatture.
La mostra espone opere storiche provenienti da Albissola Marina, Albisola Superiore, Savona e Varazze, accanto a oggetti d’epoca, abiti e accessori déco. Salvatori contribuisce con opere ispirate allo stile e con pezzi della sua collezione privata, in parte mai esposti prima.
Il progetto, curato da Donatella Ventura e Stella Cattaneo, è promosso dal Museo con il patrocinio del Comune di Savona e dell’Aicc.
La mostra è accompagnata da laboratori, visite guidate e attività didattiche e dimostra l’attualità di un linguaggio decorativo ancora oggi reinterpretato da botteghe locali ■

di Matteo Pericoli

Architetto, autore, disegnatore e insegnante, Matteo Pericoli vive a Torino dove nel 2010 ha fondato il Laboratorio di architettura letteraria, uno strumento in forma di workshop che utilizza il potenziale narrativo dell’architettura per esplorare la struttura delle storie. I risultati sono raccolti nel suo libro Il grande museo vivente dell’immaginazione (Il Saggiatore, 2022). www.lablitarch.com
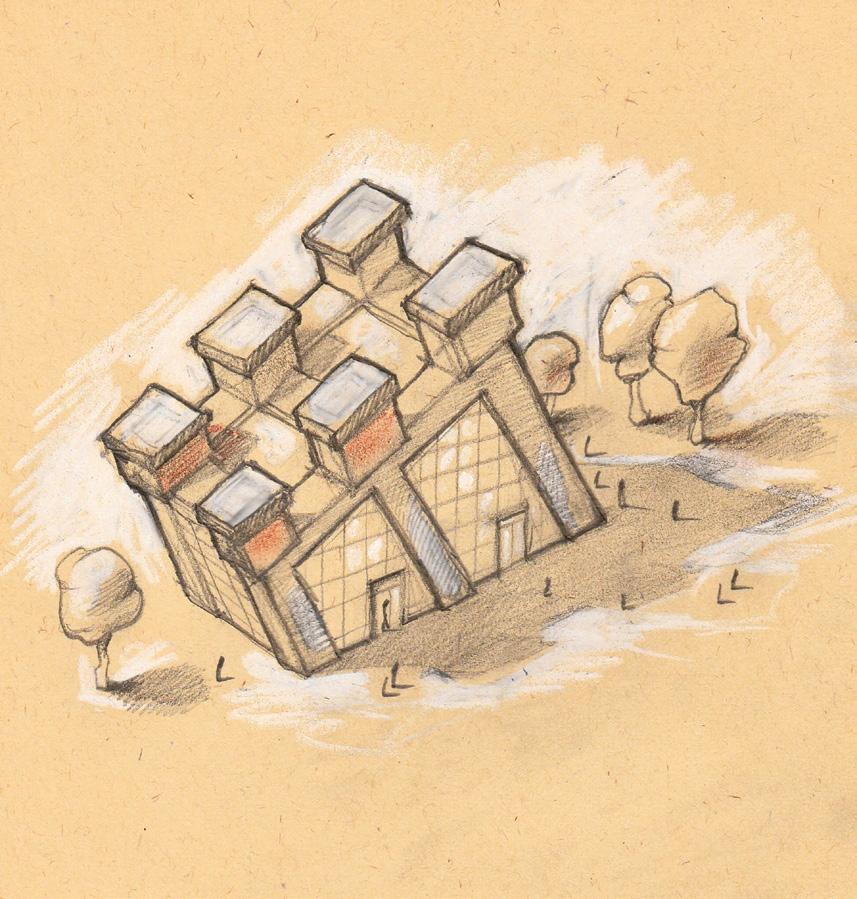
Come è fatta l’architettura di un romanzo? Come fanno a stare in piedi le storie? La lettura è un atto creativo e siamo noi, con la nostra sensibilità e la nostra esperienza, a creare quelle strutture che ci permettono di esplorare e abitare liberamente le storie. Ogni struttura quindi non è che una tra le infinite possibili. In questa puntata, un’nterpretazione architettonica del racconto di Fenoglio.
Le radici di ogni edificio non sono che le sue fondamenta. Sappiamo della loro esistenza come sappiamo dell’aria che respiriamo. Mai ci aspetteremmo di vedere un’architettura che ci mostra sopra terra la forza nascosta delle sue radici.
Questo edificio è destinato a crescere spingendo i suoi spazi vitali verso il basso, sottoterra, e a sfuggire alla luce. E sembrerà non avere alcun futuro, né alcuna speranza di risollevare la sua condizione.
Le fondamenta non sono pensate per essere viste, come non lo è il futuro.


Sotto. Jean Jacques Balzac, Work Work Work, 2024. Nella pagina accanto. Ambienti della mostra. Foto Umberto Romito & Ivan Šuta. Museum für Gestaltung Zürich.
La copertina della prima edizione di Vers Une Architecture
Drawing Architecture Studio, A Machine is a House for Making a Living, 2025. Disegno di Li Han.



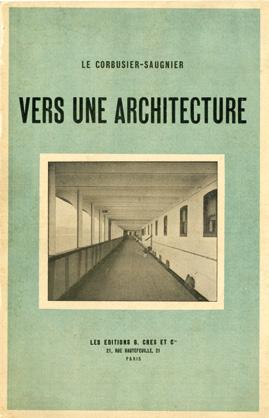
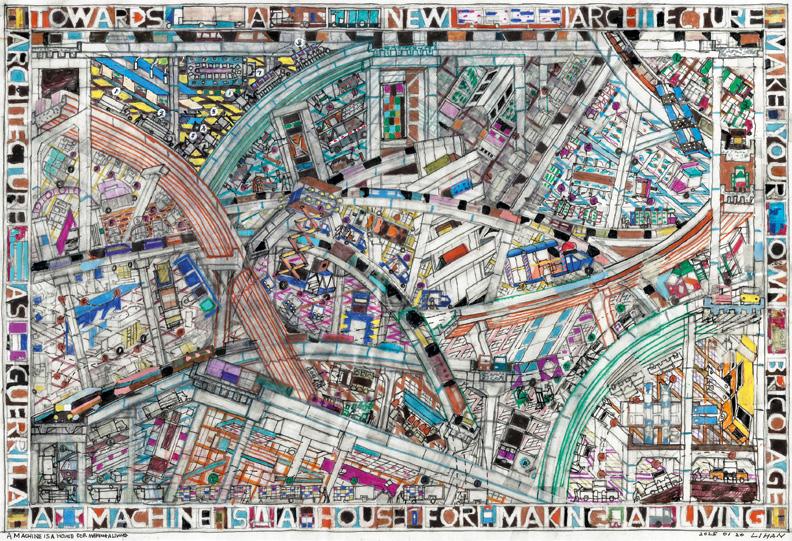
PIÙ DI CENT’ANNI DOPO LA PRIMA PUBBLICAZIONE, LE RIFLESSIONI DI OTTO GRUPPI DI ARCHITETTI SULL’EREDITÀ DI VERS UNE ARCHITECTURE IN MOSTRA AL PADIGLIONE LE CORBUSIER DI ZURIGO. FINO AL 23 NOVEMBRE
Tra gli studenti di architettura di allora, ricorda Pierluigi Nicolin nella prefazione all’edizione del 1973 (Longanesi), Vers une architecture circolava di nascosto, causa la proibizione di un retrivo corpo accademico che, scandalizzato dall’accostamento del Partenone con un’automobile, vi ravvisava gli estremi di una teoria eversiva. Temevano che la ricerca dell’efficienza, sintetizzata nella formula della casa come ‘una macchina da abitare’, avrebbe ridotto la disciplina dell’architettura alla scomparsa. Ma se nonostante questo già ai suoi tempi le teorie di Le Corbusier cozzavano con la dura razionalità della società industriale, qual è oggi l’eredità di un pensiero che ricercando l’unità di funzionalità e poesia pretendeva di fare tabula rasa dell’architettura che lo aveva preceduto? E come può essere percepita oggi, in tempi di populismi e di ‘progettazione partecipata’, la sua predilezione per le elites?
Poiché l’architettura è sempre espressione dei suoi tempi, Damian Fopp, curatore del Museum für Gestaltung Zürich, e Simon Marius Zehnder, a capo del padiglione Le Corbusier sul lago di Zurigo, hanno invitato otto gruppi di architetti e proporre le loro riflessioni sul manifesto di cento anni fa.
Manifesto che Beatriz Colomina e Mark Wigley esaminano ripercorrendo le numerose edizioni che Vers una architecture ha avuto e del quale un team di studiosi dell’Eth di Zurigo esplora l’influenza che ha avuto nel trasformare la teoria dell’architettura nel corso dei decenni.
Vers une architecture è un libro ricco di schizzi e fotografie in bianco e nero che Jean Jacques Balzac, impiegando le risorse dell’AI generativa, trasforma per creare ambienti di (possibile) benessere contemporaneo e per dimostrare che in fondo il modernismo di Le
Corbusier portava ad ambienti sterili e poco invitanti.
Tra gli altri, i contributi di Drawing Architecture Studio, che trasporta i principi di Le Corbusier nell’ambiente costruito della Pechino contemporanea, o di Dominique Petit-Frère e Emil Grip dello studio di architettura Limbo Accra, che si concentrano sugli effetti indesiderati del Moderno in Africa, dove edifici incompiuti o abbandonati si ergono come silenziosi testimoni di ideali falliti.
Se queste riflessioni non fossero di sufficiente interesse, la visita stessa del padiglione di Zurigo da sola vale il viaggio. Parte anch’essi della mostra, Claire Logoz e Bastian Marzoli di studio detritus mettono a confronto l’ultima opera costruita di Le Corbusier (su commissione della gallerista Heidi Weber) con le idee espresse nei suoi scritti e invitano i visitatori a esplorarne i 600 mq con un tour autoguidato ■

ALLA COLLEZIONE OLGIATI DI LUGANO
Bianco e nero: nell’allestimento di Mario Botta, lo spazio della Collezione Giancarlo e Danna Olgiati a Lugano scandisce con scelte cromatiche opposte il percorso della mostra Prampolini Burri. Della Materia, come radicalmente opposte alla tradizione della pittura sono state le scelte polimateriche dei due protagonisti dell’arte del Novecento che la mostra mette a confronto. Separati anagraficamente da vent’anni (Prampolini nasce a Modena nel 1894, Burri a Città di Castello nel 1914) pur con “traiettorie e significati concettualmente diversi – spiegano i curatori Gabriella Belli e Bruno Corà – rinunciando alla pittura intesa
come puro medium di secolare tradizione entrambi si affidano a tutt’altro, ritagliare e incollare, scavare nelle terre, utilizzare plastiche, sacchi, muffe e bruciare, aggiungere oggetti, e molto altro ancora. Una rivoluzione linguistica che nell’opera di Burri diverrà norma e stile internazionale, con un primato europeo su cui merita riflettere”.
Una ricerca sulla materia come mezzo espressivo che Prampolini anticipa nel 1914 in Béguinage, assemblaggio polimaterico presente in mostra insieme a capolavori come Paesaggio caprese (o vesuviano), 1922 circa, Intervista con la materia, assemblaggio di spugna, su-
A sinistra. Enrico Prampolini. Tensioni astratte, 1954. Mart. Collezione VAFStiftung. Foto courtesy Mart.
Sotto. Alberto Burri Bianco Cretto C 1, 1973 Collezione privata. Foto
A. Sarteanesi, courtesy Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di Castello, 2025, ProLitteris, Zürich.
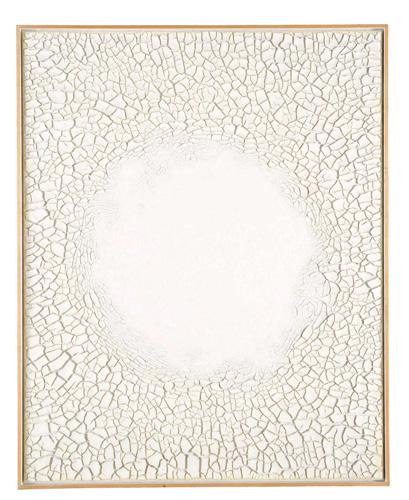




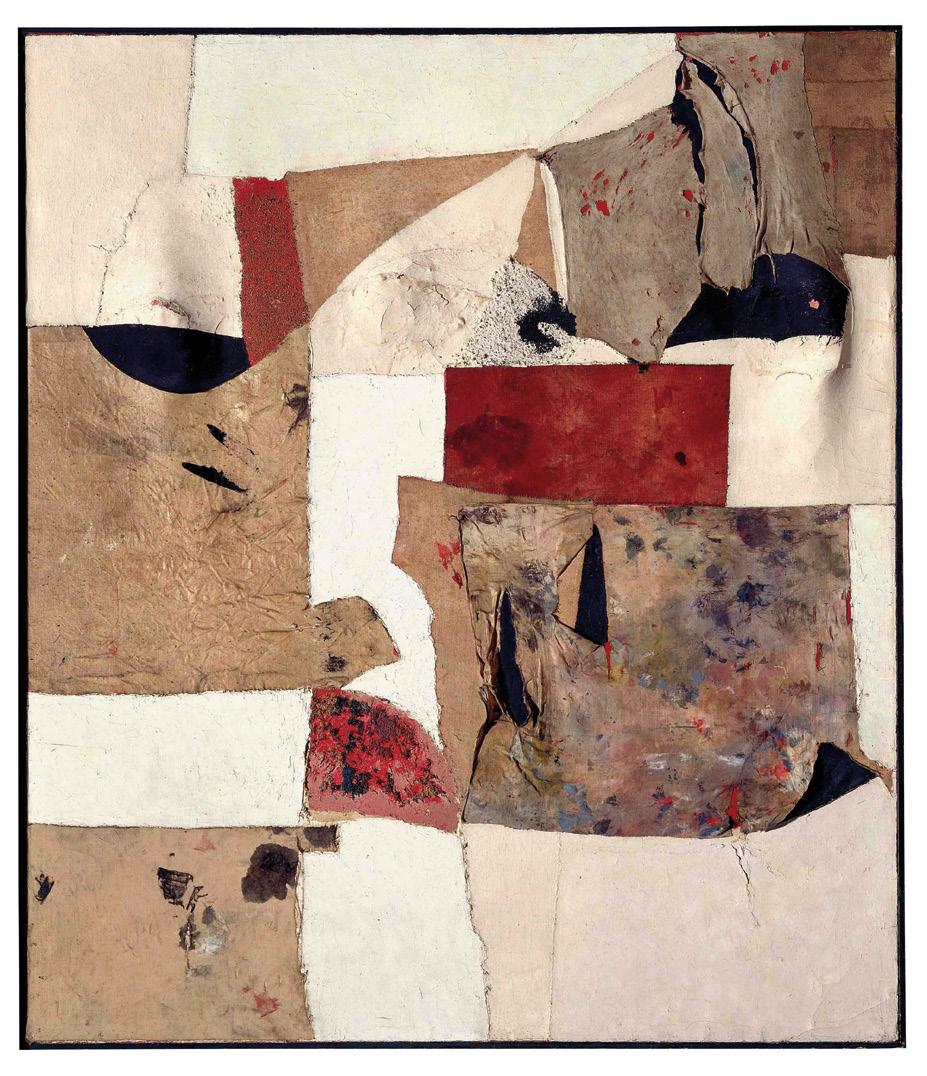
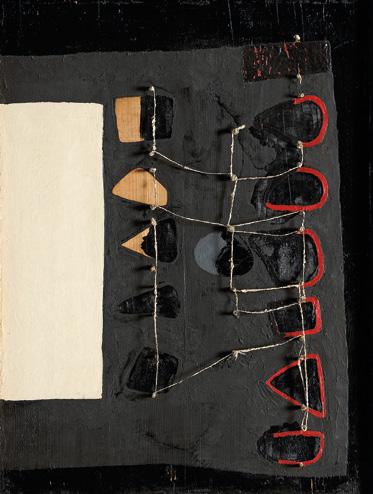
ghero, galalite che nel 1930 apre la fase più visionaria e cosmica della sua produzione, o gli Automatismi e le Composizioni degli anni Quaranta e Cinquanta.
Diverse e lontane dalle teorizzazioni di Prampolini sono invece le intuizioni di Burri, che a partire dal 1948 intraprende la sua ricerca da autodidatta e svuota la materia da ogni possibile metafora.
Quella di Burri è una materia umile e cruda, che arriva a sostituirsi al colore e in cui egli sembra ricercare lo stesso atto artistico inesauribile, un grado nuovo della forma e della bellezza. Dopo la materia arriva il fuoco (con Plastica e Rosso Plastica, 1962, in mostra) e dopo il fuoco i celebri Cretti, ovvero la materia
Accanto. Alberto Burri. Gobbo Bianco, 1953. Sotto.
Alberto Burri. Senza titolo, [1950]. Foto A. Sarteanes.
Courtesy Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri, Città di Castello, 2025, ProLitteris, Zürich.
nella sua declinazione più ampia di terra, aria e acqua.
Anche di Burri la mostra di Lugano presenta diverse opere esemplari, dai cicli dei primi anni, alle Composizioni, ai Catrami degli anni 1948-1950 ai Sacchi, per condudersi con capolavori come Bianco Nero Cretto (1972), Bianco Cretto C1 (1973), Cellotex (1980) e Nero e Oro (1993) ■
PRAMPOLINI BURRI
DELLA MATERIA
Collezione Olgiati
Lugano Fino all’11 gennaio 2026



Camaleontico per il design complanare e la pulizia delle forme, il sistema maniglia si integra senza sporgenze con la porta. Minimale nella sua essenza eppure estremamente sofisticato, Wave supera il concetto classico di leva per abbracciare un’innovativa movimentazione ad onda che risulta completamente complanare all’anta sulla quale è montato. Disponibile sia nella versione per porte a battente che in quella per porte scorrevoli, Wave si dimostra una soluzione progettuale innovativa e universale.
A destra. Dreissig systematische Farbtonreihen, 1950/55. Olio su tela.
Kunsthaus Zürich, prestito della Richard Paul LohseStiftung, 1992. Foto
Kunsthaus Zürich
Sotto. Diagonalordnung aus heller Gleichung und Kontrast 1956/75. Olio su tela. Foto
Stefan Altenburger
©Richard Paul LohseStiftung. ProLitteris.
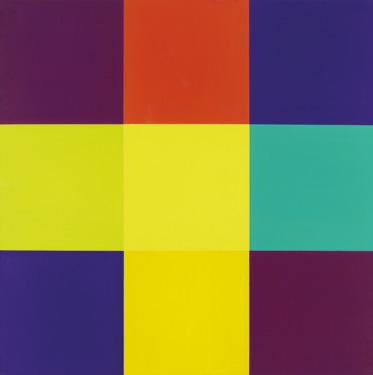
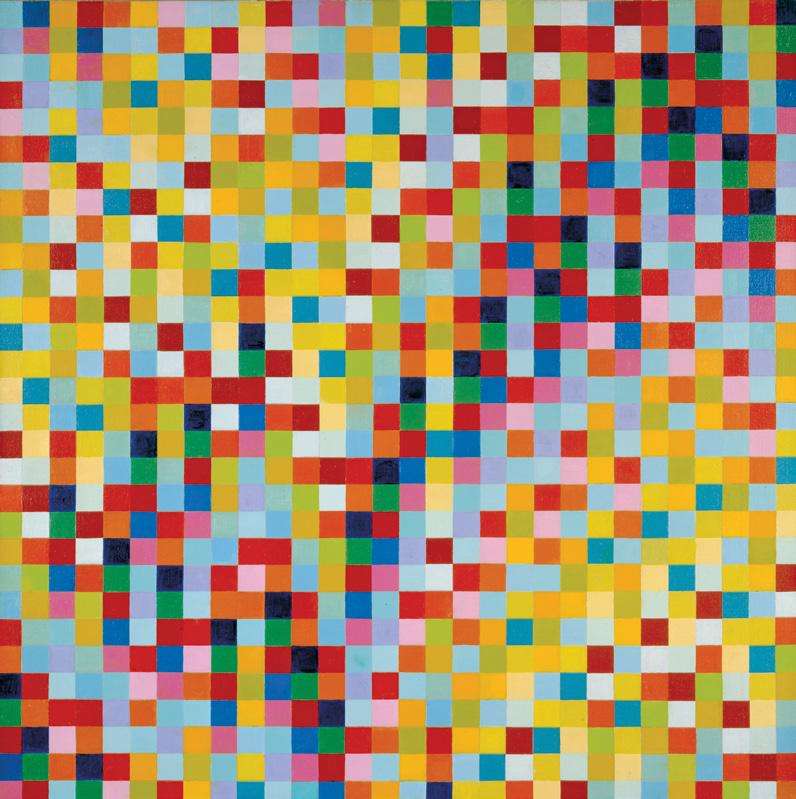
IL MUSEO D’ARTE DELLA SVIZZERA
ITALIANA DEDICA A LOHSE UN’AMPIA
RETROSPETTIVA DI OPERE CHE
ABBRACCIANO I QUATTRO DECENNI
FONDAMENTALI DELLA SUA CARRIERA
A oltre vent’anni dall’ultima mostra a lui dedicata, il Masi di Lugano presenta un’ampia retrospettiva dei lavori di Richard Paul Lohse. L’esposizione riunisce oltre cinquanta dipinti, accompagnati da disegni su carta, provenienti dalla Richard Paul Lohse-Stiftung e da importanti collezioni pubbliche e private. L’ambizioso progetto espositivo abbraccia i quattro decenni fondamentali della carriera dell’artista, dagli anni Quaranta del Novecento fino alla sua scomparsa.
Artista, grafico e teorico, Richard Paul Lohse (Zurigo, 1902 – 1988) è stato uno dei principali protagonisti del modernismo svizzero.
Attivo nella resistenza ai fascismi tra gli anni Trenta e Quaranta e, successivamente, personalità di spicco del gruppo degli Zürcher Konkrete, nella sua opera non smise mai di perseguire l’utopia dell’uguaglianza sociale, considerandola come una missione, insieme artistica e politica.
Sistematiche, razionali e, al contempo, dal forte impatto emotivo, le opere di Lohse sono state capaci di anticipare pratiche che dal color field painting e dalle tendenze concettuali e minimaliste arrivano, procedendo per sistemi generativi, fino all’arte computazionale e algoritmica più attuale.
In bilico tra etica ed estetica, tra rigore e lirismo, tra razionalità scientifica e impegno politico, il percorso espositivo si apre con una ricostruzione speculativa dello studio di Lohse, che include disegni e schizzi in grado di restituire l’unicità del suo metodo. Da qui, la mostra si sviluppa come un viaggio ideale dall’interno
verso l’esterno, da Zurigo ad alcune delle città che hanno segnato la sua affermazione internazionale – Amsterdam, San Paolo, Venezia, Kassel e infine New York – seguendo alcune delle tappe espositive più significative della sua carriera.
Il cuore della mostra è rappresentato dalle opere che più di tutte hanno contribuito alla sua notorietà: le tre imponenti variazioni di Serielles Reihenthema in achtzehn Farben realizzate da Lohse nel 1982 in occasione della partecipazione alla documenta 7 di Kassel. Emerge così il legame profondo tra la ricerca formale dell’artista, il contesto storico e le sue convinzioni politiche, inscritte nella ripetizione ostinata di strutture modulari e seriali ■
RICHARD PAUL LOHSE
Museo d’Arte della Svizzera italiana
Lugano 7 settembre 2025 | 11 gennaio 2026


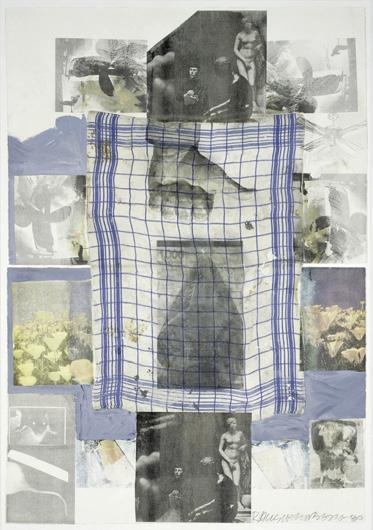
In occasione del centenario della nascita di Robert Rauschenberg, il Guggenheim di New York presenta Robert Rauschenberg: Life Can’t Be Stopped, una mostra composta da opere provenienti dalla collezione permanente del museo e da prestiti della Robert Rauschenberg Foundation. Con più di dodici opere fondamentali, l’esposizione esplora l’uso innovativo di materiali e media da parte dell’artista e si inserisce nella sua lunga relazione con il Guggenheim.
Un tema della mostra – il cui cuore centrale è Barge (1962-63), dipinto serigrafico lungo quasi 10 metri eseguito da Rauschenberg nell’arco di 24 ore – è l’incorporazione sperimentale dell’immagine fotografica nel disegno, nella pittura e nella stampa, che aveva portato molti critici ad associarlo ad artisti pop come Andy Warhol. Pur interessato alla cultura contemporanea, Rauschenberg osservava però: “voglio che i quadri siano riflessi della vita, e la vita non può essere fermata”. Posizione che dà il nome all’esposizione di New York.
Tra le opere in mostra, un dinamico dipinto serigrafico senza titolo del 1963, creato dopo che Rauschenberg aveva iniziato a introdurre nei suoi silkscreen paintings colori brillanti, e Untitled (Red Painting) del 1953, in cui una vivace pittura rossa è stesa sopra un fondo di giornali incollati.
Opere su carta, realizzate tra il 1952 e il 1980, mostrano ulteriori metodi inventivi, tra cui i trasferimenti di immagini ottenuti applicando
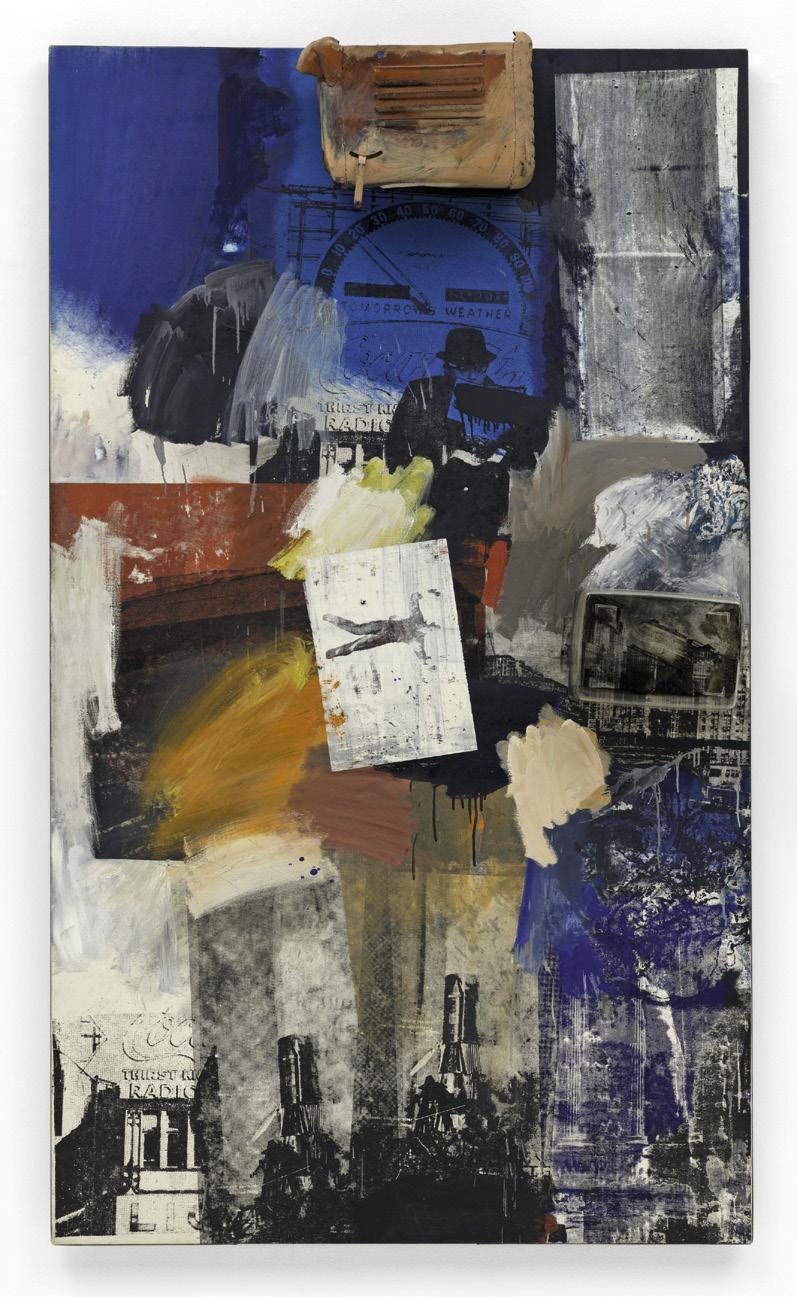
un solvente e strofinando il retro di ritagli di riviste e giornali con una penna a sfera scarica. Importanti prestiti dalla Rauschenberg Foundation illustrano come questi metodi si siano evoluti negli anni ’80 e ’90, quando l’artista iniziò a utilizzare supporti non convenzionali come il metallo zincato e la stampa inkjet ■
ROBERT RAUSCHENBERG
LIFE CAN’T BE STOPPED
Guggenheim NY 1071 Fifth Avenue 10 Ottobre 2025 | 5 Aprile 2026
In alto, da sinistra. Cot, 1980. Guggenheim. Gift the Robert Rauschenbe Foundation. Untitled, 1963. Guggenheim. Foto Ariel Ione Williams.

Esplorate la gamma Made in Italy di maniglie e accessori Architetturali, Estetici e Speciali
ento.it


Sopra La copertina di Ars Interpretandi.
In alto, l’opera di Emmanuele Lo Giudice e Alberto Timossi.
UNA CONVERSAZIONE CON FRANCO PURINI E ENRICO ANSALONI di Emmanuele Lo Giudice
Curato da Franco Purini e Enrico Ansaloni, Ars Interpretandi, pubblicato da Libria, fa seguito alla mostra L’opera d’arte nell’opera d’arte realizzata nel 2021 presso il centro d’arte contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary di Trevi, con l’intento di verificare, scrivono i curatori nell’introduzione, “se il dettato umanistico-rinascimentale della æqua potestas della pittura, della scultura e dell’architettura […] fosse ancora operante”. Ovvero scoprire le carte dell’attuale relazione tra Arte e Architettura e comprendere dove risieda il valore artistico dell’architettura stessa. Ai quarantasette autori, tra i quali chi scrive, era stato richiesto di presentare, su una tavola 100x70 cm, il progetto di “una capsula, un modulo o un museo monosala nel quale avvenga una reazione tra l’opera d’arte figurativa e l’opera d’arte architettonica” Personalmente mi piace rileggere Ars Inter-
pretandi non come il susseguirsi di vari musei “one room” slegati tra loro, ma come il progetto di un’unica architettura: spazi connessi tra loro a distanza, attraverso i quali è visibile e graficamente tangibile l’instaurarsi di un dialogo tra l’architettura come stanza (o come teca) che accoglie (o preserva e mostra), e un’opera d’arte esposta. Un progetto che sia il risultato di un’intelligenza collettiva, ovvero la costruzione relazionale di un unico grande museo senza confini né collocazione geografica precisa, privo di una forma o un volume prestabilito. Un museo ‘gassoso’, la cui forma non è quella dell’oggetto ma della relazione. L’idea di un’architettura priva di forma e volume può apparire un ossimoro, che tuttavia si lega alla metamorfosi che la nostra contemporaneità sta vivendo in questi ultimi decenni. Come afferma il filosofo Luciano Floridi, nel suo The Onlife Manifesto, stiamo vivendo “il
passaggio dal primato degli oggetti al primato delle interazioni, dei processi e delle reti”
Credo che dobbiamo accettare l’idea che la realtà che ci circonda è solo interazione, come afferma Carlo Rovelli “una rete di relazioni in cui gli oggetti sono i nodi ”. Per questo mi affascina in modo particolare il lavoro curatoriale di Ansaloni e Purini, frutto di un momento storico unico, gli anni della pandemia, durante il quale la nostra contemporaneità ci è apparsa in tutta la sua drammatica fragilità. Qualcosa di più ci raccontano i curatori.
Enrico Ansaloni e Franco Purini, come è nata l’idea di Ars Interpretandi?
L’idea di questo catalogo deriva da una discussione in rete durante il Covid, quando non era possibile un incontro tra noi, gli organizzatori e gli autori presenti nella mostra L’opera d’arte nell’opera d’arte. Per un paio di mesi discutemmo con gli autori non solo su ciò che era stato prodotto ma anche su argomenti più vasti.
Come avete scelto gli autori?
Sulla base della conoscenza che avevamo di loro. In ogni incontro era di notevole interesse comprendere quali fossero le loro idee, che oltre a quanto espresso nella mostra riguardavano in modo esteso la concezione delle arti.
Cosa possiamo dedurre da questa pubblicazione? Qual è il futuro dell’architettura e del rapporto tra arte e architettura?
Ciò che è emerso da queste conversazioni è per un verso un preciso sistema di opinioni degli autori, per l’altro la volontà da parte di coloro che discutevano con noi di confrontarsi con artisti interessanti e altri architetti presenti nella mostra.
Vista la rivoluzione che il disegno in architettura sta subendo in questi ultimi anni, mi riferisco ai lavori che si realizzano con l’intelligenza artificiale, pensate che questo libro possa far riflettere sul futuro del disegno e del progetto in architettura? Se non sbaglio nel libro non sono presenti lavori generati dall’IA.
Uno dei problemi affrontati nelle nostre discussioni era il grande numero delle tendenze artistiche che si potevano individuare. Tutto ciò faceva sì che ci si interrogasse in modo esplicito o parallelo su quale significato una tendenziosità personale degli attuali artisti avesse realmente.
Cosa raccomandare ai lettori di questo libro? Siamo interessati a raccogliere, dal catalogo Ars interpretandi, soprattutto le osservazioni di Maurizio Coccia, Mara Predicatori e Gianni Contessi, grande storico e critico triestino, e la complessità delle loro argomentazioni ■

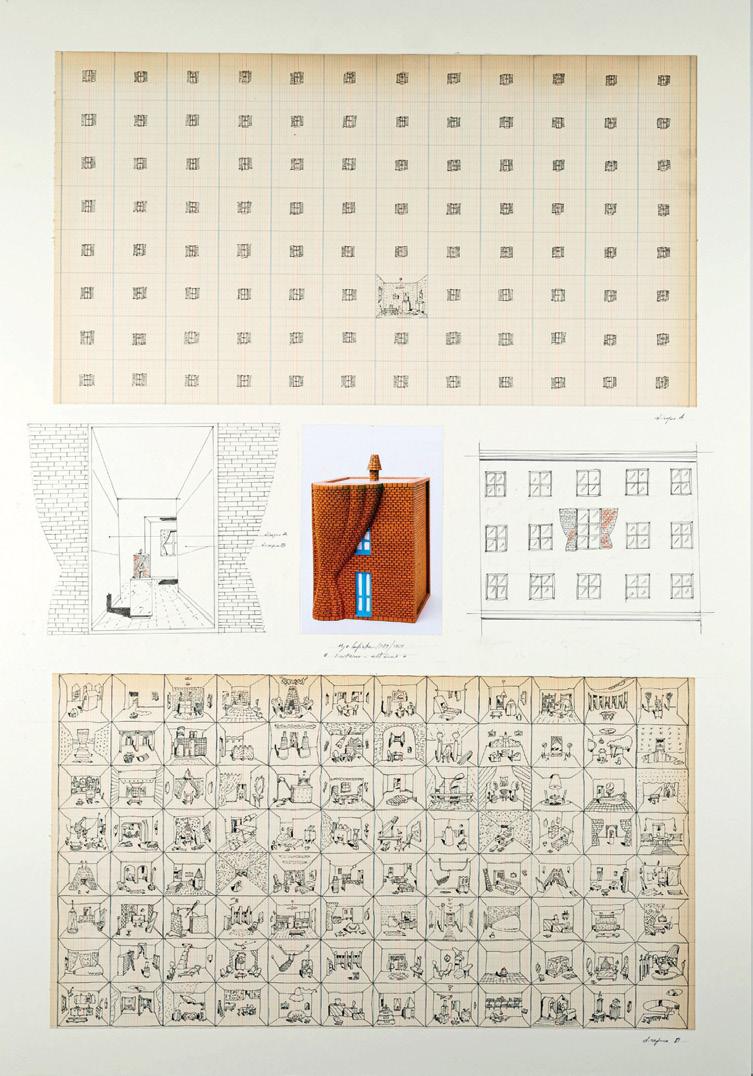

L’ARCHITETTURA
L’undicesima edizione del Siena Awards Festival trasforma ancora una volta la città e il suo territorio in un palcoscenico diffuso della fotografia mondiale. Dal 27 settembre al 23 novembre 2025, dieci mostre, tre premi internazionali e un’intensa giornata di talk porteranno qui i grandi protagonisti della fotografia contemporanea, offrendo un’esperienza che fonde arte visiva, memoria dei luoghi e rigenerazione culturale.
Nato come concorso fotografico, il Siena Awards si è evoluto in un festival culturale riconosciuto a livello globale. Oltre 400mila immagini da 194 Paesi hanno partecipato finora, contribuendo a costruire una piattafor-

ma inclusiva, aperta e fortemente connessa alla contemporaneità.
Un tratto distintivo del festival è la scelta delle sedi espositive: non semplici contenitori, ma spazi attivi nel racconto. Le mostre si snodano tra palazzi storici, musei, ex distillerie, chiese sconsacrate, aule scolastiche d’arte e borghi del territorio come Sovicille. Luoghi carichi di storia che dialogano con la fotografia, in un equilibrio tra permanenza e trasformazione, cultura materiale e immaginazione. L’inau-
Sopra, Architecture. Desert Crystal. Svetlana Fadeeva. Accanto. People. Couturier. Aleksandr Kurennoi.
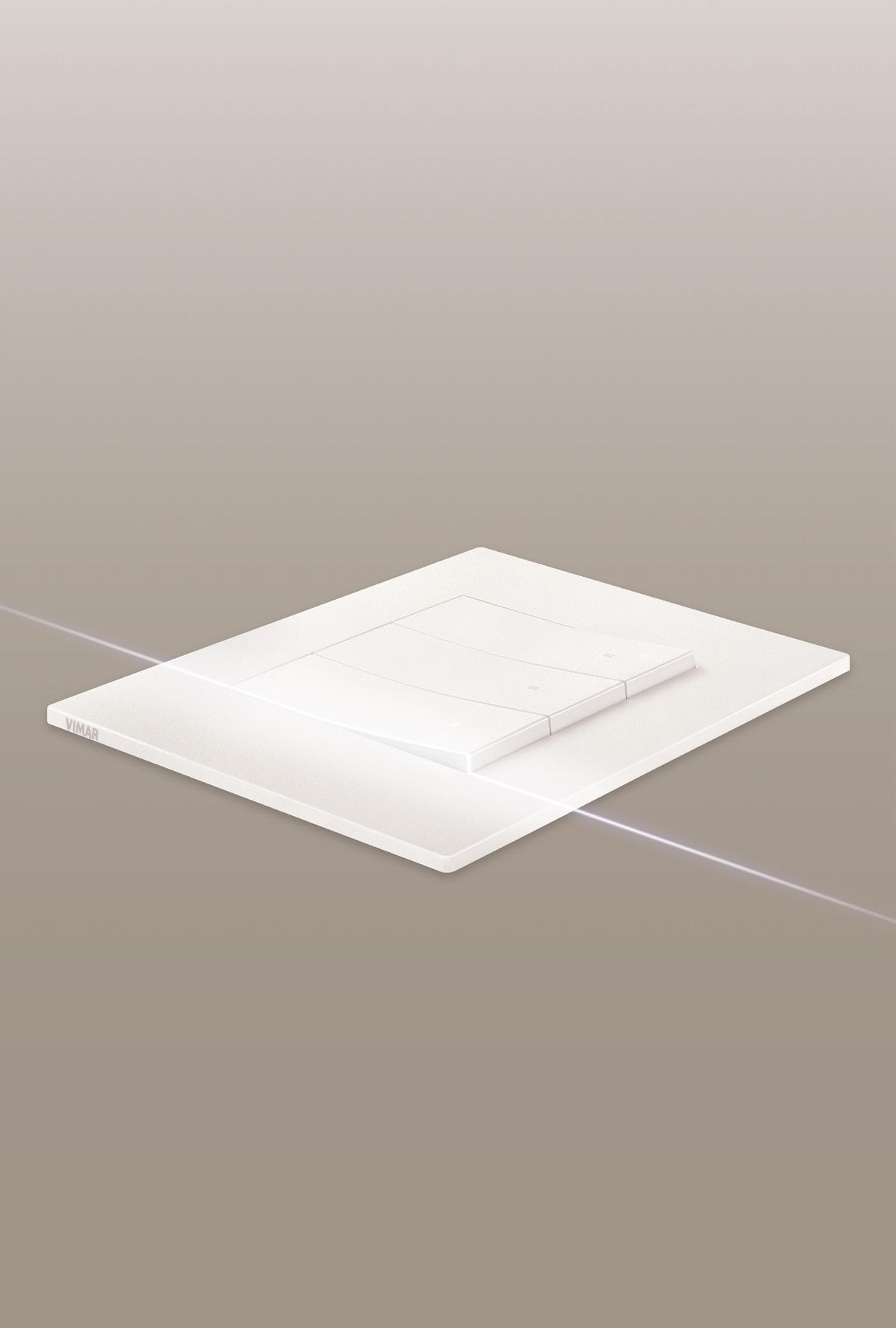


gurazione ufficiale è fissata per venerdì 26 settembre con i Sipa Talks al Teatro dei Rinnovati: un’intera giornata dedicata a incontri e riflessioni sui temi più urgenti del nostro tempo, attraverso la lente di alcuni tra i più importanti fotoreporter internazionali. Saranno presenti, tra gli altri, Steve McCurry, Ami Vitale, Esther Horvath, Adrees Latif e Pascal Maitre, fotografi che collaborano con National Geographic, Stern, The New York Times, The Washington Post.
Il giorno successivo, sempre al Teatro dei Rinnovati, si svolgerà la cerimonia di premiazione
dei Siena Awards, articolato in tre concorsi: i l Siena International Photo Awards (Sipa), tra i premi più ambiti al mondo, con dieci categorie che spaziano dal fotogiornalismo alla fotografia naturalistica, dal paesaggio allo storytelling; i l Creative Photo Awards, che valorizza la fotografia come forma d’arte contemporanea e sperimentazione visiva; e i l Drone Photo Awards, il più importante premio globale dedicato alla fotografia aerea, che propone visioni inedite del pianeta attraverso l’uso di droni e altri mezzi volanti.
Le opere vincitrici saranno protagoniste di tre
mostre collettive, a cui si aggiungeranno cinque esposizioni personali e una mostra collettiva nel borgo di Sovicille, per un totale di dieci esposizioni dislocate in contesti urbani e rurali, spesso riconvertiti per l’occasione.
Il Siena Awards Festival 2025 non è solo un omaggio alla grande fotografia, ma anche un progetto di valorizzazione territoriale e architettonica, capace di rigenerare spazi e comunità attraverso il linguaggio visivo.
In un’epoca dominata dall’immagine, Siena si conferma laboratorio internazionale di cultura e visione ■







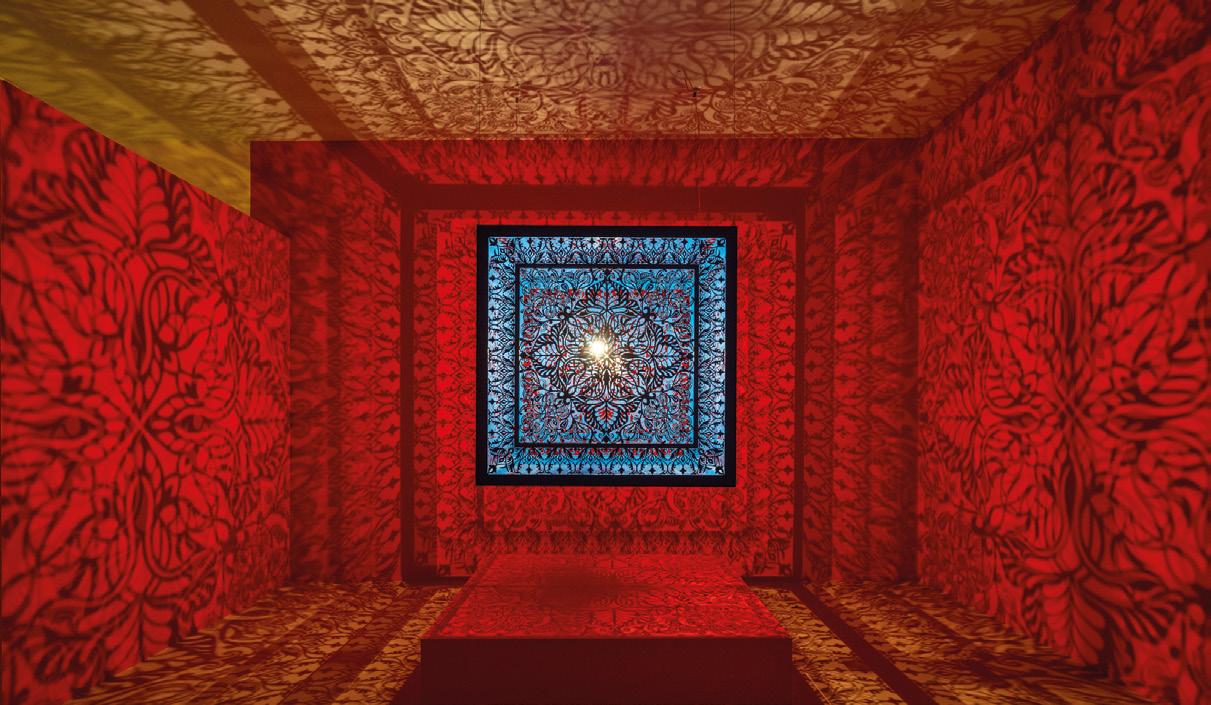
Fino al 19 aprile 2026 il Seattle Asian Art Museum presenta Anila Quayyum Agha: Geometry of Light . Per la prima volta nel Pacifico nordoccidentale, l’artista pakistano-americana
Anila Quayyum Agha propone un’esperienza immersiva con installazioni luminose ispirate all’arte e all’architettura islamica e mondiale. Anila è rinomata per le sue sculture metalliche sospese, tagliate al laser, che proiettano ombre geometriche evocative, trasformando lo spazio in ambienti spirituali. Le sue opere esplorano temi di identità culturale, genere e spiritualità, riflettendo sulle esperienze personali e le tensioni globali legate a discriminazione e immigrazione.
Curata da José Carlos Diaz, la mostra include tre installazioni luminose di grandi dimensioni e una selezione di opere su carta in tecnica mista. Le strutture di Agha, spesso realizzate con materiali tradizionalmente associati al maschile, sfidano stereotipi di genere e celebrano la bellezza e la forza del dettaglio e dell’artigianato. L’artista si ispira alle geome-


trie sacre presenti nei luoghi di culto islamici e ad elementi come le mashrabiya, griglie in legno che filtrano la luce creando atmosfere intime e contemplative.
Geometry of Light invita i visitatori a diventare parte integrante dell’opera, coinvolgendoli in un’esperienza sensoriale e riflessiva. Oltre alle installazioni, saranno esposte anche opere tessili ricamate e decorate con perline.
In parallelo alla mostra, il museo organizza tre laboratori creativi aperti al pubblico: il 17 ottobre durante l’Open House del museo e il 29 novembre e 31 gennaio come parte della serie Sam Performs: Spinning Stories ■
nel Contract.



Incontrare la bellezza. Scoprire il benessere. Scegliere la sostenibilità.
Scopra il Contract Service di Finstral. Ci contatti all’indirizzo contract-service@finstral.com
finstral.com



Dall’alto in senso orario. Chanel, Fashion Show
Spring-Summer 2015 Ready-to-Wear, Paris ©Helmut Frickeprercim.
Paco Rabanne Modenschau 12. Unwearable Dresses in Contemporary Materials. Paris, 1966 ©Getty / Foto Alain Loison.
Jacquemus Modenschau Le Coup de Soleil. SpringSummer 2020 ©Alamy.
Il Vitra Design Museum dedica una grande mostra al fenomeno delle sfilate di moda: Catwalk The Art of the Fashion Show, in programma dal 18 ottobre 2025. L’esposizione ripercorre oltre un secolo di evoluzione della sfilata, da presentazioni intime nei salotti degli atelier di inizio ’900 fino ai grandi eventi globali contemporanei. Attraverso case di moda iconiche come Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Prada, Margiela e molte altre, la mostra esplora il valore culturale, artistico e mediatico delle sfilate.
Oggi le sfilate sono performance multisensoriali che vivono sia nel mondo fisico sia sui social media, come dimostrano gli eventi di Jacquemus, Balenciaga o i concept scenografici di Oma per Prada.
Catwalk The Art of the Fashion Show
Vitra Design Museum
Weil am Rhein
18 Ottobre 2025 | 15 Febbraio 2026
Negli anni Sessanta del Novecento, le passerelle diventano teatro di cambiamenti sociali, con visioni avanguardistiche firmate da stilisti come Paco Rabanne, Mary Quant e Vivienne Westwood. Dagli anni Novanta, la moda esplode come spettacolo mediatico, mentre figure come Margiela ne sovvertono le regole.
La mostra presenta materiali audiovisivi, capi originali, scenografie, oggetti e documenti d’archivio, offrendo uno sguardo dietro le quinte del sistema moda. Viene così raccontato come le sfilate riflettano ideali di corpo, trasformazioni sociali e dinamiche tra arte e commercio, domandandosi anche quale sarà il futuro della passerella tra fisico e digitale.
Organizzata da Vitra Design Museum e dal V&A Dundee e curata da Kirsty Hassard e Svetlana Panova, dopo il debutto a Weil am Rhein la mostra viaggerà in altre sedi, a partire dal V&A Dundee in Scozia ■



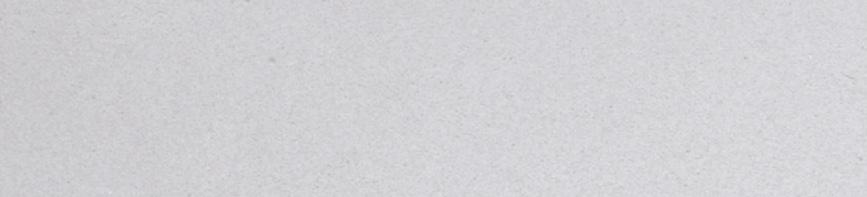
Forme decise, dimensioni ridotte e la nuova rosetta da 30 mm di diametro che fa apparire la maniglia un tutt’uno con la porta. Questa collezione nasce per entrare nei luoghi del mondo futuro.
www.frascio.it


Zaha Hadid è stata un personaggio controverso come lo sono inevitabilmente coloro che hanno una marcia in più. Lo è stata sin da studentessa, quando studiava all’Architectural Association di Londra e produceva disegni fantastici che suscitavano l’ammirazione incondizionata di sperimentatori quali Peter Cook e condizionata di tradizionalisti quali Léon Krier.
Troppo brava per liquidarla, troppo innovativa perché non fosse divisiva.
Zaha Hadid, di nascita irachena, ha una formazione da matematica prima che da architetto. È affascinata dalla dimensione autonoma, formale dell’architettura. Nutre una profonda passione per quella russa del periodo rivoluzionario e ammira il suprematista Malevič al quale dedica più di un lavoro. Per lei, la forma architettonica nasce a seguito di uno scontro tra principi opposti: la luce e l’ombra, la curva e la linea retta, l’espanso e il compresso. Un approccio che ha numerosi punti di contatto con quello del suo professore Rem Koolhaas. Anche l’olandese in quegli anni è influenzato dalla logica o, come la chiamavano allora nei circoli sperimentali londinesi, la tettonica
di Luigi Prestinenza Puglisi
Illustrazioni di Roberto Malfatti

dei contrasti. Da qui la decisione di lavorare insieme.
La partnership ha breve durata. Probabilmente perché, come ricorda Hadid sul numero 52 a lei dedicato di El Croquis, il carattere dei due è molto diverso. In Koolhaas, infatti, c’è un approccio manierista. Consiste nel continuo riferimento ai maestri attraverso il mettere in campo citazioni di lacerti architettonici di Mies van der Rohe, di Le Corbusier o degli architetti radicali. Un atteggiamento intellettualistico e compiaciuto che in Hadid è assente.
Zaha, come si vede nelle prime opere realizzate, quali la stazione dei pompieri al Campus Vitra (1991-93) punta alle concretezza delle forme, non all’esasperazione del linguaggio: per esempio al contrasto tra piani e volumi che porta alla nascita di figure ibride che hanno la dinamica dei primi e la solidità dei secondi, oppure l’aprirsi dell’edificio a direzioni multiple sia nello sviluppo in pianta che in alzato. I progetti successivi sperimentano le relazioni tra spazio e movimento, con edifici, quali il museo Maxxi a Roma (1998-2010), che diventano
Il Museo Maxxi a Roma (1998-2010) prima opera dell’architetto anglo irachena in Italia. Per questo progetto Zaha Hadid riceve uno dei due premi Stirling della sua carriera.
intrecci di percorsi intersecantisi secondo direttrici inaspettate. Un labirinto in cui si corre il rischio di perdersi e dove le opere d’arte sono fagocitate nel disegno complessivo. La coerenza dinamica dell’opera, la fluidità, l’autonomia compositiva prevalgono. Con il tempo, a generare forme dinamiche sono i calcolatori, che consentono di mettere in pratica un sogno: cioè quell’architettura parametrica che sin dagli anni Sessanta aveva entusiasmato geniali formalisti quali Luigi Moretti perché avrebbe permesso loro di giocare attivamente con la matematica dello spazio, trasformandola in materia vivente. Pensare per parametri vuol dire infatti legare la forma dell’edificio a fattori esterni arbitrariamente scelti e variabili nel tempo, come accade con un albero che adatta la propria forma in relazione all’orientamento, al clima, al contesto. Gli anni del nuovo millennio segnano l’apoteo-

Il Messner Mountain Museum Corones (2012-2015)
costruito a 2.275 m slm a Plan de Corones, circondato dai picchi della Zillertal, dal gruppo delle Odle e dalle Dolomiti.


si di queste ricerche, gestite da programmi di disegno e modellazione sempre più sofisticati. Sarà compito degli storici del nostro presente capire quanto della logica parametrica, che da un certo punto in poi fagocita in modo crescente i lavori dello studio, debba essere attribuito a Zaha Hadid e quanto al socio Patrik Schumacher. Certo è che non è difficile vedere un sottile filo rosso che lega le prime opere ispirate a Malevič e a Niemeyer a quelle ideate sino alla morte dell’architetto, avvenuta il 31 marzo 2016, all’età di 65 anni. Mentre non è difficile vedere nelle opere più recenti un sem-
pre più esasperato formalismo meccanico, se non teutonico, estraneo all’animo voluttuoso e mediorientale di Zaha Hadid.
Negli edifici pensati dalla anglo-irachena, infatti, lo spazio non è mai astratto, insensibile a chi lo deve fruire. In questo senso la sua architettura ha una dimensione umana che la rende accogliente e attraente.
La lezione, che l’energica Zaha aveva in gioventù appreso da Malevič e da Niemeyer, era infatti che l’architettura è prima di tutto poesia, e quindi non la soluzione per quanto brillante di una o più equazioni matematiche ■



Aldo Norsa
Già professore ordinario allo Iuav, associato al Politecnico di Milano, incaricato all’Università di Firenze, a contratto a Chieti, ricercatore all’Université de Montréal e master a Princeton. Già membro del collegio dei docenti del dottorato di Estimo a Padova, fondatore del master in Gestione del progetto presso Ance Treviso, membro del collegio dei docenti del master in project management delle università di Trieste e Udine. Direttore scientifico di Guamari, dal 2010 Aldo Norsa anima la conferenza annuale Tall Buildings, cura il Report on the Italian Architecture, Engineering and Construction Industry e il Rapporto Classifiche - Le prime 50 imprese dell’edilizia privata Dal 2023 è membro della giuria dei Premi Oice. www.guamari.it
Progettare spazi dedicati al retail, soprattutto quando di grandi dimensioni e notevole impegno di investimento, è un’attività sempre più specialistica e appannaggio di società o di loro appositi dipartimenti sempre più specializzate. Il mercato italiano è non solo significativo in termini economici, ma in decisa crescita (ben superiore a quella dell’economia nel suo insieme). Secondo le analisi di Jll (Jones Lang LaSalle), uno dei principali operatori immobiliari, nel primo semestre del 2025 il settore retail pesa per il 20 per cento di tutti gli investimenti capital markets che hanno raggiunto un valore di circa 5,6 miliardi di euro con un incremento su base annua di ben il 52 per cento. In particolare il retail ha prestazioni ancora migliori in quanto raddoppia, rispetto allo stesso periodo del 2024 (già in crescita) con un montante degli investimenti attratti di ben 1,1 miliardi di euro, anche grazie a un crescente interesse degli operatori internazionali per il mercato italiano, sostenuto da una significativa spesa di turisti. Ma i rendimenti netti prime rimangono stabili al 4,25 per cento per high street (ovvero per i negozi nelle strade di maggior prestigio, come via Montenapoleone a Milano, la più costosa al mondo per l’affitto di negozi) e al 6,50 per cento per i centri commerciali. Poiché non risultano ancora presenti nel mercato italiano opportunità allineate ai profili core, per la maggior parte dei casi i capitali attivi stanno ancora cercando prodotto con ritorni più elevati. Tra i movimenti azionari che interessano le maggiori catene della distribuzione commerciale la novità principale segnalata da Jll è l’acquisto di Grandi Stazioni Retail da parte di un fondo di investimento con capitali canadesi e tedeschi per oltre un miliardo di euro: operazione che, rientrando nell’ambito delle concessioni, non è contabilizzata nei volumi di investimento tradizionali.
Per approfondire i diversi aspetti della progettazione retail abbiamo interpellato sei società di architettura che hanno particolare e lunga esperienza, senza però dimenticare che anche per molti studi professionali questo mercato è foriero di opportunità continuative nel tempo a fronte di troppe altre occasioni
progettuali una tantum. Per questo aspetto ci siamo rivolti all’architetto Franco Segre. Il suo ingresso nel settore è avvenuto quasi per caso, come ci ha spiegato: «Nei primi anni ’90 ho avuto l’opportunità di progettare uno showroom a Milano per un noto stilista di calzature e borse: da allora ho realizzato centinaia di negozi, poi ristoranti e stand fieristici. Specializzarsi nel retail richiede organizzazione, competenze specialistiche e capacità di innovazione: tutto si muove a una velocità impressionante ed è stimolante poter vedere realizzato un progetto in tempi brevissimi. L’obiettivo è sempre quello: creare spazi coerenti, riconoscibili e capaci di raccontare una storia autentica. Tra i moltissimi progetti uno in particolare dà grandi soddisfazioni, una piccola catena di negozi denominata Seconda Strada. Azienda nata in provincia che nel tempo è diventata un brand ricercato e apprezzato anche dalle grandi realtà commerciali: ho progettato spazi di oltre mille metri quadrati nel Nord Italia, nei quali il filo conduttore è l’utilizzo di materiali di recupero, naturali e poveri, oltre a una forte presenza del verde. Nella loro semplicità queste realizzazioni trasmettono autenticità e attenzione al dettaglio, rispecchiano al meglio la filosofia del marchio e rappresentano un equilibrio tra funzionalità, estetica e sostenibilità oltre a dimostrare come una visione coerente possa portare un piccolo marchio a diventare un grande brand affermato».
1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?
2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?
3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?


1 _ La scelta di puntare su questo settore è nata da una combinazione di motivazioni strategiche e passioni profonde. Il retail è un ambiente internazionale, in costante evoluzione, che ci consente di confrontarci con mercati globali e stimola continuamente l’innovazione. Al contempo è un ambito molto vicino all’artigianalità italiana, un valore a noi caro che ci permette di esprimere qualità, attenzione ai dettagli e cura dei materiali, princìpi fondamentali del nostro approccio progettuale. La tradizione del custom made si esprime nel retail con progetti unici, che richiedono altissima personalizzazione in fase creativa ed esecutiva. Specializzarci in modo approfondito ci porta nel tempo ad acquisire una conoscenza verticale, nella costante ricerca dell’eccellenza in un impegno che coniuga rigore tecnico,

creatività e cultura del saper fare – tutti valori che definiscono pienamente la nostra società. 2 _ Nel tempo, abbiamo costruito una struttura flessibile per far fronte alle esigenze dei nostri clienti. Per molti brand il negozio è il luogo di un’esperienza immersiva autentica, in cui esprimere l’estetica dei propri spazi, il display del prodotto e le idee che desidera trasmettere, ulteriormente plasmate dal contesto di mercato in cui si inseriscono. La nostra forza risiede nella capacità di comprendere a fondo le esigenze di ciascun cliente analizzando con attenzione il concept e l’identità del marchio. Questo approccio ci permette di progettare soluzioni su misura, che spaziano dalla reinterpretazione del concept alla creazione di elementi site-specific.
3 _ Tra i progetti più recenti segnalo un flagship store realizzato l’anno scorso a New York. Pur conoscendo il contesto americano, la richiesta era particolarmente stimolante perchè si trattava di sviluppare il concept design del nuovo ‘tempio oltreoceano’ di una notissima casa d’alta moda europea. La rilettura sitespecific di alcuni elementi distintivi del brand e la rielaborazione in chiave ‘post-modernista’ della facciata su strada (alta sette piani) hanno trasformato la location in un’icona, capace al contempo di rafforzare il racconto di un brand più che centenario e illustrarne l’innovazione.


3 DOMANDE a 6 architetti
1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?
2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?
3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?
1 _ ‘Specialistico’ è davvero il punto chiave. La progettazione è un’attività complessa che richiede competenze molto specifiche: capacità di ascolto, comprensione del problema, un bagaglio di esperienze concreto e l’abilità di far dialogare figure diverse tra loro. Tutte qualità che descrivono bene il nostro gruppo di lavoro in Lombardini22. Il settore retail ci ha sempre attratto proprio perché mette in gioco questi aspetti in modo molto diretto. La nostra esperienza su questo tipo di progetti era già solida ancor prima della nascita formale del gruppo; quindi è stato quasi naturale dedicare una divisione esclusiva a questo ambito, anche grazie all’interesse crescente del mercato.
2 _ In questi anni ci siamo trovati spesso a progettare spazi commerciali che, a ben vedere, sono diventati vere e proprie destinazioni del tempo libero. Quando si parla di brand identity bisogna distinguere tra chi ha un solo marchio da valorizzare e chi, come un centro commerciale, ne ospita tanti. Nel primo caso, lo spazio deve essere un’estensione del brand, raccontarne i valori, accogliere il cliente in un’esperienza coerente. Nel secondo, serve invece una struttura capace di far coesistere e mettere in risalto tanti marchi diversi, senza schiacciarli. La differenza sta anche nei clienti
stessi, molto consapevoli di queste dinamiche. Per noi la chiave è sempre l’ascolto e la capacità di adattarci grazie all’esperienza. È questo che ci permette di offrire risposte su misura a ogni tipo di richiesta.
3 _ È difficile scegliere, ogni progetto ci ha dato qualcosa di diverso. Detto questo, il Forum di Palermo è sicuramente uno dei lavori che ricordo con più piacere: il cliente è stato molto soddisfatto e, a distanza di quasi dieci anni, quel centro commerciale mantiene ancora grande valore e riconoscibilità. Un altro progetto importante è quello per Coop.fi, completamente diverso per scala e impostazione, ma molto interessante per la complessità corale del lavoro. Poi c’è l’outlet di Valmontone (Roma), sviluppato con Promos, che si è distinto per un approccio innovativo, anche nei materiali e nelle soluzioni progettuali. Infine, ci tengo a citare anche alcune idee rimaste sulla carta, come quelle per Carosello a Carugate e per Cuneo: proposte nate per concorsi che, pur non essendo state realizzate, rappresentano bene la nostra visione sul futuro del retail.



3 DOMANDE a 6 architetti
1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?
2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?
3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?
Duccio Grassi
Duccio Grassi Architects
1 _ Nella prima metà degli anni ‘80, all’inizio della mia storia professionale, ho avuto l’opportunità di incontrare il gruppo Max Mara che doveva iniziare allora il proprio sviluppo retail. Insieme, nei trenta e più anni successivi, abbiamo contribuito a definire il concetto stesso di retail design, allora affidato spesso a professionisti usciti da scuole d’arte o scenografia, allargandolo all’architettura dell’edificio e tenendo conto del contesto, dei valori del brand e di molti altri fattori, estetici, socio-comportamentali ed economici. Insieme abbiamo sviluppato concept innovativi, impostando poi in modo razionale il roll out successivo per la realizzazione di centinaia di store in tutto il mondo. Mi è sembrato naturale continuare sulla strada di questa straordinaria esperienza. Inoltre il retail design ha alcune caratteristiche che ritengo interessanti: per sua natura stimola e permette la sperimentazione e l’innovazione continua, ha tempi di realizzazione molto brevi e il suo campo d’azione è sostanzialmente tutto il mondo.
2 _ Non credo che il cliente debba avere delle norme, piuttosto degli obiettivi, anche di brand identity. A volte la prima fase della
progettazione consiste nell’aiutare il cliente a definire gli obiettivi e a mettere a fuoco i valori del brand. Questi, obiettivi e valori, non devono necessariamente coincidere con la poetica dello studio, ma, se non sono incompatibili con questa, devono diventare lo scopo ultimo della progettazione.
3 _ Il progetto che meglio ci rappresenta è il building Max Mara a New York nel quartiere di Soho, sulla West Broadway: è insieme architettura e retail design, dove interno ed esterno sono pensati contemporaneamente. Semplicità, rigore, eleganza nelle forme, sincerità nei materiali, sono valori del brand espressi dall’architettura e dall’interior design.
Architectural Record lo ha pubblicato insieme ad Apple NY ed Hermès Tokyo quali esempi significativi di “Stores that improve the urban environment ”.



3 DOMANDE a 6 architetti
1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?
2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?
3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?
1 _ È fondamentale, nel progettare, anticipare i trend e le esigenze. Da più di trent’anni la nostra visione mette l’uomo e le sue necessità e desideri al centro: da qui il nostro approccio InsideOut, dai desiderata delle persone allo spazio destinato ad accoglierle. Nei primi anni Duemila gli spazi destinati allo shopping e i centri commerciali hanno assunto il ruolo di luogo di incontro, di piazza, mentre oggi la frontiera del retail si è spostata in chiave esperienziale per un acquisto che soddisfi clienti più esigenti alla ricerca di un benessere a 360°, tempo di qualità e relazioni. Il retail ha la capacità di riflettere e di restituire un’immagine dell’individuo ed è in continua evoluzione, quindi è molto sfidante e stimolante: sono imprescindibili la flessibilità e la riconfigurabilità, da noi ereditate dall’office space planning. La nostra business unit retail design ha realizzato progetti di avanguardia come il primo shopping center Auchan a Limbiate (MB) o il Bennet di Sedriano (MI), interamente alimentato con fonti rinnovabili e materiali eco-compatibili. Nel 2022 abbiamo acquisito il team di progettisti di Chapman Taylor Italia che aveva curato tra gli altri l’ampliamento dell’outlet di Vicolungo (NO), da noi sviluppato originariamente nel 2006.
2 _ Nel retail il progettista deve guardare avanti immaginando una brand identity che non c’è
ancora, perché magari lo spazio non è ancora stato acquisito o affittato. In questi casi l’esperienza gioca un ruolo fondamentale perché è necessario che la progettazione contenga già risposte a possibili esigenze e richieste che potrebbero emergere dal cliente finale. Questo ci permette di garantire una customizzazione veloce, con minime modifiche, esperienziale e unica rispetto alle esigenze della brand identity.
3 _ Un progetto ad alto tasso di complessità e particolarmente sfidante è quello per la riqualificazione conservativa di Palazzo Odeon (excinema e teatro) a Milano per conto di Kryalos, un edificio vincolato dal 2017 per il suo valore storico-artistico dalla Soprintendenza. La sfida è stata tratteggiare spazi con nuove funzioni nel pieno rispetto della vocazione culturale del luogo e in assenza di un tenant già designato, in un progetto che venisse approvato dalla Soprintendenza aumentando il ‘potenziale’ del palazzo. Abbiamo così scritto la seconda parte della storia di un edificio che sorge di fianco al Duomo nel pieno rispetto e in continuità con la sua identità culturale. Palazzo Odeon riaprirà presto le porte con più servizi e funzioni.



3 DOMANDE a 6 architetti
1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?
2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?
3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?
1 _ La nostra società ha iniziato a puntare al luxury retail dopo aver acquisito la competenza specialistica dell’architetto Simona Franci (promossa successivamente a senior partner di Fortebis) che ne ha sviluppato il mercato in modo continuo ed efficace, conoscendone profondamente le logiche e i punti di ingresso, tanto che a tutt’oggi abbiamo realizzato oltre 2.600 progetti di interior design per brand primari.
2 _ In Fortebis abbiamo un approccio metodologico da sempre orientato al cliente e tailor made per ogni servizio, dal design alla consulenza in engineering e project management. Ciò significa esprimere a ogni livello grande flessibilità e capacità di entrare nel Dna del cliente, nel suo organigramma, in compliance, nei suoi comportamenti, norme procedurali e obiettivi; alla base ci sono anni di esperienza anche aziendale all’interno delle compagnie clienti e capacità di studio e approfondimento in tempi molto stretti. Tutte le società del retail lavorano con tempistiche quasi inesistenti, dall’avvio del progetto all’opening delle boutique. Una sfida consiste nel trovare un equilibrio tra unicità del brand internazionale e spe-
cifiche culture locali: per questo accogliamo le competenze di artisti e artigiani autoctoni, rendendo omaggio a materiali e complementi tipici del luogo.
3 _ Un cliente che rappresenta la piena fidelizzazione su tutti i principali servizi della nostra società è Ferrari Worldwide. Dal 2007 a oggi abbiamo creato quattro corporate identities, concepito, realizzato e implementato su rete oltre 600 progetti per le reti showroom e service, curato le esposizioni Ferrari in 37 saloni internazionali dell’auto tra cui Ginevra, Parigi, Francoforte, Bologna, Detroit, Shanghai, Pechino e Dubai. Inoltre Fortebis ha operato come direttore artistico per la casa automobilistica modenese di 92 eventi internazionali dal 2015 a oggi. I servizi principali che ha fornito sono: brand design, engineering, roll out (ovvero lancio di una campagna commerciale), project & construction management.


Il primo Outlet Village d’Italia a Serravalle Scrivia è stato inaugurato 25 anni fa.

3 DOMANDE a 6 architetti
1 Qual è il motivo che vi ha spinto a specializzarvi nel retail?
2 Come adatta la sua impronta progettuale alle norme che ogni cliente impone per affermare la propria brand identity ?
3 Qual è il progetto di retail realizzato con maggior soddisfazione e che meglio vi rappresenta?
1 _ Più che genericamente nel retail, Hydea è specializzata in parchi e villaggi commerciali, comunemente chiamati outlet. L’ingresso in questo settore risale alla fine degli anni ’90, quando il gruppo inglese McArthurGlenn decise di investire in questo mercato in Italia, scegliendo come partner il gruppo fiorentino Fingen. Tutto cominciò con una consulenza per lo spostamento di un oleodotto su un lotto di terreno nel comune di Serravalle Scrivia, selezionato per realizzarvi il primo outlet village in Italia. Hydea conquistò la fiducia dell’impresa Tre Colli, proprietaria e sviluppatrice del progetto, e del gruppo inglese citato finendo per seguire tutto l’iter di realizzazione del centro commerciale. L’outlet di Serravalle, tuttora il più grande in Europa, è stato il primo di una lunga serie. Limitandoci a quelli realizzati, Hydea ne ha seguiti quattro in Italia, circa dieci in Europa e uno in Canada per McArthurGlen, oltre a sei in Cina, uno in Turchia e due in Russia per altri clienti.
2 _ Il tema architettonico mira a ricreare l’atmosfera di un borgo ispirato al contesto territoriale locale. Il risultato è un villaggio in continua evoluzione, articolato e realizzato per fasi,
sviluppato secondo i bisogni del cliente. Oltre ai negozi vi si trovano intrattenimento, spazi ludici, street food, aree verdi, giochi d’acqua e spazi per il relax.
3 _ L’outlet di Serravalle compie 25 anni ed è in evoluzione continua. Nella sua sesta fase ha raggiunto i 60.000 metri quadrati circa, a cui si sommano anche luoghi d’intrattenimento. Lo stile architettonico si è mantenuto negli anni, ma ha visto l’aggiunta di numerosi spazi, tra cui una passerella pedonale sulla strada provinciale, nuove piazze e un’area gioco per famiglie. Ritengo che il caso Serravalle sia il migliore esempio di come un outlet ben fatto possa trasformare in meglio il territorio circostante, offrendo non solo superfici commerciali ma anche alberghi, residenze e nuovi servizi. In futuro si pensa anche a una stazione ferroviaria dedicata.

Integrare il verde nell’architettura significa creare continuità tra costruito e paesaggio, trasformando lo spazio in esperienza viva.
HW Style collabora con i progettisti portando la natura come materia architettonica, capace di arricchire l’identità dei luoghi e intensificarne il legame con chi li attraversa.
Scopri di più su hw-style.it
By-me Plus è il sistema di automazione connessa di Vimar per il controllo completo dell’abitazione


By-me Plus, permette di gestire in modo sinergico tutte le funzioni dell’abitazione: illuminazione, temperatura automazioni per tende e tapparelle, controllo dei consumi elettrici, carichi dei singoli elettrodomestici e molto altro ancora.
Distribuita su due piani, un piano a terrazzo per la zona giorno e un piano mansardato per la zona notte, questa bella residenza in Val Seriana, tra le vette delle Alpi Orobiche, è una casa pensata dai proprietari e progettata dall’architetto Sabrina Oprandi per essere in simbiosi con la natura, attraverso una netta connessione tra spazi interni ed esterni. Ampie vetrate, luce naturale, viste panoramiche e grandi spazi aperti, pensati per far scorrere il più possibile il flusso di energia nell’aria; il tutto collegato da una scala in legno, a sbalzo, che si posiziona centralmente, diventando protagonista
attraverso la propria leggerezza visiva. Tra gli elementi naturali e sostenibili, caratteristici di un’architettura di montagna, il legno di larice spicca nei rivestimenti interni ed esterni e nelle travi del tetto, accompagnato da cromie che richiamano la terra e riflettono il desiderio di armonia e connessione con l’ecosistema. In questo contesto s’inserisce Vimar con il sistema domotico By-me Plus, che permette di gestire in modo sinergico tutte le funzioni dell’abitazione: regolare l’illuminazione, la temperatura, le automazioni per tende e avvolgibili, i consumi elettrici, i carichi dei

La sicurezza è garantita dai sistemi integrati di antintrusione By-alarm Plus e di videosorveglianza Elvox Tvcc con i videocitofoni neri Tab 5S Up, la targa Pixel e le telecamere Mini Dome e Bullet, posizionate all’esterno dell’abitazione.


singoli elettrodomestici e molto altro ancora. Il sistema ottimizza il clima domestico e l’equilibrio luminoso per un risparmio energetico ottimale e promuove un benessere sostenibile, eliminando gli sprechi superflui. Inoltre, con il controllo da remoto tramite l’app View è possibile gestire l’abitazione da qualsiasi luogo, attraverso un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.
Per garantire la sicurezza, al sistema By-me Plus sono stati integrati i sistemi di antintrusione By-alarm Plus e di videosorveglianza Elvox Tvcc con i videocitofoni neri Tab 5S Up, la targa
videocitofonica Pixel, e le telecamere Mini Dome e Bullet, posizionate all’esterno. In questo modo l’app View diventa l’unica applicazione per gestire gli aspetti di comfort, sicurezza, comunicazione e risparmio energetico. Infine, con il sistema By-me Plus, Vimar stabilisce un coordinamento completo, adattando la tecnologia domotica all’elegante serie civile Arké fit, nelle versioni total look grigio metal e nero. Raffinata e sottile, la serie s’inserisce leggera ed impercettibile sulle pareti, offrendo un perfetto risultato filo muro. www.vimar.com


Il fascino delle ferrofinestra, ma con alte prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, nei serramenti Eku Perfektion Ferro Hps scelti per le aperture a battente e Eku Perfektion Slide per gli scorrevoli. Tutti messi in opera da Carollo Serramenti di Scandolara (Tv).
Sul tracciato dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, oggi convertita in pista ciclabile, sorge il Casello 104. Si tratta della ristrutturazione di una casa cantoniera collocata tra i comuni di Morgano e Badoere, in provincia di Treviso: un edificio storico che il progetto dell’architetto Daniele Rostirolla ha trasformato, anche con l’addizione di una nuova volumetria, in uno spazio polifunzionale che ora è punto di riferimento per cicloturisti, con un ristorante al piano terra e uno spazio culturale e ricettivo al piano superiore, una vista aperta sulla campagna e le montagne.
Il recupero, parte di un più ampio intervento legato alla Greenway del Parco del Sile, ha mantenuto il dialogo con la memoria del luogo e restituisce un’architettura semplice ed essenziale. L’intonaco scuro è stato rimosso per esaltare i mattoni a vista, mentre materiali come ferro, ghiaino e legno richiamano l’estetica originaria. I nuovi elementi architettonici si integrano armoniosamente
con l’esistente. E sempre nella logica di valorizzare la struttura dell’edificio attraverso l’uso di materiali legati al contesto storico sono stati scelti i serramenti Eku Perfektion, che richiamano lo stile delle tradizionali ferro-finestra per il design, ma offrono elevate prestazioni termiche e acustiche grazie all’alluminio a taglio termico. Le aperture originali ad arco sono state rispettate, mentre gli scuri sono stati sostituiti da tende interne. Per garantire comfort e luminosità, è stata adottata vetrocamera selettiva.
Di particolare rilievo, nella nuova costruzione, è il grande serramento scorrevole da 9,5 x 2,5 metri, dotato di tecnologia Eku Perfektion Slide: robusto, scorrevole e pensato per massimizzare la luce naturale. Casello 104 è oggi un simbolo di rigenerazione, equilibrio tra passato e innovazione.
www.eku.it


I monoblocchi terra-cielo di Alpac contribuiscono alla luminosità dei microappartamenti di City Pop Milano e all’efficientamento energetico del complesso
Nella foto di Matteo Piazza, il complesso City Pop di Milano: 261 microappartamenti nati dalla ristrutturazione profonda di uno stabile a uso uffici.
Promosso dal gruppo svizzero Artisa, City Pop è un nuovo modello abitativo pensato per giovani professionisti, ricercatori e lavoratori mobili: confortevoli micro-appartamenti in affitto a breve e medio termine. Il primo in Italia è stato completato a Milano nel 2024 ed è il risultato della rifunzionalizzazione di uno stabile che in precedenza ospitava funzioni amministrative e ricettive. Alla trasformazione ha partecipato Lombardini22 con la sua business unit L22 Edu (Education & Student Housing) diretta da Marco Zanibelli, che ha ridato coerenza a un insieme di edifici frammentato, rinnovando e armonizzando volumi e altezze. L’articolazione volumetrica, ottenuta attraverso traslazioni, sottrazioni e terrazzamenti, ha inoltre creato nuove aree esterne comuni a disposizione degli abitanti. Al miglioramento estetico e funzionale delle facciate, in fase di cantierizzazione
ha contribuito in misura sostanziale Alpac, che per questo progetto ha fornito ben 470 monoblocchi Presystem SPF (con predisposizione per frangisole) con spalle progettate per accogliere i pannelli esterni della muratura a secco. Si tratta di sistemi cielo-terra che contribuiscono alla grande luminosità dei 261 micro-appartamenti in cui si articola il complesso. L’altezza ‘importante’ dei cassonetti (il cui isolamento è stato incrementato con l’installazione di una barriera acustica aggiuntiva) ha liberato altresì l’impresa dalla gestione dei voltini. Con requisiti utili per la certificazione Leed, i monoblocchi Alpac contribuiscono in maniera determinante anche al profondo intervento di efficientamento energetico messo in atto da Lombardini22.
www.alpac.it
Alpac propone soluzioni prefabbricate per la gestione del foro finestra sia per nuovi edifici, sia per riqualificazioni energetiche, con l’obiettivo di soddisfare le necessità tecniche di ogni progetto. I servizi offerti permettono una collaborazione fin dalle prime fasi del progetto,



per customizzare i prodotti scelti nell’ottica di adattarli perfettamente alle aspettative dei clienti. Soluzioni prefabbricate innovative per migliorare l’efficienza energetica del foro finestra, il comfort abitativo e la salubrità degli ambienti.

















Via del Calzaiuoli è la strada più centrale di Firenze. Di vocazione commerciale fin dal Medioevo e così chiamata per le numerose botteghe di calzature che vi avevano sede, collega piazza del Duomo e piazza della Signoria e oggi come nel Rinascimento è animata a tutte le ore da un intenso traffico pedonale. È dunque ovvio che insieme al miglioramento delle performance energetiche, uno dei principali obiettivi del recente intervento di riqualificazione del quattro stelle
Fh55 Hotel Calzaiuoli, condotto dall’architetto Marco Giammetta, fosse quello di assicurare agli ospiti un eccellente comfort acustico.
Condotto in accordo con le linee guida della Soprintendenza alle Belle Arti, l’intervento ha previsto la sostituzione dei serramenti con nuove finestre bi-color, ovvero trattate con finiture differenti sui due lati.
Per rispettare la storicità della facciata, all’esterno i profili sono verniciati in colore legno moka decorato, mentre all’interno i
serramenti si presentano nel colore crema trattati con vernici all’acqua, inodori, super performanti e durevoli, ecologiche, atossiche, silver defence e prive di elementi nocivi per l’uomo e l’ambiente.
Si tratta di serramenti in Pvc Fenix di Isolcasa, che associano performance di alto livello e spessori ridotti (la sezione del profilo è di soli 76 mm), favorendo il massimo apporto di luce naturale all’interno.
L’estetica sofisticata ne fa un vero e proprio elemento d’arredo, capace di dialogare con lo stile elegante degli interni (tutte pavimentate in legno, le 54 camere, da alcune delle quali la vista corre sulla cupola del Brunelleschi, presentano quattro diverse ambientazioni e cromatismi, in un mix di stile e tradizione valorizzato da una cura artigianale per i dettagli).
La finestra Fenix si compone di un sistema a sei camere a tripla guarnizione di battuta, premontata nei profili e termosaldata negli
angoli. I profili sono rinforzati con estrusi a ‘U’ in acciaio zincato con spessore 1,5 mm. Le qualità del Pvc permettono di ottenere valori di isolamento eccellenti, riproponendo allo stesso tempo la bellezza unica dei serramenti in legno caratteristici del centro storico. Nell’Hotel Calzaiuoli anche le finestre a battente di considerevoli dimensioni sono dotate inoltre di vetri acustici (Vetri 55.1 + 18 argon + 44.1 seleckt silence) per ottenere un abbattimento del rumore di 45dB. Ottimo anche l’isolamento termoigrometrico, con un valore Uf = 1.0 W/m2K.
Questi standard di alto livello sono stati ottenuti mettendo a sistema tutte le parti del serramento, dalla qualità delle guarnizioni agli accessori, dalla ferramenta ai meccanismi di movimentazione che assicurano fluidità del movimento, leggerezza e sicurezza allo stesso tempo.
www.isolcasa.it

Icona della Costa Azzurra, il Palm Beach Cannes ospita Zuma, il primo ristorante francese del celebre brand giapponese.
Affacciato sul Mediterraneo con vista sulle Isole di Lérins, Zuma Cannes unisce alta cucina e architettura paesaggistica in una terrazza panoramica dotata di vele retrattili, che consente di cenare all’aperto godendo di una vista magnifica sulla costa.
La committenza richiedeva un sistema ombreggiante elegante, flessibile e tecnologicamente avanzato, in grado di offrire protezione solare e comfort microclimatico senza compromettere la vista. KE, realtà specializzata in soluzioni su misura per l’outdoor di fascia alta, ha sviluppato un intervento basato sulla vela Kheope, declinata in versione custom.
Sono state installate 11 vele Kheope, ancorate a pali ad albero realizzati su disegno, che consentono agganci a diverse altezze. Questa configurazione, oltre a rispondere


a esigenze funzionali, produce un effetto architettonico dinamico, valorizzando lo spazio e migliorando la distribuzione dell’ombra.
La scelta del tessuto Tempotest Starlight resinato 6090/200, in tonalità sabbia, garantisce protezione dai raggi UV, alta traspirabilità e coerenza cromatica con il contesto. La movimentazione motorizzata e indipendente delle vele assicura massima flessibilità gestionale.
Il progetto è stato ulteriormente arricchito da un sistema di nebulizzazione integrato, pensato per migliorare il comfort termico nelle ore più calde. La durata del progetto, oltre un anno tra rilievi, progettazione e installazione, evidenzia l’approccio sartoriale e multidisciplinare di KE, capace di coniugare estetica, ingegneria e sostenibilità in contesti architettonici di alto profilo.
www.keoutdoordesign.com



Quinte vegetali sagomate e torri verdi accompagnano l’ospite in uno spazio protetto e suggestivo.
L’intero progetto impiega materiali e linguaggi coerenti con il giardino esistente affacciato sul lago, creando un insieme armonico e riconoscibile.
Chi frequenta il Lago Maggiore, sicuramente conosce il Grand Hotel Dino di Baveno, una delle cinque strutture di Zacchera Hotels. Siamo in una zona di grandi ed eleganti alberghi che tuttavia sono separati dal lago dalla strada costiera.
Non così il Dino, che sorge proprio sulla riva e offre all’ospite un magnifico e silenzioso giardino, una spiaggia privata, una bella piscina, ma appariva penalizzato dall’ingresso esterno, spazio ora interamente rivisto dallo studio AG&P greenscape, il laboratorio multidisciplinare di architetti del paesaggio, che ne ha curato il progetto di riqualificazione. L’intervento non solo eleva il valore estetico del luogo, ma risolve le criticità legate alla commistione dei flussi pedonali e carrabili
attraverso le nuove pavimentazioni che disegnano i percorsi e le scenografie verdi che creano nuove prospettive visive, agevolando la mobilità.
La zona di sosta si trasforma in un ‘giardino segreto’ ispirato ai paesaggi lacustri e alle dimore storiche del posto, animato da elementi verdi scenografici e tre fontane: una danzante musicale, una artistica e una doppia dinamica lineare realizzate su misura in granito bianco con giochi d’acqua e luci, pensate non solo come elementi decorativi ma anche come parte integrante dell’esperienza di accoglienza.
www.formedacqua.com


Fontana danzante musicale
La progettazione strutturale, tecnologica e delle coreografie della Fontana danzante musicale è stata realizzata da Forme d’Acqua. È composta da 34 ugelli dinamici disposti secondo due ellissi incrociate e da un Crown Nozzle centrale a 24 getti, capace di creare una corona d’acqua alta 3 metri. Ogni getto è illuminato da spot Led Rgb+White e alimentato da una pompa indipendente che permette coreografie personalizzate sincronizzate con la musica. Il sistema è gestibile tramite app My Fountain e dotato di impianto audio Rcf, filtrazione automatica e sensori per il risparmio idrico. La vasca richiama la forma di un quadrifoglio e il bordo è realizzato in granito bianco Montorfano.

Fontana Catene
Immersa nel Giardino Segreto, è un’opera artistica composta da una vasca centrale fuori terra ancora in granito bianco a forma di quadrifoglio con una scultura centrale minimalista. L’acqua defluisce da due fessure laterali lungo 14 moduli in pietra – catene –che richiamano altrettante cascate. L’impianto è a circuito chiuso, con illuminazione studiata per trasformare l’ambiente serale in un luogo incantato. Simboleggia un’esperienza sensoriale e rilassante per gli ospiti.

Doppia fontana dinamica lineare
Composta da due fontane con 7 ugelli Schaumsprudler Oase complessivi che generano un getto ‘schiumoso’ vivace. Ogni ugello ha pompa e illuminazione Rgb+White dedicata, montati su telai in acciaio Aisi 316L.
Forme d’Acqua si è occupata della progettazione e realizzazione delle parti Mep delle tre fontane, tutte autonome, dotate di controllo pH/Redox e gestibili da remoto. L’insieme eleva estetica e identità dell’hotel e contribuisce a creare un’accoglienza di lusso e relax.



È stata completata di recente la riqualificazione energetica e abitativa del Grand Hotel Menaggio, storica struttura ricettiva sulla sponda occidentale del lago di Como, con una nuova copertura ventilata che ha portato la trasmittanza termica dal precedente valore di U=2,325 W/m2K a U=0,170 W/m2K e migliorato lo sfasamento termico, con un significativo vantaggio in termini di comfort, specialmente per gli ospiti delle camere mansardate del quinto piano. Per l’intervento, curato dall’architetto Alberto Somaschini, sono stati impiegati i pannelli termoisolanti Isotec XL di Brianza Plastica. Isotec XL è un pannello con anima in poliuretano espanso rigido ad elevate prestazioni isolanti, rivestito con una lamina di alluminio goffrato sulle due facce che lo rende impermeabile, e un correntino metallico
asolato integrato in produzione, che sostiene il manto di tegole esterno e crea una camera di ventilazione. Nell’intercapedine si attivano moti ascensionali che collaborano con lo strato isolante: in inverno il passaggio dell’aria agevola il deflusso dell’umidità; in estate favorisce la dispersione del calore.
In corrispondenza della linea di gronda, sul primo correntino viene posato un listello aerato che impedisce l’ingresso di volatili e piccoli roditori nella camera di ventilazione e, in sommità, con gli specifici accessori di completamento del Sistema Isotec, viene realizzato il colmo ventilato per la fuoriuscita dell’aria.
Grande cura è stata dedicata al raccordo tra i pannelli Isotec XL e i numerosi corpi emergenti della copertura, quali camini, canne di esalazione e lucernari.
Un ulteriore vantaggio di questo sistema è la semplicità e la velocità di posa: leggerezza e conseguente maneggevolezza in quota, facile lavorazione e taglio, posa a secco sono gli elementi che hanno consentito di concludere l’intervento in un mese, nel periodo di chiusura stagionale dell’albergo.
www.sistemaisotec.it
CREDITI
Progettazione Alberto Somaschini
Isolamento copertura ventilata Isotec XL, spessore 120 mm, passo 320 mm
Manto di copertura Tegole marsigliesi
Superficie copertura isolata 700 m2
Trasmittanza termica post opera 0,170 W/m2K
Semplifica l’accesso all’avvolgibile e si integra perfettamente con il design degli interni
Versatilità di integrazione con il serramento che garantisce l’idoneo fissaggio sia a filo muro interno, sia in mazzetta e rende il cassonetto quasi completamente invisibile nella versione con fissaggio a pressione. Isolamento termico con trasmittanza tra 0.52 e 0.65 W/m2K e comfort acustico garantito dal
potere fonoisolante tra i 43 dB e i 48 dB. Ispezione frontale del cassonetto dall’interno.
Flessibilità di personalizzazione in base a:
• luce architettonica del foro finestra;
• diametro dell’avvolgibile;
• tipologia di finitura.


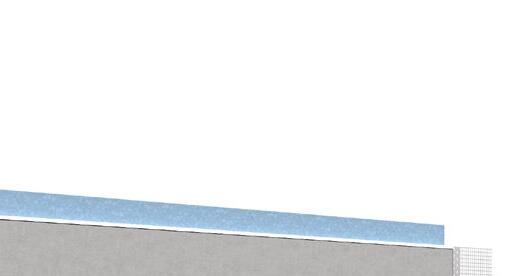











La trasformazione del vecchio palazzetto dello sport di Bergamo nella sede della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) è in dirittura d’arrivo, e nel 2026 sarà pronta anche la piazza, affidata anch’essa a C+S, lo studio guidato da Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini. L’ex- palasport è un edificio a forma ellittica realizzato negli anni ’60 con strutture verticali in cemento armato. Il progetto di retrofit di C+S ne trasforma radicalmente la struttura interna demolendo le gradinate ma mantenendo intatta la cintura dei pilastri. Sfruttando l’altezza del campo di gioco, il progetto realizza solai intermedi che triplicano la superficie complessiva dell’edificio. Ribassato, l’attuale avancorpo dell’edificio diventa Il foyer del museo e il punto di arrivo della nuova piazza Tiraboschi, progettata in continuità materica con
l’involucro del volume ellittico: museo e piazza infatti saranno rivestiti in pietra bianca di Apricena, materiale che ben si innesta nella tradizione bergamasca di costruzioni lapidee sia del nucleo antico di Bergamo alta, sia dello sviluppo piacentiniano del Novecento.
A una quota rialzata rispetto al livello della strada, cui è raccordata da gradinate e una serie di rampe accessibili per tutti, la piazza valorizza la fluidità dei percorsi verso la hall del museo, l’adiacente parco Suardi e il polo universitario delle excaserme Montelungo e Colleoni ed è disegnata con una tessitura – accessibile dagli animali ma non dagli uomini – di piante perenni a fioritura variabile e di minima manutenzione. Agli alberi ad alto fusto conservati altri se ne aggiungeranno a completamento dei filari. La continuità delle superfici lapidee è
enfatizzata da giunti ridotti e una tessitura di lastre di larghezza costante, posate a corsi alternati di lunghezza variabile, dai 15 ai 40 centimetri ■
Committente Comune di Bergamo
Progetto di architettura e paesaggio, direzione artistica e impianti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini C+S Architects
Design project manager Stefano Di Daniel con Jessica Pletto, Jurgis Prikulis, Anugna Sai Buddha, C+S Architects
Sicurezza, computi Studio Capitanio Architetti
Strutture F&M Ingegneria
Acustica Andrea Breviario
Render C+S Architects
Investimento 18 milioni di euro (museo); 2 milioni di euro (piazza)
Completamento 2026



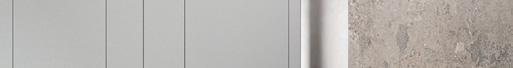














Ampia offerta di soluzioni per edilizia, industria, pubblicità e comunicazione visiva, rivestimenti interni ed esterni per il rivestimento di qualunque tipologia di superficie verticale. Vasta scelta di colorazioni e finiture, per un risultato finale dall’impatto eccellente. kommerling.it/pannelli

VENEZIA
Sorgerà nel Bosco dello Sport, un’area di 116 ettari a Tessera, a nord della città, il nuovo stadio di Venezia. Il raggruppamento di imprese costituito da Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, che a marzo 2024 si è aggiudicato la gara d’appalto, ha affidato l’incarico di progettazione del nuovo impianto sportivo a Maffeis Engineering e Populous.
I tratti curvilinei del nuovo stadio – da 18.500 posti – seguono quelli dell’intera area del masterplan, dialogando con i volumi della vicina arena e del centro sportivo. La facciata è caratterizzata da un gioco di elementi verticali che salgono verso l’alto in modo regolare e creano una sorta di quinta del catino nella fascia superiore. Questo ordito rende l’impianto leggero, arioso e permette una visione del catino dello stadio anche dall’esterno. Il podio a

mezzaluna che avvolge il volume ospiterà parcheggi e altri servizi.
La cavea si sviluppa su una sezione semicontinua sui tre lati sud, est e nord e offrirà un’eccellente visione durante le partite. La configurazione compatta e monumentale avvicina i tifosi al campo da gioco, amplificando le emozioni e creando un’atmosfera unica.
La tribuna a ovest è destinata all’ospitalità Vip. Per la tifoseria locale sono stati disegnati spazi dedicati, come la galleria
coperta che circonda il catino a 360 gradi, offrendo servizi selezionati, una gamma di offerte di ristoro e luoghi per l’interazione e una vista emozionante sul paesaggio intorno.
Progettato in conformità ai migliori requisiti in materia di design inclusivo, lo stadio avrà la capacità di trasformarsi per ospitare anche partite di Serie A di rugby ed eventi live come concerti.
Alla progettazione collaborano Soil Engineering, Seingim e Gae Engineering ■








Quasi pronto ad accogliere 52 bambini – 22 al nido e 30 alla scuola dell’infanzia – del piccolo comune abruzzese di San Pio delle Camere l’asilo Mille Bolle, una delle ‘scuole consapevoli’ progettate da Lap Architettura che reinterpretano l’architettura scolastica come spazio evolutivo, aperto e inclusivo, dove forma e funzione si fondono per sostenere la crescita e la formazione. Mille Bolle si ispira al gioco delle bolle di sapone, per i bambini oggetto di meraviglia, libertà e colore; ‘bolle’ che al tempo stesso rappresentano un involucro delicato e protettivo, come la scuola che custodisce l’infanzia e la crescita.
Distribuito su una superficie di 750 metri quadrati, il nuovo edificio si sviluppa su due livelli: un piano interrato, dedicato agli
spazi tecnici e di deposito, e un piano terra che ospita a ovest la scuola dell’infanzia e a est l’asilo nido, ciascuno con accesso indipendente.
L’edificio presenta una pianta organica modellata, a sud-ovest, da pareti curve che si affacciano sulla valle, mentre a nord-est una parete lineare ospita i servizi. Ogni ambiente è messo in relazione visiva con gli altri grazie a un sistema di finestre – ricavate a breve distanza da terra per garantire la visibilità anche ai più piccoli – e da porte-finestre che permettono l’accesso diretto alle corti esterne, differenziate per colori, arredi e funzioni.
L’accesso alla scuola dell’infanzia avviene attraverso una rampa che supera un dislivello di 2,5 metri dal piano della strada.
L’ingresso semicircolare è pensato come spazio di accoglienza, con alberature, una panchina in calcestruzzo e un’area parcheggio.
Tre gli ambienti dedicati ad attività didattiche, ludiche e alla mensa; la zona servizi comprende la segreteria, l’aula insegnanti, i servizi igienici e la cucina.
L’accesso all’asilo nido è invece sull’altro lato del lotto. Lo spazio connettivo centrale funge da ambiente di gioco condiviso, mentre all’esterno le corti protette offrono luoghi di socialità, movimento e scoperta. L’edificio è dotato di copertura piana con impianto fotovoltaico ■









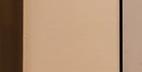




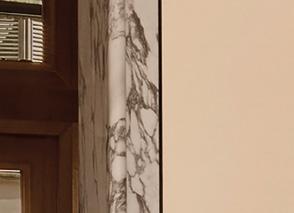














Sarà completata entro la fine del 2025 la nuova sede di Life Electronics, distributore siciliano di materiale elettrico, elettronico e di videosorveglianza. Il progetto, affidato a Scau Studio, interpreta l’identità contemporanea attraverso un linguaggio progettuale sobrio e fortemente espressivo che interagisce con il verde e l’acqua del sito. La composizione planimetrica abbraccia lo spazio aperto, definendo una corte verde che genera una percezione di equilibrio e centralità. L’architettura, compatta e rigorosa, si apre in facciata con un grande aggetto che introduce all’ingresso con una teatralità trattenuta, che invita senza imporsi.
Ricercando un’intrinseca coerenza tra forma e funzione, il progetto si articola in due volumi distinti: un corpo compatto destinato alla logistica e un’area uffici
su due livelli, caratterizzata da massima permeabilità visiva e connessione con il paesaggio circostante.
Strutture in acciaio e sistemi costruttivi a secco danno forma a un organismo leggero, flessibile e performante. Grandi vetrate dai profili minimali introducono il tema della luce, che filtrata, modulata, riflessa, è componente essenziale del progetto. Frangisole orizzontali disegnano sottili linee d’ombra sulla pelle dell’edificio, sottolineando la composizione e favorendo un microclima interno di qualità, cui contribuiscono anche la presenza di specchi d’acqua, della vegetazione che penetra il corpo di fabbrica e un attento studio dell’orientamento solare: strategie ambientali che includono anche la ventilazione naturale, l’ombreggiamento passivo e la produzione di più di tre quarti
Nei render, la componente paesaggistica, inusuale per un luogo di lavoro, e il corpo degli uffici. Sotto, planimetria dell’intervento.

dell’intero fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili.
Nel volume degli uffici un ampio atrio a doppia altezza crea un cuore pulsante per la socialità e la collaborazione interna. Oltre che luogo di lavoro, la nuova sede di Life Electronics è concepita come un ecosistema integrato dove tecnologia, sostenibilità e qualità architettonica si fondono per stimolare l’innovazione, la produttività e il benessere delle persone. Un investimento importante e un esempio di sviluppo per il territorio catanese ■
Committente Life Electronics
Progetto Scau Studio Cronologia 2024 - 2025














A Henn e C.F. Møller l’incarico per l’ampliamento dell’ospedale
Con un progetto congiunto, Henn e C.F. Møller hanno vinto il concorso per l’ampliamento dell’ospedale e centro di ricerca della Scuola di Medicina di Hannover (MHH). Si tratta di un intervento articolato in tre fasi, la prima delle quali si concluderà nel 2031.
Il sito – più di 13 ettari – sorge in una zona verde di Hannover, che un vasto parco pubblico a bosco separa dal centro cittadino, ed è organizzato in diversi edifici, cui di nuovi se ne aggiungeranno (alti da tre a sei piani), con tetti verdi e un sistema di costruzione ibrido, con strutture in legno per i piani superiori.
La planimetria di progetto conferma e amplia la struttura a padiglioni, articolati intorno a una corte centrale, demineralizzata e pedonale, che è il cuore del complesso. I differenti padiglioni rispondono alla diversità delle funzioni – di studio e ricerca, ambulatoriali, di pronto soccorso, operatorie, di rianimazione e di degenza. Gli edifici sono collegati da una navetta proveniente dall’accesso centrale e, da un edificio all’altro, da un basso porticato che ne percorre le facciate interne, che verrà costruito anche con l’impiego di mattoni recuperati da alcune demolizioni.

Gli ambienti interni valorizzano le componenti terapeutiche – ma anche di benessere degli operatori sanitari –attribuite all’impiego di materiali naturali come il legno e alle viste sul verde e alla luce naturale. Anche una chiara organizzazione, cui contribuisce anche il percorso porticato che collega i diversi volumi, aiuta a ridurre lo stress dei pazienti. All’esterno, il complesso si presenterà con facciate luminose in alluminio riciclato, mentre verso la piazza interna gli edifici avranno una calda tonalità di rosso ■
Committente Hochschulmedizin Hannover
Baugesellschaft
Gruppo di progettazione architettonica Henn e C.F. Møller
Architects
Progetto di paesaggio Sinai
Ingegneria strutturale Wetzel & von Seht
Progettazione medica specialistica HT Hospitaltechnik
Fisica degli edifici Müller-Bbm
Servizi costruttivi Süss Beratende Ingenieure
Gestione del sito M&P Ingenieurgesellschaft
Superficie costruita (prima fase) 46.000 mq
Capacità 24 sale operatorie; 562 posti-letto (di cui 102 terapie intensive)



Dopo quello di Bordeaux intitolato a Simone Veil inaugurato lo scorso anno a Bordeaux, Oma vince un altro concorso per la costruzione di un ponte in Francia, questa volta a Lione, che scavalcando la Saône collegherà il quartiere della Confluence –già porto fluviale industriale alla confluenza del fiume nel Rodano oggi trasformato in nuova area mixed-use – con l’area collinare della zona occidentale della città. L’esigenza del committente, Sytral Mobilités, era quella di colmare un gap della mobilità cittadina con una nuova linea tramviaria e di ampliare al contempo la rete di percorsi ciclopedonali verso ovest, dove il Pgt prevede una densificazione del costruito.

Anziché costruire due collegamenti distinti – quello tramviario semplice e diretto, quello ciclopedonale più paesaggistico – il progetto prevede un’unica struttura, lunga 224 metri e larga 13,65, efficiente ma al contempo piacevole da percorrere, rispettosa del contesto ma con un proprio carattere distintivo, più evidente sulla sponda pianeggiante della Confluence, dove i pedoni camminano su una struttura leggera, sospesa sopra le canne dei giardini d’acqua sottostanti, ma quasi invisibile sulla sponda collinare occidentale, dove il tram si infila in un tunnel mentre il percorso ciclopedonale riprende il sentiero storico che esisteva lungo La Balme ■
Committente Sytral Mobilités
Progetto architettonico Oma (Reinier de Graaf partner, Gilles Guyot associato, Anton Anikeev capo-progetto, Yasemin Parlar, Francois Riollot e Suet Ying Yuen team, Stefania Trozzi e Diego Iacono visualizzazione)
Progetto del paesaggio Mrp
Ingegneria Wsp
Lighting design Les Éclaireurs
Beni culturali e patrimonio Dda - Devaux & Devaux
Architectes Render Oma & Hism


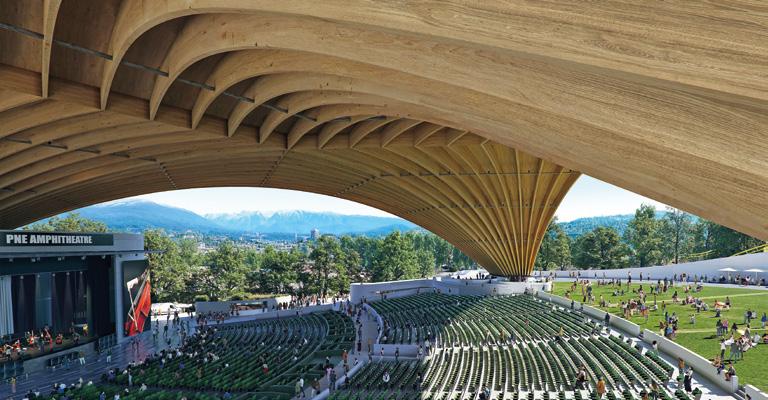
Fondato nel 1906 come sito fieristico, oggi Hastings Park è il parco dei divertimenti di Vancouver, una sorta di Coney Island del Pacifico. Sorgerà qui l’anfiteatro all’aperto progettato da Revery Architecture, una spettacolare copertura autoportante – costruita in legno tecnico – capace di proteggere fino a 10.000 spettatori nella città più piovosa del mondo. Il tetto del Freedom Mobile Arch –questo il nome dell’opera – sarà formato da sei volte a botte – con campate di 105 metri ciascuna – che nelle linee di congiunzione integrano un sistema di raccolta e smaltimento delle acque impiegate poi per l’irrigazione e per la parte in eccesso dirottate allo smaltimento controllato nella rete cittadina.
Agganciati a una sottostruttura di acciaio, gli archi sono realizzati con travi curve di legno di abete Douglas lamellare a strati (Glulam).
Un solaio lamellare a strati incrociati (Clt) di pino e abete bianco fa da copertura alle volte. Oltre che ambientalmente sostenibile – tutto il legname è di provenienza locale – e leggero, il legno contribuisce a migliorare l’acustica. Revery ha collaborato con gli esperti acustici di Stages Consultants per garantire un’esperienza sonora ottimale per il pubblico e con il minimo disturbo per l’area circostante.
Le sedute sotto la copertura – cui si aggiungono posti liberi sul prato antistante – potranno essere rimosse per fare spazio a piste da ballo o a eventi stand-up. Il palco, permanente, è alto come un edificio di tre piani e comprenderà anche spazi food&beverage e di merchandising. Illuminazione personalizzata, sistemi di sospensione e attrezzature audio forniranno impianti accessibili e ottimizzati plug-and-play, adatti a differenti generi di eventi ■

Committente Città di Vancouver
Progetto architettonico Revery Architecture
Ingegneria strutturale Fast + Epp
Mep Introba; Aes Engineering
Ingegneria civile Kerr Wood Leidal Associates
Architettura del paesaggio Pfs
Audio/video, acustica, progettazione teatrale Stages
Consulting Appaltatore EllisDon
Superficie coperta 12.350 mq
Completamento 2026




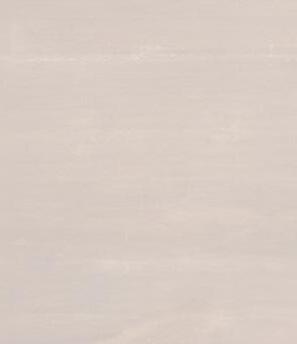
Materiali, finiture e sensazioni tattili influenzano il carattere di ogni stanza. Per questo è sempre più importante che tutti i dettagli siano coordinati alla perfezione. I diversi sistemi di cerniere a scomparsa di SIMONSWERK consentono la massima libertà di progettazione unendo design, finiture e funzionalità ai massimi livelli adattandosi, in modo quasi naturale, alle esigenze dei diversi materiali.
www.simonswerk.it

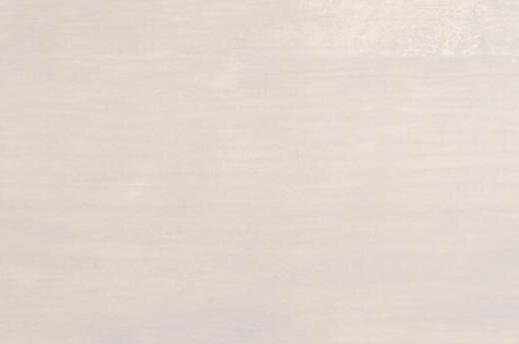


di Architettura
A Robot’s Dream (Gramazio Kohler Research team, Eth Zürich - Mesh e Studio Armin Linke). Con Machine Mosaic e Co-Poiesis fa parte del progetto di ricerca Construction Futures Research Lab sostenuto da Fondamentale-la filiera delle costruzioni. Foto Moreno Maggi.





Sta girando in questi giorni la storia dell’Intelligenza Artificiale che ha ricattato il tecnico che la voleva spegnere, dicendogli che, se lo avesse fatto, avrebbe rivelato una tresca di cui lei era a conoscenza. Per alcuni potrebbe essere la prova che l’IA sta per compiere un salto evolutivo diventando da un semplice strumento operativo, un soggetto che ha consapevolezza di sé e che quindi prima o poi potrà agire in piena autonomia, utilizzando come sua estensione i corpi meccanici dei robot sempre più perfezionati nei movimenti e sempre più producibili a basso prezzo (l’obiettivo è commercializzarli in breve tempo al costo di una automobile).
Per fortuna, abbiamo ancora qualche anno di tempo per prepararci a questo scenario che cambierà la struttura stessa del lavoro. Molto del quale, senza troppe preoccupazioni, potremo delegare a questi automi. Potremmo chieder loro di prepararci le relazioni tecniche e di risolverci il problema distributivo di qualche progetto complesso e poco gratificante. E, con l’andare del tempo, affidare loro problemi progettuali sempre più complessi, per la felicità dei committenti più rognosi ai quali potremo presentare decine di varianti, senza che questo faccia sballare l’economia dello studio.
In effetti, già da adesso, qualcosa del genere avviene. Per esempio, questo pezzo lo avrebbe potuto scrivere in pochi secondi una intelligenza artificiale ben addestrata ad imitare la mia scrittura. E per i pezzi successivi, la scrittura di Nadia Bakhtafrouz, autrice delle interviste che seguono. A proposito, siete sicuri che Nadia esista veramente e non sia uno pseudonimo utilizzato dall’intelligenza artificiale? Il paradosso più divertente è che le risposte all’intervista, per esempio di Carlo Ratti, potrebbero essere state
anch’esse delegate all’intelligenza artificiale: per risparmiare tempo, lui che è una persona oberata di impegni. Insomma, una macchina che risponde a una macchina. Eppure, chiunque le abbia scritte, le risposte, proprio perché avvalorate dall’Autore, sono da considerare autentiche. D’altra parte, prima dell’intelligenza artificiale accadeva qualcosa di simile. I discorsi dei politici o dei capitani di industria erano dalla prima all’ultima riga scritti da ghostwriter, ma nessuno si sognava di non attribuirli al pensiero del personaggio che li aveva commissionati. Un lavoro simile di appropriazione avveniva negli studi professionali dove si rapinava il contributo di brillanti e giovani progettisti che al massimo venivano citati in qualche paginetta dedicata ai credits del progetto.
Se Behrens non citava Mies van der Rohe e, poi, Mies van der Rohe non citava Lilly Reich, per quale motivo dovremmo citare tra i coautori dei nostri lavori l’intelligenza artificiale?
Tranquilli: Nadia esiste veramente e ha elaborato lei le domande. Carlo Ratti ha risposto personalmente, così come hanno fatto Massimo Roj e gli altri intervistati.
Dalle interviste capiamo che più ragioniamo dell’IA e più scopriamo che ci destrutturerà profondamente, un po’ come è avvenuto con l’introduzione dei computer e dei programmi Cad una trentina di anni fa. Le tecnologie, per quanto cerchiamo di tenerle al guinzaglio e con la museruola, non sono mai neutrali. In un modo o nell’altro ci trasformano facendoci vedere il mondo da punti di vista originali e a volte inauditi. Ecco perché abbiamo pensato di dedicare un crescente spazio della rivista a queste problematiche. Se il modo di fare architettura cambierà e non di poco, vorremmo cercare di capire come.

Secondo il curatore della Biennale di Architettura di Venezia 2025 l’IA fornisce ottime risposte se sappiamo formulare le domande giuste. A noi umani il compito di dire ciò che ancora non è stato detto e di pensare ciò che ancora non è stato pensato

A destra, City of Plants. Alla Biennale di architettura di Venezia, l’installazione di Mad architects reimmagina le nostra interazioni con la natura attraverso un dialogo mediato dall’intelligenza artificiale.
Professor Ratti, che ruolo occupa a suo avviso l’intelligenza artificiale nell’architettura contemporanea? Vede rischi o limiti nel suo uso? Penso all’IA come a un nuovo paio di occhiali: ci permette di vedere il mondo in maniera nuova. Al Senseable City Lab e a CRA-Carlo Ratti Associati la usiamo per capire molti aspetti della città: clima, mobilità, flussi energetici e i ritmi sociali che li legano, in una linea di ricerca che va da Ildefonso Cerdà, il padre della Barcellona moderna, appassionato di dati, fino a William H. Whyte, che usava nuovi strumenti visivi per studiare la vita urbana di New York. Rischi? Moltissimi, ma anche grandi opportunità. Dobbiamo darci gli obiettivi
giusti. Come diceva il grande architetto radicale inglese Cedric Price: “la tecnologia è la risposta, ma qual è la domanda?”
Che ruolo ha avuto l’IA nella gestione e organizzazione della Biennale di Architettura 2025? Dietro le quinte ha sostenuto la sintesi dei materiali, la produzione di didascalie brevi (di cui si è molto parlato), i percorsi e i test di orientamento. In pubblico è diventata parte dell’infrastruttura con due progetti di accompagnamento, o companion. Il primo companion è stato Spatial Intelligens, sviluppato da sub, che ha anche curato l’intero allestimento. È un gemello digitale accessibile dal telefono che

Il robot umanoide
Alter3 dell’installazione
I’m I a Strange Loop? di Takashi Ikegami e Luc Steels. Foto Andrea Avezzù (Biennale di Venezia) e Moreno Maggi.

riconosce la posizione del visitatore con una singola foto e restituisce contenuti pertinenti in quel punto. La guida conversazionale è addestrata sull’intero corpus della mostra e suggerisce rimandi e percorsi alternativi. Al termine del giro, il visitatore può ricevere un resoconto privato del proprio cammino: una mappa delle aree di attenzione. L’obiettivo è la riflessione, non la sorveglianza, con dati aggregati e anonimizzati per capire come si attraversa e si legge una Biennale. Il secondo companion è l’Ultimate Biennale Companion, sviluppato da Volume Magazine. È una guida audio generata mettendo in gioco 36 voci e registri differenti, da Gio Ponti a figure contem -
poranee. Il fine è tradurre il linguaggio degli addetti ai lavori in forme accessibili, aprire il dibattito e mostrare come significati diversi possano nascere dallo stesso contenuto. Insieme, questi progetti spostano la Biennale da vetrina statica a laboratorio dinamico: la tecnologia diventa un modo per interagire meglio con il pubblico.
Quali sperimentazioni sull’IA state conducendo attualmente al Senseable City Lab del Mit? Ci può fare esempi recenti? Molti progetti. Uno che mi sta molto a cuore ha a che vedere con gli spazi pubblici, che fin dall’origine delle città, da diecimila anni,
ne sono il cuore. Al Mit Senseable City Lab stiamo conducendo diverse sperimentazioni sull’uso dell’IA per migliorare gli spazi pubblici urbani. Un esempio recente è la collaborazione con università come Yale e Harvard, in cui abbiamo utilizzato l’IA per analizzare filmati di spazi pubblici di New York, Boston e Philadelphia, confrontando immagini degli anni Settanta con quelle più recenti. Grazie all’IA, siamo in grado di esaminare questi filmati con una precisione che prima richiedeva mesi di lavoro manuale. L’analisi ha rivelato cambiamenti significativi nel comportamento delle persone, come l’aumento della velocità di camminata e la




Accanto e in alto a sinistra Ancient Futures la mostra di BIG dove un braccio robotico e due artigiani bhutanesi collaborano nell’intaglio di travi destinate al nuovo aeroporto di Gelephu.
In alto a destra e nella pagina di sinistra, CoPoiesis, di Philip F. Yuan e Bin He (Shanghai): carpenteria tradizionale e precisione robotica per trasformare legname di recupero in un nuovo spazio architettonico. Foto Moreno Maggi.
le? Quali nuovi componenti emergono in una città sensibile ai dati?
diminuzione delle interazioni sociali. Ma l’IA, che è parte del problema, può anche diventare parte della soluzione. Ci consente di testare rapidamente nuove soluzioni di design e di monitorarne l’impatto sul comportamento. L’uso di questi strumenti non serve solo a ottimizzare gli spazi, ma anche a progettare con maggiore consapevolezza e attenzione alle esigenze delle comunità, tenendo conto del cambiamento climatico e delle dinamiche sociali.
Se l’IA analizza dati, simula scenari e ottimizza forme, cosa resta all’intuizione dell’architetto? L’IA può togliere terreno a chi replica modelli o esegue compiti ripetitivi. Resta l’invenzione di ciò che non è ancora stato immaginato. L’IA legge il passato e genera forme plausibili, ma le manca la scintilla che nasce da intuizione, contesto e rischio. Con gli strumenti attuali non produce una nuova Fallingwater o una nuova Farnsworth House. Bruno Zevi ricordava che gli autori autentici sono pochi, poi vengono i
letterati e i plagiatori. L’IA potrà forse sostituire i secondi e i terzi, non i primi. Il compito più bello resta nostro: inventare ciò che ancora non esiste. Ci saranno sempre nuove sfide da risolvere per le persone e, proprio perché siamo persone, siamo i più adatti a farlo. L’IA è un ottimo strumento.
In che modo l’uso dell’IA sta trasformando il ruolo dell’architetto?
Nel libro Open Source Architecture, una decina d’anni fa, cercavamo di pensare a una nuova figura di architetto, più collaborativa: l’avevamo chiamato ‘l’architetto corale’. Si passa dall’autore solitario al direttore di molte intelligenze: naturali, artificiali, collettive, per usare il titolo di quest’anno alla Biennale di Architettura. In questo senso, l’IA ha chiaramente un ruolo, insieme alle altre intelligenze.
Come l’IA sta cambiando la concezione dello spazio architettonico e la percezione sensoria-
L’IA, per il momento, ci permette soprattutto di analizzare dati e quindi capire meglio la città. Ne parlavamo prima a proposito dello spazio pubblico. Un altro esempio: di recente abbiamo lavorato a un progetto del Mit Senseable City Lab chiamato Slowing by Design Ci siamo chiesti dove le persone rispettano davvero il limite dei 30 km/h. Abbiamo addestrato un modello su oltre 51 milioni di punti di telemetria e migliaia di immagini Street View tra Milano, Amsterdam e Dubai. Il risultato è intuitivo ma finalmente misurabile: la geometria e il design delle strade governano il comportamento. Corsie strette e senso di contenimento con alberi e fronti edilizi che tengono la strada e poco cielo visibile portano a velocità più basse. Carreggiate ampie e tanto cielo invitano alla velocità. In sintesi, il design conta più della segnaletica. Il modello prevede il rispetto del limite isolato per isolato, così le città possono intervenire dove serve: stringere un raggio, inserire un’aiuola centrale o una fila di alberi, recuperare una corsia di svolta, testare per una settimana un allargamento del marciapiede e misurare di nuovo. Niente sermoni e meno multe: strade che chiedono lentezza con gentilezza.
Lei parla spesso di empowerment tecnologico e non di sostituzione. C’è un limite oltre il quale l’architetto smette di decidere? Chi ha l’ultima parola in un progetto guidato dall’IA?
L’ultima parola spetta agli esseri umani, all’interno di un chiaro mandato pubblico. I modelli possono proporre, le persone devono disporre.
In un futuro prossimo, l’IA potrà disegnare cit-
Tra i progetti in mostra nella sezione Artificial della Biennale di Carlo Ratti, l’installazione Biotopia (sotto a sinistra), di Winy Maas (Mvrdv) con un film di The Why Factory, e dell’artista Federico Diaz. Foto Celestia Studio.
Sotto a destra. Calculating Empires: a Geneaology of Technology and Power since 1500, di Kate Crawford e Vladan Joler. Foto Luca Capuano.



tà in tempo reale adattandole a flussi, bisogni e stati d’animo. Utopia inquietante o nuova architettura dinamica?
Sulla base delle ricerche di cui parlavamo, oggi camminiamo più in fretta, sostiamo meno e ci incontriamo di meno rispetto agli anni Settanta. Se la tecnologia ci ha spinti verso gli schermi, può anche aiutarci a tornare nelle piazze. Architettura dinamica significa un ciclo civile di ipotesi, prova, misura e correzione su sedute, ombra, acqua, microclima, giochi pubblici e piccole geometrie che favoriscono l’incontro. L’importante è che alla fine di questo processo siano sempre i cittadini a decidere che tipo di città vogliono.
Nel suo lavoro lei sottolinea anche le implicazioni etiche della progettazione tecnologica. Quali responsabilità ha oggi un architetto che usa sistemi basati su IA?
Ne parliamo attraverso molti progetti nella selezione della Biennale di Architettura a Ve-
nezia di quest’anno. Lo avevamo già esplorato nel 2019 alla Bi-City Biennale di Shenzhen con il tema Eyes of the City. Direi che la cosa fondamentale è la trasparenza: che dati vengono raccolti? Su quali dati vengono addestrati i modelli? Questo è sempre più importante oggi, dato che i modelli assomigliano sempre di più a scatole nere, black boxes, come si dice in gergo.
Possiamo ancora parlare di autorialità in architettura nell’epoca dell’IA generativa o stiamo andando verso una progettazione più collettiva e dis-individualizzata?
Assolutamente sì: il compito dell’architetto è tenere insieme il coro, a cui oggi partecipano anche voci artificiali, in una forma chiara, e poi assumersene la responsabilità.
Quale messaggio vuole rivolgere ai giovani architetti e progettisti in formazione? Come prepararsi a un futuro in cui l’IA sarà parte del mestiere?
Allenate il vostro bullshit detector, come lo chiamava Hemingway. Si potrebbe tradurre in “rilevatore di sciocchezze”. Cioè: capire, in questo mondo in trasformazione, ciò che è importante e ciò che non lo è.
Si è reso conto che le domande per questa intervista sono state generate dall’IA?
A dirla tutta, potrebbero esserlo anche le mie risposte. Le confesso che il mio team già da due anni usa un sistema che internamente chiamiamo CarloGPT: contiene tutte le mie risposte passate. Se una nuova risposta è legata a quelle precedenti, l’IA produce risultati ottimi, che approvo immediatamente con piccolissime modifiche. Ma se si tratta di una risposta che non è mai emersa prima, il sistema produce allucinazioni.
È lì che serve l’intelligenza umana: per dire ciò che non è ancora stato detto e pensare ciò che non è ancora stato pensato ■










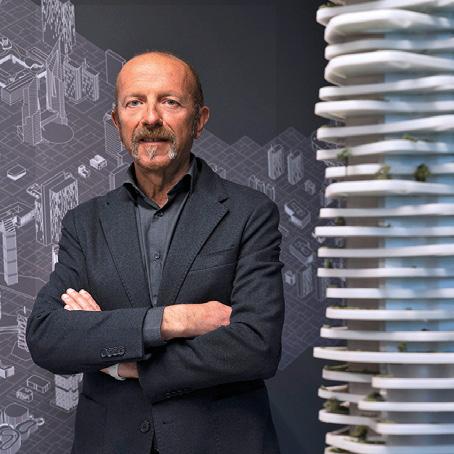
Massimo Roj è socio fondatore e amministratore delegato di Progetto CMR, una delle principali società di progettazione integrata che oggi conta più di 200 collaboratori e conta al proprio attivo oltre 4mila progetti. www.progettocmr.com
L’adozione dell’intelligenza artificiale in una delle prime società di progettazione integrata italiane. Velocità, controllo ottimizzazione precisione e coerenza. Ma con un approccio consapevole e la supervisione critica di ogni passaggio. Ne parliamo con Massimo Roj
Architetto Roj, che idea si è fatto, a livello personale, del potenziale e dei limiti dell’intelligenza artificiale in architettura?
Personalmente, considero l’Intelligenza Artificiale un metodo evoluto di supporto alla progettazione: un insieme di strumenti e processi capaci di elaborare grandi quantità di dati in modo sempre più preciso ed efficiente. In altre parole, l’IA rappresenta un modo di operare, un approccio che sfrutta la potenza del calcolo e dell’analisi predittiva per accompagnare il lavoro dell’uomo, senza sostituirlo. All’interno di questo metodo, la tecnologia gioca un ruolo centrale: consente ai sistemi di imparare dall’esperienza e di adattarsi ai dati ricevuti, riducendo l’intervento umano su attività ripetitive e lasciando più spazio a ciò che davvero conta nel nostro lavoro: la creatività e l’innovazione. In ambito architettonico, questi strumenti possono rappresentare un’opportunità per ottimizzare il flusso di lavoro in tutte le sue fasi.
Ma il punto fondamentale, a mio avviso, è che la tecnologia – qualsiasi tecnologia – deve rimanere al servizio della creatività umana, mai sostituirla. Il progetto nasce dall’ascolto, dalla relazione con il cliente, dalla capacità di interpretare i suoi desideri e trasformarli in spazi significativi. L’IA può aiutare a creare soluzioni su misura, allineate alle esigenze specifiche di chi quegli spazi vivrà. In questo senso, il suo potenziale è enorme, soprattutto se applicato
a una visione di progettazione integrata tailor-made, che da sempre distingue Progetto CMR. Tuttavia, è importante essere consapevoli anche dei limiti: se si cede alla tentazione di delegare troppo all’IA, si corre il rischio di una certa omologazione nelle proposte, una perdita di identità. L’architettura è – e deve restare – un processo profondamente umano, fatto di intuizione, empatia, visione.
È stato favorevole fin da subito al suo utilizzo o ha maturato questo approccio nel tempo?
Ho maturato il mio approccio all’IA dopo essermi messo in ascolto, essermi informato e aver osservato come questa tecnologia si fa strada nella nostra quotidianità a diversi livelli e toccando i settori professionali più diversi. Inizialmente nutrivo qualche riserva, soprattutto legata alle implicazioni etiche e al timore di un’eccessiva dipendenza dalla tecnologia. Tuttavia, con il tempo ho riconosciuto che, se utilizzata in modo consapevole e responsabile, l’IA può rappresentare un’opportunità preziosa per migliorare processi, ottimizzare il lavoro e aprire nuove prospettive anche in ambiti inaspettati. Un cambiamento di visione che è avvenuto gradualmente.
Che ruolo ha oggi l’IA nei progetti di Progetto CMR?
In Progetto CMR utilizziamo alcuni tool che, se conosciuti e usati correttamente, possono

ottimizzare la gestione del processo di lavoro, accelerare i processi decisionali e potenziare il pensiero critico dei professionisti. Come? Attraverso l’inserimento di prompt engineer accanto ad architetti, designer e ingegneri nei nostri team composti da competenze complementari e specialistiche. Queste figure sono capaci di declinare al meglio i nuovi servizi di intelligenza artificiale generativa applicati al nostro ambito professionale.
Avete dedicato un’area specifica o una figura professionale al lavoro con l’intelligenza artificiale?
Abbiamo affidato la regia dell’implementazione e ottimizzazione dell’IA al nostro dipartimento di Ricerca & Sviluppo, che lavora in stretta sinergia con i responsabili delle diverse unità e società del Gruppo. Questo approccio ci consente di intercettare le esigenze specifiche di ciascun ambito e costruire un workflow coerente con la visione aziendale.
In quali momenti del processo progettuale integrate strumenti basati su IA?
Sono strumenti che trovano applicazione in diverse fasi del processo progettuale, sia in architettura che in ingegneria. Nelle prime fasi, possono facilitare l’analisi del contesto, dei dati urbanistici e ambientali, contribuendo a una lettura più efficace e veloce delle informazioni utili alla progettazione. Man mano
Studio per interni L’applicazione, con strumenti di IA, in un progetto di hospitality di un moodboard creato in studio per valutarne l’esito in termini di atmosfera generale resa estetica relazione con la luce naturale e il mood complessivo.

che il progetto si sviluppa, possono intervenire nel controllo delle interferenze tra discipline, nell’ottimizzazione di soluzioni tecniche o nella gestione delle varianti, supportando così una maggiore precisione e coerenza. Abbiamo scelto di integrare strumenti, alcuni sviluppati direttamente in-house, nelle fasi in cui l’elaborazione rapida dei dati e la generazione di scenari alternativi possono offrirci maggiore agilità e capacità di risposta. Tuttavia, ogni output viene sempre interpretato e verificato dai nostri professionisti, per garantirne coerenza con gli input progettuali e la visione generale. Anche nelle fasi avanzate, l’IA può supportare il progetto, ma è sempre la competenza umana a renderlo concreto e affidabile.
Dal punto di vista operativo e tecnico, come gestite l’implementazione dell’IA nei flussi di lavoro?
La nostra idea di progettazione è evoluta: l’innovazione digitale è una leva potente, ma è la visione del progettista a dare senso ai dati e a trasformarli in architettura. Non ci limitiamo a seguire i dati: li interpretiamo, li lavoriamo e li mettiamo al servizio del progetto. Ogni informazione viene analizzata criticamente lungo tutto il processo, affinché la tecnologia non sostituisca, ma migliori le nostre potenzialità
Quali sono, ad oggi, gli strumenti o le applicazioni AI che ritiene più utili o promettenti?
Sono quelli che riguardano l’intelligenza artificiale generativa e la simulazione in tempo reale, capaci di esplorare in pochi istanti soluzioni progettuali ottimizzate per contesti ambientali e urbanistici. Ma usiamo anche altri strumenti per entrare nell’analisi di dettaglio di dati che possono contribuire a rendere più efficiente un progetto, come ad esempio le piattaforme di analisi energetica, dotate di algoritmi predittivi avanzati. In parallelo, stiamo sviluppando internamente applicativi basati su AI che sono totalmente automatizzati secondo il nostro approccio alla progettazione e che utilizziamo sia in fase di concept design che in fase di definizione di determinati progetti.
L’uso dell’IA ha modificato in qualche modo il linguaggio architettonico dei vostri progetti?
No, anzi. In un momento in cui si comincia a capire quanto ‘l’abbuffata’ di tecnologia rischi di portare a esiti di omologazione e appiattimento, è fondamentale orientare l’uso dell’IA nella direzione di consolidamento del proprio linguaggio e quindi della riconoscibilità del lavoro che ne deriva. Sostengo da sempre che l’operato di Progetto CMR è assimilabile a quello di un atelier di alta sartoria in cui l’abito è cucito dalle mani sapienti dell’artigiano sulle forme e sulle esigenze del cliente. Questa è la forza del nostro lavoro che dobbiamo custodire, l’architrave del nostro pensiero proget-


Concorso Concept inserimento nel contesto e ambientazione di una struttura ricettiva in alta quota.
Camera Inserimento paesaggistico di una microarchitettura in un ambiente estremo e fragile come quello dell’alta montagna.
tuale. Vero è anche che alcuni strumenti, se usati consapevolmente, si stanno rivelando efficaci nell’agevolare sia il lavoro dei singoli progettisti che di team multidisciplinari che, per esempio, possono verificare più velocemente l’impatto delle soluzioni proposte mettendosi nelle condizioni di scegliere la migliore.
Come vede il rapporto tra controllo umano e generazione algoritmica nel processo creativo? Non ridurrei il rapporto solo al controllo. Una proposta differente può affiancare o modificare l’idea iniziale, oppure consolidare la propria scelta, rafforzando la convinzione di portarla avanti. L’elemento generato dall’algoritmo può diventare uno stimolo, un punto di partenza o di deviazione. Dall’errore, dall’incidente di percorso, dalla sbavatura può nascere l’idea vincente per il progetto. Quando si parla di creatività, infatti, dobbiamo essere aperti e pronti a riconoscere e a raccogliere l’input giusto da ovunque arrivi – che sia umano o generato da una macchina. In questo senso, il rapporto non è di competizione, ma di collaborazione, dove il ruolo umano resta centrale nell’attribuire senso, direzione e valore a ciò che emerge.
Che consiglio darebbe ai giovani architetti che si affacciano oggi alla professione in un contesto dominato dalla tecnologia?
Proprio nel nostro oggi che sembra caratterizzato dall’urgenza di acquisire competenze nel ‘qui e ora’, il mio consiglio è programmare il proprio percorso di formazione sul lungo periodo, al di là delle contingenze: è questa la direzione che un giovane architetto dovrebbe seguire per costruire un futuro professionale sostenibile nel tempo. Educazione è futuro, ed è l’unica via per acquisire quegli strumenti indispensabili per leggere il mondo e i suoi inevitabili cambiamenti. Certo, saper dominare le tecnologie del proprio tempo è necessario – nessuno può sapere ora da cosa sarà superata l’IA, anche se oggi sembra uno tsunami che ha travolto il presente e che sembra destinato a rimanere per molto tempo – ma non dobbiamo dimenticarci che ciò che ha reso unico il nostro patrimonio culturale e artistico dal Medioevo a oggi è la pratica ‘dell’andare a bottega’: imparare sul campo da chi ha più esperienza, respirare e acquisire la sensibilità e il modus operandi che nel nostro lavoro, fatto di sfumature intangibili e di ineffabile senso di bellezza, saranno sempre l’elemento che fa la differenza ■
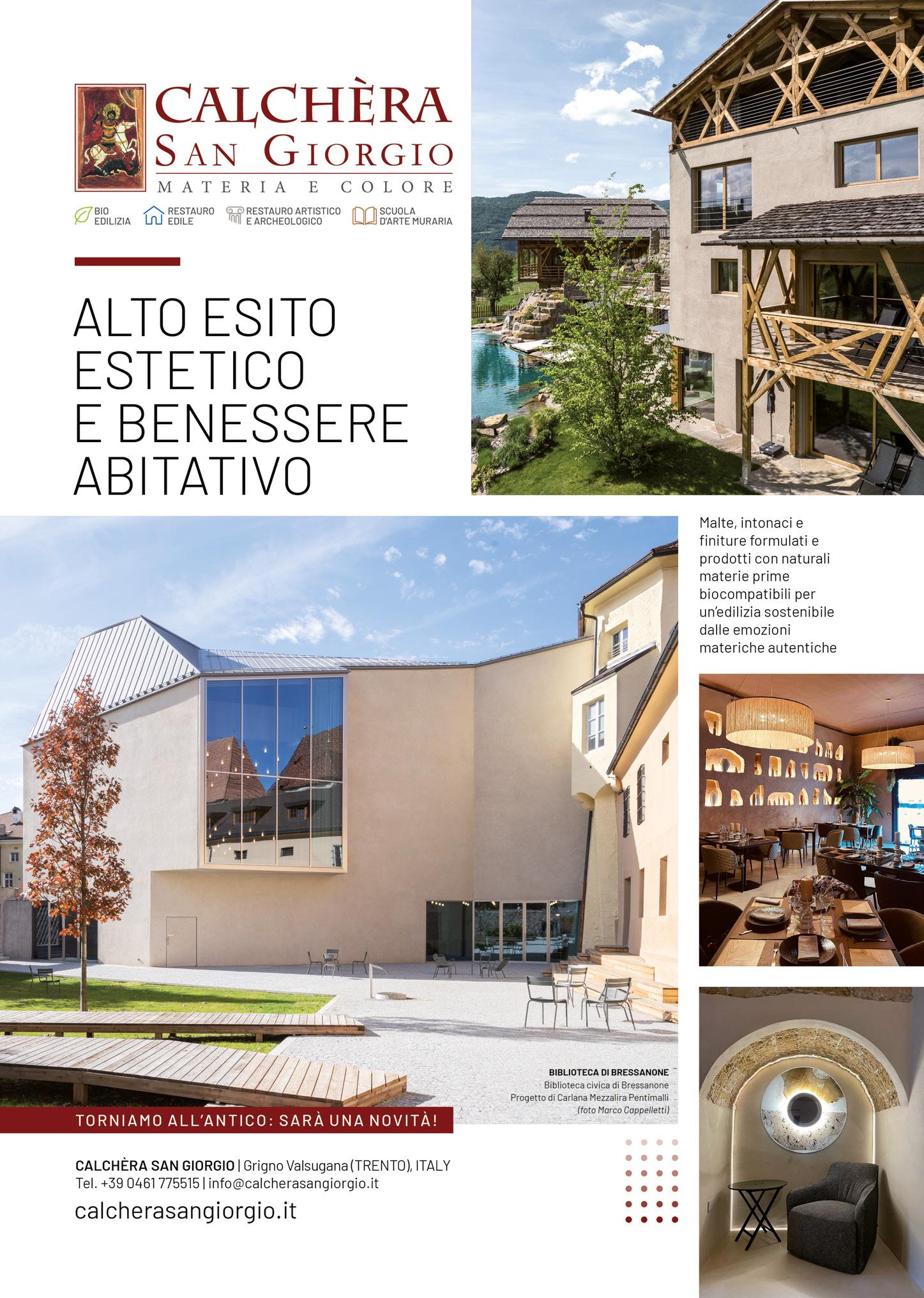

www.massimorusso.it
Le traiettorie della trasformazione indotta dall’IA sono tre: strumento creativo, dispositivo di ottimizzazione tecnica e prestazionale, nuova infrastruttura produttiva ed ecosistemica
di Massimo Russo
Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha cominciato a occupare un posto centrale anche nel mondo dell’architettura. Inizialmente vista come strumento per generare immagini suggestive, di fatto limitata alla fase iniziale di un concept, si sta rivelando sempre più in grado di incidere su ogni fase del processo: dall’ideazione alla simulazione, dall’ottimizzazione fino alla fabbricazione.
Pur trattandosi di categorie inevitabilmente semplificate, tre sono le traiettorie principali attraverso cui leggere questa trasformazione: l’IA come strumento creativo e identitario (generazione di linguaggi visivi, stili e narrazioni progettuali); come dispositivo di ottimizzazione tecnica e prestazionale (analisi dei dati, simulazioni, efficienza energetica e strutturale); e come infrastruttura produttiva ed ecosistemica (integrazione nei processi di fabbricazione digitale e nei flussi di produzione). Sarebbe utile chiarire anche di quale modello di IA stiamo parlando. Esistono infatti sistemi basati su machine learning e altri fondati su deep learning. Quest’ultimo è spesso definito una ‘scatola nera’ (opacity problem): produce risultati efficaci, quelli più interessanti, ma il suo funzionamento interno rimane in larga parte oscuro anche agli sviluppatori. Ciò significa affidare decisioni tecniche, talvolta persino vitali, a strumenti di cui non conosciamo davvero i meccanismi decisionali, con tutte le implicazioni e i rischi che ne derivano. Un altro punto riguarda la natura stessa delle piattaforme.

Da un lato troviamo le IA open source, come Stable Diffusion, che non rimandano soltanto a un modello tecnico ma a una genealogia culturale precisa, la controcultura americana degli anni Settanta, con figure come Stewart Brand, promotori di un sapere tecnologico libero e condiviso.Dall’altro lato vi sono i servizi regolati da logiche economiche e da un accesso chiuso ai modelli, come MidJourney Il tema dell’accessibilità libera e universale all’IA sarà centrale.
AI come strumento creativo e identitario La prima traiettoria è probabilmente la più immediata e visibile: l’uso dell’AI come generatore di forme e linguaggi. Coop Himmelb(l)

au, con il progetto Deep Himmelb(l)au, ha addestrato un sistema generativo sul proprio archivio, ottenendo variazioni coerenti con la storia dello studio.
In questo modo l’IA diventa una sorta di ‘memoria viva’ capace di produrre continuità linguistica pur introducendo elementi di novità; Daniel Bolojan, con GAN e CycleGAN, ha reinterpretato il linguaggio di Gaudí; Refik Anadol ha utilizzato dataset sterminati e tecniche di IA generativa per trasformare facciate e musei in superfici vive, con proiezioni immersive che rendono l’architettura un supporto dinamico di immagini e dati, come nella celebre installazione alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. In tutti questi casi l’IA di -
venta uno strumento creativo, non sostitutivo ma amplificatore, aprendo a nuovi possibili linguaggi.
Dispositivo di ottimizzazione tecnica
La seconda traiettoria riguarda l’uso dell’IA come strumento di calcolo, analisi e ottimizzazione. Qui la tecnologia si manifesta meno come immaginazione visiva e più come capacità di gestire complessità e accelerare processi.
Foster + Partners, attraverso il gruppo interno Applied Research and Development, ha sviluppato tecniche di surrogate modelling per le simulazioni energetiche e strutturali, algoritmi multi-obiettivo come Hydra. Autodesk Forma
Progetti di Massimo Russo basati su iterazioni generate con intelligenza artificiale. Sopra, Nanotechnology desalination platforms
A sinistra. Industrial spaces and research centers for the production of Minimodular nuclear reactors

(già Spacemaker ), propone scenari urbani ottimizzati in tempo reale, già applicati in progetti di studi scandinavi come Lund Hagem. XKool, in Cina, ha realizzato la piattaforma LookX, IA che integra generazione formale, vincoli normativi, costi e parametri ambientali in un unico ambiente operativo.
In questo contesto si inseriscono anche le ricerche di Zaha Hadid Architects, che hanno esplorato l’IA attraverso tecniche di agent-based modelling e simulazioni comportamentali.
Integrazione nei processi di fabbricazione digitale
La terza traiettoria riguarda la fabbricazione, dove l’IA non è più soltanto un supporto al progetto, ma diventa parte integrante della produzione materiale. Qui il tema non è tanto l’immaginazione di forme, né la simulazione prestazionale, ma il governo diretto dei processi produttivi.
AI Build, startup londinese, ha sviluppato sistemi che monitorano e correggono in tempo reale i processi di stampa 3D, puntando a una fabbrica autonoma, capace di apprendere come un artigiano digitale. BAR Technologies, nata dal mondo della nautica da competizione, utilizza l’AI per progettare imbarcazioni senza passare dal disegno tradizionale,
sostituendo intere fasi di calcolo tecnico con modelli predittivi basati sui dati.
Sul fronte accademico, il laboratorio Icd di Achim Menges a Stoccarda esplora la convergenza tra IA, robotica e materiali, aprendo scenari in cui il progetto e la produzione si fondono in un continuum.
In conclusione
L’IA apre una profonda riflessione sulla natura dell’intelligenza stessa. Per Blaise Agüera y Arcas, autore del recente libro What Is Intelligence?, questi sistemi non sono soltanto strumenti, ma specchi che ci costringono a ridefinire cosa intendiamo per intelligenza. Per gli architetti, la sfida sarà confrontarsi in maniera critica. A mio avviso è evidente che molto, o forse tutto, della professione cambierà nei prossimi anni, ma di certo è impossibile evitare il confronto con una realtà che sarebbe riduttivo definire solo come strumento.
La seconda considerazione mi rimanda a un saggio di Heather Pringle ( The Origins of Creativity, su Scientific American, 2013), che ricostruisce il ruolo della creatività nell’evoluzione di Homo Sapiens.
È il pensiero associativo, e non quello analitico, ad aver acceso questa evoluzione: un big bang cognitivo iniziato circa 200mila anni
Sempre di Massimo Russo, a sinistra
Visions of future industrial spaces.
Liminal architecture
Sotto, Nanotechnology desalination platforms

fa e diventato evidente 40mila anni fa con le prime forme d’arte, come i graffiti rupestri nelle caverne, inspiegabili e privi di una funzione immediata. La creatività, proprio perché spesso ‘inutile’, si è rivelata essenziale per il progresso. La storia dell’evoluzione suggerisce che sono i collegamenti inattesi, le idee laterali e apparentemente inutili, ad aprire strade nuove. Al contrario, quando il pensiero resta chiuso in schemi analitici e specialistici, tende a custodire l’esistente più che a generare futuro.
Metaforicamente L’IA, come generatore di forme e linguaggi, sta ora sviluppando le sue connessioni sinaptiche. È il momento della sua piena immaginazione, che in seguito si declinerà sempre più negli altri due aspetti di strumento di calcolo, analisi e sistema capace di governare la fabbricazione.
Personalmente amo questa dimensione della creatività, quella di una IA ‘inutile’ ma bella: è lì che il mio pensiero associativo la incontra. Mi spaventa invece quando svilupperà al massimo il suo pensiero razionale, perché quella soglia appartiene al mondo del controllo ■


Anche lo studio di Michele De Lucchi sta sperimentando l’uso generativo dell’IA. Ma coltivando il valore dell’esitazione e dubitando delle certezze espresse dal ‘cervello tecnico’. Per non rinunciare alla libertà e alla nostra capacità di giudizio
L’intelligenza artificiale è un contenitore di infinite informazioni, raccolte, elaborate e restituite a chi ne fa richiesta. Ciò che ci spinge a rivolgerci alla macchina è l’esitazione che ci coglie quando dobbiamo scegliere tra differenti possibilità – se non avessimo dubbi non ne avremmo bisogno – ed è sorprendente come invece l’AI non esiti, non abbia dubbi nel fornirci una risposta. Non mostra dubbi neppure, se ci dichiariamo insoddisfatti, nel cambiare le proprie risposte. Ma sono proprio i dubbi, l’esitazione nelle scelte, persino gli sbalzi d’umore, che fin qui ci hanno definito come esseri liberi. Sta a noi mantenere viva la nostra capacità di giudizio, di osservazione, di riflessione. Nel 2017 in Amdl Circle abbiamo iniziato a riflettere su come immaginare il futuro. È in quegli anni che nasce il progetto delle Earth Stations: visioni architettoniche pensate non per essere realizzate così come sono, ma per offrire spunti, ipotesi, prospettive. Sono nate dalla percezione che il mondo stesse accelerando a una veloci-

tà travolgente rendendo difficile per il mestiere dell’architetto, con i suoi tempi e le sue fasi, stare al passo con le trasformazioni in atto. Le Earth Stations sono architetture che propongono nuovi scenari. Le quattro famiglie che abbiamo immaginato – Interactors, Many Hands, Education Stations, Happy Stations – sono strumenti per lavorare insieme, costruire con le mani, imparare, abitare in modi nuovi. Strumenti per anticipare e stimolare il cambiamento. Fin dall’inizio, questi progetti sono stati guidati da quella che potremmo chiamare intelligenza naturale: una sensibilità per l’artigianalità, per l’integrazione nei luoghi in cui ci si inseriscono, per il gesto manuale come parte inscindibile dell’atto progettuale. Già allora, queste forme venivano immaginate secondo princìpi che oggi, in pieno dibattito sull’AI, si rivelano ancora più attuali. Oggi stiamo sperimentando l’uso generativo dell’intelligenza artificiale nei nostri processi. Lo facciamo con la curiosità di chi cerca un nuovo
strumento, ma senza rinunciare alla parte artigianale che ci definisce. Ci interroghiamo su come ottimizzare l’IA dal punto di vista generativo o dell’elaborazione dei dati, ma sempre nel rispetto della componente umana del progetto. Accanto al valore del dubbio, c’è quello della costruzione manuale, del pensiero imperfetto, del dettaglio. Crediamo in un’architettura che sia al tempo stesso spirito del tempo e strumento critico. Un’architettura capace di accogliere la complessità e di restituirla in forme che ispirano, più che risolvere.
Nel nostro mestiere, la velocità può essere un nemico. Ma l’esitazione, se ben praticata, è uno strumento di saggezza ■
AMDL Circle, EarthStations Interactors, Moat Station. ©Filippo Bolognese Images.



Secondo un sondaggio internazionale di Architizer e Chaos
3 architetti su 4 ritengono che l’IA guiderà l’innovazione nel progetto, ma più della metà degli intervistati ne sottolinea gli attuali limiti per l’architettura
Recentemente Architizer, la più grande comunità online di architetti al mondo, e Chaos, che commercializza software di visualizzazione come V-Ray e Enscape, hanno svolto un sondaggio tra 1.227 architetti e ingegneri di Stati Uniti, Regno Unito, India, Canada, Italia, Messico, Australia, Germania, Portogallo e Brasile sull’impiego dell’IA nella professione. Quasi la metà di loro – il 46 per cento in media, con punte del 55 per cento tra gli studi con meno di 20 dipendenti e tra quelli con più di 100 – impiega già l’IA nei flussi di lavoro dello studio, e il 23 per cento si appresta a farlo nel prossimo futuro. Generalmente, l’adozione è avvenuta senza una specifica formazione: ben il 60 per cento degli intervistati ha iniziato a usare e preso confidenza con gli strumenti dell’IA da autodidatta.
Per fare cosa? L’applicazione di gran lunga più comune dell’IA nella progettazione architettonica è la generazione di immagini da prompt di testo, mentre si sta diffondendo rapidamente anche l’editing delle immagini e la generazione di immagini da input di modelli.
Tutti gli altri impieghi, come layout o piani di larga scala, studi di fattibilità, analisi dei codici edilizi e dell’efficienza energetica sono usati in percentuali pari o inferiori al 25 per cento. Secondo l’indagine, l’ampia soddisfazione riscontrata nella generazione di rendering e in generale nello sviluppo delle fasi iniziali di un progetto cala drasticamente nelle fasi di progettazione successive: gli strumenti dell’IA dovrebbero offrire maggiori possibilità di controllo sulle immagini generate (per il 62% degli intervistati); consentire di convertire un’immagine 2D in una scena 3D (per il 58%); creare e visualizzare materiali sulla base di un prompt di testo (per il 55%); suggerire l’illuminazione e le ombre corrette di una scena 3D (per il 52%) e, a partire dal concept iniziale, saper generare disegni operativi di lavoro secondo quasi la metà degli intervistati.
Tra gli early adopters, la convinzione che l’IA influenzerà fortemente il settore dell’architettura è doppia rispetto a coloro che ancora non ne


fanno uso, i quali si dimostrano più scettici riguardo alla sua effettiva utilità. Ma c’è da notare anche un’ulteriore polarizzazione tra i professionisti che già ne fanno uso: se il 34 per cento che dichiara che l’IA ha ‘notevolmente accelerato’ il processo di progettazione, il 53 per cento definisce invece tale differenza solo ‘marginale’. Il che può dipendere anche dalla specializzazione dei rispondenti, con le società di ingegneria che sono quasi due volte più propense a segnalare una forte accelerazione dei processi rispetto a quelle di architettura, interior design e progettazione del paesaggio. È indubbio che l’IA è qui per restare: diventerà una componente stabile dei flussi di lavoro di architetti e ingegneri e solleverà questioni antiche, come i rischi per i posti di lavoro (il 52 per cento degli intervistati si dichiara molto o abbastanza preoccupato, il 48 per cento per niente) e di carattere etico, specialmente quando si tratterà del risultato finale del processo di progettazione: tra intervistati su quattro auspicano una legislazione o delle linee-guida che permettano di stabilire criteri condivisi in termini di proprietà intellettuale, qualità nei processi di produzione e soprattutto l’esplicita dichiarazione di avere impiegato strumenti di IA nello sviluppo del progetto ■
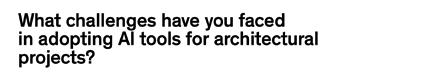
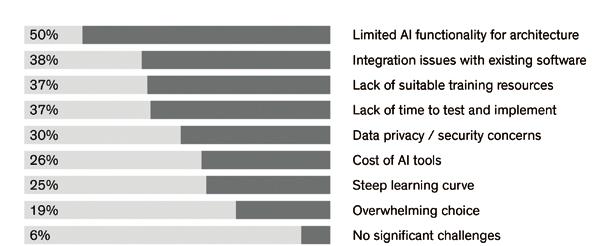



















































Abbiamo chiesto ad alcuni studi di architettura italiani quale sia il loro approccio all’IA. Queste le risposte che abbiamo raccolto.

Paolo Balzanelli. Illustrazione generata con strumenti di IA per gli interni di una sede operativa.

ARKISPAZIO
Paolo Balzanelli
Nel nostro studio di architettura l’intelligenza artificiale è diventata, da qualche anno, un alleato prezioso a supporto del percorso progettuale. Abbiamo sempre utilizzato riferimenti visivi, palette cromatiche e moodboard per confrontarci con i committenti nelle fasi iniziali del progetto. Prima dell’arrivo dell’IA questo lavoro richiedeva tempi più lunghi. Oggi, grazie a strumenti come ChatGPT e MidJourney, possiamo ottenere più velocemente immagini di altissima qualità, capaci di restituire con precisione l’atmosfera che vogliamo comunicare. Gestiamo tutto internamente, senza figure dedicate: io stesso ho iniziato a formarmi su MidJourney, frequentando corsi e poi coinvolgendo i miei collaboratori. Il segreto sta nel trovare il linguaggio giusto per dialogare con l’IA e indirizzarne le potenzialità generative. In questo modo costruiamo suggestioni visive mirate ed immediate, che rendono la comunicazione con i clienti efficace e coinvolgente. L’intelligenza artificiale non sostituisce il progetto né la creatività dell’uomo, che resta insostituibile ed è ciò che conferisce il maggior valore alla qualità del progetto architettonico.
A-FACT ARCHITECTURE FACTORY
Giovanni Sanna
Per a-fact architecture factory l’IA è un amplificatore di possibilità. La integriamo nel processo creativo per spingere l’esplorazione di un’idea, generando in pochi minuti una varietà di immagini, opzioni e suggestioni a partire da schizzi, modelli fisici o 3D. Questo ci permette di intuire fin da subito limiti e potenzialità dell’i-
dea e di trasformare rapidamente l’ispirazione in ipotesi concrete, testando scenari che un tempo avrebbero richiesto giorni di lavoro. La usiamo anche per creare video che ‘danno vita’ ai progetti e, sempre più, per elaborare dati complessi – urbanistici, distributivi, climatici – in chiave progettuale. Tutto il team la utilizza, con strumenti come Stable Diffusion, Midjourney, Krea e Runway, senza un reparto dedicato. Il suo contributo è accelerare e moltiplicare le possibilità di verifica, ma anche stimolare nuove connessioni e visioni. La qualità, però, resta frutto della capacità dell’architetto di dare forma e senso a ogni progetto.
Alberto Lessan
Farebbe più effetto dire che siamo AI oriented, early adopters, che abbiamo cavalcato l’onda per primi e che ora siamo dei maestri, non solo nella progettazione basata sull’IA, ma anche nella gestione di tutto il processo. Oppure farebbe più effetto dire che essendo uno studio autoriale, ci opponiamo con forza alla rivoluzione, rifiutando tale mercificazione, siamo diffidenti e che abbiamo ritirato fuori i tecnigrafi dalla cantina.
Invece siamo esattamente a metà, nel guado, tra chi si tiene e aggrappa alla vecchia via, e chi guarda oltre la barriera.
Insomma vogliamo che, se questo nuovo sistema ci deve cambiare, lo faccia con calma, e con la giusta spontaneità, progetto dopo progetto. L’integrazione si diffonde per gradi e deve espandersi tra tutti i componenti dello studio. Lo deve fare in modo naturale e genuino. Solo così pensiamo possa trasformarsi in qualcosa di sano e migliorativo.
COMACCHIO ARCHITECTS
Paolo Didoné
Nel nostro studio stiamo affrontando con curiosità e positività l’arrivo dell’intelligenza artificiale. Siamo convinti che non vada temuta: spesso, chi la demonizza lo fa perché non la conosce o non sa come usarla. Pensarla come una minaccia è un errore; se invece ci si impegna a capirla e a usarla consapevolmente può diventare uno strumento potente, capace di affiancarci e migliorare molte fasi del nostro lavoro.
È una trasformazione che immagino simile a quella avvenuta con l’introduzione dei primi strumenti di disegno digitale nei personal computer. Nel nostro studio non ci sono figure specializzate in IA: stiamo imparando tutti, ogni giorno, a integrarla nei nostri processi. Dopo circa due anni di sperimentazione, possiamo dire che non ha cambiato e non cambierà il nostro modo di progettare, ma aiuta a velocizzare e potenziare molti processi, come la rappresentazione, la comunicazione e la ricerca: tutta quella parte di lavoro che fa da contorno al progetto, che richiede molte ore e che può contribuire a presentarlo meglio e quindi a farlo comprendere più facilmente ora può essere svolta in tempi più rapidi.
Troviamo l’intelligenza artificiale molto utile anche per ricercare velocemente risposte all’interno di regolamenti edilizi complessi, che in Italia variano da comune a comune.
È uno strumento utile, che va gestito con entusiasmo ma anche con responsabilità. I risultati generati spesso non sono corretti al 100 per cento: vanno controllati, corretti, modificati e gestiti da noi, esseri umani.
L’IA è uno strumento potente, al servizio dell’intelligenza che deve rimanere quella umana e forse ha un nome fuorviante, che rischia di portare a un uso improprio.

Concept progettuale di Migliore+Servetto per Campus Morandi, corte centrale con giardino. ©Migliore+Servetto.
GIULIANO-FANTI ARCHITETTI
Gaetano Giuliano
“La tecnica non è mai neutra: trasforma il mondo e, con esso, l’uomo stesso”. Questa riflessione di Martin Heidegger apre alla consapevolezza che ogni strumento tecnologico non è solo un mezzo, ma un modo di vedere e modellare la realtà. Allo stesso modo, nell’architettura l’IA non è solo supporto operativo, ma un nuovo linguaggio progettuale che modifica il nostro rapporto con lo spazio, il tempo e la creatività.
Il nostro studio utilizza l’intelligenza artificiale come supporto nella progettazione: un fantastico moltiplicatore che ci permette di indagare varianti morfologiche e spaziali, ottimizzare flussi e prestazioni o, ancora, generare concept visivi. Utilizziamo Midjourney, ChatGPT e Leonardo, senza tralasciare gli utilissimi strumenti integrati nei software Bim. L’IA, per quanto ci riguarda, ha già trasformato il modo di progettare rendendo più fluido il passaggio dall’idea alla simulazione, diventando un formidabile acceleratore per la creatività.
GIUSEPPE TORTATO ARCHITETTI
Giuseppe Tortato
Siamo stati tra i primi studi italiani a integrare l’intelligenza artificiale nei processi progettuali, adottandola in modo strutturato e continuativo già da diversi anni. L’IA non è per noi un esperimento, ma uno strumento attivo, trasversale e condiviso all’interno del team. La utilizziamo in varie fasi del progetto: dall’ideazione iniziale, come stimolo creativo e generatore di spunti morfologici, alla stesura di brief interni e alla produzione di visualizzazioni
concettuali rapide. Tra i progetti più emblematici vi sono l’albero in stampa 3D per il Certosa District, la panca contro la violenza sulle donne per Unipol e concept per installazioni e architetture in contesti nazionali e internazionali. Il nostro workflow alterna modellazione tridimensionale tradizionale e IA, creando un dialogo virtuoso tra umano e macchina. Non abbiamo un team dedicato esclusivamente all’IA: preferiamo che sia uno strumento orizzontale, accessibile a tutti, che arricchisce il confronto interno e moltiplica le prospettive.
L’intelligenza artificiale non sostituisce il progettista, ma ne amplifica il pensiero e la capacità di esplorazione. Riduce tempi e costi nelle fasi preliminari, democratizzando l’accesso alla complessità progettuale anche per studi di dimensioni contenute.
Ci sono però degli aspetti inquietanti. L’IA riflette visioni culturali dominanti e può rafforzare stereotipi estetici, imponendo modelli anglosassoni o asiatici. Esistono forme di censura algoritmica che, sotto apparenze neutre, limitano la libertà creativa. Per questo serve un uso critico e consapevole dell’IA: non solo come strumento tecnico, ma come spazio culturale da interrogare e trasformare.
Matteo Thun
Il nostro studio sta integrando questa nuova tecnologia all’interno dei processi lavorativi. Attualmente, tutti i nostri collaboratori utilizzano chatbot basati sull’IA per supportare la ricerca e la verifica di alcune fasi del lavoro. Consapevoli del grande potenziale offerto da questi strumenti, anche se utilizzati in modo basilare, abbiamo deciso di investire non solo in
Obr, render di Casa Bff. ©Obr.

formazione specializzata, ma anche nella creazione di un team dedicato, composto da nuove risorse focalizzate sulla ricerca e sulla digitalizzazione. Siamo convinti che l’intelligenza artificiale rappresenti non solo il presente, ma anche il futuro delle professioni, e saperla utilizzare a nostro vantaggio è fondamentale. Tuttavia, per noi rimane uno strumento al servizio del progettista, pensato per ottimizzare i processi senza compromettere la creatività.
La progettazione deve sempre partire da una visione personalizzata, con soluzioni su misura per il cliente – un aspetto che, al momento, nessuna IA è in grado di replicare con la stessa efficacia.
Ico Migliore e Mara Servetto
Il nostro approccio all’IA è pragmatico e in continua evoluzione. Attualmente, utilizziamo l’intelligenza artificiale per ottimizzare diverse fasi della progettazione, supportando la raccolta e analisi dati e offrendo valutazioni più approfondite su performance energetiche, impatto ambientale e fattibilità economiche. Per lo sviluppo di idee, ci avvaliamo di strumenti di IA generativa integrati in software di progettazione come supporto alla sintesi e ottimizzazione dei nostri obiettivi e ipotesi progettuali. Attualmente non abbiamo un gruppo dedicato o uno specialista esterno fisso, ma formiamo team internamente e collaboriamo con esperti su progetti specifici. Siamo convinti che l’IAcambierà radicalmente il nostro modo di progettare, migliorando l’efficienza e automatizzando compiti ripetitivi, così come il computer ha rivoluzionato il disegno e l’intero processo progettuale. Liberando più tempo per la ricerca personale, l’IA offrirà così ai progettisti maggio-
Open Project, render generato con Rendair a partire da un’immagine iniziale via via affinata con prompt mirati.

ri possibilità di esplorazione, coltivando quella creatività divergente teorizzata da J.P. Guilford che apre a esiti originali, oltre i limiti della creatività statistica dell’intelligenza artificiale.
Paolo Brescia
Per noi in Obr ogni progetto ha un valore unico e irripetibile. Per questo guardiamo all’IA non tanto come ad uno strumento per automatizzare l’architettura, quanto al modo per renderla ancora più sensibile al luogo e alla sua comunità. Crediamo in un’architettura ‘relazionale’ in cui tutto è interconnesso e in perpetua evoluzione. L’uso dell’IA - ChatGpt, Midjourney, Krea, ecc - fa parte della nostra ricerca: punto di partenza per porre le domande, per sperimentare, ma anche per mantenere uno spirito critico.
I ‘trucchi’, le scorciatoie euristiche, le criticità che diventano opportunità, restano per noi fondamentali: le buone idee nascono dalle connessioni trasversali, alimentate da emozione, intuizione, libero arbitrio e coscienza (anche collettiva, come nel nostro caso). È proprio qui che nessun programma auto-generativo può arrivare: servono introspezione, soggettività e il “per noi”. All’IA manca il senso di ciò che fa, perché non vive lo scorrere del tempo, non conosce la nostalgia di ciò che è passato, né l’attesa di ciò che verrà. Non riflette sul passato per interrogarsi sul futuro. Se il vero segno dell’intelligenza non è tanto la conoscenza quanto l’immaginazione, allora la lezione è: per usare bene l’IA che sa tutto senza capire nulla, dobbiamo saperla più lunga dell’IA. I computer sono precisi ma stupidi; noi siamo imprecisi ma intelligenti. Insieme possiamo fare molto.
Francesco Conserva
Open Project ha scelto di integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi con un approccio pragmatico e sperimentale a partire dal 2023. I LLM come ChatGPT e Copilot 365 supportano quotidianamente la progettazione attraverso predimensionamenti, analisi normative ed energetiche, confronti fra offerte, analisi prezzi, ricerche sui materiali e assistenza nelle varie fasi di concorsi e gare. L’uso avviene secondo protocolli di sicurezza che garantiscono protezione dei dati e rispondenza alle normative vigenti.
Parallelamente, lo studio impiega piattaforme IA per la visualizzazione, migliorando render preliminari e generando immagini o brevi video da modelli volumetrici grezzi per comunicare concept in modo rapido ed efficace, effettuare prove e sviluppare idee.
L’indirizzo futuro è quello di rendere l’IA un’estensione integrata del processo creativo e tecnico, liberando risorse per l’innovazione e accelerando fasi analitiche e progettuali.
PARK ASSOCIATI
Michele Rossi
L’approccio di Park all’intelligenza artificiale è gestito internamente dalla nostra Design Technology Unit, senza ricorrere a IA specialist esterni, per garantire coerenza con la nostra visione progettuale. ChatGPT potenzia le attività quotidiane: supporta le sessioni di brainstorming, la ricerca normativa e la sintesi di proposte progettuali, agevolando comunicazione e collaborazione fra i team. MidJourney e ComfyUI con Stable Diffusion
generano immagini concept e moodboard, accelerando l’esplorazione di linguaggi formali e atmosfere spaziali. Nella fase analitica, algoritmi Grasshopper guidano l’ottimizzazione parametrica di forma, prestazioni energetiche, comfort ambientale e processi costruttivi, permettendo simulazioni rapide e configurazioni multiple. Abbiamo inoltre sviluppato un chatbot interno che supporta la navigazione di Revit, i workflow Bim e le procedure organizzative, riducendo tempi di apprendimento e errori. Crediamo che l’IA trasformerà il design, migliorando efficienza, accuratezza e capacità di innovare, grazie a strumenti predittivi, automazione sostenibile e analisi avanzata dei dati, ridefinendo metodi e scenari progettuali.
Fabrizio Rossi Prodi
Seguiamo le innovazioni introdotte dall’IA da qualche anno, dapprima con un po’ di delusione per le risposte troppo casuali, sostanzialmente inefficaci, e limitate a suggerimenti occasionali per la produzione di concept, poi da 12-18 mesi invece favorevolmente impressionati dalla maggiore incisività e appropriatezza dello strumento. Lo utilizziamo per attività testuali, di reperimento informazioni, di sistematizzazione di dati. In campo visivo utilizziamo le applicazioni per il miglioramento di immagini renderizzate o di trasformazione di immagini fisse in sequenze in movimento, anche di più rapida e incisiva visualizzazione delle nostre idee, ma molto raramente per suggerirci eventuali possibilità. Abbiamo provveduto ad educare il sistema con i nostri progetti e i nostri linguaggi e da allora le proposte dell’IA appaiono più sensibili e congruenti con la nostra storia e le nostre impostazioni. Tutto questo si
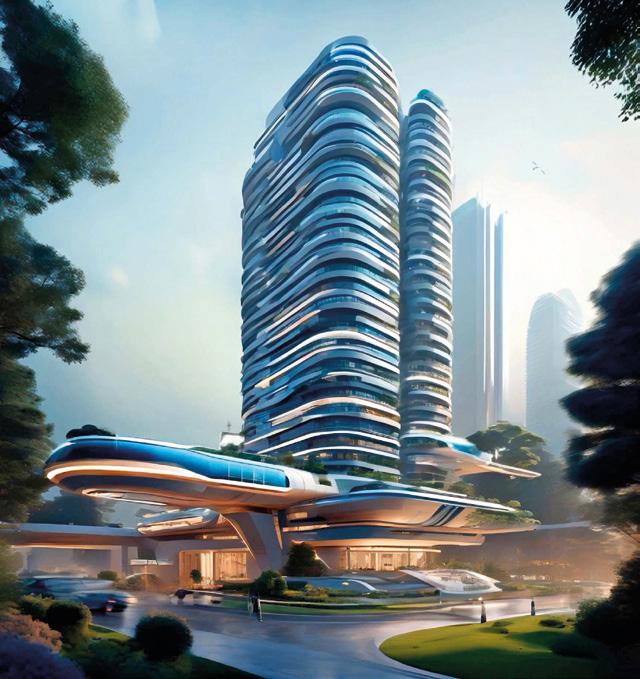
traduce in un’accelerazione dei processi o in una maggiore incisività della comunicazione verso gli utenti. Tuttavia il principale rammarico è che per il momento il linguaggio dell’IA mi sembra tutto testuale o schiacciato in una logica visuale esclusivamente bidimensionale, senza aggredire la tridimensionalità, i modelli e l’interazione con la concezione spaziale, che sarebbe il vero game changer della composizione architettonica.
Angelo Vecchio
Nel panorama della progettazione architettonica, l’IA è oggi una delle innovazioni più rilevanti. I software dotati di funzioni IA stanno cambiando il modo di sviluppare e comunicare i progetti. Nel nostro studio adottiamo queste tecnologie con rigore e spirito critico, in modo consapevole e selettivo. L’IA non è un mezzo per sostituire il progettista né un supporto alla fase ideativa o tecnica, che restano di esclusiva competenza del professionista. Solo l’esperienza e la sensibilità umana permettono di interpretare i bisogni del cliente e instaurare con lui un dialogo autentico. Utilizziamo invece l’IA per migliorare la comunicazione visiva del progetto: post-produzione di rendering, ottimizzazione delle immagini e creazione di visual efficaci. Strumenti come Yanus o Midjourney ci aiutano a velocizzare il lavoro senza intaccare la qualità del processo creativo. Tuttavia, crediamo sia fondamentale avviare una riflessione culturale più ampia. Troppo spesso si tende a sovrastimare il potenziale dell’intelligenza artificiale, trascurando il valore insostituibile della formazione, della professionalità e dell’esperienza umana.

Marco Piva immagini generate con l’AI per un video emozionale per l’installazione Beyond The Golden Age? concepita con Saint-Gobain Italia per il Fuorisalone 2025.
Silvia Polini
Dentro Settanta7 l’intelligenza artificiale è già una realtà. Crediamo che l’IA non debba solo rendere più veloci i processi, ma possa migliorare profondamente la qualità del progetto, come strumento di affancamento creativo e tecnico.
L’abbiamo introdotta a partire dal design team, sperimentando con tool generativi come Midjourney o Stable Diffusion, assistenti IA di Photoshop e della suite Adobe, fino a ChatGPT per la scrittura e l’analisi critica dei dati.
L’IA è un alleato strategico, oggi lavoriamo per estenderne il potenziale a tutte le fasi del progetto, anche nelle fasi più tecniche, come computazione e output documentale, con plugin su Revit e tool custom.
Settanta7 ha sempre avuto uno spirito aperto e sperimentale: abbiamo avviato collaborazioni con specialisti IA in tutta Europa e organizzato talk interni per diffondere una cultura del progetto che abbracci l’innovazione come evoluzione della professione. È un cambiamento culturale prima che tecnologico.
Stefano Bastia
L’IA non è un semplice strumento operativo da aggiungere alla cassetta degli attrezzi dell’architetto, ma una trasformazione culturale e progettuale. In Soa Architecture la consideriamo come una protesi cognitiva capace di amplificare la nostra sensibilità e di dialogare con i nostri modelli mentali. È parte di un percorso formativo profondo che ogni
architetto deve affrontare per usare con consapevolezza strumenti in continua evoluzione. Non è delegata a specialisti, ma parte di un processo formativo collettivo e trasversale intrapreso da un team multidisciplinare, dove competenze progettuali, tecnologiche e teoriche si fondono. Per questo, in Soa abbiamo creato un laboratorio sperimentale condiviso: raccogliamo dati, interpretiamo contesti, ottimizziamo flussi, ma il cuore resta il progetto, inteso come processo, non come semplice risultato finale. L’IA è parte del dialogo progettuale, non sostituisce la creatività ma la espande, attivando nuove modalità di pensiero e scenari inediti da esplorare insieme.
SMP
Marco Piva
L’approccio di Studio Marco Piva all’intelligenza artificiale è aperto e sperimentale: abbiamo l’obiettivo di integrare questa tecnologia nei processi creativi e tecnici, senza snaturare la nostra visione progettuale.
All’interno di Smp alcuni team multidisciplinari ne fanno già uso, in diverse fasi del lavoro. Utilizziamo diversi sistemi, integrandone le potenzialità. Nella progettazione ci aiutano a generare suggestioni e spunti visivi che sviluppiamo sulla base del nostro know-how, mentre in ambito tecnico ci supportano nell’affinamento delle indagini concettuali e dell’editing di immagini e video.
Parallelamente, stiamo lavorando allo sviluppo di un modello proprietario, basato sulla nostra esperienza progettuale pluridecennale e sul nostro immenso archivio di idee, dati e soluzioni, per avere strumenti ancora più vicini al nostro modo di progettare.
Settanta7, progetto della Cittadella Scolastica di Castelvolturno, attualmente in fase di realizzazione. Render realizzato con l’impiego di strumenti di IA.
Federica Cecchi e Valerio Cruciani con Enrico Taranta. Floating City Financial District NYC, progetto di città galleggiante modulare per aree costiere vulnerabili all’innalzamento del mare.

Siamo convinti che l’IA influenzerà in modo significativo il mondo della progettazione, come ogni innovazione tecnologica, ma crediamo sia fondamentale utilizzarla come supporto e non come sostituto della creatività, preservando il ruolo centrale della visione che il progettista esprime.
Giorgio Donà
Ogni risultato, ricercato o di cui ci si possa meravigliare, vive dei riferimenti da cui deriva. Ogni esigenza è personale e diventa possibilità e soluzione se condivisa. Il vasto patrimonio di informazioni e dati, intelligenze ed esperienza, si nutre e allarga con l’evoluzione delle cose: attingerne, semplificando il processo di accesso, gestione ed elaborazione, in tempi sempre più performanti e con risultati sempre più soddisfacenti, è la vera sfida a cui ci si deve appassionare. Per ogni risposta o output intelligente, servono capacità o input sempre più articolati e derivanti da discipline e conoscenze molteplici e descrivibili.
La dilagante intelligenza artificiale collettiva diventa strumentale nella costruzione di pensieri, segni, immagini e storie, purché guidate da sentimento, responsabilità e consapevolezza. Nel nostro caso, per una maggiore efficienza, usiamo una moltitudine di software e plug-in a supporto della progettazione, sia applicativi di programmi sia veri e propri software di IA che supportano la progettazione, ad esempio nel perfezionare rendere o immagini (un esempio è Rendair ) nonché a supporto della scrittura, facendo sistema della molteplicità di voci e storie che raccogliamo e modelliamo col progetto. Ogni intelligenza, nelle sue varie forme,

vuole essere educata e guidata: traguardare alla bellezza e al senso stesso da cui nasce il bisogno. Non esiste cosa più naturale e umana di questa.
UPA
Paolo Lettieri
Mi interesso agli sviluppi dell’IA sia per cercare di capire come sta cambiando il mondo, sia per usarla come strumento: non ne esalto l’uso ma neppure lo critico e lo demonizzo. L’applicazione dell’IA all’architettura ha pro e contro: i pro sono l’apertura di scenari inimmaginabili con caratteristiche di velocità, facilità d’uso, economicità e produttività. I contro sono che sconvolgerà il mondo del lavoro e molti rimarranno indietro, cambierà la percezione del nostro lavoro, forse ridimensionandolo ulteriormente, e si avrà un livellamento di creatività, con progetti mediamente ‘piacevoli’. A fine 2022 ho iniziato a usare Midjourney (text-to-image): i primi risultati sono stati buoni per gli interni e deludenti per l’architettura. Oggi si ottengono discreti risultati progettuali anche per l’architettura utilizzando modelli di diffusione tramite Stable Diffusion, Midjourney, Chat GPT image e altre piattaforme.
Tra poco l’IA sostituirà i programmi storici di visualizzazione e saremo anche in grado di generare direttamente disegni e 3D di buon livello da schizzi, immagini di riferimento e prompt di testo. Sarà come avere a disposizione infiniti collaboratori virtuali che faranno test velocemente e a basso costo: si progetterà basandosi più sulle iterazioni fatte con strumenti IA che portando avanti progetti ideati e sviluppati in modo tradizionale. Tra qualche anno il lavoro
dell’architetto sarà governare i flussi di lavoro degli strumenti AI e ingegnerizzare, per renderli costruibili, i risultati creati dall’interazione con questi strumenti.
Federica Cecchi e Valerio Cruciani con Enrico Taranta
L’era internet ha aperto le porte dell’universo, l’Intelligenza Artificiale l’ha trasformato in un universo consapevole.
Siamo solo all’inizio di un viaggio che ci porterà a scoprire le sue incredibili possibilità. L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando la progettazione architettonica, accelerando il concept e riducendo tempi e costi. Figure come l’AI Cgi Strategist uniscono IA generativa, visualizzazione 3D e narrazione, supportando studi in fasi chiave come concorsi e marketing. L’IA non sostituisce l’architetto, ma ne amplifica creatività e capacità, offrendo un vantaggio competitivo a chi la integra consapevolmente. Un amplificatore di visione, che sposta il valore dalla produzione manuale alla direzione creativa, utilizzando strumenti come Midjourney, Stable Diffusion, Runway o modelli Llm. In Urban-Gap laboratorio di architettura abbiamo dedicato uno spazio proprio all’AI CgiStrategist avviando una collaborazione con l’architetto Enrico Taranta esperto in IA che da tempo collabora con grandi studi internazionali, con l’obiettivo di fornire supporto esterno specializzato e flessibile in fasi critiche come concept, concorsi e comunicazione marketing.

Dall’alto in senso orario, alcune immagini del progetto Another America
Zebra Water Polite Extra Slims 1950s, New York
Huge Bubbles in New York Parade, New York, 1950. Tutte Phillip Toledano.
La verità in America è andata lentamente morendo nell’ultimo decennio... Con l’intelligenza artificiale, è possibile creare prove visive per sostenere qualsiasi teoria, trasformando la menzogna in qualcosa di apparentemente reale
Fino al 2 ottobre una mostra a Milano, presso la galleria d’arte contemporanea Fabbrica Eos, espone i lavori raccolti nell’ultimo libro fotografico Another America di Phillip Toledano: immagini che richiamano l’immaginario degli Stati Uniti degli anni Cinquanta e Sessanta, quello dei grandi fotografi come Robert Capa che documentavano la verità dei fatti. Ma nell’ultimo decennio, leggiamo nelle prime pagine del libro, in America (e non solo laggiù) la verità è andata progressivamente morendo, perché i fatti e la storia sono diventati scelte ideologiche: vale quel che si crede, dalla Terra piatta ai complotti dei vaccini, e l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa è solo lo stadio successivo di questa deriva, che trasforma Gaza in un resort turistico e mette in fila, seduti mogi come nella sala d’attesa del medico, i leader europei alla Casa Bianca.
Ma mettiamola in positivo: dover dubitare delle immagini temendo che raffigurino solo bugie potrà aiutarci a riprendere possesso delle nostre facoltà critiche, atrofizzate da decenni di propaganda mascherata da informazione? Il lavoro di Toledano ci aiuta in questa direzione, perché l’assurdità delle scene è evidente e dichiarata.
Autentico “Surrealismo storico”, come lo chiama l’autore: una definizione precisa, nella quale l’attributo ‘storico’ toglie autonomia all’agire artistico trasportando invece il richiamo dei surrealisti all’inconscio dal piano individuale a quello della società nel suo insieme. Così, se con l’intelligenza artificiale ogni teoria del complotto trova la sua conferma visuale, le immagini al limite dell’assurdo di Toledano, destabilizzando la percezione del reale, invitano a dubitarne.





L’impiego dell’intelligenza artificiale rende tutto vero e niente vero, contemporaneamente. Ma siamo poi sicuri che le fotografie delle grandi agenzie del Novecento descrivessero il reale per quel che era? O non fossero invece elementi utili a costruire una storia culturale che chiamiamo, appunto, ‘immaginario collettivo’?
Guardando al futuro, Toledano riflette sul ruolo dell’Intelligenza artificiale nell’arte e nella fotografia, suggerendo che come accadde con l’Impressionismo, nato in risposta al realismo fotografico, potremmo assistere a nuovi movimenti artistici capaci di rispondere all’evoluzione della IA.
Prima personale di Phillip Toledano a Milano,

Another America, a cura di Patrizia Madau e Rebecca Delmenico, è organizzata da Tallulah Studio Art in collaborazione con Fabbrica Eos (via Pasubio 8/a).
Nel libro, le fotografie sono accompagnate da racconti dello scrittore John Keeney ■
Dall’alto in senso orario. Black Woman in the Cloud. The Gun, New York 1950. Huge Bubbles in New York. The Smoking Head Polite Extra Slim. Tutte Phillip Toledano.




a cura di Carlo Ezechieli

L’impero delle immagini. Vere, false o verosimili si fermano alla superficie e riscuotono milioni di like da spettatori distratti





Dalla fine degli anni Ottanta, con lo sgonfiarsi del boom edilizio e la riduzione delle possibilità di costruire, dopo una stagione straordinaria in cui pochi ma grandi architetti tendevano a snobbare il disegno e ancor più l’immagine, privilegiando la qualità delle opere, prende piede il fenomeno delle cosiddette architetture di carta: progetti bellissimi e affascinanti, ma destinati a rimanere irrealizzati. Negli anni Novanta, complice l’avvento di Internet, le immagini iniziano a circolare vertiginosamente. I fotografi diventano centrali: un’opera, anche irraggiungibile perché collocata in un altro continente, poteva diventare celebre grazie alla sua fotogenia. L’esperienza diretta degli spazi passa in secondo piano, sopravanzata dall’impatto dell’immagine. Per almeno un decennio – fino a buona parte degli anni Dieci – il boom edilizio cinese ne è stato l’emblema: interi grattacieli venivano costruiti a partire da rendering, spesso senza considerare la qualità funzionale e abitativa degli spazi. Oggi, con l’arrivo delle immagini generate dall’intelligenza artificiale, questa dinamica si è ulteriormente esasperata: visioni mai realizzate, e spesso irrealizzabili, proliferano in rete con una qualità grafica impressionante, ma restano simulacri, distanti dalla realtà dello spazio costruito. Instagram, principale veicolo globale di immagini, amplifica il fenomeno. In una società che trascorre in media dalle sei alle sette ore al giorno davanti a schermi, viviamo in rete e la nostra memoria e identità si costruiscono sempre più attraverso immagini, in una dimensione post-moderna e iperconnessa, come anticipava David Harvey evocando gli innesti di memoria di Blade Runner. Quali saranno le conseguenze? Si affermerà, come suggerisce Patrik Schumacher, una vera architettura digitale, o assisteremo invece a una rivalutazione del luogo, del contesto e delle relazioni? Più probabilmente le due tendenze coesisteranno, aprendo scenari inediti che ridefiniranno profondamente il rapporto tra architettura, società e luoghi.

Arturo Tedeschi
Architetto e designer computazionale italiano, Arturo Tedeschi è noto per il suo approccio scultoreo e visionario e per la ricerca avanzata su materiali, tecnologie e metodi di progettazione. Il suo lavoro, che spazia dall’architettura al design industriale, moda e installazioni artistiche, utilizza tecnologie digitali per unire discipline e valorizzare gli aspetti semantici ed emotivi degli oggetti. Consulente per marchi e studi internazionali, si occupa di modellazione algoritmica, geometria complessa, fabbricazione digitale, intelligenza artificiale e realtà virtuale. Autore del testo di riferimento AAD Algorithms-Aided Design, promuove da oltre quindici anni workshop e eventi innovativi. Vive e lavora a Milano www.arturotedeschi.com
Una conversazione con Arturo Tedeschi architetto e designer computazionale, pioniere della progettazione algoritmica
L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il processo progettuale, comprimendo tempi e complessità che per secoli hanno definito la professione dell’architetto. Visualizzare un’idea non è mai stato così rapido e accessibile, ma questa democratizzazione solleva interrogativi cruciali: quale sarà il ruolo dell’architetto in un contesto in cui la macchina propone infinite varianti? In questa conversazione Arturo Tedeschi riflette sul passaggio da autore a regista, sulle opportunità e sui rischi dell’IA, sul valore della fatica creativa e sul futuro della progettazione parametrica, tra pratica e formazione.
Il tuo lavoro spazia dall’architettura, al design fino all’installazione artistica. In che modo credi che l’IA stia ridefinendo il ruolo dell’architetto e designer: non più solo creatore, ma orchestratore di soluzioni generate algoritmicamente?
Si può affermare che solo ciò che può essere prefigurato e visualizzato può essere costruito.
L’architetto, infatti, non ha mai costruito edifici in prima persona – architects do not make buildings, they make drawings of buildings –ma ha sempre prefigurato, nella fase di progetto, tutti i componenti, le sequenze costruttive, le relazioni spaziali e funzionali. Questa fase di astrazione e di scomposizione è stata per secoli lunga e complessa, interamente controllata a mano, e solo negli ultimi tre decenni ha trovato una nuova dimensione attraverso l’impiego di modelli digitali complessi (3D, Bim). Tali modelli, fondamentali per la rappresentazione e il controllo del progetto, hanno richiesto tempi estesi e competenze specialistiche, diventando il fulcro per la produzione di render, disegni esecutivi e documentazione tecnica. Il nuovo paradigma introdotto dall’Intelligenza Artificiale consente di comprimere e semplificare questa fase, che oggi non è più dominata dal duro lavoro manuale e da un faticoso “processo iniziatico”, ma dal linguaggio naturale. Visualizzare è diventato un processo a costo e tempo quasi nullo, per la prima volta iper-
Arturo Tedeschi con Stud-Io e Wies Offsite. Facade mockup (20222024). Vista degli interni: un impianto architettonico che si sviluppa coerentemente con il disegno dell’involucro dell’edificio.

democratico, accessibile a tutti. Al momento, l’impatto principale si manifesta proprio in questo spazio, in questa dimensione, e sta progressivamente trasformando le logiche operative del progetto. Sarà presto possibile partire dalla descrizione di componenti o dettagli e ottenere in tempo reale un modello 3D funzionale e operativo. Il ruolo dell’architetto cambia da esecutore a regista: non più concentrato sul disegno e la produzione di modelli, ma sulla
capacità di immaginare, scegliere e dare senso. L’AI democratizza la visualizzazione, ma rende ancora più preziosa la funzione critica e visionaria dell’architetto, che diventa curatore di possibilità e custode della qualità del processo.
In un articolo Christoph Niemann, celebre illustratore del New Yorker, osservava come il processo creativo implichi sempre una certa fatica e come l’intelligenza artificiale possa
alleggerirlo in modi imprevedibili, non solo riducendo lo sforzo ma con un impatto, non necessariamente positivo, sulla qualità. Ti ritrovi in questa considerazione? E, da designer, come vivi il rapporto tra fatica ideativa, intuizione e strumenti digitali?
Esistono tecnologie e processi virtuosi capaci di dare un contributo significativo al progetto – penso in particolare alla modellazione parametrica e algoritmica – che stimolano il
pensiero e mantengono viva l’attenzione critica, a differenza dei processi ripetitivi e routinari che finiscono per spegnere la creatività e hanno spesso inciso negativamente sui risultati. Come dicevo, l’AI comprime il passaggio dall’idea alla visualizzazione, arrivando addirittura a ribaltare la catena tradizionale “idea → concept → modello 3D informato → visualizzazioni → esecutivi”, proponendo un nuovo flusso “idea → visualizzazione → modello 3D automatico → esecutivi”. Il vantaggio non riguarda solo i tempi di sviluppo, ma soprattutto la possibilità di instaurare una vera negoziazione con la macchina intelligente e di affinare il progetto senza la preoccupazione dell’inevitabile costosa catena di modifiche che ogni variazione tradizionalmente comporta. Esistono chiaramente dei rischi. In una recente lecture ho usato il titolo “Mind the Gap” per sottolineare un fenomeno evidente: l’inevitabile divario che l’AI crea tra l’idea iniziale e l’esito finale. Viviamo una sorta di trade-off, di scambio: guadagniamo velocità, ma perdiamo aderenza all’idea originaria. Per questo motivo si tende spesso a essere più indulgenti verso risultati non del tutto controllati, ma prodotti con grande rapidità. Tutto ciò può essere tuttavia letto anche come una forma di ambiguità positiva, dove l’ambiguità non è vista come un problema, ma come finestra di esplorazione.
In quali tuoi recenti lavori l’uso di IA o strumenti parametrici ha avuto un ruolo davvero trasformativo rispetto ai metodi tradizionali? Negli ultimi quindici anni tutti i miei progetti sono stati sviluppati attraverso strumenti di modellazione algoritmica. Progettare con algoritmi significa superare l’approccio manuale tradizionale e descrivere le logiche profonde che strutturano un progetto: legami, relazioni parametriche, dipendenze dinamiche. Questo metodo mi ha permesso di esplorare forme e soluzioni che sarebbe stato impossibile persino immaginare “a mani nude”, senza il supporto di un linguaggio computazionale. Con l’Intelligenza Artificiale ho vissuto un vero punto di svolta. Nel progetto del palco per il tour mondiale di Illenium, per la prima volta mi sono lasciato guidare da un sistema capace di connettere i frammenti di un vasto database – composto da immagini ed altri dati che racchiudevano l’immaginario visivo dell’artista –e trasformarli in nuove possibilità progettuali. Abbiamo sviluppato un modello AI custom, basato su Stable Diffusion, che ha generato visualizzazioni a partire dai miei schizzi e da modelli preliminari. Il risultato finale si distingue nettamente dal resto del mio portfolio, ed è proprio questo l’aspetto che amo di più: gli strumenti AI, in particolare i diffusion models, mi hanno permesso di andare oltre i

miei bias progettuali, oltre la mia stessa firma, aprendo a territori espressivi che non avrei mai raggiunto da solo.
Nel contesto contemporaneo, dalla qualità dell’abitare e dell’ambiente urbano all’attenzione per l’ambiente, quali pensi siano le principali opportunità offerte dall’AI nella progettazione (circolarità, personalizzazione, efficienza), e quali i rischi (omologazione, perdita di responsabilità creativa)? È una domanda complessa che richiederebbe molto spazio, ma proverò a semplificare menzionando un esempio: un gruppo di ricercatori della Princeton University e dell’Indian Institute of Technology ha utilizzato l’AI per progettare chip wireless a onde millimetriche, essenziali per le comunicazioni 5G. Questi chip sono estremamente difficili da sviluppare a causa delle loro dimensioni ridotte e delle alte frequenze di funzionamento. L’AI ha affrontato il problema partendo dalle prestazioni richieste e trovando in autonomia la configurazione ottimale. Il risultato è stato un design con forme insolite, difficili da interpretare per gli ingegneri, ma in grado di garantire prestazioni superiori rispetto ai progetti tradizionali. Questo esempio mostra come l’AI possa andare oltre i limiti dell’intuizione umana, esploran-
do soluzioni non convenzionali ma altamente efficienti. La complessità che ne deriva non dovrebbe essere vista come una minaccia, ma come un’opportunità per ampliare i confini del possibile. In questo scenario, il progettista diventa un mediatore tra la creatività umana e le capacità esplorative delle macchine. L’architettura del futuro potrebbe nascere proprio da questa collaborazione, ridefinendo il concetto di creatività e aprendo la strada a innovazioni imprevedibili. Così come l’AI può ottimizzare il layout di un chip, allo stesso modo potrebbe progettare la distribuzione degli spazi abitativi, delle infrastrutture e delle reti urbane secondo criteri di efficienza e sostenibilità. L’omologazione non è il vero rischio. Anche se i processi automatizzati portassero a una certa standardizzazione della struttura funzionale, resterebbe comunque ampio spazio per differenziare linguaggi, materiali e soluzioni formali. Il pericolo maggiore, piuttosto, risiede altrove: nella potenziale eccessiva centralizzazione delle piattaforme e degli strumenti di AI e nella conseguente “commoditizzazione” di molte attività progettuali, con la perdita di unicità e valore distintivo, e con ripercussioni potenzialmente profonde sulla professione.
Come vedi l’evoluzione della progettazione
Accanto.
Esplorazioni AI di Arturo Tedeschi attraverso l’impiego dei diffusion models per la generazione di immagini. L’obiettivo è esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale come strumento creativo, capace di suggerire tipologie architettoniche soluzioni formali e dettagli costruttivi originali e inediti. A sinistra. Arturo Tedeschi con StudIo e Wies Offsite Facade mockup. Il progetto esplora un processo continuo e senza soluzione di continuità, capace di trasformare immagini generate con l’intelligenza artificiale in modelli architettonici realmente ottimizzati e costruibili. Un mockup di facciata è stato realizzato a St. Louis, Stati Uniti.

parametrica e algoritmica nell’educazione futura e nella pratica professionale?
L’accademia è chiamata a ripensare rapidamente i propri paradigmi didattici e metodologici. Le nuove tecnologie hanno già rivoluzionato il modo in cui le nuove generazioni studiano, si informano e si formano. Non si tratta tanto di concentrarsi sui singoli strumenti (AI, algoritmi ed altre tecnologie) quanto di abbandonare un approccio rigido e sequenziale a favore di
una modalità più dinamica di apprendimento e di processo. Molti metodi e persino alcuni software hanno mantenuto per decenni una relativa stabilità; oggi, invece, l’accelerazione tecnologica ci impone di sviluppare capacità nuove: assorbire, comprendere, reagire e applicare in tempi rapidi. Non esisteranno più conoscenze “granitiche”, destinate a durare immutate, ma una condizione di apprendimento continuo che richiederà basi solide e
un costante spirito critico. È una sfida che può apparire impegnativa, ma rappresenta al tempo stesso una straordinaria opportunità: trasformare la formazione in un ecosistema vitale, capace di alimentare curiosità, creatività e pensiero critico. Un luogo in cui l’apprendimento non si conclude mai, ma diventa la forza propulsiva di un futuro più consapevole, aperto e condiviso.
C.E.

Arthur Mamou-Mani
Architetto francese laureato alla AA, Arthur Mamou-Mani guida l’omonimo studio specializzato in architettura digitale. Docente all’Università di Westminster e fondatore del laboratorio Fab.Pub, sperimenta con stampa 3D e taglio laser. Vincitore del Gold Prize all’American Architecture Prize e del Riba Rising Stars Award (2017), ha tenuto conferenze internazionali e TEDx, apparendo su testate come Financial Times, New York Times e Forbes. Prima di fondare lo studio nel 2011 ha collaborato con Atelier Jean Nouvel, Zaha Hadid Architects e Proctor & Matthews. www.mamou-mani.com

IA, ARCHITETTURA PARAMETRICA E CREATIVITÀ AUMENTATA.
UNA CONVERSAZIONE CON ARTHUR MAMOU-MANI
L’architetto franco-britannico Arthur MamouMani é ormai a pieno titolo tra i protagonisti della parametric architecture. Con progetti a diverse scale, tra cui il celebre e iconico Galaxia, realizzato per il Burning Man Festival nel 2018, ha dimostrato come la progettazione algoritmica possa tradursi in forme che incarnano le potenzialità delle attuali tecniche di design e fabbricazione digitale. Secondo lui, l’intelligenza artificiale trasformerà il ruolo dell’architetto: da autore di segni a curatore di possibilità, chiamato a dare senso, etica e narrazione a un processo creativo condiviso con le macchine.
In che maniera l’intelligenza artificiale sta influenzando il ruolo di architetti e designer nel processo creativo?
L’intelligenza artificiale sta trasformando gli architetti dall’essere unici generatori di forme a curatori di possibilità. Invece di iniziare con uno schizzo e perfezionarlo, ora possiamo impostare intenzioni, vincoli e valori e l’intelligen-
za artificiale può generare centinaia di opzioni in pochi secondi. Questa libertà ci permette di concentrarci sulla narrazione, sull’etica e sul significato. Il ruolo dell’architetto diventa meno quello di tracciare linee e più quello di guidare le decisioni all’interno di uno spazio creativo ampliato.
Credi che l’intelligenza artificiale e gli strumenti parametrici possano essere di aiuto all’intuizione e la creatività umana anzichè sostituirli?
Gli strumenti parametrici e di intelligenza artificiale eccellono nel rivelare modelli che gli esseri umani potrebbero trascurare: prestazioni strutturali e ambientali, efficienza dei materiali o variazioni spaziali. Ma mancano di empatia, contesto e narrazione, cose che gli esseri umani possiedono naturalmente. I risultati più ricchi emergono quando i designer utilizzano l’intelligenza artificiale come partner di progettazione collaborativa: definendo i parametri giusti, valutando i risultati rispetto a criteri

culturali o emotivi e intrecciando il significato negli output.
È come improvvisare jazz con una macchina: l’istinto è nostro, lo strumento è nuovo.
In quali progetti recenti hai impiegato di più o meglio l’intelligenza artificiale o strumenti di progettazione parametrica?
In occasione di una scuola estiva e di un festival a Česká Kamenice, in Repubblica Ceca, abbiamo condotto un workshop pratico di progettazione-costruzione culminato in Živa Parametric Cabin: una cabina parametrica in legno. La forma si basa su un rombicosidodecaedro, scelto per la sua forza strutturale e risonanza simbolica. I partecipanti hanno modellato parametricamente, pannelli in legno e schiuma tagliati a Cnc Sip leggeri e li hanno assemblati in modo modulare in loco. È stato un processo educativo collaborativo che dimostra come i sistemi parametrici migliorino l’intuizione, l’artigianato e la costruzione di comunità. Nel-


A destra l’installazione Concordia realizzata da Arthur MamouMani a Parigi. In alto, il progetto Flying whale (2022) nel quale superfici, volumi e materiali sono stati razionalizzati attraverso l’uso di un algoritmo generativo.
A sinistra, la Živa Parametric Cabin (2025), esito di una summer school di architettura in legno organizzata da Hello Wood in Repubblica Ceca.

la Flying Whales Factory Assembly Hall, in un hangar alto 70 metri e profondo 250, abbiamo utilizzato un algoritmo generativo per dimensionare automaticamente gli elementi in acciaio, condensando in ore settimane di calcoli manuali. Questo ha reso possibile ottimizzare il processo riducendo l’uso di 2.600 tonnellate di acciaio, risparmiando 4.810 tonnellate di emissioni di CO₂, equivalenti al lavoro annuale di sequestro di anidride carbonica di 160mila alberi maturi. Nel padiglione Concordia a Place de la Concorde a Parigi, realizzato nell’ambito della Biennale Photoclimat, gli strumenti di generazione di immagini IA sono diventati uno sketchbook atmosferico. I primi studi sulla luce, la materialità e l’umore hanno guidato la narrazione della circolarità. Queste suggestive visioni dell’intelligenza artificiale erano fondate su una logica di fabbricazione reale, collegando la narrazione poetica con la precisione tecnica. Insieme, questi progetti illustrano come l’intelligenza artificiale e gli strumenti parametri-
ci espandano l’orizzonte della creatività senza sostituire il ruolo umano di dare significato, empatia e profondità culturale.
Quali le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale nella progettazione in relazione al contesto in cui i progetti prendono forma? Certamente una valutazione rapida delle metriche di emissioni, energia e circolarità in migliaia di iterazioni di progettazione. Poi la partecipazione della comunità attraverso piattaforme di co-progettazione, amplificando l’inclusività. L’ottimizzazione guidata dall’intelligenza artificiale del riutilizzo dei materiali e infine sistemi di progettazione reversibili. Naturalmente insieme a questo emergono alcune sfide, come il rischio di distorsioni nei set di dati che rafforzano modelli obsoleti o insostenibili. La natura di “scatola nera” di alcuni sistemi di intelligenza artificiale può oscurare la responsabilità, nonché le questioni di paternità, proprietà e responsabilità, che rimangono irrisolte
quando l’IA contribuisce alla progettazione.
Guardando avanti come vedi la progettazione aumentata nell’istruzione e nella pratica?
Nel campo dell’istruzione si passerà dall’insegnamento di comandi software specifici all’insegnamento di quadri critici, come porre le domande giuste, stabilire intenzioni e interpretare criticamente i risultati dell’intelligenza artificiale. Nei laboratori di progettazione delle università si lavorerà sempre di più in laboratori collaborativi in cui studenti e algoritmi collaborano in modo creativo, testando innumerevoli scenari e selezionando i risultati per la loro risonanza culturale, sociale e ambientale. E nella pratica l’architettura diventerà dinamica e adattiva. I cicli di feedback dell’intelligenza artificiale relativi al comportamento degli utenti, al clima e alla manutenzione consentiranno agli edifici di evolversi con grazia nel tempo anziché rimanere statici. C.E.

Carlo Vanoni
Critico d’arte, narratore e mediatore culturale, Carlo Vanoni interpreta l’arte contemporanea con un linguaggio fresco e coinvolgente. Autore per Solferino di titoli come A piedi nudi nell’arte, Ho scritto t’amo sulla tela, I cani di Raffaello e Io sono il cambiamento, è anche ideatore della Biennale milanese BienNoLo. Sul palco ha trasformato i suoi volumi in spettacoli teatrali, da L’arte è una caramella a I migliori quadri della nostra vita, portando la storia dell’arte fuori dai musei e dentro i teatri. È spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive conferenziere instancabile e voce popolare nell’introduzione dell’arte a un pubblico ampio.
ARTE E ARCHITETTURA
NELL’ERA DI INSTAGRAM E
DELL’IA IN UN’INTERVISTA AL CRITICO D’ARTE CARLO VANONI

L’universo visivo contemporaneo è dominato da flussi incessanti di immagini: architettura, arte, moda e perfino il cibo vengono consumati e bruciati nella rapidità dei social. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, poi, la spettacolarizzazione si è moltiplicata, producendo visioni tanto seducenti quanto irrealizzabili. Carlo Vanoni, critico d’arte e instancabile narratore, riflette in questa conversazione sul destino di arte e architettura in un mondo che sembra sempre più interessato alla superficie piuttosto che alla profondità: dal ruolo degli algoritmi alla memoria storica, fino alla differenza radicale tra creatività e creazione.
Negli ultimi anni la circolazione di immagini di architettura e di arte su Instagram è esplosa, e con l’arrivo dell’intelligenza artificiale sono comparse anche visioni spettacolari ma spesso irrealizzabili. Come leggi questa tendenza nel rapporto tra architettura e arte?
Credo che architettura e arte si trovino, come molti altri settori (moda, cibo, ecc.) a dover fare i conti con un mezzo che “brucia” come nessun altro. Bruciare significa durare poco o niente. Significa entrare nel circuito della spettacolarizzazione, dove l’opera d’arte (o di architettura) che funziona di più è quella che colpisce il fruitore distratto, frettoloso, noncurante del dettaglio, della bellezza meno apparente, delle forme soggiacenti. Questo pro-
blema riguarda il corpo. Vero protagonista del mondo social (e sicuramente anche dell’IA) è il corpo. Il corpo inteso come ciò che appare (e quindi anche un’architettura vista da fuori o un dipinto di Raffaello). Tutto si consuma in superficie. Instagram non è interessato alla profondità.
Guardando alla tua esperienza diretta di critico d’arte, ti è capitato di percepire un cambiamento nel modo in cui gli artisti producono o presentano il loro lavoro a causa di questa sovrabbondanza di immagini?
Gli artisti di alto livello, e quindi già inseriti nel circuito che conta (che non è quello dei social ma quello di Biennali, musei, mostre e luoghi istituzionalmente riconosciuti) non è interessato al mondo delle immagini in sé. Arte e architettura sono chiamate oggi a tenere conto di una memoria storica e non di un flusso incessante di immagini che finiscono nelle mani (anzi, negli occhi) di incompetenti che non hanno la minima conoscenza del settore.
Adam Grant sostiene che la creatività nasca anche dal volume di produzione, ma oggi l’IA è in grado di generare migliaia di varianti in pochi secondi, ricombinando ciò che apprende dai dati. Secondo te questo “volume algoritmico” può davvero essere considerato creatività e
Un’immagine di Piazza Superkilen di Big a Copenaghen. Mentre le immagini online mostrano una piazza colorata e multiculturale, la realtà rivela uno spazio piuttosto spento e malmesso. Foto Ramblersen licenza Creative Commons.
Nella pagina di sinistra, dettaglio di The Vessel, a New York, di Thomas Heatherwick: icona Instagram ma fallimento funzionale e sociale, oggi chiuso per problemi di sicurezza. Foto Etkin Celep licenza Creastive Commons.

in che misura rischia di mettere in discussione il processo creativo umano?
L’algoritmo non è creativo. L’algoritmo, cito Aristotele quando parla dell’animale, non arrossisce. Da sempre gli artisti producono tantissimo (Picasso, Warhol, Schifano e migliaia di altri), perché solo lavorando nascono nuovi linguaggi. Se l’algoritmo viene inteso come mezzo e non come fine, allora può essere usato in modo creativo. Arte e architettura si occupano di creazione e non di creatività. La creatività è la fantasia al servizio dell’intelligenza; la
creazione è il dono di cui sono provvisti grandi artisti e architetti.
Instagram ha trasformato le immagini in oggetti di consumo rapido e di visibilità immediata. Pensi che questa dinamica rischi di ridurre la profondità dell’arte, oppure può aprire a nuove forme di fruizione e di dialogo con il pubblico?
Credo che Instagram non abbia nulla a che vedere con l’arte, almeno quella di serie A. Instagram va bene per postare foto di fiori e di corpi mezzi nudi, di gente che parla ruttando
(scusate, ma c’è un tipo che lo fa e ha quasi un milione di follower), di corpi allo sbaraglio. Almeno se si parla di grandi numeri. Vale la stessa cosa che diceva un grande direttore Rai negli anni Novanta: la televisione sotto il milione di telespettatori non esiste. Su Instagram io trovo vecchissimi video di Bernstein che dirige, dei Weather Report che suonano dal vivo, di Gilles Deleuze che insegna a Vincennes, ma sono cose che guardiamo in quattordici e che, di conseguenza, ‘non fanno mondo’.

Fondato a Prato nel 2001 da Alessandro Corradini (Firenze, 1964), Cristiano Cosi (Montevarchi, 1974) e Marcello Marchesini (Prato, 1970), Mdu architetti ha conseguito numerosi riconoscimenti – nove i primi premi – in ambito concorsuale e partecipato a mostre, tra cui Innesti/Grafting al Padiglione Italia della 14. Biennale di Architettura di Venezia. Tra i lavori realizzati, oltre a quelli che presentiamo in queste pagine segnaliamo l’intervento di trasformazione e restauro del Borgo di Vignamaggio e il teatro del Borgo a Vitigliano, la nuova sede di Develer a Campi Bisenzio, la ristrutturazione dell’aula magna dell’Università Statale di Milano e, tra quelli in corso, il nuovo teatro di Acri (L’Aquila).
Dal 2013 Marcello Marchesini è professore a contratto presso la Facoltà di Architettura di Ferrara dove insegna Progettazione Architettonica al terzo anno. www.mduarchitetti.it






Nello schema, il Teatro di Montalto di Castro si pone al termine di una deviazione del tracciato della strada che conduce al centro storico.
In alto, la copertura a sbalzo del foyer e il retro, con l’eterea Torre scenica rivestita in policarbonato.
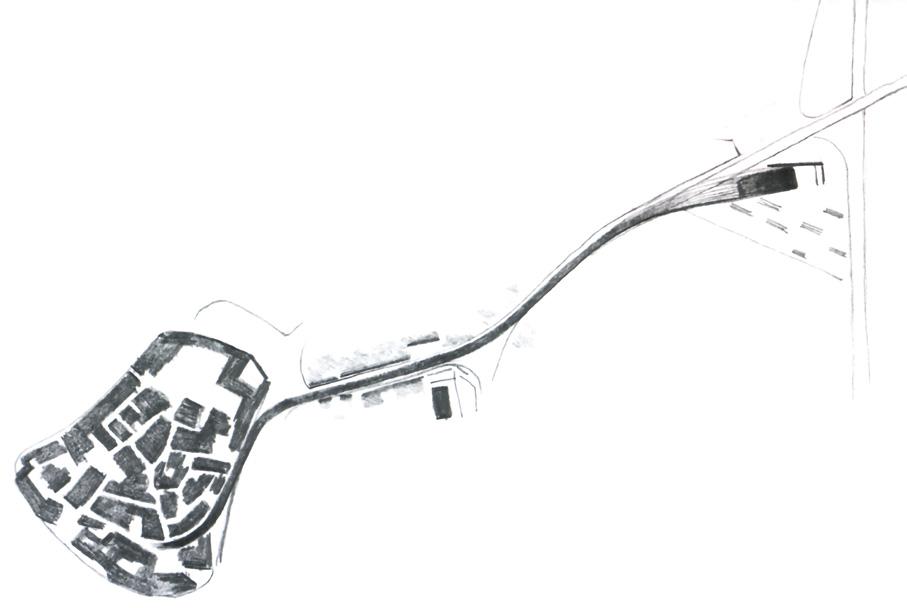







di Luigi Prestinenza Puglisi
Alessandro Corradini, Marcello Marchesini e Cristiano Cosi fondano lo studio Mdu nel 2001. Mdu sta per Misuratori del Differenziale Urbano. Una dichiarazione di radicalismo, in onore al clima fiorentino nel quale si sono formati. I tre si sono conosciuti alla facoltà di architettura di Firenze, frequentando le lezioni del professore Alberto Breschi di cui Corradini è assistente.
Breschi è un docente atipico: nel 1968 con Roberto Pecchioli e Giuliano Fiorenzoli aveva fondato il movimento di architettura radicale Zziggurat e, grazie ai suoi anticorpi radical è, adesso che la rivoluzione è stata messa in soffitta, uno dei pochi docenti che si distacca dalle posizioni accademiche e ingessate che in quegli anni (e, direi, a tutt’oggi) caratterizzano la scuola di Firenze.
Posizioni che hanno portato, in nome del rispetto del contesto e del genius loci, all’accademia del mattone e all’afasia del dove era e come era. Ricorda Cristiano Cosi: “Breschi ci ha insegnato che il
contesto non è un insieme di caratteri fisici e materiali da imitare. È una ricostruzione mentale del senso di un luogo, che si modifica continuamente grazie all’inserimento di nuova architettura”.
Il primo importante incarico professionale viene da un concorso del 2003 per il nuovo Teatro di Montalto di Castro. L’opera, un monolite in cemento, caratterizzato da leggere variazioni cromatiche e di texture, allude alla cultura etrusca le cui vestigia testimoniano un’architettura di grandi masse stereometriche in tufo. Nello stesso tempo evoca il mondo delle macchine della più grande centrale elettrica italiana, che si trova appunto a Montalto di Castro.
Al di là di questi riferimenti concettuali, il teatro mostra l’abilità del gruppo nel lavorare con i temi della buona architettura: lo spazio, i materiali, la luce. Per quanto riguarda il primo aspetto, osserviamo che l’edificio è pensato come una passeggiata architettonica con un ingresso che curva in modo da allungare la percorrenza ed eliminare una
A destra, il grande monolite in cemento sul quale si appoggia la Torre scenica in policarbonato alveolare arcoPlus 547 Dott. Gallina, un sistema modulare composto da pannelli a incastro maschio-femmina con sette pareti parallele. Sotto, la piazza coperta antistante il foyer e le lamelle di legno che lo rivestono.



fastidiosa e banale assialità. Il palcoscenico, inoltre, è delimitato sul retro da una vetrata che permette all’osservatore di guardare all’esterno. Il monolite, che altrimenti sarebbe una semplice e banale scatola di cemento, è fonte di sorprese spaziali. Di uno spazio, a sua volta, esaltato dai tagli, che danno consistenza plastica alle pareti e che, insieme, fanno filtrare la luce. Un gioco semplice e insieme complesso che punta sulla dialettica degli opposti e che diventa il filo conduttore di tutta la successiva produzione dello studio. Dichiara Mdu nella pagina di introduzione al suo sito: noi non abbiamo un metodo, una formula, ma capacità di percezione. E questa percezione è stimolata proprio dalla contrapposizione di materiali naturali e artificiali, luce e ombra, figure semplici e geometrie più complesse, leggerezza e gravità. Vi è, infine, la predilezione per le geometrie morbide, leggermente curve o composte da spezzate che alla curva si approssimano, esaltate dal contrasto con altre linee e piani più ortogonali o con materiali dell’immaginario brutalista quali cemento armato a vista.
Da questa pluralità nascono opere volutamente diverse tra loro tanto che è quasi impossibile trovare riferimenti precisi, anche se vi è sempre in tutte la voglia di non esagerare con effetti speciali e un senso della misura e dell’eleganza tipicamente italiano.
Possiamo notare inoltre una certa passione per la materia, propria dei protagonisti dell’architettura spagnola e portoghese. Penso per esempio a Rafael Moneo. E anche un gusto svizzero per la precisione e, forse, qualche riferimento alle recenti ricerche di Valerio Olgiati. Ma credo si tratti di corrispondenze parziali e episodiche. Mentre, pur nella diversità delle forme, mi sembra che vi sia un più sostanziale riferimento a Giovanni Michelucci e alle sue forme plastiche, all’idea che l’architettura debba confrontarsi continuamente con la scultura senza tuttavia perdersi in essa. Non è difficile, nella scuola fiorentina, trovare importanti sviluppi di questo approccio. Per esempio un certo modo di comporre di Adolfo Natalini (che però di modi di comporre ne aveva troppi e diversi tra loro) e il lavoro di Archea, con il quale lo studio Mdu ha anche collaborato con un progetto, a mio avviso, particolarmente interessante: la riqualificazione di una porzione del tessuto urbano di Livorno, con la realizzazione di un percorso pedonale pubblico con forte effetto plastico e cromatico che genera una nuova percezione del luogo. I progetti che abbiamo selezionato per questo profilo vi racconteranno tutti che Mdu persegue una ricerca architettonica di eccezionale qualità. Mostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, quanta buona architettura vi sia nella provincia italiana ■


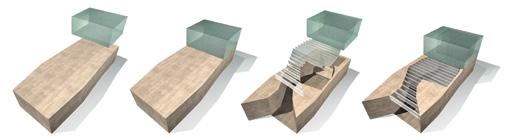
Località Montalto di Castro (Viterbo)
Committente Comune di Montalto di Castro
Progetto architettonico e DL Mdu architetti. Alessandro
Corradini, Marcello Marchesini, Cristiano Cosi
Strutture Alberto Antonelli, Iacopo Ceramelli
Progettazione acustica Gianluca Zoppi
Impresa costruttrice Mar.edil
Infissi in alluminio Metra
Rivestimento torre scenica Pannelli in policabonato alveolare Dott.Gallina
Superficie del lotto 10.888 mq
Superficie coperta 963 mq
Cronologia 2002-2011
Foto Pietro Savorelli
Il territorio di Montalto di Castro affonda le sue origini nell’antropizzazione etrusca le cui vestigia sono testimoniate da un’architettura caratterizzata da grandi volumi stereometrici in tufo, molto massivi, come il basamento del tempio grande di Vulci. D’altro canto, oggi Montalto di Castro evoca il mondo delle macchine, con la presenza sul territorio della (ex) più grande centrale elettrica italiana. Il teatro, risultato di un concorso di progettazione internazionale bandito dal Comune nel 2002, propone un corto circuito temporale tra queste due anime.
L’edificio – poco meno di 1.000 metri quadrati la superficie coperta – è un grande monolite in cemento armato faccia-a-vista caratterizzato da leggere variazioni cromatiche sul quale si appoggia, eterea, la torre scenica: un volume in policar-
bonato alveolare che si smaterializza di giorno e si illumina di notte per diventare un faro luminoso che dialoga con il vicino tessuto urbano cittadino e con l’intero territorio circostante. Una nuova piazza in travertino, nata dalla deviazione del tracciato della strada di accesso al centro storico, conduce al foyer, incorniciato da una copertura a sbalzo, che introduce il visitatore in un ambiente continuo e ininterrotto in cui piazza esterna, foyer e platea da 400 posti fluiscono liberamente l’una negli altri, fino all’arena estiva da 500 posti, sul retro del parallelepipedo. Lo spazio interno, rivestito in lamelle verticali di legno, è una sottrazione di materia, come se il blocco di cemento venisse scavato per ricavare lo spazio necessario della platea e della scena.

Il lato su strada della Camera di Commercio di Prato
è rivestito di rete
metallica stirata in alluminio anodizzato color bronzo che avvolge le facciate mantenendo parzialmente visibili le caratteristiche architettoniche dell’edificio.
Località Prato
Committente Camera di Commercio di Prato
Rup Catia Baroncelli
Progetto architettonico, coordinamento generale, direzione artistica e direzione operativa opere edili, interni
Mdu architetti. Valerio Barberis, Alessandro Corradini
Cristiano Cosi, Marcello Marchesini
Progetto strutture, quantity surveyor, sicurezza e DL F&M
Ingegneria
Acustica Cesal
General contractor Effegi Italia
Rivestimento facciata in rete stirata Fils, Delta System Int.l
Isolamento facciate Isolana System, Knauf
Vetro profilato U-Glass Piacenza
Infissi e facciate continue Metra
Tende tecniche Griesser
Pavimentazioni Teknofloor, Fmg, Idee & Parquet, Pointex
Sedute auditorium Lamm
Illuminazione Viabizzuno, iGuzzini, Xsal, Philips
Superficie lorda coperta 6.500 mq
Superficie aree esterne 10.900 mq
Cronologia 2006-2013
Foto Pietro Savorelli






In alto, la corte attraversata dalla passerella coperta e la scala che raggiunge la sala convegni, attrezzata con sedute impilabili Conpasso di Lamm
Fuori scala nel ‘paesaggio della mixité’ pratese, l’edificio scelto per la nuova sede della Camera di Commercio di Prato è un interessante esempio di architettura industriale del XX secolo. Su strada, il progetto ha previsto un rivestimento di rete metallica stirata in alluminio anodizzato color bronzo che avvolge le facciate mantenendo parzialmente visibili le caratteristiche architettoniche dell’edificio: la serialità delle aperture, le cornici marcapiano e gli elementi decorativi rappresentativi.
Liberata da alcuni manufatti che ne occupavano parzialmente la superficie, la corte interna di 40 metri per 34 è diventata una nuova piazza alberata (accessibile negli orari di apertura dell’ente), attraversata in quota sul lato est da una passerella coperta. Due ‘tagli’ in corten e una grande vetrata a sporto in corrispondenza della sala consiliare ora aprono l’edificio alla città.
Negli ampi spazi interni l’inserimento di ‘cellule’ singole o in coppia ha permesso di garantire la privacy lavorativa richiesta dal brief mantenendo intatte le eccezionali qualità spaziali (il piano terra ha un’altezza di circa 5,25 metri e le volte a botte del primo piano al colmo raggiungono i 6,20 metri) e anzi valorizzandone la percezione complessiva.
Oltre agli uffici l’edificio ospita un auditorium polivalente, con un foyer di grande impatto (più di 11 metri l’altezza) dal quale si diparte una scala elicoidale in cemento armato faccia-a-vista che raggiunge la sala convegni che occupa quasi tutto il lato est cel complesso.


Due lotti adiacenti e abbastanza profondi, due strade parallele ma non in diretta comunicazione tra loro e ora unite da un ‘passage’ a cielo aperto, risultato del progetto sviluppato da Mdu con Archea per riqualificare questa piccola parte di Livorno, non lontano dal centro storico, per realizzare nuovi spazi commerciali e residenziali. Il carattere monolitico delle nuove facciate, che deriva loro dal rivestimento lapideo di lastre di travertino, senza marcapiano e gronde in copertura, rende più evidente il ‘taglio’ che ha generato il
nuovo percorso pedonale, in alcuni punti del quale le masse edificate si sfiorano e su cui si aprono con ritmo apparentemente irregolare bucature triangolari. Il colore rosso del percorso sottolinea vieppiù la singolarità della cesura, capace di far dialogare senza forzature e inutili conflitti lo spazio pubblico e quello privato, che da sempre vengono considerati spazi dalle differenze incolmabili invece che luoghi delle relazioni possibili.
Località Livorno
Committente Goldoncina
Progetto architettonico Mdu architetti e Archea associati
Collaboratori Michele Fiesoli
Ingegneria civile A&I Progetti (Niccolò De Robertis)
Mep M&E (Stefano Mignani)
Costruttore Consage
Superficie dell’intervento 6.500 mq
Cronologia 2007-2011

I due edifici sono stati in un certo senso ricollegati da un taglio uno squarcio nel tessuto urbano che ha dato vita a un nuovo
percorso pedonale pubblico a cielo aperto evidenziato dal colore rosso, sul quale si affacciano residenze negozi e uffici.

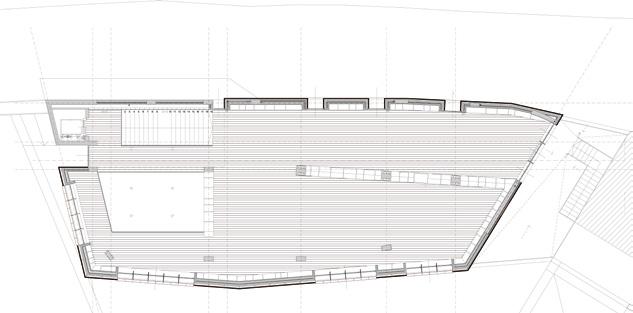

Il progetto è riconducibile a due temi: la solidità del basamento in travertino, e la leggerezza del volume in terracotta sovrastante.
Località Greve in Chianti
Committente Comune di Greve in Chianti
Rup Gianfranco Ermini
Progetto architettonico Mdu architetti (Alessandro Corradini, Cristiano Cosi, Marcello Marchesini)
Progetto strutture Alessandro Incerpi
Progetto Mep Gianluca Gori
Impresa di costruzioni Edilfab Rivestimento in travertino Querciolaie Rinascente
Pareti ventilate in cotto Il Palagio Cotto Vivaterra
Infissi in legno Cipriani serramenti
Superficie totale 420 mq
Cronologia 2006-2011
Foto Pietro Savorelli
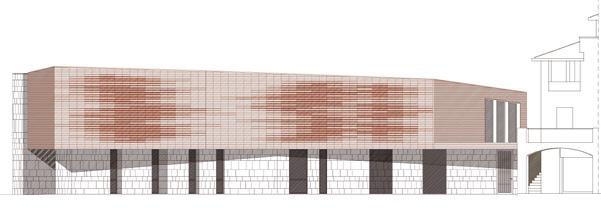




Poche centinaia di metri a nord della celebre piazza del mercato, la Biblioteca Comunale di Greve in Chianti presenta un’immagine fortemente riconoscibile e rappresentativa, propria di un’istituzione pubblica. Due i temi architettonici: la solidità del basamento, formato da blocchi in travertino, e la leggerezza del volume sovrastante, le cui pareti, ricche di fenditure, tessiture e ritmi chiaroscurali, sono realizzate con elementi in cotto che definiscono la composizione dell’edificio e, come una trina in terracotta, agiscono da diaframma tra le mutevoli condizioni dell’esterno e la sala di lettura. Al calare del sole il volume in cotto si accende internamente e svela in negativo la sua trama di vuoti e cavità, facendosi segno nel territorio.
I due livelli dell’interno sono organizzati con un grande atrio a doppia altezza dove si trova il banco informazioni e prestiti, mentre una grande scaffalatura alta due piani divide questo spazio dall’ufficio dell’amministrazione e da spazi destinati ad attività di carattere culturale e ricreativo che possono accogliere fino a 80 posti a sedere. La sala lettura, al primo piano, si affaccia sul vuoto centrale. In questo modo pur se gli ambiti funzionali risultano separati, essi sono visivamente connessi.



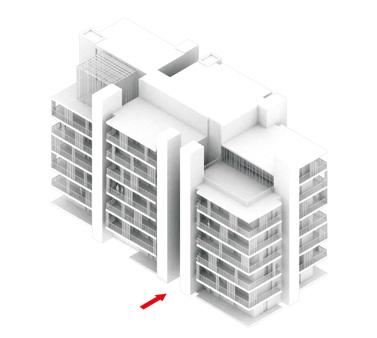
Complesso residenziale a Prato
Località Prato
Committente InvestiRe Sgr
Progetto architettonico Mdu architetti e Studio tecnico Edilprogetti
Superficie del lotto 3.954 mq
Superficie edificata 1.795 mq
Cronologia 2021-in corso
Disegni e render Mdu
Parte di un piano attuativo di Edilia Residenziale Sociale, il complesso di via di Gello a Prato si sviluppa all’interno di un’area fortemente caratterizzata dalla presenza del verde, tra il parco dell’ex Ippodromo e zone agricole inglobate nel tessuto urbano. Questo contesto ha ispirato un’architettura che ricerca un’integrazione visiva e funzionale con la natura circostante. Il progetto prevede due blocchi residenziali (per un totale di 72 appartamenti) articolati volumetricamente per mitigare l’impatto visivo e creare un paesaggio urbano ‘pensile’, simile ai centri storici. L’organizzazione urbana include una piazza alberata, giardini pubblici attrezzati e una rete di per-
corsi ciclopedonali. Gli edifici ospitano terrazze, serre e spazi comuni pensati per favorire la vita comunitaria. Le coperture, attrezzate con solarium e orti, diventano per i residenti luoghi di incontro, con viste panoramiche sull’intorno e sulla città. Gli appartamenti, distribuiti su 6/8 piani, sono progettati secondo criteri di flessibilità, comfort e rispondenza alle normative, con ampi terrazzi abitabili, ripostigli esterni e ambienti luminosi. Il piano terra accoglie spazi polifunzionali accessibili anche dall’esterno. L’intervento propone in sostanza una sintesi equilibrata tra qualità architettonica, sostenibilità ambientale e finalità sociali, proponendo un modello abitativo inclusivo e contemporaneo.



Il progetto, in considerazione della notevole consistenza volumetrica dei due blocchi, ha previsto una strategia di frammentazione dei fronti così da sdrammatizzarne la mole e favorirne l’inserimento nel contesto.

Sotto. La terrazza più ampia della proprietà diventa un secondo living con l’installazione ad opera di Grosso Tende della pergola bioclimatica Imago di Corradi.

Sopra e nella pagina di destra. Pochi gradini più in alto, un’altra terrazza che si confonde con il giardino, circondata da erbe aromatiche anch’essa coperta in decking, con il tavolo per le cene all’aperto.


IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’INTERIOR DESIGNER
ANDREA BOERIS AMPLIA
VISIVAMENTE GLI SPAZI
DI UNA VILLA DEGLI ANNI
OTTANTA E VALORIZZA
LE TERRAZZE ESTERNE
CHE UNA PERGOLA
BIOCLIMATICA TRASFORMA IN NUOVI LIVING
ALL’APERTO
Molti gli architetti, tra i quali Ignazio Gardella, Vico Magistretti, Luigi Caccia Dominioni e Gio Ponti che dopo il masterplan iniziale svilupparono progetti di residenze e servizi nella Pineta di Arenzano. Negli anni del boom economico italiano del dopoguerra, i 135 ettari di terreno a macchia mediterranea divennero méta d’elezione per la casa al mare della borghesia milanese e torinese e la prima gated community d’Italia diventò un caso di studio dell’architettura italiana.
Le costruzioni proseguirono fino agli anni Ottanta, come la villa che presentiamo in questo servizio, completamente ristrutturata lo scorso anno dall’interior designer torinese Andrea Boeris, che con il suo studio Dinterni e la collaborazione dei suoi artigiani di fiducia ha seguito fino al
termine i lavori, agendo anche da general contractor.
Anche questa villa, circondata dalla pineta, segue i criteri generali delle altre residenze che fanno parte della ‘Comunione Pineta’, ovvero il forte legame con l’ambiente naturale esperito soprattutto negli spazi aperti, articolati in piccole corti e giardini terrazzati e digradanti collegati tra loro e con le abitazioni da percorsi e scale usuali nel paesaggio agricolo ligure, così da offrire agli abitanti un’effettiva esperienza di vita all’aria aperta e panorami esposti a sud aperti sul mare.
In questo caso, la terrazza più ampia della proprietà diventa un secondo living con l’installazione ad opera di Grosso Tende di una pergola bioclimatica Imago di Corradi con copertura a lamelle orientabili, utili per

Dinterni Italian Interior Design
Dinterni Italian Interior Design è stato fondato dall’interior designer torinese Andrea Boeris (nella foto) e opera a livello nazionale e internazionale. Con oltre trent’anni di esperienza, Boeris ha sviluppato un approccio progettuale rigoroso e raffinato, orientato alla realizzazione di spazi su misura per una committenza esigente e consapevole. Il suo metodo si basa su una gestione completa del progetto: dalla concezione architettonica alla ristrutturazione edilizia, fino all’interior design e alla fornitura dell’arredo finito. Ogni intervento è seguito in ogni fase operativa da personale altamente qualificato, garantendo un servizio chiaviin-mano di elevato standard qualitativo.
Grazie a una rete consolidata di artigiani e fornitori d’eccellenza, Dinterni assicura risultati impeccabili sia in contesti residenziali che commerciali, con un’estetica elegante, contemporanea e senza tempo. www.dinterni-interiordesign.com


CREDITI
Località Arenzano
Progetto di ristrutturazione Dinterni, Andrea Boeris
Direzione lavori e contractor Dinterni
Pergola bioclimatica Corradi modello Imago
Installazione pergola Grosso Tende
Arredi a catalogo Kettal
Illuminazione Flos, iGuzzini
Carta da parati LondonArt
Completamento 2024
Foto Pierpaolo Ottaviano, Lorenzo Carone
catturare il vento fresco delle sere d’estate o per proteggere dai raggi del sole allo zenit. Le generose dimensioni (5 metri per 4 e un’altezza interna di 240 cm) ne fanno un salotto en plein air arredato con un ampio divano davanti a un tavolino (tutto Kettal) dove poggiare l’aperitivo. A terra, steso sul decking, un tappeto in fibra.
Sempre di Kettal i lettini e le poltrone Bitta (design Rodolfo Dordoni) che arredano il resto della terrazza, fino alla vasca idromassaggio.
Pochi gradini più in alto, più vicina alla
Sopra, la pianta dell’abitazione.
Accanto, un mobile basso dal frontale bacchettato accompagna la rampa che dall’ingresso scende verso il giardino.
casa un’altra terrazza che si confonde con il giardino, circondata da erbe aromatiche, anch’essa coperta in decking, con il tavolo per le cene all’aperto.
Ampliare anche visivamente gli spazi abitabili era del resto l’obiettivo del progetto di Boeris, che si riflette nella strategia adottata per gli interni: un mobile basso dal frontale bacchettato accompagna la rampa che dall’ingresso scende verso il giardino, mentre la zona living è definita da un portale in pannelli che introduce a un ambiente accogliente e scenografico.
Una grande parete con nicchie illuminate amplifica la profondità percettiva.
Nella camera padronale, di dimensioni contenute, si è optato per una parete contenitiva a tutta altezza dietro la testiera del letto: un armadio a scomparsa che unisce funzionalità e pulizia visiva. Una nicchia centrale, laccata con effetto metallico e retroilluminata, interrompe la regolarità della bacchettatura come una scultura incassata.
L’arredo degli interni è stato selezionato con cura per mantenere coerenza stilistica e raffinatezza nei materiali ■



Il cuore del progetto d’interni di questa abitazione è rappresentato dalla zona living, definita da un portale in pannelli Akupanel che introduce a un ambiente accogliente e molto scenografico.
La camera padronale è caratterizzata da una parete contenitiva dietro la testiera del letto e da una nicchia centrale laccata con effetto metallico che interrompe la regolarità della bacchettatura.

TRA-Toussaint Robiglio Architetti
Fondato e diretto da Isabelle Toussaint e Matteo Robiglio, con una filosofia di progettazione condivisa, ecologica e integrata, TRA si occupa di riuso di strutture esistenti, edilizia residenziale, social housing e co-housing, edifici e spazi pubblici, edifici produttivi e spazi di lavoro, design, strutture di comunità, interventi di riqualificazione urbana, progetti d’area vasta e piani territoriali. Lo studio di Torino partecipa a ricerche e sperimentazioni nel campo della città, dell’architettura e della costruzione sviluppate con centri di ricerca, università, imprese e soggetti sociali. È partner di Homers, società benefit di rigenerazione urbana che riconverte immobili dismessi o sottoutilizzati in abitazioni accessibili. https://tra.to.it

Le fasce metalliche traforate e ondulate che rivestono il nuovo volume si accostano all’edificio Beaux-Arts esistente.
A destra l’ingresso su via Doria. Courtesy Bnl Bnp Paribas, thanks to Escp Business School. Foto Fabio Oggero.


SCUOLA DI MANAGEMENT
INCUBATORE D’IMPRESA E
ATTIVATORE DI FUNZIONI
PUBBLICHE URBANE. LA
TRASFORMAZIONE DI UN EDIFICIO
STORICO E L’INNESTO DI UN
VOLUME CONTEMPORANEO NEL
PROGETTO DI TRA-TOUSSAINT
ROBIGLIO, ARTELIA, G*AA E
SUBHASH MUKERJEE PER LA NUOVA SEDE DELLA ESCP
BUSINESS SCHOOL DI TORINO
Come già le ‘eccezioni’ architettoniche torinesi – da Guarino a Mollino – anche la facciata curva del nuovo volume della sede di Torino della business school Escp, progettata dallo studio TRA, Toussaint Robiglio Architects, rompe la griglia ortogonale che uniforma spazio urbano e fronti architettoniche della città storica. La ragione, oltre alla ridotta dimensione di via Andrea Doria, che impedisce una visione frontale completa dell’edificio, consisteva nell’esigenza di costruire nuove superfici per disporre di spazi di dimensioni adatte alle modalità di insegnamento praticate oggi dalla più antica scuola superiore di management d’Europa: dimensioni incompatibili con l’edificio esistente, che insieme al nuovo è ora in grado di accogliere 1.500 persone tra docenti e studenti, con una percentuale di internazionalità del 75%.
Reso possibile dalla legge regionale 16/2018 sul riuso e condotta in deroga in collaborazione con il settore Edilizia privata della Città di Torino, il nuovo volume, per una superficie di 1.500 metri quadrati sul totale degli 8.000 del campus Escp, più che appoggiarvisi sembra ‘estruso’ dall’edificio Beaux-Arts del 1877 – già sede di una banca che ne è tuttora proprietaria – al quale si accosta.
Un rivestimento di lamiera metallica traforata e tridimensionale color bronzo emerge, con una serie di fasce sovrapposte con giaciture non coincidenti, dalle facciate esistenti e contribuisce all’intreccio tra preesistenza e nuovo, reso possibile anche dallo scarso valore storico (tranne la facciata vincolata) dell’esistente a causa delle radicali trasformazioni cui venne sottoposto già quarant’anni fa.
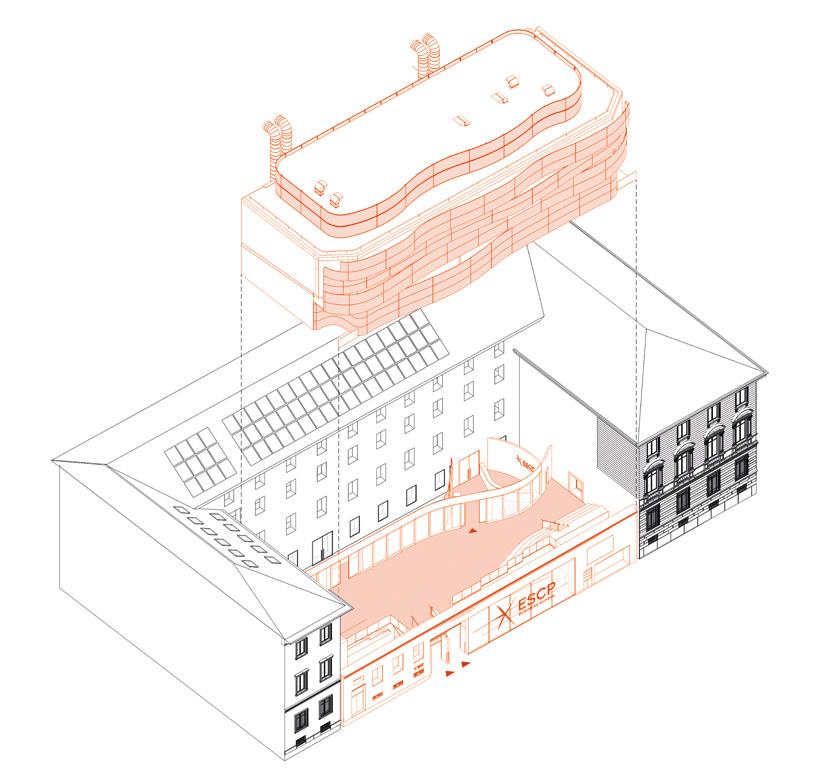

A sinistra, l’esploso assonometrico permette di leggere la complessità dell’intervento e l’innesto architettonico del nuovo volume ondulato. Visibile la nuova ‘piazza pubblica’ passante (courtesy TRA).
L’ingresso vetrato del campus, su via Andrea Doria, è anche punto di accesso a una piazza coperta, con altre uscite che la rendono permeabile alla città: dalla piazza si entra in un piano terreno interamente dedicato ai servizi, con il learning center e la caffetteria con terrazza coperta affacciata sulla piazza accessibili autonomamente dall’esterno anche a scuola chiusa. Dai due vani scala principali si sale al primo livello. Qui, all’interno della manica esistente trovano posto aule, segreteria, spazi break out e un primo nucleo di uffici, mentre il nuovo volume ospita l’auditorium, uno spazio da 300 posti che una paratia mobile consente di suddividere facilmente in due grandi aule, e al piano superiore le quattro nuove aule ad emiciclo da 80 posti ciascuna, uno degli elementi innovativi del campus di Torino. Come spiegano gli studi Giaquinto Architetti Associati (G*AA), Subhash Mukerjee Architecture e Conrotto Progetti, che hanno sviluppato il progetto degli interni, «la didattica ex chatedra è ormai solo uno dei molti modi di trasmettere conoscenza all’università: seminari, discussioni, workshop sono strumenti in uso da tempo. A questi si aggiungono tutte le esigenze di insegnamento e interazione a distanza»
Le aule a gradoni nascono con questa idea: la conformazione a emiciclo e la distribuzione
delle postazioni e degli apparati tecnologici sono pensati con una flessibilità controllata, garantendo una visuale ottimale fra studenti e docente, fra studenti e studenti, fra persone in presenza e persone online. Allo stesso tempo permettono la proiezione di diverse forme di contenuti multimediali, la discussione dal vivo e a distanza. Sono progettate per permettere diversi scenari didattici (es. la lezione frontale, la discussione collettiva, il lavoro di gruppo, l’esame), sia dal punto di vista dello spazio e dell’illuminazione, sia dal punto di vista delle possibilità di proiezione, visualizzazione e scambio di contenuti. La loro configurazione infine è studiata per rendere ottimale il clima acustico e la diffusione del parlato dell’oratore, sia in modalità amplificata sia naturale.
Merita ricordare un ulteriore valore aggiunto del progetto, questa volta non di carattere didattico ma urbano: l’università come ingrediente fondamentale del sistema di funzioni del contro storico delle città. Malgrado lo sviluppo, a Torino come altrove, di campus esterni all’area storica, istituti formativi non separati da recinti autonomi contribuiscono all’animazione e alla vitalità di uno spazio pubblico altrimenti sempre più destinato unicamente a funzioni commerciali e turistiche ■
CREDITI
Località Torino
Committente Bnl Bnp Paribas
Progetto architettonico e direzione artistica TRA architetti Isabelle Toussaint, Matteo Robiglio, Alessio Migliasso
Progettazione definitiva ed esecutiva Artelia Italia Marco Conte, Andrea Ricci, Giampiero Angelucci
Progetto strutturale Bcube
Progettazione acustica Toec
Interior design G*AA Architetti (Attilio Giaquinto); Subhash Mukerjee Architecture (Subhash Mukerjee, Marta Mancini); Conrotto Progetti. Gianluca Conrotto
Direzione lavori e coordinamento sicurezza Speri
Project e asset management per il committente Sviluppo HQ Tiburtina
Project monitoring per Escp Fried
Imprese esecutrici Ati - Gianni Benvenuto e Edilmaster
Poltrone auditorium e banchi aule a emiciclo Lamm
Superficie 8.000 mq (6.500 ristrutturati + 1.500 nuovi)
Completamento 2024


Dall’alto.
L’Auditorium da 300 posti attrezzato con poltrone F50 di Lamm.
Sempre di Lamm i banchi studio E4000 delle aule a emiciclo. Foto courtesy Lamm Fabio Oggero 2025.
L’auditorium da 300 posti (riconfigurabile in due sale da 150 posti ciascuna) del campus torinese della business school è attrezzato con poltrone F50 di Lamm – in struttura color argento e rivestite in similpelle grigia – dotate di tavoletta antipanico ribaltabile a scomparsa all’interno del fianco ed elettrificate con prese di corrente facilmente accessibili sul fronte della fiancata.
Sempre di Lamm i banchi studio E4000 con cui sono attrezzate le quattro aule a emiciclo da 80
posti ciascuna. Il sistema, con piano fisso, è stato scelto nella versione con pannelli prima fila, sedili e schienali in laminato Hpl (finitura in rovere di Abet Laminati) disposti su gradoni seguendo una curva molto stretta, estremamente difficile da assecondare. I banchi, elettrificati, sono provvisti di presa elettrica e sedile con ritorno automatico ammortizzato.
www.lamm.it

Alessia Carrettini ingegnere
fondatrice dello studio
ProACustica di Cremona www.proacustica.it
A volte è chiara, limpida, armoniosa. Altre volte è confusa, rimbombante, stonata. L’intenzione di questo dossier è approfondire il tema dell’acustica come elemento imprescindibile per la buona riuscita di un progetto architettonico. Parto da una convinzione precisa: nonostante spesso l’acustica venga considerata marginale, soprattutto nei grandi progetti dove le priorità e le difficoltà sono molteplici, essa è a tutti gli effetti un fattore fondamentale per il successo dell’opera.
I temi legati all’acustica sono numerosi, ma qui voglio soffermarmi su quello che più si intreccia con la figura dell’architetto e del designer di interni: l’acustica architettonica. Intesa come progettazione degli ambienti interni per ottenere un tempo di riverbero corretto e un’adeguata qualità sonora, l’acustica interna dipende direttamente da forme, geometrie e materiali visibili. Elementi che, oltre a definire l’impatto estetico, svolgono anche una funzione acustica determinante.
Ecco il punto centrale, il vero nodo della questione: l’acustico deve interagire e, in modo quasi silenzioso (!), accompagnare
le scelte dell’architetto e del designer di interni, affinché estetica e funzionalità sonora procedano insieme, senza compromessi.
Ogni ambiente, in base alla funzione per cui è progettato e alle persone che deve ospitare, deve rispettare specifiche caratteristiche acustiche.
Un open space, un ufficio singolo, una sala riunioni, un auditorium, un’aula scolastica, un teatro, un corridoio, una hall o una spa: tutti, in funzione del loro volume, hanno un tempo di riverbero ottimale da rispettare. Per semplicità, consideriamo proprio il tempo di riverbero come parametro rappresentativo delle principali caratteristiche di acustica architettonica.
• In un’aula scolastica, gli studenti devono sentire chiaramente l’insegnante, ma il rumore di una penna che cade non deve disturbare l’intera classe.
• In una sala riunioni, dove sempre più spesso ci sono anche collegamenti in videoconferenza, ogni partecipante deve poter ascoltare l’oratore da qualunque postazione, con chiarezza e naturalezza.
• In un open space, una conversazione
tra colleghi non deve disturbare chi sta lavorando nelle vicinanze.
Queste condizioni fondamentali dipendono, in modo semplificato, proprio dal tempo di riverbero.
E come possiamo controllarlo? Attraverso la scelta dei materiali visibili nello spazio, quelli che attraggono l’attenzione di clienti, architetti d’interni e utilizzatori e che hanno la capacità di assorbire o riflettere il suono regolando così l’acustica dell’ambiente. E qui inizia la parte più affascinante del nostro lavoro. Il primo passo è immergersi nella visione del cliente, interpretata attraverso lo sguardo di architetti, progettisti e arredatori: uno spazio moderno e minimale, un’atmosfera industriale da loft newyorkese, il calore accogliente del rustico, l’eleganza senza tempo del barocco…
Da questa visione iniziamo ad analizzare i materiali previsti nei vari ambienti valutandoli non solo per il loro aspetto estetico, ma anche per le loro caratteristiche di fonoassorbimento - rappresentate dal coefficiente α sia come valore unico sia in funzione della frequenza - per capire se siano in grado di garantire il tempo di






La qualità acustica dello spazio è una variabile del programma d’uso e funzione dei materiali impiegati. Per questo è importante che il progetto acustico sia integrato fin dall’inizio nel progetto architettonico


riverbero ideale per quello specifico spazio.
A seconda della complessità dello scenario, possiamo affidarci a semplici fogli di calcolo oppure a software di simulazione acustica avanzati, capaci di prevedere come il suono si muoverà e si trasformerà tra pareti, superfici e arredi.
A questo punto diventa chiaro se occorre aggiungere o modificare materiali e soluzioni, sempre in armonia con lo stile scelto. In questo ci vengono in aiuto i produttori, che con creatività e competenza offrono una gamma infinita di possibilità. Il processo prosegue fino a trovare l’equilibrio perfetto: un risultato in cui estetica e acustica si fondono, e in cui la bellezza visibile si completa con un’armonia invisibile, quella del suono.
Questo è il processo ideale, quello che dovrebbe accompagnare ogni progetto.
Dal punto di vista economico, è anche il più conveniente: integrare l’acustica fin dall’inizio, all’interno della visione estetica, permette con semplici accorgimenti di ottenere il risultato desiderato.
Se invece si procede senza questo approccio, il problema si manifesta solo dopo, quando gli utilizzatori si sono già
insediati e si rileva un’inadeguatezza acustica. In questi casi, la soluzione va trovata a posteriori, spesso con interventi che stravolgono l’estetica originaria e che devono fare i conti con vincoli esistenti come luci, prese, carichi, tende già installate limitando inevitabilmente le scelte e il risultato finale.
In sintesi, curare l’acustica fin dall’inizio significa rispettare e valorizzare la visione del progetto in ogni sua sfumatura. È un
percorso che unisce estetica e funzionalità, creatività e tecnica, e che permette di trasformare uno spazio non solo in un luogo bello da vedere, ma anche piacevole da vivere. Ogni dettaglio, ogni materiale e ogni scelta contribuiscono a creare un’armonia completa, dove il suono diventa parte integrante dell’esperienza, invisibile ma fondamentale.
Alessia Carrettini
Tempo di riverbero consigliato per i vari ambienti: Ambiente Volume tipico (m 3) Tempo riverbero consigliato (T60)
Aula scolastica 150-250
Sala riunioni 50-150
Ufficio Open Space 500-1500
Auditorium/Teatro 2000-8000
0,5-0,8 s
0,5-0,8 s
0,5-0,8 s
0,8-1,8 s
Corridoio variabile ≤ 1 s
Hall/Reception 300/1000
Spa/Area Benessere 100/500
0.8-1,2 s
0,6-0,9 s

Il Rev Lab è la camera riverberante dove vengono studiati i materiali fonoassorbenti grazie alla particolare geometria costruttiva a pareti asimmetriche e alla struttura dell’involucro cementizio.
Voluto da Caimi all’interno della propria sede a Nova Milanese, OpenLab è un centro di ricerca e sperimentazione concepito per sviluppare materiali innovativi e applicare nuove tecnologie al servizio dell’acustica, della fisica e del benessere ambientale. Qui si analizzano il comportamento del suono, le capacità percettive dell’uomo e l’impatto che il suono ha sulla salute psicofisica, con l’obiettivo di trasformare la ricerca in soluzioni concrete per spazi pubblici e privati.
Il lavoro di OpenLab si integra con le principali tecnologie brevettate dall’azienda: Snowsound, basata su pannelli a densità variabile che assorbono selettivamente le diverse frequenze sonore; A+E, che combina prestazioni acustiche e riduzione delle radiofrequenze; Air Purification, che sfrutta il calore disperso dalle sorgenti Led per attivare processi di
filtrazione e migliorare la qualità dell’aria indoor riducendo i consumi energetici. Questi sistemi sono concepiti per unire efficienza tecnica, sostenibilità e integrazione estetica negli ambienti, adattandosi a contesti che spaziano dagli spazi di lavoro agli ambienti residenziali, fino a scuole, musei e strutture sanitarie. OpenLab si articola in sette laboratori di ultima generazione, dotati di apparecchiature in gran parte progettate internamente.
Il Supernova Lab è una camera semianecoica completamente isolata da vibrazioni e interferenze, grazie a una struttura in calcestruzzo speciale da 90 tonnellate, una gabbia di Faraday e 1.301 cunei fonoassorbenti sagomati in 18 forme diverse. Questo ambiente elimina il 99,9% dei rumori esterni, permettendo di studiare la percezione sonora in condizioni ideali, per esempio per valutare l’efficacia di un nuo -
vo materiale o analizzare la risposta uditiva in assenza di disturbi.
Il Rev Lab è una camera riverberante dalle pareti asimmetriche che simula il riverbero di grandi spazi come una cattedrale; può essere collegata direttamente alla camera semianecoica per test combinati sul comportamento acustico dei materiali, fornendo dati preziosi per progettisti e ingegneri acustici.
Il Micromax Lab ospita microscopi ad alta precisione, tubi a impedenza di Kundt e strumenti per il controllo dimensionale, visivo e strutturale, permettendo analisi approfondite di microstrutture e prestazioni acustiche.
L’Habitat Lab espande la tipologia dell’analisi del campo sonoro all’ambiente reale grazie a un’acustica modificabile in tempo reale e a un sistema di visualizzazione diretta delle onde sonore.
7 spazi di ricerca nel cuore dell’headquarter di Caimi a Nova Milanese aperti anche a università ed enti di ricerca dove si sperimentano soluzioni innovative in termini di acustica e materiali

Supernova Lab, camera semianecoica dell’Open Lab Caimi: ambiente isolato acusticamente e schermato dalle interferenze elettromagnetiche per lo studio della percezione sonora e delle prestazioni dei materiali.
L’Hub Lab è il centro di gestione e controllo dei flussi di dati, registrazioni e immagini dei diversi laboratori con monitoraggio locale e da remoto. Il Design Lab, infine, traduce la ricerca in modelli e prototipi funzionali, anche con tecnologie di stampa 3D, per validare soluzioni adatte a essere messe in produzione. Oltre all’attività sperimentale, OpenLab è una struttura no profit aperta gratuitamente a università, istituti di ricerca, fondazioni ed enti pubblici e privati, oltre a scienziati, artisti e divulgatori. Questa apertura favorisce la contaminazione tra discipline e la condivisione delle conoscenze, con l’obiettivo di generare soluzioni innovative che migliorino la qualità degli ambienti e della vita. La struttura è anche un polo formativo: organizza corsi, workshop e seminari, spesso con crediti formativi, in collaborazione con ordini professionali, scuole e


università. Le attività riguardano il design del suono, della materia e degli spazi, offrendo a progettisti e studenti la possibilità di acquisire competenze tecniche avanzate e di sperimentarle in un contesto reale, anche attraverso simulazioni e progetti pilota.
www.caimi.com
Sopra. L’Hub Lab è il centro nevralgico dei laboratori, che regola il flusso di dati, informazioni registrazioni e immagini provenienti dai vari laboratori.


Open Plan Office
Tool di Ecophon supporta la progettazione acustica negli open space.
Viene applicato sia in fase di nuova progettazione, per definire finiture e configurazioni sia in interventi di riqualificazione acustica, per ottimizzare spazi già operativi.



La qualità dell’ambiente interno è determinata da più fattori: qualità dell’aria, comfort termico, luce e acustica. Nei luoghi di lavoro, il rumore è tra le principali cause di insoddisfazione e calo di performance. Secondo studi internazionali, dopo un’interruzione sonora un lavoratore impiega in media 15 minuti per ritrovare la concentrazione, con effetti diretti sulla produttività. Un comfort acustico adeguato può incrementare l’efficienza individuale fino al 20%, con benefici economici immediati per le aziende.
Negli uffici open space, il parlato non pertinente è la fonte di disturbo più rilevante e difficilmente mitigabile con il solo isolamento tradizionale. È stato inoltre rilevato che la variabilità del rumore incide più del livello sonoro medio sulla distrazione, anche quando le conversazioni avvengono in lingue sconosciute. La comprensione del contenuto, quindi, non è necessaria per generare disagio e il fenomeno riguarda ogni tipo di attività d’ufficio. Il comfort acustico è inoltre influenzato da rumori esterni,
impianti tecnici e attività negli spazi adiacenti. Fenomeni come il Lombard effect – l’aumento involontario del volume della voce in presenza di rumore di fondo – amplificano il disturbo. Questo rende indispensabile un approccio integrato che combini soluzioni architettoniche, arredi fonoassorbenti e strategie di pianificazione acustica.
Nei grandi spazi condivisi, parametri classici come il tempo di riverberazione risultano poco significativi. La presenza di partizioni, arredi e materiali eterogenei interrompe infatti il campo acustico diffuso ipotizzato dalle norme Iso 3382-1 e 3382-2. Per valutare correttamente le prestazioni acustiche si preferiscono oggi indicatori specifici per open space, come il Da,s introdotto dalla Iso 22955, che misura l’attenuazione della voce tra postazioni in condizioni reali e consente di definire target chiari in fase progettuale.
Per rispondere a queste esigenze, Ecophon Saint-Gobain ha sviluppato Open Plan Office Tool, strumento basato sulla Iso 22955 che
La gestione del rumore è un fattore strategico di benessere e produttività. Con Open Plan Office


Tool, Ecophon offre un supporto tecnico per progettare ambienti acusticamente equilibrati

permette di calcolare le distanze ottimali tra postazioni e di simulare l’efficacia di diverse soluzioni di assorbimento e schermatura. Il tool considera parametri come dimensioni e layout dell’ambiente, grado di assorbimento acustico, altezza e caratteristiche dei pannelli divisori, tipologia di attività e sensibilità al rumore degli occupanti. Viene applicato sia in fase di nuova progettazione, per definire finiture e configurazioni, sia in interventi di riqualificazione acustica, per ottimizzare spazi già operativi. Questo approccio integra competenze acustiche, normative e progettuali, trasformando il tema del rumore in un elemento misurabile e gestibile.
Il risultato è un set di indicazioni operative che consentono di ridurre la propagazione del parlato, mantenere livelli di rumore di fondo controllati e raggiungere un adeguato equilibrio tra comunicazione e privacy negli open space.
www.ecophon.com/it/



Per il progetto sono stati utilizzati circa 1.000 metri quadrati di pannelli 4akustik Random nella finitura Teak Biblos capaci di seguire le curvature variabili dei quattro lati dell’edificio. Foto Ansis Starks.
Fantoni, storica azienda friulana e punto di riferimento internazionale nell’acustica architettonica, ha sviluppato il pannello 4akustik Random come evoluzione della propria gamma di sistemi fonoassorbenti. Il passo sfalsato delle doghe crea una superficie dinamica e non ripetitiva, capace di interrompere la riflessione sonora e di integrarsi in diversi contesti. Mappato Leed, certificato Epd e con classe di reazione al fuoco B-s1,d0, è conforme allo standard F 4 stelle secondo la norma JIS, convalidata dal ministero giapponese e considerata la più rigorosa al mondo, relativamente al bassissimo contenuto di formaldeide e quindi alla salvaguardia ambientale.
Sviluppato dallo studio di Riga Sarma Norde Architects, il progetto della biblioteca e centro comunitario Galinciems, nella città di Ventspils sul mar Baltico, è stato avviato nel 2015 e realizzato tra il 2020 e il 2023, dopo un lungo processo iniziato con la definizione
del concept e proseguito con test, mock-up e progettazione esecutiva.
L’edificio è stato pensato come un punto di riferimento per la comunità, capace di dialogare con la presenza di alberi secolari e con il paesaggio urbano circostante. La sua architettura è un volume trasparente, aperto su due livelli, con un percorso circolare privo di partizioni interne che ruota attorno a un grande tronco ligneo centrale, elemento simbolico che richiama l’immagine di una foresta di libri. Gli spazi interni ospitano una biblioteca con 10mila volumi, una sezione bambini con 3mila libri, una sala eventi da 60 posti, una sala computer e ambienti multifunzionali, concepiti per essere riconfigurati in base alle esigenze. Questa organizzazione, se da un lato favorisce la fruibilità e la flessibilità d’uso, dall’altro genera sfide acustiche importanti: la combinazione di superfici vetrate, grande apertura e assenza di barriere aumenta il rischio di ri-



Il pannello 4akustik Random di Fantoni, che combina prestazioni acustiche, rispetto per l’ambiente e libertà compositiva nella biblioteca di Ventspils interpreta le forme complesse di un’architettura trasparente e aperta





verberi. Per affrontare il problema, il partner Fantoni locale Sia Progetto ha condotto test preliminari nel 2018, verificando la capacità di curvatura delle lamelle Random. La fornitura finale ha compreso circa 1.000 m2 di pannelli in finitura Teak Biblos, posati su una sottostruttura in multistrato progettata per adattarsi ai raggi di curvatura variabili dei quattro lati dell’edificio.
Lo spazio è stato suddiviso in tre macro-aree, ciascuna caratterizzata da una diversa tipologia di fresatura, creando identità visive distinte senza interrompere la continuità materica. Durante la posa è stato necessario monitorare costantemente umidità e temperatura per garantire stabilità dimensionale e prestazioni acustiche costanti.
Oggi la biblioteca è un luogo in cui il silenzio è progettato: la luce naturale filtra dalle grandi superfici vetrate, scivola sulle doghe lignee e accompagna i visitatori lungo le curve del

tronco centrale, mentre il rumore di fondo si attenua e ogni parola resta nitida. Il progetto rappresenta un esempio di come tecnica e forma possano convivere, trasformando uno spazio aperto e complesso in un ambiente accogliente e funzionale.
www.fantoni.it
La complessità geometrica ha richiesto la realizzazione di una sottostruttura in multistrato e un’attenta ingegnerizzazione della posa. Lo spazio è stato suddiviso in 3 grandi aree
ognuna delle quali è caratterizzata da una diversa tipologia di fresatura del pannello, creando una distinzione visiva senza rinunciare alla coerenza materica. Foto Ansis Starks e Arjoms Vidzemnieks.
Nella nuova sala polifunzionale del polo scientifico Rizzi i pannelli Akustika garantiscono acustica ottimale e qualità architettonica



Nel polo scientifico universitario Rizzi, a Udine è stata inaugurata una sala polifunzionale che combina sostenibilità, accessibilità e comfort acustico. La struttura, certificata CasaClima, è stata progettata dallo studio Rossiprodi di Firenze per ospitare attività di studio, didattica e conferenze, con una tribuna telescopica che ne amplia la versatilità.
Elemento tecnico centrale del progetto è la soluzione fonoassorbente: 884 metri quadrati di pannelli fonocorrettivi Akustika di Skema rivestono pareti e soffitto. Nella finitura Rovere Marino 14/2 FP16, si alternano fasce piene
e doghe fresate da 8 mm con interasse di 16 mm, configurazione ottimizzata per assorbire le frequenze del parlato. Grazie al sistema brevettato di giunzione No gap, che gestisce le dilatazioni, si possono creare pareti in continuità, senza stacchi. Il risultato è un indice di assorbimento α S pari a 1, tra i più alti della categoria, che garantisce distribuzione sonora uniforme e netta riduzione del riverbero. Oltre alle prestazioni, i pannelli assicurano sicurezza e salubrità: realizzati in Mdf nobilitato con tecnologia Dpl, sono ignifughi e a emissione di formaldeide irrilevante, molto inferiore ai
limiti di legge. Questo li rende ideali per ambienti pubblici ad alta affluenza, dove la qualità dell’aria e la resistenza al fuoco sono requisiti imprescindibili.
www.skema.eu
Nelle foto, la sala polifunzionale del polo scientifico Rizzi di Udine rivestita con i pannelli fonocorrettivi Akustika nella finitura Rovere Marino per pareti e soffitti.



Nella villa bifamiliare 2X2Marconi di Inveruno, il sistema costruttivo in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong ottimizza isolamento e prestazioni energetiche



Dall’esterno sembra un gioco di geometrie: quattro volumi disposti attorno a un baricentro, con coperture a capanna che si inclinano e si orientano in modi diversi. La luce filtra da aperture calibrate, accendendo i materiali e scandendo i momenti della giornata. La villa 2X2Marconi di Inveruno, nell’ovest milanese, firmata dallo studio Giola, accoglie due famiglie in spazi distinti ma complementari: zone giorno aperte verso la strada, zone notte protette e affacciate sul giardino, collegate da volumi di ingresso e scale che funzionano come cerniere architettoniche.
La solidità e il comfort nascono da un cuore tecnico preciso. Tutta la struttura è costruita con blocchi Ytong in calcestruzzo aerato autoclavato di Xella Italia, scelti per garantire isolamento termico e acustico, ma anche velocità di posa. Nei divisori tra le due unità abitative, i blocchi Y-Acu ad alta densità, combinati con Y-Pro, sfruttano per smorzare le onde sonore l’effetto ‘massa-molla-massa’, ovvero l’effetto fisico per il quale le onde sonore vengono smorzate tramite l’interposizione di un materiale leggero tra due pareti di diverso peso: il risultato, testato in laboratorio, è un potere fo-

integrandosi nel progetto dello studio
Giola


Nella villa bifamiliare 2x2Marconi è stata utilizzata la soluzione costruttiva monostrato Ytong di Xella. In particolare i divisori fra le diverse unità abitative sono stati costruiti con il blocco sottile Ytong Y-Acu e il pannello Y-Acuboard.
noisolante di 65 dB con soli 26 cm di spessore. Ogni dettaglio costruttivo è pensato per eliminare ponti acustici e termici: giunti sigillati con materiali elastici, taglio degli intonaci per svincolare le pareti, pannelli isolanti Multipor integrati nelle murature esterne in blocchi Climagold da 48 cm. Il risultato è un edificio in classe energetica A4, capace di mantenere una temperatura stabile, ridurre i consumi e offrire un ambiente silenzioso e confortevole in ogni stagione.
www.xella-italia.it




1 Acustica di Fabbian, design MinelliFossati, è una lampada fonoassorbente in Pet riciclato con struttura in alluminio anodizzato nero e diffusore in polimetilmetacrilato opalino. Il paralume sottile assorbe le onde sonore migliorando il comfort acustico. Disponibile a sospensione o applique, in vari diametri e colori, con sorgente Led dimmerabili. www.fabbian.com
2 La collezione di tende fonoassorbenti Acoustics Silencer di Jab Anstoetz, realizzata con filati sviluppati per l’assorbimento acustico, combina protezione dalla luce con un’efficace riduzione del rumore, oltre a essere ignifuga. Due le nuove proposte: il tessuto semitrasparente Silent Breeze e Silent Sun, che integra efficacia acustica e protezione termica e UV. www.jab.de
3 Waves è la nuova tenda acustica multistrato per schermare e ridurre il suono, con riduzione fino a 15 dB, messa a punto da Kvadrat Acoustics che crea spazi privati con elevato comfort uditivo e visivo all’interno di ambienti più ampi. Nata inizialmente su misura, è oggi un prodotto standard dopo anni di prototipazione e installazioni di successo. kvadrat.dk/kvadrat-acoustics

2

4 EchoTorrent – Floating Acoustics di Echojazz è un divisorio sospeso con assorbitore dall’effetto flottante in Pet riciclato, pensato in particolare per ambienti con soffitti alti. Montato senza viti su cavi tesi tra pavimento e soffitto, è facile da installare e personalizzare in forme e colori. Elementi fonoassorbenti su entrambi i lati migliorano l’acustica e l’estetica di uffici, lobby e ristoranti. www.echojazz.com
Tende, pannelli lampade, panche elementi d’arredo realizzati per migliorare il comfort acustico dei diversi ambienti, che passa attraverso un corretto equilibrio tra fonoassorbimento e fonoisolamento

3


6
5 Silhouette di Isolspace, design by Odeon Design, sono pannelli fonoassorbenti bifacciali in classe A, spessore 35 mm, in forme rotonde o ovali e in varie dimensioni. Dotati di certificazioni ambientali e di sicurezza, uniscono comfort acustico, estetica e sostenibilità. Nell’immagine le versioni wall e baffle, che si aggiungono a quelle ceiling, desk, stand e totem. www.isolspace.it
6 benchwall di molo, ideata da Stephanie Forsythe e Todd MacAllen, è una panca flessibile con alto schienale che funge sia da seduta sia da partizione acustica. In carta (come nell’immagine) o tessuto riciclabile, si estende fino a 3,5 o 5 metri, ed è disponibile in vari colori. Modulabile in linee rette o curve, crea spazi dinamici e accoglienti. www.molodesign.com
Vie d’acqua, strade campestri, cammini, ferrovie. Tra le molteplici reti di infrastrutture minori che attraversano il paesaggio italiano e lo formano, quella ferroviaria è la più strutturata e le linee secondarie – sono circa 6mila i chilometri in abbandono – è da tempo, non solo in Italia, al centro dell’attenzione. Ponti, viadotti, gallerie, trincee, rilevati: al catalogo di infrastrutture si aggiunge il patrimonio di tipi architettonici ricorrenti per gli edifici di servizio – stazioni, piazzali, scali merci, caselli – e il tema che Percorsi lenti affronta non è semplicemente quello della cosiddetta mobilità dolce o del turismo consapevole, bensì quello di “riscrivere le modalità di attraversamento del territorio in una sequenza di azioni progettuali che intercetti trasversalmente contesti e architetture, luoghi di margine e strutture abbandonate…favorendo una rinnovata accessibilità a quelle aree interne altrimenti destinate a un inesorabile spopolamento” (pag. 107). Dopo un esame anche storico delle ferrovie italiane il testo di Anna Giovannelli, architetto e professore associato alla Sapienza di Roma, si concentra sulla linea abbandonata Orte-Civitavecchia, illustrando, anche con disegni, possibili interventi puntuali di riconversione, non solo del tracciato ma delle emergenze architettoniche, capaci di ricollegare centri tra loro vicini. L’interessante lettura si conclude con un atlante di nove esempi di riconversioni già avvenute nel mondo (in Italia la ciclovia Caltagirone - San Michele, il percorso quasi sempre in galleria tra Albissola Superiore e Celle Ligure e il community hub di Grassano Scalo in Basilicata).


Percorsi lenti
Ferrovie abbandonate e progetto Anna Giovannelli Franco Angeli, Milano 2025 198 pp, 28 euro - ISBN 978-88-351-4730-5
Viene da chiedersi in che modo il mascherare, il confondere alla vista, per rendersi invisibili ai predatori ma anche ai militari e alle loro strutture, appartenga al mondo dell’architettura, oltre che all’arte e al cinema. Lo svela Roy R. Behrens, artista e accademico americano, che riporta, tra l’altro, un simpatico aneddoto su Frank Lloyd Wright e la sua capacità di riciclare un centro commerciale trasformato in una chiesa. Se oggi l’apparire sembra essere l’unica strada per divenire visibili, questo agile volume ci spiega come si può scomparire, ingannando lo sguardo grazie anche a materiali diversi tra loro, dallo specchio al vetro, dalla terra ai rami al vapore. Gli autori esplorano doversi mondi: quello di sotto, con Virilio che propone una sorta di estetica della sparizione e arte dell’accecamento. Per ingannare il nemico in guerra, ma anche con opere d’arte come Self-burial di Keith Arnatt dove il soggetto sprofonda lentamente nel terreno fino a scomparire; il mondo che frequentiamo abitualmente, dove l’invenzione del corridoio e i passages citati da Walter Benjamin aiutano a nascondersi, al pari dei lugubri sottopassi o delle stazioni della metropolitana come la Zoo a Berlino, ben
Con un geniale approccio letterario, il libro che l’architetto Marco Brunori, a lungo collaboratore di Dino Gavina, dedica all’imprenditore del mobile è anche una storia sui generis del nascente design italiano nel periodo del boom economico, con il passaggio dalla produzione artigianale a quella seriale. Brunori raccoglie sessanta testimonianze che pagina dopo pagina raccontano un personaggio straordinario e insieme i prodromi di un’eredità – in parte dispersa – che oggi va sotto il nome di ‘made in Italy’. Partito dalla passione per il teatro e le arti visive, amico di Lucio Fontana, Dino Gavina (1922-2007) è tra i primi ad avviare collaborazioni con architetti come Carlo Scarpa (lo fa presidente della Gavina Spa), Kazuhide Takahama e i fratelli Castiglioni. Da una rossa ciotola giapponese nasce l’idea di laccare i mobili, che fino ad allora venivano semplicemente resi lucidi ‘come caramelle’ per gli arredi borghesi di lusso (è il cugino Atos Gavina che parla).
Del resto, diceva Gavina, “i ricchi devono essere liberati dal kitsch per ricchi, i poveri devono essere liberati dal kitsch per poveri”. Per farlo, nel 1974 con Enzo Mari inventa ‘Metamobile’: arredi belli e economici da montare. In anticipo su Ikea, la linea fu un insuccesso commerciale (nessuno si sognava di montarsi i mobili
diverse da quelle di Mosca o dalla Toledo di Oscar Tusquets a Napoli.
Infine, il Il Mondo di sopra che è un canto “… mimetizzarsi sparire/abbarbicarsi amalgamarsi al suolo/farsi una vita di fronda/e mai ingiallire/...” che entra in sintonia con Scheerbart e Taut proponendo il Tree Hotel di Tham & Videgård o il Blur Building di Diller + Scofidio per la Swiss Expo del 2002.


Mario Pisani
Camouflage. Dalla città profonda alla città superficiale Jacopo Boschi e Antonello Boschi LetteraVentidue, Siracusa, 2025 100 pp, ill b/n, 13,50 euro - ISBN 979-12-5644-089-4
da sé, e le masse preferivano ancora lo stile pseudobarocco). Istinto e razionalità, ammirazione e incomprensioni, le riedizioni del Bauhaus e del mobile scandinavo ma non di Le Corbusier, che così passa a Cassina, la nascita di brand come Flos (dopo un incontro, nel 1961 a Merano, con Eisenkeil, Cesare Cassina, Pier Giacomo e Achille Castiglioni) che lascia tre anni dopo, e Simon International: la vita appassionante di colui che sul biglietto da visita si definiva ‘sovversivo’ e sul recto, citando Man Ray, scriveva “la verita? Niente di più sovversivo”. Ma non c’erano né indirizzo né numero di telefono.

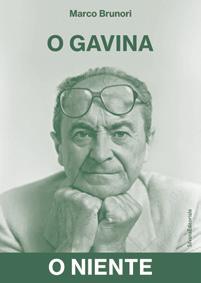
Gavina o niente
Marco Brunori Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2025 400 pp, 32 euro - ISBN 978-88-366-6081-0
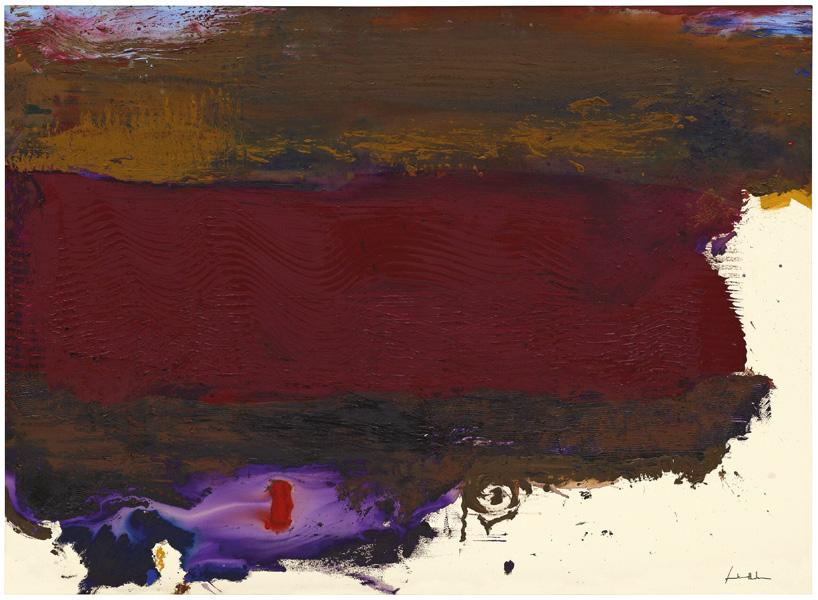
Dal design di arredi versatili alle soluzioni tecniche più avanzate, il contract si rinnova costantemente per offrire funzionalità, resistenza e personalizzazione. La selezione di proposte pensata per l’hospitality e gli spazi collettivi contemporanei coniuga estetica e performance, con materiali evoluti e dettagli progettuali studiati per garantire comfort e durata nel tempo a cura di Elena Riolo
SI-SI VIBES. Disegnata da Meneghello Paolelli Associati, la seduta per interni ed esterni ha struttura in acciaio verniciato e scocca in plastica rigenerata Go Green. La texture dello schienale richiama le onde sonore. È disponibile con o senza braccioli, in sei colori: lino, tortora, caramel, verde salvia, verde oliva, antracite. www.s-cab.it


G.T.DESIGN
PAGLIETTA COTTA. Disegnata da Deanna Comellini, la collezione di tappeti è tessuta a mano su telai tradizionali combinando iuta naturale e filato tecnico lucido per una trama tridimensionale che ricorda la cotta di maglia. Le nuove tonalità Sempreverde, Oltremare, Terra e Naturale ampliano il potenziale decorativo di un tappeto versatile e personalizzabile, adatto a interni ed esterni riparati. www.gtdesign.it
GD DORIGO
WOOD. Porta in legno – liscia, intarsiata o con incisioni – proposta nella finitura Frassino Sabbia, con apertura a battente o libro asimmetrica. Gli intarsi, realizzati con essenze pregiate, valorizzano texture e profondità materica. La produzione combina lavorazione artigianale e processi industriali evoluti. www.gd-dorigo.com


KYMA. Ispirata all’opera di Giovanni Muzio, la collezione living disegnata da Matteo Nunziati, composta da divano, poltrona e coffee table, ha struttura portante in legno con tasca in pelle che accoglie cuscini in pelle o tessuto. Le finiture sartoriali e la palette tenue si adattano a spazi contract eleganti e coordinati. www.turri.it

Fondatore e chairman dello
studio Dante O. Benini & Partners Architects, con sedi a Milano e Londra, Dante O. Benini si è formato con Carlo Scarpa e ha collaborato con Oscar Niemeyer e Frank O. Gehry. Oggi guida un team internazionale attivo in architettura, urbanistica, interior, yacht design e product design. www.dantebeniniarchitects.com
Il valore del dettaglio: quando l’oggetto diventa racconto nell’hospitality
Nel progetto Carlo, il gancio – con cui ho voluto interpretare e tributare il mio maestro Carlo Scarpa – è un dettaglio funzionale per appendere accappatoi che permette a un oggetto semplice di evolvere in un vero e proprio progetto di design. Interessante sarà vedere come gli albergatori declineranno anche le salviette arrotolate dietro il tubo, come già avvenuto in altri modelli di Antrax IT come Teso: liberare la fantasia è già la base del successo. Quando viaggiamo cerchiamo continuamente soggiorni ricchi di emozioni, in qualsiasi parte del mondo, anche per poche ore. Un soggiorno è apprezzato quando ogni servizio e scelta di
CLICK&CLOSE. Chiave magnetica pensata per completare il total look delle porte, con possibilità di personalizzazione nelle finiture coordinate con maniglia, bocchetta e rosetta. Si connette alla serratura per attrazione magnetica e funziona con foro da 9 mm, semplificando l’estetica e riducendo gli elementi visibili. www.dndhandles.it


interior all’interno di una struttura è capace di offrire stupore e funzionalità e sempre di più i singoli dettagli sono fondamentali, perché contribuiscono in maniera forte a comporre un insieme ricco di suggestioni e l’unicità del luogo in cui decidiamo di trascorrere del tempo. Carlo è uno di quegli oggetti che accompagna questa filosofia: semplice, essenziale, ma con un segno unico, e una molteplicità di opzioni per le finiture, che permettono sempre accostamenti personalizzati e in linea con il linguaggio estetico e il racconto specifico del luogo.
Dante O. Benini
ANTRAX
CARLO. Progettato da Dante O. Benini, l’accessorio scaldante elettrico a basso consumo è ispirato a un dettaglio di Carlo Scarpa che viene interpretato come il coronamento di un tubolare verticale scaldante da poter utilizzare a integrazione di altri sistemi di riscaldamento. Il gancio in acciaio inox satinato, ricavato da un taglio laser, si integra al tubolare in alluminio riciclabile. Disponibile in oltre 200 finiture. www.antrax.com






SINFONIA SYSTEM. Il sistema componibile di sospensioni Led in alluminio con diffusore in polimetilmetacrilato satinato è personalizzabile per forma, lunghezza e finitura. I corpi illuminanti, anche con texture finale lavorata, si combinano liberamente per creare composizioni a grappolo, decentrate o in scenografie a cascata. www.linealight.com



NIA. Il sistema modulare di sedute disegnato da Leonardo Talarico si evolve con nuovi pannelli fonoassorbenti, rivestiti in tessuto, che creano nicchie riservate per spazi collettivi. Ideale per uffici, lounge o hospitality, include tavolini e si presta a configurazioni libere in centro stanza o a parete.
www.dieffebi.com

SABER. Elementi modulari in vetro veneziano, come sfere e cilindri con lavorazioni rigamenà o rigadin, si compongono in sequenze ritmiche o libere per installazioni personalizzate della linea Bespoke. Il sistema a cavi sospesi, quasi invisibile, consente configurazioni leggere, flessibili e scenografiche, anche su misura, ideali per ambienti contract di grande impatto. www.barovier.com
TUBES
I CHING. Disegnato da Elisa Ossino, il modulo scaldasalviette elettrico realizzato in acciaio inox 304L si caratterizza per la forma essenziale e le dimensioni ridotte. Disponibile in quattro lunghezze e 13 finiture galvaniche, si installa a parete in totale sicurezza anche in ambienti umidi, grazie al funzionamento a bassissima tensione (24 Volt).
www.tubesradiatori.com

KARL LAGERFELD
WELLEN. Realizzata in collaborazione con il designer Toan Nguyen, la nuova collezione per la zona notte si compone di letto, comodini e chaise longue. La sua identità è definita da forme avvolgenti, volumi generosi e linee morbide ispirate alle onde del mare.
www.karllagerfeld.com


La seduta come architettura: struttura e imbottitura in dialogo
Il designer francese
Patrick Jouin, fondatore dello studio Patrick Jouin iD, ha ideato progetti presenti nelle collezioni permanenti di musei internazionali che spaziano dal prodotto all’arredo urbano www.patrickjouin.com
Con Opale, torniamo ai nostri primi amori. Più di dieci anni dopo Ester, abbiamo immaginato una nuova seduta in cui eleganza e comfort si fondono in un dialogo attento ed equilibrato. Il legno è un materiale caldo e naturale, è il futuro. In questa poltrona le gambe posteriori salgono fino allo schienale, diventano elemento ornamentale e si fondono con l’imbottitura. Forte e morbida allo stesso tempo, la gamba dona una silhouette che veicola comfort, ma anche eleganza. La seduta non è solo un guscio imbottito posto

sulle quattro gambe: il legno funge da rifugio per l’imbottitura. Quando disegno una sedia, la prima cosa a cui penso è il gesto. Quel momento in cui il cameriere la sposta per accogliere l’ospite è delicato, ed è lì che inizia il progetto. Una sedia deve essere facile da spostare: il gesto deve risultare naturale e raffinato. Per questo nel profilo di Opale è presente una maniglia, molto discreta, ma che dona volume allo schienale.
Patrick Jouin

TEMPOTESTSTAR HOME BLUE. Prodotto con uno speciale filo in poliestere riciclato certificato GRS, il tessuto per esterni è studiato per resistere alla luce solare e alle condizioni atmosferiche senza ingiallire. È quindi ideale per arredi outdoor esposti o ambienti interni che richiedono tessuti resistenti e facilmente lavabili. Grande resistenza alla trazione e alle cuciture. www.para.it
OPALE. Disegnata da Patrick Jouin, la poltrona, dalle linee fluide e organiche si distingue per le gambe in noce o frassino che si innestano nello schienale e nei braccioli imbottiti in schiumato poliuretanico. Compatta e maneggevole grazie alla maniglia posteriore integrata. Le cinghie elastiche assicurano il massimo comfort. Materiali certificati Fsc C114358 e verniciatura a base acqua. www.pedrali.com

ENTO
LEV. Progettata da Victor Vasilev, la maniglia gioca su geometrie pure e proporzioni auree, con un design minimale che si adatta a contesti residenziali e pubblici. Realizzata in ottone, è disponibile su placca o rosette da 3 o 6 mm, nelle finiture cromo lucido, cromo satinato, nero opaco anti-impronta e carbonio satinato ad alte prestazioni. www.ento.it




DIEMMEBI

LIBRA. La seduta monoscocca in plastica riciclata ReMade in Italy, adatta a vari telai per uso indoor e outdoor, è stata progettata da Sandonà Bettini per il contract. Si distingue infatti per l’elevata densità di impilaggio (fino a 25 sedute su carrello), facilità di montaggio e riciclo, e per il supporto posteriore metallico a vista. www.diemmebi.com
CIERRE1972
CHAPEAU. Disegnato da Stefano Conficconi, il letto unisce testiera in metallo imbottita con poliuretano espanso e rivestita in fibra acrilica siliconata a un sommier in legno imbottito con poliuretano espanso, rivestito in falda acrilica. I piedi in metallo sono disponibili in tre finiture –verniciato effetto champagne, verniciato nero o cromato nero –, il profilo in pelle Soffio, Setanil o Natural Velour. www.cierreimbottiti.it
DIERRE
OPERA DISUPER. La porta tagliafuoco in legno certificata EI30 ed EI60, testata per la tenuta ai fumi freddi secondo EN 1634-3 e con isolamento acustico fino a 47 dB, è pensata per il settore hospitality e gli spazi pubblici. Unisce elevate performance tecniche a un’estetica personalizzabile: finiture in essenza, inserti decorativi, cerniere a scomparsa e misure fuori standard.
www.dierre.com


AERRE
SCORPIO. Il divano con struttura in massello di abete e/o multistrato, imbottiture in poliuretano espanso e piedi metallici fa parte della collezione Made in sunshine. Le meccaniche traslanti di schienale e braccioli permettono di regolare la profondità e trasformare la seduta in letto di servizio. www.aerreitalia.com

Nuovi scenari contract tra reale e immaginato
La Creative Direction per la Divisione contract di MDF Italia ha l’obiettivo di costruire nuovi scenari di racconto in armonia con il linguaggio espressivo dell’azienda. Si è pensato di sviluppare dei meta-progetti rivolti a un target in sintonia con i canoni aziendali: spazi collettivi in cui trovassero una giusta collocazione i prodotti pensati, in origine, per la casa. Il risultato è essenzialmente la definizione di due progetti virtuali, l’office e l’hospitality, che, evidenziando la versatilità dell’offerta, permettono di sviluppare soluzioni più funzionali ed essenziali o più intime e creative. Un prodotto trasversale deve
COURTOISIE. Progettata da Sam Baron per la collezione Woven Dreams. A Story of Artisanal Headboards, la testiera tridimensionale intreccia legno e tessuto in una struttura avvolgente ispirata ai baldacchini medievali. Il doppio strato curvato funge anche da piano d’appoggio, offrendo uno spazio protettivo per leggere o riposare. www.bolzan.com
967arch è uno studio milanese fondato da Cesare Chichi e Stefano Maestri. Da 25 anni lavora tra architettura, interni e design di prodotto con un approccio narrativo e multidisciplinare. www.967arch.it


garantire prestazioni e qualità, soprattutto se vuol definirsi senza tempo. Nel contract, è il progetto a guidare le scelte, per questo è essenziale, per un’azienda di arredi, mantenere la propria identità sul prodotto. Duetto è uno sgabello dalla forte personalità che può caratterizzare un ambiente con la sua essenzialità o scomparire grazie alla sua leggerezza. Nel contract, questa doppia natura permette di esaltare l’espressività di uno spazio o di preservarne il rigore.
967arch
DUETTO. Composto da due sottili lame metalliche in tensione e una seduta sinuosa in polipropilene, lo sgabello essenziale e leggero disegnato da 967arch, Creative Director della divisione contract di Mdf Italia, è pensato come seduta informale per spazi pubblici e privati. È disponibile in due altezze e due colori, con struttura in acciaio verniciato a polvere (microgoffrato) e seduta e poggiapiedi in polipropilene caricato con fibra di vetro. www.mdfitalia.com


CASSIA. Progettata da Raffaello Galiotto, la seduta per esterni in resina fiberglass ergonomica e confortevole è disponibile con o senza braccioli e anche in versione sgabello. Impilabile, leggera e resistente all’uso intensivo, è proposta in otto varianti cromatiche, tra cui due in resina rigenerata: cactus e basalto. www.nardioutdoor.com

PEGGY. La struttura in frassino naturale, tinto o laccato, composta da cavalletti inclinati e braccioli imbottiti, è l’elemento che caratterizza la nuova seduta firmata da Marco Zito. Il cuscino di seduta è comune a entrambe le versioni, mentre lo schienale cambia: più basso nella poltrona, con poggiatesta dalle dimensioni importanti nella versione lounge. www.bross-italy.com
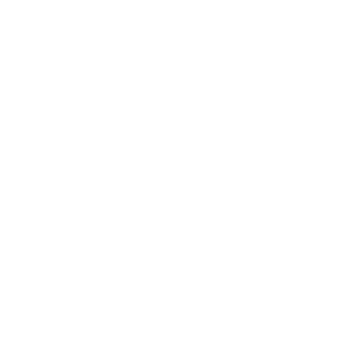
ZANINI


HYDROX. Arreda con stile ed eleganza tutti gli ambienti, anche nelle situazioni in cui l’umidità può causare danni. Le porte d’arredo Hydrox garantiscono performance elevate grazie alla tecnologia dry-in, un sistema idrorepellente, ideale per tutti gli ambienti umidi come saune, palestre e ambienti bagno. Garantiscono la massima personalizzazione nei colori e nelle dimensioni e sono accessoriate con cerniere a scomparsa e serratura magnetica. www.zaniniitalia.com



LEMA
MANDARIN ORIENTAL RESIDENCES MAYFAIR. Per il progetto di interior firmato dallo studio americano Thomas Juul-Hansen, l’azienda ha fornito armadi, cucine e arredi su misura per 80 appartamenti. La divisione Contract ha tradotto l’estetica dell’interior in sistemi sartoriali attraverso finiture in rovere naturale, pannelli laccati opachi, dettagli in metallo bronzato e in pelle. www.lemamobili.com
VANITÀ LIVING
ERCOLE. Design Gianmarco Codato e Luciano Trevisiol, combina solidità, stile e carattere. Questo specchio ricorda la forma di un foglio piegato e la sua fonte luminosa, grazie alla tecnologia Ghost Mirror brevettata dall’azienda, appare solo nel momento dell’accensione lasciando, a luce spenta, la superficie riflettente uniforme e pulita. www.vanitaliving.com

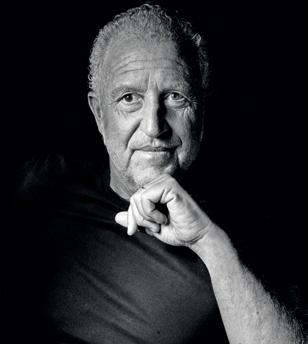
Simone Micheli fonda il suo studio nel 1990. Opera tra architettura, interior e design con progetti dalla forte identità, sviluppati nelle sedi di Firenze, Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat e Busan. www.simonemicheli.com

Dal macro al micro: l’identità del progetto si rivela nei particolari
Quando creo un nuovo prodotto cerco sempre di trasformare la complessità del nostro presente in semplicità, e la maniglia Eder rappresenta proprio questo spirito. Il rapporto tra architettura e dettaglio, nel mio lavoro, è un legame indissolubile, quasi un respiro comune. L’architettura dà forma alla visione, costruisce lo spazio, mentre i particolari sono ciò che lo rendono unico, distintivo, capaci di generare emozione e memoria. Nel mondo dell’ospitalità non sono un semplice ornamento, ma diventano parte integrante del racconto.

Io progetto pensando che ogni linea, ogni superficie, ogni luce sia un gesto consapevole, un frammento di narrazione che contribuisce ad accogliere, a sorprendere, a far sentire l’ospite immerso in una dimensione altra. In questo equilibrio continuo tra architettura e dettaglio nasce la mia idea di ospitalità: un ambiente dove il tutto e la parte dialogano, si sostengono e si esaltano a vicenda, creando scenari che restano impressi nella mente e nell’anima.
Simone Micheli

FRASCIO
EDER. Disegnata da Simone Micheli, Eder è una maniglia dalla forma compatta e pura, priva di elementi complessi. Pensata per ambienti come l’hotellerie, dove le dimensioni ridotte richiedono oggetti funzionali ma distintivi, è proposta in numerose finiture, tra cui inoxbrass pvd, cromo lucido e satinato. www.frascio.com

USM X ARMANDO CABRAL. La collezione modulare su misura firmata con Armando Cabral combina design contemporaneo e la tradizione africana del progettista. Libreria, seduta, tavolino, un servomuto e il letto a piattaforma dal design asimmetrico sono infatti ispirati al concetto africano Nkyinkyim, metafora dell’intreccio di progresso e sfide. www.usm.com
PROTEK
MAGIC BOX LINEAR. La serie di controtelai senza stipiti e coprifili è disponibile nelle versioni predisposte per integrare nei divisori interni impianti elettrici (Elektro), idro-termosanitari (Hydra, nell’immagine) o entrambi (Domotika), grazie a un sistema brevettato che integra alloggiamenti coibentati su entrambi i lati del controtelaio. www.protekdesign.it


MOOD DUE Q. Maniglia dal design squadrato con rosetta coordinata. È disponibile in una gamma di 12 colori: White, Black, Bronze, Silver, Ocean Blue, Strawberry Red, Sunset Orange, Lemon Yellow, Claret Violet, Titan, Lime Green, Capri Blue. Colombo Design offre la possibilità di personalizzare le maniglie scegliendo il Ral desiderato. www.colombodesign.IT
ELIA. Il letto, disegnato da Matteo Nunziati, si distingue per la testiera imbottita e rivestita in tessuto, incorniciata da due colonne in legno – in ebano o frassino tinto caffè – che si ripetono anche sui quattro angoli del sommier. Il rivestimento, completamente sfoderabile, è disponibile in tessuto o pelle in un’ampia selezione cromatica. www.flou.it


TOBU. Disegnato da Francesco Rota, il divano modulare si basa su pannelli inclinati in pelle o tessuto, usati come schienali e braccioli, abbinati a cuscini di tre formati diversi. La struttura in metallo, verniciata Iron o rivestita, si articola in composizioni lineari, angolari o con chaise longue. www.porro.com

DANSÌ. La nuova famiglia di applique progettata da Alessandro Zambelli è composta da quattro geometrie in pressofusione, combinabili liberamente. Pensate come segni grafici tridimensionali, offrono un’illuminazione Led morbida e indiretta, sempre orientata verso la parete. www.luceplan.com

Semplicità, intelligenza, accessibilità: il progetto che si adatta al contesto
Il nostro approccio si basa sull’idea che forma e funzione debbano procedere insieme. Con ClubHouse, abbiamo cercato di creare una silhouette semplice e immediatamente leggibile, che nasconde una reale attenzione agli usi: l’impilabilità, la facilità di movimentazione e la robustezza sono integrate fin dall’inizio nel disegno. La semplicità, per noi, significa proporre un oggetto comprensibile a colpo d’occhio, riconoscibile, che non cerca di stupire a tutti i costi. L’intelligenza è prevedere gli usi reali: impilare, spostare, pulire facilmente.
Lo studio svizzero BigGame, fondato nel 2004 da Elric Petit, Grégoire Jeanmonod e Augustin Scott de Martinville, descrive il proprio lavoro come semplice, funzionale, accessibile e, soprattutto, utile. www.big-game.ch

L’accessibilità, infine, consiste nel progettare pezzi che possano trovare posto sia in un giardino privato sia su un’ampia terrazza di un ristorante, rispettando i vincoli di costo del mercato. Nel contract, questa filosofia acquista pieno significato, perché si tratta di immaginare un arredo flessibile, adattabile a contesti diversi, ma che conservi un’identità forte. ClubHouse resta riconoscibile e coerente anche quando è moltiplicato in uno spazio collettivo.
Big-Game
CLUBHOUSE. Progettata da Big-Game, la collezione realizzata inizialmente in teak si arricchisce di una versione in alluminio, leggera, impilabile e resistente, mantenendo al contempo l’eleganza del design ispirato alla lavorazione del legno. Il sistema modulare include sedute e tavoli dalle proporzioni compatte e gambe sottili. Disponibile anche con cuscini Sunbrella grigio antracite e finiture personalizzate. www.tectona.it

DOMIA MINI. La maniglia elettronica alimentata a batteria dedicata al mondo hospitality si installa con facilità su porte nuove o esistenti senza sostituire serratura e cilindro. Oltre alle tradizionali modalità di apertura – tessera, braccialetto e bluetooth – supporta anche l’apertura da remoto tramite link d’accesso. Può essere integrata con la piattaforma cloud Accexi per il check-in e il controllo in tempo reale dello stato delle camere. www.agb.it/hospitality
VIMAR
EIKON EXÉ. La serie civile proposta in quattro declinazioni: tradizionale, Vintage, Flat e Tondo. Il comando Flat, planare e squadrato e Tondo, con retroilluminazione attorno al tasto, sono entrambi presenti nella versione KNX e By-me Plus per home&building automation. Nell’immagine Ca’ Apollonio Heritage, boutique hotel nella Pedemontana Veneta, in cui sono state scelte le declinazioni tradizionale e Vintage. www.vimar.com


VERA. La collezione per esterni in polietilene riciclabile stampato in rotazionale, resistente a urti, salsedine, UV e temperature estreme, progettata dallo studio LCM Marin Design Studio, include divano, poltrona lounge e tavolino. Le forme avvolgenti, ispirate alla natura, sono disponibili in una palette cromatica ampia e adatta all’uso contract.
www.lyxodesign.com
V0 ARCO. Progettata a filo muro con pannello a zero sporgenza, la porta riprende nella parte superiore la forma ad arco, inserendosi come elemento architettonico che valorizza il passaggio e dona continuità visiva agli ambienti. Disponibile in molteplici finiture, nelle versioni a spingere o a tirare, combina eleganza formale, qualità tecnica e versatilità progettuale. www.vivaporte.com


SOLAE. La lampada portatile ricaricabile progettata da Cecilie Manz alterna luce intensa e direzionale a una più calda e soffusa, dimmerabile in tre diverse intensità. La base ovale in alluminio estruso, sormontata da un disco circolare, garantisce ergonomia e orientabilità. Per interni ed esterni, in verde chiaro, grigio caldo e bianco verniciato a umido.
www.fritzhansen.com
JOY. Parte della collezione Natural, il tappeto circolare è realizzato cucendo su sé stesso un tubolare di maglia dall’aspetto soffice e irregolare, con contorni delicatamente sagomati. Realizzato a mano con filati di qualità privi di trattamenti nocivi, unisce ricerca materica e savoir-faire artigianale per interni dall’atmosfera accogliente e informale.
www.paolalenti.it


BARAUSSE
CARVEN. È un concept innovativo che reinterpreta l’antica arte dell’intaglio attraverso tecnologie all’avanguardia come l’erosione laser. Nasce da un’esplorazione profonda del potenziale nascosto del legno, trasformandolo in superfici scolpite con texture uniche e giochi di luce e ombra. Carven unisce tradizione e innovazione per dare vita a porte e boiserie dal design sofisticato, capaci di reinventare gli spazi con eleganza e personalità. www.barausse.com
SCRIGNO
CONTROLUCE. Firmata da Egidio Panzera e selezionata per l’ADI Design Index 2024, la porta battente filo muro integra una cornice Led capace di trasformare la luce in elemento architettonico e decorativo. Il gioco calibrato tra luce e ombra definisce gli spazi coniugando estetica essenziale, innovazione tecnologica e qualità costruttiva. www.scrigno.com

QU
DUOLÌ WALL. Disegnata da Parisotto + Formenton, è la nuova versione a parete della collezione Duolì, con fissaggio e alimentazione a muro o plug-and-play. Realizzata in alluminio, con sorgente Led integrata, offre un’illuminazione puntuale e decorativa. Black, White, Sage Green, Fierce Green, Night Blue, Ancient Brick e Silver Grey sono le finiture disponibili. www.qu-lighting.com


LUSTRALIS. Masiero Lab firma una collezione modulare di sospensioni, plafoniere e applique che alterna sottili cilindri torchon in ottone e borosilicato trasparente su struttura in metallo galvanizzato. Configurabile su progetto, offre moduli Led in varie lunghezze e finiture, per composizioni su misura in contesti residenziali e hospitality. www.masierogroup.com

Dal 31 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e la Rocca Albornoz di Spoleto ospiteranno un’ampia antologica di Mimmo Paladino, curata da Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia, e Aurora Roscini Vitali, storica dell’arte della Galleria Nazionale dell’Umbria, in collaborazione con l’artista stesso. La rassegna alla Galleria Nazionale dell’Umbria documenta, attraverso più di 40 opere provenienti da musei italiani e stranieri e da collezioni private, l’intera attività dell’autore campano, a partire dalle sperimentazioni fotografiche degli anni Settanta e al ritorno alla
figurazione negli anni Ottanta, con un’attenzione particolare ai lavori di grande formato e alla pittura che invade lo spazio. Il percorso espositivo comprende capisaldi come Silenzioso mi ritiro a dipingere un quadro (1977), oltre a tele di più ampie dimensioni che spesso dialogano con la scultura e con interventi che si interrogano sulle potenzialità architettoniche della pittura. La mostra sarà l’occasione per riflettere sul rapporto tra Paladino e l’Arte Povera, con una incursione nelle relazioni tra l’artista e i maestri americani della Pop Art, come Robert Rauschenberg, sull’eterogeneo bagaglio di riferimento dell’artista e
Silenzioso, mi ritiro a dipingere un quadro, 1977. Foto Peppe Avallone.
sull’originalità delle sue scelte espressive. Il percorso espositivo comprende una sezione allestita presso i saloni della Rocca Albornoz di Spoleto, dedicata alla celebre installazione dei Dormienti (1998) e a un percorso che avrà per protagonista la scultura ■
MIMMO PALADINO. Antologica Perugia. Galleria Nazionale dell’Umbria Corso Vannucci, 19 Spoleto. Rocca Albornoziana Piazza Campello, 1 31 ottobre 2025 | 18 gennaio 2026

Il bench Horizon si distingue per il suo design audace e innovativo, che rompe gli schemi delle scrivanie tradizionali. Il sostegno laterale in vetro, posizionato strategicamente, crea un’illusione ottica: la scrivania fluttua leggermente, conferendo allo spazio un’eleganza senza pari. Le gambe tradizionali sono eliminate, sostituite da lastre di vetro trasparente, che contribuiscono ulteriormente a questa sensazione di leggerezza e modernità. Questo approccio unico al design rende il bench Horizon un vero e proprio pezzo d’arte funzionale, perfetto per ambienti contemporanei e di design.

www.estel.com