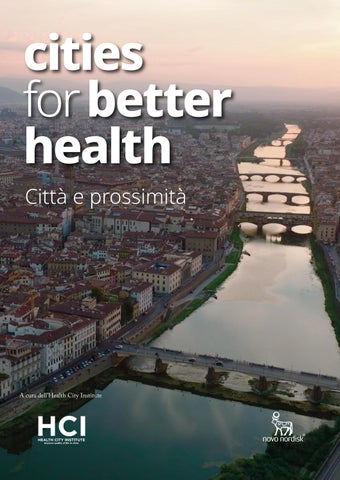Città e prossimità

A cura dell’Health City Institute

Editoriale
Sanità di prossimità e periferie: la cura passa dal territorio
di Andrea Lenzi
Presidente Health City Institute e coordinatore Science for Cities
Le periferie delle nostre città sono spesso territori dimenticati, spazi di marginalità dove il diritto alla salute e al benessere sociale viene eroso da disuguaglianze strutturali. Quartieri con servizi insufficienti, popolazioni vulnerabili e difficoltà di accesso alle cure sono il sintomo di una frattura crescente tra centro e periferia, tra chi può e chi non può permettersi un’assistenza adeguata. In questo contesto, le reti di prossimità socio-sanitarie emergono come una risposta concreta e necessaria per ricucire il tessuto sociale e garantire a tutti il diritto alla salute.
Prossimità: un nuovo paradigma per la salute Il concetto di prossimità nel settore socio-sanitario si basa sulla capacità di portare i servizi sanitari e sociali vicino alle persone, superando barriere geografiche, economiche e culturali. Non si tratta solo di aprire nuovi ambulatori o presidi medici nelle periferie, ma di costruire una rete di assistenza diffusa e capillare, che integri medici di base, servizi sociali, associazioni del terzo settore e cittadini stessi in un modello di cura partecipativa e territoriale.
Questo approccio si oppone alla logica dell’ospedalizzazione e dell’assistenza frammentata, puntando invece su un modello preventivo e comunitario. Gli infermieri di comunità, gli assistenti sociali e le unità mobili di assistenza diventano attori chiave nella presa in carico delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili, come anziani, disabili, migranti e famiglie in difficoltà.
Le periferie come laboratorio di innovazione sociale
Le periferie, spesso viste solo come luoghi di disagio, possono trasformarsi in laboratori di innovazione sociale proprio attraverso le reti di prossimità. Esperienze in diverse città italiane e internazionali dimostrano che dove esistono modelli di assistenza integrata, i risultati sono tan-
gibili: riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso, miglioramento della salute pubblica, rafforzamento della coesione sociale.
Un esempio emblematico è il modello delle Case della Salute e delle Case di Comunità, luoghi in cui i servizi sanitari e sociali si incontrano per rispondere ai bisogni dei cittadini, offrendo non solo cure mediche, ma anche supporto psicologico, consulenze sociali e spazi di aggregazione.
L’importanza della partecipazione e del territorio
Affinché le reti di prossimità funzionino, è essenziale coinvolgere attivamente la comunità. Le associazioni, i volontari, le parrocchie, i centri culturali e sportivi possono diventare punti di riferimento per individuare i bisogni reali e costruire risposte adeguate. In questo senso, la sanità non può essere solo un servizio da erogare, ma deve diventare un processo partecipato, in cui la comunità si prende cura di sé stessa.
Conclusioni: una sfida politica e culturale
Investire nelle reti di prossimità socio-sanitarie non è solo una scelta tecnica, ma una decisione politica e culturale. Significa riconoscere che la salute è un diritto universale e che la segregazione territoriale non può più essere accettata. Significa, soprattutto, ripensare le città come spazi inclusivi, dove nessuno è lasciato indietro.
Le periferie non hanno bisogno di assistenzialismo episodico, ma di un modello strutturale di welfare di comunità, che metta al centro la dignità delle persone. La prossimità, in questo senso, non è solo una questione geografica, ma un atto di giustizia sociale.

Novo Nordisk
Guidare il cambiamento per sconfiggere le malattie croniche
Novo Nordisk è una multinazionale farmaceutica globale nata a Copenaghen e presente in Italia da oltre 40 anni. La missione di Novo Nordisk è quella di guidare il cambiamento per sconfiggere le malattie croniche e migliorare la qualità della vita di milioni di persone in tutto in mondo. Oggi le malattie croniche, come il diabete, l’obesità, le patologie cardiovascolari e altre patologie correlate, rappresentano una delle sfide più urgenti e complesse della nostra società.
Ecco perché il concetto di salute e del prenderci cura non può limitarsi all’assenza di malattia ma al benessere della persona e questo è ancor più importante se parliamo di malattie croniche che interessano milioni di persone anche in Italia e le accompagnano per tutta la vita. La nostra visione in questo senso ci ha portato da sempre a sviluppare iniziative sul territorio che facciano la differenza per la salute e la qualità della vita dei cittadini – tra queste, il progetto Cities for better health.
L’ambizione del programma internazionale Cities for Better Health è contribuire alla missione di sconfiggere le malattie croniche non trasmissibili attraverso la promozione di stili di vita più corretti, sana alimentazione, sport e attività fisica. Una rete internazionale di città nata più di 10 anni fa a livello globale e in Italia realizzata grazie ad una partnership tra Health City Institute, ANCI e Novo Nordisk, che attraverso la collaborazione tra amministratori locali, Università, autorità sanitarie, centri di ricerca e istituzioni affronta in maniera sinergica le problematiche relative alla salute e contribuisce a fornire soluzioni basate su un approccio olistico alla Salute e al Benessere della popolazione.
L’iniziativa investe nelle città e riconosce il ruolo fondamentale di tutte le istituzioni per la salute dei cittadini, dalla progettazione dei sistemi di trasporto, alla sostenibilità ambientale e alle disuguaglianze sociali. Anche in questo caso l’Italia ha dimostrato la sua eccellenza, rappresentando il primo paese al mondo per numero di città coinvolte, con una rete che interessa oltre il 40% della popolazione italiana.
L’impegno di Novo Nordisk nel promuovere la salute e il prendersi cura attraverso Cities for Better Health rappresenta non solo un passo avanti nella lotta contro le malattie croniche, ma anche un’opportunità per trasformare le città e gli spazi urbani in luoghi in cui il benessere e la qualità della vita siano al centro, contribuendo così a un futuro più sano per tutti.
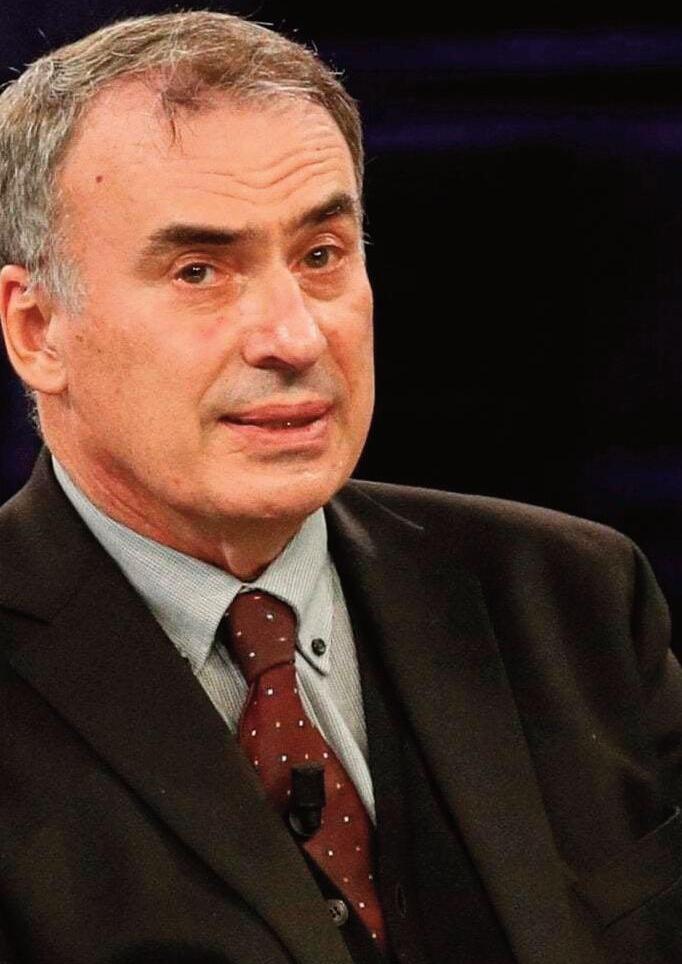
Gentrificazione, salute urbana e il futuro delle città: un equilibrio precario
di Federico Serra e Ranieri Guerra CITIES +
La gentrificazione è spesso analizzata sotto una lente economica e sociale, ma raramente viene messa in relazione con le politiche sulla salute pubblica e con il fenomeno della popolazione insistente nelle grandi città, ovvero il numero crescente di persone che vivono stabilmente in aree urbane con infrastrutture e servizi sempre più sotto pressione.
La trasformazione dei quartieri non è solo una questione di immobili e affitti, ma anche di benessere fisico e mentale, accesso ai servizi sanitari e qualità della vita. L’articolo di City Observatory, “Our 2025 list from A to Z of everything that causes gentrification”, sottolinea con ironia come si tenda a individuare colpevoli ovunque, trascurando il fatto che la vera sfida è garantire che i cambiamenti urbani non peggiorino le condizioni di salute delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Esaminiamo come la gentrificazione influisca sulle politiche sanitarie e sul benessere delle città italiane, con esempi concreti e possibili strategie per gestire il fenomeno in modo più sostenibile.
Gentrificazione e salute pubblica: un legame sottovalutato
Quando si parla di gentrificazione, spesso ci si concentra sull’aumento dei prezzi degli immobili e sulla trasformazione socio-economica dei quartieri. Tuttavia, uno degli aspetti più critici è l’impatto che questi cambiamenti hanno sulla salute delle persone che vivono nelle città, specialmente quelle a basso reddito.
1. Spostamento forzato e stress psicologico
Uno degli effetti più immediati della gentrificazione è il cosiddetto displacement (spostamento forzato), ovvero l’allontanamento delle fasce più povere della popolazione dai quartieri riqualificati. Questo non è solo un problema economico, ma anche un fattore di rischio per la salute mentale.
L’incertezza abitativa, la paura di perdere la propria casa e il senso di perdita di appartenenza a una comunità possono portare a un aumento dei livelli di stress, ansia e depressione. Studi condotti negli Stati Uniti e in Europa hanno dimostrato che il displacement è correlato a un peggioramento della salute mentale e a un maggiore rischio di malattie cardiovascolari.
2. Accesso ridotto ai servizi sanitari
Man mano che i quartieri si gentrificano, cambia anche la rete di servizi disponibili. Molti studi dimostrano che le aree a basso reddito tendono ad avere meno ospedali e cliniche rispetto ai quartieri benestanti. Se il processo di gentrificazione non è accompagnato da una pianificazione sanitaria adeguata, il rischio è che le fasce più vulnerabili della popolazione si trovino a dover percorrere distanze maggiori per accedere a cure essenziali.
Un esempio è il centro storico di Firenze, dove l’espulsione dei residenti a favore del turismo ha ridotto la domanda di servizi sanitari locali, portando alla chiusura di alcune strutture e farmacie di quartiere. Chi vive ancora nella zona si trova spesso costretto a spostarsi in periferia per ricevere assistenza.
3. Cambiamenti negli stili di vita e salute fisica
Uno degli aspetti più paradossali della gentrificazione è che, pur portando miglioramenti infrastrutturali come piste ciclabili, spazi verdi e una maggiore attenzione all’alimentazione sana, questi benefici tendono a non essere accessibili a tutti.
Quartieri un tempo popolari diventano costosi, e molte persone con redditi più bassi sono costrette a spostarsi in zone periferiche meno servite, dove l’accesso a cibo sano, attività fisica e spazi pubblici adeguati è più difficile. Questo può portare a un aumento dell’obesità, delle malattie metaboliche e della sedentarietà, con un impatto negativo sulla salute pubblica.
Un caso emblematico è Milano, dove quartieri come Isola e Porta Venezia hanno visto la proliferazione di negozi di alimentazione biologica e palestre esclusive, ma dove il costo della vita ha reso difficile per molti cittadini accedere a queste nuove opportunità di benessere.
La popolazione insistente nelle città: un problema di sostenibilità urbana
Un altro aspetto da considerare è il crescente fenomeno della popolazione insistente nelle grandi città, ovvero il numero sempre maggiore di persone che vivono stabilmente in aree urbane già sature. La gentrificazione, in combinazione con una gestione inadeguata degli spazi urbani, ha reso la situazione ancora più complessa.
1. Aumento della densità senza adeguati servizi pubblici
Molte città italiane stanno sperimentando una forte crescita della popolazione urbana, ma senza un parallelo adeguamento delle infrastrutture. L’aumento della densità abitativa in alcuni quartieri, dovuto alla gentrificazione e al turismo, sta mettendo sotto pressione i trasporti pubblici, gli ospedali e le scuole.
A Roma, ad esempio, il quartiere Pigneto è diventato un’area molto ambita per i giovani professionisti, ma la sua crescita non è stata accompagnata da un adeguato potenziamento dei servizi sanitari e sociali. Le poche strutture sanitarie rimaste devono far fronte a una domanda crescente, con tempi di attesa sempre più lunghi.
2. Disuguaglianze sanitarie tra centro e periferia
Con l’aumento dei prezzi nelle zone centrali, molte famiglie sono costrette a spostarsi nelle periferie, dove l’accesso ai servizi sanitari è spesso più limitato. Questo crea una frattura nella qualità dell’assistenza sanitaria tra chi può permettersi di vivere in zone con ospedali e medici facilmente accessibili e chi deve affrontare viaggi lunghi e costi aggiuntivi per ricevere cure adeguate.
Un caso evidente è quello di Torino, dove i quartieri centrali hanno ospedali ben attrezzati, mentre le zone periferiche, come Barriera di Milano, hanno meno strutture sanitarie, con conseguenti disuguaglianze nell’accesso alle cure.
Come affrontare il problema? Strategie per un’urbanizzazione più equa
Affrontare la gentrificazione e i suoi effetti sulla salute pubblica richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga urbanisti, amministrazioni locali, esperti di sanità pubblica e cittadini. Alcune possibili strategie includono:
• Potenziamento dei servizi sanitari nelle zone a rischio gentrificazione – Prevedere l’apertura di nuovi poli sanitari nei quartieri soggetti a forti trasformazioni per evitare la carenza di servizi.
• Controllo degli affitti e politiche abitative inclusive – Incentivare alloggi a prezzi accessibili per garantire che le fasce più deboli possano continuare a vivere nei quartieri in trasformazione.
• Sviluppo di infrastrutture sanitarie nelle periferie –Evitare la concentrazione dei servizi sanitari solo nelle aree centrali, bilanciando l’offerta su tutto il territorio urbano.
• Regolamentazione del turismo e degli affitti brevi –Limitare la speculazione immobiliare per mantenere una popolazione residente stabile e garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali.
Conclusione: città più sane e più giuste
La gentrificazione non è solo una questione economica, ma anche un fenomeno che influisce profondamente sulla salute e sulla qualità della vita. Senza una pianificazione adeguata, il rischio è quello di creare città sempre più polarizzate, dove il benessere è un lusso per pochi e le fasce più vulnerabili sono relegate in aree sempre più marginalizzate.
Le politiche urbane devono evolversi per affrontare queste sfide, garantendo un equilibrio tra sviluppo, equità sociale e salute pubblica. Perché una città che esclude i suoi abitanti più deboli non è solo ingiusta, ma anche insostenibile nel lungo periodo.


Rete di Prossimità Socio-Sanitaria:
Un Modello di Assistenza Territoriale a Misura di Cittadino
a cura di Health City Institute e Cities+
Negli ultimi anni, molte città italiane hanno implementato reti di prossimità socio-sanitaria per garantire ai cittadini un accesso più rapido e integrato ai servizi di salute e assistenza sociale. Un esempio virtuoso di questa innovazione è rappresentato dal modello adottato a Bologna, dove la rete territoriale ha migliorato il coordinamento tra ospedali, medici di base, servizi sociali e realtà del terzo settore.
Un nuovo approccio all’assistenza territoriale
L’obiettivo principale della rete di prossimità è evitare la frammentazione dei servizi sanitari e sociali, permettendo una presa in carico efficace e tempestiva dei pazienti, soprattutto quelli più fragili come anziani, persone con disabilità e soggetti con patologie croniche.
A Bologna, la rete si sviluppa attraverso:
• Case della Salute: punti di riferimento per i cittadini, in cui operano medici di base, infermieri, assistenti sociali e specialisti.
• Unità di Continuità Assistenziale (UCA): team multidisciplinari che offrono assistenza domiciliare per chi ha difficoltà a spostarsi.
• Punti Unici di Accesso (PUA): sportelli dedicati all’orientamento dei cittadini, per semplificare la fruizione dei servizi.
• Integrazione con il volontariato: associazioni locali supportano pazienti e famiglie con servizi di accompagnamento, assistenza domiciliare leggera e supporto psicologico.
I benefici per la comunità
L’implementazione della rete di prossimità a Bologna ha portato a una serie di miglioramenti concreti:
• Riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso grazie a una gestione più efficace delle patologie croniche.
• Migliore qualità della vita per i pazienti che ricevono cure domiciliari personalizzate.
• Maggiore collaborazione tra enti sanitari e sociali, che consente una risposta più rapida ed efficiente ai bisogni della popolazione.
• Sostegno alle famiglie attraverso servizi di orientamento e supporto domiciliare.
Un modello replicabile in altre città
L’esperienza di Bologna dimostra come una rete di prossimità socio-sanitaria possa trasformare il sistema di assistenza, garantendo un modello di cura più umano ed efficiente. Questo approccio sta ispirando altre città italiane, come Firenze e Torino, che stanno sviluppando progetti simili per rendere il sistema sanitario sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.
Il successo di queste iniziative dipende dalla capacità di integrare risorse e competenze, creando una rete solida in grado di offrire risposte tempestive e mirate. L’obiettivo finale è chiaro: costruire un sistema socio-sanitario realmente a misura di comunità, dove nessuno venga lasciato indietro.

Tassonomia della Prossimità Socio-Sanitaria
a cura di Health City Institute e Cities+
1. Concetto di Prossimità
• Definizione: Approccio che porta i servizi sanitari e sociali il più vicino possibile alle persone, in termini geografici, relazionali e organizzativi.
• Obiettivi: Accessibilità, continuità delle cure, personalizzazione degli interventi, equità.
• Principi: Multidisciplinarietà, integrazione socio-sanitaria, domiciliarità, innovazione tecnologica.
2. Livelli di Prossimità
2.1. Prossimità Territoriale
• Rete dei servizi locali: Case della Comunità, ambulatori di medicina generale, farmacie dei servizi.
• Unità mobili e telemedicina: Assistenza remota per aree periferiche e rurali.
• Punti unici di accesso (PUA): Sportelli di orientamento per i cittadini.
2.2. Prossimità Relazionale
• Operatori di fiducia: Medici di famiglia, infermieri di comunità, assistenti sociali.
• Coinvolgimento della comunità: Volontariato, caregiver familiari, reti di mutuo aiuto.
• Personalizzazione delle cure: Piani assistenziali individualizzati (PAI).
2.3. Prossimità Organizzativa
• Integrazione socio-sanitaria: Coordinamento tra ASL, servizi sociali, terzo settore.
• Continuità assistenziale: Dimissioni protette, case management.
• Processi semplificati: Digitalizzazione delle prenotazioni, fascicolo sanitario elettronico.
3. Modelli di Intervento
3.1. Assistenza Domiciliare
• ADI (Assistenza Domiciliare Integrata): Prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative a casa.
• Infermiere di famiglia e comunità: Supporto a domicilio e nelle comunità.
3.2. Strutture Intermedie
• Ospedali di Comunità: Ricovero per pazienti a bassa intensità di cura.
• Case della Comunità: Centri multiservizi per cure primarie e sociali.
3.3. Innovazione e Digital Health
• Telemedicina: Monitoraggio remoto, teleconsulto, teleassistenza.
• Piattaforme di salute digitale: Fascicolo sanitario elettronico, prescrizioni online.
• Intelligenza artificiale e Big Data: Prevenzione e personalizzazione delle cure.
4. Attori Coinvolti
• Sanitari: Medici, infermieri, farmacisti, operatori sociosanitari (OSS).
• Sociali: Assistenti sociali, educatori, caregiver, volontari.
• Istituzionali: Regioni, ASL, Comuni, Ministero della Salute.
• Tecnologici: Aziende di e-health, ricercatori, esperti di innovazione digitale.

Survey sulla qualità della vita e salute
nelle periferie di Roma
Condotta da: Health City Institute, , Science for Cities, Cities+, Osservatorio sulla salute bene comune, Cattedra UNESCO Chair on Urban Health, Osservatorio permanente sullo sport, BHAVE
Aree: Tor Bella Monaca, Morena, Ciampino
Periodo di rilevazione: 10-28 febbraio 2025
Metodologia: CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing)
Numero di persone intervistate: 462
Progetto: Analisi della prossimità socio-sanitaria a Roma
Introduzione
Tor Bella Monaca, situata nel Municipio VI di Roma, è una delle aree con il più alto indice di vulnerabilità sociale della capitale, caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione e difficoltà di accesso ai servizi. Morena, nel Municipio VII, presenta invece un tessuto sociale più stabile con una popolazione di classe media e un discreto livello di benessere. Ciampino, comune autonomo nell’area metropolitana di Roma, ha una realtà eterogenea con una rete di servizi più sviluppata.
Le tre aree considerate sono state scelte per questa indagine in quanto rappresentano un microcosmo significativo delle periferie romane, con caratteristiche socio-economiche differenti che permettono di analizzare il fenomeno della prossimità socio-sanitaria in contesti diversi. Tor Bella Monaca riflette un’area ad alta vulnerabilità con limitato accesso ai servizi sanitari e sociali, Morena è un quartiere di transizione con una popolazione in parte stabile e in parte in crescita, mentre Ciampino, pur essendo un comune autonomo, è direttamente connesso alle dinamiche urbane di Roma e offre un punto di confronto utile per valutare le differenze nella qualità dei servizi e delle condizioni di vita.
• Numero di abitanti:
•• Tor Bella Monaca: circa 35.000
•• Morena: circa 25.000
•• Ciampino: circa 39.000
• Composizione del campione:
•• Uomini: 48%
•• Donne: 52%
•• Età media uomini: 42 anni
•• Età media donne: 45 anni
• Grado di istruzione:
•• Licenza media 30%
•• Diploma superiore 45%
•• Laurea 25%
• Reddito medio per abitante:
•• Tor Bella Monaca 15.000 €/anno
•• Morena 24.000 €/anno
•• Ciampino 27.000 €/anno
• Numero di nuclei monofamiliari:
•• Tor Bella Monaca 38%
•• Morena 28%
•• Ciampino 30%
• Utilizzo dei mezzi di trasporto per recarsi al lavoro:
•• Uso dell’auto 55%
•• Uso dei mezzi pubblici 35%
•• Altri mezzi (bicicletta, a piedi) 10%
Stato di Salute e Accesso ai Servizi Sanitari
• Percezione della propria salute:
•• Eccellente 10%
•• Buona 40%
•• Sufficiente 35%
•• Scarsa 15%
• Principali problemi di salute riportati:
•• Ipertensione 30%
•• Obesità/sovrappeso 25%
•• Diabete 12%
•• Problemi respiratori (asma/BPCO) 10%
•• Disturbi mentali (ansia, depressione) 20%
• Difficoltà di accesso ai servizi sanitari locali:
•• Tempi di attesa lunghi per visite specialistiche 65%
•• Scarsa presenza di medici di base 30%
•• Difficoltà di accesso a farmacie e strutture sanitarie 25%
Stile di Vita e Abitudini Alimentari
• Attività fisica regolare:
•• Regolare (almeno 3 volte a settimana) 25%
•• Saltuaria (meno di 3 volte a settimana) 30%
•• Assente 45%
• Pratica sportiva:
•• Regolare 30%
•• Occasionale 40%
•• Nessuna attività sportiva 30%
• Abitudini alimentari:
•• Dieta equilibrata (frutta, verdura, proteine) 35%
•• Consumo eccessivo di cibo spazzatura 40%
•• Consumo moderato di cibo industriale 25%
• Fumo e alcol:
•• Fumatori abituali 28%
•• Consumo regolare di alcol 18%
•• Astemi 54%
Conclusioni e Raccomandazioni
Dalla survey emerge una forte richiesta di miglioramento nell’accesso alle cure mediche, nella sicurezza e nelle infrastrutture urbane. In particolare:
• Potenziare i servizi sanitari territoriali, aumentando la presenza di specialisti e riducendo i tempi di attesa.
• Migliorare la sicurezza urbana, con un maggiore controllo del territorio e iniziative di prevenzione.
• Incrementare la presenza di spazi verdi e infrastrutture ricreative, promuovendo il benessere psicofisico della popolazione.
• Rafforzare la mobilità pubblica, con collegamenti più efficienti tra le periferie e il centro di Roma.
• Promuovere programmi di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute, con particolare attenzione a malattie croniche come il diabete e l’ipertensione. Queste misure potrebbero migliorare significativamente la qualità della vita e lo stato di salute delle popolazioni nelle aree analizzate.


Tingbjerg: Un Modello di Prossimità per la Salute
nelle Città del Futuro
L’esperienza danese e la sua applicabilità in Italia
a cura di Health Cities Institute
Nel cuore della periferia di Copenaghen, il quartiere di Tingbjerg è diventato un esempio concreto di come le reti di prossimità possano trasformare il benessere delle comunità urbane, riducendo il rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2. Grazie al progetto “Tingbjerg Changing Diabetes” (TCD), parte dell’iniziativa globale “Cities Changing Diabetes” promossa da Novo Nordisk, il quartiere ha sviluppato una cultura della salute basata su inclusione, alimentazione sostenibile e partecipazione attiva dei cittadini.
Ma cosa possiamo imparare da questa esperienza e come può essere adattata in Italia?
Il modello di Tingbjerg e la visione per l’Italia
L’esperienza di Tingbjerg dimostra che la prevenzione delle malattie croniche non può essere solo una questione sanitaria, ma deve coinvolgere la comunità attraverso iniziative locali concrete. Il modello di prossimità adottato in Danimarca è basato su:
• Cucina comunitaria e alimentazione sana: programmi educativi incentrati sulla preparazione di cibi salutari, favorendo la socializzazione e la consapevolezza nutrizionale.
• Spazi verdi e agricoltura urbana: creazione di orti condivisi e giardini sociali per incentivare il consumo di cibo fresco e la coesione sociale.
• Collaborazioni tra enti pubblici e privati: coinvolgimento di aziende, associazioni locali e istituzioni sanitarie per creare progetti di lungo termine.
Questi elementi sono perfettamente in linea con il concetto di “reti di prossimità”, già in fase di sviluppo in diverse città italiane, soprattutto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Applicazione del modello in Italia: le città in prima linea
Alcune città italiane stanno già sperimentando modelli simili a Tingbjerg, promuovendo prossimità e integrazione dei servizi sanitari e sociali.
• Genova e Cities Changing Diabetes: attraverso il programma promosso da Novo Nordisk, la città sta studiando le vulnerabilità sociali e ambientali legate al diabete, per progettare interventi mirati basati sulla prevenzione.
• Bologna e i Quartieri della Salute: la città ha sviluppato un modello di assistenza territoriale che promuove la salute attraverso servizi di comunità e programmi di educazione alimentare.
• Milano e le Food Policy: il capoluogo lombardo ha implementato strategie per migliorare l’accesso al cibo sano, promuovendo la sostenibilità e il coinvolgimento delle comunità locali.
L’esempio danese mostra che il coinvolgimento diretto dei cittadini è un fattore chiave per il successo delle reti di prossimità. Per questo, è fondamentale che le amministrazioni italiane rafforzino le iniziative di welfare urbano, integrando la sanità con politiche sociali e ambientali.
Conclusioni: il futuro della salute nelle città italiane
L’esperienza di Tingbjerg dimostra che un approccio integrato e partecipativo alla salute urbana può ridurre le disuguaglianze e migliorare il benessere delle persone. In Italia, l’espansione delle Case della Comunità, il rafforzamento della sanità territoriale e il potenziamento delle reti di prossimità possono rappresentare la chiave per un futuro più sano e inclusivo.
Seguendo il modello danese, le città italiane hanno l’opportunità di trasformarsi in luoghi dove la salute non è solo una questione medica, ma un valore condiviso che nasce dalla comunità stessa.

Cities for Better Health – Città global Partner
Bari: costruire forti Partnership per promuovere la salute nella Città
1. Iniziative per la salute pubblica
Cities for Better Health a Bari ha creato una solida rete di collaborazione con le farmacie locali per diffondere informazioni sulla salute e sugli stili di vita. Questo approccio multidisciplinare e integrato si avvale di partenariati pubblico-privati per contrastare l’aumento del diabete nell’area urbana.
Dati chiave:
• L’incidenza del diabete a Bari è passata dal 3,3% al 7,7% in 17 anni.
• Circa 70-80% delle risorse sanitarie della città sono destinate alla gestione delle malattie croniche come il diabete.
La città interviene su fattori sociali, culturali ed economici per migliorare la prevenzione e l’accesso alle cure.
2. Sfruttare il potenziale ambientale della città
Bari, la città italiana più a sud a far parte del progetto Cities for Better Health, sfrutta la sua posizione sul mare Adriatico per promuovere stili di vita sani.
• La collaborazione con le farmacie locali permette la distribuzione di informazioni nutrizionali per prevenire obesità e diabete di tipo 2.
• Si sta valutando l’utilizzo della rete delle farmacie per monitorare parametri di salute, come la circonferenza della vita, e misurare l’impatto delle informazioni distribuite.
3. Formazione degli Health City Manager
Bari ha ospitato un corso di alta formazione per Health City Manager, supportato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Questo programma ha formato dirigenti sanitari locali per integrare la salute nelle politiche cittadine.
4. Educazione scolastica alla sana alimentazione
Il team di Cities for Better Health Bari sta sviluppando un progetto educativo scolastico per sensibilizzare i giovani sull’importanza della sana alimentazione.
• I bambini documenteranno con fotografie un corretto stile alimentare, dall’acquisto di prodotti freschi alla preparazione dei pasti.
• Le informazioni raccolte su obesità e diabete saranno analizzate e presentate in un ATLAS, condiviso con i partner della città come base per un ACTION PLAN.
5. Leadership e governance
• Presidente Comitato promotore: Vito Leccese, Sindaco di Bari
• Presidenti del Comitato esecutivo e scientifico: Francesco Giorgino (Università di Bari), Luigi D’Ambrosio Lettieri (Ordine dei farmacisti di Bari)
Dichiarazioni
Vito Leccese, Sindaco di Bari: “Il concetto di salute è legato a fattori sociali, ambientali, abitativi e culturali. Il sindaco ha il compito di guidare la città verso il benessere, promuovendo stili di vita sani.”
Francesco Giorgino, Presidente Comitato scientifico: “Contrastare obesità e diabete è fondamentale. La urbanizzazione può rappresentare un fattore di rischio, soprattutto nelle aree a basso reddito, richiedendo politiche sanitarie mirate.”
Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Comitato scientifico: “La prevenzione e la sensibilizzazione sono strumenti chiave per migliorare la salute della comunità e ridurre l’impatto del diabete.”

Cities for Better Health – Città global Partner
Milano: creare una rete metropolitana per affrontare diabete e obesità
1. Una rete di comuni per la salute urbana
Dal 2018, Milano ha aderito al programma Cities for Better Health, creando una rete con 40 comuni dell’hinterland che rappresentano il 65% della popolazione metropolitana.
• Questa rete consente la condivisione di buone pratiche e interventi urbanistici per migliorare la salute pubblica.
• I comuni coinvolti hanno sottoscritto il Manifesto sull’Urban Health, impegnandosi in un’azione congiunta.
2. Action Plan per contrastare le disuguaglianze sanitarie
Milano affronta la sfida dell’obesità e del diabete con dati allarmanti:
• 27,7% della popolazione adulta è in sovrappeso.
• 7,8% della popolazione è obesa.
• 5,75% convive con il diabete, con una tendenza in crescita.
Nel 2020, è stato lanciato il Milano Diabetes Atlas, un’analisi basata su studi condotti da Regione Lombardia, Comune di Milano, Università di Milano e ATS, con il coinvolgimento di oltre 80 esperti.
Il risultato è stato un Piano d’Azione 2022-2025 con proposte per ridurre le disuguaglianze sanitarie e migliorare la gestione del diabete.
3. Integrare la salute nelle politiche cittadine
Milano ha promosso un corso di alta formazione per Health City Manager, supportato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
• Obiettivo: fornire agli esperti gli strumenti per integrare la salute nelle politiche urbane.
• I professionisti formati potranno sviluppare strategie per migliorare la qualità della vita in città.
4. Milano Olympic Active City
Per incoraggiare la mobilità attiva, Milano ha creato:
• 34 percorsi di trekking urbano per un totale di 175 km.
• L’obiettivo è di diventare la prima Olympic Active City in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2026.
• Il progetto prevede la creazione di 133 nuovi percorsi pedonali, uno per ciascun comune dell’area metropolitana.
5. Leadership e governance
• Presidente Comitato promotore: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano
• Presidenti del Comitato esecutivo e scientifico: Michele Carruba (Centro Studi e Ricerche sull’Obesità, Università di Milano), Livio Luzi (Università di Milano)
Dichiarazioni
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: “Sosteniamo il programma Cities Changing Diabetes per affrontare collettivamente l’aumento del diabete nelle città.”
Michele Carruba, Presidente Comitato esecutivo: “Si stimano oltre 240.000 persone con diabete nell’area metropolitana di Milano. Il costo medio annuo per paziente è di 2.912 euro, con i ricoveri che pesano maggiormente sui costi sanitari.”
Livio Luzi, Presidente Comitato scientifico: “L’obesità è un fattore di rischio cruciale per il diabete e il suo aumento è legato ai cambiamenti dello stile di vita urbano. Servono programmazione e sinergie per contrastare il fenomeno.”