
Cambiamento climatico, non più un problema del futuro ma del presente.




https://www.urbesmagazine.it/
https://www.urbesmagazine.it/
Promosso da:


https://healthcityinstitute.com/


Cambiamento climatico, non più un problema del futuro ma del presente.




https://www.urbesmagazine.it/
https://www.urbesmagazine.it/
Promosso da:


https://healthcityinstitute.com/
di Federico Serra
Nel gennaio 2024, in apertura del World Economic Forum di Davos, è stato presentato uno dei rapporti più significativi degli ultimi anni: il Global Risks Report. Tra i primi cinque rischi globali che l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi dieci anni, ben quattro sono direttamente collegati alla crisi climatica e ambientale: eventi meteorologici estremi, cambiamenti profondi nei sistemi naturali, perdita di biodiversità e disastri ambientali su larga scala.
È la conferma, autorevole e inequivocabile, che il tempo della negazione o della sottovalutazione è definitivamente finito. Il cambiamento climatico non è un problema del futuro. È il presente. E nel presente, il primo spazio in cui si manifestano gli impatti più visibili, concreti e disuguali del cambiamento climatico è la città.
La città al centro della crisi (e della soluzione)
Le città occupano solo il 3% della superficie terrestre, ma ospitano oltre il 56% della popolazione mondiale (che diventerà il 70% entro il 2050), consumano oltre il 75% dell’energia globale e producono più del 70% delle emissioni di gas serra. Ma sono anche, per natura e funzione, centri di innovazione, governance, cultura, capacità adattiva.
Dunque, non possiamo che partire dalle città per affrontare la crisi climatica. Le città devono essere contemporaneamente la prima linea della resistenza e il laboratorio della trasformazione.
È qui che si gioca la partita del clima. È qui che va riscritta l’alleanza tra uomo, natura e sviluppo.
Una nuova responsabilità urbana
Pensare la città come semplice contenitore di servizi e infrastrutture è un’idea anacronistica. L’urgenza climatica impone una ridefinizione integrale del concetto stesso di urbanità. Il nuovo paradigma è quello della resilienza urbana integrata.
Significa progettare città in grado di assorbire shock, adattarsi al cambiamento, rigenerarsi senza perdere la propria funzione economica, sociale e ambientale. Ma anche città che riducano le disuguaglianze e migliorino la qualità della vita per tutte e tutti.
In concreto, ciò si traduce in almeno cinque ambiti d’intervento prioritari:
1. Pianificazione urbana ecologica
Non si tratta più solo di “fare verde”, ma di costruire una vera infrastruttura ecologica urbana capace di regolare le temperature, assorbire le acque meteoriche, filtrare l’aria, offrire benessere psico-fisico. Serve un piano di rinaturalizzazione diffusa che trasformi la città in un ecosistema vivo.
2. Mobilità sostenibile e giusta
La transizione ecologica parte dalla mobilità. Ridurre il traffico privato, investire nel trasporto pubblico elettrico, creare reti ciclopedonali, promuovere soluzioni di mobilità condivisa sono azioni fondamentali non solo per il clima, ma per la salute e l’equità sociale.
3. Efficienza e rigenerazione energetica
Gli edifici consumano enormi quantità di energia. Serve un piano straordinario di rigenerazione energetica e sismica del patrimonio edilizio, pubblico e privato, che produca anche lavoro qualificato e inclusivo. L’energia va prodotta in loco, in modo distribuito, con

4 fotovoltaico e geotermia urbana.
4. Governance multilivello e partecipativa
La crisi climatica non si governa da soli. Serve una cooperazione tra istituzioni nazionali, città, regioni e Unione Europea, ma anche una partecipazione reale dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali. La resilienza è un processo collettivo, non tecnocratico.
5. Giustizia ambientale e salute urbana
I cambiamenti climatici colpiscono di più chi ha meno strumenti per difendersi: anziani, bambini, persone fragili, periferie. La risposta urbana alla crisi climatica deve essere anche una risposta alla crisi delle disuguaglianze. Il diritto alla salute urbana, all’aria pulita, a spazi pubblici vivibili, deve essere il nuovo pilastro delle politiche urbane.
Città come bene comune globale
Il World Economic Forum ha messo nero su bianco ciò che molti attivisti, ricercatori, sindaci e cittadini denunciano da anni: la crisi climatica è il principale rischio per l’umanità. Ma ha anche riconosciuto che i sistemi urbani – se guidati con visione e coraggio –possono essere la risposta più rapida, efficace e concreta
per affrontarla.
La città non è un problema, ma la soluzione. A condizione che sia ripensata non come somma di progetti e quartieri, ma come organismo vivente, intelligente e giusto. Una città che non consuma il pianeta, ma lo cura. Che non emargina, ma include. Che non teme il futuro, ma lo costruisce.
Conclusione: l’ora di agire
Non c’è più tempo per soluzioni parziali o per il linguaggio dell’intenzione. Serve una rivoluzione politica, culturale e operativa delle politiche urbane, capace di allinearsi agli obiettivi climatici globali ma radicarsi nei bisogni reali delle comunità locali.
Ogni sindaco, ogni urbanista, ogni cittadino ha un ruolo. E una responsabilità. Non basta dichiarare l’emergenza climatica: dobbiamo agire come se fosse un’emergenza. Perché lo è.
La città del futuro si costruisce oggi. E deve essere una città per tutti, in pace con il clima, e in armonia con la vita.


EDITORIALE
AGORÀ
ZIBALDONE IN PUNTA DI PENNA
CITTADINI
GENERAZIONE Z FOCUS ON SOCRATIC DIALOGUE
SPIGOLATURE
RECENSIONI
A DIO PAPA FRANCESCO
RIFLESSIONI YMCA SU PAPA FRANCESCO
NUOVO PAPA
DIALOGO CON ANTONIO GUTERESS
DIALOGO CON GIUSEPPE DE RITA
DIALOGO CON WATER RICCIARDI
CITIES SPEAKING
HEALTH CITY ALUMNI
CITTÀ
ANCONA
INTERVISTA AL SINDACO DI ANCONA
Kalundborg: Il Modello Pionieristico di Simbiosi Industriale
INTERVISTA AL SINDACO dI COPENAGHEN
OECD URBAN DAYS
LA CITTA' CHE SCOTTA
SONDAGGIO GLI ITALIANI E IL CAMBIAMENTO CAMBIAMENTO CLIMATICO
MILITELLO VAL DI CATANIA BORGO DEI BORGHI
SCOPITTO CON INTERVISTA CON INTERVISTA AL SINDACO E FOTO
LE CASE A 1 EURO DI SAMBUCA DI SICILIA

IN COLLABORAZIONE CON l'OSSERVATORIO SULLA SALUTE BENE COMUNE.
PLANETARY HEALTH, INNER CIRCLE
SCIENZA, SALUTE E CAMBIAMENTO CLIMATICO
IL CLIMA NELLE CITTA'
BENESSERE PSICOLOGICO E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Il Futuro del Benessere nel 2025: tra ritorno all’analogico e biotecnologie avanzate
CLIMA E INDUSTRIA
YMCA: INIZIATIVE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO PER COMUNITÀ PIÙ SANE
Diabete e cambiamento climatico
Il decalogo del Medico di famiglia per affrontare il caldo estremo
CLIMATE CHANGE ED IMPATTO DELLE RADIAZIONI SOLARI SULLE MALATTIE DELLA CUTE
Aree interne e crisi climatica: territori fragili, risorse strategiche
DI HEALTH CITY INSTITUTE
Sfida Globale per la Salute: Al via la Healthy Cycling Challenge 2025
BARI PEDALA VERSO IL FUTUR0
Il cambiamento climatico e il futuro del vino
Combattere il caldo a tavola
Federico Serra Presidente YMCA
Federsanità - Asl Salerno
Allergie e città
Sustainable City
L'Intelligenza Artificiale per il benessere nelle città
Intervista a Nicola Armentano
Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Viviamo immersi in una delle più grandi illusioni del nostro tempo: la convinzione che il problema climatico possa essere affrontato senza mettere radicalmente in discussione il nostro stile di vita, il nostro modello di sviluppo, le nostre priorità. È l’utopia del clima: l’idea seducente che basterà la somma delle buone pratiche individuali, dei progressi tecnologici e delle dichiarazioni di principio per riportare il pianeta su un sentiero di equilibrio. È una narrazione rassicurante, ma profondamente distaccata dalla realtà.

Negli ultimi trent’anni, il cambiamento climatico è passato da questione marginale per pochi scienziati e attivisti a emergenza riconosciuta su scala globale. Gli allarmi si sono moltiplicati: modelli climatici sempre più accurati, eventi estremi sempre più frequenti, segnali biologici inequivocabili. Eppure, la nostra risposta collettiva è stata segnata da una costante oscillazione tra l’indifferenza e l’autoassoluzione.
Abbiamo creduto che bastasse migliorare l’efficienza energetica, diffondere l’auto elettrica, incentivare il riciclo. Abbiamo celebrato ogni summit internazionale come se una firma su un trattato potesse, da sola, cambiare la traiettoria delle emissioni globali. Abbiamo continuato a misurare il successo in punti percentuali di PIL, a pensare che “crescita sostenibile” fosse qualcosa di diverso da una contraddizione in termini.
La verità è che il cambiamento climatico non è solo una crisi ambientale: è una crisi di civiltà. È il sintomo di una frattura profonda tra l’uomo e la natura, figlia di secoli di sfruttamento, colonizzazione, mercificazione di ogni risorsa vivente e inanimata. Pensare di “aggiustare” il clima con gli stessi strumenti, le stesse logiche, gli stessi paradigmi che lo hanno spezzato è, appunto, un’utopia.
Il pianeta che abbiamo conosciuto – un clima relativamente stabile, una biodiversità straordinaria, cicli na-
turali prevedibili – è già cambiato e continuerà a cambiare. Alcuni degli equilibri che consideravamo eterni sono andati perduti, forse irreversibilmente. Questo non significa che ogni sforzo sia vano, né che il fatalismo debba prevalere. Ma implica la necessità di una nuova consapevolezza: non possiamo più limitarci a “salvare il mondo” dalle conseguenze peggiori; dobbiamo imparare a convivere con un mondo che sarà comunque diverso, e a farlo in modo più giusto, più resiliente, più rispettoso.
Per questo la sfida climatica è prima di tutto culturale ed etica. Non sarà vinta nei laboratori delle multinazionali o nei corridoi delle diplomazie internazionali, se prima non sarà vinta nei nostri immaginari collettivi. Dobbiamo ridefinire il concetto stesso di benessere, liberandolo dall’idea di consumo illimitato. Dobbiamo ripensare la città, la mobilità, l’alimentazione, il modo in cui abitiamo il territorio. Dobbiamo accettare che la “transizione ecologica” non sarà indolore: comporterà cambiamenti profondi, a volte difficili, ma anche straordinarie opportunità di reinventare le basi della convivenza umana.
Oggi molti governi, aziende, persino movimenti di opinione propongono soluzioni “win-win”, in cui tutti avrebbero da guadagnare e nessuno dovrebbe rinunciare a nulla. Ma il vero cambiamento comporta delle scelte: scegliere significa anche rinunciare. E non tutti i sacrifici saranno equamente distribuiti, a meno che non si affronti insieme la questione della giustizia sociale e globale. Non possiamo costruire una transizione climatica sulle spalle di chi già oggi paga il prezzo più alto della crisi: le popolazioni indigene, i lavoratori precari, i paesi più poveri.
Tecnologie come il sequestro del carbonio, la geoingegneria, l’energia nucleare di nuova generazione hanno un ruolo da giocare, ma nessuna tecnologia sarà mai una bacchetta magica. Il rischio è che vengano usate

come alibi per non cambiare davvero: per continuare a crescere, a consumare, a spostare semplicemente il problema più in là nel tempo o nello spazio.
La vera utopia non è credere che il clima tornerà a quello di una volta. È pensare che possiamo rimanere quelli di sempre in un mondo che cambia. È immaginare che possiamo sfuggire alle leggi della fisica, dell’ecologia, della finitezza.
Accettare la realtà non significa arrendersi. Significa prepararsi, adattarsi, trasformarsi. Significa coltivare un altro immaginario: fatto di sobrietà, solidarietà, lentezza, cura. Non si tratta di tornare indietro, ma di andare avanti verso un nuovo patto con la Terra e tra di noi.
La posta in gioco non è solo la temperatura media del pianeta: è il tipo di civiltà che vogliamo essere nel XXI secolo. Siamo all’alba di un’epoca in cui il futuro non è più qualcosa che semplicemente accade, ma qualcosa che dobbiamo scegliere, costruire con fatica, custodire con attenzione.
L’utopia del clima, nella sua versione più diffusa, ci invita a credere che tutto sia ancora possibile senza cambiare noi stessi. La realtà ci chiede di essere più audaci: non salvare il mondo, ma salvare la nostra umanità nel mondo che verrà.



Il cambiamento climatico è già tra noi. Non si tratta più di un’ipotesi lontana o di un monito per il futuro, ma di una realtà concreta, palpabile, che investe soprattutto le città: gli epicentri della vita moderna, e ora anche dell’emergenza climatica. Secondo la NASA, l’aumento delle temperature globali causato dalle attività umane sta intensificando eventi estremi come ondate di calore, alluvioni, incendi e siccità. Ed è nei contesti urbani che questi fenomeni mostrano il loro volto più drammatico.
Le città nella morsa degli eventi estremi
Le città sono ambienti particolarmente vulnerabili. L’effetto “isola di calore” urbano – dovuto all’abbondanza di superfici asfaltate e alla scarsità di vegetazione – amplifica l’intensità delle ondate di calore. In quartieri densamente edificati, temperature già elevate diventano letali, soprattutto per le persone anziane, i bambini e coloro che soffrono di patologie croniche. La crescente intensità delle piogge estreme sta sommergendo infrastrutture inadatte, mettendo a rischio la sicurezza di milioni di cittadini. Sistemi fognari sovraccarichi, trasporti pubblici bloccati, danni ad abitazioni, scuole e ospedali: gli eventi meteorologici estremi non sono solo una sfida ambientale, ma una crisi umanitaria urbana.
E mentre gli incendi boschivi divorano aree verdi ai margini delle città, le periferie urbane diventano sempre più esposte ai rischi di evacuazione, perdita di case, danni economici e traumi psicologici.
I dati che non possiamo ignorare
La NASA, grazie alle sue missioni satellitari e ai modelli climatici avanzati, fornisce prove inconfutabili: le città si stanno riscaldando più velocemente delle aree rurali circostanti. I programmi di osservazione come il Global Precipitation Measurement e i dati dei satelliti GRACE documentano l’aumento delle precipitazioni estreme e la perdita di riserve idriche, elementi che aggravano la vulnerabilità delle aree urbane.
Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, con una temperatura media globale superiore di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Gli incendi estremi sono raddoppiati negli ultimi vent’anni. Le alluvioni e le siccità si intensificano, e con esse cresce il numero delle città in difficoltà.
Tuttavia, come evidenziato da analisi recenti, i finanziamenti alla ricerca climatica, inclusi quelli destinati alla NASA, rischiano tagli significativi proprio nel momento in cui i dati scientifici sono più indispensabili che mai per guidare l’azione politica.
Il paradosso urbano: causa e vittima
Le città sono responsabili di circa il 70% delle emissioni globali di CO₂, ma sono anche tra le prime vittime delle loro stesse emissioni. Questo paradosso le rende sia agenti del cambiamento che campi di battaglia della crisi climatica.
Non tutte le aree urbane, però, sono colpite allo stesso modo. Le disuguaglianze socioeconomiche si intrecciano con i rischi climatici: i quartieri meno abbienti soffrono di maggiore esposizione agli eventi estremi e minore capacità di adattamento. Questo scenario fa del cambiamento climatico non solo una questione ambientale, ma anche una questione di giustizia sociale.
Riprogettare le città: un’urgenza non negoziabile
Se vogliamo sopravvivere e prosperare nell’era climatica, dobbiamo ripensare radicalmente le città. Serve una pianificazione urbana che sia climaticamente intelligente:
• Espandere il verde urbano: piantare alberi, creare parchi, proteggere gli spazi naturali urbani.
• Modernizzare le infrastrutture: adeguare le reti idriche, elettriche e di trasporto alle nuove condizioni estreme.
• Costruire rifugi climatici: spazi pubblici climatizzati accessibili a tutti, specialmente ai più vulnerabili.
• Incentivare l’efficienza energetica: edifici a basso impatto, sistemi di energia rinnovabile diffusa.
• Governare l’equità climatica: assicurarsi che le politiche di adattamento non aumentino ulteriormente le disuguaglianze sociali.
Il rischio di non agire è immenso: migrazioni interne di massa, collasso delle infrastrutture, emergenze sanitarie, crescita della povertà urbana.
Città come faro del cambiamento
La buona notizia è che molte città stanno già mostrando la via. Da Rotterdam a Singapore, da Parigi a Città del Capo, emergono modelli di adattamento innovativo che combinano sostenibilità, resilienza ed equità sociale. Queste esperienze ci insegnano che le città, lungi dall’essere solo vittime della crisi climatica, possono essere protagoniste della risposta globale.
La battaglia per il clima si vincerà – o si perderà – nelle città. Saranno i sindaci, gli urbanisti, gli architetti, i cittadini attivi a costruire (o a distruggere) il nostro futuro climatico.
Agire ora non è solo una scelta di responsabilità: è una scelta di sopravvivenza.
di Fabio Mazzeo
Giornalista e divulgatore scientifico


Sul clima, la salute e le città dobbiamo smettere di fingere. Abbiamo gli strumenti, ci manca solo il coraggio di usarli per non sottrarre il futuro a chi verrà dopo di noi.
Per parlare di cambiamento climatico e salute delle città è necessario parlare prima delle cause e quindi di noi. Dobbiamo compiere uno sforzo di verità, chiederci cosa ci interessi davvero, come intendiamo spendere il tempo che abbiamo, quanto vale per noi il detto che ci hanno consegnato i nostri padri, invitandoci a lasciare un mondo migliore di quello ereditato. Nei giorni scorsi, subito dopo la morte di Pepe Mujica, ho sentito l’esigenza di riprendere “Non fatevi rubare la vita”, un volume che avevo letto poco prima della pandemia. A quel libro avevo ripensato durante i lockdown necessari per salvare la vita a milioni di persone, ragionando sulle cause di una così rapida diffusione del virus, capace per sopravvivere e moltiplicarsi di sfruttare il modello di sviluppo delle città in cui viviamo, lavoriamo, tutto incentrato sul fine di una maggiore produttività per alimentare un sempre crescente consumismo. Pepe Mujica ha trascorso la sua esistenza ponendoci la domanda: è davvero questo l’unico modello di felicità possibile? La libertà si misura nella possibilità di acquisto di un bene materiale? O forse la società dei consumi ci toglie la possibilità di essere davvero liberi? Domanda che ha radici profonde e un senso solo se partiamo dal presupposto che la libertà sia il bene più prezioso da conquistare e preservare. Ipotesi interamente da verificare, questa della libertà bene supremo, mentre all’interno dei nostri autobus, metropolitane, nei centri commerciali, giriamo puntando il naso sullo smartphone per postare sui social il nostro stato, in una autorappresentazione permanente, ignorando il prossimo che ci passa accanto. Secondo diversi grandi pensatori questo narcisismo di massa non ci ha reso più liberi, ci ha trasformati in automi dell’autosfruttamento. E questo indipendentemente dalla nostra condizione economica, sociale. Tutti insieme stiamo distruggendo l’essenziale. La causa dell’impoverimento del mondo siamo noi, quelli che accelerando i cicli del consumo, senza renderci conto, stiamo esaurendo l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, le condizioni minime per la sopravvivenza umana sul Pianeta. Altri commentatori di questa rivista spiegano meglio le cause del peggioramento degli standard di qualità dell’aria, dell’acqua, del perché tutto questo dipenda da come abbiamo realizzato le città in cui viviamo e dell’urgenza con la quale dovremmo provvedere al cambiamento. E così lo spazio a me concesso voglio dedicarlo nel continuare porre una do-
manda perché ciascuno fornisca il proprio contributo di ragionamento a una risposta collettiva: perché ci disinteressiamo in modo così sfacciato, così imprudente, a tutti quegli indicatori che ci parlano di un pianeta sfinito dalla nostra bulimia? È come se, di fronte alle ormai esigue risorse ancora disponibili, invece di ragionare sul come preservarle e costruire un futuro migliore volessimo tutti correre a prenderci l’ultimo pezzettino che resta. Non stupisce certo simile comportamento in un mondo popolato da persone che da tre anni si dividono e ricorrono a sofismi invece di esprimersi semplicemente sulle barbarie russe ai danni dell’Ucraina, assistendo impotenti al genocidio in Palestina, e quindi come possiamo sorprenderci se la salute collettiva non fa più notizia? Se nessuno si indigna davanti al fatto che l’inquinamento è oggi una guerra mondiale a cui tutti dovremmo dire stop? Sale la temperatura, ma le coscienze restano fredde.
Eppure, la tecnologia non è solo quella cosa che ci consente di sproloquiare sui social di cose che non abbiamo approfondito. E le piattaforme di servizi possono essere sfruttate per fini diversi dall’acquisto compulsivo di oggetti inutili che producono il benessere effimero di un piacere che svanisce nello stesso istante in cui premiamo il click dell’acquisto. Oggi serve una forte scelta politica, culturale, umana. Serve uno scatto etico che ripensi le città come un organismo vivo, non come un deposito di individui in apnea. E la scienza ha già i suoi ritrovati per sfruttare meglio l’acqua piovana, organizzare le risorse idriche, ripulire e preservare il mare, salvare i boschi e impiantare nuovo verde, costruire palazzi e immaginare trasporto di merci e persone in modo sostenibile. Tutto si può fare, se c’è una cosa che la tecnologia ci consente è quella di bollare come falsario chi dice che gli strumenti per costruire un mondo meglio di così è impossibile. Bisogno solo avere il coraggio di porre fine alle conferenze permanenti, alla scrittura di protocolli che non saranno rispettati, e poi i piani, i bilanci verdi e tutto quel gigantesco e divisivo bla bla bla che popola i social e le aule delle istituzioni. Dare spazio alla nuova coscienza urbana, attivista, radicale, dei giovani che richiedono giustamente il futuro perché il futuro è roba loro.

L'INTERCONNESSIONE TRA CRISI CLIMATICA E SALUTE PUBBLICA IMPONE UN APPROCCIO
INTEGRATO, MULTIDISCIPLINARE E ORIENTATO ALLA SOSTENIBILITÀ PER FRONTEGGIARE
EFFICACEMENTE LE TRASFORMAZIONI AMBIENTALI, SOCIALI E SANITARIE IN ATTO.
Il cambiamento climatico, un fenomeno ormai supportato da numerose ricerche e solide prove scientifiche, sta profondamente modificando gli equilibri ambientali del nostro pianeta, con impatti significativi sulla salute, sull’economia e sulla sicurezza globale. Questi cambiamenti, possono avvenire in maniera naturale, tuttavia, negli ultimi decenni sono principalmente imputabili alle attività umane, influenzando l’intero ecosistema in cui viviamo e accelerando processi che un tempo richiedevano secoli.
Parlare di cambiamento climatico impone un’inevitabile riflessione sulla salute planetaria, un concetto che considera la salute umana come strettamente legata alla salute del pianeta e dei suoi sistemi naturali. Le alterazioni climatiche, infatti, influenzano la qualità dell’aria, l’accesso all’acqua potabile, la disponibilità di cibo e la diffusione di malattie infettive, che trovano terreno fertile in ambienti sempre più instabili e vulnerabili. Eventi climatici estremi come ondate di calore, alluvioni e incendi boschivi, ormai sempre più frequenti, mettono a rischio la vita di milioni di persone e sovraccaricano i sistemi sanitari nazionali, spesso già fragili.
Di fronte a questo scenario è fondamentale riconsiderare il nostro approccio alla prevenzione, alla promozione della salute e alla pianificazione urbana, fondando il nostro agire su stili di vita più sostenibili e scelte quotidiane consapevoli, che mettano al centro il rispetto per l’ambiente. Come cittadini, possiamo contribuire alla resilienza delle nostre comunità attraverso piccoli gesti che, sommati, producono un impatto reale e significativo.
Parallelamente, le istituzioni sono chiamate a ripensare una revisione dei servizi sanitari, in chiave più integrata tra sanità e assistenza sociale, con una maggiore attenzione alla salute urbana. Le città devono evolvere verso modelli sostenibili, attraverso politiche di mobilità intelligente, riduzione delle emissioni, valorizzazione del
verde urbano e infrastrutture che promuovano il benessere dei cittadini.
Le conseguenze del cambiamento climatico si estendono anche alla sfera geopolitica e sociale. Fenomeni come la desertificazione, l’innalzamento dei mari, la riduzione delle risorse naturali e l’aumento delle temperature medie stanno generando una crescente instabilità globale. Le migrazioni climatiche, che interessano milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie terre per sopravvivere in cerca di condizioni di vita dignitose e sicure, sono una delle manifestazioni più evidenti di questa crisi.
A fronte di questa complessa situazione, l’Unione Europea e i governi nazionali hanno avviato processi di transizione ecologica, spesso al centro di polemiche per la loro radicalità o per i tempi tardivi con cui sono stati implementati. Tuttavia, tali trasformazioni sono sempre più urgenti e necessarie. Nonostante il contesto internazionale sia segnato da crisi economiche e tensioni geopolitiche, è importante che il tema del cambiamento climatico rimanga sempre al centro dell’agenda politica e sociale. Affrontare questa sfida richiede l’impegno continuo e congiunto di cittadini, amministrazioni, istituzioni e imprese, operando in sinergia secondo un approccio olistico, integrato e orientato alla sostenibilità a lungo termine.
Ogni gesto quotidiano può fare la differenza, contribuendo a un cambiamento più ampio. Solo attraverso uno sforzo collettivo sarà possibile mitigare gli effetti della crisi climatica che stiamo vivendo e garantire un futuro più sano, equo e sostenibile per le generazioni presenti e future.
Focus

di Ludovica Serra
“Non stiamo solo cercando di salvare il futuro.
Stiamo cercando di sopravvivere nel presente.”
C’è una voce che si alza ogni giorno un po’ di più, con tono fermo e occhi lucidi. È la voce della Generazione Z, quella dei nati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del Duemila. Una generazione cresciuta tra eventi climatici estremi, emergenze globali, crisi ecologiche mai risolte e promesse mancate. Una generazione che non ha fatto in tempo a vivere l’illusione di un mondo stabile, perché ha conosciuto fin da subito il volto instabile del nostro tempo.
Per questi giovani, il cambiamento climatico non è un’ipotesi remota, non è un dibattito tra scienziati o un titolo da notiziario. È una presenza costante, un pensiero che accompagna ogni decisione, ogni sogno, ogni piano per il futuro. Un’ombra che si allunga fino dentro le loro emozioni, generando una nuova forma di malessere psicologico: l’eco-ansia.
L’eco-ansia non è una moda: è un grido silenzioso
L’eco-ansia è una condizione emotiva profondamente diffusa tra i giovani, ma ancora troppo poco riconosciuta. Non è semplice paura. È uno stato di stress persistente, un senso di impotenza che nasce dalla percezione che il pianeta – la nostra casa – sia in pericolo. Ma più ancora, nasce dalla sensazione che chi dovrebbe agire non lo stia facendo, o lo faccia troppo lentamente. I giovani si sentono abbandonati in un mondo che crolla e nel quale, paradossalmente, vengono invitati a “costruire il loro futuro”.
Numerosi studi lo confermano. Uno su tutti, la ricerca pubblicata su The Lancet Planetary Health, che ha intervistato 10.000 giovani in dieci Paesi del mondo. Il 59% si è dichiarato “molto preoccupato” per il cambiamento climatico; il 45% ha detto che l’ansia climatica incide negativamente sulla propria vita quotidiana. E ancora: il 75% giudica il futuro “spaventoso”, e molti sentono che “l’umanità ha fallito”.
Ma questi numeri, per quanto drammatici, non bastano a raccontare la portata profonda del disagio. Per comprenderla davvero, bisogna guardare negli occhi
chi la vive. Ascoltare i racconti dei ragazzi che, pur amando la vita, esitano a progettare un domani. Che si chiedono se ha senso costruire qualcosa mentre il mondo brucia. Che si sentono sopraffatti da una responsabilità enorme che non hanno scelto, ma che hanno ereditato.
Una generazione ferita… ma non spezzata
Eppure, c’è qualcosa che distingue la Gen Z da chiunque l’abbia preceduta. Forse è la loro capacità di non voltarsi dall’altra parte. Di affrontare il dolore senza fuggire. Di trasformare la paura in azione.
Sono tantissimi, in ogni angolo del mondo, i giovani che stanno reagendo. Che scelgono l’impegno invece della rassegnazione. Che scendono in piazza con i cartelli scritti a mano, che organizzano marce, campagne, raccolte fondi. Che fondano associazioni, innovano con startup green, scrivono libri, lanciano podcast. Alcuni diventano influencer per la sostenibilità, altri parlano davanti all’ONU. Altri ancora, in silenzio, piantano alberi nel loro quartiere o cambiano le abitudini della propria famiglia.
Perché l’attivismo climatico oggi non è solo una questione politica: è anche e soprattutto una forma di cura. Prendersi cura del pianeta diventa prendersi cura di sé. Reclamare giustizia ambientale significa chiedere giustizia emotiva. E unirsi ad altri ragazzi con la stessa ansia e la stessa rabbia diventa un balsamo per il cuore.
Un antidoto alla solitudine.
Il documentario che racconta la verità:
“Gen Z Mental Health: Climate Stories”
Proprio per dare voce a questo intreccio profondo tra mente e ambiente, è nato il progetto del Climate Mental Health Network, che ha prodotto il documentario
“Gen Z Mental Health: Climate Stories”. In poco più di mezz’ora, giovani attivisti da tutto il mondo raccontano la loro esperienza con l’eco-ansia, con la paura, con la fatica di restare ottimisti.
Non sono eroi. Sono ragazzi e ragazze qualunque: studentesse, artisti, figli di migranti, adolescenti delle periferie, giovani leader indigeni. Persone che lottano, che cadono, che si rialzano. Persone che piangono ma non smettono di credere. La forza di questo documentario sta proprio nella sua sincerità: non nasconde la fragilità, la celebra. E ci invita a fare lo stesso.
Un’alleanza tra generazioni è possibile
Se la Gen Z ha imparato a gridare, ora tocca agli adulti imparare ad ascoltare. La crisi climatica non si risolverà con i giovani da soli. Servono politiche lungimiranti, investimenti radicali, un cambiamento di paradigma. Ma soprattutto serve un patto tra generazioni. Serve che gli adulti riconoscano i giovani non come “utenti” o “futuri elettori”, ma come alleati, come co-costruttori del presente. Serve che la salute mentale dei giovani venga messa al centro delle agende ambientali e sanitarie.
E serve empatia. Serve che chi ha vissuto in un mondo meno incerto riconosca la fatica di chi oggi vive in un mondo che sembra franare sotto i piedi. Perché negare l’eco-ansia significa negare l’evidenza. Ma riconoscerla, ascoltarla, accompagnarla… significa forse, per la prima volta, iniziare davvero a guarire.
Oltre la paura, la possibilità
C’è una frase, ricorrente nei discorsi di molti giovani attivisti: “Non abbiamo altra scelta che sperare.” Eppure, la speranza della Gen Z non è cieca. È una speranza combattiva, costruita giorno dopo giorno, gesto dopo gesto. È la speranza di chi sa che le cose possono cambiare. E di chi ha deciso di non aspettare che siano gli altri a farlo.
In fondo, il futuro non è qualcosa che ci aspetta. È qualcosa che creiamo, insieme. E forse, se impariamo ad ascoltare la Generazione Z, possiamo ancora salvarlo.

IL Direttore di Urbes ha ricevuto, da parte Royal Institute of International Affairs, comunemente noto come Chatham House:
https://www.chathamhouse.org/, che è un centro studi britannico, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali l’invito di partecipare ad un incontro a porte chiuse a Londra lo scorso 15 Maggio
Tra i più accreditati think tank a livello mondiale prende il nome dall’edificio dove ha sede a St. James’s a Londra; inoltre ha dato origine alla cosiddetta Chatham House Rule, la regola convenzionale che disciplina la confidenzialità, in relazione alla fonte di informazioni scambiate nel corso di discussioni in riunioni a porte chiuse.
Sin dalla sua fondazione, Chatham House opera sotto il patronato del monarca regnante del Regno Unito. L’attuale amministratore delegato è Sir Simon Fraser, mentre il direttore è Bronwen Maddox.
Nella struttura di governance sono presenti tre presidenti, uno per ciascun partito politico presso il parlamento britannico, al fine di garantire l’indipendenza e
la neutralità sulle questioni di politica internazionale; attualmente ricoprono la carica l’ex-primo ministro John Major, l’ex-direttore generale dell’MI5 Eliza Manningham-Buller e l’ex-Primo ministro della Nuova Zelanda Helen Clark.
Oltre agli studi oggetto delle pubblicazioni nelle varie discipline, Chatham House ospita frequenti e regolari conferenze con interventi di personalità di alto livello in ambito politico, economico e sociale dal mondo intero. Recentemente sono intervenuti nei dibattiti tra gli altri Shinzō Abe, Paolo Gentiloni, David Cameron, Aung San Suu Kyi, Christine Lagarde, Federica Mogherini, Madeleine Albright, Ellen Johnson Sirleaf, Abdullah Gül, Anders Fogh Rasmussen, Herman Van Rompuy, Muhammad Yunus, Ban Ki-moon e Muhammadu Buhari.
Di seguito l’intervento fatto in questa occasione.
Segretario Generale di Health Cities Institute, Cities+, e dell’Osservatorio Italiano sulla Salute come Bene Comune, Presidente di IPPAA-EMEA, Chair del Three Bees Inner Circle, Direttore del Planetary Health Inner Circle, Responsabile della Segreteria Tecnica del Gruppo Interparlamentare Qualità della Vita nelle Città, Direttore responsabile di URBES, Presidente YMCA
Signore e Signori, oggi ho l’onore di condividere una visione che può plasmare il futuro delle nostre comunità, delle nostre economie e del nostro pianeta: una visione in cui la salute non è soltanto un diritto, ma un catalizzatore per una crescita inclusiva, per l’innovazione e per la competitività.
Per troppo tempo la salute è stata percepita principalmente come un costo.
Ma oggi sappiamo: la salute è un investimento — in produttività, in resilienza, in prosperità.
In questa nuova visione, le città sono al centro.
Entro il 2050, quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane.
Le città sono motori di attività economica, ma anche epicentri di disuguaglianze sanitarie, malattie croniche non trasmissibili, inquinamento e vulnerabilità climatica.
La salute urbana deve diventare una priorità strategica, perché non può esserci crescita sostenibile senza città sane e inclusive.
Sappiamo anche che la salute umana è inseparabile dalla salute del pianeta.
La crisi climatica è già una crisi sanitaria.
Ondate di calore, inquinamento atmosferico, malattie zoonotiche, insicurezza idrica — queste minacce sono reali e immediate.
È per questo che dobbiamo abbracciare i principi della
Salute Planetaria: riconoscere che la nostra sopravvivenza dipende dalla salute degli ecosistemi che ci sostengono.
Papa Francesco, nella sua Enciclica Laudato Si’, scriveva dieci anni fa:
“L’attuale sistema mondiale è insostenibile sotto diversi aspetti... Le previsioni catastrofiche non si possono più
guardare con disprezzo o ironia.”
Il rischio è concreto: potremmo lasciare alle generazioni future un pianeta devastato e inabitabile.
E i giovani lo sentono profondamente.
Uno studio di Hickman et al., pubblicato su The Lancet Planetary Health nel 2021, ha rilevato che il 75% di bambini e giovani nel mondo ritiene che il futuro sia spaventoso — con percentuali superiori all’80% in paesi come Brasile, Portogallo e India.
Le loro paure comprendono conflitti nucleari, pandemie, collasso climatico, disastri legati all’intelligenza artificiale.
Soprattutto, si sentono impotenti e vulnerabili, di fronte a sfide troppo vaste, troppo interconnesse, e apparentemente fuori dalla portata dell’azione individuale.
Tra gli adulti, osserviamo tre reazioni comuni:
Rifiuto: negare il problema, credere che il mondo abbia sempre affrontato difficoltà e sia sempre sopravvissuto.
Rassegnazione: accettare fatalisticamente che non si possa fare nulla.
Resistenza: reagire con attivismo e determinazione.
Ma oggi propongo una quarta reazione:
Rivalutazione — riconoscere le vulnerabilità attuali, ma anche mobilitare le nostre capacità morali e tecniche per guidare un discorso di speranza, un discorso di azione per un mondo migliore.
E questo richiede leadership — la capacità di guidare e gestire allo stesso tempo — e, soprattutto, immaginazione.
La nostra immaginazione non deve limitarsi a replicare esperienze passate.
Deve essere creativa, costruttiva, visionaria — capace di osare nel costruire futuri che ancora non esistono.


Credo che questa Accademia — e tutti noi, nei nostri ruoli e responsabilità — debba farsi strumento di questa visione.
Tuttavia, ci troviamo di fronte a un’altra minaccia grave: la scienza è sotto assedio.
Oggi, in molte parti del mondo, forze politiche minano la competenza, smantellano istituzioni di ricerca, e sostituiscono le politiche basate sull’evidenza con ideologie.
Negli Stati Uniti, la storia viene riscritta.
I vaccini salvavita vengono descritti come pericolosi. I ricercatori vengono demonizzati. Le istituzioni scientifiche indebolite, i fondi congelati, il personale licenziato, le agenzie sanitarie pubbliche private di risorse. La disinformazione dilaga, avvelenando la ricerca nazionale e la collaborazione internazionale.
L’erosione della credibilità scientifica minaccia la salute globale, la coesione sociale e la stessa democrazia. Noi, come comunità scientifica e politica, non possiamo restare passivi.
L’Europa — che ha superato le epoche più buie del Novecento — ha una responsabilità di leadership. Deve difendere e riaffermare le politiche basate sull’evidenza.
Se gli Stati Uniti arretrano dal loro storico ruolo di guida nella scienza e nella sanità globale, l’Europa deve farsi avanti.
I governi devono approvare tutele giuridiche per le istituzioni di ricerca.
Le università devono offrire rifugi sicuri agli scienziati minacciati.
La comunità scientifica deve riconquistare il proprio ruolo come fonte affidabile di conoscenza e orientamento.
La posta in gioco non potrebbe essere più alta.
La scienza non è solo scoperta.
È il fondamento delle decisioni informate, del progresso tecnologico, del benessere umano.
Se le forze politiche riusciranno a smantellare la scienza, il costo si misurerà in morti, disperazione, e disgregazione delle istituzioni democratiche.
Ora è il momento di difendere la scienza.
Ora è il momento di difendere la salute, le persone, e il pianeta.
Il futuro dipende dalla nostra capacità di lottare non solo per nuove tecnologie, ma per la verità, la speranza, e un bene comune sostenibile.
Agiamo con coraggio.
Guidiamo con immaginazione.
Reimmaginiamo insieme un mondo in cui salute, scienza e solidarietà costruiscano un domani migliore per tutti.
Nel mondo interconnesso del XXI secolo, il turismo è diventato uno degli ingranaggi fondamentali dell’economia globale. Rappresenta circa il 10% del PIL mondiale, genera centinaia di milioni di posti di lavoro e promuove scambi culturali e cooperazione internazionale. Ma questa straordinaria forza propulsiva ha anche un volto meno celebrato: quello dell’impatto ambientale. In particolare, l’industria turistica contribuisce per circa l’8-10% alle emissioni globali di gas serra. La crisi climatica pone dunque una sfida ineludibile: può il turismo continuare a crescere e prosperare senza compromettere l’equilibrio del pianeta?
L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) ha risposto a questa domanda con determinazione, mettendo l’azione per il clima al centro della propria agenda per lo sviluppo sostenibile. La Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, lanciata nel 2021 durante la COP26, è il manifesto di una transizione necessaria: ridurre del 50% le emissioni del settore entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Un obiettivo ambizioso, ma non negoziabile.
Un impegno globale, un’agenda condivisa
Ad oggi, oltre 800 firmatari – tra governi, imprese turistiche, enti locali, ONG e istituzioni accademiche –hanno sottoscritto la dichiarazione, riconoscendo che la sostenibilità ambientale non è più una scelta accessoria, ma un criterio fondante per l’intero ecosistema turistico. L’UNWTO ha fatto da catalizzatore di questa alleanza, sottolineando che non si tratta solo di firmare un documento, ma di assumere un impegno operativo strutturato: sviluppare un piano d’azione climatica entro 12 mesi, monitorare annualmente i progressi, condividere dati e indicatori trasparenti, collaborare con gli altri attori del sistema.
Le linee guida elaborate dall’UNWTO per i governi e le destinazioni turistiche offrono un framework chiaro:

di Riccardo Baicchi
migliorare l’efficienza energetica nelle infrastrutture ricettive, favorire la mobilità sostenibile, incentivare il turismo lento e di prossimità, proteggere gli ecosistemi e le comunità locali, ripensare il rapporto tra turisti e territorio. In quest’ottica, il turismo non deve più essere visto solo come una fonte di pressione sugli ecosistemi, ma come un potenziale alleato per la tutela del clima e della biodiversità.
Integrazione con le politiche climatiche nazionali
Un punto cruciale dell’agenda dell’UNWTO riguarda l’integrazione del turismo nelle Contribuzioni Determinate a livello Nazionale (NDC) previste dall’Accordo di Parigi. Storicamente, il turismo è rimasto ai margini dei negoziati climatici, nonostante la sua rilevanza. Ora si punta a superare questa disconnessione. A novembre 2024, oltre 50 paesi hanno incluso in modo esplicito il turismo nei propri piani climatici nazionali. Un passo storico, che riconosce il settore come parte attiva – e responsabile – della transizione ecologica.
L’azione multilivello è un altro tassello fondamentale. Le città, le regioni, le destinazioni turistiche locali sono chiamate a fare la loro parte. Le reti di Osservatori del Turismo Sostenibile coordinate dall’UNWTO forniscono strumenti per monitorare gli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, con indicatori comparabili a livello internazionale. Si tratta di una rete viva, in costante espansione, che consente alle amministrazioni locali di disporre di dati solidi per politiche più efficaci.
Il ruolo del settore privato: dalla consapevolezza all’azione
Accanto alle istituzioni pubbliche, è il settore privato che detiene la leva per cambiare davvero le dinamiche del turismo globale. Catene alberghiere, compagnie aeree, tour operator, piattaforme digitali: tutti sono

chiamati a misurare, ridurre e compensare le proprie emissioni. La World Sustainable Hospitality Alliance, ad esempio, ha sviluppato una piattaforma per aiutare le strutture ricettive a calcolare l’impronta di carbonio, il consumo idrico, la produzione di rifiuti e l’uso di energia. Strumenti come questo permettono di passare da una sostenibilità dichiarata a una sostenibilità misurabile.
Allo stesso tempo, cresce anche la sensibilità dei viaggiatori, soprattutto tra le nuove generazioni. Il “climate conscious traveler” sceglie destinazioni meno affollate, mezzi di trasporto meno impattanti, strutture certificate, esperienze immersive nella natura. E sempre più spesso chiede trasparenza, rendicontazione, coerenza. Il mercato sta cambiando, e il turismo che non si adatta rischia di perdere rilevanza.
Oltre la mitigazione: il turismo come agente di resilienza
Ma l’azione per il clima nel turismo non si esaurisce nella mitigazione delle emissioni. L’adattamento e la resilienza sono altrettanto cruciali. Il cambiamento climatico sta già alterando stagionalità, accessibilità, sicurezza e attrattività di molte destinazioni turistiche: dagli atolli del Pacifico alle Alpi, dalle città d’arte esposte alle ondate di calore ai parchi naturali minacciati dagli incendi. Aiutare le destinazioni a prepararsi, adattarsi e rigenerarsi è una priorità globale.
L’UNWTO promuove anche lo sviluppo di soluzioni basate sulla natura, l’uso di energie rinnovabili, l’agricoltura sostenibile legata al turismo rurale, e forme di finanziamento innovative – come i green bonds e il climate finance – per sostenere le transizioni nei paesi in via di sviluppo, dove il turismo può rappresentare un’ancora di crescita sostenibile, ma anche una vulnerabilità esposta.
La narrazione da cambiare
Infine, va detto che il turismo ha bisogno di un cambio di paradigma anche culturale. Non è più sufficiente raccontare il viaggio come e vasione, consumo, accumulo di esperienze. Occorre ritornare a una dimensione più lenta, riflessiva, responsabile. L’etica del viaggio va ripensata: il turista del futuro dovrà essere anche un custode del pianeta, non solo un fruitore di bellezza.
La sfida climatica è forse la più grande che il turismo abbia mai affrontato. Ma è anche un’occasione unica per ridefinirne i confini, i valori, gli impatti. Se il turismo saprà mettersi davvero al servizio del clima, potrà continuare a essere ciò che è sempre stato: un ponte tra culture, territori e generazioni. Solo questa volta, con un biglietto di sola andata verso un futuro più giusto e sostenibile.
Riccardo Baicchi è un imprenditore italiano con una lunga esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi e congressi, in particolare nell’ambito medicoscientifico. Dal 1996 si occupa della progettazione e realizzazione di eventi di varie dimensioni, contribuendo alla fondazione di diverse società che oggi fanno parte del gruppo che presiede. È il principale dirigente di Regia Congressi Srl, fondata nel 1989 a Firenze, specializzata nell’organizzazione di congressi, meeting e convention, offrendo servizi completi che spaziano dalla pianificazione alla gestione logistica . Baicchi è anche coinvolto in altre realtà imprenditoriali, come Virtual Training Support Srl, dove ricopre un ruolo chiave nella gestione e nello sviluppo di soluzioni formative innovative . La sua esperienza e competenza nel settore lo hanno portato a essere riconosciuto come una figura di riferimento nell’industria degli eventi e della formazione professionale in Italia.
Urban Health: A Practical Application for Clinical-Based Learning
Autore: Endah Fitriasari
Anno di pubblicazione: 2025
Lingua: Inglese
Editore: Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Press
: Questo volume rappresenta una novità significativa nella letteratura sull’Urban Health, colmando un vuoto tra il sapere accademico e la pratica clinica quotidiana nei contesti urbani. L’autrice, docente e ricercatrice presso l’Universitas ‘Aisyiyah di Yogyakarta, propone un metodo innovativo di apprendimento clinico basato su scenari urbani reali, con un impianto pedagogico ispirato al “case-based learning” e al “problem-solving approach”.
Il testo si distingue per la sua struttura modulare, che consente ai lettori – principalmente studenti e operatori sanitari – di affrontare capitolo per capitolo le principali problematiche legate alla salute urbana: malattie trasmissibili e non trasmissibili, determinanti sociali della salute, salute mentale, accesso diseguale ai servizi sanitari, impatto ambientale (aria, rumore, traffico), e crisi sanitarie urbane (come COVID-19). Ogni unità include obiettivi didattici, domande di riflessione, schemi di analisi, casi pratici, esercitazioni individuali e in gruppo.



Il punto di forza del libro risiede nella sua vocazione educativa, che supera la teoria per fornire strumenti utili alla pratica sul campo, soprattutto nei sistemi sanitari urbani dei Paesi a medio reddito, spesso sotto stress per l’espansione demografica e l’inadeguatezza delle infrastrutture. Il testo è arricchito da riferimenti all’Agenda 2030, all’approccio One Health e alle principali policy globali in tema di salute urbana. Una lettura indispensabile per chi si occupa di formazione sanitaria, medicina di comunità e politiche urbane integrate.
Disparities in Urban Health: The Wounds of Policies and Legal Doctrines
Autore: Edward V. Wallace
Anno di pubblicazione: 2024
Lingua: Inglese
Editore: Health Justice Press
Questo saggio costituisce una delle riflessioni più lucide e coraggiose degli ultimi anni sul rapporto tra disuguaglianze sociali, salute e diritto urbano. Edward V. Wallace – attivista, giurista e docente di sanità pubblica – esplora in profondità il modo in cui le politiche abitative, le leggi urbanistiche, la segregazione razziale e le pratiche di “redlining” abbiano prodotto e continuino a riprodurre cicli di esclusione e malattia nelle grandi città nordamericane e non solo.
L’autore non si limita a una disamina delle cause strutturali delle iniquità sanitarie: mette in discussione interi paradigmi normativi, mostrando come il diritto urbanistico e la gestione del territorio siano spesso stati strumenti di dominio, e non di giustizia. Il testo alterna analisi giuridiche approfondite, studi di caso (Chicago, New York, Detroit), dati epidemiologici e testimonianze dirette, in uno stile che coniuga rigore accademico e potenza narrativa.
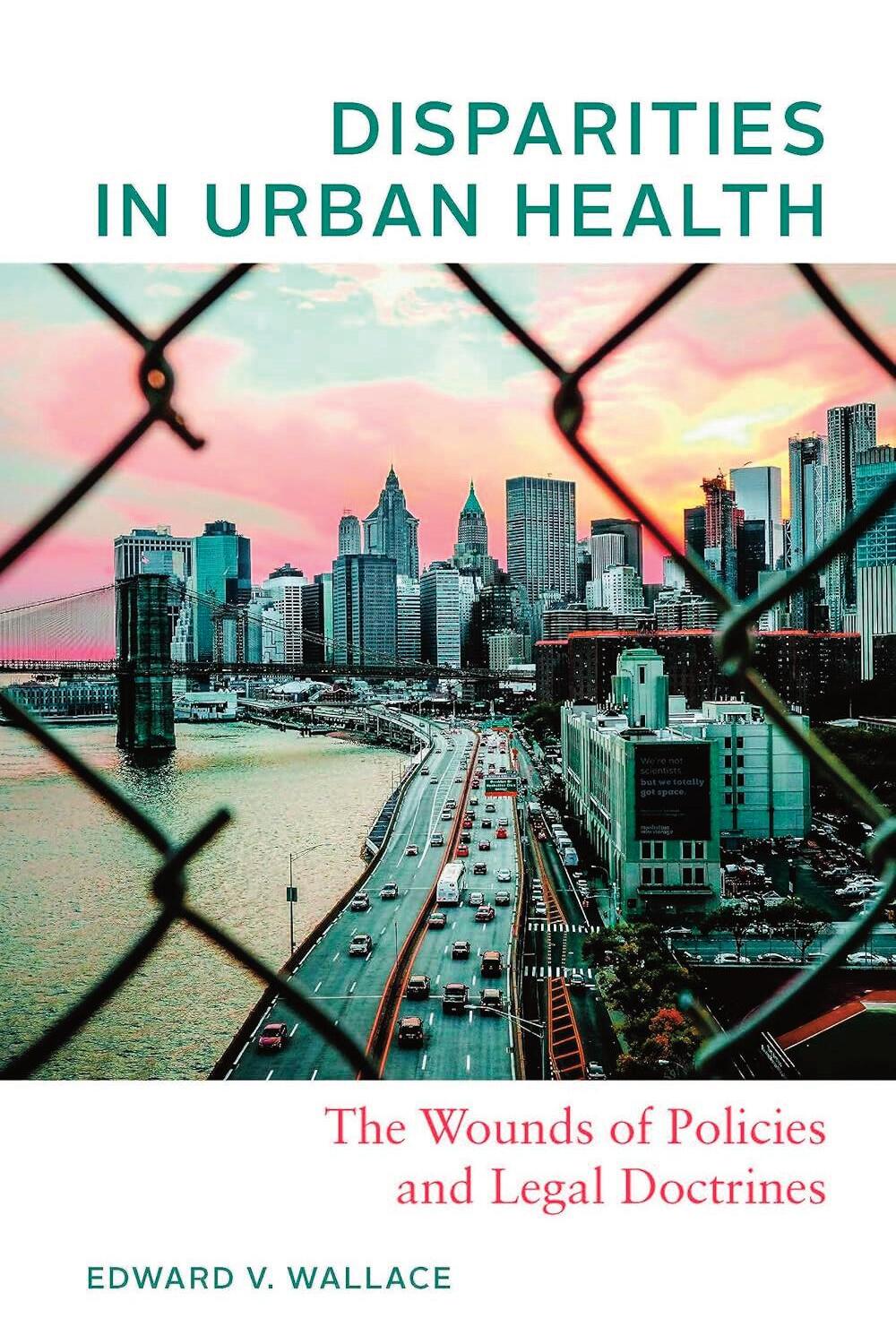
Particolarmente toccanti sono i capitoli dedicati ai quartieri “disinvestiti”, dove la mancanza di accesso a cure, alimentazione sana, trasporto pubblico e sicurezza ambientale si traduce in mortalità precoce e cronicità evitabile. Wallace propone un’agenda di riforme orientata alla giustizia riparativa, alla redistribuzione delle risorse urbane e all’empowerment comunitario. Un libro scomodo ma necessario, che fa da ponte tra sanità pubblica, diritto e diritti umani.

di Federico Serra

A Dio, Papa Francesco. Non è solo un commiato terreno, ma un’affermazione di fede. È il saluto che accompagna chi torna alla Casa del Padre, dopo aver consumato la propria vita a servizio degli altri. Non un addio, ma un “a Dio”, in quell’affidamento ultimo che riconduce tutto al senso pieno del cammino cristiano. E in questo cammino, Papa Francesco ha inciso una traccia profonda, umile, irripetibile.
La sua voce si è levata dal “fine del mondo”, come egli stesso disse affacciandosi per la prima volta dalla Loggia di San Pietro. Ma da quel giorno – 13 marzo 2013 – ha parlato al cuore del mondo. Ha riplasmato l’immagine del Papato restituendole la forma evangelica: quella del pastore che cammina con il gregge, dietro quando serve ascoltare, davanti quando serve guidare. Non ha avuto paura di toccare le ferite dell’umanità: la povertà, la migrazione, l’indifferenza, la solitudine. Ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, e allo stesso tempo di pronunciare parole che profumano di misericordia.
Con lui, la Chiesa ha respirato con un ritmo più umano. Ha rallentato quando il mondo accelerava, ha teso la mano quando i muri si alzavano, ha invocato la pace mentre infuriavano le guerre. Ha parlato agli ultimi, ai dimenticati, ai feriti del nostro tempo. Non
come un sovrano dall’alto, ma come un fratello. Il suo magistero –fatto di gesti tanto quanto di parole – ha ridato dignità ai volti che la società vorrebbe invisibili.
Ma ora, il tempo del cammino si è fatto tempo del ritorno. Il “pellegrino venuto dalla fine del mondo” è giunto alla soglia dell’eterno. E noi, figli e fratelli di questa umanità ferita che lui ha tanto amato, gli diciamo “A Dio” con la gratitudine di chi ha ricevuto in dono un padre che ci ha ricordato, ogni giorno, quanto Dio sia vicino.
In un’epoca attraversata dalla crisi della verità e della compassione, Papa Francesco è stato voce profetica. Non ha cercato il consenso, ma la coerenza con il Vangelo. Ha scomodato le coscienze, sì. Ma per svegliarle alla speranza.
Oggi il mondo lo saluta con gli occhi umidi e il cuore pieno. Il suo pontificato non si chiude: si compie. Come una parabola che si apre alla luce del Regno.
E allora davvero possiamo dirlo con la fede dei semplici e la commozione dei figli:
A Dio, Papa Francesco. Buon ritorno a Casa.
Riflessioni di Federico Serra, Presidente di YMCA Health e di Sandro Indovina, Segretario Generale della Federazione italiana delle YMCA in occasione della Messa Esequiale per il Sommo Pontefice Francesco
Papa Francesco ci ha lasciato e con lui se ne va una delle voci più potenti e autentiche del nostro tempo nel difendere la salute come diritto universale, come bene comune e come atto concreto di fraternità. Il Pontefice ha sempre affermato con forza: la salute non può essere un privilegio. La sua visione rifiuta in modo netto e profetico la logica del profitto e del mercato applicata al corpo umano. Per Francesco, l’assistenza sanitaria deve essere pubblica, equa, accessibile a tutti, e ogni esclusione è una ferita alla fraternità universale.
È un tema che ha attraversato tutte le sue encicliche, i suoi messaggi per la Giornata Mondiale del Malato e le numerose udienze con operatori sanitari. Un pensiero profondo, coerente, attuale, che oggi ci consegna con urgenza una responsabilità: portare avanti la sua eredità.
Papa Francesco e YMCA: un cammino condiviso
Nel nostro lavoro con YMCA Health, sentiamo il legame ideale con il magistero sociale di Papa Francesco. Quando nel 2019 ricevette una delegazione internazionale di YMCA Health in Vaticano, Francesco parlò con affetto e stima del nostro impegno educativo e spirituale, soprattutto a favore dei giovani più fragili. Quelle parole sono state un incoraggiamento potente per tutte le realtà del movimento, in Italia e nel mondo, che ogni giorno si impegnano per la salute integrale delle persone e delle comunità.
Papa Francesco e YMCA hanno condiviso una stessa visione della salute: non solo come cura della malattia, ma come piena fioritura della persona in tutte le sue dimensioni — fisica, psicologica, relazionale, ambientale e spirituale.
Fraternità, salute e prossimità: da Fratelli tutti al Buon Samaritano
Nella sua enciclica Fratelli tutti (2020), Papa Francesco aveva affidato al Buon Samaritano il compito di diventare paradigma etico e sociale del nostro tempo. Non è solo una figura evangelica, ma una scelta politica, una presa di posizione civile: “In ogni momento della storia, ci troviamo di fronte alla scelta di essere passanti distratti o prossimi premurosi.”
Francesco chiedeva e credeva in una sanità della prossimità, che non si limiti a gestire strutture e risorse, ma che accolga i più fragili, senza discriminazioni, senza esclusioni. I poveri, i migranti, i malati cronici, le persone con disabilità: tutti devono essere messi al centro.
E dove c’è distanza o esclusione, lì la società si ammala. Ecologia integrale e salute nella Laudato si’
In Laudato si’ (2015), il Pontefice aveva affermato con chiarezza che non esiste salute umana senza salute del pianeta. L’inquinamento, la mancanza d’acqua, il degrado urbano, la cattiva alimentazione: sono tutte ferite al corpo umano, soprattutto dei più vulnerabili. “L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme.” La crisi ambientale è crisi sanitaria, e viceversa.
Il messaggio è rivolto anche ai professionisti della salute: non possono più restare neutri. Devono essere testimoni attivi nella difesa del creato, perché ogni danno alla Terra è un danno al corpo delle persone che la abitano.
La cura come vocazione e atto d’amore
Nella recente Dilexit nos (2024), Papa Francesco rifletteva sulla cura come espressione dell’amore cristiano: “L’amore che guarisce è quello che si fa carne, che non fugge di fronte alla fragilità altrui.” Medici, infermieri, psicologi, volontari: tutti coloro che si prendono cura sono testimoni viventi della compassione.
Per Francesco, la medicina non è mai solo tecnica. È missione umana, spirituale, sociale. È vocazione a stare accanto, ad ascoltare, a vedere nel malato un volto e non un caso clinico. Contro la burocrazia, contro l’efficienza senz’anima, il Papa ha sempre invocato uno sguardo umano sul paziente, fatto di tempo, empatia, tenerezza.
Una sanità pubblica, giusta, universale
Nel 2022, ricevendo nuovamente YMCA Health, Papa Francesco ha pronunciato parole durissime e verissime: “Tagliare le risorse per la salute è un oltraggio all’umanità”. E ha messo in guardia contro la sanità a due velocità, dove chi ha più mezzi riceve cure migliori, mentre chi è povero resta ai margini.
Per lui, la sanità è bene comune. Non può essere lasciata al mercato. Deve essere garantita dallo Stato, accessibile a tutti, capace di prendersi cura delle periferie esistenziali. È un dovere morale, un segno di civiltà, una concreta espressione di giustizia sociale.
Lumen fidei: non si può credere senza amare, non si può amare senza curare
Infine, nella sua prima enciclica, Lumen fidei (2013), Francesco scriveva che la fede autentica genera legami, apre alla relazione, produce incontro. La fede non è mai disincarnata. E chi ama, si prende cura. Anche questo è un messaggio per i credenti e per i non credenti: la cura è il linguaggio universale dell’amore.
L’eredità del Papa: una sanità sociale che ricuce, accoglie, unisce
Come YMCA Health, raccogliamo con gratitudine e responsabilità l’eredità di Papa Francesco. Il suo insegnamento ci spinge a promuovere una sanità:
• accessibile e gratuita,
• territoriale e comunitaria,
• umana e spirituale,
• attenta ai più fragili e ai più poveri,
• capace di coniugare giustizia e compassione.
In un mondo segnato da pandemie, guerre, disuguaglianze e cambiamento climatico, le sue parole restano una profezia da realizzare.
Il benessere psicofisico dei giovani, nuova frontiera della cura
Papa Francesco ha sempre avuto un’attenzione speciale
per i giovani. Non li ha mai trattati come una categoria da proteggere paternalisticamente, ma come protagonisti responsabili del presente. Tuttavia, ha riconosciuto che il tempo che viviamo espone i giovani a forme inedite di fragilità: pressioni scolastiche e sociali, isolamento digitale, crisi ambientale, incertezze economiche. La salute mentale e fisica dei giovani si è incrinata, e la pandemia non ha fatto che accelerare questa frattura silenziosa.
Questa condizione non è solo una questione sanitaria, ma antropologica. Il Papa invitava a riscoprire l’importanza del “toccare la carne dell’altro” anche tra i giovani: ritessere relazioni, coltivare la dimensione comunitaria, educare alla corporeità, alla lentezza, all’interiorità. La logica del consumo, del successo immediato e della competizione individuale sta generando una generazione stanca, spesso ferita. Da qui nasce l’invito a creare luoghi di cura non clinici, spazi di ascolto, di sport, di silenzio, di impegno sociale, dove i giovani possano ritrovare il senso di sé e del mondo.
Non si tratta solo di offrire servizi, ma di educare alla cura di sé, degli altri, del creato. L’YMCA, in questo senso, rappresenta un modello prezioso: promuove salute e benessere con approccio integrato, tra corpo, mente e spirito. Francesco ci chiede di andare oltre l’emergenza, e di costruire un ecosistema di cura permanente, in cui la prevenzione sia relazione, cultura, accompagnamento, non solo diagnosi.
Il bene comune, principio politico e spirituale del prendersi cura
Nel vocabolario di Papa Francesco, “bene comune” non era un concetto astratto, ma una realtà viva che interpella le coscienze e le istituzioni. La salute, la pace, l’ambiente, l’accesso all’educazione, il lavoro dignitoso: tutto rientra nella trama del bene comune, che è sempre inclusivo, mai elitario.
Francesco lo diceva chiaramente: non si può parlare di sviluppo autentico se qualcuno resta indietro. E nella sua visione, ispirata a una tradizione cattolica che risale al Concilio Vaticano II e ai grandi padri del pensiero sociale cristiano, il bene comune è anche condizione per la dignità individuale. Non si realizza da soli. Ogni forma di salute – individuale, sociale, ambientale – esiste solo nella reciprocità.
Il Papa rifiutav l’idea che la sanità possa essere trattata come un mercato. Denuncia la cultura dello scarto, che elimina gli anziani, i disabili, i poveri, i migranti. Ogni esclusione è una frattura del bene comune. E ogni co-


munità che vuole dirsi civile ha il dovere di proteggere ciò che appartiene a tutti, non come bene disponibile, ma come dovere etico condiviso.
In questo senso, la costruzione del bene comune è anche una scelta politica. Ma non solo nel senso istituzionale del termine. È una scelta quotidiana: nel modo in cui usiamo le parole, costruiamo alleanze, progettiamo città e ospedali, educazione e impresa. Il bene comune, diceva Francesco, è il nome della giustizia fatta carne nella società.
Papa Francesco ci ha insegnato che curare e prendersi cura è un atto politico, spirituale e sociale. E che nessuno può salvarsi da solo e che il bene comune è la stella polare dove indirizzare il nostro cammino
YMCA Health, è una rete internazionale, animata da medici, operatori sociosanitari e volontari, ispirata ai valori del movimento YMCA, che promuove in tutto il mondo la salute, l’accesso alle cure, al benessere psico-fisico, la giustizia sociale attraverso il volontariato e il lavoro comunitario.




“Siamo
Nel cuore del Museo Americano di Storia Naturale, tra le ossa pietrificate dei dinosauri, António Guterres ha pronunciato una frase destinata a restare nella memoria collettiva: “Nel caso del cambiamento climatico, non siamo i dinosauri. Siamo il meteorite.” Con questa immagine cruda e potente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha voluto lanciare un messaggio chiaro: non siamo vittime di una catastrofe naturale, ma autori di un disastro annunciato.
Da troppo tempo il cambiamento climatico è trattato come una minaccia astratta, un pericolo lontano, qualcosa che accade altrove o nel futuro. Ma i dati parlano con la precisione tagliente della scienza: il riscaldamento globale è qui, ora, e colpisce ovunque. “Siamo passati dall’era del riscaldamento globale all’era dell’ebollizione globale,” ammonisce Guterres, riportando l’attenzione sulla crescente frequenza di eventi estremi, dall’Africa australe all’Artico, dall’Amazzonia all’Asia.
Non è un’emergenza nuova. Ma oggi ci troviamo davanti a un bivio definitivo: proseguire sulla via della distruzione, o invertire la rotta. “Stiamo giocando alla roulette russa con il nostro pianeta,” ha detto con fermezza, puntando il dito contro chi continua a sostenere un’economia basata sui combustibili fossili, nonostante gli allarmi della comunità scientifica e le promesse disattese degli accordi internazionali.
Le responsabilità, secondo Guterres, sono chiarissime. Le compagnie dei combustibili fossili sono i “padrini del caos climatico”. Conosciamo da decenni l’effetto devastante delle loro attività, ma continuiamo a sovvenzionarle con fondi pubblici, a permettere che si promuovano attraverso campagne pubblicitarie ingannevoli, a dar loro potere nei tavoli negoziali sul clima. “È ora di vietare la pubblicità del carbone, del petrolio e del gas,” dice Guteress “Come è stato fatto con il tabacco, deve essere fatto con i combustibili fossili.”
La denuncia è dura, ma non priva di speranza. Perché se è vero che l’umanità è la causa della crisi, è anche vero che può esserne la soluzione. “Abbiamo bisogno di un’uscita dall’autostrada verso l’inferno climatico. E la verità è che abbiamo il controllo del volante.” Le tecnologie per una transizione sono già disponibili: energie rinnovabili, reti elettriche intelligenti, sistemi di trasporto sostenibili, agricoltura rigenerativa. “Le energie rinnovabili stanno crescendo mentre i costi crollano – e i governi si rendono conto dei benefici di un’aria più pulita, buoni posti di lavoro, sicurezza energetica.”
Non è una sfida puramente tecnica. È una questione di giustizia. I paesi che hanno emesso di più sono anche quelli meglio attrezzati per proteggersi, mentre le nazioni più vulnerabili – quelle che hanno contribuito meno al disastro – affrontano le conseguenze peggiori. Ecco perché Guterres chiede che “le compagnie dei combustibili fossili paghino per i danni che hanno causato”, e propone una tassa globale sui loro profitti straordinari per finanziare l’adattamento climatico dei paesi più fragili.
Ma il suo messaggio più profondo è rivolto a tutti noi. Perché ogni scelta quotidiana, ogni voto, ogni investimento è parte del problema o della soluzione. “Abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno per salvarci,” ci dice. “Le nostre foreste, le nostre zone umide, i nostri oceani: assorbono carbonio, ci proteggono. Sono alleati straordinari. Ma dobbiamo rispettarli, proteggerli, valorizzarli.”
Guterres crede nella possibilità di una trasformazione sistemica. Una transizione giusta, equa, sostenibile. Una rigenerazione profonda, che non sia solo ambientale, ma culturale. Perché la crisi climatica è anche una crisi di immaginazione. “La battaglia per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C sarà vinta o persa negli anni ’20 – sotto la guida dei leader di oggi.” È un tempo storico, e la finestra d’azione si sta chiudendo.
Eppure, non tutto è perduto. Se abbiamo il coraggio di cambiare, possiamo ancora evitare il peggio. Non si tratta di tornare indietro, ma di avanzare in modo nuovo: verso città resilienti, economie circolari, società più giuste. Il futuro non è una minaccia: è una responsabilità.
Possiamo essere il meteorite che cancella. O possiamo essere la scintilla che rigenera.
La scelta è nostra.
Federico Serra è autore di “Geopolitica della Salute”, di “Salute Planetaria: Riflessioni per un Futuro Sostenibile” e “L’orto di Michelle: la sanità mondiale secondo l’Obama family” è presidente dell’International Public Policy Advocacy Association e del Planetary Health Inner Circle. Si occupa di diplomazia climatica, diritto alla salute, di Planetary Health e transizione ecologica.
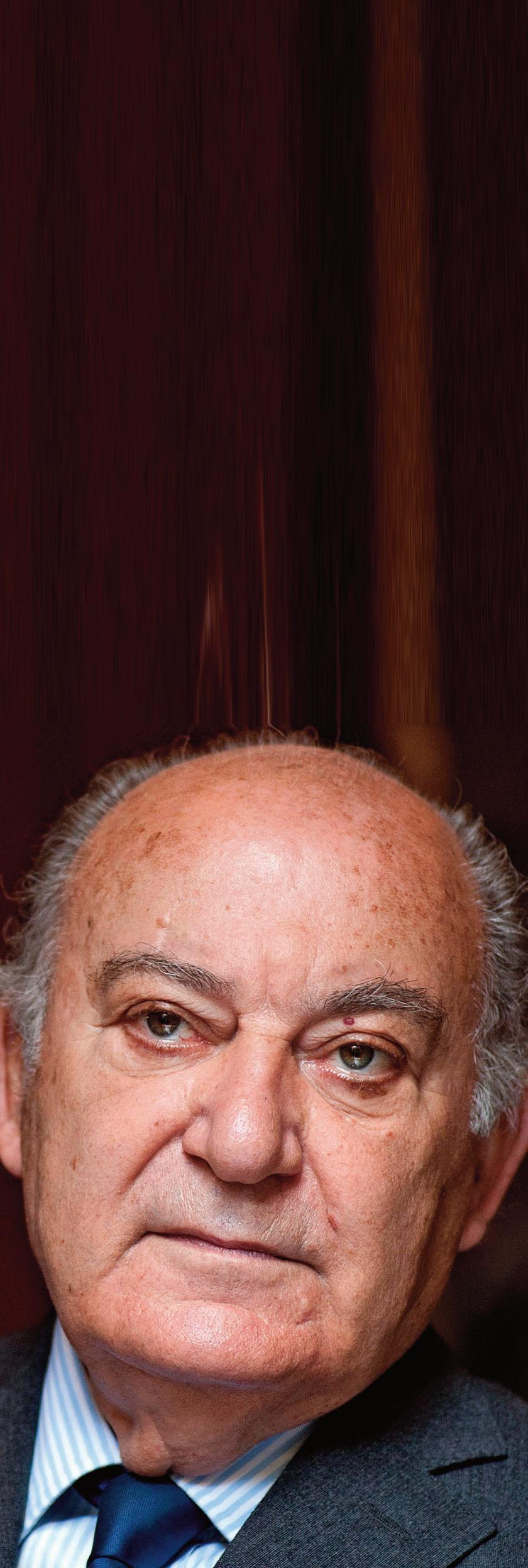
di Federico Serra
In un tempo in cui il cambiamento climatico è entrato con forza nel dibattito pubblico e nei vissuti quotidiani delle comunità, comprendere come la società italiana percepisca e affronti realmente questo fenomeno diventa cruciale. Ne abbiamo parlato con Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione CENSIS e uno dei più autorevoli sociologi italiani, che da oltre sessant’anni interpreta i mutamenti della società con uno sguardo lucido e profondo. In questa conversazione, De Rita ci offre una lettura disincantata ma preziosa della cultura ambientale nel nostro Paese, mettendo in luce le contraddizioni tra opinione e comportamento, la debolezza delle leadership politiche, il ruolo delle giovani generazioni e la centralità dei territori.
Professore, oggi si parla tanto di cambiamento climatico. Ma secondo lei, gli italiani hanno una consapevolezza reale e strutturata del fenomeno o si tratta più di reazioni emotive a eventi estremi?
È più una percezione legata agli eventi. Quando accade qualcosa di estremo, pensiamo sia sintomo di una crisi profonda, ma poi non ci comportiamo di conseguenza. La nostra cultura popolare assorbe l’evento dentro una narrazione tradizionale. A Roma, per esempio, un acquazzone è semplicemente “lo sgrullone”, non una “bomba d’acqua” legata al cambiamento climatico. È la normalità. Ecco perché manca una risposta strutturata: ci lasciamo influenzare dagli eventi, ma non cambiamo i nostri comportamenti.
Dal punto di vista collettivo, c’è maggiore sensibilità ambientale in alcune aree del Paese?
Sicuramente sì, ma solo dove ci sono stati disastri ricorrenti. In Emilia Romagna, ad esempio, la consapevolezza è cresciuta dopo anni di alluvioni. Ma l’Italia è fatta di microclimi, quindi generalizzare è difficile. Ci sono luoghi con maggiore paura, maggiore reattività, e altri dove non c’è alcuna urgenza percepita.
Esiste, secondo lei, una corrispondenza tra la consapevolezza dichiarata e i comportamenti concreti delle
persone?
Il comportamento è rigido, sedimentato da secoli. Non cambia solo perché c’è una grande discussione sul clima. Prendiamo il fumo: è cambiato il numero di sigarette, ma non la struttura del comportamento. Lo stesso vale per l’uso dell’auto: quanti passano all’elettrico per convinzione ecologica e quanti solo perché possono entrare nelle ZTL? Il cambiamento non è spontaneo, ma indotto, e spesso per ragioni strumentali.
Il cambiamento climatico è diventato un elemento strutturale dell’immaginario collettivo?
Non direi. Manca una leadership politico-culturale sul tema. Non abbiamo avuto, per l’ambiente, una figura come Sirchia lo è stato per la lotta al fumo. Edo Ronchi è stato un tentativo, ma non ha lasciato un segno profondo. E senza una personalità forte, l’opinione pubblica non segue. Anche i media enfatizzano l’evento, poi si chiude tutto con un decreto emergenziale e passa la paura.
Le giovani generazioni sembrano più attente al tema ambientale. È solo una fase o può generare un cambiamento strutturale?
Le generazioni producono opinione, ma non strutture. Sono onde emotive. Negli anni Cinquanta c’era la Terza Generazione, poi il Sessantotto, poi il femminismo… Tutto ha lasciato tracce nell’opinione pubblica, ma non nella struttura istituzionale del Paese. Greta Thunberg ha smosso coscienze, ma quanto si è tradotto in scelte politiche concrete? Poco o nulla. È l’effetto “fuoco fatuo”: acceso e spento in poco tempo.
Che ruolo possono avere le comunità locali o i corpi intermedi per trasformare questa sensibilità in azione concreta?
Possono fare molto, ma devono assumersi una responsabilità vera. La gestione dell’ambiente va oltre il movimentismo: occorrono regole, tecnicalità, istituzioni. I movimenti locali possono influenzare una delibera co-
munale, ma per un cambiamento sistemico serve un passaggio istituzionale. Il movimento deve diventare cultura, politica, entrare nelle istituzioni e fare le regole.
Ma esiste questa possibilità, o l’antagonismo che spesso caratterizza l’ambientalismo rischia di renderlo inefficace?
L’antagonismo ha una componente suicida: porta gente in piazza, crea attenzione, ma poi non costruisce nulla. Serve una visione costruttiva, non solo oppositiva. I leader verdi oggi non hanno costruito una vera politica ambientale. È una militanza di appartenenza più che un progetto credibile. Serve qualcuno che sappia governare l’opinione e trasformarla in istituzione.
Quindi, Professore, che speranze abbiamo di costruire un intervento climatico strutturale e duraturo in Italia?
L’unica speranza sono i territori. I sindaci, le regioni: sono loro a vivere gli effetti reali, e possono agire. Ma hanno mille altre priorità, e il clima è orizzontale, non facilmente gestibile da soli. Servirebbe un’“amministrazione speciale” per coordinare le politiche climatiche su vasta scala, come fu la Cassa del Mezzogiorno. Un’alleanza concreta tra territori, non solo progetti isolati. Ma serve potere e responsabilità condivisa, altrimenti si resta nell’occasionalità.
È mancata quindi anche una domanda forte da parte dell’opinione pubblica?
Sì. L’opinione pubblica non è convinta, e quindi non spinge. Senza una base solida di consenso, i politici non si muovono. E quando manca anche una struttura capace di intervenire a livello comprensoriale, il problema si sfalda. Serve una responsabilità chiara, distribuita ma coordinata, se no si resta nell’occasionalità.
CHI È GIUSEPPE DE RITA
Giuseppe De Rita è il fondatore e attuale Presidente della Fondazione CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali), uno dei più importanti istituti di ricerca socioeconomica in Italia. Nato nel 1932, laureato in giurisprudenza, ha contribuito in modo decisivo alla comprensione dell’evoluzione della società italiana nel secondo dopoguerra. Autore di numerosi saggi e rapporti annuali sulla realtà sociale ed economica del Paese, è considerato una delle voci più autorevoli e ascoltate nel dibattito pubblico. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti accademici e istituzionali per la sua attività di ricerca e divulgazione. Con uno stile sempre riflessivo e anticonformista, De Rita continua a offrire chiavi di lettura originali sui grandi temi del nostro tempo, tra cui – oggi – anche l’ambiente e il cambiamento climatico.
di Federico Serra

La crisi climatica rappresenta oggi uno dei più gravi rischi sistemici per la salute globale. Il riscaldamento della temperatura terrestre, l’aumento di eventi meteorologici estremi, l’innalzamento dei mari, la perdita di biodiversità, l’inquinamento atmosferico e idrico non sono solo problemi ambientali: sono determinanti sanitari sempre più centrali. La Planetary Health, o salute planetaria, nasce come risposta integrata a questa complessità crescente. In Italia, una delle voci più autorevoli su questo fronte è quella del professor Walter Ricciardi, docente di Igiene e Sanità Pubblica, Direttore dell’Osservatorio sulla Salute Bene Comune e membro fondatore del Planetary Health Inner Circle, rete internazionale impegnata nella ridefinizione delle politiche sanitarie in chiave climatica, ecologica e sociale e uno dei massimi esperti mondiali di salute pubblica.
Lo abbiamo incontrato per affrontare una delle sfide più cruciali del nostro tempo: proteggere la salute umana in un mondo in rapido mutamento climatico.
Professore, da tempo lei insiste su un concetto che oggi sta diventando centrale nel dibattito scientifico internazionale: la salute non può più essere concepita separatamente dalla salute del pianeta. Può aiutarci a capire cosa significa davvero parlare di Planetary Health?
La Planetary Health, letteralmente “salute planetaria”, è un paradigma che ridefinisce completamente il nostro approccio alla salute pubblica. Significa riconoscere che il benessere umano dipende in modo intrinseco e non negoziabile dall’equilibrio dei sistemi naturali: il clima, la biodiversità, la qualità dell’aria, dell’acqua, dei suoli. Finché distruggiamo questi equilibri, stiamo minando le basi stesse della nostra sopravvivenza. Lo abbiamo visto con la pandemia da COVID-19 – causata da uno spillover zoonotico favorito dalla deforestazione – e lo vediamo ogni anno con l’aumento di eventi climatici estremi. Il punto è che la Planetary Health non è una nuova branca della medicina, ma una cornice etica, scientifica e politica per ripensare il nostro posto nel mondo.
Una visione ampia, che tocca molte dimensioni della società. Come si concretizza, nella pratica, questa connessione tra ambiente e salute?
Si concretizza in molte forme. Pensiamo alla qualità dell’aria: ogni anno muoiono più di sette milioni di persone per malattie legate all’inquinamento atmosferico. Pensiamo al riscaldamento globale: le ondate di calore non sono solo fastidiose, sono letali – soprattutto per bambini, anziani e persone con malattie croniche. E poi ci sono le malattie trasmesse da vettori – come dengue e chikungunya – che si stanno diffondendo in aree dove prima erano sconosciute. Ma gli effetti non sono solo fisici: pensiamo anche alla salute mentale, che viene gravemente intaccata dalla crisi climatica, dalla precarietà ecologica, dalla cosiddetta eco-ansia. Ogni stress ambientale diventa uno stress sanitario e sociale.
Professore, quanto incide oggi la crisi climatica sulla salute pubblica? Siamo di fronte a un’emergenza o a una transizione di lungo periodo?
Direi entrambe le cose. La crisi climatica è già qui e sta già incidendo in modo grave sulla salute pubblica, in Italia come nel resto del mondo. Basta pensare alle ondate di calore: solo in Europa, nel 2022, sono morte oltre 60.000 persone a causa delle temperature estreme. Ma non si tratta solo di caldo. I cambiamenti nei regimi di precipitazione, l’aumento dell’umidità, la desertificazione, la perdita di raccolti e l’insicurezza alimentare sono fattori che colpiscono milioni di persone. Le popolazioni fragili – anziani, bambini, persone con patologie croniche – sono le prime vittime. La crisi climatica non è una questione futura: è una moltiplicatrice di disuguaglianze, una lente che esaspera tutte le vulnerabilità del nostro sistema sanitario.
Molti cittadini fanno ancora fatica a comprendere il nesso tra il clima e la salute. Perché secondo lei?
Perché per decenni ci hanno raccontato che l’ambiente era un ambito separato, una questione per tecnici, per attivisti, non per medici o amministratori. Ma oggi sappiamo, con solide evidenze scientifiche, che il clima è uno dei principali determinanti della salute globale.
Quando aumenta la temperatura terrestre, aumenta la concentrazione di ozono troposferico, che danneggia i polmoni. Quando ci sono incendi boschivi, milioni di particelle tossiche entrano nei nostri organismi. Quando sciogliamo i ghiacci artici, liberiamo agenti patogeni antichi e modifichiamo gli equilibri microbiologici del pianeta. Queste non sono più teorie: sono effetti documentati. Eppure il legame clima-salute è ancora sottovalutato nei media, nei programmi scolastici, nelle agende politiche. Proprio per questo servono nuovi strumenti di alfabetizzazione ecologica e sanitaria, come quelli che stiamo sviluppando con il Planetary Health Inner Circle.
Lei parla spesso di “stress ambientale” come causa diretta di patologie. Ci spiega meglio questo concetto?
Certo. Pensiamo al corpo umano come a un sistema adattativo. Ogni volta che subiamo uno stress – fisico, chimico, termico o psicosociale – il nostro organismo attiva risposte fisiologiche. Se però lo stress è continuo, cronico, eccessivo, il sistema collassa. Ebbene, il cambiamento climatico è un moltiplicatore di stress: genera ansia collettiva (la cosiddetta eco-ansia), indebolisce il sistema immunitario, riduce la qualità del sonno, compromette le funzioni cardiovascolari e cognitive. Ma c’è di più: i cambiamenti climatici stanno alterando la distribuzione delle malattie infettive. Le zanzare che trasmettono dengue, chikungunya e zika sono ormai presenti anche in Italia. Questo è uno degli effetti più insidiosi: il clima sta cambiando la geografia delle malattie.
In questo scenario complesso, quale ruolo giocano le istituzioni sanitarie? Stanno cambiando approccio?
Le istituzioni sanitarie stanno iniziando a comprendere l’urgenza del nesso tra clima e salute, ma il cambiamento è ancora lento. Troppo lento. Il nostro sistema sanitario è stato progettato per gestire la cura, non per prevenire su scala ecologica. Bisogna ripensare l’intero modello: investire sulla sanità pubblica territoriale, creare osservatori locali di impatto climatico-sanitario, integrare le valutazioni ambientali nei Piani sanitari regionali. Il mio lavoro all’Osservatorio sulla Salute Bene Comune va in questa direzione: produrre dati, modelli e raccomandazioni per una sanità integrata nella transizione ecologica. E con il Planetary Health Inner Circle lavoriamo perché anche a livello internazionale si creino linee guida condivise e strumenti di pianificazione climatica in sanità.
Quali sono secondo lei le azioni più urgenti per affrontare la crisi climatica in chiave sanitaria?
Innanzitutto la decarbonizzazione rapida dei trasporti, delle industrie e degli edifici pubblici, con un’attenzione specifica agli ospedali, che sono tra le strutture più energivore. Poi la riforestazione urbana e la creazione di microclimi protettivi nei quartieri più vulnerabili. E poi un grande investimento nella Planetary Health Literacy: dobbiamo rendere consapevoli medici, infermieri, dirigenti pubblici e cittadini del ruolo che la salute ambientale gioca nella nostra quotidianità. E infine, occorre integrare la giustizia climatica con la giustizia sanitaria: chi subisce di più gli effetti del cambiamento climatico spesso ha meno accesso alle cure. È un paradosso che dobbiamo risolvere con politiche mirate e inclusive.
Una riflessione conclusiva, professore. Dove possiamo trovare speranza?
La speranza sta nel fatto che possiamo ancora cambiare rotta. La salute planetaria è una bussola etica e scientifica per orientarci nel caos. E non parlo solo di governi: parlo di scuole, aziende, professionisti, cittadini. Ogni giorno possiamo fare scelte migliori. Ma serve un salto culturale: riconoscere che la salute non è un fatto individuale, ma un bene collettivo, fragile, condiviso. La crisi climatica è anche una grande occasione: per creare città più giuste, stili di vita più sani, relazioni più eque. La vera emergenza è l’inerzia. Ma la vera risorsa è la conoscenza. Usiamola bene.
Walter Ricciardi è professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica del Sacro Cuore. È Direttore dell’Osservatorio sulla Salute Bene Comune, un centro interdisciplinare che promuove politiche sanitarie basate sull’equità, la sostenibilità e l’approccio One Health. A livello internazionale, è membro fondatore e coordinatore del Planetary Health Inner Circle, rete globale che promuove l’integrazione tra salute umana, ambientale e animale. È stato Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, rappresentante italiano presso l’OMS e tra i principali esperti mondiali nel campo della sanità pubblica, dell’health literacy e delle politiche per la transizione ecologica della salute. Autore e consulente di organismi internazionali, è oggi punto di riferimento nella promozione di un nuovo paradigma di salute: integrata, sistemica e orientata al futuro.

Cura l’Oxford handbook of public health practice, pubblicato dalla Oxford University Press, ed è stato componente del National board of medical examiners degli USA.
Nel 2013-2014 ha coordinato su commissione delle Nazioni Unite la prima indagine di analisi comparativa sui rischi professionali del personale del World food program, dell’UNHCR, della Banca Mondiale e del Nel febbraio 2021 Papa Francesco lo nomina membro della Pontificia Accademia per la Vita e nel maggio dello stesso anno è entrato a far parte del comitato scientifico di Santé Publique France, equivalente francese dell’ISS.
È stato Presidente della Federazione Mondiale delle Associazioni di Sanità Pubblica (WFPHA) (20202022) e dell’Associazione Europea di Sanità Pubblica (EUPHA) (2003-2004 e 2010-2014).
È Presidente del Mission Board for Cancer (EC), del Comitato Scientifico della Human Technopole Foundation e dell’European Mission Board for Vaccination.

di Ludovica Serra
Il futuro delle città nel mondo post-pandemico: tra crisi e rinascita urbana. Dieci esempi di città che hanno trovato soluzioni.
Quando, nel 2020, il mondo si è fermato, le città – solitamente simbolo di movimento, densità, interconnessione – sono diventate improvvisamente luoghi di vuoto e silenzio. Le strade, un tempo brulicanti di vita, si sono svuotate; i trasporti pubblici sono diventati simboli di rischio; gli uffici, i centri commerciali, gli spazi pubblici si sono ritrovati inerti. Da allora, ci si interroga sul futuro delle città. La pandemia ha rappresentato soltanto una parentesi oppure ha segnato un punto di svolta nella storia urbana contemporanea?
Secondo Ed Glaeser, autorevole economista urbano dell’Università di Harvard, intervistato dal McKinsey Global Institute, non solo la pandemia ha profondamente alterato le dinamiche urbane, ma ha anche accelerato processi già in corso, rendendo visibili con nuova forza i punti di forza e di fragilità delle città globali.
Il lavoro remoto e la trasformazione degli spazi urbani
Uno dei cambiamenti più immediati e radicali riguarda il lavoro. L’adozione su larga scala dello smart working ha avuto un impatto diretto sulla struttura economica e fisica delle città. Interi quartieri costruiti attorno alla presenza di uffici – basti pensare al Financial District di New York, alla City di Londra, o all’EUR di Roma – hanno perso, nel giro di pochi mesi, il loro ruolo centrale. Questo ha provocato una contrazione dei mercati immobiliari commerciali, un declino nei servizi collegati (dalla ristorazione al commercio), e una ridefinizione delle priorità urbanistiche.
Tuttavia, per Glaeser, non si tratta solo di un problema economico. È anche una sfida creativa. Le città hanno sempre avuto la capacità di adattarsi. Ciò che serve oggi è un processo di riconversione intelligente degli spazi: trasformare uffici vuoti in abitazioni, spazi culturali, luoghi di co-working flessibili. Non si tratta di negare la città come spazio di interazione – anzi – ma
di ripensarla come un ecosistema più fluido e reattivo alle nuove abitudini.
La tentazione della “città dei 15 minuti”: opportunità e rischi
Tra le soluzioni emerse nel dibattito internazionale vi è il concetto, affascinante e largamente promosso, di “città dei 15 minuti”. L’idea è semplice: vivere in quartieri dove ogni servizio essenziale – lavoro, scuola, sanità, commercio, tempo libero – sia raggiungibile a piedi o in bicicletta in un tempo massimo di un quarto d’ora. Un modello pensato per aumentare la qualità della vita, ridurre l’inquinamento, rafforzare la coesione sociale.
Ma Glaeser invita alla cautela. Sebbene il modello abbia senso sul piano ambientale e urbanistico, rischia di produrre effetti collaterali se non viene implementato in modo equo. Le città non sono tutte uguali e, soprattutto, non sono eguali all’interno. Esistono, in molte realtà, quartieri benestanti con alta dotazione di servizi, e zone marginali dove mancano persino le infrastrutture di base. Senza un intervento pubblico deciso, la “città dei 15 minuti” rischia di diventare un privilegio per pochi, rafforzando le disuguaglianze anziché colmarle.
Le disuguaglianze urbane e l’ingiustizia infrastrutturale
Uno dei contributi più interessanti dell’analisi di Glaeser riguarda proprio il concetto di “disuguaglianza infrastrutturale”. Durante la pandemia, è emerso con chiarezza come alcuni gruppi sociali – spesso minoranze etniche o popolazioni a basso reddito – vivano in quartieri più esposti all’inquinamento, con strade in cattive condizioni, scuole meno attrezzate, e servizi sanitari più distanti o carenti. Queste disuguaglianze materiali si riflettono in vulnerabilità sociali che la crisi sanitaria ha amplificato.
Il futuro delle città, allora, non potrà essere immaginato senza una radicale politica di riequilibrio infrastrutturale. Occorre investire nei quartieri periferici, migliorare la qualità dell’abitare, ridurre le barriere nei trasporti, garantire accesso equo alla connettività digitale. Le città devono diventare piattaforme di emancipazione, non luoghi di esclusione.
Le città globali come laboratori di innovazione
Non mancano, nel panorama internazionale, esempi virtuosi. Singapore ha saputo integrare tecnologia e pianificazione per creare una città digitale, verde e altamente connessa. Seoul ha trasformato antiche infrastrutture in parchi urbani intelligenti, come il Cheonggyecheon, mentre Medellín in Colombia ha promosso una rigenerazione urbana basata sulla mobilità sostenibile e la cultura comunitaria. Queste esperienze mostrano che è possibile ripensare la città senza rinunciare alla densità, ma rendendola più inclusiva e orientata alla qualità della vita.
Per le città occidentali, afferma Glaeser, è il momento di apprendere da questi modelli: non con spirito imitativo, ma con apertura all’innovazione. Ogni città ha la sua identità, ma tutte condividono la necessità di adattarsi ai mutamenti ambientali, tecnologici e demografici del nostro tempo.
Verso una nuova urbanità: il ruolo della politica e della comunità
Alla fine, il nodo cruciale è politico. Le scelte che verranno fatte nei prossimi anni – su trasporti, edilizia, ambiente, salute pubblica – determineranno il tipo di città in cui vivremo per generazioni. È necessario superare le visioni settoriali, promuovere una governance urbana integrata, partecipativa, in grado di coinvolgere cittadini, amministrazioni, imprese e istituzioni accademiche.
Glaeser ricorda che le città sono state, nella storia, straordinari motori di progresso e creatività. Anche oggi, dopo una delle crisi più dure del secolo, possono tornare a esserlo. A condizione che si abbia il coraggio di cambiare davvero: non tornando indietro, ma guardando avanti.
8 ESEMPI DI CITTÀ NEL MONDO CHE STANNO AFFRONTANDO IN MODO INNOVATIVO LE SFIDE DEL POST-PANDEMIA, CIASCUNA CON STRATEGIE DISTINTIVE PER RIPENSARE URBANISTICA, INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA
1. Parigi – Il modello della “città dei 15 minuti”
Sotto la guida della sindaca Anne Hidalgo, Parigi è diventata il simbolo internazionale della “ville du quart d’heure”. Il piano prevede la riconversione degli spazi pubblici, la riduzione del traffico automobilistico, l’aumento delle piste ciclabili e la promozione di scuole, negozi, centri sanitari e culturali a distanza di una breve passeggiata. L’obiettivo è una città più vivibile, meno inquinata e più equa.
2. Barcellona – Superilles e urbanismo tattico
Barcellona ha avviato il progetto delle “superilles” (superblocchi), che trasformano insiemi di isolati in quartieri a misura d’uomo, chiusi al traffico di attraversamento, con spazi verdi, panchine e aree gioco. Dopo il COVID, il comune ha accelerato l’espansione delle superilles per favorire la socialità e la salute urbana.
3. Singapore – Pianificazione integrata e città intelligente
Singapore è un esempio di città-Stato che unisce pianificazione a lungo termine, tecnologia e sostenibilità. Ha investito in smart city, monitoraggio ambientale, edilizia pubblica di alta qualità e gestione intelligente dei trasporti. Dopo la pandemia ha potenziato il “Work Near Home”, per creare spazi di co-working nei quartieri e ridurre i pendolarismi.
4. Medellín – Inclusione urbana e rigenerazione sociale
Una delle città più trasformate al mondo negli ultimi 20 anni, Medellín ha usato la pandemia come occasione per accelerare l’urbanizzazione inclusiva: ha promosso mobilità elettrica, funivie urbane per connettere i quartieri periferici, scuole e biblioteche nei quartieri marginali. È un esempio di come la città possa ridurre le disuguaglianze attraverso l’architettura e i servizi pubblici.
5. Milano – Transizione ecologica e quartieri policentrici
Milano ha intrapreso un percorso di transizione verso una città più verde e policentrica, puntando su spazi pubblici riconvertiti, mobilità ciclabile e coesione sociale. Il piano “Milano 2030” prevede un modello di città compatta, con ogni quartiere come un piccolo ecosistema urbano autosufficiente. Durante e dopo la pandemia, la città ha trasformato decine di chilometri di strade in percorsi pedonali e ciclabili.
6. New York – Rigenerazione degli spazi pubblici e giustizia ambientale
Dopo l’impatto devastante del COVID-19, New York ha investito nella riqualificazione di strade, piazze e parchi. Il progetto “Open Streets” ha aperto centinaia di chilometri di vie al solo traffico pedonale. Inoltre, con il programma “Green New Deal for NYC”, la città punta a una transizione energetica con attenzione alle comunità più vulnerabili.
7. Tokyo – Sicurezza, densità efficiente e resilienza tecnologica
Tokyo ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, grazie a una densità abitativa ben gestita e a una cultura del rispetto delle regole. La città ha sviluppato politiche per l’abitare flessibile, sistemi digitali per la gestione della mobilità e un forte investimento nella sanità pubblica di prossimità.
8. Copenaghen – Leadership climatica e qualità della vita
La capitale danese è all’avanguardia per sostenibilità urbana. Ha puntato su trasporto ciclabile, gestione intelligente dell’acqua, edifici a basse emissioni e resilienza climatica. Dopo la pandemia, ha investito nel benessere psicosociale e nella promozione della salute mentale attraverso spazi verdi e servizi comunitari.



Nasce Health City Managers Alumni, una rete professionale e culturale che rappresenta uno spin-off strategico dell’Health City Institute, ideata per valorizzare il capitale umano formato dai corsi di alta formazione “Sport and Health City Manager” promossi da ANCI insieme all’Health City Institute e a numerosi partner istituzionali e accademici.
Come evidenziato da Roberto Pella, Vicepresidente ANCI con delega alla salute “… questa community costituisce un tassello fondamentale nella costruzione di una nuova governance del la salute nelle città. In un contesto urbano sempre più complesso e interconnesso, diventa indispensabile investire nella formazione di amministratori e dirigenti pubblici capaci di integrare salute, prevenzione, ambiente ed equità nelle politiche locali.”
L’Health City Managers Alumni non è soltanto un luogo di aggiornamento o condivisione, ma si configura come una vera e propria piattaforma nazionale di innovazione civica e di advocacy per la promozione della salute come bene comune, in linea con i principi del Manifesto sulla salute nelle città.
Secondo Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute, la community rappresenta “l’evoluzione naturale di un percorso formativo che ha saputo mettere al centro il legame inscindibile tra città, salute e responsabilità pubblica”. L’obiettivo è costruire un network stabile di professionisti capaci di interpretare la complessità urbana attraverso una visione sistemica fondata su dati, partecipazione, pianificazione e innovazione.”
Una rete dinamica e strutturata
La rete Health City Managers Alumni è aperta a tutti i diplomati dei corsi di alta formazione che abbiano completato il percorso con il rilascio dell’attestato finale. L’adesione è gratuita e regolata da criteri di selezione definiti dal Comitato Alumni, l’organo di
governance della community, composto da rappresentanti dell’Health City Institute, di ANCI, del mondo accademico e da membri eletti tra gli Alumni stessi.
Le attività principali della rete includono:
• Annual Meeting degli Health City Managers, con tavole rotonde, workshop e scambio di buone pratiche territoriali;
• Webinar tematici su salute urbana, sport, governance e pianificazione partecipata;
• Una piattaforma digitale collaborativa per il networking continuo e la condivisione di risorse;
• La raccolta e pubblicazione di progetti, policy locali e casi studio innovativi.
Visibilità e riconoscimento
Gli Alumni riceveranno un badge ufficiale e potranno utilizzare il logo “Health City Managers Alumni” in progetti approvati e coerenti con i valori della rete, rafforzando così la propria identità professionale e il legame con il network nazionale.
Una community per il futuro delle città
La nascita di Health City Managers Alumni rafforza l’impegno dell’Health City Institute per una salute urbana che sia bene comune, integrando sport, ambiente, inclusione sociale e prevenzione. Con una durata illimitata e un funzionamento dinamico, questa community si candida a diventare un punto di riferimento strategico per le politiche urbane della salute, non solo in Italia, ma anche nel contesto europeo e internazionale.
La sfida che gli Health City Managers Alumni raccolgono è chiara: trasformare le città in veri e propri ecosistemi di benessere, equità e sostenibilità per tutte le comunità.

di Ludovica Serra
Ancona è una città che vive di luce propria, affacciata sul mare Adriatico e plasmata nei secoli da culture, commerci e migrazioni. Situata in una posizione strategica, nel cuore della costa marchigiana, il suo stesso nome – Ankon, “gomito” in greco – richiama la sua conformazione geografica, che le consente di essere una delle poche città italiane dove si può ammirare il sole sorgere e tramontare sul mare.
Fondata dai Greci siracusani nel 387 a.C., Ancona è stata poi colonia romana e per secoli uno snodo vitale per i traffici tra Occidente e Oriente. L’Arco di Traiano, risalente al II secolo d.C., è una delle testimonianze più significative della sua antica centralità nell’Impero. Durante il Medioevo e il Rinascimento, Ancona divenne una Repubblica marinara, un centro commerciale fiorente e cosmopolita, con ambasciatori, mercanti e viaggiatori provenienti dal Mediterraneo orientale e dai Balcani. Le tracce di questo passato vivono ancora oggi nei vicoli del centro storico, nella Loggia dei Mercanti, nei palazzi nobiliari e nelle chiese che costellano il paesaggio urbano.
La sua cultura marittima si fonde con una vocazione all’accoglienza e al dialogo. L’arte, la musica, il teatro e le istituzioni culturali della città – dal Teatro delle Muse alla Mole Vanvitelliana – continuano a riflettere un’identità aperta, in continua evoluzione. Ma Ancona è anche innovazione, ricerca, università, porto e industria. Ed è proprio a partire da questa combinazione unica di storia, logistica e impegno civile che la città si è ritrovata, nel 2024, al centro del mondo.
ANCONA, MODELLO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Ancona non è solo una città di storia e cultura: è anche un nodo strategico per il commercio e lo sviluppo industriale dell’Italia centrale e dell’area adriatica. Il suo porto internazionale, tra i più attivi del Paese per traffico merci e passeggeri, rappresenta da sempre una porta aperta verso i Balcani, l’Egeo e il Medio Oriente,
e si inserisce pienamente nelle direttrici logistiche della Macroregione Adriatico-Ionica.
Accanto alla vocazione portuale, Ancona ha sviluppato nel corso del Novecento un sistema produttivo industriale e manifatturiero fortemente legato ai settori della cantieristica navale, della meccanica di precisione, dell’agroalimentare e dell’innovazione tecnologica. La presenza storica di Fincantieri, con uno dei poli cantieristici più importanti d’Europa, ha contribuito a generare un indotto di alta specializzazione e competenze, che ancora oggi costituiscono un asset competitivo per l’intera Regione Marche.
Oggi, con l’espansione della Zona Logistica Semplificata e la sinergia tra porto, interporto e retroporto, Ancona si propone come hub logistico e industriale integrato, in grado di attrarre investimenti, favorire l’export e potenziare la connettività tra l’Italia, l’Europa orientale e il Mediterraneo. Il tutto, in dialogo con il sistema universitario e con le politiche di sviluppo sostenibile promosse a livello locale.
Il G7 Salute 2024 ad Ancona: salute globale, c omunità e visione
Dal 9 all’11 ottobre 2024, Ancona ha ospitato la riunione dei Ministri della Salute del G7, evento di portata mondiale che ha riunito i leader sanitari dei principali paesi industrializzati, insieme a rappresentanti dell’OMS, della FAO, dell’OCSE e di altre agenzie internazionali.
I lavori del summit si sono articolati attorno a tre grandi direttrici:
Salute globale e preparazione alle pandemie; Invecchiamento attivo e innovazione sanitaria; Approccio One Health, che collega salute umana, animale e ambientale.
Il Ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, ha richiamato l’attenzione su una delle sfide cruciali del nostro tempo:
“La resistenza antimicrobica è un nemico silenzioso. Si nasconde nell’ombra, ci minaccia e rischia di vanificare i progressi della medicina moderna. È la nuova pandemia.”
Nel suo intervento, Schillaci ha anche valorizzato la scelta di Ancona come sede:
“Questa città è un simbolo di eccellenza sanitaria e di integrazione tra ospedale e territorio, una direzione che dobbiamo rafforzare in tutto il Paese.”
Il significato per la città: “Un investimento politico e simbolico”
Per Ancona, l’evento è stato molto più di un appuntamento istituzionale. Il Sindaco Daniele Silvetti, nel suo discorso di apertura, ha dichiarato:
“Il G7 Salute è un momento storico per Ancona, per gli anconetani e per la Regione Marche. È un investimento politico sulla città, sul suo rilancio e sulla percezione nuova di una città che si apre. Non vogliamo che il G7 resti confinato in una torre d’avorio: deve ispirare progetti, cultura, partecipazione.”
E così è stato. Accanto al vertice ufficiale, la città ha ospitato l’Extra G7 Salute, un festival della salute aperto alla cittadinanza, con oltre 50 eventi, 400 relatori da 7 nazioni e una partecipazione di oltre 6.000 persone. Convegni, laboratori, mostre, incontri nelle scuole e nei quartieri hanno reso visibile e tangibile il messaggio del G7: la salute come bene comune, da costruire insieme.
Il sindaco Silvetti ha sottolineato l’importanza di non aver voluto confinare i lavori del G7 in una “torre d’avorio”, ma di renderli ispiratori di iniziative aperte alla cittadinanza.
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della quale il sindaco di Ancona Daniele Silvetti è Vice Presidente vicario, ha avuto un ruolo significativo nel contesto del G7 Salute 2024 ad Ancona. In particolare, ANCI Marche ha organizzato un convegno intitolato “Il ruolo dei territori per la salute dei cittadini”, svoltosi al Ridotto del Teatro delle Muse. Questo evento ha rappresentato un momento di dialogo volto a promuovere l’integrazione sociosanitaria all’interno della regione .
Un ponte tra tradizione e futuro
Ancona ha dimostrato di essere molto più di una cornice logistica: è stata un soggetto attivo, capace di interpretare le sfide del futuro senza dimenticare le sue radici. In un tempo segnato da crisi globali e trasformazioni profonde, ha saputo offrire una prospettiva di cooperazione, resilienza e innovazione.
Oggi, grazie anche al ruolo avuto nel G7, la città rilancia il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale. Un ruolo che parte dalle sue basi storiche – la cultura, il porto, la vocazione mediterranea – e si proietta in avanti, verso un modello urbano integrato, sano, inclusivo e sostenibile
Una città che parla al mondo
In pochi giorni, Ancona è diventata un simbolo di diplomazia della salute, un luogo dove le istituzioni, la scienza, le comunità e i cittadini si sono incontrati per pensare insieme il domani. Ma il G7 è stato solo l’inizio: oggi, la città è pronta a consolidare questo percorso, con nuovi progetti, reti internazionali, e un’idea di salute che non è solo assenza di malattia, ma qualità della vita, giustizia sociale, ambiente e partecipazione.
Perché, come ha ricordato ancora il sindaco Silvetti, “Ancona è sempre stata una città di mare, e come tutte le città di mare ha lo sguardo aperto. E oggi più che mai guarda avanti.”


Kalundborg, una cittadina danese situata a circa 100 km da Copenaghen, è riconosciuta a livello mondiale come il primo e più emblematico esempio di simbiosi industriale. Negli anni ‘60, senza una pianificazione centralizzata, le aziende locali iniziarono spontaneamente a collaborare, condividendo risorse, energia e sottoprodotti. Questa cooperazione ha dato vita a un ecosistema industriale interconnesso, dove gli scarti di un’azienda diventano risorse per un’altra, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza economica.
Cos’è la Simbiosi Industriale?
La simbiosi industriale è una strategia che promuove la collaborazione tra diverse imprese per ottimizzare l’uso delle risorse. Attraverso lo scambio di materiali, energia, acqua e sottoprodotti, le aziende possono ridurre i rifiuti, diminuire i costi operativi e migliorare la sostenibilità ambientale. Questo approccio si ispira agli ecosistemi naturali, dove nulla viene sprecato e ogni elemento ha una funzione all’interno del sistema.
La Rete di Kalundborg
Il cuore della simbiosi industriale di Kalundborg è rappresentato da una rete di aziende che collaborano attivamente:
• Asnæs Power Station: una centrale termoelettrica che fornisce vapore e calore residuo ad altre industrie e alla rete di teleriscaldamento cittadina.
• Statoil Refinery: una raffineria di petrolio che riceve vapore dalla centrale e fornisce gas di scarico utilizzato come combustibile.
• Novo Nordisk: azienda farmaceutica che utilizza il vapore per i suoi processi produttivi e fornisce fanghi biologici come fertilizzanti per l’agricoltura.
• Gyproc: produttore di cartongesso che utilizza il gesso derivante dalla desolforazione dei fumi della centrale.
• Kalundborg Municipality: l’amministrazione comunale che supporta e coordina le iniziative di simbiosi industriale.
Queste interazioni hanno portato a oltre 30 scambi di materiali e risorse, creando un sistema efficiente e sostenibile.
Benefici Ambientali ed Economici
L’approccio adottato a Kalundborg ha generato significativi vantaggi:Riduzione delle emissioni: la cooperazione tra le aziende ha portato a una diminuzione delle emissioni di CO₂ e altri inquinanti.
• Risparmio energetico: l’utilizzo condiviso di energia e calore ha migliorato l’efficienza energetica complessiva.
• Valorizzazione degli scarti: i sottoprodotti di un’azienda diventano materie prime per un’altra, riducendo la necessità di smaltimento.
• Benefici economici: le aziende coinvolte hanno registrato risparmi significativi nei costi operativi e nuove opportunità di business.
Un Modello Replicabile
Il successo di Kalundborg ha ispirato numerose iniziative simili in tutto il mondo. La chiave del successo risiede nella collaborazione volontaria tra le aziende, nella fiducia reciproca e nella visione condivisa di sostenibilità. Questo modello dimostra che la simbiosi industriale non solo è possibile, ma anche vantaggiosa sia dal punto di vista ambientale che economico.

di Federico Serra
Delegato Health City Institute – OECD Urban Days 2025

le grandi sfide ambientali, sociali e sanitarie del nostro tempo. Con questo spirito si è svolta a Parigi, nella sede dell’OCSE, la prima edizione degli OECD Urban Days, dal 14 al 17 aprile 2025.
Un evento che ha riunito leader politici, urbanisti, funzionari delle Nazioni Unite e della Commissione Europea, esperti di economia circolare, finanza urbana e salute pubblica, in una convergenza di saperi e prospettive per immaginare, progettare e finanziare le città del futuro.
Tra i cento esperti invitati, anche l’Health City Institute, in rappresentanza dell’Italia, ha avuto l’onore di contribuire alle riflessioni sul ruolo della salute nelle trasformazioni urbane. Una presenza che conferma l’importanza crescente della salute urbana nelle agende internazionali.
Quattro giornate per ridefinire il futuro delle città
Ogni giornata degli Urban Days è stata dedicata a una dimensione specifica del cambiamento urbano: inclusione, economia circolare, sostenibilità e finanziamento. Una narrazione articolata che ha permesso di legare l’azione locale alle grandi sfide globali, dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile all’Accordo di Parigi.
Giorno 1 – Cities for All: città inclusive per tutte le età
Il 14 aprile si è aperto con la 7ª riunione dei Sindaci Campioni per la Crescita Inclusiva, presieduta da Matúš Vallo, sindaco di Bratislava. I sindaci hanno lanciato un appello per una maggiore equità urbana, promuovendo politiche su mobilità, accesso all’abitare, resilienza locale e coesione intergenerazionale.
“Le città devono diventare luoghi in cui tutti possano vivere con dignità, dal bambino all’anziano. Non possiamo progettare spazi pubblici che escludono o
digitali e inclusivi.
Giorno 2 – Circular Cities: l’economia del futuro è rigenerativa
Il 15 aprile ha portato al centro il tema della circolarità urbana, con il lancio del report OCSE “Circular Economy in Cities and Regions of the EU”, che documenta le pratiche circolari di oltre 60 territori europei. La masterclass di Carlos Moreno, ideatore del modello della “città dei 15 minuti”, ha segnato un momento ispiratore. “La prossimità è una rivoluzione culturale prima ancora che urbanistica. Le città devono rispondere ai bisogni quotidiani delle persone senza costringerle a muoversi, inquinare, consumare tempo e salute”, ha affermato
Approcci innovativi alla gestione delle risorse, alla costruzione sostenibile e alla circolarità dell’acqua sono stati discussi nei workshop pomeridiani, offrendo spunti operativi per trasformare l’urbanizzazione in un processo rigenerativo.
Giorno 3 – Sustainable Cities: SDGs e leadership territoriale
Il 16 aprile si è concentrato sulla localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con UN Habitat. In particolare, si è discusso del programma TACAR (Territorial Approach to Climate Action and Resilience) e delle esperienze locali che stanno guidando la transizione ecologica.
Il caso di Yokohama, in Giappone, ha dimostrato come sia possibile integrare pianificazione urbana, infrastrutture verdi e coinvolgimento della cittadinanza per costruire resilienza climatica a scala urbana.
“Non possiamo più attendere una transizione dall’alto. Le città stanno guidando la rivoluzione climatica attraverso il territorio, le comunità e l’innovazione sociale”, ha affermato Lamia Kamal-Chaoui, direttrice


nodo centrale del finanziamento urbano. Due nuovi rapporti OCSE hanno fornito scenari e strumenti per mobilitare risorse pubbliche e private per infrastrutture sostenibili, digitali e inclusive.
La sessione “Financing the Cities of Tomorrow: A Shared Responsibility” ha ribadito il bisogno di un partenariato multilivello, con il coinvolgimento strategico di governi, istituzioni finanziarie e investitori.
“L’80% degli edifici che useremo nel 2050 esiste già. Il futuro si gioca nella rigenerazione e nella riqualificazione, non nella sola espansione”, ha dichiarato Renata Haseth di Bankers without Boundaries.
Anche il tema del City-to-City Finance ha suscitato grande interesse, con esempi di cooperazione tra città europee e latinoamericane per attrarre capitali e fondi multilaterali attraverso progetti condivisi e reti territoriali.
Il focus dell’Health City Institute: salute urbana come bene comune
Nel quadro degli Urban Days, l’Health City Institute ha portato il proprio contributo nel dibattito su salute, ambiente e pianificazione urbana. Abbiamo illustrato i contenuti dei Piani Urban Health sviluppati in Italia, con un approccio integrato alla qualità dell’aria, al rumore, alla fragilità sociale, all’urbanizzazione non pianificata e alla promozione di stili di vita sani.
“Non c’è sostenibilità urbana senza salute. La salute deve diventare un criterio guida della pianificazione urbana, non un effetto collaterale da mitigare a posteriori”, è stato il messaggio al centro del nostro intervento.
Il concetto di salute come infrastruttura urbana, centrale nelle politiche promosse dal nostro Istituto, ha suscitato particolare interesse tra le delegazioni nordiche, latinoamericane e giapponesi, aprendo a future collabo-
stato nominato membro dello steering group dei Champion Mayors for Inclusive Growth, accanto ai sindaci di Parigi, Tokyo, Bruxelles, Glasgow, Braga e Renca.
Nel corso della sessione Cities for All Ages, Lo Russo ha evidenziato le sfide legate all’invecchiamento demografico e alla disuguaglianza nei contesti urbani:
“Torino ha vissuto significativi cambiamenti economici e demografici, tra cui un rapido invecchiamento della popolazione. Con un’età superiore alla media nazionale italiana, quella demografica è una delle crisi che come amministrazione ci troviamo oggi ad affrontare.”
Ha poi aggiunto:
“Per rendere le città davvero competitive, servono investimenti sociali a lungo termine, maggiore integrazione delle politiche sociali e sanitarie, e un ripensamento generale dei temi relativi all’immigrazione e alla partecipazione attiva dei cittadini.”
Il suo contributo è stato particolarmente apprezzato nel panel su mobilità urbana inclusiva e resiliente.
Conclusioni: una nuova agenda urbana per il XXI secolo
Gli OECD Urban Days 2025 ci lasciano un messaggio potente: le città non sono solo luoghi da amministrare, ma sistemi complessi da ripensare alla luce dei cambiamenti globali.
Le parole chiave che attraversano l’evento – inclusione, circolarità, salute, finanza – non sono compartimenti stagni, ma dimensioni interconnesse di una sfida unica: rendere le città più giuste, più verdi, più sane.
Parigi ha dimostrato che è possibile unire pensiero strategico, azione locale e cooperazione internazionale. Adesso tocca a noi, in ogni città, trasformare le idee in politiche concrete.

di Federico Serra e Ranieri Guerra
Quando il termometro supera i 35 gradi e l’asfalto sembra ribollire sotto i piedi, nelle città l’estate non è solo una stagione: è un’emergenza. Mentre le campagne si lasciano accarezzare dalla brezza e il calare del sole porta un po’ di ristoro, nei centri urbani la temperatura continua a salire anche dopo il tramonto, in una spirale di calore che rende le notti insonni, gli ospedali affollati e la qualità della vita sempre più a rischio.
Questo fenomeno ha un nome preciso: isola di calore urbana, in inglese Urban Heat Island (UHI). Ed è uno degli effetti più tangibili – e sottovalutati – del cambiamento climatico, dell’urbanizzazione selvaggia e di un modello di sviluppo che ha spesso dimenticato la natura nella pianificazione delle città.
Cos’è un’isola di calore urbana e perché ci riguarda tutti
L’isola di calore urbana è una condizione in cui una città, o una sua parte, registra temperature sensibilmente più alte rispetto alle zone rurali circostanti. Si parla spesso di differenze di 3-5 gradi, ma in alcune città, durante le ondate di calore, si possono raggiungere anche 7-10 gradi in più. E la tendenza è in aumento.
Le cause sono molteplici ma interconnesse:
• Materiali artificiali come cemento, asfalto e mattoni assorbono e trattengono calore molto più della vegetazione o dei suoli naturali;
• Assenza di ombra e verde urbano, che favorirebbero l’evapotraspirazione, ovvero la capacità delle piante di “raffreddare” l’aria;
• Uso intensivo di energia, soprattutto per climatizzatori e veicoli, che rilasciano calore residuo;
• Scarsa ventilazione dovuta alla densità edilizia e alla mancanza di corridoi d’aria;
• Urbanizzazione incontrollata, che impermeabilizza i suoli e impedisce la regolazione naturale della temperatura.
In sostanza, le città si comportano come gigantesche spugne di calore: si caricano durante il giorno e rilasciano energia termica lentamente di notte, impedendo il naturale raffreddamento notturno.
Italia rovente: i casi di Milano, Roma, Napoli
Il fenomeno non risparmia nessuna città italiana, anzi. I centri urbani del nostro Paese sono tra i più colpiti in Europa, complici la morfologia storica, la carenza di strategie urbane climatiche e la crescente urbanizzazione.
Milano, ad esempio, registra costantemente differenze di temperatura tra il centro e le aree verdi periferiche. Uno studio del Politecnico ha evidenziato che la zona di Piazza San Babila può essere fino a 6°C più calda rispetto al Parco Nord o al Parco della Martesana. Il centro, denso e cementificato, trattiene calore in modo massiccio, mentre le aree verdi agiscono come polmoni termici.
Roma, la “città eterna”, è anche una delle più calde d’Europa. I sampietrini e i monumenti storici assorbono il sole estivo, mentre l’espansione urbanistica a macchia d’olio ha ridotto le aree agricole e boschive della periferia. Zone come il quartiere Appio o la Tiburtina risultano bollenti, mentre il Parco della Caffarella o l’Appia Antica rappresentano vere oasi climatiche.
A Napoli, i quartieri storici e i rioni popolari densamente edificati – come la Sanità o il centro antico –soffrono di carenza di verde e ventilazione, mentre le zone collinari e i parchi (Capodimonte, Posillipo) offrono rifugio. Qui, la disuguaglianza climatica è particolarmente evidente: chi vive in aree più povere ha meno accesso a raffrescamento e spazi verdi.
Impatto sulla salute: chi paga il prezzo più alto del caldo urbano?
Le isole di calore non sono solo un fastidio estivo.
Sono una vera minaccia per la salute pubblica, soprattutto per i soggetti più vulnerabili.
• Gli anziani soffrono per l’incapacità del loro organismo di termoregolarsi;
• I bambini sono più esposti alla disidratazione e ai colpi di calore;
• Le persone fragili o malate (cardiopatici, diabetici, asmatici) vedono aggravarsi le loro condizioni;
• I lavoratori all’aperto, come fattorini, muratori o addetti alla logistica, sono esposti a stress termici insostenibili.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le ondate di calore hanno provocato fino a 18.000 morti premature solo in Europa nell’estate 2022, con un impatto significativo proprio nelle aree urbane. E la frequenza di questi eventi estremi è destinata ad aumentare.
Soluzioni e buone pratiche: come le città possono rispondere
Non tutto è perduto. Molte città stanno adottando misure efficaci per contrastare le isole di calore, ridisegnando lo spazio urbano in chiave climatica.
Rinverdire le città
La strategia più semplice e potente: piantare alberi, creare tetti verdi, aumentare la copertura vegetale. Gli alberi abbassano la temperatura grazie all’ombreggiamento e all’evaporazione dell’acqua attraverso le foglie.
• Parigi ha avviato il piano “Oasis”, trasformando i cortili scolastici in microclimi verdi con alberi, fontane e superfici permeabili, accessibili anche al pubblico durante le estati calde.
• Bologna partecipa al progetto europeo GAIA per mappare il microclima urbano e pianificare interventi verdi mirati. Il Comune ha anche attivato un “Piano del verde urbano” per aumentare la superficie forestale cittadina.
Materiali e superfici riflettenti
Le “cool surfaces” sono pavimentazioni e tetti chiari, capaci di riflettere la luce solare invece di assorbirla.
• New York ha tinteggiato di bianco migliaia di tetti piani negli ultimi anni per ridurre il calore assorbito.
• A Londra, ogni nuovo progetto edilizio deve dimostrare impatto positivo sul microclima, attraverso materiali riflettenti, alberature e ventilazione.
Acqua e ventilazione naturale
Introdurre l’acqua in città (fontane, canali, laghetti) aiuta a raffrescare l’ambiente urbano. Anche aprire corridoi per la ventilazione naturale, evitando “effetti canyon” tra palazzi, è strategico.
• Freiburg, in Germania, ha sviluppato un piano regolatore climatico che preserva le correnti d’aria naturali e integra la rete idrica nella progettazione urbana.
Diritto alla freschezza: verso un nuovo concetto di equità urbana
Affrontare le isole di calore urbane significa ripensare la giustizia urbana e ambientale. Le zone più calde spesso coincidono con le più povere, le meno servite, le più abbandonate.
Chi ha meno ha anche meno possibilità di difendersi dal caldo: meno accesso a spazi verdi, meno possibilità di usare condizionatori, meno tempo per fuggire verso luoghi freschi. La lotta contro il caldo urbano è anche una lotta per l’equità, la salute e la dignità.
Conclusione: rinfrescare il futuro
“La città che scotta” non è una metafora esagerata, ma una realtà con cui dovremo convivere ancora a lungo, se non cambiamo rotta. Ma la buona notizia è che le soluzioni sono a portata di mano: servono visione, investimenti e coraggio politico. Serve un’urbanistica nuova, che metta la salute, il verde, l’ombra e la resilienza climatica al centro dei piani regolatori.
Raffrescare la città non è solo un obiettivo ambientale. È un diritto di cittadinanza, un’azione di cura collettiva, un atto di giustizia verso le generazioni presenti e future.

&
Periodo: maggio 2025 | Campione: 1.200 cittadini italiani | Metodo: CATI/CAWI
1. Percezione della gravità del cambiamento climatico
• Totale:
•• Molto seria: 82%
•• Abbastanza seria: 12%
•• Poco rilevante: 6%
Indice generazionale:
Fascia d’età Molto seria
18-34 anni 90%
35-54 anni 82%
55+ anni 74%
2. Cause percepite del cambiamento climatico
• Causato da attività umane: 67%
• Combinazione di cause naturali e antropiche: 21%
• Fenomeno naturale: 12%
Indice generazionale:
Fascia d’età Causa antropica
18-34 anni 78%
35-54 anni 66%
55+ anni 58%
3. Preoccupazioni principali (risposte multiple)
Impatto climaticoTotale 18-34 35-54 55+
Ondate di calore estremo
Siccità e crisi idriche
Eventi estremi (frane, alluvioni)
Aumento del costo del cibo
Malattie da vettori (zanzare)
4. Comportamenti sostenibili adottati
Comportamento Totale 18-34 35-54 55+
Raccolta differenziata 84%
Uso ridotto dell’auto privata
Acquisto a km zero/ biologici
Installazione impianti rinnovabili
5. Responsabilità principali percepite
Attore responsabile
e istituzioni
Grandi imprese
6. Disponibilità personale al cambiamento
Scelta
Pagare di più per prodotti
7. Valutazione delle politiche italiane sul clima
• L’Italia sta facendo troppo poco: 71%
• In linea con l’Europa: 20%
• Impegno positivo: 9%
Indice generazionale:
Fascia d’età “Fa troppo poco”
18-34 78%
35-54 70%
55+ 65%
8. Fiducia nei giovani e nella scienza
Opinione Totale 18-34 35-54 55+ I giovani sono più
nella scienza
Conclusioni
Il sondaggio mostra un’Italia attenta e preoccupata per i cambiamenti climatici. La grande maggioranza della popolazione riconosce l’urgenza del problema, soprattutto i giovani. Tuttavia, accanto alla consapevolezza, emergono frustrazione e senso di impotenza, legati alla percezione che le scelte individuali non bastino.
I cittadini chiedono più coraggio alle istituzioni e alle imprese. La fiducia nella scienza è alta, ma serve una governance più incisiva, accompagnata da strumenti che facilitino comportamenti sostenibili.
Voci dai cittadini
“Mi sento impotente. Faccio la raccolta differenziata, evito l’auto quando posso, ma ho la sensazione che non sia abbastanza.”
— Luca, 32 anni, Bologna
“I miei figli mi chiedono se avranno un futuro su questo pianeta. Non so cosa rispondere.”
— Giulia, 45 anni, Napoli
“È frustrante vedere che le grandi aziende continuano come se nulla fosse. Noi cittadini facciamo la nostra parte, ma loro?”
— Marco, 28 anni, Milano
“Ho iniziato a soffrire di ansia pensando al futuro del clima. È una preoccupazione costante.”
— Elena, 22 anni, Firenze
“Vedo i cambiamenti nel mio orto: le stagioni non sono più le stesse. È inquietante.”
— Giuseppe, 60 anni, Catania










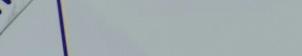



“Città piùcomunitàintelligenti, più sane ”




















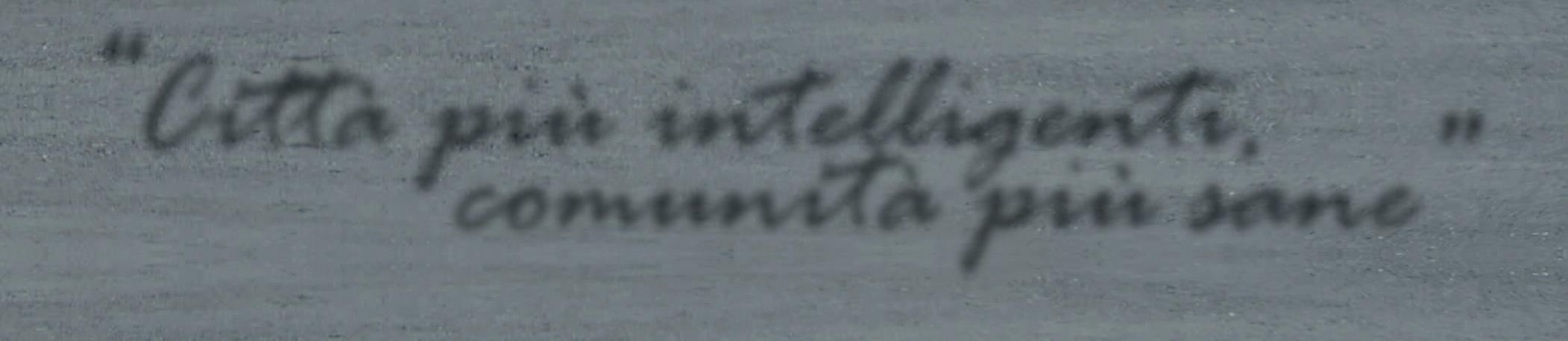







































Militello in Val di Catania è stato incoronato Borgo dei Borghi 2025, conquistando l’ambito titolo nella dodicesima edizione del concorso organizzato dal programma televisivo “Kilimangiaro” su Rai 3. Una vittoria che non solo celebra la bellezza architettonica e naturale di questo piccolo centro siciliano, ma che riconosce anche la forza di una comunità che ha saputo custodire e valorizzare le proprie radici storiche, culturali e identitarie.
Un successo popolare e meritato
La proclamazione è frutto soprattutto del voto popolare, che ha inciso per l’85% sull’esito finale, accompagnato da un giudizio tecnico della giuria composta da Alberta Campitelli, Barbara Gallavotti e Jacopo Veneziani (per il restante 15%). Militello ha saputo imporsi su una rosa di venti borghi finalisti, superando in volata Agliè (Piemonte) e Vignanello (Lazio), che si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. Un risultato che conferma come la bellezza e l’autenticità dei borghi del Sud Italia siano sempre più apprezzate e valorizzate.
Un tesoro barocco riconosciuto dall’UNESCO Militello in Val di Catania è un autentico scrigno d’arte: già dal 2002 fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, come una delle Città tardo barocche del Val di Noto. Passeggiare per le sue vie significa immergersi in un affascinante viaggio tra chiese, conventi e palazzi nobiliari, testimoni di una stagione artistica straordinaria. Spiccano il Castello Barresi Branciforte, la scenografica Fontana della Ninfa Zizza, la Chiesa Madre di San Nicolò e del Santissimo Salvatore, e il suggestivo Monastero di San Benedetto, solo per citare alcuni dei luoghi simbolo del borgo.
Con più di venti edifici religiosi, il centro storico di Militello racconta secoli di fede, arte e potere aristocratico. Ogni scorcio, ogni pietra racconta una storia, in un equilibrio perfetto tra rigore architettonico e creatività siciliana.
Natura, paesaggio e tradizioni Accanto al fascino urbano, Militello è anche custode di un paesaggio naturale di rara bellezza. Le cascate dell’Oxena, poco fuori dal centro abitato, offrono uno spettacolo incontaminato che attira ogni anno visitatori e appassionati di escursionismo. La natura qui non è semplice cornice, ma parte integrante dell’identità del luogo.
Le tradizioni culinarie sono un altro pilastro dell’attrattività del borgo: dalla scacciata militellese alla mostarda di fichi d’India, passando per la Sagra della
Mostarda e del Fico d’India che anima il borgo ogni ottobre, la gastronomia locale è un viaggio sensoriale che affonda le radici nella cultura contadina e nell’ingegno popolare.
Il paese natale di Pippo Baudo
Un elemento affettivo e simbolico che ha contribuito alla notorietà del borgo è il suo legame con uno dei più amati volti della televisione italiana: Pippo Baudo, nato proprio qui il 7 giugno 1936. A lui è intitolata una delle strade principali del paese, e il suo ricordo è ancora vivo nella memoria collettiva. Baudo ha più volte dichiarato il proprio amore per la sua terra natale, contribuendo a portarne il nome anche oltre i confini regionali.
Una comunità orgogliosa e un futuro da protagonista Il sindaco Giovanni Burtone, visibilmente emozionato al momento della proclamazione, ha voluto sottolineare come questo riconoscimento sia il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto cittadini, istituzioni locali e associazioni. “Questa vittoria – ha dichiarato –è un tributo alla bellezza, alla storia e alla passione di una comunità che non ha mai smesso di credere nel valore del proprio patrimonio”.
Il titolo di Borgo dei Borghi porterà sicuramente nuova linfa al turismo locale e alla valorizzazione economica del territorio. Grazie all’eco mediatica nazionale e al crescente interesse per il turismo lento e culturale, Militello in Val di Catania si prepara a vivere una nuova stagione di visibilità e riscoperta.
Una meta da non perdere
Con questa vittoria, Militello entra a pieno titolo tra le mete imperdibili per chi ama scoprire l’anima autentica dell’Italia: quella fatta di pietre antiche, panorami mozzafiato, sapori genuini e storie che si tramandano di generazione in generazione. Un luogo dove il tempo sembra rallentare, per permettere al visitatore di assaporare ogni dettaglio, ogni angolo, ogni emozione. Il Borgo dei Borghi 2025 non è solo un titolo: è una promessa di bellezza.




di Enrica Frutti
In un contesto nazionale e internazionale sempre più attento alla promozione della salute, alla valorizzazione delle risorse locali e alla costruzione di modelli di sviluppo sostenibile, il Comune di Scoppito rappresenta un esempio virtuoso di come un piccolo territorio possa diventare protagonista di un cambiamento culturale e sociale profondo.
Situato nel cuore di una zona collinare dal forte valore ambientale e storico, Scoppito ha saputo trasformare le sue dimensioni ridotte in un’opportunità: quella di sperimentare, in scala umana, politiche integrate per il benessere della comunità, fondate su partecipazione, inclusione, prevenzione e promozione della qualità della vita.
Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha avviato un percorso strutturato di innovazione territoriale, puntando su alcune leve strategiche: lo sport come diritto e strumento di salute, la cura degli spazi pubblici come luoghi di incontro e socialità, la tutela dell’ambiente come investimento intergenerazionale, e il turismo culturale e sostenibile come motore economico e identitario.
Il Comune ha scelto di adottare una visione olistica della salute, intesa non solo come assenza di malattia, ma come equilibrio tra corpo, mente e territorio. Da qui nascono iniziative che intrecciano sanità pubblica, educazione, cultura, mobilità dolce, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio immateriale. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una “comunità attiva e resiliente”, in grado di rispondere ai bisogni delle persone con soluzioni semplici ma efficaci, capaci di far dialogare tradizione e innovazione, radicamento e apertura.
Questo approccio, basato sulla cooperazione tra istituzioni, associazioni, professionisti, scuole e cittadini, ha reso Scoppito un punto di riferimento anche per altri comuni che cercano modelli replicabili per un futuro più sano, giusto e attrattivo. La scelta di integrare politiche per la salute, il benessere e lo sviluppo turisticoculturale in una cornice coerente e partecipata dimostra che anche i piccoli territori, se guidati da visioni strategiche, possono generare impatto, attrarre energie, innovare la governance e accrescere il senso di appartenenza.
È all’interno di questo quadro che si inseriscono i progetti e le strategie raccontate in questa scheda, con l’obiettivo di far conoscere un’esperienza locale che, per visione, concretezza e capacità di coinvolgimento, rappresenta oggi un modello di riferimento per le politiche integrate di salute e territorio.
Scoppito: sport, salute e cultura per lo sviluppo locale
Il profilo del territorio
Scoppito è un comune dell’entroterra italiano, nella provincia di L’Aquila, immerso in un contesto naturalistico fatto di boschi, sentieri, colline e borghi storici. Conta circa 4.000 abitanti e si caratterizza per un’economia tradizionalmente legata all’agricoltura, all’artigianato locale e a un turismo lento e consapevole. La sua posizione lo rende un crocevia naturale tra percorsi escursionistici, rotte enogastronomiche e itinerari culturali.
Cenni storico-culturali
Il borgo di Scoppito, alle pendici del Monte Calvo, che si trova a 1.898 metri sul livello del mare, si sviluppa in epoca medievale lungo un’importante direttrice tra le valli dell’Appennino centrale.
La zona era abitata sin dall’antichità, in epoca romana e pre-romana, ma il borgo di Scoppito propriamente detto si sviluppa nel medioevo. La sua posizione si colloca lungo la direttrice tra l’area aquilana e la Sabina.
Il paese si sviluppa intorno al castello verso il secolo XI, con insediamenti come Civitatomassa e Vigliano che si sovrappongono agli antichi insediamenti italici di Foruli e Fisternae. Il toponimo, secondo alcune interpretazioni, deriverebbe da “scopulus” (altura rocciosa), a indicare la posizione sopraelevata dell’abitato originario, che offriva un punto strategico di osservazione e difesa; secondo altre alle asperità del terreno. Tra i monumenti più rappresentativi del territorio spiccano numerose chiese, testimonianza della profonda tradizione religiosa della zona: l’Abbazia di San Bartolomeo, la chiesetta del miracolo di San Bernardino a Sella di Corno, la Chiesa di San Giacomo Apostolo e la Chiesa di Santa Maria del Mazzetto.
Nel corso dei secoli, il borgo ha mantenuto un forte legame con la sua tradizione contadina e artigianale, oggi riscoperta e valorizzata attraverso eventi stagionali, rievocazioni storiche e mercatini.
Oggi Scoppito è custode di una memoria storica viva, che si intreccia con i nuovi linguaggi dell’arte, del teatro e della narrazione del territorio. Le sue piazze e corti ospitano laboratori creativi, incontri culturali e spettacoli all’aperto, rendendo la cultura un elemento attivo della vita comunitaria e un fattore identitario per le nuove generazioni.
Uno degli eventi più significativi nella storia recente di Scoppito è il ritrovamento, avvenuto nel 1954, dei resti di un mammut risalenti al Pleistocene inferiore. Durante una perforazione nella Fornace Santarelli, nella frazione Madonna della Strada, furono scoperti i resti fossili di un mammut che risalivano a circa 1.3 milioni di anni fa. Questo ritrovamento si è rivelato uno dei più completi mai rinvenuti in Europa, fornendo un’importante testimonianza della fauna preistorica che abitava il nostro territorio. In occasione del 70° anniversario della scoperta, nel 2024, il Museo Nazionale d’Abruzzo
(MUNDA) ha celebrato questa straordinaria scoperta con una serie di eventi, mostre e presentazioni di prototipi 3D del mammut. I resti originali sono esposti al pubblico presso il Castello di L’Aquila, dove attirano l’attenzione di studiosi, turisti e appassionati di paleontologia.
Sport e stili di vita attivi come motore di comunità
L’amministrazione comunale ha investito con determinazione nella promozione dell’attività fisica e dello sport per tutte le età. Sono stati riqualificati i campi sportivi esistenti, creati percorsi nei parchi e attivati progetti scolastici per l’educazione motoria.
Ogni anno il Comune ospita la Festa della Montagna una giornata di sport all’aperto che coinvolge associazioni locali, le scuole e i visitatori, celebrando le bellezze naturali e le tradizioni del territorio, e rafforza il senso di comunità.
L’iniziativa si è concretizzata in una serie di attività, tra cui eventi culturali e che hanno permesso di coinvolgere i residenti e i visitatori in un dialogo costante con le tradizioni e il patrimonio naturale di Scoppito.
Il turismo esperienziale e culturale
Il comune intende valorizzare la propria vocazione turistica con una proposta centrata su esperienze autentiche, tra cui escursioni guidate, degustazioni in cantina, laboratori di artigianato e rievocazioni storiche. La Via dei Castagneti, che si snoda nel territorio di Scoppito, è uno degli itinerari più apprezzati del comprensorio che unisce sport, natura e cultura, attraversando alberi secolari, antichi sentieri e aree di interesse paesaggistico.
Partecipazione e governance locale
L’approccio partecipativo dell’amministrazione è uno dei pilastri della trasformazione di Scoppito. Le politiche su sport, salute e cultura sono co-progettate con cittadini, associazioni, scuole e operatori economici.
La partecipazione alla Unione dei comuni montani Montagna aquilana ha permesso di sintetizzare i bisogni delle comunità e favorire azioni coordinate, mettendo a sistema i punti di forza dei territori e favorendo il superamento dei punti di debolezza degli stessi, soprattutto in termini di divario digitale e spopolamento.
Visione futura e modelli replicabili
Scoppito ambisce a diventare un laboratorio nazionale di innovazione civica nei piccoli comuni, dove il benessere non è solo un obiettivo sanitario, ma una leva per rigenerare comunità, rafforzare legami sociali e rilanciare territori fragili.
La collaborazione con università e istituzioni locali aprirà la strada a progettualità europee su salute urbana e resilienza territoriale, rendendo Scoppito un modello replicabile in altri contesti.
Intervista – Cinque domande al Sindaco di Scoppito
Loreto Lombardi
In che modo il Comune di Scoppito promuove la pratica sportiva come strumento di benessere e coesione sociale, anche valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche del territorio?
«A Scoppito crediamo fortemente che lo sport sia uno strumento essenziale non solo per il benessere fisico, ma anche per la costruzione di legami sociali e per l’inclusione. Il nostro Comune, pur nelle sue dimensioni contenute, ha investito negli ultimi anni su strutture accessibili e multifunzionali, come il campo sportivo comunale, la palestra scolastica aperta anche alle associazioni, e spazi per il calcio giovanile, la pallavolo e l’attività motoria.
Abbiamo anche avviato iniziative per valorizzare l’ambiente come “palestra a cielo aperto”: stiamo potenziando la rete sentieristica e i percorsi escursionistici, in particolare nell’area del Monte Calvo e delle frazioni collinari, per favorire le camminate, i percorsi in mountain bike e attività all’aperto. Eventi come il Trail le Turri, organizzato dalla Pro Loco di Scoppito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuovono uno stile di vita attivo attraverso la riscoperta del nostro paesaggio.
Infine, lavoriamo con le scuole e con il volontariato sportivo per integrare le attività motorie nel percorso educativo, e stiamo valutando progetti inclusivi rivolti anche alle persone con disabilità. La nostra priorità è costruire una comunità sana, attiva e unita, partendo proprio dal corpo e dal territorio.»
Quali strategie ha adottato l’amministrazione per coniugare salute pubblica, attività all’aria aperta e fruizione sostenibile del patrimonio culturale locale?
«Negli ultimi anni abbiamo cercato di sviluppare un approccio integrato che metta al centro il benessere dei cittadini, valorizzando allo stesso tempo il nostro patrimonio ambientale e culturale. In primo luogo, abbiamo promosso la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili che collegano le frazioni e i principali luoghi di interesse storico e naturalistico. Questo consente ai cittadini e ai visitatori di praticare attività fisica in sicurezza, immersi nella bellezza del territorio.
Parallelamente, stiamo lavorando alla mappatura e alla segnaletica dei sentieri storici che conducono a chiese rurali, fontane antiche. Questi percorsi sono pensati
non solo per il turismo lento, ma anche come strumenti di educazione ambientale e valorizzazione dell’identità locale.
In collaborazione con le scuole e le associazioni, promuoviamo giornate di cammino, visite guidate e attività intergenerazionali all’aperto, con l’obiettivo di rendere la salute una responsabilità condivisa e la cultura un’esperienza viva. Per noi la salute pubblica non si tutela solo con i servizi sanitari, ma anche con scelte urbanistiche e sociali che favoriscano la vita attiva, la bellezza e il senso di appartenenza.»
Ci sono progetti o eventi che integrano sport, turismo e cultura per attrarre visitatori e al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti?
«Sì, negli ultimi anni stiamo puntando molto su iniziative che uniscono sport, cultura e promozione del territorio, nella convinzione che questi ambiti non siano separati, ma parti di un’unica strategia di sviluppo sostenibile e benessere. Evento di punta di questa Amministrazione sono la Notte bianca città territorio e il Wine foruli, quest’ultima una manifestazione enogastronomica che si svolge nella frazione di Civitatomassa.
Un altro appuntamento centrale è la Sagra del Tartufo, che si tiene ogni anno nel mese di agosto e rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate scoppitana. La manifestazione nasce per valorizzare il tartufo nero locale, ma nel tempo è diventata un’occasione di promozione turistica e coesione comunitaria. Accanto alle degustazioni e agli stand gastronomici, organizziamo concerti, mercatini artigianali, mostre e attività per famiglie. L’evento culturale più recente di rilievo è stato il Terre Sonanti, una manifestazione che ha celebrato l’arrivo di un mammut a grandezza naturale nel 2024, con l’intento di creare un parco tematico dedicato al mammut per il 2026, in occasione dell’anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. L’obiettivo è attrarre visitatori, ma anche offrire ai cittadini momenti di qualità, all’aperto, in un contesto identitario forte. È così che proviamo a coniugare turismo, cultura e benessere nella vita quotidiana del nostro comune.»
Come viene favorita la sinergia tra enti locali, associazioni, scuole e imprese per promuovere uno sviluppo territoriale che metta al centro il benessere, la salute e l’identità culturale di Scoppito?
«A Scoppito siamo convinti che nessun progetto di sviluppo duraturo possa essere calato dall’alto: deve nascere da una collaborazione reale tra chi vive e lavora nel territorio. Per questo favoriamo la sinergia tra amministrazione comunale, associazioni del terzo settore, istituti scolastici e imprese locali, creando momenti di confronto e progettazione condivisa.
Con le scuole, ad esempio, abbiamo attivato percorsi educativi sul patrimonio culturale e ambientale, laboratori di storia locale e attività all’aperto che collegano salute e identità. Le associazioni culturali e sportive che sono coinvolte in tutte le principali manifestazioni, dalla Notte bianca, al Wine foruli alla Sagra del Tartufo.
Anche le imprese locali, soprattutto quelle agricole e artigianali, vengono valorizzate come parte integrante del tessuto culturale del territorio. Collaborano con noi in occasione della sagra con spazi legati all’enogastronomia e al turismo rurale.
Inoltre, stiamo rafforzando i legami con gli altri Comuni della zona, in particolare per accedere in modo congiunto a bandi regionali e risorse del PNRR, con l’idea di costruire un’area interna dinamica, capace di attrarre giovani, investimenti e nuove idee, ma sempre nel rispetto dell’identità e della sostenibilità.
Il benessere, per noi, è una costruzione collettiva: passa dalla qualità delle relazioni e dalla capacità di fare comunità attorno a progetti concreti e condivisi.»
Quali sono, secondo lei, i punti di forza e le sfide ancora aperte per rendere Scoppito un esempio virtuoso di “comunità attiva”, attrattiva per turisti e salutare per i cittadini?
«Scoppito ha diversi punti di forza su cui stiamo costruendo una visione di sviluppo integrato, una posizione strategica tra L’Aquila e il confine reatino. Le frazioni alte di Cave, Sella di Corno e Vigliano per l’accesso diretto alla montagna; Collettara caratterizzata da una edilizia residenziale ben strutturata e dalla presenza di cliniche e residenze per anziani. Un paesaggio ancora integro e ricco di biodiversità, una storia millenaria che parte dalla romana Foruli di Civitatomassa e testimonia un profondo legame con le tradi-
zioni, celebrato oggi attraverso eventi socio-culturali come la Notte Bianca, il Wine Foruli e la Sagra del Tartufo, fino a giungere all’eredità medievale e rurale. Una comunità viva, partecipe, solidale e profondamente convinta del valore della partecipazione. Un nuovo polo centralizzato, inoltre, che vede nella stessa area la concentrazione dell’impiantistica sportiva, del nuovo plesso scolastico e del municipio, collegati dalla pista ciclopedonale che, una volta completata, metterà in connessione il centro commerciale con quello abitato e dei servizi.
Un altro punto di forza fondamentale è l’area commerciale sulla strada statale 17 in posizione strategica per gli snodi stradali, e la presenza della Sanofi, un’importante azienda farmaceutica internazionale che ha scelto Scoppito come sede per uno dei suoi principali stabilimenti produttivi. Questo insediamento rappresenta non solo un’importante fonte di occupazione, ma anche una risorsa fondamentale per il nostro tessuto economico, contribuendo a creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla sostenibilità.
Inoltre, possiamo contare su un tessuto associativo attivo, una buona dotazione di spazi Times New Romanpubblici e un forte legame con le tradizioni, come dimostra ogni anno la Sagra del Tartufo, ma anche le feste patronali e le iniziative legate alla montagna e ai prodotti locali. Questo ci permette di promuovere un’idea di comunità attiva che unisce salute, cultura e senso di appartenenza.
Le sfide aperte, tuttavia, non mancano: dobbiamo contrastare lo spopolamento giovanile, migliorare l’accessibilità tra le frazioni, investire ancora di più in mobilità dolce e servizi alla persona, e rafforzare la nostra offerta turistica in modo stabile, anche con l’uso intelligente del digitale e della promozione territoriale.
Il nostro obiettivo è quello di rendere Scoppito non solo un luogo dove si vive bene, ma anche dove si sceglie di venire per fare esperienza di benessere, natura e comunità. Per farlo, serve visione, ma soprattutto la partecipazione convinta di tutti: istituzioni, cittadini, scuola e mondo del lavoro.»

di Ludovica Serra
Nel cuore della Sicilia, tra le colline della Valle del Belice, sorge un borgo che negli ultimi anni è diventato simbolo di un’Italia che vuole rinascere: Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Un piccolo centro di circa 5.000 abitanti, insignito del titolo di “Borgo dei Borghi” nel 2016, che ha saputo trasformare una crisi demografica in una straordinaria opportunità di rigenerazione urbana e rilancio economico grazie a un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: vendere case a 1 euro.
La genesi del progetto
Il progetto nasce ufficialmente nel 2019, quando il Comune di Sambuca decide di mettere all’asta 16 immobili abbandonati nel centro storico al prezzo simbolico di un euro. Non si trattava di case di pregio o pronte all’uso, ma di abitazioni spesso in stato di degrado, alcune delle quali danneggiate dal terremoto del 1968. Eppure, l’iniziativa ha avuto un successo immediato e travolgente: in poche settimane, il Comune ha ricevuto migliaia di richieste da ogni parte del mondo — dagli Stati Uniti al Canada, dall’Europa all’Australia, fino al Sudafrica e alla Russia.
Dietro l’apparente semplicità dell’operazione, c’era una strategia ben calibrata. Non si trattava di “regalare” le case, ma di attivare un meccanismo virtuoso: gli acquirenti, oltre a versare una cauzione di 5.000 euro (restituita al termine dei lavori), si impegnavano contrattualmente a ristrutturare l’immobile entro tre anni, con un investimento medio stimato tra i 30.000 e i 200.000 euro, a seconda delle condizioni della casa e delle scelte progettuali.
Perché funziona? Il modello Sambuca
Diversi comuni italiani hanno tentato iniziative simili, ma Sambuca è considerata un caso di successo unico per alcune ragioni specifiche:
1. Proprietà pubblica degli immobili: tutte le case messe in vendita erano di proprietà del Comune, il che ha evitato complicazioni legate alla multipro-
prietà, successioni non chiare o contenziosi familiari. Questo ha permesso una gestione amministrativa fluida e veloce.
2. Comunicazione internazionale efficace: la notizia è stata rilanciata da media di tutto il mondo, dalla BBC al New York Times, fino ai canali televisivi americani. L’attrice Lorraine Bracco, nota per “I Soprano”, ha addirittura comprato una casa a Sambuca e ha girato un reality per HGTV intitolato “My Big Italian Adventure”, contribuendo ulteriormente alla notorietà del borgo.
3. Visione di lungo periodo: il Comune ha accompagnato l’iniziativa con interventi di valorizzazione del territorio, miglioramento delle infrastrutture digitali, spazi di co-working e promozione turistica. Non si è trattato solo di vendere case, ma di creare una nuova identità per Sambuca.
Un’opportunità per i comuni italiani
Per i piccoli comuni italiani in via di spopolamento, il progetto rappresenta molto più di una trovata mediatica. È un’occasione concreta per:
• Valorizzare il patrimonio edilizio abbandonato, spesso altrimenti destinato al crollo.
• Rilanciare l’economia locale attraverso il lavoro di imprese edili, artigiani, architetti, attività commerciali e turistiche.
• Attrarre nuovi residenti (anche temporanei o stagionali), rivitalizzando il tessuto sociale e culturale.
• Internazionalizzare il borgo, portando capitali esteri, diversità culturale e nuove competenze professionali, come accaduto a Sambuca con l’arrivo di “nomadi digitali” e artisti.
Secondo i dati diffusi dal Comune, le aste successive (una nel 2021 con case a 2 euro, e una nel 2023 con prezzi da 3 euro) hanno generato un indotto economico di oltre 20 milioni di euro.

Un’opportunità per gli acquirenti
Per chi acquista, si tratta di un sogno accessibile: una casa in Sicilia, tra vigne e uliveti, in un contesto storico affascinante e autentico. Ma è anche:
• Un progetto di vita o di vacanza: molte famiglie straniere usano le case come seconde abitazioni, altri come rifugi per periodi sabbatici o lavoro da remoto.
• Un investimento a lungo termine: con la ristrutturazione, molti immobili possono diventare strutture ricettive (B&B, case vacanza), in un’area sempre più apprezzata dal turismo internazionale.
• Un’avventura culturale: vivere o passare del tempo in un borgo siciliano significa entrare in contatto con tradizioni, cibo, ospitalità e uno stile di vita slow.
Naturalmente, chi acquista deve essere consapevole degli oneri: le ristrutturazioni possono essere complesse, e vanno rispettati vincoli urbanistici e architettonici, trattandosi spesso di immobili storici. Tuttavia, molti acquirenti raccontano esperienze molto positive e trasformative.
Un’eredità che ispira
L’esperienza di Sambuca ha ispirato decine di altri co-
muni in tutta Italia: da Gangi in Sicilia a Ollolai in Sardegna, da Taranto a Lecce, da Zungoli (Campania) a Borgomezzavalle (Piemonte). La “casa a 1 euro” è diventata una nuova frontiera dell’urbanistica partecipata, capace di attivare desideri, narrazioni, economie e senso di comunità.
Come ha dichiarato il sindaco di Sambuca, Giuseppe Cacioppo:
“Non volevamo vendere solo case, ma costruire un ponte tra passato e futuro. Tra chi è andato via e chi può tornare. Tra chi cerca un luogo autentico e chi vuole dare nuova vita a questi luoghi.”
Il progetto delle case a 1 euro a Sambuca di Sicilia non è solo una storia di marketing immobiliare, ma un esempio concreto di come un’amministrazione coraggiosa, una visione strategica e il potere delle emozioni possano rimettere in moto territori abbandonati. È un invito a ripensare i borghi non come “resti del passato”, ma come laboratori viventi di futuro, dove abitare, investire, crescere, sognare.
Per chi cerca una nuova casa e una nuova vita, Sambuca offre più di un tetto: offre una possibilità.

a cura di Andrea Lenzi per Science for Cities
Il cambiamento climatico non è più una minaccia remota o una previsione scientifica: è una realtà quotidiana, tangibile, che sta modificando radicalmente il nostro modo di vivere, ammalarsi e curarci. La crisi climatica non è solo ambientale, ma anche e soprattutto una crisi sanitaria e sociale. I suoi effetti si riverberano sulle città, che sono oggi il principale teatro delle trasformazioni in atto: epicentri di emissioni, ma anche laboratori di soluzioni. In questo contesto, scienza e salute diventano alleati strategici per affrontare un futuro incerto e per garantire giustizia climatica e benessere collettivo.
Il nesso tra clima e salute: una nuova priorità globale
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il cambiamento climatico è la più grande minaccia alla salute globale del XXI secolo. L’aumento delle temperature, l’intensificarsi degli eventi estremi, l’alterazione degli ecosistemi e la diffusione di vettori patogeni stanno già incidendo sulla salute fisica e mentale delle persone. Inquinamento atmosferico, ondate di calore, carenza idrica e insicurezza alimentare rappresentano rischi crescenti, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini, malati cronici, migranti.
Le città come hub di trasformazione
Oltre il 70% delle emissioni di gas serra proviene dalle aree urbane. Ma le città, con la loro densità, infrastrutture e capacità innovativa, possono essere anche il luogo dove si costruiscono risposte efficaci. Politiche urbane lungimiranti – dalla mobilità sostenibile all’edilizia verde, dalla rigenerazione degli spazi pubblici alla promozione di stili di vita sani – possono ridurre le disuguaglianze ambientali e migliorare la salute dei cittadini. È nelle città che si possono testare modelli di resilienza e adattamento capaci di integrare scienza, governance e partecipazione.
Il ruolo della scienza: dati, decisioni, democrazia
La scienza è il motore del cambiamento. Non solo come fonte di evidenze, ma come strumento per orientare le politiche pubbliche, promuovere l’alfabetizzazione climatica e rafforzare la democrazia delle scelte. La collaborazione tra istituzioni accademiche, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni e società civile è fondamentale per trasformare i dati in azione. La produzione e l’accesso trasparente a informazioni affidabili sono un presupposto per costruire fiducia e consenso intorno a una transizione ecologica giusta.
Salute urbana come bene comune
Rimettere la salute al centro delle politiche climatiche significa superare la visione settoriale e promuovere un approccio integrato. La salute non è solo assenza di malattia, ma equilibrio tra persone, ambiente e comunità. È un diritto umano fondamentale, ma anche un indicatore della qualità della democrazia e della sostenibilità. Le città devono dotarsi di strumenti nuovi –osservatori locali, Health City Manager, piani intersettoriali – per monitorare e governare le determinanti ambientali e sociali della salute.
Cinque azioni per rafforzare la cooperazione scientifica nazionale
Per affrontare efficacemente la crisi climatica nelle città italiane, Science for Cities propone cinque azioni concrete da attuare in stretta collaborazione con la comunità scientifica nazionale:
• Creare Osservatori Urbani Clima-Salute Costituire una rete nazionale di Osservatori Urbani sul Clima e la Salute, in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e agenzie ambientali regionali, per raccogliere dati, analizzare i rischi e supportare la pianificazione urbana resiliente.
• Promuovere un “Patto per la Scienza Urbana”
Avviare un patto nazionale che impegni università, IRCCS, istituzioni sanitarie, tecnici e amministrazioni a integrare la conoscenza scientifica nelle decisioni urbane e a sperimentare progetti pilota nei territori.
• Attivare programmi di formazione interdisciplinare
Formare nuove figure professionali come gli Health City Manager, offrendo corsi interdisciplinari su epidemiologia ambientale, governance urbana e adattamento climatico.
• Istituire un fondo per la ricerca locale applicata
Creare un fondo nazionale dedicato alla ricerca urbana sul nesso clima-salute, per finanziare iniziative scientifiche, progetti nei quartieri più fragili e sistemi di monitoraggio integrato.
• Costruire una piattaforma nazionale di comunicazione scientifica
Lanciare una piattaforma digitale che renda accessibili a cittadini, scuole e amministratori dati, mappe, scenari e buone pratiche sul cambiamento climatico e la salute urbana.
Una chiamata all’azione per città più giuste e vivibili
L’agenda urbana della scienza e della salute deve essere al centro delle strategie di adattamento e mitigazione climatica. Serve un cambio di paradigma: non possiamo più pensare all’ambiente come sfondo, ma come protagonista delle politiche sanitarie e sociali. Le città che investono in spazi verdi, in qualità dell’aria, in infrastrutture sostenibili, non solo combattono il cambiamento climatico, ma migliorano la qualità della vita, riducono i costi sanitari, rafforzano la coesione sociale.
Science for Cities promuove una visione sistemica e cooperativa del futuro urbano: una visione che mette al centro la scienza, la salute e il benessere delle comunità. Perché abitare il pianeta, oggi, significa prendersene cura. E le città possono – e devono – essere il primo passo verso una nuova

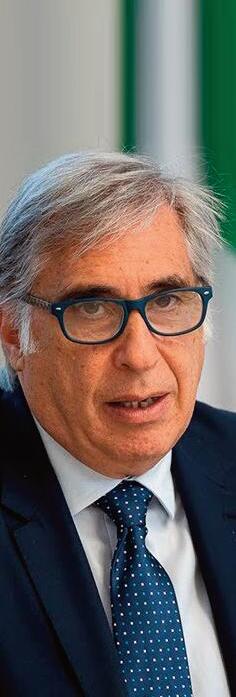

di Alessandro Solipaca
Direttore scientifico dell’Osservatorio per la Salute
come Bene Comune – Università Cattolica di Roma
Il contesto urbano sta sperimentando da anni significativi aumenti di temperatura dell’aria che determinano condizioni di calore critiche, aggravate dal fenomeno microclimatico tipico delle aree urbane. Tale dinamica è estremamente pericolosa per la salute umana, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, in particolare per gli anziani. I cambiamenti climatici sviluppatisi nel corso di molti anni sono ritenuti dalla comunità scientifica frutto delle attività antropiche, per tale motivo, nell’ultima Conferenza Annuale delle Nazioni Unite di Dubai del 2023, si è sentita la necessità esortare la comunità internazionale a porre in essere iniziative per limitare l’aumento della temperatura media globale a +1,5°C, soglia già definita nell’Accordo di Parigi 2015. Numerosi studi evidenziano che gli effetti del cambiamento climatico sono molto evidenti nelle aree urbane, dove l’aumento delle temperature e dei fenomeni estremi causano numerosi danni all’ambiente e ai sistemi economici urbani, e spesso la perdita di vite umane. In molte città la soglia obiettivo di +1,5°C della temperatura media appare superato in diverse occasioni nel corso dell’ultimo decennio.
Nel periodo 1971-2022 la temperatura media annua registrata nelle città capoluoghi di Regione mostra un trend significativo di crescita, con i valori più alti registrati nell’ultimo decennio. In particolare, il 2022 segna la temperatura media più alta dal 1971, circa 16,6°C, con un picco di anomalia termica mai registrato, pari a 1,7°C rispetto alle medie climatologiche di riferimento calcolate in tutto il mondo su un intervallo di 30 anni.
Il 2022 è stato l’anno più caldo dal 1971, con una temperatura media di circa 16,6°C che ha fatto registrare un’anomalia termica di +1,7°C rispetto al trentennio 1981-2010. Sono circa 9,5 milioni le persone esposte a queste temperatura anomale. Nel 2022, le città mediamente più calde sono state Palermo (circa 19,8°C), Cagliari (19,5) e Roma (18,7). I valori massimi più elevati si sono registrati a Roma (24,8°C), Cagliari (24) e Palermo (23,1). Le città con variazioni medie di temperatura più elevate sono state Roma (+2,7°C) e Milano (+2,5), seguite da Perugia (+2,3) e Torino (+2,1). Le anomalie più contenute si registrano per Ancona (+0,7°C), Palermo (+0,9) e Bari (+1). Le ondate di calore estreme sono aumentate rispetto al trentennio climatologico 1981-2010. Le giornate con temperatura massima superiore a 25°C (giorni estivi) e quelle con temperatura media mai di sotto dei 20°C (notti tropi-
cali) sono sempre più frequenti. Nel periodo 20062022, si sono rilevati in media 113 giorni estivi e 49 notti tropicali all’anno. I giorni estivi aumentano più significativamente per Roma (+54 giorni), Genova e Aosta (+41), mentre le notti tropicali per Milano (circa +57 notti), Torino e Genova (+49) e Bologna (+47).
Le aree verdi nelle grandi città possono rappresentare una delle soluzioni naturali al riscaldamento climatico, poiché assorbono la CO2 e sono estremamente efficaci per mitigare le temperature. L’utilità di ampi polmoni verdi nelle grandi aree metropolitane è ben testimoniata dai dati. Nella città di Roma la differenza di temperatura tra aree urbane e vegetate circostanti è di +6,5°C, circostanza che si riscontra principalmente nelle aree centrali della città (Municipio I e II) e nel quadrante ad est (Municipio V). Roma risulta anche la città con il differenziale di temperatura più basso, che si registra più frequentemente nei Municipi IX, X e XIV. In questi Municipi la maggiore presenza di aree vegetate rende l’aria più fresca fino ad abbassare la temperatura di quasi tre gradi (-2,9°C). Nella città di Milano le temperature medie rilevate nelle aree urbane e in quelle vegetate mostrano escursioni di temperatura comprese tra -0,5°C (zone altamente vegetate) e +3,7°C (zone maggiormente urbanizzate). Le aree meno colpite si rilevano nei Municipi V, IV e nelle aree a sud di Milano, con temperature mediamente simili tra quelle urbane e quelle vegetate, nelle quali si misurano escursioni tra -0,5 e +1,1°C. Il fenomeno è più marcato nei quartieri centrali (Municipio I) e nella zona a nord (Municipio IX) nelle quali l’escursione termica varia tra +2,8 e +3,7°C. A Napoli le escursioni termiche più basse si riscontrano nei Municipi IX e VIII, variazioni medie tra (+0,7°C e +0,8°C). Al contrario, quelle mediamente più elevate riguardano i Municipi IV e II, tra +2,8°C e +3,7°C.
L’altro aspetto del cambiamento climatico è rappresentato dalle precipitazioni che nel periodo 1971-2022 ha evidenziato una elevata variabilità, con periodi prolungati di siccità alternati a periodi di elevata piovosità. Nel decennio 2006-2015, sono caduti circa 232 mm di pioggia in meno. Le diminuzioni maggiori si sono riscontrate a Torino (-676,6 mm), Milano (-569,2 mm) e Genova (-531,2). Il 2022 è stato il secondo anno meno piovoso dal 1971 (dopo il 2007), con una precipitazione totale media di 576 mm. Il calo interessa 17 di queste città, in particolare Milano (-585,5 mm), Genova (-567,3) e Torino (-496,4). In generale, nel 2022, la precipitazione annua è più bassa in valore assoluto per l’insieme dei Capoluoghi di Isole e Nord-ovest (rispettivamente circa 420 mm e 540, valori inferiori a quello medio 2006-2015).
Benessere psicologico e cambiamento climatico: da spettatori impauriti a cittadini attivi
di David Lazzari


Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo. Gli effetti tangibili sono sotto gli occhi di tutti, tuttavia, accanto alle conseguenze ambientali ed economiche, esiste un impatto meno visibile ma altrettanto significativo: quello sul benessere psicologico delle persone.
Negli ultimi anni si è cominciato a esplorare il legame tra crisi climatica e salute mentale. Il risultato è un quadro preoccupante: la crescente consapevolezza della gravità della situazione ecologica sta generando un’ondata di disagio psicologico, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. Ansia, tristezza, rabbia, senso di colpa e impotenza sono emozioni sempre più comuni di fronte a un futuro percepito come incerto e minaccioso.
Uno dei termini che ha guadagnato attenzione è ecoansia, ovvero l’ansia legata alla crisi ambientale. Non si tratta di una patologia riconosciuta nei manuali diagnostici, ma di una reazione emotiva reale e diffusa, una preoccupazione intensa per il deterioramento dell’ambiente e per le conseguenze a lungo termine del cambiamento climatico sulla vita umana e sul pianeta.
Inoltre, le comunità colpite da disastri naturali – incendi, alluvioni, uragani – sperimentano un forte stress acuto che può evolvere in disturbi da stress post-traumatico. Anche chi non ha vissuto direttamente questi eventi può provare un senso di vulnerabilità e insicurezza, alimentato dalle immagini e dalle notizie che circolano quotidianamente nei media.
A essere colpiti non sono solo gli individui, ma anche le relazioni sociali e le comunità. Le migrazioni climatiche, l’aumento della competizione per risorse scarse e la crescente disuguaglianza possono minare la coesione sociale, generando tensioni e conflitti. La crisi climatica, quindi, mette a dura prova anche i legami tra le persone e il senso di appartenenza.
Gli atteggiamenti verso il tema sono condizionati da ragioni evolutive e storiche, da interessi economici e da un meccanismo di negazione attribuibile a diversi fattori.
Evolutivamente c’è una visione di fondo del clima come “ciclicità”, variazioni naturali e quindi non influenzate dagli umani, oppure in epoca più recente, dalla inedita emancipazione delle attività umane dal clima naturale. Questi schemi mentali limitano la comprensione del quadro attuale.
Il ruolo degli interessi economici limita l’adozione di politiche attive per contrastare il cambiamento e una informazione adeguata e puntuale. A ciò si aggiunga l’azione di meccanismi psicologici difensivi di fronte a
situazioni viste come non controllabili, soprattutto a livello individuale, e potenzialmente molto negative, in questo caso il più diffuso è la negazione totale o la sottovalutazione.
Questo scenario richiede la promozione di una capacità di “consapevolezza costruttiva”: accanto alle emozioni negative, già oggi molte persone sperimentano anche una maggiore consapevolezza, senso di responsabilità e desiderio di cambiamento. In alcuni casi, l’ansia può trasformarsi in attivismo, l’angoscia in partecipazione. Questo passaggio – da spettatori impauriti a cittadini attivi – è fondamentale per proteggere non solo l’ambiente, ma anche la salute mentale collettiva.
Per tutelare il nostro benessere psicologico in tempi di crisi climatica in primo luogo, è importante riconoscere e legittimare le emozioni legate alla crisi ambientale. Provare ansia o tristezza non è segno di debolezza, ma una risposta empatica e consapevole a una realtà complessa. Parlare di questi sentimenti con amici, familiari o professionisti può aiutare a elaborare il disagio e a non sentirsi soli.
In secondo luogo, è utile cercare un senso di agency, ovvero la percezione di poter agire. Anche piccoli gesti – come ridurre il consumo, partecipare ad attività di sensibilizzazione, sostenere politiche sostenibili – possono restituire un senso di controllo e contribuire al benessere psicologico. Sentirsi parte di una comunità attiva e solidale è un antidoto potente contro il senso di impotenza.
Infine, è necessario integrare il benessere psicologico nelle politiche climatiche. I governi, le istituzioni e le organizzazioni internazionali devono riconoscere che il cambiamento climatico è anche una questione di salute pubblica. Investire in supporto psicologico per le comunità vulnerabili, formare operatori capaci di affrontare questi temi, promuovere la resilienza individuale e collettiva sono passaggi cruciali per affrontare in modo completo e umano la sfida climatica.
Il benessere psicologico non è un lusso da relegare in secondo piano, ma una risorsa fondamentale per affrontare con lucidità e speranza i grandi cambiamenti del nostro tempo. Prendersi cura della psiche, così come del pianeta, è un atto di resistenza, responsabilità e amore verso il futuro.

benessere, innovazione e qualità della vita in Italia e nel mondo.
Il 2025 segna un punto di svolta per il mondo del benessere. In un’epoca dominata dalla velocità digitale e dalle sfide ambientali, emergono nuove esigenze e sensibilità che ridefiniscono il concetto stesso di wellness. Il Global Wellness Summit, punto di riferimento internazionale del settore, ha identificato dieci tendenze chiave che plasmeranno il panorama globale nel prossimo futuro. Come Italian Wellness Alliance, le accogliamo come una guida per ispirare, innovare e migliorare la qualità della vita di cittadini, professionisti e istituzioni.
1. Il ritorno all’analogico: il benessere disconnesso L’eccessiva esposizione agli schermi ha generato un desiderio crescente di esperienze analogiche. Si riscoprono attività semplici come la scrittura a mano, i giochi da tavolo, i laboratori artigianali e le passeggiate nella natura. Questo trend non è nostalgia, ma una vera e propria strategia di salute mentale: staccare per riconnettersi con sé stessi.
2. La sauna reinventata: tecnologia e ritualità
La sauna, simbolo ancestrale di purificazione, viene rilanciata con design contemporanei e tecnologie integrate: luci circadiane, aromaterapia programmata, ambienti multisensoriali. Non più solo relax, ma spazi sociali dove il calore diventa esperienza condivisa e terapeutica.
3. Il paradosso degli integratori: tra hype e scienza
Nel 2025 si rafforza l’interesse per integratori alimentari sempre più personalizzati e scientificamente validati. Parallelamente, si chiede maggiore trasparenza: efficacia reale, sicurezza, qualità. È il trionfo del “clean label” e del biohacking responsabile.
4. Adolescenza e benessere: la nuova priorità
Dalla pandemia in poi, il disagio psicologico tra i giovani è aumentato. Oggi il benessere adolescenziale di-
venta una priorità globale. Nascono spazi protetti nei campus, percorsi di mindfulness nelle scuole, format digitali che educano alla cura di sé e alle emozioni.
5. Wellness e crisi idrica: salute delle persone e del pianeta
Il benessere del futuro non può ignorare l’acqua, risorsa fragile. Spazi termali, spa e centri fitness si dotano di tecnologie idro-efficienti, sistemi di recupero delle acque grigie e iniziative educative per ridurre gli sprechi. Wellness e sostenibilità si fondono.
6. Biologia aumentata: corpo umano potenziato Neurotecnologie, wearables, test genetici e dispositivi impiantabili: nel 2025 il corpo umano dialoga con la tecnologia in modo sempre più sofisticato. L’obiettivo non è solo la cura, ma il potenziamento delle capacità cognitive, motorie ed emozionali. Resta fondamentale il dibattito etico.
7. Benessere in viaggio: treni e crociere slow life
Il viaggio si trasforma in un percorso di rigenerazione. Le compagnie ferroviarie e navali sviluppano ambienti “wellness-friendly” con spazi per la meditazione, trattamenti olistici, cucina funzionale. Il turismo lento incontra il benessere, offrendo esperienze trasformative.
8. Il wellness contro le dipendenze
Il settore si mobilita per affrontare il tema delle dipendenze (droghe, gioco, tecnologia, alcol) con approcci olistici: programmi di disintossicazione integrata, terapie corporee, supporto psicologico e pratiche di consapevolezza. Si punta a una guarigione profonda e multidimensionale.
9. Lavoro e longevità: reinventare la carriera senior Con l’aumento della popolazione attiva over 60, il benessere lavorativo assume nuovi significati. Le aziende più lungimiranti offrono programmi di mentorship
intergenerazionale, flessibilità oraria, supporti ergonomici e percorsi di formazione continua. L’età non è più un limite, ma un valore.
10. Medio Oriente: il nuovo hub del wellness globale
Emirati, Arabia Saudita e Qatar investono massicciamente in città del benessere, resort olistici e cliniche di longevità. Il modello fonde medicina integrata, spiritualità e lifestyle, con l’ambizione di guidare l’innovazione del settore a livello globale. È una sfida anche geopolitica.
Verso una nuova cultura del benessere
Le tendenze del 2025 segnalano un’epoca di transizione: da un lato l’avanzata delle tecnologie biomediche, dall’altro il bisogno profondo di autenticità, lentezza e relazioni significative. Il benessere non è più solo individuale, ma collettivo, ambientale, culturale. Come Italian Wellness Alliance, riteniamo che l’Italia, con la sua tradizione termale, l’arte del vivere, la biodiversità e la cultura della prevenzione, possa essere leader di una nuova visione di benessere integrato e sostenibile. Un wellness che include, educa e rigenera.
Riscoprire il benessere: una responsabilità personale e collettiva
In questo scenario in evoluzione, riscoprire il proprio benessere psico-fisico significa tornare a mettere al centro la cura di sé attraverso: sani stili di vita: alimentazione equilibrata, movimento regolare, sonno di qualità e gestione dello stress; qualità della vita abitativa: ambienti domestici salubri, spazi verdi, comfort acustico e illuminazione naturale; cura delle relazioni e del contesto sociale: appartenenza, mutualismo e partecipazione attiva nella comunità di riferimento.
Il benessere, dunque, non è un lusso, ma un diritto e una pratica quotidiana. Non è solo assenza di malattia, ma presenza di significato, armonia, energia vitale. È un processo continuo di consapevolezza e scelta. Come alleanza italiana del benessere, crediamo che questa trasformazione debba partire da ogni cittadino e coinvolgere imprese, istituzioni e territori. Perché prendersi cura di sé è anche un atto di responsabilità verso gli altri e verso il futuro.

di Ludovica Serra
Nel cuore delle trasformazioni economiche, climatiche e sociali che attraversano l’Europa, un elemento si impone con forza crescente: le città non sono solo luoghi da governare, ma veri e propri motori del cambiamento. È qui che si gioca la partita più delicata – e forse decisiva – per integrare le politiche industriali con gli obiettivi climatici, trasformando la sfida ambientale in un’opportunità concreta di rilancio economico e coesione sociale.
Questa visione – condivisa sempre più da studiosi, amministratori e policy maker – è al centro di un recente appello lanciato dal network C40 Cities, che riunisce alcune tra le più grandi metropoli del mondo impegnate contro la crisi climatica. Secondo C40, per costruire un’Europa verde, competitiva e inclusiva, non si può prescindere da una strategia industriale fondata sul protagonismo delle città.
Dalla transizione ecologica alla trasformazione industriale
Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha rafforzato il proprio impegno per il clima con strumenti come il Green Deal, e più di recente con il Clean Industrial Deal, che punta a decarbonizzare l’economia europea valorizzando innovazione, autonomia energetica e filiere produttive sostenibili.
Ma questi grandi quadri strategici, per non restare dichiarazioni d’intenti, devono radicarsi nei territori. È qui che entrano in gioco le città, che più di ogni altro livello istituzionale vivono – e devono governare – l’impatto concreto della transizione. Le città europee, infatti, sono responsabili di circa il 70% delle emissioni di gas serra, ma al contempo sono anche il luogo dove si possono sviluppare soluzioni scalabili, eque e ad alto impatto.
Lavoro, innovazione e inclusione: il triplice pilastro urbano
Uno dei cardini della transizione climatica è l’occupa-
zione verde. Investire in infrastrutture sostenibili, energie rinnovabili, mobilità pulita e rigenerazione urbana non solo riduce l’impronta ecologica delle città, ma genera anche nuovi mercati del lavoro. Secondo i dati diffusi da C40, le città europee che aderiscono alla rete contano oggi oltre 2,3 milioni di green jobs, pari all’8% dell’occupazione urbana totale.
Di questi, 1,3 milioni sono impiegati in settori chiave come le rinnovabili e la gestione dei rifiuti, mentre quasi un milione svolge ruoli indiretti di supporto alle industrie verdi. Ma il dato forse più rilevante è che i lavori verdi generano fino al 30% in più di occupazione rispetto agli investimenti tradizionali, rendendoli uno strumento cruciale per affrontare contemporaneamente crisi ambientale e disoccupazione
Città laboratorio di equità: una transizione giusta è possibile
Non tutte le trasformazioni, però, sono automatiche. La transizione verde comporta anche rischi: ristrutturazioni produttive, perdita di posti di lavoro in settori inquinanti, esclusione delle fasce più vulnerabili. Per questo, il concetto di transizione giusta è diventato fondamentale nel lessico delle politiche urbane.
Le città, con la loro capacità di prossimità, hanno un potere unico: possono accompagnare il cambiamento con misure di protezione sociale, formazione professionale, politiche abitative ed educative. Possono attivare reti di supporto per lavoratori in fase di riconversione, donne, giovani, migranti. E possono fare tutto questo attraverso un’alleanza virtuosa tra istituzioni, imprese, sindacati e società civile.
Dalle buone pratiche agli ecosistemi urbani
Molti esempi concreti mostrano che questa integrazione è già in atto. A Madrid, il progetto TándEM ha offerto percorsi di formazione per energie rinnovabili e riqualificazione edilizia a gruppi vulnerabili, con un impatto diretto su occupazione e inclusione. A Londra,

le Green Skills Academies hanno creato un ecosistema formativo condiviso tra pubblico e privato per formare la nuova forza lavoro della transizione. A Rotterdam, il programma BRIDGE collega istruzione e industria, orientando le nuove generazioni verso i settori più innovativi della green economy.
Queste esperienze, pur diverse, condividono una stessa visione: la transizione climatica non può essere imposta dall’alto, ma deve essere costruita dal basso – città per città, comunità per comunità.
Un nuovo ruolo per i sindaci d’Europa
In questo contesto, emerge con forza un rinnovato ruolo politico delle città. I sindaci non sono più solo amministratori locali, ma attori globali nella lotta alla crisi climatica e nella definizione del futuro industriale europeo. Le loro decisioni su trasporti, edilizia, energia e lavoro hanno impatti diretti sull’economia continentale.
Per questo, il messaggio lanciato da C40 Cities è chiaro: il Clean Industrial Deal europeo deve essere pensato e
costruito con le città, non sopra di esse. Serve una governance multilivello che riconosca il valore strategico dell’azione urbana, con risorse dedicate, competenze rafforzate e strumenti flessibili per adattare le politiche alle specificità locali.
Conclusioni: l’Europa che verrà parte da qui
La battaglia per il clima e per un’economia più giusta e sostenibile non si vincerà nei palazzi istituzionali o nei board delle grandi imprese, ma nelle strade, nei quartieri, nei laboratori urbani di innovazione. È qui che si incrociano le sfide dell’ambiente, dell’equità e della crescita. Ed è da qui che può emergere un nuovo modello europeo, capace di coniugare industria e clima, sviluppo e giustizia.
Le città non sono un livello “secondario” di governo: sono il terreno su cui si costruisce il futuro. E questo futuro, come ci ricorda C40, può e deve essere verde, inclusivo e guidato da chi vive, lavora e innova nei territori ogni giorno.

La YMCA (Young Men’s Christian Association) si distingue a livello globale per il suo impegno nell’affrontare le sfide del cambiamento climatico e nel promuovere la salute delle comunità. Attraverso una serie di iniziative innovative, l’organizzazione integra la sostenibilità ambientale con il benessere fisico e mentale, coinvolgendo attivamente giovani e comunità locali.
La YMCA ha delineato una strategia ambiziosa denominata “Vision 2030”, con l’obiettivo di diventare un movimento climaticamente neutro. Questa visione si concretizza attraverso il pilastro “Sustainable Planet”, che mira a responsabilizzare le comunità e i giovani, educandoli all’azione climatica e promuovendo la giustizia ambientale.
La partecipazione attiva della YMCA alle conferenze internazionali sul clima, come la COP, testimonia il suo ruolo
di Alessandro Indovina, Segretario Geerale Federazione Italiana delle YMCA
Negli Stati Uniti, la YMCA ha implementato il programma “Healthier Communities Initiatives” (HCI), che si concentra sulla promozione di stili di vita sani attraverso politiche e strategie comunitarie. Queste iniziative comprendono
• Creazione di collegamenti comunitari per fornire accesso a programmi di prevenzione delle malattie croniche.
• Miglioramento della sicurezza di strade e marciapiedi per favorire il trasporto attivo.
• Promozione dell’accesso a cibi nutrienti attraverso l’introduzione di mercati agricoli in quartieri con scarse opzioni alimentari sane.
• Collaborazione con le scuole per aumentare l’educazione fisica e l’attività fisica durante la giornata scolastica.
Queste azioni mirano a ridurre le disparità sanitarie e le malattie croniche, migliorando la salute generale delle comunità.
Educazione Ambientale per le Nuove Generazioni
La YMCA, in collaborazione con il National Park Service, ha lanciato l’iniziativa “Youth Outdoors”, che offre ai giovani esperienze educative all’aperto, promuovendo la consapevolezza ambientale e la responsabilità sociale. Attraverso campi estivi e progetti di servizio, i partecipanti apprendono l’importanza della conservazione ambientale e sviluppano competenze di leadership.
Inoltre, la YMCA sta testando diversi curricula sul cambiamento climatico in collaborazione con il National Park Service, con l’obiettivo di identificare i programmi educativi più efficaci per sensibilizzare i giovani sulle sfide ambientali.
Infrastrutture Resilienti e Sostenibili
La YMCA del Greater Toronto ha sviluppato una “Strategia di Resilienza Climatica” per adattare le sue
strutture agli impatti del cambiamento climatico. Tra le iniziative intraprese:
• Valutazione dei rischi climatici per le strutture esistenti.
• Implementazione di sistemi energetici ad alta efficienza, inclusi impianti solari e sistemi di cogenerazione.
• Partecipazione al programma “Beat the Heat” della città di Toronto, offrendo spazi climatizzati durante eventi di calore estremo.
Collaborazioni Globali per l’Azione Climatica
La YMCA collabora con diverse organizzazioni per ampliare l’impatto delle sue iniziative ambientali. Un esempio è la partnership con Enhesa, che mira a fornire formazione sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (ESG) a giovani leader in tutto il mondo. Attraverso webinar e programmi di mentoring, i partecipanti acquisiscono competenze essenziali per affrontare le sfide globali, inclusi il cambiamento climatico e la giustizia sociale.
Sebbene molte delle iniziative descritte siano attualmente in corso in Nord America, esistono opportunità per implementare programmi simili anche in Italia.
YMCA Health vuoleo trarre ispirazione da questi modelli per sviluppare progetti locali che integrino la promozione della salute con la sostenibilità ambientale, adattandoli alle specificità del contesto italiano.
In conclusione, la YMCA rappresenta un esempio di come le organizzazioni possono integrare la promozione della salute con l’azione climatica, coinvolgendo attivamente le comunità e le nuove generazioni per costruire un futuro più sostenibile e resiliente.

di Raffaella Buzzetti
Presidente
e

della Società Italiana di Diabetologia
della Federazione delle Società di Diabetologia
Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana o un argomento confinato ai tavoli delle conferenze internazionali. È una realtà concreta che sta trasformando le nostre vite, le nostre città e i nostri sistemi sanitari. I suoi effetti, sebbene su larga scala, colpiscono in modo diseguale le fasce di popolazione più vulnerabili: tra queste, vi sono milioni di persone che convivono con il diabete, una delle patologie croniche più diffuse e complesse del nostro tempo.
Quando parliamo di cambiamento climatico, spesso ci soffermiamo sulle sue ripercussioni ambientali o economiche. Ma troppo poco si discute dell’impatto diretto sulla salute, e ancor meno sull’intersezione tra alterazioni climatiche e malattie croniche come il diabete. Eppure, la scienza ci dice chiaramente che esiste una relazione profonda, bidirezionale e preoccupante.
L’innalzamento delle temperature: un rischio sottovalutato
Le ondate di calore rappresentano uno dei fenomeni più tangibili del cambiamento climatico. Secondo i dati più recenti, esse sono diventate più frequenti, più lunghe e più intense. Per una persona con diabete, affrontare temperature elevate non è solo scomodo: può essere pericoloso.
I meccanismi di termoregolazione sono spesso compromessi nei soggetti diabetici, soprattutto se affetti da neuropatia autonomica. Questo li espone a un rischio aumentato di disidratazione, colpi di calore e scompensi metabolici. L’assunzione di farmaci ipoglicemizzanti, come l’insulina, può ulteriormente amplificare questo rischio, interferendo con la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress termico.
Inquinamento atmosferico e incidenza del diabete
L’inquinamento atmosferico, in particolare l’esposizione a particolato fine (PM2.5), rappresenta un’altra variabile ambientale strettamente legata sia all’insorgenza che all’aggravamento del diabete di tipo 2. Gli studi epidemiologici hanno dimostrato come le polveri
sottili siano in grado di attivare risposte infiammatorie sistemiche e di aumentare la resistenza insulinica.
Inoltre, vivere in aree urbane ad alta densità e con scarsa qualità dell’aria può scoraggiare l’attività fisica all’aperto, contribuendo indirettamente alla sedentarietà e all’obesità, due fattori chiave nello sviluppo della malattia diabetica. Non sorprende che le persone con diabete che vivono in zone fortemente inquinate mostrino più frequentemente complicanze cardiovascolari, una peggiore qualità del controllo glicemico e un rischio aumentato di ospedalizzazione.
Eventi climatici estremi: la fragilità delle cure croniche
Alluvioni, incendi, siccità e uragani sono manifestazioni sempre più frequenti della crisi climatica. Oltre ai danni diretti alle infrastrutture e alle abitazioni, questi eventi mettono a dura prova la capacità delle persone con malattie croniche di accedere ai servizi sanitari.
Le malattie infettive emergenti e il rischio aumentato per i diabetici
Il riscaldamento globale ha anche un effetto diretto sulla diffusione geografica di vettori di malattie infettive, come zanzare e zecche. Patologie come la dengue, la chikungunya o la malattia di Lyme stanno espandendo il proprio raggio d’azione verso latitudini precedentemente inattese. Le persone con diabete, che spesso presentano una compromissione della risposta immunitaria, sono più suscettibili a queste infezioni, con un rischio aumentato di complicanze.
Inoltre, la coesistenza di infezioni e malattia metabolica può comportare una maggiore instabilità glicemica, favorire l’insorgenza di chetoacidosi o ipoglicemie, e rendere più difficile l’erogazione delle cure.
Salute ambientale e salute metabolica: due facce della stessa medaglia
Alla luce di queste evidenze, è sempre più chiaro che
la salute dell’ambiente e la salute delle persone sono interdipendenti. È necessario adottare un approccio “One Health” che riconosca come il benessere umano, animale e ambientale siano parte di un unico ecosistema.
La prevenzione del diabete – così come la sua gestione efficace – passa anche da città più verdi, aria più pulita, sistemi alimentari sostenibili e modelli di mobilità che favoriscano l’attività fisica. L’adattamento ai cambiamenti climatici deve includere misure specifiche per proteggere le persone con malattie croniche, garantendo l’accesso continuo alle terapie e rafforzando la resilienza dei sistemi sanitari.
Conclusioni: un nuovo paradigma per la diabetologia
Come presidente della Società Italiana di Diabetologia e della Federazione delle Società Diabetologiche , credo sia nostro dovere portare la questione climatica al centro del dibattito scientifico e politico anche in ambito diabetologico. Dobbiamo formare professionisti consapevoli di queste nuove intersezioni, sensibilizzare i pazienti, promuovere ricerche interdisciplinari e costruire alleanze con chi si occupa di ambiente, urbanistica, trasporti e politiche alimentari.
La crisi climatica è una crisi anche della salute. E chi si occupa di cronicità non può più restarne ai margini. Solo una risposta integrata e lungimirante ci permetterà di proteggere le persone con diabete, oggi e nei decenni a venire.
Nota: Questo articolo è stato redatto integrando informazioni tratte da studi scientifici pubblicati su fonti autorevoli, tra cui la National Library of Medicine e il Diabetes Research and Clinical Practice.

di Alessandro Rossi
Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie
Il riscaldamento globale ha trasformato le ondate di calore in un rischio crescente per la salute pubblica. In Italia, ogni estate fa registrare un aumento di accessi ai servizi sanitari e decessi correlati al caldo eccessivo, con picchi tra i soggetti più fragili. In questo contesto, la Medicina Generale è chiamata a un ruolo cruciale: informare, prevenire, proteggere.
L’esposizione prolungata a temperature elevate non comporta solo disagio fisico, ma può determinare un peggioramento delle condizioni cliniche preesistenti, aumentare l’incidenza di eventi acuti e compromettere l’autonomia funzionale dei soggetti più fragili. Diventa quindi fondamentale promuovere strategie preventive basate su comportamenti protettivi semplici, ma efficaci (tab. 1).
Tabella 1. Il decalogo del Medico di famiglia per affrontare il caldo estremo
1. Idratarsi correttamente
Bere acqua frequentemente, anche senza avere sete. Evitare alcol e bevande zuccherate o molto fredde.
2. Alimentarsi in modo leggero
Preferire frutta e verdura di stagione. Ridurre cibi grassi e ricchi di proteine animali.
3. Vestirsi in modo adeguato
Abiti chiari, leggeri, traspiranti. Cappello a tesa larga e occhiali da sole quando si è all’aperto.
4. Rinfrescare gli ambienti domestici
Chiudere persiane e finestre esposte al sole. Usare ventilatori o climatizzatori con moderazione, puntando sulla funzione “deumidificatore” oppure mantenendo la temperatura indoor tra i 24 e i 26°C.
5. Evitare di uscire nelle ore più calde
Restare all’ombra o in ambienti climatizzati tra le 11 e le 18.
6. Prendersi cura dei vicini fragili
Offrire supporto a parenti, vicini o pazienti anziani che vivono soli.
7. Evitare sforzi fisici eccessivi Rimandare attività pesanti alle ore più fresche della giornata.
8. Controllare la propria terapia farmacologica Alcuni farmaci (diuretici, antipertensivi, psicotropi) possono aumentare il rischio di disidratazione o ipotensione. Consultare il medico di famiglia.
9. Monitorare segni di disidratazione o colpo di calore
Mal di testa, crampi, vertigini, confusione, febbre alta: in presenza di questi sintomi rivolgersi al proprio medico di famiglia.
10. Informarsi sui bollettini meteo-sanitari Seguire le indicazioni del Ministero della Salute e dei servizi locali di allerta.
Per essere davvero efficaci, le strategie di prevenzione devono tenere conto della diversa suscettibilità individuale agli effetti del caldo estremo. L’impatto sanitario del caldo, infatti, non è uniforme nella popolazione; alcuni gruppi presentano una maggiore vulnerabilità alle conseguenze delle ondate di calore, per condizioni cliniche, età o contesto socioassistenziale:
• Anziani, soprattutto se soli o non autosufficienti
• Persone con patologie croniche (cardiopatie, BPCO, diabete, insufficienza renale)
• Pazienti in trattamento con farmaci a rischio di disidratazione o termoregolazione alterata
• Neonati e bambini piccoli
• Persone con disabilità fisica o cognitiva
• Lavoratori esposti al sole o ad ambienti caldi
• Persone senza fissa dimora
Il Medico di medicina generale, grazie alla conoscenza diretta e continuativa dei propri assistiti e del loro contesto familiare e sociale, rappresenta un punto di osservazione privilegiato per individuare precocemente condizioni di fragilità e rischio. Questo ruolo lo rende centrale nella pianificazione e nell’attuazione di interventi di prevenzione personalizzati, soprattutto nei confronti dei pazienti più vulnerabili.
Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali ma una componente ricorrente della stagione estiva, è necessario che la sanità territoriale – e in particolare la Medicina Generale – sia preparata ad attivare misure concrete e tempestive, tanto nella pratica clinica quanto nella promozione di comportamenti protettivi. La prossimità e la continuità dell’assistenza, caratteristiche proprie della Medicina Generale, rappresentano strumenti fondamentali per tutelare la salute dei cittadini anche di fronte a questa nuova sfida ambientale. In ogni ambulatorio, in ogni casa, in ogni comunità: il Medico di famiglia c’è.

di Marco Ardigò
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas e Capo dell’Oncologia dermatologica dell’’Humanitas Research Hospital di Milano
Sottile mezzo millimetro nelle sedi dove più delicata e spessa solo pochi millimetri nel suo spessore massimo, la pelle funge da principale interfaccia e protezione dal mondo esterno. La pelle è esposta all’ambiente e deve resistere ai cambiamenti che si verificano intorno a noi, come l’aria secca stagionale e l’incremento stagionale delle radiazioni ultraviolette.
La pelle è estremamente sensibile ai cambiamenti climatici ed ecologici e per millenni, si è specializzata nel gestire le sfide ambientali, dai patogeni alle radiazioni ultraviolette.
Medici, ricercatori ed esperti di salute pubblica stanno lanciando l’allarme sull’impatto che il nostro pianeta, sempre più instabile e in continuo riscaldamento, sta lasciando sul nostro organo più grande e probabilmente più vulnerabile. L’esaurimento dell’ozono, le emissioni di gas serra e l’aumento delle temperature catalizzano cambiamenti sia atmosferici che comportamentali che aumentano il rischio di tumori della pelle a causa della maggiore esposizione ai raggi ultravioletti.
Da un lato è diffusamente dimostrato come i raggi solari siano un alleato del nostro umore, tanto che le fonti luminose sono spesso utilizzate anche per combattere le forme maggiori di depressione e che i benefici derivanti dall’esposizione solare comprendono anche una stimolazione della produzione di Vitamina D, importante per la salute di denti ed ossa, che risulta sempre più carente nella popolazione generale. Non bisogna pero’ dimenticare la possibilità di sviluppare danni da UV che vanno da scottature solari, invecchiamento cutaneo fino allo sviluppo di tumori della pelle sia melanoma che non melanoma come il carcinoma basocellulare o il carcinoma squamocellulare.
In Italia, negli ultimi anni si osserva un aumento dell’incidenza dei tumori cutanei in generale fra il 3 e 8%. Piu’ in dettaglio, da fonti della Societa’ Italiana di Dermatologia nel 2022 sono state registrate 12.700 nuove diagnosi di melanoma, con un incremento del
7% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è riscontrabile sia negli uomini che nelle donne e con un trend in aumento, con un +4.4%/anno nei maschi e +3.1%/anno nelle femmine, soprattutto nel CentroNord Italia e sembra essere dovuto a diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’aspettativa di vita e l’esposizione alle radiazioni solari aggravata dal cambiamento climatico. Quest’ultimo sembra aumentare indirettamente il rischio di cancro della pelle attraverso una maggiore esposizione alle radiazioni UV dovuta all’esaurimento dell’ozono e alle alterazioni meteorologiche, nonché attraverso un aumento dell’inquinamento atmosferico. I livelli misurati di radiazione ultravioletta sono ampiamente indipendenti dal calore e dall’umidità, tuttavia, l’aumento delle temperature può alterare il comportamento umano, portando a trascorrere più tempo all’aperto senza un’adeguata protezione, come la crema solare o indumenti protettivi. Inoltre, il riscaldamento globale allunga la stagione estiva con incremento del danno cutaneo indotto dalle radiazioni ultraviolette.
L’eccessiva e scorretta esposizione ai raggi solari, in particolare durante l’infanzia, è il principale fattore di rischio di insorgenza di melanoma, quindi la protezione della pelle è particolarmente importante dal punto di vista della prevenzione. Altri fattori associati allo sviluppo di melanoma sono: predisposizione familiare, fototipo basso e presenza di un numero elevato di nei. Anche le persone con fototipo scuro o con pochi nei devono prestare ugualmente attenzione all’eccessiva esposizione al sole, perché l’abbronzatura e le scottature comportano sempre un aumento di rischio nello sviluppo di tumori.
Sebbene nessuno possa essere completamente protetto dal cambiamento climatico e dalle sue minacce per la pelle, alcune popolazioni sono particolarmente a rischio. Medici e ricercatori sono preoccupati per le persone nei paesi in via di sviluppo, i senzatetto e gli sfollati,


di Floriana D’Ambrosio, Leonardo Villani
Osservatorio sulla Salute bene comune - Sezione di Igiene, Dipartimento
Universitario di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Nell’epoca della grande crisi climatica, le aree interne italiane, spesso ai margini dello sviluppo industriale e infrastrutturale, si pongono come crocevia tra vulnerabilità ambientali, dinamiche di spopolamento e opportunità concrete di rinascita ecologica e comunitaria. Questi territori, storicamente caratterizzati da una minore pressione antropica e da un rapporto più equilibrato con l’ambiente, sono al tempo stesso sempre più esposti e fragili di fronte all’intensificarsi degli effetti della crisi climatica. Il riscaldamento globale, l’alterazione dei regimi pluviali e l’aumento della siccità stanno trasformando in profondità il paesaggio rurale e montano, con conseguenze già visibili nella riduzione della produttività agricola, nel degrado dei suoli, nella perdita della biodiversità e nell’aumento del rischio idrogeologico e di incendi boschivi. Il loro peculiare contesto geografico, spesso montano o collinare, li rende particolarmente sensibili a questi mutamenti. Le aree interne si trovano ad affrontare eventi estremi, come frane, alluvioni e ondate di calore prolungate, in condizioni di isolamento infrastrutturale e con una rete di servizi essenziali, inclusi quelli sanitari, spesso inadeguata e in via di contrazione. La fragilità delle comunità locali si aggrava ulteriormente in assenza di strumenti di prevenzione efficaci, di una tempestiva assistenza in caso di emergenza e di un supporto sociale e psicologico adeguato. Qui si manifesta in modo lampante la visione Planetary Health: la salute delle persone è intrinsecamente e indissolubilmente legata alla salute degli ecosistemi in cui vivono. L’incuria ambientale, la perdita di equilibrio ecologico e il mancato investimento nella tutela del territorio si traducono direttamente in un peggioramento delle condizioni di salute umana, un onere particolarmente gravoso per popolazioni già vulnerabili.
Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, al 1 gennaio 2024, le aree interne italiane ospitavano circa 13,3 milioni di persone, distribuite in oltre 4000 comuni, pari a circa un quarto della popolazione nazionale. Tuttavia, tra il 2014 e il 2024, la popolazione residente in queste aree è diminuita del 5%, con punte del -6,3% nei comuni periferici e del -7,7% in quelli ultraperiferici. Questa emorragia demografica contribuisce a indebolire ulteriormente il tessuto sociale e la capacità di resilienza. In queste stesse aree, oltre un quarto degli abitanti ha più di sessantacinque anni e vive in contesti spesso privi dei principali servizi essenziali come trasporti efficienti, connettività digitale e presidi sanitari di base. Inoltre, il 49,6% della popolazione delle aree interne risiede in zone a rischio sismico elevato o molto elevato, con percentuali che superano il 56% nei comuni più periferici. Questa combinazione di declino demografico, invecchiamento progressivo della popolazione e accentuata esposizione a molteplici rischi ambientali acuisce in modo drammatico la necessità di un approccio che veda la salute in un contesto più ampio e interconnesso.
Nonostante queste sfide, le aree interne offrono opportunità uniche e inesplorate per una rinascita, sia ecologica sia sociale, che può fungere da modello per il resto del Paese. Valorizzare in modo sostenibile le risorse ambientali locali può diventare una leva strategica di sviluppo non solo per il territorio stesso, ma per l’intera nazione. I territori interni custodiscono una ricchezza ambientale straordinaria: dai bacini idrici, alle foreste, ai terreni agricoli fertili. Investire in pratiche di agricoltura sostenibile e biologica, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella gestione attiva e conservativa del patrimonio naturale e in forme di tu-

rismo lento e rispettoso del territorio significa promuovere nuove economie circolari, più radicate, resilienti e a basso impatto ambientale, capaci di rigenerare profondamente il tessuto sociale e ambientale. Se gestite con lungimiranza e secondo principi di sostenibilità, queste risorse possono generare valore economico e benessere collettivo duraturo, senza compromettere l’equilibrio degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi vitali.
Negli ultimi anni, sempre più persone guardano a questi contesti con rinnovato interesse. Giovani, famiglie, professionisti in cerca di stili di vita più sostenibili e a contatto con la natura, e anche migranti, stanno progressivamente riscoprendo le potenzialità delle aree interne, attratti dalla qualità della vita e dalla possibilità di contribuire a un modello di sviluppo diverso. Questo movimento, ancora frammentato ma in costante crescita, rappresenta una concreta opportunità di rigenerazione demografica e sociale, a condizione che sia sostenuto da politiche inclusive, capaci di garantire accesso ai servizi essenziali, alla mobilità efficiente e alla connettività digitale. Questo richiede un’applicazione concreta e diffusa del principio di “salute in tutte le politiche”, dove ogni settore, dai trasporti all’agricoltura, dall’urbanistica all’istruzione, riconosce e massimizza
il proprio impatto sulla salute pubblica e sulla sostenibilità ambientale. Le decisioni politiche non possono più essere prese in silos, ma devono considerare le loro ripercussioni incrociate. Riconoscere il potenziale di questi territori richiede quindi un cambio di prospettiva radicale, abbandonando la logica centro-periferia. È indispensabile promuovere una visione integrata e interconnessa dello sviluppo, che non separi rigidamente ambiente, salute, economia e coesione sociale, ma li consideri elementi sinergici di un unico sistema. La crisi climatica, con le sue conseguenze profonde e trasversali, ci impone di ripensare radicalmente il concetto stesso di sviluppo, non più basato solo sulla crescita economica, ma riportando al centro la qualità della vita, la resilienza delle comunità e la cura dei luoghi e degli ecosistemi. L’impegno non è solo ecologico o sanitario, ma profondamente etico e sociale: garantire che nessuna comunità, e nessun individuo, sia lasciato indietro in questa transizione epocale, fornendo le risorse e il supporto necessari alle aree e alle popolazioni che sono in prima linea di fronte ai cambiamenti climatici e al depauperamento demografico. Il futuro del Paese, e la sua capacità di affrontare le sfide globali, passa anche dalla rigenerazione delle sue aree interne



di Ludovica Bricca, Fabio Panariello
Osservatorio sulla Salute bene comune - Sezione di Igiene, Dipartimento Universitario di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Introduzione. La nuova grammatica della crisi climatica
Per lungo tempo, il cambiamento climatico è stato confinato nel perimetro delle questioni ambientali, percepito come un problema di “lontani orizzonti”: lo scioglimento dei ghiacci polari, l’innalzamento dei mari, le estinzioni di specie esotiche. Ma oggi è sempre più evidente che si tratta di un fenomeno sistemico, concreto, che incide in modo diretto sulla salute degli individui e sul funzionamento stesso delle città.
Il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale: è una crisi sanitaria. E, soprattutto, è una crisi urbana. Le città, dove vive oltre il 55% della popolazione mondiale, sono i luoghi in cui gli impatti si manifestano in modo più drammatico, ma anche dove le risposte possono essere più efficaci. L’urbanizzazione intensiva, la densità abitativa, le isole di calore, le disuguaglianze sociali e ambientali rendono l’ambiente urbano un crocevia critico nella relazione tra salute e clima.
Parlare oggi di cambiamento climatico significa ripensare la salute pubblica, l’equità, l’economia urbana e le scelte politiche. Significa, in altre parole, riscrivere la grammatica della pianificazione urbana e sanitaria nel XXI secolo.
I molteplici impatti del cambiamento climatico sulla salute
Caldo estremo: una nuova emergenza urbana
L’aumento delle temperature medie globali sta rendendo sempre più frequenti le ondate di calore. Questi eventi non sono semplici giornate afose, ma vere e pro-
prie emergenze sanitarie. Le ondate di calore aggravano patologie preesistenti – cardiovascolari, respiratorie, renali – e colpiscono con forza i soggetti più vulnerabili: anziani, bambini, lavoratori esposti, persone che vivono sole o in abitazioni poco ventilate.
L’episodio estivo del 2003, che causò oltre 70.000 decessi in Europa, resta emblematico. In Italia, il 92% della mortalità in eccesso colpì persone sopra i 75 anni. In Francia, centinaia di corpi non vennero reclamati per le esequie, rivelando una drammatica combinazione tra fragilità fisica e isolamento sociale. Le città furono l’epicentro di questa crisi.
Eventi meteorologici estremi e sistemi sanitari sotto pressione
Alluvioni, siccità, incendi boschivi, tempeste sempre più intense: il cambiamento climatico alimenta eventi estremi che mettono a dura prova le infrastrutture urbane, inclusi ospedali, centri di primo soccorso e reti idriche. Le alluvioni, ad esempio, provocano traumi, contaminano le acque, distruggono impianti sanitari e causano malattie trasmesse dall’acqua. Gli incendi, aggravati da siccità prolungate, causano crisi respiratorie e cardiovascolari, anche a centinaia di chilometri di distanza.
In un contesto di risorse limitate, la tenuta dei sistemi sanitari urbani dipende dalla capacità di adattamento infrastrutturale, logistico e tecnologico. Senza una pianificazione anticipatoria, la risposta agli eventi estremi resta vulnerabile.
Ecosistemi alterati, malattie amplificate
Il cambiamento climatico modifica gli equilibri ecolo-
gici che regolano la trasmissione di molte malattie. Le alterazioni di temperatura e umidità stanno espandendo la geografia di malattie trasmesse da vettori: la dengue, il virus del Nilo occidentale, la chikungunya, e persino la malaria tornano a minacciare territori prima ritenuti sicuri, anche in Europa meridionale.
In parallelo, l’inquinamento atmosferico, la desertificazione e la perdita di biodiversità aggravano patologie croniche e allergiche, contribuendo a un carico sanitario aggiuntivo che si accumula silenziosamente ma inesorabilmente.
L’urbanizzazione amplifica i rischi, ma può generare soluzioni
Le città sono al tempo stesso vittime e vettori del cambiamento climatico. Da un lato, concentrano le emissioni (traffico, riscaldamento, industria); dall’altro, ospitano le popolazioni più esposte e le infrastrutture sanitarie più critiche. L’urbanizzazione non pianificata aggrava l’esposizione ai rischi ambientali: quartieri informali costruiti in zone inondabili, mancanza di verde urbano, insufficiente accesso all’acqua potabile.
Tuttavia, le città rappresentano anche il principale laboratorio per la resilienza climatica. Investire in mobilità sostenibile, riqualificazione energetica, tetti verdi, corridoi ecologici, sistemi di allerta precoce e sanità territoriale significa agire localmente per mitigare e adattarsi a una crisi globale.
La prospettiva della “Salute nelle politiche urbane” –già promossa dall’OMS con il programma Healthy Cities – è oggi più urgente che mai. Non basta una sanità curativa: serve una sanità urbana preventiva e ambientale, che operi nei quartieri, nelle scuole, negli spazi pubblici.
Giustizia climatica e salute: un nodo etico e politico
Il cambiamento climatico è anche un potente moltiplicatore di disuguaglianze. I Paesi che hanno storicamente emesso più gas serra – in Europa, Nord America e Asia orientale – sono spesso quelli meglio equipaggiati per proteggersi. Al contrario, molte comunità nel Sud globale, che hanno contribuito in misura marginale al problema, affrontano gli impatti più gravi con sistemi sanitari fragili, economie vulnerabili e capacità di adattamento limitate.
Anche all’interno dei Paesi occidentali le disuguaglianze sono evidenti. Chi vive in quartieri densamente popolati, senza accesso al verde, in abitazioni malsane o con redditi bassi, subisce più intensamente gli effetti del clima. È in gioco una giustizia sanitaria e climatica che impone scelte politiche chiare: chi deve pagare i costi della transizione? Chi riceverà supporto per adat-
tarsi? Come redistribuire i benefici di un’economia a basse emissioni?
Decarbonizzare il settore sanitario: parte del problema, parte della soluzione
Paradossalmente, il settore sanitario – pur avendo la missione di proteggere la salute – è responsabile di circa il 4,4% delle emissioni globali. Se fosse un Paese, sarebbe il quinto emettitore al mondo. Questa impronta climatica è dovuta a consumi energetici, trasporti, catene di fornitura, rifiuti sanitari e uso di farmaci ad alta intensità carbonica (come alcuni anestetici gassosi).
La decarbonizzazione del settore sanitario è quindi un’urgenza strategica e morale. Serve una sanità “climate-smart”: ospedali alimentati da energie rinnovabili, sistemi di efficienza energetica, trasporti a basse emissioni, digitalizzazione sostenibile (telemedicina, monitoraggio remoto), procurement verde, gestione intelligente dei rifiuti.
Ma serve anche un cambiamento culturale. I professionisti sanitari devono essere formati a considerare la sostenibilità ambientale come parte integrante della cura. Le società scientifiche possono includere l’impatto ambientale nelle linee guida terapeutiche. La sanità può – e deve – guidare l’esempio.
Politiche integrate: città, salute e clima nella stessa agenda
L’intersezione tra clima, salute ed economia impone un nuovo modello di politica pubblica, capace di agire trasversalmente. Le città, in particolare, possono diventare “policy hub” della transizione giusta. Alcune priorità emergono con chiarezza:
• Piani di adattamento urbano integrati, che includano la protezione delle infrastrutture sanitarie, la mappatura delle vulnerabilità, la gestione delle emergenze.
• Trasporti pubblici sostenibili e accessibili, per ridurre emissioni e migliorare la qualità dell’aria.
• Pianificazione urbana verde e resiliente, con spazi pubblici fruibili, zone d’ombra, orti urbani, piste ciclabili.
• Educazione alimentare e accesso a diete sane, in linea con i principi della dieta mediterranea.
• Investimenti in salute territoriale e prevenzione ambientale, soprattutto nei contesti più fragili.
Caso studio: la dieta mediterranea come strumento di prevenzione clima-salute
Uno studio pubblicato su Nutrients nel 2024 ha stimato i benefici economici e sanitari derivanti da una più ampia adozione della dieta mediterranea: riduzione della spesa sanitaria pubblica, prevenzione delle malattie croniche, maggiore sostenibilità ambientale. Le politiche pubbliche dovrebbero favorire l’accessibilità economica a questi alimenti, limitarne il marketing dannoso (soprattutto verso i bambini) e integrarli nei programmi educativi.
Anche in ambito urbano, la promozione di mercati locali, orti condivisi e filiere corte può contribuire a costruire un ecosistema alimentare più sano e resiliente, con effetti benefici tanto per la salute quanto per il clima.
Il ruolo delle tecnologie emergenti: dati, simulazioni, IA
Le tecnologie immersive – come i digital twin, la realtà aumentata, la sensoristica ambientale e l’intelligenza artificiale – offrono nuovi strumenti per affrontare la complessità del cambiamento climatico in ambito urbano. Simulazioni di eventi estremi, mappe interattive del rischio, modelli predittivi per l’inquinamento o per la diffusione di patologie ambientali: la città può diventare un ambiente intelligente in cui i dati supportano decisioni tempestive e basate su evidenze.
Ma per farlo servono investimenti in infrastrutture digitali pubbliche, formazione multidisciplinare, interoperabilità tra sanità, ambiente, urbanistica e protezione civile.
Conclusione. Salute e clima: un’agenda per le città del futuro
Il cambiamento climatico non è un capitolo da aggiungere all’agenda sanitaria: è l’agenda stessa. La salute delle popolazioni urbane dipende oggi da scelte che riguardano l’ambiente, l’equità, le infrastrutture, le politiche fiscali e l’architettura del welfare.
Le città non devono subire la crisi climatica: possono guidare una trasformazione profonda, fondata su coesione, innovazione e giustizia. Le amministrazioni locali, i servizi sanitari, i professionisti, gli urbanisti, le comunità devono costruire insieme una visione condivisa del benessere urbano.
Una visione in cui salute del pianeta e salute delle persone non siano più mondi separati, ma un’unica responsabilità collettiva.
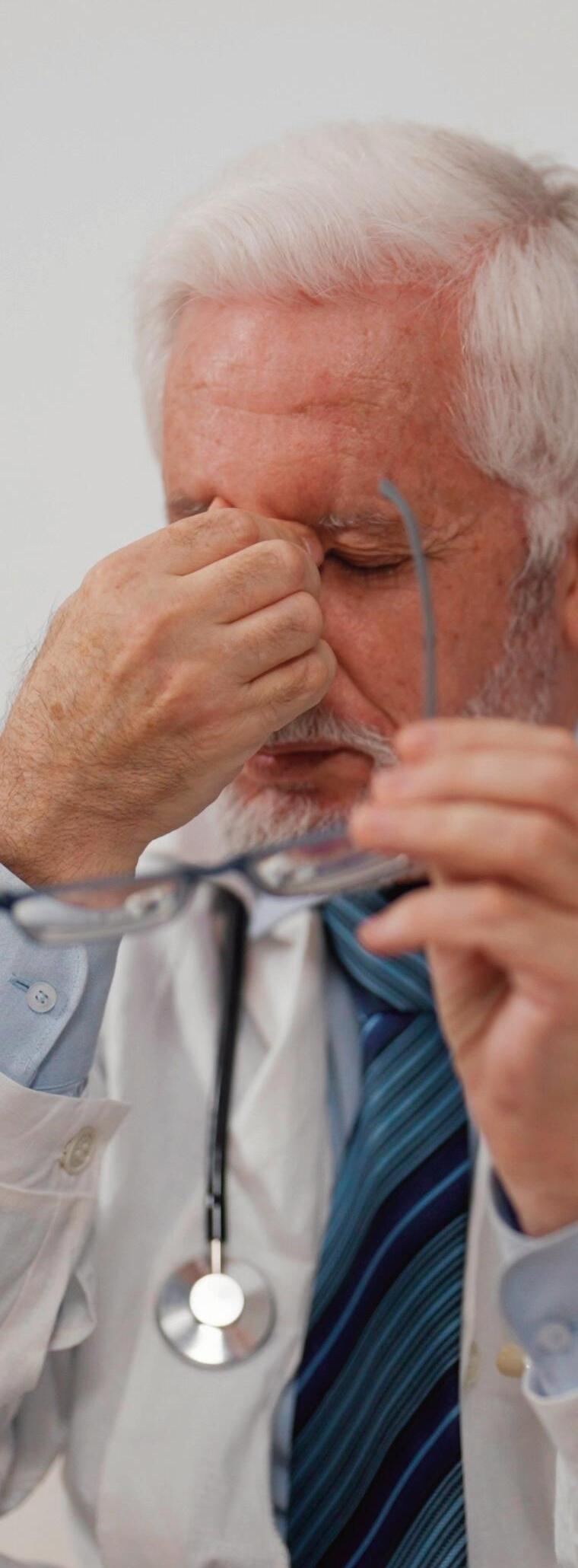

Cities for Better Health e la European Cyclists’ Federation (ECF) hanno lanciato la Healthy Cycling Challenge 2025, un’iniziativa internazionale che invita città e organizzazioni a presentare progetti scalabili e guidati dalla comunità per promuovere l’uso della bicicletta. L’obiettivo è migliorare la salute pubblica, rafforzare la resilienza climatica e ampliare la mobilità urbana equa.
Ciclismo come Strumento di Salute Pubblica
Il ciclismo regolare è una forma di attività fisica quotidiana che contribuisce a ridurre il rischio di malattie croniche come l’obesità, le malattie cardiache e il diabete di tipo 2. Inoltre, pedalare al posto di guidare riduce le emissioni di traffico, portando a una diminuzione dell’inquinamento atmosferico e a un ambiente più sano.
La bicicletta rappresenta anche un’opzione di trasporto inclusiva per le comunità svantaggiate, offrendo un mezzo accessibile per raggiungere lavoro, istruzione e assistenza sanitaria.
Principi Guida della Sfida
Ogni proposta deve allinearsi ad almeno uno dei due principi fondamentali:
1. Quartieri attivi e accessibili: promuovere il ciclismo quotidiano nelle comunità locali, garantendo che tutti i residenti possano scegliere di pedalare in sicurezza per brevi tragitti.
2. Infrastrutture resilienti ed eque: creare o migliorare infrastrutture ciclabili sicure, durevoli e progettate per tutti.
Inoltre, i partecipanti sono incoraggiati a incorporare due principi opzionali:
• Spazi pubblici vivaci e sicuri
• Destinazioni integrate e connesse
Questi principi mirano a creare aree pubbliche vivaci e sicure e a collegare il ciclismo con altri mezzi di trasporto e destinazioni chiave.
Premi e Scadenze
La Healthy Cycling Challenge accoglie una vasta gamma di idee e innovazioni adattabili ai contesti locali e scalabili per un impatto più ampio. Tre proposte eccezionali riceveranno ciascuna 100.000 USD per realizzare le loro idee trasformative.
Le candidature sono aperte fino al 26 giugno 2025.
Per ulteriori informazioni e per presentare una proposta, visita il sito ufficiale: citiesforbetterhealth.com
coloro che hanno meno risorse finanziarie e coloro che vivono in aree con infrastrutture sanitarie o un’istruzione limitate. Ad esempio, individui affetti da albinismo sono particolarmente vulnerabili al cancro della pelle a causa della mancanza di melanina nella pelle, che protegge dai danni dei raggi UV.
Al fine di prevenire lo sviluppo del melanoma e degli altri tumori cutanei, occorre proteggersi mediante un abbigliamento adeguato (es. cappelli, magliette…) e creme schermanti, preferibilmente con alto fattore di protezione (SPF 50+). Inoltre, limitare l’esposizione al sole, soprattutto nelle ore di massima esposizione ai raggi UV (dalle 10:00 alle 15:00) e utilizzare la protezione solare sono misure preventive fondamentali. Se la prevenzione primaria dei tumori cutanei risiede nelle mani degli individui e sostenuta da una adeguata informazione, la diagnostica precoce (prevenzione secondaria) rimane presidio per medici e personale medico ed è fondamentale al fine di individuare lesioni cutanee modificatesi nel tempo o di nuova insorgenza, per asportarli al fine di un corretto inquadramento istologico. Gli stadi iniziali di melanoma, infatti, possono essere trattati efficacemente con la sola escissione chirurgica.
Inoltre, comprendere il cambiamento climatico, implementare lo sviluppo di percorsi educazionali sulla adeguata protezione dalle radiazioni ultraviolette unitamente ai percorsi sanitari volti all’identificazione precoce dei pazienti a rischio, rappresentano mezzi efficaci per contrastate l’incremento dei tumori cutanei e controllarne l’impatto sulla salute dei cittadini.


Bari ha recentemente aderito al programma globale
“Cycle for Better Health”, un’iniziativa promossa da Cities for Better Health in collaborazione con BYCS, con l’obiettivo di migliorare la salute dei bambini attraverso il ciclismo. Si tratta di un progetto internazionale che mira a promuovere l’attività fisica tra i più giovani, soprattutto nelle comunità vulnerabili, offrendo loro l’opportunità di apprendere e praticare il ciclismo in un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante.
Un programma per la salute e l’inclusione
Il progetto si rivolge ai bambini tra i 6 e i 12 anni dei quartieri di San Paolo, Libertà e San Nicola, attraverso una serie di workshop scolastici in cui i partecipanti imparano non solo le basi del ciclismo — equilibrio, frenata, sicurezza — ma anche competenze trasversali come l’autonomia e la fiducia in sé stessi.
L’obiettivo è coinvolgere tra i 500 e i 750 bambini, con una particolare attenzione all’inclusione delle bambine, grazie a iniziative mirate come il Girls on Bike Bootcamp. A supportare l’iniziativa sul territorio c’è Terreno Cycling Therapy, partner locale con una lunga esperienza nell’organizzazione di programmi di ciclismo terapeutico e attività dedicate all’empowerment femminile su due ruote.
Un movimento globale che cresce
Con questa adesione, Bari si unisce ad altre città del mondo che hanno già implementato con successo il programma, come Bogotá (Colombia) e Bratislava
(Slovacchia). I risultati internazionali sono significativi: a Bogotá, oltre il 90% dei partecipanti ha aumentato la consapevolezza sui benefici del ciclismo per la salute e più dell’85% di chi non aveva mai pedalato prima ha acquisito le competenze base per farlo.
Il programma si dimostra quindi efficace nel promuovere uno stile di vita attivo, trasformando un’attività ricreativa in uno strumento di prevenzione sanitaria e crescita personale.
Verso una città più sana e sostenibile
“Cycle for Better Health” non è solo un progetto sportivo. L’obiettivo più ampio è quello di trasformare il ciclismo in un mezzo di trasporto quotidiano per i bambini, incentivando spostamenti casa-scuola, interazioni sociali autonome e abitudini sostenibili.
In questo modo, il progetto favorisce l’attività fisica, la mobilità dolce, la riduzione dell’inquinamento urbano e la costruzione di una cultura ciclabile nelle nuove generazioni.
Una sfida educativa e sociale
La partecipazione della città di Bari a questo programma globale rappresenta un passo concreto verso una visione urbana più sana, equa e attenta all’ambiente. Insegnare ai bambini a pedalare oggi significa formare cittadini consapevoli e attivi domani, capaci di scegliere stili di vita salutari e di contribuire, con piccoli gesti quotidiani, al benessere della comunità.

di Antonio Gaudioso
Tra eventi climatici estremi e innovazione tecnologica: come il settore vitivinicolo italiano sta reagendo tra crisi produttive, tecnologie emergenti e nuove consapevolezze culturali
Il cambiamento climatico, con i suoi effetti sempre più evidenti e frequenti, è ormai una realtà che sta trasformando radicalmente ogni aspetto della nostra vita: dalla salute alla filiera produttiva, dall’agricoltura ai flussi migratori. Uno dei settori più colpiti è quello vitivinicolo, cuore pulsante della cultura, dell’economia e dell’identità italiana. Le stagioni, sempre più polarizzate tra ondate di caldo estremo e freddo intenso, siccità prolungate e precipitazioni violente, stanno profondamente alterando la produzione vinicola. Negli ultimi anni, eventi climatici estremi hanno avuto effetti devastanti. Emblematico è il caso della peronospora, che solo due anni fa ha causato perdite fino al 70-80% della produzione in alcune regioni italiane, con gravi ricadute economiche per le aziende agricole. Non si tratta più, dunque, solo di osservare passivamente un fenomeno: serve una reazione concreta. È fondamentale interrogarsi su come mitigare gli effetti di fenomeni che rischiano di diventare irreversibili. La risposta passa necessariamente da scelte politiche lungimiranti e da un ripensamento del modo in cui conviviamo con una nuova realtà ambientale.
Il settore vitivinicolo si sta già muovendo in questa direzione. Accanto alle pratiche tradizionali, si stanno diffondendo tecnologie avanzate per prevenire e gestire meglio gli impatti climatici. Tra queste, i controlli satellitari e l’uso di droni per il monitoraggio delle vigne e l’applicazione mirata dei trattamenti, ma anche lo sviluppo di varietà più resistenti. Un esempio promettente è rappresentato dalle viti Piwi, piante ottenute tramite innesti naturali che mostrano una maggiore resistenza a malattie e condizioni climatiche avverse. Pioniere in questo campo è la Germania, ma anche l’Italia sta sperimentando queste soluzioni con crescente interesse, cercando di comprenderne gli effetti sia sulla produzione che sulla qualità del vino.
Tuttavia, l’adozione di queste innovazioni non è priva di ostacoli. Le resistenze culturali rappresentano una sfida significativa: i disciplinari del vino, frutto di secoli di tradizione, spesso faticano ad adattarsi a pratiche più moderne. È dunque fondamentale trovare un equilibrio tra conservazione e progresso, aggiornando i re-
golamenti in modo da favorire la sostenibilità senza snaturare l’identità storica del vino.
A rendere ancora più urgente il cambiamento è l’aumento costante delle temperature, che ha già portato a un innalzamento del grado alcolico dei vini. Basti pensare che, fino a 15 anni fa, un vino come il Chianti presentava una gradazione intorno ai 12 gradi; oggi si arriva facilmente a 13,5 o 14. Un incremento così rapido riflette un cambiamento ambientale profondo, che incide non solo sulla produzione, ma anche sulle abitudini dei consumatori.
Di conseguenza, in questo contesto, sostenibilità significa anche promuovere un consumo informato e moderato.
Il vino è parte della nostra storia, ma ignorare il rischio di abuso sarebbe irresponsabile. Occorre avviare una nuova stagione di informazione consapevole, che racconti il valore ambientale, culturale e produttivo del vino, ma anche l’impegno delle imprese nella transizione ecologica. Educare i consumatori è essenziale per rendere il cambiamento sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale.
Le imprese del settore stanno già dimostrando una notevole capacità di adattamento. Cresce, ad esempio, l’offerta di vini a basso contenuto alcolico, pensati per rispondere ad una domanda di uno stile di consumo più leggero. Altre aziende, invece, stanno sperimentando la produzione di vini bianchi a partire da bacche rosse, una scelta che consente di non estirpare interi vigneti per impiantare nuove varietà di uva, adattandosi alle richieste di mercato.
Ma l’impatto climatico non si limita alle coltivazioni: grandinate, siccità e piogge intense stanno facendo aumentare drasticamente i premi assicurativi, mettendo a rischio la sostenibilità economica del sistema. Quando il rischio diventa certezza, assicurare le colture non è più possibile, né per le imprese né per le compagnie.
In definitiva, il cambiamento climatico pone sfide complesse, ma apre anche nuove strade.
Coniugare tradizione e innovazione, passato e futuro, è la vera opportunità per un salto di qualità che coinvolga l’intera filiera, verso un modello più consapevole, resiliente e responsabile.

Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, il nostro corpo affronta un cambiamento importante: il metabolismo rallenta, il fabbisogno di acqua aumenta e il desiderio di leggerezza prende il sopravvento. È proprio in questi momenti che il cibo può diventare un grande alleato, se scelto e preparato con attenzione.
Combattere il caldo a tavola significa ascoltare i segnali del corpo, idratarsi correttamente e prediligere alimenti freschi, stagionali, ricchi di acqua, sali minerali e vitamine. Ma vuol dire anche portare in tavola colore, creatività e sapore, trasformando ogni pasto in un momento di benessere.
Idratazione: la prima regola del benessere
L’idratazione non passa solo dall’acqua che beviamo, ma anche da quella che mangiamo. Frutta e verdura, infatti, sono composte per oltre il 90% da acqua e rappresentano un modo naturale e gustoso per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. Melone, anguria, cetrioli, pomodori, zucchine, pesche, albicocche e lattuga sono alimenti ideali per contrastare la disidratazione e mantenere freschezza interna.
Bere almeno due litri d’acqua al giorno è fondamentale, ma possiamo arricchire la nostra routine con:
• Acque aromatizzate con fette di limone, cetriolo, menta o zenzero.
• Tisane fredde a base di finocchio, melissa, karkadè o camomilla.
• Centrifugati e frullati di frutta e verdura, da gustare a merenda o a colazione.
Cosa evitare quando fa caldo
Quando le temperature superano i 30 gradi, alcuni alimenti diventano veri nemici del nostro benessere:
• I piatti elaborati, con salse e condimenti pesanti.
• I fritti e i cibi molto grassi, che appesantiscono la digestione e aumentano la temperatura corporea.
• Le carni rosse in grandi quantità.
• Le bevande alcoliche o zuccherate, che danno una
falsa sensazione di freschezza ma aumentano la disidratazione.
Gli alleati perfetti: cosa portare in tavola
Per rendere la nostra alimentazione un’arma contro l’afa estiva, ecco le categorie alimentari da privilegiare:
1. Frutta e verdura di stagione
Oltre a idratare, sono ricche di antiossidanti e vitamine che aiutano a combattere l’azione dei raggi solari. L’anguria è un vero superfood estivo: dissetante, ricca di licopene e povera di calorie. I cetrioli rinfrescano, drenano e si prestano a piatti veloci. Le carote aiutano la pelle a difendersi dal sole grazie al betacarotene.
2. Cereali integrali e piatti unici freddi
Riso, farro, quinoa e couscous possono diventare basi perfette per piatti freddi. Aggiungendo legumi, verdure grigliate e un filo d’olio extravergine, otterremo pasti completi, nutrienti e digeribili.
3. Proteine leggere
Meglio optare per pesce azzurro (sgombro, alici, tonno), carni bianche (pollo, tacchino) e formaggi freschi (mozzarella, stracciatella, ricotta). Anche le uova, se consumate sode o in insalata, possono offrire una soluzione proteica bilanciata.
4. Latticini freschi e yogurt
Lo yogurt, in particolare se bianco e senza zucchero, è ricco di fermenti lattici utili alla digestione e si sposa perfettamente con frutta, miele, cereali o verdure per piatti salati.
Idee pratiche per il menu estivo
Ispirandoci alle proposte di La Cucina Italiana, possiamo reinventare i classici della tradizione con ingredienti rinfrescanti e abbinamenti inediti. Ecco alcune idee:
Antipasti e piatti leggeri
• Tartare di cetrioli con menta e yogurt greco: cremosa e croccante, ideale per un inizio fresco.
• Insalata di anguria e feta con pesto di olive nere: salino e dolce si incontrano in una combinazione irresistibile.
Primi piatti freddi
• Couscous con melone, cipollotto e triglie grigliate: un piatto unico colorato, perfetto anche da portare al mare.
• Pasta fredda con pomodorini, basilico, capperi e limone: profumi mediterranei per un pranzo leggero.
Zuppe fredde
• Gazpacho di anguria, pomodoro e mandorle: una zuppa alternativa, dolce e speziata al tempo stesso.
• Vellutata fredda di zucchine e menta: da servire con crostini integrali.
Dessert e merende
• Sorbetto di anguria e pompelmo: da provare anche in abbinamento a pesce crudo per un antipasto gourmet.
• Smoothie di pesca, banana e basilico: cremoso e profumato, perfetto per la colazione.
Piccoli consigli per grandi benefici
• Cucina la sera: preparare i pasti dopo il tramonto consente di evitare il calore dei fornelli nelle ore più calde.
• Fraziona i pasti: meglio 4-5 pasti leggeri al giorno che abbondanti portate in un solo momento.
• Scegli metodi di cottura leggeri: vapore, griglia, forno statico a basse temperature.
• Sfrutta le erbe aromatiche: menta, basilico, timo e salvia regalano freschezza senza aggiungere calorie.
Mangiare bene in estate è un esercizio di equilibrio tra gusto e benessere. “Combattere il caldo a tavola” non significa rinunciare alla buona cucina, ma imparare a scegliere ciò che fa bene al corpo, alleggerisce la mente e rispetta la stagionalità. Con un po’ di creatività e consapevolezza, ogni pasto può diventare un’occasione per prendersi cura di sé, anche quando il termometro segna 35 gradi.
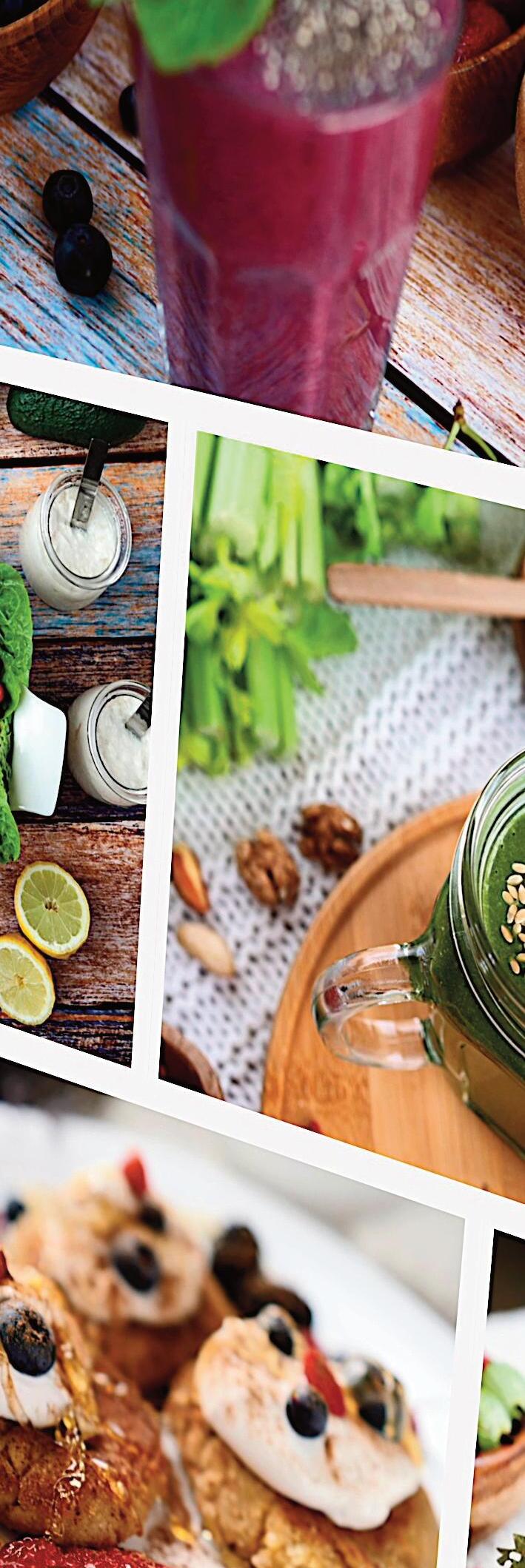



Alessandro Indovina
Secretary General Ymca Italy presso Ymca Italy Federation
L’Assemblea nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani – YMCA ha eletto Federico Serra Presidente per il quadriennio 2025–2028. Contestualmente, il Comitato Nazionale ha confermato Alessandro Indovina nel ruolo di Segretario Generale, valorizzando il suo percorso e la sua visione strategica.
Federico Serra, già Presidente di YMCA Health, vanta una consolidata esperienza nella promozione della salute pubblica, nelle politiche giovanili, nell’advocacy internazionale e nella cooperazione. Il suo mandato si apre in una fase in cui l’associazionismo è chiamato ad essere motore di comunità resilienti, inclusive e spiritualmente vive.
«Essere chiamato a guidare YMCA Italia è per me un onore profondo e una responsabilità. La nostra casa, basata sul dialogo e sulla speranza, vuole essere una fucina di relazioni autentiche e di opportunità per i giovani. Tra le priorità vi è il rilancio del progetto YCare, ispirato al modello internazionale che promuove il counselling giovanile, il rafforzamento della salute mentale e la partecipazione intergenerazionale. In un’epoca segnata da fragilità e isolamento, vogliamo essere la presenza che fa la differenza».
YMCA, fondato a Londra nel 1844, oggi opera in oltre 120 Paesi, con più di 10.000 sedi locali e coinvolge circa 65 milioni di persone ogni anno. In Italia, la Federazione è presente in 8 sedi territoriali e raggiunge direttamente o indirettamente oltre 300.000 persone attraverso attività sportive, educative, culturali, spirituali, dialogo interreligioso e volontariato.
Nel prossimo quadriennio, YMCA Italia intensificherà l’azione nelle aree più vulnerabili del Paese, sviluppando progetti di partenariato internazionale, promuovendo il benessere psicofisico dei giovani, il dialogo intergenerazionale, la prevenzione del disagio giovanile e la testimonianza dei valori cristiani, in coerenza con il Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani del Vaticano.
Confermato Segretario Generale, Alessandro Indovina ha dichiarato: «In questo nuovo quadriennio, proseguiremo il cammino avviato verso la nascita dell’Università YMCA, un progetto già in corso come interlocuzione con il MIUR e supporto della Fondazione YMCA Italia. È un percorso che mira a costruire un ateneo innovativo, capace di formare giovani leader con competenze integrali. Parallelamente, rafforzeremo il Centro di Formazione di Anagni e restituiremo centralità alla storica sede e agli impianti sportivi dell’EUR, trasformandoli in laboratori permanenti di sport sociale, cultura e comunità».
Le nomine sono state accolte positivamente dai vertici dello YMCA a livello internazionale. Carlos Sanvee, Segretario Generale del World YMCA, ha sottolineato che “l’Italia è un pilastro storico della nostra Alleanza globale. La nuova leadership rafforzerà il legame tra spiritualità, giustizia sociale e innovazione educativa nei contesti più vulnerabili”. Analogamente, Juan Simoes Iglesias, Segretario Generale di YMCA Europe, ha dichiarato che “la visione espressa da YMCA Italia è perfettamente allineata alla Vision2030 e permetterà di costruire risposte concrete e inclusive ai bisogni dei giovani in tutta Europa”.
Con questo rinnovamento, YMCA Italia riafferma la sua vocazione: generare futuro attraverso accoglienza, educazione, spiritualità e cittadinanza attiva, radicata nei tre pilastri fondanti: corpo, mente e spirito.



di Teresa Bonacci
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione istituzionale Federsanità e Francesco Colavita, Dirigente area strategica, Asl Salerno
Il nodo centrale della rete dell’assistenza sui territori, oggi, è rappresentato dalla capacità di connessione tra i vari attori che compongono il sistema di presa in carico della comunità. Infatti, se si è presenti ma non connessi si è soli. Il concetto stesso di comunità – o di community building, alla base dei provvedimenti normativi come il DM 77/2022 o della Legge Delega 33/2023, è la costruzione di un sistema di welfare sociosanitario e socioassistenziale che si occupi della persona.
Il grado di connessione caratterizza la garanzia di risposta di un sistema complesso e, allo stesso tempo, di partecipazione al welfare sociosanitario. Più aumenta la connessione, tanto più i servizi vengono utilizzati in maniera appropriata e veloce.
Vi sono poi posti dove connettere i servizi è più complesso rispetto ai centri urbani dove la tecnologia e la rete di offerta è sicuramente favorita. Sono le aree interne del Paese dove, effettivamente, si combatte la partita della “casa come primo luogo di cura e dei servizi di integrazione sociosanitaria”. Seppur dal punto di vista tecnologico il gap sia difficile da ridurre, dal punto di vista della comunità è sicuramente più facile integrare le attività delle Istituzioni e del volontariato rispetto agli obiettivi comuni della socialità e del vivere comune.
Partendo quindi dalle loro specificità, da considerarsi come risorsa e non come svantaggio, si dovrà valorizzare il ruolo delle aree interne come territori con uno specifico grado di potenzialità rispetto alle politiche di sviluppo economico e coesione sociale. Una vera, grande e inequivocabile questione che deve veder impegnata la programmazione di politiche sociosanitarie nella ricerca di modelli che garantiscano l’equità della salute e una migliore vivibilità per i cittadini, ricostruendo sistemi di sanità di prossimità, utili a garantire i livelli di assistenza di base, in territori dove lo spopolamento e la desertificazione la fanno da padrona.
Nel vasto territorio della Asl di Salerno, 158 Comuni che fanno riferimento a 13 Distretti Sanitari, la risposta a questo stato di cose si chiama “Punto di Facilitazione Digitale”, un progetto innovativo, realizzato in collaborazione con la Regione Campania, che mira a rendere più accessibili i servizi digitali sanitari. Inaugurati i primi a gennaio scorso, saranno complessivamente circa 40 quelli attivati su tutto il territorio con l’obiettivo di promuovere l’inclusione digitale e sviluppare competenze di base indispensabili per il lavoro, la crescita personale e la cittadinanza attiva.
Ma cosa avviane nei punti di facilitazione digitali? I cittadini vengono aiutati ad utilizzare i servizi digitali resi disponibili dalla Regione tramite l’accesso al Portale Salute del Cittadino: Spid, Fascicolo Sanitario elettronico, Scelta e revoca del medico, CUP prenotazioni on line, pagamento ticket sanitari, ecc. Il servizio non si limita ai cittadini meno esperti con la tecnologia - i cosiddetti “non nativi digitali” - ma si rivolge anche al personale dell’ASL, fornendo formazione e assistenza per migliorare l’efficienza interna e l’accesso ai servizi regionali.
I Punti di facilitazione rientrano in una strategia più generale di azione sul territorio rispetto alla presa in carico nei territori più interni e disagiati. L’Asl di Salerno ha infatti realizzato un modello sperimentale, integrando il DM/77 nella rete territoriale di assistenza delle Case e degli Ospedali di Comunità, per portare i servizi sanitari e socio-sanitari nelle aree del Cilento interno: le Botteghe della Comunità. Un nuovo tassello che “connette” e rafforza la costruzione di un modello organizzativo, che sistematizza le energie del territorio e abbina diverse fonti di finanziamento.
“L’assistenza sociosanitaria per le aree interne è un tema centrale per la programmazione sanitaria. Metà dell’Italia oggi è area interna: un Comune su due dove vive un quarto della popolazione nazionale (13,6 milioni di persone) è a una rilevante distanza dai princi-
pali “centri di offerta di servizi” – ha detto il Direttore Generale della ASL Salerno e Vicepresidente nazionale di Federsanità, l’Ing. Gennaro Sosto. “Il modello delle Botteghe della Comunità, una sperimentazione gestionale unica nel suo genere, ha attivato le energie di tanti partner istituzionali e privati, oltre al volontariato, che hanno rafforzato la struttura del framework. Lavoriamo anche sulla connessione tra i cittadini e dei servizi, per portare l’assistenza e la cura direttamente a casa della persona, per realizzare la completa “presa in cura” anche in territori con marcate difficoltà demografiche, orografiche e di accesso ai servizi”.
Un modello pubblico sperimentale in cui gli operatori sanitari e sociosanitari, volontariato e Istituzioni locali rappresentano il collegamento fra i residenti e i Servizi all’interno di una proposta condivisa con l’Amministrazione regionale e con i Sindaci del territorio, con la ASL Salerno capofila, per combattere lo spopolamento, aumentare il grado di equità del sistema sociosanitario e contrastare le fragilità sociali.
27 Botteghe connesse tra loro e che connettono la cittadinanza, partendo dai 216 abitanti del paese più piccolo del Cilento interno. Lo scopo è quello di potenziare i servizi di assistenza territoriale nei Comuni ricompresi nell’area interna del Cilento, con l’intento di offrire alla popolazione percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che, integrandosi, possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato. A questa nuova sperimentazione di servizi sul territorio hanno partecipato e partecipano tanti partner istituzionali (Federsanità, Regione Campania, Agenas, ANCI, Università, SNAI, Servizio Civile Universale, City Competent, Ambiti Territoriali Sociali, Comunità Montane ed Ente Parco).
Nell’integrazione delle risorse e delle progettualità, è poi quindi entrata nell’ecosistema delle Botteghe della Comunità anche la Misura 1.7.2 del PNRR, calata dalla ASL Salerno sulle aree interne, e che prevede lo sviluppo di una “rete dei servizi di facilitazione digitale”, con l’obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base così da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del 70% della popolazione in possesso delle competenze
di base.
I facilitatori digitali rientrano nel più ampio progetto nazionale PNRR, attraverso cui la Regione Campania ha stipulato con IFEL Campania e con la direttrice Annapaola Voto un accordo interistituzionale per l’attuazione della Misura, conferendo alla Fondazione IFEL Campania il ruolo di soggetto sub-attuatore.
L’ASL Salerno, partner per la realizzazione, ha inteso rafforzare la connessione dei cittadini delle aree interne attraverso un appropriato uso della tecnologia. I facilitatori digitali contribuiscono, quindi, ad animare la Botteghe, insieme agli altri attori del volontariato come i city competent, e contribuiscono ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini delle aree interne, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp.
Il
fine ultimo è quello di consentire un approccio consapevole alla realtà digitale e all’equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche, e più nello specifico dai servizi sanitari digitali della ASL Salerno e del portale regionale SINFONIA.
Direttamente dalla Bottega, i cittadini vengono accompagnati e formati al progressivo utilizzo autonomo e consapevole di internet e delle tecnologie digitali dei principali servizi digitali pubblici, compresi quelli relativi all’identità digitale, al cambio medico, al CUP, fino alla telemedicina e al Fascicolo Sanitario Elettronico.



di Eva Massari
Centro Studi Fondazione The Bridge
Nell’era della digitalizzazione, il concetto di connessione assume un significato sempre più ampio e profondo. Essere connessi riguarda tanto le nostre relazioni sociali e il modo in cui accediamo alle informazioni, quanto il modo in cui le città stanno evolvendo per migliorare la qualità della vita dei cittadini grazie a una molteplicità di servizi, anche legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA), che nell’immaginario collettivo rappresenta ancora una nebulosa dentro la quale far confluire elementi dei quali di base si ignorano talvolta gli utilizzi e il fine ultimo. Tendenzialmente, il luogo comune più diffuso è quello secondo cui l’intelligenza artificiale ruberà il posto di lavoro agli umani e appiattirà il nostro modo di pensare e il senso critico”, ma, come spesso accade, cambiando il punto di osservazione si aprono prospettive che possono risultare molto interessanti.
Basti pensare alle città moderne, che affrontano in questo momento storico sfide complesse in diversi e fondamentali ambiti, tra i quali rientrano il tema della sanità e dalla salute, della gestione del traffico, l’aumento dell’inquinamento, il tema della sicurezza e la gestione dei servizi pubblici. Qui entra in gioco l’intelligenza artificiale, che, attraverso l’analisi dei dati, permette di ottimizzare le risorse e rendere gli spazi urbani più vivibili. Pensiamo ai sistemi di trasporto intelligenti, capaci di ridurre la congestione adattando i flussi di traffico in tempo reale, o ai sensori ambientali che monitorano la qualità dell’aria e suggeriscono interventi mirati per ridurre l’inquinamento.
Focalizzandosi sull’ambito sanitario, l’intelligenza artificiale è e sarà sempre più utilizzata per migliorare diagnosi, trattamenti e gestione delle risorse in ambito, a titolo di esempio, di diagnosi e imaging medico, di supporto alle decisioni cliniche, di medicina personalizzata e predittiva, di robotica chirurgica, di gestione delle cartelle cliniche e ottimizzazione dei percorsi, di medicina digitale e monitoraggio remoto.
Essere connessi, dunque, significa saper ottimizzare l’utilizzo degli strumenti che ci vengono offerti, anche per creare comunità più coese e inclusive. L’intelligenza artificiale può abbattere barriere, facilitare l’accesso alle informazioni per le persone con disabilità e promuovere un maggiore coinvolgimento civico attraverso piattaforme digitali che permettono ai cittadini di interagire direttamente con le istituzioni. Un esempio concreto è rappresentato dalle app per la segnalazione di problemi urbani, che permettono ai residenti di comunicare direttamente con le amministrazioni locali per migliorare i servizi.
Ma la connessione non è solo tecnologica: deve essere anche umana. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita urbana ha senso solo se mette al centro le persone, garantendo che il progresso tecnologico non lasci indietro nessuno. La vera sfida sarà trovare un equilibrio tra efficienza e privacy, tra innovazione e tutela dei diritti individuali. Una governance trasparente e una regolamentazione etica sono cruciali per evitare derive che potrebbero minare la fiducia dei cittadini.
In un mondo sempre più interconnesso, l’intelligenza artificiale offre dunque strumenti straordinari per costruire città più intelligenti e sostenibili. La tecnologia, però, deve essere al servizio del benessere collettivo, affinando il concetto di connessione: non solo digitale, ma anche sociale e ambientale. Perché una città veramente connessa è quella che sa mettere in rete non solo i dati, ma anche le persone, le idee e le opportunità, promuovendo una crescita armoniosa e sostenibile per le generazioni future.


Ci spiegherebbe quali sono gli elementi essenziali del suo mandato e il ruolo della Città Metropolitana nel coordinare le politiche pubbliche per lo sport e la salute nei comuni?
La Città Metropolitana di Firenze ha intenzione di realizzare tante iniziative per migliorare le condizioni psico-fisiche dei cittadini e avvicinarli sempre di più alla partica sportiva. Per questo faremo progetti che hanno come obiettivo quello di promuovere le politiche dello sport, la salute e l’inclusione. Per noi, assume anche una notevole rilevanza il fenomeno del turismo sportivo. Perciò vogliamo portare e realizzare grandi eventi sportivi non solo per valorizzare e promuovere il nostro territorio, ma anche per avvicinare i cittadini a discipline sportive meno diffuse ma non seconde per importanza,
Un altro dei punti a cui attribuisco una rilevanza significativa è quello della creazione dello Sport & Health City Manager, che avrà il compito di ideare e realizzare in concreto progetti finalizzati al raggiungimento dei nostri obiettivi.
Quali a suo avviso sono oggi o possono diventare i fattori di attrattività per il territorio della Città Metropolitana di Firenze, sia per ospitare eventi sportivi sia per promuovere la salute?
Per prima cosa è importante avere delle strutture ricettive che hanno non solo un rapporto qualità-prezzo ottimale, ma che offrono anche diverse tipologie di servizi in modo che questo genere di iniziative possa essere accessibile a tutti indipendentemente dalla propria condizione economica, dal proprio stato di salute e dalle proprie condizioni psico-fisiche.
Sicuramente anche l’impiantistica sportiva è un fattore rilevante che genera attrattività nei confronti del nostro territorio.
Infine, per ultima ma non per importanza, anche la viabilità è una componente fondamentale perché, se vuoi organizzare un evento sportivo di rilevanza nazionale e/o internazionale è necessario garantire sicurezza nelle strade e rendere il traffico più fluido possibile in modo da non creare nessuna problematica per i nostri cittadini nella loro quotidianità. Cosa che abbiamo fatto in maniera ottimale durante il Tour de France che ab-
di Giulio Benvenuto
Sport & Health City Manager
biamo ospitato lo scorso anno a Firenze.
Quali le sue aspettative per il futuro e i prossimi appuntamenti da segnare in agenda?
Vogliamo realizzare degli eventi sportivi di rilevanza nazionale con l’obiettivo di valorizzare e promuovere quei luoghi della Città Metropolitana di Firenze di valore inestimabile che non sono ancora noti come dovrebbero. Infatti, vogliamo organizzare molte manifestazioni nel Parco Mediceo di Pratolino, che è patrimonio artistico Unesco e un parco di rara bellezza. All’interno del Parco, vogliamo organizzare anche degli spazi all’aperto di salute accessibili a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro condizione economica e dal loro stato di salute per far vivere il parco ogni giorno e renderlo un luogo di inclusione e socializzazione.
Per perseguire questo nostro obiettivo, a breve realizzeremo una palestra all’aperto, che si ispira al modello “jungle jim”, con attrezzatura in legno per promuovere la sostenibilità ambientale, che è fondamentale salvaguardare
Rispetto al binomio Sport & Salute, che cosa potrebbe fare di più o meglio l’UE?
Investire risorse nell’ammodernamento dell’impiantistica sportiva, realizzare eventi che possano garantire a tutti l’accessibilità agli impianti sportivi indipendentemente dalla tipologia di partecipazione. Per esempio, tutti i cittadini devono poter svolgere attività sportiva in un impianto, soprattutto le persone con disabilità. Ritengo opportuno che si debba investire in tecnologie avanzate per permettere per esempio anche ad un cieco o ad una persona affetta da disturbi intellettivi di poter fare sport come “una persona normale”.
Inoltre è importante anche rendere gli impianti sportivi accessibili e garantire ogni genere di servizi alle famiglie e/ o a persone disabili. Assistere ad una manifestazione sportiva genera momenti di condivisione e socializzazione che possono portare poi, anche chi affetto da disabilità, a diventarne appassionato ed iniziare a praticare quella disciplina sportiva a cui ha assistito e magari chissà diventarne anche un campione.


di Federica Ascoli
Connessione è l'essenza stessa del concetto di Smart & Sustainable City, è parte del suo DNA. Non solo infrastrutture digitali e fisiche interconnesse, ma anche e soprattutto relazioni umane che si intrecciano, creando un tessuto urbano intelligente e vivibile. In un mondo sempre più interconnesso, le città del futuro si trasformano in ecosistemi dove la tecnologia è al servizio delle persone, facilitando la mobilità, l'accesso ai servizi e la comunicazione, per una vita più efficiente, piacevole e sana. Milano rappresenta un modello di Città sostenibile e intelligente in evoluzione. Grazie a investimenti in infrastrutture digitali, mobilità sostenibile e progetti di riqualificazione urbana, il capoluogo lombardo si sta trasformando in un laboratorio di innovazione e connettività, anche oltre i propri confini cittadini.
Esempio eclatante e davvero visionario è il progetto FILI del Gruppo FNM, un'iniziativa che sta trasformando la Lombardia in un modello di connettività integrata. Grazie a nuove stazioni ferroviarie, piste ciclabili e percorsi pedonali, FILI non solo avvicina i luoghi, ma crea nuove opportunità di connessione tra le persone senza rinunciare a promuovere la sostenibilità e la mitigazione climatica. Pensiamo che sarà possibile raggiungere Brera partendo da Saronno in pochi minuti, un sogno che diventa realtà, grazie a una rete di trasporti efficiente e interconnessa. Il progetto è infatti un imponente modello di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana ed extra urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Il progetto interessa l’asse Milano-Malpensa, corridoio
fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si presenterà come un’intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità. I luoghi toccati dall’intervento saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, con un intervento che arriverà a interessare progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all’interno della Lombardia. Ciliegina sulla torta del progetto, la realizzazione di una Foresta Sintetica Pensile che, come una immaginaria fabbrica, produrrà aria pulita per la città di Milano. Che meraviglia essere



di Mario Di Gioacchini
Past
President della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica
L’aumento delle allergie, una tendenza ormai costante da qualche decennio, trova la sua causa nei cambiamenti dello stile di vita e in fattori ambientali e climatici. La “teoria igienica” si basa sul fatto che l’ambiente rurale protegge dall’insorgenza delle allergie, in quanto l’esposizione ai microrganismi ambientali tipici di queste condizioni favorisce un normale sviluppo del sistema immunitario. Al contrario, l’ambiente urbano comporta una riduzione di tale esposizione, determinando uno sviluppo anomalo del microbiota intestinale e respiratorio, con una conseguente riduzione della biodiversità e un aumento del rischio di sviluppare allergie. Inoltre, l’ambiente urbano comporta un’esposizione a fattori inquinanti che inducono una deviazione del sistema immunitario verso pattern citochinici e cellulari tipici delle reazioni IgE allergiche. Numerosi studi hanno dimostrato che il rischio di sviluppare allergie è maggiore del 50% negli ambienti urbani rispetto a
quelli rurali.
L’inquinamento urbano deriva principalmente dal traffico veicolare, dalle attività industriali e dal riscaldamento domestico. Il particolato fine (proveniente soprattutto dalla combustione diesel), l’ossido di azoto, l’ozono, il biossido di zolfo, l’anidride carbonica e il nanoparticolato agiscono direttamente sull’apparato respiratorio, alterandone la barriera epiteliale. Questa subisce modifiche strutturali e risponde a tali sostanze producendo composti che attivano il sistema immunitario, indirizzandolo prevalentemente verso una risposta di tipo T2, tipica delle malattie allergiche.
Le sostanze inquinanti possono inoltre modificare la struttura del polline e, in particolare, delle molecole allergeniche presenti nei granuli pollinici, incrementandone la potenza allergenica. Questo provoca una stimolazione più intensa del sistema immunitario e una maggior severità delle manifestazioni cliniche dei pazienti esposti. L’aumentata allergenicità dei pollini si combina negativamente con il prolungamento delle stagioni polliniche, conseguenza delle variazioni climatiche anch’esse legate all’inquinamento atmosferico. I cambiamenti climatici provocano un aumento della concentrazione atmosferica dei pollini, lo spostamento delle zone di vegetazione di diverse piante e l’introduzione di vegetazioni non autoctone, e quindi di nuovi allergeni. Tutto ciò comporta una maggiore gravità e durata dei sintomi allergici, particolarmente accentuati

durante eventi atmosferici estremi associati all’aumento delle temperature. In queste situazioni, è stata identificata una condizione clinica chiamata “asma da tempesta” (thunderstorm asthma), caratterizzata da asmatici sintomi gravi dovuti all’esposizione a una miriade di frammenti pollinici altamente allergizzanti.
L’incremento dell’esposizione allergenica, prevalentemente ad acari, muffe ed epiteli animali, è riscontrato anche all’interno delle abitazioni delle nostre città. La ventilazione naturale è spesso ridotta per migliorare l’efficienza energetica, con un aumento indoor non solo degli allergeni ma anche di inquinanti. In situazioni estreme, si parla di “sindrome dell’edificio malato”, che impatta in modo significativo sui pazienti allergici, poiché le principali manifestazioni colpiscono l’apparato respiratorio.
Molte sostanze inquinanti non solo favoriscono la sensibilizzazione allergica, ma peggiorano anche le condizioni cliniche di chi è già allergico, provocando sintomi a carico dell’apparato respiratorio. Un’indagine svolta su 57.000 bambini ha rilevato un aumento significativo del consumo di farmaci e del ricorso a visite in emergenza tra gli abitanti delle città rispetto a quelli residenti in zone rurali. Alcuni inquinanti, come il biossido di zolfo, peggiorano unicamente la condizione clinica dei soggetti asmatici, con effetti modesti sui soggetti sani.
Come in tutte le condizioni sfavorevoli per la salute, i
soggetti a rischio nelle aree urbane sono i bambinile donne in stato di gravidanza e gli anziani. A questi si aggiungono coloro che svolgono attività fisica (per sport o per lavoro) in ambiente urbano, poiché inalano una quantità maggiore di allergeni e sostanze inquinanti in relazione all’intensità dello sforzo e quindi alla quantità d’aria inalata.
La prima fase preventiva consiste nel limitare l’attività lavorativa o sportiva nelle città e, quando inevitabile, nell’indossare mascherine protettive all’aperto. Si dovrebbero evitare le ore più calde della giornata, quando l’ozono, le sostanze inquinanti e la concentrazione pollinica sono più elevate. È utile preferire percorsi a traffico lieve, evitando quelli con traffico intenso o congestionato. Sarebbe anche opportuno arieggiare gli ambienti interni nelle ore in cui l’aria è più pulita, come la mattina presto o la sera tardi.
In generale, è necessario educare la popolazione per aumentarne la consapevolezza su queste problematiche. Diventa fondamentale promuovere azioni politiche che ripensino il verde urbano, evitando le specie vegetali più allergizzanti e favorendo la biodiversità. Infine, per affrontare efficacemente il problema, è indispensabile migliorare la qualità dell’aria nelle città, sia all’esterno che all’interno delle abitazioni, proponendo modelli urbanistici alternativi a quelli attuali.

Respirare, muoversi, vivere.
Il nostro pianeta la risorsa certa per le generazioni future.

