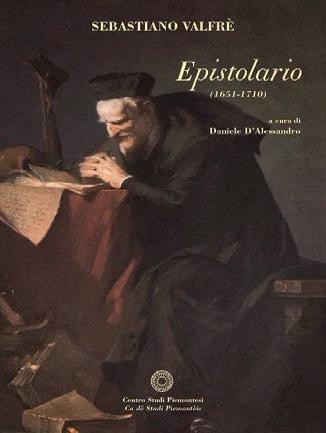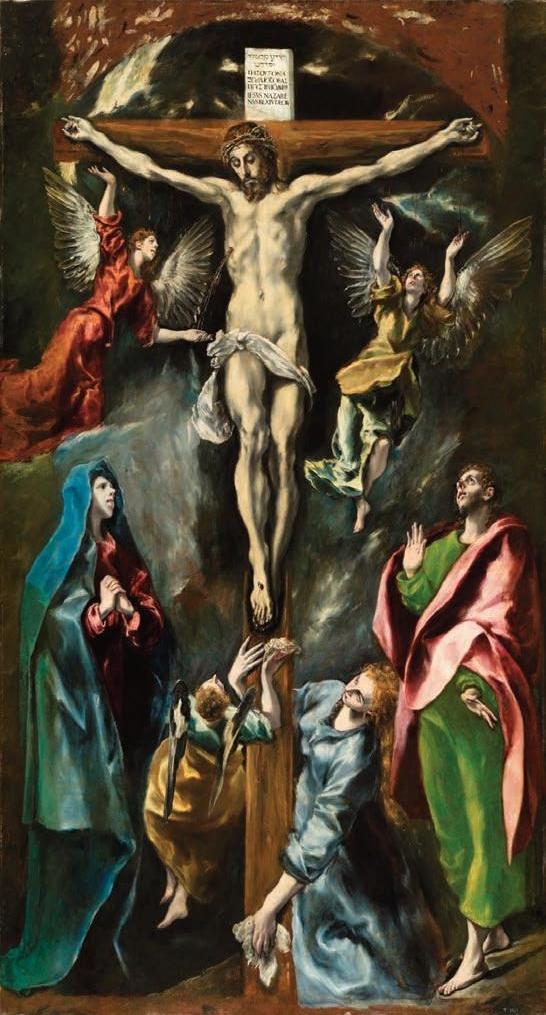10 minute read
Chi invocare contro le pandemie di Cristina Siccardi
by Radici Cristiane - Il mensile che si richiama ai valori perenni della Civiltà europea e occidentale





Sant’Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi da tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio (nella foto, sant’Antonio abate di Francisco de Zurbarán, 1664).



Chi invocare contro le pandemie
Ci sono, nella storia della Chiesa, alcuni santi maggiormente invocati nei momenti delle calamità epidemiche, come sant’Antonio Abate, san Sebastiano, sant’Erasmo di Formia, santa Rita da Cascia, san Francesco da Paola ed i Santi Ausiliatori. Perché proprio loro? Per le opere compiute in vita oppure per i segni soprannaturali ed i miracoli che hanno manifestato, in vita e in morte, per volontà di Dio.
Cristina Siccardi
La religiosità popolare ha riscoperto in questi mesi le devozioni più diffuse per contrastare malattie contagiose, pestilenze, pandemie, come quella che stiamo vivendo, causata dal Covid-19. Ci sono, nella storia della Chiesa, alcuni santi maggiormente invocati nei momenti delle calamità epidemiche, in particolare sant’Antonio Abate (251 d.C. - 356), san Sebastiano (256-288), sant’Erasmo di Formia (?-303), santa Rita da Cascia (1381-1457), san Francesco da Paola (1416-1507) e i Santi Ausiliatori. Perché proprio loro? La scelta è pertinente alle opere della loro vita oppure ai segni soprannaturali e ai miracoli che hanno manifestato, in vita e in morte, per volontà di Dio.

Sant’Antonio abate
Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni e morì ultracentenario. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità, pellegrini e bisognosi da tutto l’Oriente. Anche Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. La sua vicenda è raccontata da un suo discepolo, sant’Atanasio, grande combattente contro l’arianesimo. Per due volte lasciò il suo romitaggio: per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia e poi, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà nei confronti del Concilio di Nicea.

San Sebastiano
I dati storici circa la figura di san Sebastiano sono limitati alla menzione nel più antico calendario della Chiesa di Roma, la Depositio Martyrum, confluita nel Cronografo, risalente al 354, e ad una citazione nel Commento al Salmo 118 di sant’Ambrogio, vescovo di Milano. Una Passio scritta intorno al V secolo aggiunge che Sebastiano era un membro dei pretoriani, le guardie al diretto servizio dell’Imperatore di Roma, ed era cristiano dalla nascita. Portò conforto ai cristiani destinati al martirio. A sua volta fu denunciato come cristiano e condannato al supplizio delle frecce, per aver tradito la fiducia dell’imperatore Diocleziano. Ne uscì vivo, ma non illeso: dopo le cure, si ripresentò a Diocleziano per rimproverarlo aspramente di quanto aveva commesso contro i cristiani. Frustato a morte, venne gettato nella Cloaca Massima. Le sue spoglie furono però ritrovate e deposte nelle catacombe della via Appia.
Sant’Erasmo
Sant’Erasmo, vescovo di Formia, fu martire al tempo di Diocleziano e Massimiano (303 d.C.) e sepolto nella località costiera del Lazio meridionale. La sua Passio risale al VI secolo, ma si hanno scarse notizie su di lui. È menzionato, oltre che negli antichi martirologi, anche nel Calendario marmoreo di Napoli. Nell’842, dopo che Formia era stata distrutta dai Saraceni, le reliquie furono nascoste nella vicina Gaeta. Quando furono ritrovate, nel 917, il martire venne proclamato patrono della diocesi del Golfo. È invocato contro le epidemie e le malattie dell’intestino per il fatto che, nel martirio, gli sarebbero state strappate le viscere. I marinai lo venerano con il nome di Elmo.
Santa Rita da Cascia
Secondo la tradizione, santa Rita da Cascia era figlia unica e, fin dall’adolescenza, desiderò consacrarsi a Dio, ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane ghibellino, dal temperamento aggressivo, che la santa seppe convertire. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei parenti, che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, venne più volte respinta dal monastero agostiniano di santa Maria Maddalena in Cascia, dove ella aveva scelto di vivere. Ma un miracolo le permise di entrare nel chiostro senza che nessuno le aprisse la porta: il dato di fatto impedì alla Badessa di cacciarla. Visse per quarant’anni anni nell’umiltà e nella carità, nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita, portò su di sé il segno della sua profonda unione con Gesù crocifisso: una spina della corona di Cristo, partita dal crocifisso affrescato su una parete del monastero, di fronte al quale si era soffermata
Secondo una Passio scritta intorno al V secolo, Sebastiano era un membro dei pretoriani, le guardie al diretto servizio dell’Imperatore di Roma, ed era cristiano dalla nascita. Portò conforto ai cristiani destinati al martirio. Denunciato, venne martirizzato (nella foto, il secondo supplizio di san Sebastiano, opera di Paolo Veronese, 1565).


Sant’Erasmo, vescovo di Formia, fu martire al tempo di Diocleziano e Massimiano. È invocato contro le epidemie e le malattie dell’intestino per il fatto che, nel martirio, gli sarebbero state strappate le viscere. I marinai lo venerano con il nome di Elmo (nella foto, Il martirio di Sant’Erasmo di Nicolas Poussin, conservato presso i Musei Vaticani).





a pregare ed adorare. Invocata come taumaturga, è universalmente chiamata “Santa degli impossibili” ovvero dei casi umanamente non risolvibili.
San Francesco da Paola
La vita di san Francesco da Paola è avvolta in un’aura soprannaturale dalla nascita alla morte. I suoi genitori erano devoti di san Francesco d’Assisi, al quale attribuirono la grazia della nascita del loro bambino: da qui il nome e la decisione di indirizzarlo alla vita religiosa nell’ordine francescano. Dopo un anno di prova, tuttavia, il giovane lasciò il convento e proseguì la sua ricerca vocazionale con viaggi e pellegrinaggi. Infine, scelse la vita eremitica e si ritirò a Paola in un territorio di proprietà della famiglia. Qui si dedicò alla contemplazione e alle mortificazioni corporali, suscitando stupore e ammirazione tra i concittadini. Ben presto iniziarono ad affluire al suo eremo molte persone desiderose di porsi sotto la sua guida spirituale; seguirono la fondazione di numerosi eremi e la nascita della congregazione eremitica paolana detta anche Ordine dei Minimi. Innumerevoli le grazie e i miracoli che si verificarono per sua intercessione e si diffuse grandemente la sua fama di taumaturgo, fino a raggiungere la corte di Luigi XI (14231483), allora infermo. Fu così che il sovrano chiese a papa Sisto IV (1414-1484) di far giungere l’eremita presso di lui. Nei 25 anni che restò in Francia, il santo, oltre a stabilire importanti rapporti fra la corte e il papato, riformò la vita religiosa.
I Santi Ausiliatori
C’è un bellissimo santuario del XVII secolo su una collina verdeggiante nel Comune bavarese di Bad Staffelstein, circondario di Lichtenfels nell’Alta Franconia, dedicato ai quattordici Santi Ausiliatori, chiamati anche Salvatori, coloro che vengono pregati singolarmente per specifiche malattie, mentre in gruppo sono invocati contro le epidemie. Il loro culto sorse già nel Trecento, quando l’Europa venne flagellata dalla peste nera, iniziata intorno al 1346 nel nord della Cina e che, attraverso la Siria, si diffuse in fasi successive alla Turchia, per poi raggiungere la Grecia, l’Egitto, la penisola balcanica e la Sicilia. I focolai della pandemia scomparvero nel 1353, dopo aver provocato l’uccisione di almeno un terzo della popolazione del Continente (secondo le più recenti stime perirono 20 milioni di persone). Fu proprio in quel tempo e in Germania che i cristiani iniziarono a supplicare un gruppo di quattordici Santi, celebri, ciascuno, per i loro straordinari miracoli.

Secondo la tradizione della Chiesa i Santi Ausiliatori sono sant’Acacio di Bizanzio (o Agazio, ?303), invocato contro l’emicrania; santa Barbara (III-IV secolo), contro i fulmini, la febbre e la morte improvvisa; san Biagio di Sebaste (?-316), contro il male alla gola; santa Caterina d’Alessandria (287305), contro le malattie della lingua; san Ciriaco di Roma (?-306), contro le tentazioni e le ossessioni diaboliche; san Cristoforo (?-350 ca.), contro la peste e gli uragani; san Dionigi da Parigi (?250/285), contro i dolori alla testa; sant’Egidio abate (640 ca.-720 circa), contro il panico e la pazzia; sant’Erasmo di Formia (?-303), contro i dolori addominali; sant’Eustachio (I-II secolo), contro i pericoli del fuoco; san Giorgio (275/285 ca.-303), contro le infezioni della pelle; santa Margherita di Antiochia (275-290), contro i problemi del parto; san Pantaleone di Nicomedia (?-305), contro le infermità di consunzione; san Vito (?303), contro l’idrofobia, la letargia e l’epilessia.
L’apparizione a Langheim


Il culto al gruppo di Santi si espanse e crebbe di importanza, in particolare dopo le apparizioni al pastorello Hermann Leicht di Langheim, oggi Lichtenfels (cittadina della Baviera sul fiume Meno), figlio del locatario del podere di Frankental. Sovente le apparizioni celesti si verificano in presenza di chi è ancora nell’età dell’innocenza, così, il 17 settembre 1445, Gesù Bambino, circondato da candele accese, si presentò al pastorello tedesco. L’evento si replicò il 29 luglio 1446, nello stesso luogo, ma questa volta Gesù infante era accompagnato da quattordici bambini. Herman domandò chi fossero ed essi si identificarono come i «quattordici salvatori» e fecero la richiesta che venisse dedicata loro una cappella. L’avvenimento suscitò clamore per trovare maggior forza con la guarigione miracolosa di una ragazza gravemente malata, giunta sul sito delle apparizioni.
Il popolo e i pellegrini, che sempre più numerosi si recavano lì in pellegrinaggio, si attivarono per fare richiesta della cappella in onore dei Santi Ausiliatori e le insistenze furono talmente pressanti che l’Abate del monastero cistercense di Langheim dovette cedere. Ogni santo aveva la propria festa liturgica in giorni diversi del calendario romano, ma in alcuni luoghi i Santi Ausiliatori, collettivamente, iniziarono ad essere celebrati in un’unica data, l’8 agosto. A tale devozione Papa Niccolo V (1397-1455) legò delle particolari indulgenze.
I pellegrinaggi s’incrementarono con il trascorrere del tempo e, dopo la distruzione della cappella nel corso della guerra dei contadini (1524-1526), che si inserì nel contesto delle guerre di religione e della Rivoluzione luterana, vi fu eretta una chiesa nel 1543. Tuttavia, la devozione sempre più importante per i Santi Ausiliatori portò a realizzare un santuario vero e proprio fra il 1743 e il 1772, progettato dal celebre architetto e ingegnere Johann Balthasar Neumann (1687-1753).
Il monastero cistercense di Langheim venne soppresso nel 1803 con le leggi napoleoniche, perciò il santuario iniziò ad essere retto, dal 1839 in poi, dall’Ordine dei Francescani. Ogni anno si recano in questo sacro luogo circa mezzo milione di visitatori, ma ci auguriamo vivamente che, terminata la pandemia del Coronavirus, i pellegrinaggi e gli ex-voto si moltiplicheranno per le grazie corporali e spirituali ricevute.

Il santuario del XVII secolo (nella foto, su licenza Creative Commons), eretto su di una collina nel Comune bavarese di Bad Staffelstein, circondario di Lichtenfels nell’Alta Franconia, è dedicato ai 14 Santi Ausiliatori, coloro che vengono pregati singolarmente per specifiche malattie, mentre in gruppo sono invocati contro le epidemie.