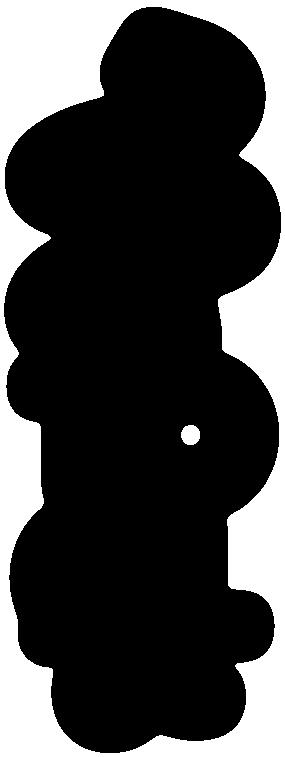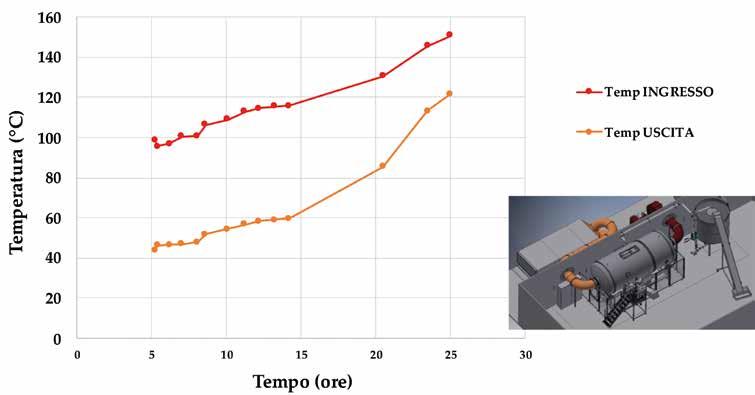BIRRA NOSTRA

NOVITÀ, DEGUSTAZIONI, PRODUZIONI, ITINERARI NEL MONDO BIRRARIO
BIRRA E MUSICA
JOHN BARLEYCORN: BIRRA E MUSICA
DELLE TRADIZIONI NEL ROCK di Antonio Boschi
UNIVERSITÀ E RICERCA
LA MALTERIA SPERIMENTALE
DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe
MATERIE PRIME
CHI BEVE BIRRA CAMPERÀ CENT’ANNI?
di Luca Pretti
FOCUS
Home brewing: come tarare la strumentazione di Massimo Faraggi

N.2| APRILE 2023 MAGAZINE

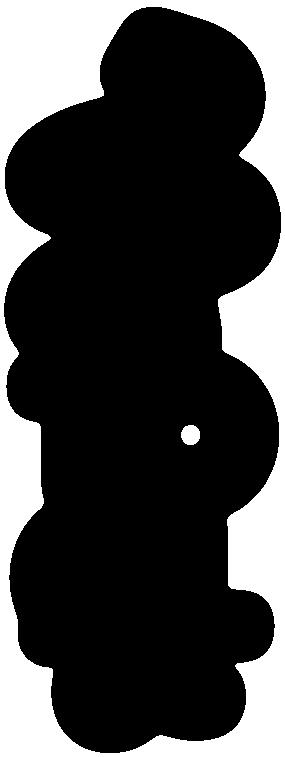










COLORI, forme e suoni
Ci sono coppie indissolubili, elementi che quando si incrociano ed entrano in relazione scatenano potenti alchimie. Birra e musica sono una di queste! Da questo numero la famiglia di Birra Nostra Magazine si allarga per ospitare tra le sue pagine la firma di Antonio Boschi, tra le altre cose scrittore, grafico, divulgatore di musica e redattore per la rivista “Il Blues” oltre che socio fondatore di A-Z Blues, società che si occupa di musica blues, musica tradizionale americana e rock. Suo l’articolo di apertura dedicato a John Barleycorn che porta i lettori a scoprire le origini di questo potente legame e che traccia l’avvio di un percorso che ci porterà a conoscere in maniera più approfondita il valore della musica e a renderci più consapevoli di quanto un buon ascolto debba essere sempre accompagnato da una buona birra. Tra i nuovi ingressi merita di essere segnalata anche la collaborazione con l’Università di Udine, nelle figure di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe che, dopo le Università di Parma e di Palermo, allarga la qualità dei contributi scientifici sviluppati da studiosi del settore; protagonista di questo numero, la malteria sperimentale avviata nell’ateneo friulano e valorizzata dalla collaborazione con l’Associazione Produttori di Orzo e Malto che riunisce aziende agricole che puntano a valorizzare il comparto cerealicolo. Che poi
non si dica che il mondo della birra non è vivo e fecondo!
I colori sono anche quelli che arrivano dai Paesi Baschi visitati da Eleni Pisano in un viaggio attraverso i sapori tipici di un territorio che merita di essere scoperto ed apprezzato anche nelle sue località meno turistiche. Ad Alberto Grandi e Roberto Muzi il compito di un’analisi sensoriale e degustativa che mette insieme, sempre a proposito di alchimie, la coppia per eccellenza, birra e pizza, e un’insolita accoppiata rappresentata da birra e caffè, in relazione al valore storico di due bibite oggi tanto lontane quanto un tempo tra loro alternative! A Luca Pretti, dottore di ricerca in biotecnologie microbiche e ricercatore del centro Porto Conte Ricerche di Alghero, il compito di capire se alla birra possa spettare il ruolo di elisir di lunga vita, alla luce di uno sviluppo che riconosce anche alla birra lo status di “bevanda funzionale”, ossia contenente sostanze che producono effetti benefici per la salute. L’analisi del mercato, di aspetti legati al marketing o alle caratteristiche tecniche spettano ad esperti nelle varie materie come Simonmattia Riva, Matteo Malacaria, Flavio Boero e Massimo Faraggi in una varietà di articoli pieni di colori, forme e suoni che neanche il più sofisticato caleidoscopio potrebbe produrre!

Buona lettura e buona bevuta!
Professionista della scrittura e della comunicazione, collaboro da dieci anni al progetto Birra Nostra
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 1 aprile 2023 Editoriale
MIRKA TOLINI




2 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 SEGUICI SU facebook.com/BirraNostraMagazine IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE Colori, forme e suoni 1 BIRRA E MUSICA John Barleycorn: la birra e la musica delle tradizioni nel rock 4 di Antonio Boschi MARKETING Le 4P del marketing mix 10 di Matteo Malacaria ABBINAMENTI La pizza alla romana (L’elementare) 16 di Roberto Muzi MATERIE PRIME Chi beve birra camperà cent’anni? 22 di Luca Pretti La qualità in microbirrificio 28 di Flavio Boero MERCATO I dolori del giovane publican 34 di Simonmattia Riva 4 22 16 10 NOVITÀ, DEGUSTAZIONI, PRODUZIONI, ITINERARI
MAGAZINE
NEL MONDO BIRRARIO
BIRRA NOSTRA
Birra Nostra Magazine - Bimestrale Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Verona in data 22 novembre 2013 al n. 2001 del Registro della Stampa
Direttore Responsabile
Mirka Tolini
Comitato di Redazione
Davide Bertinotti, Luca Grandi redazione@birranostra.it
Hanno contribuito a questo numero
Flavio Boero, Antonio Boschi, Stefano Buiatti, Massimo Faraggi, Alberto Grandi, Matteo Malacaria, Roberto Muzi, Paolo Passaghe, Eleni Pisano, Luca Pretti, Simonmattia Riva.
Quine Srl
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione n. 12191
Costantino Cialfi - Direttore Commerciale c.cialfi@lswr.it - tel. +39 3466705086

Coordinamento editoriale
Chiara Scelsi c.scelsi@lswr.it
PUBBLICITÀ commerciale@birranostra.it
TRAFFICO
Ornella Foletti ornella.foletti@quine.it Tel. +39 3427968897
Impaginazione
LIFE - LSWR Group
Produzione Antonio Iovene
Stampa
Tipolitografia Pagani - Passirano (BS)
Archivio immagini
Shutterstock
Foto di copertina di Sofie Delauw
Redazione Simone Ciapparelli s.ciapparelli@lswr.it
ABBONAMENTI
Quine srl, Via G. Spadolini, 7 20141 Milano – Italy
Tel. +39 02 88184.117 www.quine.it
Sara Biscaro abbonamenti@quine.it
Birra Nostra Magazine è frutto della collaborazione tra Birra Nostra e MoBI - Movimento Birrario Italiano www.birranostra.it - www.movimentobirra.it


Tutto il materiale pubblicato dalla rivista (articoli e loro traduzioni, nonché immagini e illustrazioni) non può essere riprodotto da terzi senza espressa autorizzazione dell’Editore. Manoscritti, testi, foto e altri materiali inviati alla redazione, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Tutti i marchi sono registrati.
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Si rende noto che i dati in nostro possesso liberamente ottenuti per poter effettuare i servizi relativi a spedizioni, abbonamenti e similari, sono utilizzati secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Titolare del trattamento è Quine srl, via Spadolini, 7 - 20141 Milano (info@quine.it). Si comunica inoltre che i dati personali sono contenuti presso la nostra sede in apposita banca dati di cui è responsabile Quine srl e cui è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.Legs 196/2003. © Quine srl - Milano
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 3 aprile 2023 STORIA E TRADIZIONI
e caffè: uno strano confronto durato due secoli 40 di Alberto Grandi UNIVERSITÀ E RICERCA La malteria sperimentale dell’università di Udine 46 di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe TURISMO BIRRARIO Viaggio tra le birre dei Paesi Baschi 52 di Eleni Pisano
Densimetro e rifrattometro, come tararli 58 di Massimo Faraggi
DAL MONDO BIRRARIO
SCRITTO PER NOI
Birra
HOMEBREWING
NOVITÀ
HANNO
52
40
JOHN BARLEYCORN La birra e la musica delle tradizioni nel rock
Un bel giorno, nella primavera del 1966, molte persone dell’area di Chicago, prima, e di mezzo mondo, poi, ebbero la possibilità di far scorrere la puntina del proprio giradischi sulle tracce scolpite nel vinile “The Real Folk Blues” del già celebre artista ame-
ricano John Lee Hooker, ed uscito sul mercato discografico grazie all’etichetta Chess Records che già dalla fine degli anni ’50 aveva intravisto nel bluesman di Clarksdale, Mississippi, una delle figure di spicco dell’allora fiorente panorama blues della “Windy City”.
Quasi in chiusura della seconda facciata, il cantante e chitarrista padre del boogie blues, accompagnato dal piano di Lafayette Leake, dalla chitarra di Eddie Burns più una non ben identificata sezione ritmica, ci propone una bellissima versione di “One Bourbon, One Scotch,

4 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
BIRRA E MUSICA
di Antonio Boschi
One Beer” brano scritto originariamente da Rudy Toombs e registrato da Amos Milburn nel 1953.
Una
storica accoppiata
Anche la birra è protagonista in un testo di una canzone e non è la prima volta e nemmeno sarà l’ultima, perché birra e musica sono legate da un filo indissolubile, anche se la cosa non era certamente voluta o progettata con fini di lucro o quant’altro. Ma è impossibile non riuscire ad immaginare di ascoltare musica, sia live che su disco, senza che ti venga voglia di assaporare una birra di qualità, senza quella piacevolezza di poter abbinare il gusto della nostra bevanda preferita ad accompagnare il fruire di note musicali che ci regalano emozioni. Si possono fare tantissimi ragionamenti su questa ormai storica accoppiata, a partire dalla qualità spesso pessima della birra proposta agli spettacoli live, specialmente quelli che attirano tanto pubblico, ma ci sono - fortunatamentetante occasioni dove la buona musica è abbinata ad una preziosa scelta di birra, soprattutto artigianale di alto livello. Questo aspetto, fortunatamente sempre più frequente, ci ha fatto pensare ad una nuova rubrica dedicata alla musica, con consigli per gli ascolti - magari casalinghi - dove poter dare una giusta “colonna sonora” ad uno dei nostri passatempi preferiti, ovvero quello di gustare una prelibata birra in perfetto relax. La birra protagonista - ma non necessariamente - in canzoni o album che hanno fatto la storia della musica moderna, oppure in dischi non diventati famosi come meritavano ma che andrebbero riscoperti.
Rock, blues, country, jazz, musica angloscoto-irlandese e delle tradizioni USA…

Tutte sonorità che da tempo si accompagnano al bere una birra, con calma e con attenzione, e se nelle pagine della rivista potete trovare tutti i consigli su quali birre scegliere o come gustarle nel modo più corretto, in questa rubrica cercheremo di darvi le indicazioni e gli stimoli giusti per ascoltare brani musicali
che pensiamo possano essere ideali per trascorrere un piccolo momento di puro godimento personale.
La musica è stata una delle prime forme di comunicazione per l’uomo, così come la birra una delle prime bevande alcoliche prodotte. Questo lo possiamo trovare anche in vecchie ballate della tradizione anglosassone, ad esempio, che fortunatamente sono arrivate ai giorni nostri grazie al lavoro di alcuni ricercatori che hanno avuto l’intelligenza e la pazienza di andare a recuperare materiale storico. Pensiamo, sempre, che in tantissimi aspetti della cultura
popolare la canzone non era solamente un modo per divertirsi ma, anche, una forma di comunicazione su quanto accadeva. Insomma, i vari cantori erano una sorta di moderni giornalisti che attraverso le parole dei loro brani proposti raccontavano storie locali, descrivendo avvenimenti - spesso cruenti - portando la notizia nelle piazze e nelle zone dei vari spettacoli.
Testi e armonie che hanno fatto il giro del mondo, attraversando Oceani per arrivare persino nel nuovo continente americano e dove, addirittura, sono state ritrovate le uniche tracce ancor oggi
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 5 aprile 2023 BIRRA E MUSICA
John Lee Hooker
esistenti, soprattutto nelle aree più rurali come quelle dei Monti Appalachi. Un chiaro esempio lo abbiamo grazie alle raccolte dell’etnomusicologo britannico Cecil J. Sharp (1859-1924) che affrontò un periglioso viaggio lungo la lunghissima catena montuosa statunitense, quasi abbandonata da Dio, per recuperare armonie ormai perdute e che possiamo ancor oggi consultare nel preziosissimo

John Barleycorn Must Die
Canzoni che rappresentano una chiara fotografia dell’epoca e di come la popolazione, in questo caso britannica, vivesse. Una raccolta che ha, successivamente, influenzato la “nuova musica” che ha attinto a piene mani da questa
monumentale opera, regalandoci tutto quello che è stato, per esempio, l’esplosione della musica folk tra la fine degli anni ’50 e i ’60. Un caso molto noto è la canzone che dà il titolo all’album più celebre della band britannica dei Traffic, quella “John Barleycorn Must Die” ancora oggi pietra miliare della musica rock. Ed ecco che compare la birra poiché in questa ballata di origine inglese e scozzese - elencata col numero 164 nel Round Folk Song Index, compilato da Steve Roud, ex bibliotecario del London Borough of Croydon - l’orzo è il protagonista assoluto di questa canzone che cela al suo interno una metafora, ovvero la vera personificazione di questo cereale e delle bevande alcoliche che da esso si ricavano: birra, appunto, e whisky. All’interno del brano John Barleycorn subisce chiaramente una serie di umiliazioni, dei veri e propri attacchi sino ad incontrare addirittura la morte. Umiliazioni che, nella metafora, stanno a sottintendere le varie fasi di lavorazione dell’orzo, dalla mietitura alla maltazione.
Non si conosce con certezza quando questo brano sia stato scritto la prima volta, ci sono però tracce già nel 1568 quando John Barleycorn aveva ancora il nome di Allan-a-Maut in una canzone scozzese, mentre viene menzionato per la prima volta col suo nome, che ancora oggi conosciamo, nel 1624 questa volta in Inghilterra. Tracce del testo le troviamo anche nella vicina Irlanda dalle cui coste, molto facilmente, è salpata attraversando l’Oceano per giungere fino in America. Cambiavano alcuni aspetti ma la sostanza, alla fine, rimaneva sempre quella, ovvero la produzione di birra o whisky, bevande che non sono mai mancate nella cultura anglosassone. La versione più nota e di maggior successo è quella, come dicevamo, proposta dai Traffic che va ad impreziosire uno degli album fondamentali per chi ama la musica di un’epoca che ha fatto la storia e che vede in Steve Winwood uno dei protagonisti assoluti.
6 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 BIRRA E MUSICA
volume “English Folk Songs from the Southern Appalachians”.
Cecil Sharp House a Londra, sede di The English Folk Dance and Song Society
Un artista da riscoprire
In Italia, Winwood non ha forse goduto della giusta considerazione - senza essere certamente sottovalutato - ma mai osannato come altri suoi colleghi, forse anche per un carattere schivo e riservato. Eppure, pensiamo, sia uno di quelli da mettere sul gradino più alto di un ipotetico podio. Eccelso tastierista - pianoforte oppure Hammond B3 - tra i più creativi e dotati di originalità, grandissimo chitarrista e con una delle più belle voci del firmamento musicale, ha anche dalla sua una grande scrittura che lo ha visto comporre pezzi memorabili della scena musicale dagli anni ’60 quando, appena diciassettenne, scrisse la hit “Gimme Some Lovin’” assieme al gruppo nel quale militava all’epoca: The Spencer Davis Group.
Il brano fu capace di raggiungere i primissimi posti delle classifiche radio USA nella sezione dedicata alla musica afroamericana dove, tra l’altro, nessuno immaginò che potesse essere di un bianco (per di più minorenne) quella voce così ricca di groove
L’aver vissuto in Inghilterra in quegli importanti anni per il British Blues fu un piccolo colpo di fortuna che gli permi-
se di fare esperienze al fianco di fondamentali artisti dell’epoca, sia locali che arrivati direttamente dagli States, come Howling Wolf, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, John Lee Hooker ma, anche, Jimi Hendrix (è di Winwood la parte di Hammond nella celebre versione di “Voodoo Chile”), di Joe Cocker e dell’amico Eric Clapton col quale costituì, nel



1969, il supergruppo Blind Faith e per il quale compose la meravigliosa “Can’t Find My Way Home”.
Questo in una pausa riflessiva del suo progetto principale, Traffic, dal qualedopo l’album iniziale “Mr. Fantasy” e il seguente omonimo “Traffic” - si separò (mettendo alla luce l’album postumo “Last Exit”) per poi ritrovarsi nel 1970
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 7 aprile 2023 BIRRA E MUSICA
Steve Winwood
per registrare quello che per tanti è il lavoro più rappresentativo: “John Barleycorn Must Die”, che inizialmente era previsto a nome del solo Winwood, ma il ritorno di Jim Capaldi e Chris Wood consigliò di recuperare lo storico marchio. Meno psichedelico dei precedenti lavori, questo disco è una esplosiva miscela di jazz, progressive, folk e rock dove in sei soli brani emerge l’immensità composi-

tiva di Winwood, autore di tutti i brani con l’aiuto di Capaldi.
Si parte con uno dei più bei riff di pianoforte supportato dall’organo Hammond in “Glad” che per 7 minuti macina suoni in un perfetto incastro di strumenti fino ad arrivare in una sorta di limbo psichedelico che precede e lancia la seguente “Freedom Rider” dove possiamo sentire la voce black di Steve in una disperata esecuzione dall’assoluta bellezza, mentre tutti gli strumenti arrivano, in un magnifico crescendo, a costruire un finale muro sonoro. Il brano che chiude la prima facciata è “Empty Pages” dai toni prettamente soul giocata magistralmente sulle tastiere del leader. Il lato B si apre con “Stranger To Himself”, ballata molto “southern” con un acido solo di chitarra che mette in grande evidenza l’abilità ma, soprattutto, gusto e personalità del Winwood chitarrista. Ed eccoci ad inoltrarci nella storia della musica con la seguente “John Barleycorn”, la bellissima folk ballad nella quale riecheggia la tradizione popolare inglese su una bellissima chitarra acu-
stica accompagnata dal flauto di Chris Wood. Chiude l’album “Every Mother’s Son”, un blues di grandissimo spessore dove la band risulta essere stellare, e un solo di organo di gran classe. Un disco, questo, che rimarrà in eterno nella storia della musica e che nella ristampa in CD contiene ben quattro bonus tracks, le inedite “I Just Want You To Know” e “Sittin’ Here Thinkin’ Of My Love” decisamente minori e che provengono dalle sessions precedenti all’arrivo di Capaldi e Woods, oltre a due versioni registrate live al Fillmore East di NYC nel mese di novembre, con il grande Bill Graham che presenta la formazione e via verso un’interessante “Who Knows What Tomorrow May Bring” seguita da una sempre grande versione di “Glad”.
Disco imperdibile, ideale per una serata in solitudine o in buona compagnia ma - certamente - con una birra di qualità. Provatelo e chissà che il fantasma di John Barleycorn non decida di venire a sedersi accanto a voi per gustarsi questa ennesima versione di una canzone che parla di lui. ★

8 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
BIRRA E MUSICA
Copertina del disco John Barleycorn Must Die (1970)


MACCHINE IMBOTTIGLIATRICI 1.000-20.000 B/H fraz. Cappelli 33/b, 12040 Ceresole d’Alba (Cn) tel. +39 0172 574 416 - fax +39 0172 574 088 email: gai@gai1946.com - www.gai1946.com Scriba Studio / ph Paolo Marchisio Qualità la progettiamo, la costruiamo, la imbottigliamo
LE 4P DEL MARKETING MIX

Un nuovo modo di vedere (e bere) la birra artigianale
Alzi la mano chi conosce le 4P del Marketing Mix. Nessuno? Bene, facciamo un passo indietro affinché si possa essere tutti sulla stessa pagina, introducendo prima il concetto di Marketing Mix e poi successivamente entrando nel dettaglio delle singole voci. Al termine di questa boriosa ma necessaria introduzione capirai dove voglio arrivare. Pronto? Partiamo!

Dunque, il Marketing Mix viene definito – riporto quella, tra le tante definizioni esistenti, che reputo essere più rappresentativa – l’insieme delle leve di marketing che l’impresa definisce e impiega per soddisfare il consumatore e raggiungere i propri obiettivi di mercato. Si tratta
quindi di un insieme, un paniere di strumenti sui quali si ha un diretto controllo aziendale, e che quindi si differenziano da tutti i fattori cosiddetti esogeni, ovverosia esterni e che esulano dal controllo aziendale, che l’impresa subisce più o meno passivamente. Bene, adesso che abbiamo definito questo paniere di leve la domanda che sorge spontanea è: quali sono queste fantomatiche leve?
Philip Kotler, il Kuaska del marketing per intenderci, è colui che ha coniato l’espressione e individuato le 4P anche se a onor del vero, pur con le dovute differenze, in principio furono teorizzate da Jerome McCarthy. Le 4P in questione corrispondono a Prezzo,
10 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
MARKETING di Matteo Malacaria
Prodotto, Promozione e Distribuzione (dall’inglese Placement). Questa teoria, trita e ritrita, più volte rivista e ampliata - oggi qualcuno addirittura parla delle 7P - rappresenta una pietra miliare del marketing e la base del successo di ogni impresa che si rispetti. Ho voluto rendertene partecipe per uno scopo ben preciso: farti comprendere quanto al mercato della birra artigianale italiana manchino, appunto, le basi.
La leva del prodotto
Partiamo dalla prima riflessione in merito: com’è possibile che il Prodotto sia considerato una leva di marketing?
Questa è la domanda che potrebbe porsi chi non ha letto i miei articoli precedenti (vedi Birra Nostra Magazine 2022) in cui provavo a informare i lettori sul fatto che “fare marketing” è ben diverso da “fare comunicazione”, né tantomeno si può ridurre a “vendere l’anima al diavolo pur di fare cassa”. Fare marketing significa “fare mercato”. Punto. In questa espressione, semplice e concisa, si raccoglie invero un mondo fatto di infinite possibilità, tutte assorbite all’ampio raggio di azione del marketing. Ecco perché, quando un birrificio artigianale alquanto tradizionale si scontra con le bislacche azioni di promozione attivate dalla concorrenza, sostiene - e praticamente accusa - il concorrente di pratica sleale: fare marketing anziché fare prodotto. E qui casca l’asino, perché abbiamo appena detto - pardon, Mister Kotler ha detto - che il prodotto è una leva di marketing tanto quanto lo sono promozione, prezzo e distribuzione. Ma allora perché serpeggia così tanto malumore quelle rare volte in cui si assiste a un uso così peculiare di codeste leve? I più maliziosi direbbero l’invidia da parte di chi “non ci ha pensato prima”, la verità è che su questo tema regna il caos. La maggior parte della confusione riguarda il concetto stesso di marketing, che per certi versi ricalca la stessa confusione che serpeggia ancora oggi nel consumatore medio quando
si trova ad affrontare la distinzione tra birra artigianale e birra industriale. C’è tuttavia una differenza, una clamorosa differenza: mentre la confusione tra birra industriale e artigianale è responsabilità di noialtri, inesperti nell’utilizzo della leva della Promozione, la confusione sul marketing, invece, è dovuta alle pregresse lacune, alla mancanza di studi appositi e di conoscenze sul tema, nonostante si tratti delle basi dell’attività di impresa.

Il secondo spunto di riflessione riguarda il fatto che, se si prova ad analizzare il comportamento degli attori di mercato, ossia dei birrifici artigianali, con riferimento alle summenzionate leve, è possibile avere un’idea più chiara di quelle che sono le diffuse tendenze improprie, gli errori e tutta quella marea di opportunità che ripetutamente vanno perdute, un po’ come i fondi stanziati dall’Europa per il sostegno del comparto imprenditoriale italiano. In questo dato di fatto, testimoniato dalle statistiche che confermano la pressoché totale immobilità del consumo pro-capite italiano di birra artigianale - il quale non solo rimane stabile da molti anni a
questa parte, si attesta anche ben al di sotto dei paesi più virtuosi - dimostra il principale limite di questo mercato: l’incapacità di guardare oltre.
Il piccolo birrificio made in Italy è bello, romantico, affascinante… Possiamo riempirlo di complimenti sotto l’aspetto puramente estetico, per converso bisogna ammettere che non è coraggioso, essendosi sempre accontentato di ragionare in piccolo, limitandosi a curare il proprio circoscritto giardino. Il risultato di questa diffusa tendenza è che oggi l’Italia possiede birrifici sparsi a destra e a manca lungo tutto lo stivale, eppure nessuno di questi vanta una produzione che sia anche solo lontanamente paragonabile ai colossi mondiali, anch’essi sempre e comunque artigianali. Che ci piaccia o no, in Italia ce la cantiamo e ce la beviamo da soli.
Ragionare in prospettiva
Di recente mi è parso davvero triste un episodio occorso a seguito di una delle più importanti kermesse di settore. Rimangono a me sconosciuti - fortunatamente - i particolari, tuttavia sono stato testimone dello sfogo riversato
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 11 aprile 2023 MARKETING
sui social forse con troppa leggerezza. Non entro nei dettagli, tuttavia mi permetto di menzionarlo per avvalorare la mia arringa. È accaduto che un singolo individuo, uno chiunque che bazzica il mondo della birra artigianale, si è lasciato andare in un pianto dirotto a seguito della manifestazione, additando la colpa a un mondo che non lo considerava abbastanza. Uno sfogo doppiamente sbagliato: eticamente, se così possiamo dire, poiché fatto sulla piazza sbagliata; e concettualmente, perché trovo assai curioso che il singolo individuo debba pretendere l’attenzione da parte del collettivo, figurarsi dell’intero mercato della birra artigianale. La mia personalissima chiave di lettura è che a furia di frequentarci sempre tra i soliti quattro gatti e di incontrarci durante questa o l’altra occasione, ci siamo intimamente convinti di essere protagonisti di questo
settore. Peccato che siamo solo spettatori. Basti pensare alla totale ininfluenza del peso del singolo consumatore nel mercato della birra industriale, che con le dovute differenze dovrebbe essere il benchmark per il mondo della birra artigianale. A rendere ancora più drammatico il fenomeno di puro egoismo, c’è da dire che la stessa platea di spettatori di cui facciamo parte dovrebbe essere ben più estesa. Torniamo così al fatto che siamo sempre e solo noi, i soliti noti, a far fuori qualche birra alla settimana. Giusto per fare un termine di paragone, mentre l’industria riempie e fa straripare gli stadi, noi del settore artigianale è già tanto se riusciamo a riempire gli spalti di un teatro. E ritorno al succo della questione: non ragioniamo in prospettiva. Basterebbe utilizzare correttamente le suddette 4P per riuscire nell’intento. Il Prodotto è già di per sé tangibile e ricco
di intrinseco successo, giacché con il suo peculiare carattere la birra artigianale ha certamente la capacità di affascinare, incuriosire, fare innamorare al primo sorso. Esattamente come per il sottoscritto, invaghitosi della birra dopo un illuminante assaggio, sono sempre più le persone che decidono di frequentare corsi di degustazione poiché interessati a vivere un approccio più consapevole con una bevanda dalle sfumature prima ignote. Poi subentra il Prezzo, e qui si apre un’altra parentesi che non farei in tempo ad argomentare in questa sede, ma che ho già parzialmente espresso altrove. Là fuori è pieno di esempi di Prodotto che hanno un Prezzo ben al di sopra del valore di produzione. Aggiungiamoci il margine di profitto, va bene, ma tutto il resto cos’è, aria fritta? E no, caro mio, il margine esistente tra costo di produzione e ricavo di vendita si chia-

12 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
MARKETING






ma semplicemente brand. Una solida e rispettabile - se non addirittura iconica - immagine aziendale dà al prodotto o servizio un valore aggiunto, che il consumatore apprezza e a fronte del quale è disposto a pagare più. Un esempio eclatante, giusto per rendere l’idea: perché una bottiglia Cantillon costa molto di più rispetto ad altre bottiglie simili? Perché la domanda è alimentata dal desiderio di possedere il brand e solo in maniera residuale dalla voglia di assaporare la bontà del contenuto. L’esempio che porto sempre ai miei alunni per rendere intellegibile il concetto è il paragone tra una tuta Nike e una della Kappa: a parità di tessuto e di design, la differenza di prezzo è data dal logo impresso. Stiamo verosimilmente disposti a pagare anche il doppio per una tuta Nike, perché in quel nome, in quel logo e in quel prodotto si riversa tutto il lavoro fatto negli anni da parte dell’impresa per la costruzione di una propria Brand Reputation. Ritornando alla birra, quindi, il problema non è
tanto che la birra artigianale costa più di quello industriale, il problema è che i birrifici non sono riusciti (ancora) a crearsi una loro identità e a monetizzarla, e di conseguenza faticano a giustificare il differenziale di prezzo. Una pezza è parzialmente data dai diffusi riferimenti alla qualità, che tuttavia ti ricordo essere un fattore ininfluente se prima non si lavora sulla percezione di qualità. Il che rimanda alla terza P…
Promozione = comunicazione
La Promozione è la leva che più di tutte può essere considerata espressione del marketing, perlomeno secondo l’accezione comune, seguita immediatamente dalla Distribuzione, che più delle altre evidenzia il ridotto raggio d’azione del comparto attuale. Da una parte occorre innanzitutto rivedere integralmente l’approccio, capovolgendolo completamente: la promozione/comunicazione non va intesa a fini istituzionali, né tanto meno limitarsi a sottolineare solo ed esclusivamente gli aspetti più squisi-

tamente qualitativi; il nuovo approccio deve pensare in grande, creare campagne pubblicitarie che lascino il segno, che facciano parlare di sé prima ancora che del prodotto.
In oltre trent’anni di birra artigianale italiana è mancato il sensazionalismo, il coraggio di bussare alla porta degli italiani con iniziative diverse dal classico produco-quindi-vendo. Restare nella propria comfort-zone è bello, piacevole, confortante, ma non sostenibile, e qualcuno ne ha fortunatamente preso coscienza. Adesso ci sarebbe bisogno che quel qualcuno diventino tutti e il gioco è fatto. Ragionare in piccolo va bene solo e soltanto in un mercato non in espansione, dove non sussiste il rischio di saturazione e dove non nascono nuovi concorrenti un giorno sì e l’altro pure. E per favore, non venire a dirmi che quando il prodotto è tradizionale la Promozione deve comportarsi di conseguenza, perché mi basta menzionare Taffo e la sua straordinaria capacità di distruggere un tabù secolare per contraddirti. Vuoi un esempio che riguardi più da vicino la birra artigianale? Detto, fatto: le pizzerie, come anche le attività a vocazione agricola, stanno vivendo oggi una nuova primavera. Si sono scrollate di dosso le ragnatele e hanno saputo rivedere il loro modo di fare impresa, grazie anche all’apporto di giovani imprenditori che hanno apportato innovazioni di prodotto, di processo e anche di concetto. Oggi ci sono attività agricole che sono fenomeni di rilevanza sociale, così come pizzerie osannate alla stessa stregua di locali stellati. Dici niente!
Non mi stancherò mai di sottolineare che il male del marketing è chi lo utilizza come bluff, puntando tutto sull’apparenza senza un briciolo di sostanza. Questa pratica, purtroppo assai diffusa ed erroneamente considerata “fare marketing”, in realtà poco c’entra con la materia in oggetto. Giacché fare marketing significa fare mercato, vendere con il solo scopo di monetizzare “tutto e subito” non aiuta a conseguire quest’obiettivo. Una vol-
14 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MARKETING
ta, forse, questa pratica funzionava, ma stiamo parlando degli albori del marketing, degli anni ’50. Oggi è tutta un’altra storia. Oggi fare marketing significa costruire relazioni salde, rapporti di reciproco valore che motivino le persone a favoreggiare un prodotto rispetto a un altro nel rispetto di uno specifico brand. Il mio invito, rivolto a chi la birra la fa buona per davvero, è appunto di iniziare
a ragionare in grande, da imprenditori e non solo da birrai, nella consapevolezza che non sempre “piccolo è bello”: a volte è semplicemente sfigato.
Il pensiero al consumatore
Concludo facendoti una domanda: abbiamo parlato di Promozione, quale credi che sia il suo oggetto? La birra, vero? Ecco un altro errore da novizi:
vendere birra parlando di birra è roba da poppanti. Le grandi aziende, dal settore birrario a quello dell’abbigliamento sportivo, ci insegnano che la promozione/comunicazione di brand ha come oggetto il consumatore. È lui il vero protagonista della storia d’impresa, ed è colui che decreta il successo oppure il fallimento di ogni iniziativa di marketing. Lungi da me condividere il vecchio adito secondo cui “il cliente ha sempre ragione”. Con quanto appena espresso vorrei semplicemente sottolineare che comunicare per vendere oggi non ha più alcun effetto, se non su una ristretta cerchia di consumatori a cui il prodotto piace. I soliti noti, appunto. Per andare oltre, per arrivare alle grandi masse critiche di consumatori, occorre rivedere l’attuale Promozione di settore e i suoi due interlocutori: da una parte il brand, non più il birrificio, dall’altra il consumatore, non più il prodotto. Un esempio eclatante su tutti: BrewDog. Anche loro, oggi colossi a cavallo tra l’artigianale e l’industriale, all’inizio erano quattro gatti, anzi due persone e un cane. Tuttavia hanno sempre saputo guardare in prospettiva, utilizzando la birra come mezzo - e non come fine - per raggiungere i loro scopi: creare un brand di successo. Il fatto che là fuori sia pieno di BrewDog Bar e di consumatori che si comportano da ambasciatori del marchio è la dimostrazione tangibile del loro successo. Il nome stesso individua come tutto fosse frutto di una strategia ben studiata, della volontà di non essere un birrificio tra i tanti, bensì di essere il riferimento per tutti coloro i quali vogliono partecipare alla “rivoluzione” della birra artigianale. Checché se ne dica, anche se non esistono più le Punk IPA di una volta, ai piani alti di BrewDog poco importa finché il mercato dà segnali di apprezzamento e crescita. Questo, come altri esempi virtuosi - in Italia, tra tutti, spicca Cr/Ak - dimostra che prima di pensare ai quattro ingredienti per fare la birra bisognerebbe pensare alle 4P del Marketing Mix. Meditate, gente, meditate!★


BIRRA NOSTRA MAGAZINE 15 aprile 2023 MARKETING
LA PIZZA ALLA ROMANA (L’elementare)

La pizza tonda, passione irresistibile. Questo semplice disco di pasta lievitata, fatto con acqua, farina e sale, lavorato con le mani, concedendogli tempo, reso finalmente edibile dal fuoco, risulta irrimediabilmente attrattivo. Per noi italiani, poi… Nonostante negli USA molti credano che la pizza sia stata inventata lì e nonostante la sua creazione e diffusione siano piuttosto recenti, possiamo dire che per noi del Belpaese è praticamente un cibo genetico.
A partire dalla città di Napoli, con cui vanta un legame unico, viscerale. Qui è stato trovato il primo documento, datato 1799, che certifica l’esistenza della figura del pizzaiuolo: lavoro così umile e poco considerato da non poter avere la propria corporazione di mestiere. Nel suo dizionario italiano del 1905, il lessicografo Alfredo Panzini è il primo a definire in modo corretto non solo la pizza, ma anche, il suo luogo di consumo, la pizzeria. Anche se, ancora per un bel
po’, questo straordinario cibo rimarrà un fenomeno limitato al contesto partenopeo. Nel 1884, ne Il ventre di Napoli, Matilde Serao aveva scritto: “Un giorno un industriale napoletano ebbe un’idea. Sapendo che la pizza è una delle adorazioni culinarie napoletane, sapendo che la colonia napoletana in Roma è larghissima, pensò di aprire una pizzeria a Roma. […] Sulle prime la folla vi accorse, poi andò scemando. La pizza, tolta al suo ambiente napoletano, pareva una
16 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 ABBINAMENTI
di Roberto Muzi
stonatura, e rappresentava una indigestione; il suo astro impallidì e tramontò, in Roma; pianta esotica, morì in questa solennità romana”.
La diffusione a livello italiano (e internazionale) avviene solo nel secondo dopoguerra, con l’emigrazione napoletana e la creazione di un vero mercato nazionale, e grazie a un contesto di imponenti cambiamenti economici, sociali e culturali, che vedono nascere e crescere un pubblico cittadino perfetto per la fascia di mercato delle pizzerie: voglia di uscire, nuove abitudini serali, ambienti confidenziali, Scarsa possibilità di spesa.
L’attualità parla di una presenza capillare delle pizzerie, con pochi posti, però, va detto con onestà, dove si mangia una pizza con ingredienti selezionati, lievitazioni e cotture corrette, realizzata con dedizione, competenza, gioia. Allo stesso tempo, dobbiamo raccontare di un numero piccolo, ma crescente di locali condotti in maniera virtuosa, con una proposta originale di impasti, ricette e accompagnamenti alcolici.
E proprio a quest’ultimo aspetto vogliamo dedicarci.
Lo storico matrimonio tra birra e pizza, in realtà scaturito da limitazioni legali (originariamente nelle pizzerie non si potevano servire bevande con gradazioni superiori all’8%), è poi divenuto inscindibile (e non scevro da storture e pessimi luoghi comuni). Roma, probabilmente per via dell’esplosione del consumo di artigianali, è divenuta uno dei punti principali di idee, tecniche e progetti imprenditoriali originali e notevoli. A partire dalla metà degli anni 2000, grazie soprattutto al modo tutto nuovo con cui Gabriele Bonci ha reinterpretato la pizza al taglio (importanza alla materia prima, condimenti arditi, capacità comunicativa) e Giancarlo Casa e Stefano Callegari hanno rinnovato il concetto di quella al piatto (leggera, ben fatta, con ingredienti selezionati, ampia scelta di vini e birre, personale competente). Nelle loro cucine si sono formati decine di pizzaioli, cuochi e camerieri che si

sono poi riversati nella capitale (e non solo) a “spargere il verbo”. Visto il successo di questo nuovo concetto di pizzeria, molti sono stati persuasi nell’imboccare la medesima strada. Ciò, al netto di scialbi duplicati, ha sortito il significativo effetto di riempire la capitale di progetti pizzaioli che hanno notevolmente elevato il livello e creato una nuova attenzione, da parte del pubblico e dei giornalisti di settore.
La qualità è Elementare
In questo “risveglio capitale”, interessanti e positivi gli esiti delle proposte di una nouvelle vague che ha investito la riscoperta della pizza autoctona, quella alla romana.
Tra i progetti più interessanti c’è sicuramente L’elementare, nato originariamente “in esterna”, nell’estate 2020, dentro il grande contenitore estivo di Parco Appio, con la volontà di una proposta senza fronzoli, con lievitazioni ben condotte, ingredienti di alto livello e attenzione alla filiera (spicca su tutti la collaborazione con Ethical Food), ricette della tradizione gastronomica romana
che diventano pizza, ambiente informale, ma curato, e possibilità di attingere alla varietà della proposta alcolica, con una quindicina di spine e una stuzzicante carta di vini naturali. Il successo riscontrato ha convinto i due protagonisti, Federico Feliziani, giovane imprenditore impegnato anche nel mondo della distribuzione, e Mirko Rizzo, pizzaiolo romano conosciuto e talentuoso, a farne un locale vero e proprio. Vista anche la contemporanea e golosa occasione di rilevare il mitico Bir & fud, un locale a cui tutti gli appassionati di birre (e pizze) buone devono qualcosa e che, per varie ragioni, ansimava da qualche tempo. Proprio qui ho voluto trascorrere una serata di abbinamenti speciale, da raccontare.
A tavola
Cominciamo con la pizza crostino. Un grande classico, arricchita da uno dei prosciutti cotti più buoni attualmente in circolazione, quello di Pork’n roll, riuscitissimo e articolato progetto dei fratelli Roccia (fattoria, bottega, norcineria, pub, beer firm).
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 17 aprile 2023 ABBINAMENTI
Per l’abbinamento abbiamo scelto la Calandrina, hoppy saison con aggiunta di scorze di agrumi e bacche di ginepro, 4.8% di alcol, di Hilltop Brewery, una delle migliori realtà brassicole del Lazio. La personalità dei due elementi è la stessa, spiccata; la birra, in stato di grazia, vanta note fruttate e floreali che si aggiungono alle tendenze dolci e alla percezione di un umami (del prosciutto cotto) sontuoso; rimane in bocca una stimolante disputa tra le tendenze dolci dei malti e la sapidità del salume. La gasatura pulisce le resistenze finali dell’untuosità, mentre si compone la retrolfattiva con un tocco balsamico e un accenno di miele di tiglio. Un grande inizio, un matrimonio straordinario.


Secondo abbinamento
Proseguiamo con un altro classico, ma rivisitato: la Marinara doppia, con passata di datterino giallo, pachino gialli arrostiti, alici di Sciacca,
olio all’aglio, basilico, prezzemolo e peperoncino. Ingredienti molto semplici che riescono a costruire un insieme eccellente: i pomodorini gialli conferiscono dolcezza e acidità, la tendenza piccante è evidente, sapidità e aromaticità delle (freschissime) alici inconfondibili: una pizza profumata e invitante. L’abbinamento in questo caso è ricaduto sulla Porpora, storica ricetta di Birrificio Lambrate, che nel tempo è stata cambiata e affinata e che oggi può essere inserita nella originale categoria delle hoppy doppelbock, con taglia etilica che raggiunge l’8%. Il connubio è prodigioso: lo spessore dei malti è una necessità per la sapidità e per il piccante,
enfatizzato dalla luppolatura generosa, ma non soverchiante; la spiccata aromaticità della pizza trova un valido alleato nella componente caramellata, cui si appoggia, cui aggiunge gusto, mentre le capacità asciuganti dell’alcol e del luppolo assorbono le untuosità vaganti. Il palato rimane nettato, ricco di una memoria di stimoli e ritorni aromatici. Viene voglia di ripetere morso e sorso e di farlo ancora e ancora.

Una ricetta originale
Terzo assaggio, Al norcino non far sapere, ricetta composta da una base bianca
18 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 ABBINAMENTI
Porpora del Birrificio Lambrate
con cicoria, prosciutto crudo riserva Re Norcino, composta di pere, pecorino Coccia Nera.
Pizza molto ricca, fatta soprattutto di piccantezza, sapidità e ricchezza aromatica, dalla retro-olfattiva molto persistente.
L’abbiamo abbinata con la Ciube, conosciuta e apprezzata Double IPA, consolidata ricetta di un altro birrificio ormai storico come Lariano, con l’8% di alcol.
La birra, ambrata, caramellata, fondamentalmente morbida, permette di ripulire, attenuare il piccante e l’amaro, liberare una fine balsamicità, toni da Maillard e fertili contrasti gustativi (tra dolce e sapido, da una parte pera, malti, impasto della pizza, dall’altra, prosciutto e pecorino) e aromatici (prosciutto, cicoria e pere sfidano la pugnacità di caramello, resine, agrumato).
Un amaro ben dosato e un quantitativo di alcol opportuno permettono di chiudere l’abbinamento in maniera favorevole, preparando al prossimo morso.
Dopo aver mangiato quasi una tonda intera e aver assaggiato numerose birre al fine di trovare gli accostamenti migliori (si dice così, no?), conscio del fatto che mi avrebbero aspettato almeno altri due assaggi (e altrettante prove di abbinamento), mi sono alzato per due chiacchiere con Mirko.
L’avevo conosciuto e apprezzato già ai tempi di Pommidoro, piccola e frequentatissima pizzeria al taglio nel quartiere Centocelle. Gli chiedo, innanzitutto, di questa virata dalla teglia al disco.

“La pizza romana qui nella capitale è sempre stata un’abitudine. Però, quando già ero del mestiere e la cercavo al piatto, non riuscivo a trovarne una che mi soddisfacesse. Dunque, pensai che potesse essere una buona idea imprenditoriale e mi venne la voglia di applicare alla tonda ciò che avevo imparato negli anni di esperienza con un prodotto molto tecnico come la pizza al taglio. Volevo semplicemente realizzare con cura un cibo che amavo e che mi ricordava l’infanzia: è con tali premesse che è iniziata questa piacevole sfida.”
La pizza è farina (di frumento), innanzitutto, e Mirko lo sa bene. Per il suo impasto, utilizza la tipo zero, con una minima aggiunta di tipo 2, entrambe prodotte da Molini Fagioli (Magione, PG), scelte per la qualità dei prodotti e per l’attenzione all’aspetto ecologico, con il progetto OIRZ (Origine Italia Residuo Zero, nato con il fine di costruire una filiera sostenibile). Dopo anni di collaborazioni, anche l’azienda umbra ha scelto lui, come figura di ambasciatore del marchio.
Acqua, farina e poi il lavoro del lievito: la proverbiale leggerezza dell’impasto è favorita da un percorso di lievitazionematurazione di circa 24 ore, da alti livelli di idratazione, dall’attenta cottura nel forno a legna.
Infine l’aspetto, differenza sostanziale tra pizza napoletana e romana, poiché in quest’ultima, bassa e schiacciata, si comprime l’impasto col mattarello. “La stesura della palletta, del peso di circa 180 grammi, avviene prima tramite apertura a mano e poi mediante appiattimento con il mattarello. Doppia operazione che porta a un bordo presente, frutto del lavoro di manipolazione, e a
un interno del disco sottile, ma senza disintegrare la struttura dell’impasto: il compromesso che mi soddisfa di più.”
E pure a me, devo dire, che torno al tavolo per gli ultimi due assaggi.
Bufala e Reggiano
La quarta pizza è una classica Margherita di bufala con il noto cacio emiliano grattugiato sopra (che aggiunge aromaticità e sapidità).
Normalmente con una pizza margherita si trova grande soddisfazione nell’accop-

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 19 aprile 2023 ABBINAMENTI
Il bancone di Bir & Fud
piamento con una classica hellerbock. Ma questa volta, complice anche la presenza del Parmigiano, l’idea era di battere una strada alternativa e la scelta è ricaduta sulla splendida Barry’s bitter, ancora di Hilltop: da un punto di vista tecnico l’abbinamento è quasi indecifrabile, essendo una birra con poco corpo, scarsa gradazione alcolica (4.2%) e poca persistenza gusto-olfattiva. Ma è probabilmente l’impasto a darci una mano, poiché, essendo una base neutra, tampona l’acidità del pomodoro e la grassezza della bufala, che altrimenti soverchierebbero l’esile bitter, permettendo alle tostature dei malti di liberare classe e aromi (fetta biscottata, foglie da tè) e di trovare un dialogo con i condimenti presenti. Di difficile spiegazione, di elevata soddisfazione. Come pizza di chiusura optiamo per la Capricciosa, con uovo alla Bismarck: un classico inossidabile, come le polpette della nonna o la lasagna della mamma (o viceversa), sempre in grado di carezzare e consolare.

Per comporre la coppia è stata coinvolta la Winter ale, una natalizia col 9% di alcol, brassata da Yblon, opificio ragusano in costante crescita. È caratterizzata da una grande generosità maltata, offrendo al naso riconoscimenti di frutta scura matura e caramello e in bocca tendenze dolci e lunghezza gusto-olfattiva, chiudendo il sorso con lievi toni affumicati.

In abbinamento fa sentire la sua personalità, rimettendo equilibrio dopo il passaggio della pizza e disciplinando l’anarchica energia delle tante stimolazioni aromatiche e gusto-olfattive presenti sulla pizza: la nuance fumè aggiunge verve al prosciutto, mentre la parte maltata dialoga con l’acidità del pomodoro, aiuta a domare l’amaro del carciofo (e quello più leggero dei funghi) e ci permette di affrontare con poca riverenza l’uovo aperto e cotto, normalmente un fattore incline alle bizze, nell’abbinamento. Resta in bocca una gioia aromatica, una scia, lieve e invitante, di liquirizia e speziature.

Teoricamente avremmo finito. Ma a catturare l’attenzione è un dolce scritto sulla lavagna: “Capo Nord: pane speziato farcito con zabaione, mostarda di zucca e mele, chicchi di melograno”. Troppo attraente per farselo scappare. Una scusa, probabilmente, per bere e abbinare l’Emilia Paranoica, imperial stout da 10 gradi, ennesima perla di Liquida (Ostellato, FE).
Nell’attesa, mi viene in mente la perfetta considerazione che fece il grande Jean Anthelme Brillat-Savarin a proposito della pasticceria: “I dolci si mangiano solo quando l’appetito naturale è già soddisfatto e non rimane allora che quell’appetito di lusso che siamo costretti a stimolare con quanto l’arte ha di più raffinato e la varietà di più solleticante”.
La scelta del dessert è stata felice: profumato, rotondo, suadente, e lo è altrettanto l’incontro con la signora scura nel bicchiere, un’intesa tra due persone di classe superiore, capaci di mostrare talento ma, allo stesso tempo, di mettersi reciprocamente a disposizione: insieme creano il sapore del pan di Spagna (che non c’è) ed enfatizzano la nota di cannella, mentre le tostature completano il ricco portfolio aromatico, mettendo in evidenza lievi e piacevoli percezioni ossidate, variegate “dolcezze aromatiche” e refoli speziati. ★
20 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
ABBINAMENTI
Emilia Paranoica, Stout di Liquida
HOSPITALITY 2023, una grande platea per la birra artigianale

La 47a edizione di Hospitality
- Il Salone dell’Accoglienza, fiera internazionale leader in Italia dedicata all’Ho.Re.Ca. che si è tenuta a Riva del Garda (Trento) dal 6 al 9 febbraio ha superato ogni migliore previsione offrendo ai 18.500 visitatori, tutti operatori di settore, uno spaccato di quanta e autorevole offerta ci sia nel variegato mercato dell’ospitalità.
In una delle poche strutture fieristiche verticali italiane, tre piani fittamente occupati da stand e postazioni, abbiamo assistito all’esibizione professionale di aziende, società di servizi, rivenditori, finanche di scuole specializzate che hanno sicuramente restituito al pubblico presente un soddisfacente e qualificato quadro del mondo dell’accoglienza oggi in Italia.
Limitandoci al Padiglione che ha ospitato SOLOBIRRA - oltre a Winescape, l’area dedicata al turismo del vino e dell’olio, e a RPM-Riva Pianeta Mixology, riservata all’arte del bere miscelato - abbiamo registrato un crescente interesse nei riguardi dei birrifici artigianali, peraltro coinvolti in numerose iniziative, tenutesi nella Beer Arena. Nell’arco dei quattro giorni della manifestazione si sono così tenuti workshop, iniziative esperienziali, case history, seminari e due contest, il concorso tecnico Solobirra 2023, che ha messo in gara 243 birre artigianali italiane di 22 diverse categorie, ed il Best Label 2023, dedicato alle eccellenze grafiche, dove sono state valutate 60 diverse etichette originali e il miglior packaging coordinato. Ad aggiudicarsi il premio Best Beer
2023 è stata la 21 12 del Birrificio Incanto, mentre il premio Best Label
2023 è stato assegnato a Dario Fruttarolo Design con il progetto grafico ideato per il Birrificio Badalà. Allo studio Frei und Zeit, invece, il premio per il miglior packaging coordinato con un progetto realizzato per il Birrificio Viertel Group.
L’area SOLOBIRRA, animata dalla notevole partecipazione di Birrifici Artigianali Italiani presenti, ha ospitato inoltre diverse proposte degustative, grazie all’apporto di beer sommelier e degustatori qualificati che si sono alternati nei giorni di fiera.
Birra Nostra è stata coinvolta dall’organizzazione di Hospitality per una serie di interventi dedicati al turismo brassicolo che in fiera è stato affrontato anche grazie al contributo degli organizzatori della Strade delle Birra della Regione Marche, con la presenza degli amici del Birrificio del Catria. Da segnalare inoltre la partecipazione del Giardino delle

portunità che ha visto la partecipazione di Giorgio Zinno di Turisti in Fermento, e Giulia Vinci, responsabile eventi del Comitato operativo GREAL-Geographic Research and Application Laboratory dell’Università Europea di Roma. Tra i relatori anche Fabio Simoni, del Birrificio Bionoc, intervenuto in qualità di Presidente degli Artigiani della Birra di Trento, e Luca Grandi di Birra Nostra, che ha moderato l’appuntamento e curato l’organizzazione.
Per la numerosa platea che ha preso parte agli incontri è stata l’occasione per conoscere questo interessante ed innovativo segmento turistico attraverso le testimonianze dirette dei produttori, da noi considerati veri e propri presidi del territorio in cui operano, e le analisi e le prospettive illustrate dai ricercatori e dagli operatori coinvolti in questa due giorni dedicata alla craft tourist revolution.
Luppole con una case history dal titolo HopTour e HopFood: il luppolo in cucina, nuove esperienze degustative e turistiche. Qualificata la presenza al talk show Turismo brassicolo in Italia: prospettive e op -
L’esperienza di Birra Nostra MAGAZINE, media partner di Hospitality 2023, è stata significativa per riuscire a consolidare un risultato che lascia ben sperare per il futuro del settore e per nuove collaborazioni in vista dell’edizione 2024.
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 21 aprile 2023
CHI BEVE BIRRA camperà cent’anni?

MATERIE PRIME di Luca Pretti
Sono definite come “bioattive” le molecole considerate non indispensabili nella dieta, che hanno la proprietà di determinare un beneficio alla salute, contrastando e/o inibendo la comparsa di alcune patologie. Quando sono presenti in un alimento o in una bevanda, si assiste ad una semplificazione che porta ad estendere le loro proprietà terapeutiche all’alimento che le contiene.
Anni fa fu la volta del resveratrolo, sostanza fenolica assai diffusa nel mondo vegetale con riconosciuta attività cardioprotettiva; isolata anche nei vini rossi sarebbe tuttavia necessario, per raggiungere gli effetti desiderati, un consumo che si potrebbe definire spropositato. Molecole bioattive sono state isolate anche nella birra quasi a voler confermare il proverbio che “chi beve birra campa cent’anni”. Alcune di queste provengono direttamente dalle materie prime, altre sono il risultato dell’interazione e dall’effetto sinergico che si realizza tra di esse. In molti lavori scientifici è stato proposto che l’elevato contenuto di polifenoli sia nel vino sia nella birra contribuisca ad ottenere effetti benefici sulla salute con il vantaggio che la birra, rispetto al vino, presenta mediamente un contenuto alcolico inferiore.
I polifenoli, gli oli essenziali o le vitamine nella birra presenti in concentrazioni maggiori nei luppoli, sono però componente minoritaria tra gli ingredienti della birra e sono, per loro natura, soggetti ad ossidazione e termolabili, il che, tendenzialmente, li porta a perdere parte delle loro proprietà funzionali durante la bollitura del mosto. È anche bene ricordare che ogni varietà, utilizzata per la realizzazione dei differenti stili birrari presenta caratteristiche compositive geneticamente determinate ma che dipendono anche dalle condizioni colturali, dal clima, dalla natura del suolo o dall’altitudine alle quali le piante vengono coltivate. Alla luce di queste evidenze e del fatto che le quantità mediamente utilizzate rispetto agli altri ingredienti
sono di poca entità (in alcuni casi 200 g ogni 100 litri di mosto) la tipologia e la concentrazione di sostanze, con attività potenzialmente benefica nella birra finita, sono estremamente variabili.


I benefici del luppolo
Tra le varie molecole presenti generalmente nei luppoli e delle quali sono note le proprietà farmacologiche troviamo la 8-prenilnaringenina, un fitoestrogeno
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 23 aprile 2023 MATERIE PRIME
presente anche nella soia o nel trifoglio, che avrebbe un ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, dell’osteoporosi e dei tumori al seno. Secondo alcune sperimentazioni inoltre, quando assunto come integratore alimentare, produce una riduzione significativa dei sintomi della menopausa. È chiaro
che si tratta di risultati ottenuti utilizzando molecole in purezza, con quantitativi e protocolli standardizzati sia per la preparazione dei campioni sia delle persone sottoposte al test. Alcuni autori hanno però riscontrato un effetto positivo anche nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, demenza e di-
sturbi cognitivi, derivante dal consumo moderato di birra. Effetto che è stato correlato all’assunzione diretta del fitoestrogeno ed anche dalla possibilità che un suo precursore, sempre proveniente dal luppolo, possa essere convertito in questa molecola dal microbiota del tratto intestinale del consumatore.
Tecnologia produttiva
Anche questo aspetto può avere una influenza nella quantità e qualità di molecole che possono permanere nella forma bioattiva nella birra. Un esempio è rappresentato dalla luppolatura in fermentazione o post fermentazione (dry hopping) che le preserva dall’effetto dannoso delle alte temperature. Quando poi la birra viene sottoposta a rifermentazione in bottiglia, si stima che le cellule di lievito che residuano dopo il processo rilascino una buona percentuale di proteine (45-60%), sali minerali, vitamine del complesso B, β-glucani, oligosaccaridi e altri preziosi componenti. Per quanto riguarda i β-glucani, la parete cellulare, nel genere Saccharomyces sp. ne contiene circa il 55-65%; esiste un’ampia bibliografia che ne sottolinea la funzione immunomodulatoria antitumorale, ed altri effetti come le attività antiossidanti, antimicrobiche e positiva sulla salute delle vie respiratorie superiori. Lo studio della ecologia microbica attraverso l’isolamento, la classificazione e la caratterizzazione tecnologica dei fermenti da matrici biologiche di differenti domini alimentari, come nel caso delle paste acide, rappresenta un altro serbatoio di notevole importanza, in virtù della potenziale produzione di molecole bioattive tra le più diverse.
I probiotici
Un altro dei modi in cui il consumo di birra può essere combinata con l’ideale effetto benefico sulla salute è quello relativo all’uso nel processo di produzione di microrganismi probiotici. Le fonti tradizionali di microrganismi probiotici sono i prodotti lattiero-caseari rappre-


24 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME
sentati da batteri lattici dei generi Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus o Streptococcus a cui viene riconosciuto un effetto positivo sulla salute del tratto gastrointestinale.

L’uso di lieviti probiotici nella produzione di birra non è stato studiato in maniera approfondita, ma non mancano casi studio dai quali trarre degli spunti interessanti. In particolare è stata verificata la possibilità di utilizzare un lievito della specie Saccharomyces cerevisiae var. boulardii che ha dimostrato possedere la capacità di proteggere le cellule epiteliali intestinali dalle infezioni causate da batteri come l’Escherichia coli o da quelli appartenenti al genere Clostridium
Resta inteso che secondo le normative vigenti, le bevande che contengano concentrazioni superiori all’1,2% v/v di etanolo non possono essere considerate tra i prodotti probiotici. Pertanto, l’utilizzo di questo microrganismo nella tecnologia brassicola deve necessariamente essere inteso solo nella realizzazione di birre analcoliche.
Aggiunta di mosti
Un’altra possibilità di aumentare la presenza nella birra di sostanze benefiche consiste nell’aggiungere mosti di uva o altre varietà di frutta (fermentate o meno), di spezie o di erbe spesso derivanti dalla tradizione agricola locale.
Una pratica che trova ampia applicazione nel movimento birrario artigianale che, se da un lato permette una notevole diversificazione dell’offerta sul mercato di prodotti diversi, dall’altra amplifica la difficoltà nell’attribuire in maniera generica “alla birra”, nella sua accezione comune, proprietà benefiche. L’aggiunta di uva in ricetta come avviene per alcune birre appartenenti allo stile Italian Grape Ale porta ad aumentare in maniera significativa la concentrazione dei polifenoli in ricetta, e la conseguente attività antiossidante rispetto ad alcune birre industriali. Questo lo osservammo in un lavoro realizzato nel 2014 insieme alla collega Vanna Sanna dell’Università
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 25 aprile 2023 MATERIE PRIME
di Sassari, dove confrontammo alcune birre artigianali con mosto d’uva e altre maturate in botte anche con alcuni vini ottenuti da uve sia a bacca bianca sia a bacca rossa.
Birre funzionali
L’ideale potrebbe essere raggiunto con la realizzazione di birre che possano essere considerate alla stregua di bevande funzionali. In Italia sono definite tali quando contengono sostanze con una specifica attività fisiologica, da cui derivi un effetto benefico per la salute. Queste possono includere tra le altre vitamine, minerali, erbe o integratori alimentari e devono essere presenti in quantità significative rendendole riconoscibili per questa funzione dalle altre bevande. Non basterà ovviamente fare riferimento a delle presunte attività benefiche sull’organismo di un determinato
ingrediente; sarà invece necessario che questa venga riconosciuta da prove sperimentali certificate e che gli ingredienti siano riportati in etichetta in termini sia qualitativi che quantitativi.
La salubrità alimentare non riguarda solo l’assunzione di molecole potenzialmente benefiche, ma anche il saper evitare quelle potenzialmente dannose. In questo senso, anche le birre senza o con una bassa concentrazione di alcol assumono un sempre maggiore interesse tra i consumatori e proposte con maggiore frequenza anche tra i produttori di birra artigianale.
La diffusione delle birre funzionali ha la possibilità di contribuire a costruire il profilo di un nuovo tipo di consumatore che sarà sicuramente più esigente rispetto alle problematiche legate alla salute. Tuttavia è bene ricordare che la composizione chimica e sensoriale alla base
dei profili delle birre analcoliche è influenzata dalla tecnologia che si sceglie di utilizzare per ottenerle. Quelle basate sulla rimozione fisica dell’alcol etilico si dimostrano non selettive determinando un generale impoverimento nel profilo attribuibile alla componente degli esteri, aumentando la percezione acida.
Quando il processo è basato sull’evaporazione, oltre ad una bassa intensità aromatica le birre si caratterizzano per una percezione di un corpo scarso; mentre nel caso delle fermentazioni controllate, gli zuccheri residui rappresentano la frazione sensorialmente più rilevante, indirizzando la percezione sensoriale verso un maggiore corpo. Il compito della ricerca sarà in questo caso prezioso nell’aiutare i mastri birrai ad ottenere prodotti funzionali, di bassa gradazione alcolica, ma con profili sensoriali del prodotto su livelli di elevata qualità. ★

26 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
MATERIE PRIME
Che siano per calici per la birra artigianale o tumbler per una strawblond, i bicchieri creati da RASTAL sono pensati per enfatizzare l’esperienza multisensoriale del consumatore e al contempo soddisfare le esigenze pratiche dei professionisti della ristorazione.


RASTAL Italia srl Via Angelo Calvi, 35 29015 Castel San Giovanni Tel. +39 0523 883805 Fax +39 0523 881995 info@rastal.it www.rastal.it
T E L E
PER TUT
B I R R E
Un a ga mma c o m ple t a pe r ogni st il e
LA QUALITÀ IN MICROBIRRIFICIO Terza
puntata: misurare
densità, grado Plato e alcol nel
mosto e nella birra
In Baviera si praticava un metodo alquanto singolare per stabilire la qualità della birra: ne veniva versata un po’ sulla panca su cui si sedevano gli avventori che, come di costume, allora indossavano il classico pantalone di cuoio. Dopo la bevuta, quando si alzavano, se la birra era di buona qualità i pan-

taloni dovevano rimanere incollati alla panca. In caso contrario o il birraio aveva risparmiato troppo sulle materie prime, o l’oste aveva annacquato la birra. Le prime misure strumentali per stabilire la qualità della birra risalgono all’Inghilterra della fine del ’700. L’invenzione del saccarometro è attribuita a Thomas
Thomson, ma le prime applicazioni avvennero nell’ambito della distillazione. Il primo saccarometro per birrai fu costruito da Benjamin Martin: venne utilizzato la prima volta nella produzione di birra da James Baverstock nel 1770, ma fu reso popolare da John Richardson nel 1784. Richardson ne consentì un’ampia diffusione tra i birrai inglesi. Le prime misure esprimevano il risultato in libbre per barile e hanno permesso di stabilire le accise in modo accurato.
I gradi Brix e Plato
Carl Josef Napoleon Balling nel 1843 ha ulteriormente migliorato il saccarometro, ma soprattutto ha proposto una correlazione tra la densità e la concentrazione degli zuccheri definendo il grado Balling °Bl come percentuale peso in peso alla temperatura di 17,5 °C. In seguito, il merito principale di Balling è stato quello di trovare una formula empirica che attraverso il residuo dei carboidrati non fermentati e dell’alcol formato dopo la fermentazione permettesse di risalire all’estratto originale della birra. Nei successivi 20 anni ha continuato a perfezionare la formula mettendo in relazione l’estratto origi-

28 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME di Flavio Boero
Thomas Thomson
nale del mosto alla birra dopo la fermentazione. Ancora oggi la formula di Balling ci permette di risalire al grado originale del mosto conoscendo almeno due parametri, ad esempio, la densità della birra e il contenuto in alcol. A fine ’800 Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix e successivamente ai primi del ’900 Fritz Plato hanno ulteriormente migliorato la scala di Balling introducendo i gradi Brix l’uno e i gradi Plato l’altro. I miglioramenti di Brix e Plato hanno portato ad effettuare le misurazioni alla temperatura standard di 20°C al posto dei 17,5°C stabiliti da Balling; inoltre sono riusciti ad ottenere valori

IL METODO DELLA GOCCIA
Negli anni ’70 non esistevano i piccoli densimetri di oggi, che danno risultati affidabili con poche gocce di liquido. Nella ricerca per le fermentazioni sperimentali si disponeva di pochi litri di mosto soggetto ad un intenso campionamento. Allora si ricorreva a un metodo un po’ approssimato, ma pratico, che permetteva di usare pochi cc di liquido: si preparavano diverse soluzioni a concentrazione nota di saccarosio, si prelevava una piccola quantità del prodotto in fermentazione e si versava una goccia della soluzione zuccherina a concentrazione nota, il
più vicina possibile al risultato atteso. A quel punto si osservava il comportamento della goccia: se la goccia fosse affondata, si sarebbe ripetuta l’operazione su un altro campione con una goccia di soluzione zuccherina meno concentrata. Se la prima goccia invece avesse galleggiato, la seconda prova si sarebbe eseguita con una goccia più concentrata. Per ottenere una misura approssimata ma non lontana da quella reale si interpolavano i °P delle due soluzioni zuccherine utilizzate. Ovviamente le soluzioni dovevano essere preparate fresche tutti i giorni.
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 29 aprile 2023 MATERIE PRIME
di densità più accurati passando da 3 a 5 cifre significative. Il °P si è meglio adattato alle misure di densità del mosto e della birra ed è utilizzato ancora oggi in questo campo. Il °Bx è rimasto valido per tutto il mondo delle bevande, del vino e dei succhi di frutta. A ben vedere al giorno d’oggi non potremmo più fare affidamento sul °Bl, perché con sole tre cifre significative dei valori di densità non potremmo andare oltre alla prima cifra decimale nel calcolo del grado Plato. I densimetri moderni riescono a misurare fino alla sesta cifra decimale: considerando corretta la quinta cifra decimale, il calcolo del °P alla seconda decimale risulta preciso e accurato. Ai fini pratici spesso si confonde la densità con il peso specifico: Il concetto di densità è meno tangibile di quello di peso specifico, perché la densità è una

proprietà intrinseca della materia e misura il rapporto tra la massa e il suo volume, ma ai fini pratici è impossibile misurare la massa se non viene sottoposta a una forza. Il modo più semplice per misurare massa è attraverso la forza di gravità, e perciò attraverso il peso. Per ottenere il peso specifico occorre anche una forza che si opponga alla gravità, per questo bisogna avvalersi della spinta di Archimede. Per farlo dobbiamo applicare uno dei concetti della fisica newtoniana che abbiamo appreso fin dalla scuola media: ricordate il terzo principio della dinamica? “Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”, in questo caso la forza che si oppone alla gravità è la spinta di Archimede. “un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del fluido spostato”. Questa è la risposta alla forza di gravità che ha fatto gridare “Eureka” ad Archimede. Il peso del volume è il peso specifico. Se fossimo a gravità zero, ad esempio nello spazio, avremmo ancora una massa, ma non il peso specifico, per cui non saremmo in grado di usare il saccarometro. La misura della densità deve tenere in considerazione anche altri parametri che possono influire su precisione e accuratezza. I parametri che possono influire su massa e volume sono: temperatura e pressione. Occorre però anche chiarire il concetto di Densità Assoluta e Relativa. La Densità Assoluta è la massa di un solido, un liquido o un gas per unità di volume, in condizioni di pressione e temperatura standard (20°C e 1 atm); il valore è espresso attraverso le dimensioni che si attribuiscono alla massa e al volume e possono essere kg/m3 nel sistema internazionale oppure kg/dm3 o g/cm3 o ancora altre. Nei solidi e nei liquidi che sono incomprimibili possiamo ritenere la pressione trascurabile, mentre bisogna prenderla in considerazione nei gas che sono comprimibili. Discorso diverso per la temperatura che influisce sul volume di tutti gli stati della materia quindi anche
su solidi e liquidi. La densità assoluta è una misura dimensionale, quindi, assume una dimensione per la massa (kg) e uno per il volume (dm3). Se usassimo g per la massa, per essere congruenti dovremmo usare i cm3 per il volume. Ed è qui che entra in ballo la densità relativa, che si ottiene dividendo la densità assoluta espressa in kg/dm3, a 20°C, con la densità assoluta dell’acqua distillata pura, espressa in kg/dm3 alla temperatura di 4°C (perché a questa temperatura la densità assoluta dell’acqua è pari a 1 kg/dm3). La densità relativa solitamente viene indicata come “d” (20/4)°C senza indicare le dimensioni. Dal punto di vista pratico, nel mosto o nella birra si utilizza una densità relativa leggermente diversa: invece che rapportarla all’acqua a 4°C lo si fa con acqua a 20°C. In questo caso la densità assoluta dell’acqua non è più 1 kg/dm3, ma 0,9982071 Kg/dm3. Per distinguere la nuova densità relativa da quella classica a 4°C citata nelle pubblicazioni, la troveremo indicata con la sigla SG (20/20)°C (Specific Gravity). Ovvero peso specifico, non assoluto, ma relativo all’acqua a 20°C che, essendo adimensionale, è in realtà equiparabile alla densità relativa. La densità relativa (o Specific Gravity) attraverso formule empiriche può essere messa in relazione con le concentrazioni zuccherine per costruire delle tavole di conversione, o ancora meglio, per formulare delle equazioni polinomiali molto accurate con almeno 4 o 5 cifre significative per SG e 2 cifre significative per l’estratto °P. La densità può essere misurata con sistemi che a partire dal saccarometro di Thompson sono diventati sempre più sofisticati: il saccarometro si basa sulla densità dell’acqua e di sue miscele zuccherine. Per il principio di Archimede, i corpi che hanno densità relativa superiore a 1 affondano in acqua, quelli che l’hanno inferiore galleggiano. Il saccarometro è un corpo cavo non omogeneo che per la sua forma galleggia in un intervallo di densità ben definito, ma
30 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME
emergendo ad altezze diverse, l’asta graduata misura la densità relativa.
Altri metodi del passato
Un’altra possibilità per la misura della densità ci è fornita dalla rifrattometria, molto usata ad esempio nel mosto non fermentato. Questo metodo si basa sulla relazione che il grado di rifrazione ha con la concentrazione degli zuccheri e destrine presenti nel mosto. Un sistema molto usato in passato, più preciso del saccarometro, ma laborioso, ricorreva al picnometro, un recipiente a collo stretto che contiene un volume noto e di cui si conosce il peso preciso della tara e il volume. In questo caso era necessario l’utilizzo di una bilancia analitica di precisione e di un bagno termostatico di precisione. Questo sistema, usato insieme alla distillazione, rappresentava il metodo ufficiale adottato dalla legislazione italiana ed europea. Il metodo per distillazione prevede la separazione dell’alcol dalla componente solida, principalmente costituita da destrine; quindi, dopo aver riportato al volume iniziale con acqua distillata, si misura sia il distillato sia il residuo della distillazione. Un metodo considerato legalmente ufficiale, ma presto caduto in disuso e ora praticamente dimenticato, fu la bilancia di Westphal, uno strumento che rappresenta una via di mezzo tra una bilancia e un saccarometro.
Il sistema a tubo a U oscillante
Negli ultimi quarant’anni, questo sistema ha preso pieno possesso delle misure di densità, per l’elevato grado di affidabilità e per la sua praticità. Il tubo a U, quando viene sollecitato attraverso una vibrazione con frequenza costante, mostra un calo della frequenza proporzionale alla densità del campione in esame. Questo approccio, insieme alla misura dell’alcol con la tecnologia all’infrarosso, è il nuovo metodo ufficiale. Un tempo, per il passaggio da densità a °P si usavano delle tabelle di conversione,
o dei nomogrammi basati sulla tecnica del regolo calcolatore, sistemi completamente soppiantati prima dai calcolatori e oggi dal computer. Metodi che richiedevano delle interpolazioni o comunque delle approssimazioni. Già in passato si poteva ricorrere a curve polinomiali, più precise ma poco pratiche almeno allora. Oggi anche con un semplice foglio excel possiamo usufruire facilmente di queste formule, migliorando oltretutto la precisione del risultato e limitando la possibilità di errori. Per trovare una relazione tra SG e °P si ricorre a una equazione polinomiale al posto delle ormai obsolete tabelle. Ecco la prima polinomiale valida per un mosto con SG > 1,060
°P=135,997*SG3 - 630,272*SG2 + 1111,14*SG - 616,688
La legge sulla birra del ’62
Dal punto di vista pratico i vecchi saccarometri avevano la possibilità di essere graduati direttamente in Gradi Plato. Mentre nella strumentazione più moderna la polinomiale è già inserita nell’algoritmo di calcolo degli strumen-
ti. In Italia, la legge sulla birra n.1324 del 1962 aveva complicato la vita ai birrai: a differenza di altri paesi, da noi le accise non si pagavano sul grado Plato, ma su un fantomatico grado saccarometrico in volume, per cui il risultato ottenuto dal calcolo del grado Plato doveva essere riconvertito nel grado in volume per essere riconosciuto dalla legge italiana. Nelle birre di bassa gradazione la differenza era poco meno di 0,5°P, ma comunque significativa per i limiti di controllo. Sono dovuti passare oltre 35 anni perché il legislatore si accorgesse che era necessario uniformarsi al resto dell’Europa, riconoscendo il grado Plato come unico sistema di calcolo per stabilire la concentrazione zuccherina e per il calcolo dell’accisa: nel 1998 la modifica alla legge 1324 del 1962 ha adottato il grado Plato come misura e ridisegnato i limiti che stabilivano la denominazione delle birre. Così la vecchia denominazione legale “Birra Normale” compresa tra 11 e 13 gradi saccarometrici in volume diventava semplicemente “Birra” ed era compresa tra 10,5 e

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 31 aprile 2023 MATERIE PRIME
Bilancia di Westphal
12,5 gradi Plato. La definizione di “Birra Speciale” compresa tra 13 e 15 gradi saccarometrici in volume passava da 12,5 a 14,5 gradi Plato. La “Birra Doppio Malto” definita oltre 15 gradi saccarometrici in volume passava a oltre 14,5 gradi Plato. Inoltre, le definizioni “Birra Speciale” e “Birra Doppio Malto” perdevano l’obbligatorietà, ma venivano introdotte altre due definizioni legali: “Birra Leggera” e “Birra Analcolica”. Ma la novità più importante per il birraio era la possibilità di pagare l’accisa non più prima della produzione del mosto, come richiesto dalle leggi allora vigenti, ma solo dopo l’uscita dal magazzino fiscale. Dal punto di vista analitico però, i metodi ufficiali di analisi erano gli stessi previsti dalla vecchia legislazione: lenti, poco accurati e soggetti a errore umano. Il lato positivo era comunque il pagamento dell’accisa non più calcolato sul mosto, ma sulla birra finita e l’attenzione del calcolo delle accise si spostava dal mosto alla birra. La formula di Balling, tanto cara ai birrai di tutto il mondo da oltre 150 anni, assumeva così un ruolo cardine anche per il calcolo dell’accisa. Dopo le modifiche alla legge sulla birra del 1998, il metodo per distillazione e l’utilizzo del tubo oscillante e la tecnologia a infrarosso per l’alcol sono andati avanti in
parallelo per parecchi anni per valutarne la compatibilità. Cosa avvenuta anche in ambito europeo.
La formula di Balling
Questa è una formula empirica ricavata dalla sperimentazione di tante fermentazioni che ne hanno attestato la riproducibilità. In pratica, Balling ha constatato che 2,0665 g di zuccheri fermentabili a fermentazione completa producono 1 g di alcol, 0,9565 g di anidride carbonica e 0,11 g di lievito in sostanza secca. Questa relazione può quindi essere intesa come un equilibrio delle singole componenti dell’equazione, dove l’anidride carbonica fuoriesce durante la fermentazione e il lievito viene rimosso a fine fermentazione. La formula finale per ricavare l’estratto reale è la seguente:
ER = estratto reale
SGER = Specific Gravity Estratto reale (da densimetro a U o residuo distillazione)
Un ultimo rapido appunto
p = estratto originale nella birra in °Plato

A = alcool in % peso g/100g

ER = Estratto reale della birra in °Plato. 1,0665 = anidride carbonica + lievito
Il valore di A e di ER si ottengono dalle formule di Tabarie che sono delle equazioni polinomiali che utilizzano le densità del distillato e del residuo della distillazione. A si può ottenere dalla seguente formula1 :
A = (1-SGA) + 5084 (1-SGA)2 + 33503 (1-SGA)3
A = Alcol % peso
SGA = Specific Gravity Alcol (distillato o ottenuto da spettroscopia ad infrarosso)
L’estratto reale si può ottenere invece dalla seguente formula1
ER= -460,234 + 662,649 SGER
– 202,414 SGER2
Dedichiamo infine una riflessione al sistema di accise che si differenzia dal sistema europeo perché si basa sull’alcol invece che su Original Gravity. Nel Regno Unito l’Original Gravity è usata solo a fini tecnologici per cui i tanti birrai usano ancora vecchi sistemi tradizionali, per esempio moltiplicare per 1000 la Specific Gravity ottenendo un numero adimensionale di 4 cifre dei °P. Da questo sistema di calcolo deriva anche un metodo ormai poco usato, che dava un punteggio di due cifre alla Original Gravity: dal valore della Specific Gravity, si toglie 1 e il risultato si moltiplica per 1000. Si ottiene un numero di 2 cifre intere; per esempio, con una SG di 1,060 si ottengono (1,060-1)*1000 = 60 punti. Se questo numero si divide per 4 si ottiene un valore approssimato in °P 60/4 = 15°P. Qui ora mi fermo, e faccio i complimenti a tutti coloro che sono giunti a questo punto della lettura di questo articolo, perché mi rendo conto di aver affrontato un tema non facile. Mi auguro almeno di aver suscitato la curiosità di qualche lettore interessato alla conoscenza storica e scientifica della misura della densità della birra: quasi due secoli di ricerca per il miglioramento continuo della qualità di una misura fondamentale per il birraio. ★
Note
1 THE ALCOHOL TABLE FOR BEER ANALYSIS AND POLYNOMIALS FOR ALCOHOL AND EXTRACT
Submitted On Behalf of the EBC Analysis Committee BY I. ROSENDAL. AND F. SCHMIDT (United Breweries, Copenhagen) For the conversion of specific gravity of distillate to alcohol content in beer analysis the OIML table is recommended. Polynomials are given for alcohol ad extract (J. lst. Brew., September—October 1987, Vol. 93, pp. 373 377)
32 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MATERIE PRIME


I DOLORI del giovane publican
❱ l’impianto di spillatura e i frigoriferi per le bottiglie con la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
❱ la fornitura delle birre in fusto e bottiglia (e spesso anche di bibite, vini, acqua minerale);
❱ bicchieri e sottobicchieri contrassegnati con il logo e i colori delle birrerie prescelte;
❱ complementi d’arredo, anch’essi “griffati”, come tavoli, sedie, ombrelloni e posacenere;
❱ gadget e altra oggettistica come apribottiglie, magliette, grembiuli e così via.
?
Che c’è di nuovo? Che hai alla spina? Che IPA hai? La birra più forte che hai?
Tante domande che alludono ad una sola entità, la tap list o, come si diceva una volta, la carta o lista delle birre: biglietto da visita, per non dire vero e proprio documento di identità per il locale che la propone, l’elenco delle referenze proposte alla spina e in bottiglia può dare, ad un occhio smaliziato, parecchie informazioni su quali siano le preferenze e le priorità di chi gestisce il pub e addirittura se la scelta delle birre sia o meno farina del suo sacco.
È possibile individuare, almeno a grandi linee, nella dinamica delle birre proposte dai locali specializzati, delle tendenze definite e individuabili e provare a capire come la situazione si stia evolvendo nell’ultimissimo periodo? Proviamo a ripercorrere un po’ di storia recente.
C’era una volta il comodato d’uso
Agli albori dei pub in Italia il mercato era costituito da pochi, forti e ben strutturati distributori che proponevano agli aspiranti titolari e gestori di bar dei veri e propri pacchetti “chiavi in mano” comprendenti:

In sostanza, l’aspirante publican accettava di pagare la birra qualche spiccio in più alleggerendosi, in cambio, da un bel po’ di preoccupazioni: per qualunque guasto o malfunzionamento all’impianto bastava una telefonata al proprio distributore (all’epoca spesso chiamato grossista), idem per eventuali esigenze di prodotti o accessori in momenti di emergenza.
Sicurezza e affidabilità in cambio di una personalizzazione dell’offerta estremamente ridotta, in quanto limitata alle birre proposte dal grossista di turno, erano dunque alla base del patto commerciale che portava con sé, quale importante effetto secondario, anche un’impronta identitaria decisamente forte e costante: nel pub Alfa si trovavano, invariabilmente in ogni giorno dell’anno, le birre Beta, Gamma e Delta, senza alcuna possibilità di sorpresa salvo qualche specialità stagionale.
34 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MERCATO di Simonmattia Riva
La coerenza tra contenitore e contenuti in ogni minimo dettaglio aveva in questo modello un’applicazione maniacale e un’importanza che oggi potrebbe sembrarci decisamente esagerata: se si parla, ancora ai nostri giorni, con titolari e gestori che hanno vissuto questa epoca si scoprirà come per loro, paradossalmente, fosse preferibile servire una birra in un bicchiere ad essa poco appropriato o addirittura dalla forma penalizzante per lo stile ma riportante il giusto logo del produttore rispetto al servire la birra Delta nel bicchiere migliore per lo stile birrario ma con il logo del birrificio Gamma! Anche utilizzare un semplice sottobicchiere di un marchio non corrispondente a quello della birra servita era ed è, per questi publican della prima generazione, sintomo di sciatteria e superficialità nel servizio. Il modello del locale “vincolato” ha vissuto il suo massimo trionfo negli anni Novanta con la diffusione in tutta Italia degli Irish pub marchiati Guinness e non è ancora del tutto scomparso, specie nelle località costiere e turistiche: non è peraltro affatto una prerogativa italiana, se si pensa al sistema britannico, ove la stragrande maggioranza dei pub è tied, ovvero legata a un birrificio (e Oltremanica furono la stessa Guinness, per il lancio della Harp, e Canadian Breweries, in origine proprietaria del marchio Carling Black Label, a investire massicciamente a inizio anni Sessanta nell’acquisto di pub e birrifici locali contribuendo in maniera determinante a trasformare i britannici in bevitori di lager) o a una grande catena a gestione centralizzata come Wetherspoon o Nicholson.
Proprio per evitare una tale situazione, in cui la varietà dell’offerta è giocoforza limitata, negli Stati Uniti si è optato per un sistema chiamato three tiers in cui produzione, distribuzione e mescita sono ciascuna in mano a soggetti diversi, con l’ovvia eccezione delle tap room (punti vendita dei microbirrifici) che sono però soggette a vincoli diversi rispetto ai pub e bar veri e propri.
Il pub indipendente
La rivoluzione portata dalle microproduzioni artigianali e, prima ancora, la volontà di alcuni publican illuminati di rifornirsi di prodotti di qualità direttamente nei paesi di tradizione birraria portò alla nascita di questo modello: all’opposto rispetto al pub vincolato, proprietà e manutenzione dell’impianto sono qui di pertinenza del titolare o gestore, che ha totale libertà nella scelta degli approvvigionamenti ma deve provvedere in prima persona a tutte le incombenze che in passato venivano scaricate sul grossista.
United Indi Pubs, un movimento promosso nel primo decennio degli anni Duemila da publican italiani che avevano compiuto scelte radicali come Michele Galati, Nino Maiorano, Manuele Colonna, Alessandro Belli, Claudio Capelli e Andrea Ambrosini, promosse anche festival e convegni aperti a contributi di analoghe realtà estere come il Moeder Lambic di Bruxelles o l’Homo Sibaris di Barcellona e diventò un punto di riferimento per le nuove leve che volevano affacciarsi al vecchio mestiere del publican

Un fenomeno in crescita crea inevitabilmente un indotto e, altrettanto ineluttabilmente, attira anche persone più interessate al risultato economico che al
prodotto e al servizio in quanto tali: gli anni Dieci del XXI secolo videro così da un lato la nascita e la crescita delle prime piccole distribuzioni esclusivamente vocate alle birre artigianali e di qualità ma dall’altro il proliferare di una serie di personaggi che, al motto de la birra artigianale tira, si improvvisarono titolari o gestori di pub e beershop senza avere piena consapevolezza di cosa stessero servendo e vendendo e, specie nel caso di molti beershop che, a Roma più che altrove, videro una vera e propria esplosione, senza scelte fondate e razionali in tema di posizionamento e prezzi dei prodotti.
Nel giro di un lustro, infatti, il modello del beershop senza mescita si rivelò per

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 35 aprile 2023 MERCATO
lo più insostenibile sul piano economico portando chi lo aveva adottato a trasformarsi a sua volta in pub o piccolo distributore o a chiudere; sul versante dei locali di somministrazione invece l’ingresso nel settore di titolari o gestori senza la necessaria cultura della birra artigianale (e senza nemmeno la motivazione ad ac-
quisire conoscenza) portò alla diffusione di nuovi pub con tap list che parevano fotocopiate una dall’altra perché basate sui cataloghi degli stessi distributori specializzati in craft a cui non di rado l’improvvisato publican diceva semplicemente “fai tu, dammi qualcosa di particolare e che piaccia alla gente”: il cliente si ritrovava

in una situazione per certi versi analoga a quella del passato pre rivoluzione craft e anche il sedicente publican si ritrovava legato mani e piedi ai suoi fornitori al pari dei suoi predecessori ma senza nemmeno avere i vantaggi in termini di assistenza capillare e fornitura di arredi e gadget garantiti dai grossisti di birra industriale. L’amara scoperta che la birra artigianale ha margini operativi decisamente più ridotti rispetto ad altri prodotti ha presto allontanato dal settore gli illusi che vi avevano erroneamente scorto una gallina dalle uova d’oro e la pandemia da Covid-19, di cui a breve si parlerà, ha poi completato l’opera.
La personalità e la cultura del publican, al pari di quella del birraio in sala cotte per i birrifici, tornarono così ad essere la principale garanzia per la validità della tap list e il vero fattore di fidelizzazione del cliente, con tutti i rischi comuni alle imprese eccessivamente individualizzate. Avvicinandosi agli anni Venti del nuovo secolo, però, altri fattori sono cambiati: in primo luogo sempre più birrifici hanno compreso l’importanza sul piano economico di detenere un canale di vendita diretta.
Il modello del brewpub (produzione e mescita nel medesimo luogo), in precedenza minoritario in Italia al contrario di quanto accaduto negli USA, è così stato sempre più adottato dalle nuove aperture mentre birrifici già consolidati si sono attrezzati con tap room o locali di proprietà, a volte non adiacenti al birrificio ma collocati in aree urbane commercialmente più promettenti: per i pub vicini alla tap room o al nuovo locale di un birrificio che magari trovava sovente spazio nel loro menù si sono così imposte scelte magari difficili ma necessarie per differenziare la propria offerta e continuare ad esercitare appeal sui clienti.

Pandemia e rincari
Anche il Covid-19, con la sospensione delle attività di somministrazione nei mesi di chiusure forzate, ha dato un’ulteriore spinta alla vendita diretta da par-
36 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MERCATO



te dei birrifici ai clienti finali tramite consegna a domicilio nel vicinato o grazie a piattaforme di e-commerce. Nel maggio 2022, al momento della definitiva riapertura senza restrizioni e distanziamenti, dunque, pub, distributori e birrifici hanno dovuto fare i conti con questa maggiore incidenza del canale diretto produttori-clienti privati così come con due assai poco gradevoli novità: la sempre più forte difficoltà nel reperire personale (pare che nessuno voglia più lavorare nei locali e nei ristoranti in cui tutti vogliono andare a divertirsi nel fine settimana) e i rincari di materie prime ed energia dovute sia al conflitto russo-ucraino che alle solite disdicevoli manovre speculative messe in atto da qualche soggetto senza scrupoli a monte delle filiere.
La tanto attesa euforia per la fine dell’emergenza pandemica è stata dunque diluita da uno scenario complicato per tutti gli attori che si sono trovati ad avere priorità diverse e non sempre conciliabili: ❱ i birrifici, gravati dai rincari energetici, hanno dovuto inevitabilmente ritoccare verso l’alto i propri listini e,
per difendere la propria marginalità, hanno dato un’ulteriore spinta alla vendita diretta andando sempre più a scavalcare i distributori non solo con e-commerce e locali di proprietà ma anche cercando un contatto diretto con i publican, con l’obiettivo di garantirsi, tramite opportune scontistiche, una maggiore costanza negli acquisti: la “spina fissa” in un locale di successo è diventata così un obiettivo particolarmente ambito;
❱ i distributori, dopo due anni di pandemia trascorsi non di rado in sofferenza finanziaria, causata anche dal pernicioso vizio tutto italiano di pretendere e concedere pagamenti su tempistiche follemente dilazionate (il famigerato “a babbo morto”), si sono di nuovo trovati nella posizione scomoda di intermediari che birrifici e publican cercano, quando possono, di scavalcare per difendere i propri margini. Le aziende distributive si trovano anche nel “letto di Procuste” costituito dall’esigenza di ampliare sempre più il catalogo delle birre
per allettare i titolari dei locali, contrapposta al malcontento dei birrifici che, ad ogni nuova etichetta inclusa nel portfolio del proprio distributore, temono di vedere ridotte le proprie vendite;
❱ i pub, quasi tutti con carenza di personale e quindi con minor tempo a disposizione del titolare o gestore per selezionare i prodotti e a loro volta colpiti dai rincari, si sono trovati sempre più spesso nell’esigenza di cercare intese-quadro con birrifici o distributori per ottenere prezzi più vantaggiosi in cambio di una certa costanza nella fornitura. Sempre più spesso capita così di vedere tap list che sono contraddistinte dal rapporto vincolante con un birrificio e un distributore e tale scelta non è più causata, come una dozzina di anni fa, dalla mancanza di conoscenza dei prodotti da parte di publican improvvisati ma da ineludibili ristrettezze economiche e gestionali.
A farne le spese, ovviamente, è la varietà dell’offerta, che il cliente più esigente può però recuperare appoggiandosi a due-tre locali di fiducia anziché uno solo, mentre se vogliamo trovare un aspetto positivo in tutta la faccenda è che il periodo di vacche magre sta probabilmente contribuendo a estinguere le tap list costruite seguendo i punteggi dei siti birrari di rating come Untappd e Ratebeer, che sono notoriamente il modo migliore per rinchiudersi nell’autoreferenzialità e ostacolare l’avvicinamento di nuovi clienti al mondo artigianale.
? Ma come si costruisce, dunque, una buona tap list?

Dopo tanti anni al bancone, mi permetto di redigere un breve vademecum:
1. Sii un trapezista
Ovvero in perfetto equilibrio e bilanciamento: una buona tap list rappresenta più tipologie possibili
38 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 MERCATO
considerando il numero di spine a disposizione. La “chiara base”, sia essa una Pils, una Helles o una Keller non può mai mancare e deve essere sempre in forma perché è il traino per tutti gli altri consumi; in un locale dedicato alle birre artigianali è poi indispensabile offrire in spina almeno una Ipa in qualche declinazione, una birra a tendenza più dolce e dal buon tenore alcolico (Bock, Strong Ale, Tripel), una scura (Porter, Stout o Schwarz), magari una birra di frumento in primavera ed estate e una sour. Questa è la base, poi c’è spazio per la fantasia del publican
Solo il titolare o gestore ha il polso dei consumi e può decidere il corretto dimensionamento della batteria di spine: per fortuna la moda del più è meglio che aveva contrassegnato la metà degli anni Dieci sembra essere definitivamente tramontata e probabilmente non vedremo più locali con 50 spine, una buona metà delle quali occupate da birre zombie pronte ad addentare le papille gustative del malcapitato avventore. Gli stili con più breve shelf life come lager chiare
e birre luppolate necessitano di stazionare il meno possibile nei tubi e quindi ancora una volta: meglio proporre una sola IPA sempre fresca che tre che si fanno concorrenza tra loro e restano troppo a lungo nei fusti.

3. Se ci credi tu, ci credono i clienti Ovvero, quando un publican propone una birra o un birrificio che gli stanno a cuore e in cui ha piena fiducia (basata sulle caratteristiche organolettiche del prodotto e non solo sul basso prezzo d’acquisto, ovviamente) il cliente lo percepisce ed è più propenso ad ordinarla.
4. Il cliente va aiutato ad avere ragione
Una Golden Ale a pompa? Buonissima, ma riesci a venderla? A me chiedono solo IPA!
Un collega di un’altra città mi presentò questa considerazione qualche anno fa davanti a una pinta di Sleck Dust di Great Newsome che gli avevo appena spillato. Ciò che gli risposi è che il cliente spesso chiede solo IPA perché è l’unica tipologia artigianale che conosce, padroneggia e sa con certezza che, più o meno, gli piace, però così come il marketing
non è banalmente “dare alla gente ciò che vuole”, fare il publican non è solo servire al cliente le birre che chiede: instaurare una relazione di fiducia e proporre un assaggio porta le persone a scoprire nuove tipologie e anche a chiarire meglio i propri gusti, allargando il proprio raggio di bevute. La stessa Golden Ale dello Yorkshire appena citata, proposta a un bevitore compulsivo di IPA che era inizialmente renitente all’assaggio suscitò come reazione una dilatazione delle pupille e l’esclamazione: oh, ma di queste me ne bevo sessanta!
5. Locale è bello
Per un pub che ambisca al massimo livello possibile di autonomia costruire rapporti di fiducia con i più validi birrifici presente sul suo territorio provinciale o regionale è assolutamente cruciale: non è solo una questione biecamente legata ai costi, la conoscenza dei processi produttivi e delle persone che li mettono in atto permettono di capire meglio le birre e la loro evoluzione, presentandole meglio ai propri clienti e tornando così al punto 3).
6. Collaboration not litigation
Ovvero: darsi una mano tra colleghi! Principio sempre valido ma che troppo spesso viene miopemente dimenticato bollando come “concorrenti” gli altri locali che propongono birre artigianali e di qualità nello stesso territorio: la “concorrenza” che tutti insieme dovremmo combattere è quella rappresentata dai locali che offrono birre scadenti e per giunta spillate male!
Tra colleghi sarebbe più proficuo aiutarsi e parlarsi, magari cominciando proprio dalla diversificazione delle tap list e delle forniture in modo tale da invitare i clienti a frequentare più locali, ma sempre di qualità, e magari a passare la voce e portare altri amici. ★
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 39 aprile 2023 MERCATO
2. Meglio poche ma buone
BIRRA E CAFFÈ: uno strano confronto durato due secoli

La birra, come è noto, è una delle bevande più antiche del mondo; in pratica la sua invenzione corrisponde alla trasformazione dell’uomo da cacciatore ad agricoltore, diciamo
grossomodo 10.000 anni fa e forse anche qualcosa di più, in una regione che possiamo individuare tra la Mesopotamia e l’Egitto. Il caffè, inteso come bevanda, è invece molto più recente: anche se le
notizie certe sono poche, possiamo presumere che i primi consumatori di caffè siano stati gli arabi nella prima metà del XV secolo. Quindi, quando il caffè divenne di uso comune, la birra era già
40 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 STORIA E TRADIZIONI di Alberto Grandi
diffusa tra gli esseri umani di tutte le latitudini da almeno 9.000 anni. Eppure, nonostante questa evidente differenza di età e questo differente radicamento nella cultura alimentare di molti popoli, quando il caffè arrivò in Europa, si sviluppò, tra queste due bevande che oggi stenteremmo a considerare alternative, una sorprendente contesa che durò quasi due secoli.

Tutto ebbe inizio nel 1657… ...quando un giudice gallese di nome Walter Rumsey, che era stato allievo nientepopodimeno che di Francis Bacon e di William Harvey, diede alle stampe un curioso libro dal titolo Divers new experiments of the virtue of Tobacco and Coffee. In questo breve testo ad un certo punto, quasi con noncuranza, l’autore si permette di fare un’affermazione che nell’Inghilterra del XVII secolo era destinata a diventare una bomba: “coffee had the power to cure drunkards”, insomma il caffè riesce a curare gli ubriaconi. Questa teoria ebbe talmente tanto successo che ancora oggi risulta molto diffusa la convinzione, del tutto errata, che una tazza di caffè possa rendere sobri. Per comprendere la portata del testo di Rumsey, bisogna partire dai dati spaventosi sull’alcolismo nell’Inghilter-
ra del Seicento. Il consumo di birra in particolare era diffuso tra tutte le classi sociali e in tutte le fasce di età. Oltre ad essere consumata in occasioni di eventi e festività, esattamente come oggi, o per stordirsi nei momenti di baldoria, era anche una fonte primaria di alimentazione, seconda soltanto al pane nella dieta comune. I dati in nostro possesso, derivanti dalle testimonianze di molti cronisti dell’epoca, attestano un consumo quotidiano, per una tipica famiglia inglese del XVII secolo, di tre quarti di gallone a testa, inclusi i bambini, vale a dire circa 3 litri e mezzo. La piaga dell’alcolismo non riguardava solo le isole britanniche. Un po’ in tutta l’Europa centrale e del nord i consumi di birra rimasero altissimi per tutto il medioevo e l’età moderna. Nel 1551, ad esempio, il medico tedesco Johann Bretschneider notava come le classi popolari si mantenessero “più con la birra che con il cibo. Gente di entrambi i sessi e di ogni età, sani e infermi la reclamano”. Un consumo tanto alto e diffuso dipendeva anche dal fatto che in tutta l’area mitteleuropea la tipica colazione dei ceti urbani consisteva generalmente in una zuppa di birra. Non solo, ma la preparazione della birra rientrava a pieno titolo tra i doveri comuni di una casalinga.

Alcol e religione
Il consumo delle bevande alcoliche continuò ad aumentare durante tutta l’età moderna, tanto che nel XVIII secolo, in Europa e nelle colonie inglesi del nord America, si moltiplicarono i casi di ubriachezza in pubblico e, a poco a poco, il vizio del bere cessò di interessare unicamente la salute degli individui e la pace familiare, per divenire un
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 41 aprile 2023 STORIA E TRADIZIONI
problema più grave, una minaccia per la società, a cui furono addebitati i furti e i crimini, la dissoluzione dei costumi e la rovina delle famiglie.
Proprio per questi aspetti legati alla sfera pubblica, la lotta contro l’ubriachezza divenne uno dei temi di predicazione nelle chiese. Ma è importante rilevare come essa sia stata affrontata prima nelle confessioni protestanti, in particolare con l’inizio dell’azione di John Wesley (1703-1791), il fondatore della chiesa metodista, nel XVIII secolo. A partire da questo periodo si intensificò tra i protestanti la lotta contro i bevitori e contro i tavernieri che spingevano la gente a bere, mentre il clero cattolico cominciò a seguire moderatamente questa strada soltanto qualche decennio più tardi. La spiegazione di questa differenza di atteggiamento tra cattolici e protestanti storicamente viene attribuita alla cosiddetta geografia della vite, che, come si sa, viene maggiormente coltivata nell’Europa meridionale, proprio quella parte rimasta legata alla chiesa di Roma. Ma questa teoria è smentita dall’ovvia constatazione che anche molti protestanti coltivavano la vite in Francia e
non solo; di conseguenza, le differenti posizioni intorno al consumo degli alcolici vanno ricercate in una opposta concezione della gioia e del peccato. Nell’etica protestante, poiché il bere è un piacere, doveva essere bandito allo stesso titolo del gioco o della danza, in quanto rappresentava un’offesa a Dio. Il cattolicesimo era invece più indulgente e anche se l’intemperanza e la gola costituiscono dei peccati capitali, fu necessario attendere la fine del XIX secolo perché, per esempio, in Francia i preti facessero dell’ubriachezza un argomento di predica. Nel frattempo, l’influenza dei medici aveva trasformato lo stato alterato dovuto al consumo di alcol non solo in un vizio da bandire per ragioni morali, ma anche nella causa scientificamente dimostrata di malattie fisiche e soprattutto di numerosi disturbi mentali.
Un antidoto all’ubriachezza
Proprio l’ingresso dei medici nel dibattito contribuì a creare un altro effetto paradossale: con la presa di coscienza acquisita progressivamente dall’Europa dei pericoli insiti nelle bevande alcoliche, venivano messe sotto accusa
le bevande distillate piuttosto che le altre, quelle che venivano definite bevande “igieniche”, come il vino e birra. Tali alcolici erano ritenuti bevande il cui consumo può solo essere benefico; in questo caso sarà necessario attendere addirittura l’inizio del XX secolo per veder abbandonata un’idea così clamorosamente errata. Nel contesto dell’ubriachezza, che potremmo definire pandemica, dell’Inghilterra del XVII secolo, si può quindi comprendere meglio perché la teoria di Rumsey, che vedeva nel caffè un antidoto contro l’ubriachezza, ebbe un’immediata eco in tutto il Paese e successivamente divenne un testo fondamentale anche a livello continentale.
Alla base delle convinzioni del giudice gallese c’era l’osservazione diretta; coloro che bevevano caffè o tè nel corso della giornata erano più sobri ed efficienti di quanti bevevano birra. Rumsey aveva già intuito, in maniera empirica, gli effetti temperanti ed energetici delle sostanze caffeinate. Tali effetti sono stati progressivamente enfatizzati da tutti gli studiosi, soprattutto in contrasto con l’indolenza e l’inettitudine legate al consumo delle bevande alcoliche. Ma come detto, vista la presenza pervasiva di vino, distillati e birra nella vita degli europei a partire dal Medioevo e per tutta l’età moderna, l’istituzione di quella che potremmo chiamare una sobrietà cronica rappresentò un radicale cambiamento di vita.
Con i primi segnali di una incipiente moderna società industriale, in Inghilterra prima e in Europa poi cominciò a imporsi un atteggiamento nuovo verso l’alcol, ben rappresentato dal giudice Rumsey. Nel contesto dell’ubriachezza pandemica, alcune delle difese più accanite degli effetti salutari del caffè ci sembrano del tutto razionali, anche se basate su analisi poco solide dal punto di vista scientifico. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire e l’ascesa del caffè a scapito della birra suscitò occasionali rimostranze. È il caso, ad esempio, di Liselotte von der Pfalz

42 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 STORIA E TRADIZIONI
(1652-1722), una principessa tedesca che si trasferì a Parigi dopo il matrimonio con il duca di Orléans. Nella sua corrispondenza criticava spesso il consumo di caffè che si faceva alla corte di Versailles: “Il caffè mi fa pensare alla fuliggine o ai semi di lupino e mi dà il voltastomaco. Quanto preferirei una zuppa di birra, che di certo non mi rivolterebbe lo stomaco.” Altre testimonianze di questo tenore ci arrivano dalle colonie inglesi in America, dove la popolarità del caffè era già visibile nel 1670, appena sei anni dopo che gli inglesi erano subentrati agli olandesi a New Amsterdam, sostituendo il caffè alla birra come bevanda preferita a New York.
Caffè e capitalismo
Ma fu sicuramente Linneo, il grande botanico svedese del Settecento a intuire che la caffeina avrebbe favorito la transizione da un mondo dipendente dall’al-
col a un altro dipendente dal lavoro: “Potremmo dunque considerare il caffè utile per quanti stimano più importante salvare il loro tempo che conservare la vita o la salute o che sono costretti a lavorare di notte”. Questo suo commento rivela una lucida comprensione di ciò che oggi consideriamo il beneficio più importante della caffeina, prevenire il sonno, e la sua applicazione più importante, in quanto ci aiuta a lavorare quando ci è richiesto di farlo. Linneo, per altro, si dimostra anche consapevole del pericolo che l’uso di stimolanti o il super-lavoro possono comportare.
Ci vorrà un filosofo come Jules Michelet (1798-1874), per comprendere la reale portata dei cambiamenti apportati dal caffè nella vita degli uomini. Scrivendo dell’Europa seicentesca e rappresentando la nera bevanda proveniente dall’Arabia come l’elisir di lucidità mentale, mise
fortemente in contrasto i vecchi eccessi dell’alcol con la nuova sobrietà del caffè: “Dunque la taverna è stata spodestata, dove ancora cinquant’anni prima i giovani barcollavano tra le botti di birra e le donnacce. (…) Il caffè, la sobria bevanda, il potente nutrimento del cervello, che, solo, accresce chiarezza e lucidità; il caffè, che disperde le fosche nubi dell’immaginazione e d’improvviso, illumina la realtà con l’empito della verità.”
Alla fine, la vittoria del caffè fu schiacciante. La birra venne relegata a un consumo limitato e circoscritto solo ad alcuni momenti della giornata. A ben guardare è stata la vittoria del sistema di produzione capitalistico, sulle fosche nubi dell’immaginazione, che non erano più compatibili con un modello di vita che chiede agli uomini di essere sempre produttori, anche quando non sono direttamente produttivi. ★

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 43 aprile 2023 STORIA E TRADIZIONI















LA MALTERIA SPERIMENTALE dell’università di Udine
Con 118 mila occupati e una produzione di quasi 18 milioni di ettolitri di birra (report Assobirra 2021), il il settore brassicolo e maltario rappresenta un settore economico molto importante per l’economia nazionale che tuttavia soffre di una forte dipendenza estera relativamente ai cereali utilizzati 1. In senso più ampio, secondo i recenti dati dell’Istat relativi ai primi quattro mesi del 2022, è infatti aumentata non di poco l’importazione di cereali in Italia2. Si può quindi tracciare un quadro del mercato del malto in Italia, nel quale esiste una difficoltà di reperimento di materia prima nazionale. I produttori artigianali di birra, spesso, si vedono costretti ad acquistare malto di origine estera o in alcuni casi, se produttori di orzo oltre che di birra, ad inviarlo alle malterie estere con inevitabile ag-


46 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 UNIVERSITÀ E RICERCA di Stefano Buiatti e Paolo Passaghe
Figura 1 - La malteria dell’Università di Udine. A sinistra il serbatoio tronco-conico dove avvengono le fasi di bagnatura ed asciutta, a destra il cilindro di germinazione
gravio dei costi derivanti dal trasporto, per non parlare dell’impatto ambientale provocato dal trasporto su gomma. Si possono quindi ben comprendere le difficoltà con cui un piccolo produttore si scontra nel momento in cui vuole legare il suo prodotto al territorio.
Malteria Uniud: progetti in corso
La malteria sita presso le strutture dell’ateneo udinese (Figura 1) si inserisce a livello regionale come l’anello mancante nella filiera della produzione artigianale sia birraria sia di altri alimenti. Infatti, sebbene sia di piccole dimensioni (capacità di 500 Kg), può consentire la valorizzazione di orzi prodotti localmente e la produzione di birre autenticamente legate al territorio. Diverse realtà produttive hanno manifestato l’interesse a collaborare con l’Università di Udine con l’obiettivo di tracciare la qualità delle materie prime (malti) e quindi di legare le loro birre al territorio. A tal proposito si evidenzia la collaborazione dell’Università con l’ASPROM (Associazione Produttori di Orzo e Malto), una rete di aziende agricole in grado di valorizzare il comparto cerealicolo. Un altro importante progetto in corso è indirizzato invece alla produzione di malti biologici ed è realizzato in collaborazione con il birrificio artigianale Foran di Udine.
La filiera di produzione del malto
Il processo di trasformazione della cariosside in malto prevede cinque operazioni, interamente realizzate presso il laboratorio di maltazione dell’Università: calibratura, bagnatura (o steeping), germinazione, essiccamento e spazzolatura (Figura 2).

Bagnatura
Dopo essere stato pulito e calibrato (Figura 3), l’orzo viene caricato attraverso il nastro trasportatore nel serbatoio tronco-conico dove avvengono le fasi
di bagnatura ed asciutta; il serbatoio in dotazione può contenere da 300 a 500 kg d’orzo distico (Figura 1). Nella fase di bagnatura (durata di circa 2 giorni) il seme viene idratato (utilizzando 1000 –1200 l d’acqua).
Il serbatoio tronco-conico, in corrispondenza della parte superiore, è dotato di un tracimatore per l’evacuazione del troppo pieno e di eventuali “sporcizie” residue. L’impianto è dotato di sensori che permettono di affidare il controllo del processo a un sistema PLC, ovvero un pannello operatore “touch screen” capace di pilotare i relè di azionamento dei singoli componenti. Grazie al sistema PLC, quindi, viene impostato un programma (Figura 4) che gestisce l’alternanza tra le fasi di bagnatura e asciutta. Questo programma permette di monitorare le seguenti operazioni unitarie:
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 47 aprile 2023 UNIVERSITÀ E RICERCA
Figura 3 - Calibratore per la calibrazione (eliminazione dei semi con diametro < a 2,2 mm) e l’allontanamento dei semi estranei e/o rotti
Figura 2 - La filiera di produzione del malto
lo scarico dell’acqua e il successivo caricamento dell’acqua di seconda e, a volte, terza bagnatura, l’aerazione dei semi (insufflazione di aria compressa), l’aspirazione dell’anidride carbonica che si produce in fase di asciutta e che deve essere allontanata onde evitare l’asfissia del seme. Il serbatoio è coibentato per garantire il mantenimento della temperatura dell’acqua durante questa fase del processo.
L’incremento di umidità dei semi è monitorato attraverso un campionatore
denominato Bernreuther ( Figura 5 ), un contenitore in acciaio inox cilindrico e forato; in esso vengono caricati 100 g di orzo, il tutto viene inserito nel serbatoio assieme al resto dei semi, in modo da essere sottoposto alle stesse condizioni di trattamento della massa in maltazione.


Germinazione
Una volta raggiunto il 42%, il ciclo procede con il trasferimento della massa di semi nel cilindro di germinazione
(Figura 1). Il germinatore è un cilindro con sviluppo orizzontale, dotato di un tamburo rotante esterno drenante al fine di smaltire l’acqua utilizzata per il trasferimento della massa di semi. Il cilindro è dotato di portello di carico/scarico, per le cariossidi ed il malto finito, e di un portello per prelevare campioni (monitoraggio durante la germinazione e l’essiccamento). È presente un motore elettrico in grado di fare ruotare il cilindro durante la germinazione al fine di prevenire un “infeltrimento” a seguito dello sviluppo delle radichette: grazie al sistema PLC possono essere impostati i cicli di rivoltamento (durata e numero/frequenza). In questo processo è fondamentale la verifica della lunghezza dell’acrospira, cioè vengono prelevati dei campioni di semi al fine di verificarne la lunghezza all’interno degli stessi. Durante la germinazione, che dura da 4 a 6 giorni, attraverso il sistema PLC, vengono impostate le condizioni operative per controllare l’umidità e la temperatura all’interno del
48 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 UNIVERSITÀ E RICERCA
Figura 4 - Finestra del PLC, tramite la quale si possono impostare le condizioni operative adottate nelle fasi di bagnatura ed asciutta
Figura 5 - Bernreuther per monitorare l’umidità dei semi in bagnatura
cilindro, per favorire la biosintesi degli enzimi di interesse brassicolo.

Essiccamento
Quando la lunghezza dell’acrospira raggiunge i tre quarti del seme, si arresta la germinazione attraverso la fase di essiccamento: i semi vengono essiccati (sempre all’interno del cilindro di germinazione) al fine di bloccare la germinazione, mantenere attivi gli enzimi necessari, permettere lo stoccaggio e il trasporto del malto. In funzione delle condizioni di essiccamento si possono produrre malti diversi per colore, flavour ed attività amilolitica. Presso la malteria dell’Università sono state definite diverse condizioni di essiccamento per la produzione sia di malti base (chiari) che speciali (es. malti Monaco, Caramello, Amber ecc.). Per la produzione del malto Caramello, ad esempio, il malto verde (a fine germinazio-
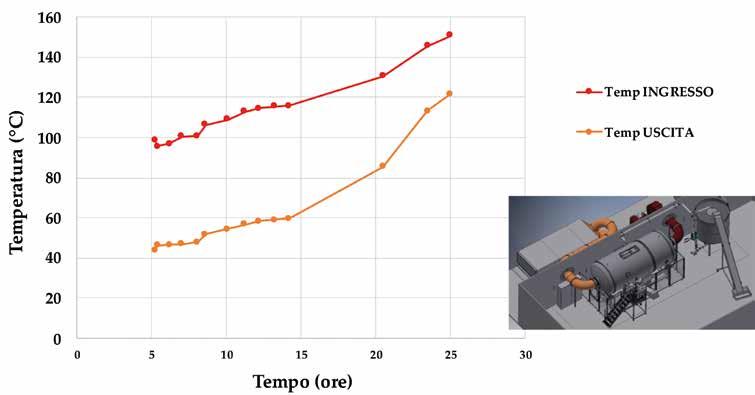
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 49 aprile 2023 UNIVERSITÀ E RICERCA
Figura 6 - Condizioni di essiccamento (tempo, temperatura) adottate nel ciclo di produzione del malto Caramello. In basso a destra una rappresentazione della malteria dove sono visibili i tubi dell’aria in ingresso (rosso) e dell’aria in uscita (giallo) nel cilindro di germinazione/ essiccamento
ne) viene reidratato sino a raggiungere il 50% di umidità e, successivamente, la temperatura viene innalzata da 40°C a 65°C in 17 ore (Figura 6). La combinazione di temperature e umidità elevate favorisce l’amilolisi e la proteolisi. La temperatura di ingresso, quindi, viene innalzata da 65°C a 150°C in 8 ore.

Spazzolatura
Nella Figura 6 sono visibili le temperature di ingresso e di uscita, dove queste ultime si avvicinano maggiormente alla temperatura interna del cilindro. La fase di incremento della velocità di essiccamento è nota come break-point ed è
Tabella 1 - Ciclo di maltazione
FASE A (BAGNATURA, ASCIUTTA)*
1 6 ore di bagnatura (primo steeping)
2 15 ore di asciutta (primo air rest)
FASE B (GERMINAZIONE, ESSICCAMENTO)**
5 giorni di germinazione
50°C (per 24 ore)
3 6 ore di bagnatura (secondo steeping) 80°C (per 4 ore)
4 15 ore di asciutta (secondo air rest)
121°C (per 3 ore)
5 Trasferimento della massa Raffreddamento (a T ambiente), 1 ora
* = temperatura compresa nell’intervallo 18 – 20°C;
** = durante la germinazione viene gestita, attraverso il PLC, l’unità di trattamento dell’aria per controllare umidità/temperatura all’interno del cilindro, e la rotazione dello stesso per evitare l’infeltrimento della massa a seguito dello sviluppo delle radichette
accompagnata da un aumento rapido della temperatura dell’aria in uscita, in questo punto la maggior parte dell’umidità dei semi è stata rimossa3. Dopo il break-point gli enzimi vengono inattivati, quindi l’essiccamento dovrebbe completarsi (per mantenere la massima attività enzimatica) nel minor tempo possibile. Terminata la fase di essiccamento, attraverso il nastro trasportato, il malto viene trasferito nella spazzolatrice (Figura 7), ed, infine, stoccato.
Ciclo di maltazione
Un ciclo di maltazione ha una durata compresa tra 8 e 10 giorni. Qui di seguito (Tabella 1) viene riportato uno schema delle fasi del processo per la produzione di un malto speciale tipo Amber, malto già prodotto con la malteria Uniud ed utilizzato per la produzione della prima birra dell’Università di Udine.
Stoccaggio
I malti prodotti sono stoccati in celle frigo a temperatura ed umidità controllate per due settimane (il tempo minimo per garantire una uniforme distribuzio-
ne dell’umidità residua all’interno del seme) e successivamente sottoposti alle analisi di controllo qualità. Vengono eseguite, ad esempio, le determinazioni di colore, umidità e resa in estratto attraverso i metodi ufficiali dell’EBC4, acronimo dell’European Brewing Convention, associazione che si occupa dello sviluppo e della codifica di metodiche per la valutazione della qualità della birra, e delle materie prime utilizzate (acqua, malto, luppolo, lievito). ★
Bibliografia
1. Assobirra Annual Report, https://www.assobirra.it/annual-report-assobirra/ [Ultima consultazione 05/03/2023];
2. https://www.exportiamo.it/settori/1352/cereali-nei-primi-4-mesi-del-2022-acceleranosia-l-import-che-l-export/ [Ultima consultazione 05/03/2023];
3. Guido, L.; Moreira, M. Engineering Aspects of Cereal and Cereal-Based Products. In Malting; Guiné, R., Correia, P. (eds.); CRC Press, 2013, pp.51-70;
4. European Brewery Convention (2007) Analytica-EBC. Norimberga: Fachverlag Hans Carl
50 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 UNIVERSITÀ E RICERCA
Figura 7 - Spazzolatrice per l’allontanamento delle radichette dai semi alla fine dell’essiccamento
A TRUE VOCATION FOR BEER
Un birrificio indipendente dello Yorkshire che dal 2015 produce birre di ottima bevibilità ed equilibrio. Quattro domande a Ian Harvey, Export Manager del birrificio per conoscerne storia, filosofia e sguardo al futuro.
Un po’ di storia
L’anno di svolta per John Hickling è stato il 2015, quando decide di abbandonare il suo lavoro nell’IT per trasformare la sua passione di beer lover e homebrewer, in un vero e proprio business. A partire dai pochi elementi di una cucina riadattata e un solo dipendente, nasce Vocation. Oggi il birrificio ha più di 100 dipendenti e produce l’equivalente di oltre 16 milioni di lattine ogni anno. John è riuscito nel suo più grande obiettivo: seguire la sua Vocazione.

Come racconti Vocation e le sue birre a chi non vi conosce?
Produciamo nello Yorkshire sfidando il freddo e ventoso clima britannico, lavoriamo tutti i giorni per produrre la birra migliore possibile. Il nostro obiettivo è creare birre audaci, che superino i limiti e possano diventare veri e propri punti di riferimento. Se ci pensi il birrificio in sé, è solo un luogo di produzione. Sono le persone e la loro passione a fare la differenza.
Produciamo Pale Ale intensamente luppolate, Stout morbide ed intense e ci divertiamo a sperimentare con le fermentazioni acide. Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro e vogliamo che più persone possibili al mondo assaggino le nostre birre.
Vocation ha appena introdotto Crush Hour alla core line, puoi dirci qualcosa in più?
Oggi la nostra core line comprende Pale Ale e IPA di diverse gradazioni alcoliche,
dalle versioni più leggere e profumate a strutturate ed amare Double IPA. Crush Hour è nata da una precisa idea dei birrai: una birra da bere ogni giorno, una birra facile e scorrevole, profumata e dissetante. Ha una gradazione alcolica contenuta (4,6% abv), note di frutta tropicale ed agrumi equilibrate da un amaro delicato. Come tutte le birre di
Vocation è disponibile in lattina e Key Keg.
Quali sono i cambiamenti più importanti sul mercato in questo momento? È cambiato l’approccio dei consumatori inglesi alla birra artigianale?
Il cambiamento più grande in UK riguarda lo spostamento verso gradazioni sempre più basse. Birre low abv o addirittura analcoliche, stili session che rispondono sia alla ricerca di bevibilità, sia a necessità economiche dato l’aumento sui dazi previsto per agosto. La sfida dei birrai di oggi è mantenere inalterati i profili aromatici, creando birre d’effetto, pur contenendo l’abv.
Vocation in Italia
Le birre di Vocation vengono apprezzate in Italia da diversi anni. Tutti i prodotti del birrificio, dalle lattine ai fusti, passando per le piccolissime e super speciali produzioni in bottiglia, sono disponibili grazie alla collaborazione in esclusiva con l’importatore e distributore bolognese Ales&Co: alesandco.it

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 51 aprile 2023 INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
VIAGGIO TRA LE BIRRE dei Paesi Baschi
La Spagna si colloca da alcuni anni tra i primi cinque produttori di birra in Europa. Il mercato delle birre artigianali è in continua crescita con un andamento, nell’ultimo biennio, che ha visto una diffusione e un consumo di birra artigianale più rapido e ad ampio raggio.
La Spagna è un paese di grande estensione geografica, moltissima varietà interna dal sud al nord cambiando luoghi, idiomi, paesaggi, clima, contesti storici e culturali e come sempre quello che
si mangia e si beve rappresenta al meglio la specificità di un contesto locale. In questo la birra non perde occasione di raccontare ed interpretare un luogo; oggetto del mio viaggio sono stati alcuni luoghi caratteristici come San Sebastian, Hondarribia e San Juan.

Come chiedere una birra in Spagna
Se in Spagna per ordinare una birra si chiede “una cerveza por favor”, sarà quasi automatico che chi stia dietro il
bancone, si renda conto di avere a che fare con un turista. Cerveza in spagnolo significa genericamente birra, intesa come la bevanda, ma il modo in cui servirla, elemento di grandissima importanza per gli spagnoli, determina anche il modo in cui chiederla. La vastità del territorio spagnolo la declina in molti modi diversi; i più diffusi sono:
❱ il zurito, circa 150/200 ml nel classico bicchiere da txikiteo;
❱ la cana, circa 200/300 ml poco meno di mezza pinta inglese;
TURISMO BIRRARIO 52 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 di Eleni Pisano
❱ il tubo, circa 300 ml in un bicchiere lungo e stretto;
❱ la jarra, circa 560 ml come pinta inglese.
Molto spesso le birre servite alla spina, in Spagna, hanno dimensioni tendenzialmente più piccole di quelle servite in Italia e nel resto d’Europa. Il motivo è principalmente dovuto al fatto che le birre sono servite molto fredde e di conseguenza in quanto piccole si consumano rapidamente senza correre il rischio di scaldarle, cosa che ne impedirebbe l’ottimale degustazione. Bisogna evidenziare inoltre che le birre maggiormente consumate sono di stili (lager o keller principalmente) che non amano le temperature di decantazione.
Il zurito: la dimensione che racconta una storia
Se vuoi bere birra nella zona basca di San Sebastian meglio non utilizzare il termine Cana ma piuttosto Zurito che in altre realtà spagnole si identifica con corto, vale a dire un bicchiere che può contenere 150 millimetri e che originariamente era destinato a contenere un vino rosso denominato txikito.
Il nome che oggi identifica il vino in realtà deriva da una tradizione molto diffusa a San Sebastian negli anni Sessanta, quando txikiteo non era altro che la modalità di spostarsi da un bar all’altro con un gruppo di amici, la cuadrilla, per bere in ogni bar un vino diverso offerto, di volta una volta, da un appartenente al gruppo. Una tradizione utile per socializzare e stare insieme formando appunto delle cuadrillas che si disponevano anche in maniera tattica attorno al bancone. Il racconto di queste bevute in compagnia narra di un ragazzo di nome
Carlos Pérez Garrido che, stanco di bere sempre vino, decise di bere birra ma, non essendo all’epoca nei bar ancora molto presenti le spine, ad ogni fermata doveva prendere una birra in bottiglia e, vista la dimensione del bicchiere, riusciva solo a berne una metà, concluden-
dola poi nel tradizionale ed inevitabile secondo giro. Il termine zurito pare sia stato dato dall’oste e proprietario del Bar Irutxulo a cui, quando aumentò il consumo di birra nei giri del txikiteo, venne dato l’incarico di scegliere come chiamare il bicchiere con la birra per distinguerlo da quello con il vino. Egli decise allora di chiamarlo zurito, in onore di Carlos che era un appassionato del torero Gabriel de la Haba detto anche “Zurito di Cordoba”. Carlos Pérez Garrido è morto nel 2018 e fu tra gli ultimi testimoni di quella tradizione popolare e sociale molto diffusa tra giovani nelle vie di San Sebastian e di altri paesi nella zona basca. Oggi questa storia viene tenuta viva dai locali della zona in cui chiedere un zurito è ancora dimostrazione di grande rispetto e conoscenza della loro storia e contesto, cosa che per chi viaggia e per chi accoglie è il primo segno di socializzazione di un territorio.

Etxeberria: la casa nuova
Vicinissimo all’aeroporto di San Sebastian, praticamente quasi al confine con la Francia ed affacciato sull’oceano, si trova un piccolo ed antico borgo medievale con molte note fiamminghe di nome Hondarribia.
Il centro storico è collocato in alto e caratterizzato da strade ciottolate e da una bella piazza centrale. Per strada si sentono parlare spagnolo francese e basco. L’atmosfera è quella classica dei luoghi di confine, quasi sospesa, ma accogliente e pacata.
Il primo locale che visito è Etxeberria, che in basco significa casa nuova; è un luogo molto accogliente. I piatti sono quelli classici della tradizione culinaria locale in cui la cucina di mare si integra molto bene con quella di terra. Iniziando con le tapas e i pinchos e finendo o proseguendo con piatti della tradizione e gli ottimi panini ricchi e colorati. In questo locale che apparentemente sembra un normale bar spagnolo si possono trovare molte birre artigianali selezionate tra birrifici della zona, spagnoli e francesi, con immancabili presenze di qualche birra belga e inglese. Le spine sono cinque e di birre diverse in stile, provenienza e struttura, in modo da offrire una buona scelta a chi decide di gustarsi un’esperienza brassicola in questo locale. Alfonso e il resto dello staff sono stati non solo gentili ed accoglienti, cosa alla base di un buon locale che vuole provare a restare aperto e lavorare, ma anche entusiasti del mio lavoro e di quello che
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 53 aprile 2023 TURISMO BIRRARIO
Zurito
avrei fatto. Volevo provare una birra in lattina (sono di sempre maggior uso in Spagna) e una alla spina. Ho bevuto, anche su consiglio dell’oste, una summer ipa di un birrificio molto noto nella zona che parte e predilige lo stile americano ma non solo. Il clima in effetti non era quello invernale e freddo che avevo lasciato a Milano e i sentori citrici ed agrumati davano una freschezza e leggerezza alla bevuta molto piacevole. Il grado alcolico era del 5,2%. Ho deciso di gustarla con un bocadillo con jamon serrano, il prosciutto Iberico, e queso de cabra, un formaggio di capra accompagnato da una fetta di pomodoro. Il risultato è stato un ottimo connubio tra la morbidezza e secchezza agrumata della birra e la sapidità del panino. Dopo la summer ipa ho scelto una Belgian Dubbel con gradazione pari a 7,2. La prima dubbel per il birrificio Basqueland, pluripremiato in molte occasioni in Spagna e fuori. Sentori attenti e precisi nello stile, bevuta ottima e piacevole. In abbinamento, dopo averla bevuta ho deciso di degustare solo un caffè, scelta che ha dato valore alle note tostate di questa birra e lasciato un piacevole sentore al palato.

All’ingresso dell’oceano: Muguruza-Ardoak
Durante il mio soggiorno basco ho alloggiato a San Juan, uno splendido borgo all’ingresso dell’oceano, un fiordo spagnolo, con una vista mozzafiato sul fiume e l’ingresso al mare. L’unione dei due flussi di acqua rende l’aria intensa e piacevole e, complice anche un inaspettato e inusuale sole, l’atmosfera mi ha permesso di degustare i miei aperitivi con maggiore piacere. Inevitabile infatti per un viaggiatore legare le sue sensazioni ai luoghi e all’atmosfera nella quale si ritrova a vivere durante la vacanza e, anche per chi apre un locale di somministrazione, si tratta di un aspetto di non secondaria importanza da tenere in considerazione.
A San Juan ho visitato Muguruza Ardoak, un piccolo locale semplice e con una lunga tradizione familiare che si legge sulle pareti e negli arredi accoglienti del bar. Un posto dell’oceano, classico borgo di pescatori e non solo che vivono da sempre in simbiosi con l’acqua e le attività del porto. Dietro al banco e in cucina tre donne che con dei meravigliosi sorrisi invitano a socializzare e stare bene. Quattro spine, due dedicate a birre locali del-

la zona, una chiara e una morada (rossa), nel frigo vetrina diverse birre anche artigianali in lattina o bottiglia.
Su ogni tavolo non mancava almeno una birra in formato non più grande di mezza pinta e affiancata da una leccornia che questo piccolo locale regala a chi ha voglia di stare in tranquillità, godendosi l’aria all’imbocco dell’oceano.

54 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 TURISMO BIRRARIO
Il colorato paese di Hondarribia
La belgian dubbel di Etxeberria
Le birre assaggiate al Muguruza Ardoak di San Juan
In questo caso l’abbinamento è stato fatto con un bocadillo con tonno e peperoncini verdi sottaceto, tipici della zona e un pinchos, una fetta di pane condita con uno spiedo di acciughe e olive verdi. La sapidità del pesce e la dolcezza acre del peperoncino e delle olive sono state ottime compagne per la degustazione di queste birre che non avevano grandi pretese ma regalavano una bevuta facile e piacevolissima con qualche nota di stile interessante. Lager e keller sono i due stili da sempre più diffusi in Spagna. Prezzo ottimo per prodotti freschi e di qualità, ulteriormente valorizzati da un’’accoglienza che resta nel cuore.
Un luogo di aggregazione per il quartiere: Bar Desy
La città di San Sebastian, o Donostia in basco, è un luogo che mi ha sorpreso per il suo essere così perfettamente spagnola con visioni francesi ma senza il prevalere di nessuno dei due aspetti. L’oceano in città, la bellezza degli angoli, il sapore delle vie del centro ricche di piccoli negozi di ogni genere e gusto, il surf che esce dall’oceano e vive nelle strade della città, la cultura discreta ma decisa di un luogo che ha molto da raccontare e che forse sarebbe ancora più bello se non fosse caratterizzato da quel turismo che non è capace di vivere un posto senza masticarlo velocemente in attesa del prossimo boccone.

Tra queste piccole strade si trova un luogo di culto per la zona e per chi a San Sebastian vuole degustare delle ottime birre e buon cibo in un’atmosfera piena di pacata ed attenta competenza. Il terzo locale oggetto del mio tour brassicolo è il Bar Desy; anche se la maggiore attrazione è rappresentata dal suo oste, Gorka, che trasmette passione già dal sorriso con cui ti accoglie.
Al bar Desy sono rimasta a lungo proprio perché mi sentivo a mio agio e non avevo voglia di andarmene. Ho degustato 4 diverse birre e un paio di assaggi dell’oste. Il bar è lungo e stretto con diversi tavoli esterni nel dehor. Al ban-
co sei spine, in vetrina frigo un’ampia selezione di birre, in particolare quelle acide e a fermentazione spontanea, che adoro e che non sono facili da comunicare e da degustare per il palato di molti ma che, quando vengono intese e spiegate, diventano subito tra le preferite.
Gorka mi accoglie entusiasta, iniziamo a parlare del mondo artigianale in Italia e in Spagna e mi dice che fino a pochi anni fa in Spagna poche persone bevevano birra artigianale: lui, un suo amico e pochissimi altri. L’interesse per questo mondo sta però sempre più crescendo, complice anche il fatto che la Spagna parla e vive con la birra da sempre, vi si trovano infatti birrifici di altissimo livello che stanno facendo un buon lavoro tra locale e straniero. Le persone, inoltre, sono curiose se ben educate a provare nuovi sapori. Inizio il mio viaggio di degustazione con una bitter gradazione 4,6, una birra
classica inglese che il birrificio ha voluto personalizzare con un tocco, in dry hop, di Bramling Cross. Sentore di frutti rossi tra cui ribes nero e prugna. Leggermente amara e morbida. In abbinamento un panino con sgombro, un pesce troppo spesso sottovalutato, e peperoncini verdi. Immancabili le patate alla Desy con pancetta affumicata e salsa all’aglio. Ottimo il contrasto che poi si bilancia al palato e viene esaltato.
La seconda birra è stata una Ipa da 6 gradi di un birrificio della zona Gross. Una birra semplice ma di carattere con decisi sentori tropicali e note di pino e resina che danno leggera secchezza e amarezza. A questa birra ho abbinato, su suggerimento di Gorka, la loro chuleta (un burger), fatto con un pane artigianale, una crema di formaggio e maionese leggera e ottima carne cotta per restare morbida e succosa. A parte la gioia scatenata dal mangiare carne di alto livello in un bar, cosa che conferma
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 55 aprile 2023 TURISMO BIRRARIO
La città di San Sebastian
la mia teoria che apparire e basta non serve a molto, il connubio al palato era perfetto e piacevole, tanto da portarmi velocemente alla terza birra.
Il bar Desy è distributore ufficiale di Cantillon a San Sebastian, per cui nella loro proposta di mescita e in bottiglia sono molte le birre con questo marchio. Gorka mi spiega che questa è una birra molto particolare e che lui non manca mai di raccontarla e farla assaggiare a tutti; ne è così innamorato che nel locale ci sono anche delle foto dell’affinamento in botte. Mi fa provare una lambic, kriek, da 5 gradi prodotta con ciliegie e mosto d’uva. Il colore è ammaliante e sincero al naso, un’esperienza intensa ma dinamica che si modifica velocemente con la decantazione nel bicchiere. Alla bevuta un mondo che riporta ad uno stile fatto di lunghissime tradizioni e di alchimie. Mi

consiglia di abbinarlo ad un pinchos di gamberi avvolti nella pancetta e pane con un pizzico di olio d’oliva. La dolcezza del gambero, la determinazione della pancetta e la morbidezza del pane finale rendono piacevolissima la scelta della lambic. Sembra di banchettare ad una tavola piena di sapori bilanciati. Infine, arriva una delle mie preferite, una strudel stout da 11 gradi. Il momento della mescita è quello che più mi emoziona. Il bicchiere viene fatto passare in acqua bollente per prepararlo ad una birra che ha bisogno di calore per essere accolta e poi degustata. Il sapore al naso è deciso e avvolgente e la bevuta riprende i sensi con le alte note di una birra prodotta in Estonia con mele e cannella e fatta invecchiare in botti di brandy e cognac. L’abbinamento intenso ma piacevole è con la torta di formaggio della casa ma è consigliato an-

56 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 TURISMO BIRRARIO
La lambic del bar Desy
che con pesce crudo, magari le ostriche che nella regione non mancano.
Una birreria tra spiaggia e centro storico: Mala Gissona beer house
L’innamoramento per questa zona continua e si conclude, per questa volta, con il brewpub di Mala Gissona. Tra i vari locali visti quello che più si avvicina ad uno stile internazionale con note chiare tipiche di un beerstrot con un arredo di stile di gusto, ampi quadri alle pareti, arte e design dei materiali. Il locale si trova a pochissimi passi dalla spiaggia della città di San Sebastian e non risulta assurdo poter trovare sul pavimento qualche granello di sabbia dato che il brew è frequentato, nella zona del pranzo, da moltissime famiglie di ritorno dalla spiaggia. Ad accogliermi c’è Nico che, con maestria e con sorriso sulla faccia, riesce a gestire da solo il locale, supportato dalla bravissima chef che in cucina segue le comande con tempi e modalità che rendono l’esperienza nel locale davvero piacevole. Le spine sono 12, solo


birre prodotte dal birrificio che porta il nome del locale Mala Gissona, nella vetrina frigo anche qualche ospite. Il locale ha un bancone accogliente e mi vede subito comodamente seduta. Spiego a Nico come vuole raccontarsi in tre birre, mi piace farlo quando vedo moltissime referenze per un solo marchio. Iniziamo con una porter, in assoluto tra i miei stili preferiti e proprio per questo tra quelli che cerco di degustare con grande attenzione e critica. Gradazione 7, schiuma leggera e cremosa, ottima al palato con un mix di sentori maltati e tostati e un leggero sentore acido tipo della parte che ricorda il cioccolato. L’abbino con delle olive verdi condite con spezie e limone. Il contrasto cioccolato e limone è ammaliante. Intermezzo la degustazione con la loro bitter e l’apparente irriverenza al naso forte ed intensa si bilancia benissimo in bocca e la finisco subito. La mia degustazione prosegue con una farmhouse grape ale, gradazione 7, che nasce dalla collaborazione con un’antica sidreria della zona, altro capitolo molto interessante della zona che merita da solo un approfondimento, che produce anche il vino bianco non filtrato tipico della zona: Txakoli. Colore limpido, note acide e sapide che ricordano bene il luogo in cui ci si trova. Bevuta profumata floreale al naso e maggiore secchezza al palato. L’abbino con delle patate fatte con alcune salse prodotte da loro; una maionese semplice ma di grande consistenza e sapore delicato e un salsa dal sapore affumicato con note dolci e piccanti. La finisco senza accorgermene. Prima di uscire mi fa assaggiare un sorso di rye red ale ed io rispondo che ci vedremo presto ed esco anche da qui con un gran sorriso. Arrivata alla fine del mio viaggio posso affermare che la birra in Spagna e nei Paesi Baschi, che ho visto per la prima volta, è alla base della socializzazione al bar e di bar in Spagna ce ne sono moltissimi e di mille tipi diversi. Solitamente si tratta di locali senza grandi
pretese stilistiche, forse perché il loro ruolo è semplicemente quello di accogliere e promuovere la socializzazione, di rappresentare un luogo di riferimento per le piccole comunità locali, una “casa comoda”, infatti non a caso molti locali nella zona basca si chiamano anche etxe (casa in basco), locali dove ritrovarsi a fine giornata o durante il giorno per scaricare un po’ di tensione dal lavoro o anche solo per farsi una chiacchierata o una risata. Una cosa certa è che chi come me frequenta la Spagna da molti anni ha visto e confermato che il mondo della birra artigianale sta entrando sempre di più anche nei piccoli bar di quartiere, senza troppa comunicazione e pubblicità ma con lo spirito concreto dell’assaggio e della buona mescita. Questa rivoluzione artesanal sembra che stia piacendo sempre di più a tutti e il motivo della forza di questo è anche la curiosità che accompagna la clientela spagnola, fedele sì a molti sapori fatti di tradizioni e territorio ma con un occhio al nuovo e alle contaminazioni positive. ★
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 57 aprile 2023 TURISMO BIRRARIO
La farm grape ale del Mala Gissona
La porter del Mala Gissona
Densimetro e rifrattometro, COME TARARLI
cheri, ovvero 120 gr di zuccheri per ogni Kg di mosto. Notiamo che si sta parlando di Kg di mosto, non di litri di mosto. Da una parte questo può sembrare innaturale: nel formulare le nostre ricette, infatti, sembra logico e pratico indicare i nostri ingredienti in peso per ottenere un certo volume (ad es. i classici 23 litri) e in genere sia nel produrre una birra che nel berla parliamo di litri e non di Kg! Ma la gradazione in peso oltre a essere più “omogenea” (peso in peso) ha come vedremo anche un’utilità pratica. Viene comunque talvolta usata anche la scala in volume (gr di zucchero per litro di mosto, i gradi saccarometrici in volume che fino ad alcuni anni fa erano spesso indicati in etichetta).
Non sono molti gli homebrewer che si preoccupano di tarare i propri strumenti di misura - in primis il proprio strumento base, il densimetro - ma è un aspetto che dovrebbe riguardare non solo gli “scienziati” interessati a dettagliare al meglio i propri parametri di produzione: un minimo di precisione è infatti importante anche per l’HB “pratico”. Se vi basate sull’esperienza e non ritenete necessario replicare le proprie birre con precisione industriale, è comprensibile e tutto sommato giusto non preoccuparsi di una estrema precisione delle misurazioni - peraltro non ottenibile con strumenti amatoriali. A tutti però sarà̀ capitato ad esempio di essere in dubbio sulla fermentazione di una birra fermatasi non 1 ma 2 o 3 punti di OG sopra il valore aspettato: e se quei 3 punti dipendessero almeno in parte dalla
propria strumentazione? Meglio quindi cercare di avere un minimo di affidabilità, pur negli ampi limiti della tolleranza sufficiente per i propri scopi.

La Gradazione
Prima di illustrare i semplici procedimenti di taratura di un densimetro o di un rifrattometro, la prima cosa da chiedersi è: cosa vogliamo misurare?
La grandezza principale che interessa al birraio è la gradazione saccarometrica: quanti zuccheri (fermentabili o meno) ha il mio mosto? Si tratta del principale parametro riguardo alla “forza” di una birra, dal quale discendono tutti gli altri. La scala maggiormente usata è la gradazione Plato: semplicemente, la percentuale in peso di zuccheri nel mosto. Ad esempio, 12 gradi Plato significano il 12% in peso di zuc-
L’altra cosa da notare è che parliamo sempre di zuccheri per peso di soluzione “totale”, compresi gli zuccheri stessi.
Gli strumenti utilizzati
La misura della concentrazione zuccherina è misurata dal birraio in modo indiretto. Il più frequente è quello di misurare la densità, o peso specifico [1] del mosto. Dato che gli zuccheri - una volta disciolti in soluzione - hanno un peso specifico maggiore dell’acqua, una soluzione in cui essi siano presenti avrà anch’essa un peso specifico maggiore dell’acqua pura. Si può dimostrare che la differenza fra il PS della soluzione (mosto) e quello dell’acqua (eguale a 1 per definizione) è direttamente proporzionale alla gradazione zuccherina, più precisamente alla gradazione in volume. La cosa è intuibile con questo esempio: pensiamo di avere un litro di
58 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 HOMEBREWING di Massimo Faraggi
acqua, e di sostituirne 100 ml con altrettanti ml di zuccheri (aggiungendo cioè zucchero fino a tornare a un litro). Poiché il PS dello zucchero è di circa 1,6, i 100 ml peseranno 160 gr e il litro di soluzione avrà un peso di 900+160= 1060 g quindi un PS di 1,060. Se sostituiamo invece 200 ml la soluzione avrà un peso di 800+320=1120 g (PS di 1,120). Come vedete l’aumento (differenza) di PS passa da 0,060 a 0,120, quindi raddoppia esattamente come la gradazione zuccherina. La gradazione in peso è poi in semplice relazione a quella in volume (basta dividere per il PS stesso!) e da questi semplici ragionamenti derivano le formule di conversione fra densità, gradi in volume e gradi in peso (Plato). La densità del mosto è misurata grazie al densimetro, sfruttando il principio di Archimede: il galleggiante graduato emerge dal mosto tanto più quanto questo ha un maggiore PS.
Il rifrattometro, invece, misura la gradazione zuccherina grazie all’angolo di rifrazione della luce attraverso una goccia di soluzione: in pratica la luce viene deviata tanto più quanto è maggiore la presenza di zuccheri, e questa deviazione viene letta attraverso lo strumento. Convenzionalmente la scala del rifrattometro è in gradi Brix, ma la differenza fra questa scala e quella dei Plato è minima e del tutto trascurabile per gli scopi del birraio. La lettura del rifrattometro va comunque corretta di un piccolo fattore - in genere va divisa per 1,03 o 1,04 - questo non per la differenza di scala ma per tener conto di altre sostanze non zuccherine presenti nel mosto di birra, le quali modificando la rifrazione distorcono leggermente la lettura dello strumento.
Questa correzione, quindi, non va applicata nel caso di soluzione composta esclusivamente da zuccheri[2].
Metodologia
La verifica minimale di questi strumenti prevede molto semplicemente la misurazione di un campione di acqua “pura”
(non è necessario che sia distillata per i nostri scopi) verificando che la lettura dia 1000 (o zero Brix per il rifrattometro). Questo ci rassicura solo in parte, perché i nostri strumenti potrebbero essere allineati correttamente su questo valore ma essere imprecisi nel misurare valori di gradazione via via maggiore: è necessario quindi verificare la correttezza delle misurazioni anche mediante un paio di misurazioni di mosti zuccherini di densità conosciuta.
Nel tarare i nostri strumenti, la logica premessa è che gli strumenti utilizzati per la calibrazione e verifica abbiano una precisione uguale o maggiore di quella desiderata per il nostro densimetro o rifrattometro: se da essi pretendiamo una accuratezza dell’1% per la gradazione zuccherina, non possiamo utilizzare ad esempio una bilancia con precisione del 5%!

Per questo aspetto è da tener presente che le misure di peso sono in genere ben più precise che con quelle di volume: ad esempio su una provetta da 100ml, stimare un ml in più o in meno (1%) significa riuscire a leggere una variazione di uno o due millimetri sul livello della soluzione, mentre una bilancia di precisione anche economica non ha problemi a rilevare scostamenti anche ben inferiori al grammo. Sotto questo aspetto ci viene in aiuto il fatto di usare la scala Plato (in peso) illustrata più sopra, piuttosto che quella in volume, per poi utilizzare le opportune formule di conversione.
Procedimento
In un recipiente posto su una bilancia di precisione aggiungere 15 g di zucchero da tavola. Aggiungere poi acqua a temperatura ambiente (20°C) fino a raggiungere i 100 g di peso. Se necessario scaldare la miscela per sciogliere lo zucchero, ma lasciarla raffreddare fino a 20°C. Per definizione, la soluzione ha 15 gradi Plato, equivalenti a una OG di 1,061. Misurare con il densimetro e con il rifrattometro e verificare la correttezza, annotando l’eventuale errore. Aggiungere altra acqua
fino ad un peso di 200 g. Per definizione, la soluzione ha ora 7,5 gradi Plato, equivalenti a una OG di 1,030 (per l’esattezza 1,029.6). Misurare con il densimetro e con il rifrattometro e verificare la correttezza (se 100 ml di soluzione sono insufficienti a riempire la vostra provetta del densimetro, potete ad esempio raddoppiare tutte le quantità riportate, sia di acqua che di zucchero).
Risultati
Che fare se i valori rilevati si discostano da quelli teorici? In teoria si dovrebbe fare una interpolazione lineare dell’errore rilevato: detto in modo più semplice, se rileviamo valori corretti per 1,000 e 1,030 e 2 punti di errore nel test a 1,061 (ad esempio, rilevando 1,063) possiamo considerare che il nostro densimetro segni due punti in più intorno ai 1,060; sia corretto intorno ai 1030; e a metà stra-
BIRRA NOSTRA MAGAZINE 59 aprile 2023 HOMEBREWING
da (tra i 1040 e i 1050) possa rilevare un punto di troppo. In pratica se l’errore è limitato possiamo trascurarlo, tenendo anche conto che una eventuale piccola imprecisione può essere causata dall’accuratezza del procedimento: ad esempio un errore di 0,2 g nel pesare lo zucchero determina una discrepanza di 0,2 nella gradazione Plato. Se effettuiamo la calibrazione contemporaneamente per densimetro e rifrattometro, e rileviamo un piccolo e simile errore in entrambi, è
probabile che esso sia dovuto a quanto sopra, e possiamo trascurarlo.
Monitorare la fermentazione
Oltre che per determinare la gradazione “originale” del mosto, densimetro e rifrattometro sono strumenti utili in particolare per monitorare l’andamento della fermentazione. Il motivo è semplice: gli zuccheri vengono convertiti in alcool; il rifrattometro rileverà quindi una concentrazione zuccherina via via minore e così

il densimetro. Infatti, poiché gli zuccheri sono più pesanti dell’acqua e l’alcool ha un peso specifico minore, la densità diminuisce. È necessario a questo punto fare due considerazioni. Per quanto riguarda il rifrattometro, la rifrazione e quindi la lettura viene falsata dalla presenza di alcol (attenzione: non ci si riferisce al fatto della minore densità dell’alcol, stiamo parlando di un’altra cosa). Per fortuna esistono delle tabelle (e delle formule di approssimazione) che tenendo conto della quantità di alcol determinano la correzione da applicare alla lettura. In realtà in questa fase non sappiamo la percentuale di alcol presente (per conoscerla ci servirebbe la misura stessa che stiamo effettuando!) ma se abbiamo in precedenza annotato la OG, mettendo in relazione le varie grandezze si possono ottenere formule che ci permettono di stimare tutti i dati di interesse.
Diversi software per homebrewing hanno una parte relativa al rifrattometro, e in una APP Android sviluppata con la mia collaborazione è presente una sezione in cui sono anche riportati tutti i calcoli descritti nel sito (Beer Lab Free). Riguardo al densimetro, ricordo l’avvertenza di “sgasare” il campione da misurare: l’effervescenza presente in una birra ancora in fermentazione può infatti falsare la lettura anche di alcuni punti. Esistono metodi “standard” per farlo, nella pratica si tratta di travasare o agitare più volte il campione lasciando ogni volta dissipare la schiuma. ★
1. Per questi e altri interessanti approfondimenti sul rifrattometro rimando al mio sito: http:// www.maxbeer.org/ita/uso_rifrattometro.htm
2. Maggiori dettagli in un’altra pagina del mio sito: http://www.maxbeer.org/ita/uso_densimetro. htm
Note
[1] Densità e peso specifico sono due grandezze diverse, ma che ai fini pratici di questa discussione possiamo considerare equivalenti. Nel seguito vengono indicate con PS.
[2] Per l’idromele il fattore potrebbe essere diverso; personalmente nella pratica in questo caso non ho applicato fattore di correzione.
60 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023 HOMEBREWING
Le guide Le guide Le guide
Gli ingredienti della birra www.edizionilswr.it



Scopri la nostra selezione di volumi dedicati a chi vuole produrre birra, a partire da qualsiasi livello di esperienza, ma anche a tutti gli appassionati e i tanti curiosi che desiderano esplorare questo mondo.
Cercali in tutte le librerie online e sul territorio.

edizioniLSWR seguici
su
Acqua Luppolo Lievito Orzo/Malto
Le guide Le guide Le
LE TUE BIRRE FATTE IN CASA

Ricette per tutti gli stili - Seconda edizione di Davide Bertinotti, Massimo Faraggi
Davide Bertinotti e Massimo Faraggi, tra i massimi esperti italiani di birra fatta in casa e artigianale, in questo libro hanno selezionato oltre 90 ricette per realizzare nella propria cucina i più diversi e apprezzati stili birrari, dalle Lager alle Ale inglesi, dalle IPA ai Lambic. Tutte le ricette sono state premiate in concorsi birrari e includono sia birre strettamente aderenti allo stile presentato sia “interpretazioni” più libere, comunque testate e approvate da esperti giudici degustatori. Per ogni stile è presente la descrizione completa tratta dalla revisione 2021 del BJCP (Beer Judge Certification Program), ossia il disciplinare che descrive e definisce ogni stile birrario in termini tecnici e organolettici, e che è alla base delle più importanti competizioni amatoriali e commerciali in tutto il mondo.
ISBN 9788868959470
Pagine 368 | Colori
Prezzo 22,90 euro
www.edizionilswr.it edizioniLSWR seguici su
NOVITÀ DAL MONDO BIRRARIO
DA PROVOCAZIONE A TERZA FORZA POLITICA IN AUSTRIA: È IL PARTITO DELLA BIRRA!
La birra è entrata in politica! A sdoganare questo nuovo campo di applicazione della bionda bevanda è stato Dominik Wlazny. Trentacinquenne austriaco, meglio conosciuto come Dr. Pogo, è musicista e frontman di un gruppo punk rock, comico e medico. Se l’idea di lanciarsi in politica nel 2014 con un partito dal nome Bierpartei Österreich
BPÖ, letteralmente “Il Partito della Birra austriaco” ha rappresentato una provocazione al sistema politico con evidente intento satirico, nel tempo e negli anni ha invece rappresentato l’occasione per raccogliere intorno a sé consensi sempre più ampi fino a trasformarsi semplicemente in Bierpartei passando dallo 0,10% alle elezioni politiche del 2019 all’1,8% alle elezioni statali viennese del 2020 che, se non gli hanno permesso di ottenere seggi
nel consiglio comunali hanno comunque permesso al suo partito di ottenere 11 seggi nei vari consigli distrettuali viennesi. L’exploit lo ha ottenuto lo scorso autunno in occasione delle elezioni presidenziali del 2022 dove, forse anche per merito di un programma più serio incentrato su proposte come la necessità di inserire corsi di alfabetizzazione mediatica nel curriculum scolastico o l’istituzione di un “Ministero del futuro” con lo scopo di garantire una pianificazione di lungo periodo, ha ottenuto l’8,31% dei voti diventando di fatto il terzo partito del paese! Immancabili le provocazioni come ad esempio la proposta di “abolire” la tassa sulle bevande nei bar/ristoranti e compensare con una nuova tassa del 50% “sulla birra Radler e altre atrocità”. Le presidenziali sono state vinte dall’eco-
nomista e accademico Alexander Van Der Bellen, sostenuto dai Verdi rieletto con il 56,69% dei voti. (mi.t.)
SALVA BIRRA. APPROVATO L’EMENDAMENTO CHE CONCEDE SCONTI FISCALI PER IL 2023

Il Decreto Milleproroghe approvato dal Senato a febbraio contiene anche la proroga del taglio delle accise sui birrifici. A godere dei benefici saranno soprattutto i produttori e i distributori che potranno beneficiare, per tutto il 2023, di importanti agevolazioni fiscali utili per riuscire a contrastare l’aumento dei costi delle materie prime. Soddisfatta Coldiretti che in un comunicato ha fatto sapere che “il taglio delle accise aiuta la ripresa del comparto italiano della birra, mettendo in sicurezza lo sviluppo della filiera e l’aumento di produzione di materia prima in Italia”. Un aiuto al made in Italy quindi che punta a tutelare la grande produzione artigianale di birra italiana che,
secondo i dati Coldiretti, genera un giro d’affari di 9,5 miliardi di euro prodotto da aziende piccole, medie e grandi disseminate per l’Italia che garantiscono 140 mila posti di lavoro a livello nazionale. I tagli fiscali saranno inversamente proporzionali alla dimensione dell’impresa: per i piccoli birrifici con una produzione fino a 10 mila ettolitri lo sconto sulle accise è stato confermato, anche per l’anno in corso, al 50%; per le aziende che invece producono fino a 30 mila ettolitri la riduzione scende al 30% e per le imprese più grandi che producono fino a 60 mila ettolitri lo sconto arriva al 20%. L’accisa per ettolitro e per Grado Plato è stata infine ridotta da 2,99 a 2,97. (mi.t.)

BIRRA NOSTRA MAGAZINE 63 aprile 2023 a cura della redazione
HANNO SCRITTO PER NOI
Flavio Boero




Perito chimico, ho iniziato a lavorare nel 1973, in qualità di tecnico di Laboratorio, alla Poretti S.p.A. di Induno Olona e quando l’azienda è stata acquisita da Carlsberg sono diventato responsabile qualità fino al pensionamento. Fin dal sorgere dei primi microbirrifici mi sono appassionato alla birra artigianale collaborando attivamente ai corsi di formazione per birrai e beer-sommelier. Partecipo, in qualità di giudice, ai concorsi birrari In Italia e all’estero.
Antonio Boschi
Grafico di professione e grande appassionato di musica e di arte. Titolare dell’agenzia WIT Grafica & Comunicazione, ho all’attivo l’ideazione e l’organizzazione di alcuni festival, tra cui il Rootsway premiato nel 2009 come migliore a livello europeo. Redattore della rivista Il Blues, da anni collaboro con Visit USA Italy oltre ad essere uno dei soci fondatori della società A-Z Blues. Autore del libro “Blues Pills e altre storie”.
Stefano Buiatti
Dal 1994 docente di Tecnologia della Birra presso l’Università di Udine. Esperienze in controllo qualità della Birreria Moretti di Udine e di ricerca presso il Brewing Research International a Nutfield, in Inghilterra. Consulente esperto nella valutazione di progetti tecnico scientifici per la Commissione Europea e presso la Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige. Autore di pubblicazioni scientifiche e divulgative.
Massimo Faraggi


Pioniere dell’homebrewing in Italia e docente di birra fatta in casa, sono stato co-fondatore di MoBI e curatore della rivista dell’associazione. Sono autore di articoli e libri di tecnica e cultura birraria.
Alberto Grandi
Professore di storia economica all’Università di Parma,mi sono occupato di Corporazioni nel Medioevo e in Età Moderna e di mercati alimentari nel periodo preindustriale. Sono autore di circa cinquanta pubblicazioni accademiche in Italia e all’estero e dilibri come Denominazione di Origine Inventata (Mondadori 2018), Parla mentre mangi (Mondadori 2019) e L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa (Aboca 2022), Autore del podcast “DOI - Denominazione di Origine Inventata”.
Matteo Malacaria
Giudice qualificato BJCP e beer sommelier, autore del blog Birramoriamoci.it e del libro “Viaggio al centro della birra”. Mi occupo di comunicazione e marketing applicati al settore birrogastronomico e sono docente presso la NAD di Verona.



Roberto Muzi
Formatore, sommelier, assaggiatore ONAF e consulente di settore. Laureato in Scienze Politiche, sono stato responsabile regionale per la Guida alle birre d’Italia di Slow Food Editore dal 2014 al 2021 e giurato in diversi concorsi birrari nazionali.

Eleni Pisano
Scrivo, fotografo, insegno e racconto di cibo. Esperta di turismo esperienziale in ambito brassicolo, beerchef, food stylist e beernauta in cerca di eccellenze in ambito brassicolo. Ho lavorato per grandi marchi del mondo birrario italiano e poi mi sono avvicinata al mondo brassicolo artigianale. Lavoro come consulente e beerchef in diversi locali tra Milano e Monza. Collaborazione su beer pairing.
Paolo Passaghe
Laureato in Controllo e Gestione della Qualità dei Prodotti Alimentari, dottorato in Scienze degli Alimenti (2014), con uno studio sulla stabilità colloidale di birre artigianali prodotte con succedanei gluten free, presso l’Università degli Studi di Udine. Collaboratore del Prof. Stefano Buiatti nella sezione di ricerca e sviluppo (Brewing Science Group) e tecnico della micromalteria sperimentale dell’Università di Udine.
Luca Pretti
Laureato in Scienze agrarie e dottore di Ricerca in biotecnologie microbiche. Ricercatore nel centro Porto Conte Ricerche di Alghero, dal 1999 mi occupo della caratterizzazione di materie prime locali (luppoli e orzi) per le produzioni birrarie della Sardegna. Conduco corsi di divulgazione della cultura birraria per appassionati e professionisti. In qualità di giurato ho partecipato al concorso Birra dell’anno ed al Bruxelles Beer Challenge. Collaboro con Slow food per l’area birra in Sardegna.
Simonmattia Riva
Nel 2015 ho vinto il campionato mondiale dei Biersommelier Doemens. Giudice nei principali concorsi internazionali, sono docente in numerosi corsi di degustazione, membro di Unionbirrai Beer Taster e collaboratore delle principali riviste e guide di settore. Sono titolare del pub Beer Garage di Bergamo.

64 BIRRA NOSTRA MAGAZINE aprile 2023
Flavio Boero
Antonio Boschi
Stefano Buiatti
Massimo Faraggi
Alberto Grandi
Matteo Malacaria
Roberto Muzi
Eleni Pisano
Paolo Passaghe
Luca Pretti
Simonmattia Riva

2 5 ANNI DI I NNOVAZION I E BIOTECNOLOGIE AGROALIMENTAR I AMMOSTAMENTO FILTRAZIONE RAFFREDDAMENTO BATTERI LATTICI RAFFREDDAMENTO FERMENTAZIONE LIEVITO MATURAZIONE CONFEZIONAMENTO BOLLITURA 12 - 24 h 100° C
T i p o d i c a m p i o n e : M o s t o
M o s t o i n f e r m e n t a z i o n e B i r r a f i n i t a
P a r a m e t r i :
A l c o l , S G , d e n s i t à , p H , R D F , e s t r a t t i ( g r a d o P ° ) e c a l o r i e
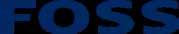
I birrifici artigianali possono adesso accedere ad analisi facili, veloci e accurate senza pretrattamento campione. Garantisci la qualità dei tuoi prodotti in tempo reale!
BeerFoss™ FT Go fornisce i dati chiave per il controllo dell’intero processo di birrificazione, dal mosto alla birra finita. Utilizzando BeerFoss™ FT Go puoi sapere esattamente cosa sta succedendo nel fermentatore senza necessità di filtraggio o degasaggio



™
D A T I E S S E N Z I A L I S U L P R O C E S S O D I B I R R I F I C A Z I O N E C O N U N S E M P L I C E C L I C K
B e e r F o s s
F T G o
w w w . f o s s . i t