

La nuova normativa sulla cybersicurezza
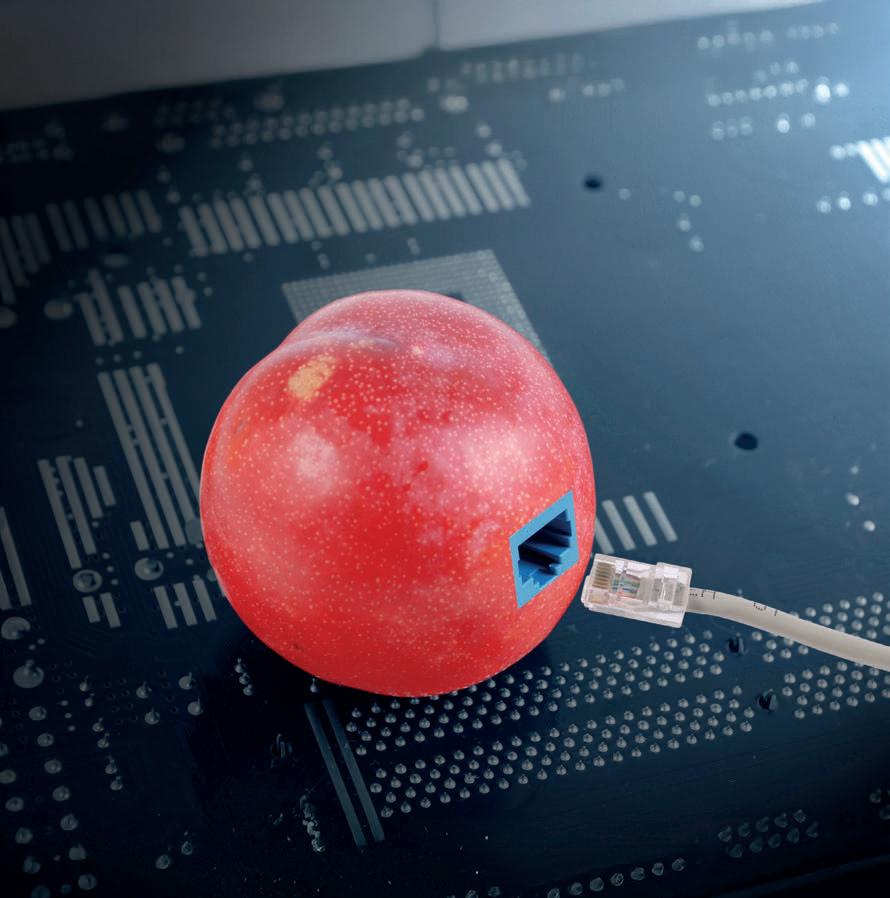
COATING A BASE DI CELLULOSA
MICRO-NANO FIBRILLATA









SALVIETTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
Salviette e Mop per pulizia e disinfezione delle superfici in tutti gli ambiti. Le salviette sono disponibili in molti modelli diversi per materiale, taglio, dimensione, sterilità, tipo di busta, preumidificazione, idoneità all’uso in clenaroom.
Visita www.kairosafe.it per vedere l’intera gamma di salviette e mop!

salviette pronte per essere imbevute - in busta stand-up
Da umidificare con la propria soluzione disinfettante, Versatili e comode.
salviette asciutte
Adatte a tutti gli usi ed economiche.

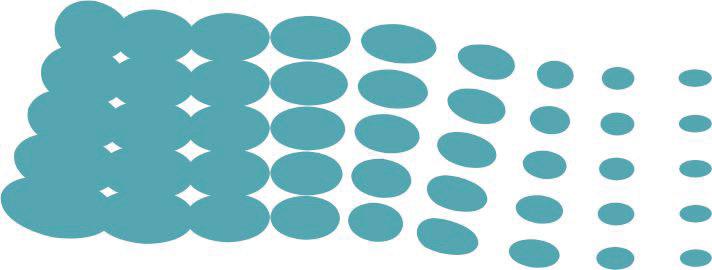


Salviette presaturate IPA ALCOOL ISOPROPILICO
Pronte all’uso, per massimizzare i processi.

BENEDETTA BOTTARI
Professore Associato
Microbiologia degli Alimenti
Università degli Studi di Parma
LISTERIA ZERO
Il panorama normativo europeo in materia di sicurezza alimentare si aggiorna con un’importante modifica: il 21 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento (UE) 2024/2895 della Commissione. Questo provvedimento introduce un cambiamento chiave nel Regolamento (CE) 2073/2005, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, con particolare attenzione ai limiti previsti per Listeria monocytogenes nei prodotti già immessi sul mercato. Finora, per gli alimenti pronti in grado di favorire la crescita di Listeria monocytogenes, il criterio di sicurezza alimentare variava in
Cambiamento chiave nel
Regolamento (CE) 2073/2005, relativo ai
base alla loro posizione nella filiera. I parametri principali di classificazione rimangono invariati: pH e attività dell’acqua dell’alimento, nonché la durata commerciale superiore o inferiore a cinque giorni. La vera novità riguarda invece la classificazione degli alimenti che, a priori, non sono considerati terreno favorevole alla crescita del patogeno. Il nuovo regolamento stabilisce che tale classificazione dovrà essere supportata da
uno studio sperimentale preventivo, un challenge test, obbligatorio prima della verifica analitica condotta dai laboratori di controllo ufficiali. Un aspetto cruciale del regolamento è la gestione dei casi in cui l’operatore del settore alimentare non abbia ancora effettuato tali studi di stabilità microbiologica. In queste situazioni, il regolamento stabilisce che il criterio di sicurezza alimentare applicabile sia “Listeria monocytogenes non rilevabile in 25 g”, o Listeria zero per dirlo all’Americana, fino a quando non si dimostri con certezza che il livello del patogeno non supererà le 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità dell’alimento. Il criterio più restrittivo è volto a garantire una maggiore tutela del consumatore, ma il nuovo regolamento, che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026, rappresenta per gli operatori del settore alimentare una sfida ad adeguarsi entro quella data. Sarà fondamentale per le aziende effettuare o commissionare gli studi richiesti, avvalersi di laboratori accreditati per il Challenge test e predisporre adeguate giustificazioni scientifiche basate su letteratura, modelli matematici o studi sperimentali. Si tratta quindi di un passo significativo verso un controllo più rigoroso di un microrganismo patogeno particolarmente problematico per il settore alimentare. L’obbligo di effettuare studi sperimentali preliminari per dimostrare la sicurezza microbiologica dei prodotti rappresenta un’importante responsabilità per gli operatori del settore, che dovranno attrezzarsi per affrontare queste nuove sfide. Certamente, l’adeguamento alle nuove disposizioni richiede tempo e risorse, ma la prevenzione e il rigore scientifico restano la chiave per garantire alimenti sempre più sicuri e di alta qualità.
Pressostato compatto con indicazione a 360° della condizione d’intervento

256 colori
Selezionabile individualmente:
Misura in corso Commutazione del sensore Malfunzionamento nel processo
Design compatto
Sistema di adattatori igienici
www.vega.com/vegabar 15 cm
Calibrazione con smartphone
INGRANDIMENTI
Listeria zero
Benedetta Bottari 2
NEWS DAL MONDO a cura della Redazione 6
TECNOLOGIA APPLICATA
Ricerca scientifica internazionale a cura della Redazione 12
FUORI CASA
Ristorazione, il valore del Made in Italy
Diletta Gaggia 16
L’aperitivo e i vegetali conservati sottolio a cura della Redazione 18
Ristorazione, modesto incremento della spesa a cura della Redazione 19
ATTUALITÀ
L’agrifoodtech in Italia a cura della Redazione 20
IMPIANTI
Innovazioni nella disidratazione degli alimenti
Biagio Calcavecchia e Valentina Vasta 22
SPECIALE PACKAGING
Coating a base di cellulosa micro-nano fibrillata
Andrea Feroce, Fabio Licciardello, Luciano Piergiovanni 28
NORMATIVA
PFAS negli alimenti
Avv. Chiara Marinuzzi 32
SOLUZIONI
Prodotti e soluzioni dalle aziende a cura della Redazione 34
IPACK-IMA
Processing, packaging e nuovi materiali
Diletta Gaggia 36


MACCHINE E IMPIANTI
Novità e soluzioni dalle Aziende a cura della Redazione 40
DIRITTO ALIMENTARE
NIS 2: la cybersicurezza in Italia
Avv. Chiara Marinuzzi 42
ATTUALITÀ
La DOP economy guarda con ottimismo al futuro
David Migliori 46
BAKERY
Strategie di riduzione e di arricchimento
David Migliori 54
Prodotti e soluzioni dalle aziende a cura della Redazione 57

PEST MANAGEMENT
Framework integrato per il Pest Management sostenibile
Francesco Fiorente e Francesco Nicassio
Prodotti e soluzioni dalle aziende a cura della Redazione
Direttore Responsabile Giorgio Albonetti
Direttore Scientifico
Massimo Artorige Giubilesi
Comitato tecnico scientifico
Giancarlo Belluzzi, Vincenzo Bozzetti, Francesco Fiorente, Gaetano Forte, Luciano Negri, Erasmo Neviani, Serena Pironi, Daniele Roseghini
Coordinamento editoriale
Chiara Scelsi c.scelsi@lswr.it Cel. 3490099322
Redazione
Diletta Gaggia d.gaggia@lswr.it redazione.food@quine.it
Impaginazione LSWR
Immagini Shutterstock
Produzione Antonio Iovene a.iovene@lswr.it Cel. 3491811231
Direttore Commerciale Costantino Cialfi c.cialfi@lswr.it tel. 3466705086
Traffico
Ilaria Tandoi i.tandoi@lswr.it
ABBONAMENTI www.quine.it abbonamenti.quine@lswr.it Tel. 02 864105 www.alimentinews.it
Costo copia singola: € 2,80
Abbonamento annuale Italia: € 40
Stampa
New Press Edizioni S.r.l. Lomazzo (CO)
ABBIAMO PARLATO DI
ACMA pag. 35 www.acma.it
AETNA GROUP pag. 38 www.aetnagroup.com
BITZER pag 41 www.bitzer.de
BÜHLER pag. 40 www.buhlergroup.com
FANUC pag. 39 www.fanuc.eu
ELESA pag. 39 www.elesa.com
METTLER TOLEDO pag. 40 www.mt.com
OMAS INDUSTRIES pag. 39 www.omasindustries.com
RELICYC pag. 41 www.relicyc.com/it/
RENTOKIL INITIAL pag. 63 www.rentokil.com
TUIDI pag. 57 www.tuidi.ai
TÜV ITALIA pag. 34 www.tuvsud.com
Tutti gli articoli pubblicati su Produzione & Igiene Alimenti sono redatti sotto la responsabilità degli Autori. La pubblicazione o la ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall’Editore. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pubblicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dal GDPR. I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Quine Srl, Via Spadolini 7 - 20141, Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.
Testata Associata

Quine Srl Produzione & Igiene Alimenti - Bimestrale Rivista ufficiale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 510 del 29-10-1983 Iscrizione al ROC n. 23531 dal 6 Maggio 2013 INDICE INSERZIONISTI ALITEST IV Copertina BIOAGRO III Copertina CSB-SYSTEM pag. 9
AGRIBOLOGNA, AL VIA IL PROGETTO ‘F.I.R.O.’
Fertilizzazione e irrigazione sono al centro del Progetto F.I.R.O., lanciato dal Consorzio Agribologna, capogruppo del Gruppo omonimo, fra i leader nella produzione e nella distribuzione di ortofrutta in Italia, in programma fino a fine 2026. Il progetto prende le mosse dalle valutazioni e dalle conclusioni derivanti da FIGARO e dalle progettualità precedenti, realizzate fra il 2022 e il 2024. I produttori di Agribologna sono risultati sempre più motivati a sviluppi ulteriori, in particolare all’analisi della soluzione circolante e fogliare, approccio alternativo a cui si è deciso di dedicarsi dopo avere testato i più avanzati sensori sul mercato per la misurazione dei nutrienti nel suolo. Nello specifico, i soci coinvolti nel progetto F.I.R.O. sono 11 in totale.
Alla base della visione di Agribologna, è centrale la consapevolezza delle sfide cruciali in agricoltura, oggi e per il futuro: i cambiamenti climatici, l’imperativo della sostenibilità e la necessaria razionalizzazione dei costi impongono strategie e azioni mirate e indifferibili. Agribologna investe in fertirrigazione e irrigazione razionale per un’agricoltura più sostenibile, scientifica e performante.
Obiettivi di F.I.R.O.
Con F.I.R.O., l’agricoltura si fa sempre più smart. Il progetto vede al suo centro: monitoraggio, analisi e tecnologie avanzate, per ottimizzare irrigazione e nutrizione, risparmiare risorse e incrementare la sostenibilità e la qualità delle produzioni orticole e frutticole. E più in dettaglio: consentire l’evoluzione di nutrizione e irrigazione delle colture, grazie a sensori e lisimetri, contribuire alla riduzione degli sprechi di risorse (acqua e nutrienti), proseguire nella formazione degli agricoltori all’uso di tecnologie agronomiche avanzate, ottimizzare la gestione colturale, anche in caso di eventi climatici critici e d’impat-



to e aumentare resistenza e conservabilità delle produzioni.
Le coltivazioni interessate sono orticole (caratterizzate da cicli brevi e apparati radicali più contenuti): melanzane, zucchine, cetrioli; e frutticole (colture pluriennali caratterizzate da un apparato radicale espanso e profondo): pesche, nettarine, mele, albicocche, kiwi. Per entrambe le specie vengono prese in esame coltivazioni in terreno. Nello specifico, le colture frutticole sono in pieno campo mentre per quanto riguarda le orticole, melanzane e cetrioli sono in suolo sotto serra e le zucchine in pieno campo.
Il sistema suolo-acqua-radici durante il
complesso e quanto mai variabile ciclo di crescita è un mondo a sé. Il mondo con cui dialogano e si confrontano da sempre gli agricoltori. Conoscere esattamente, momento per momento, di cosa necessiti la pianta è fra le sfide più attuali e ineludibili. Così com’è ineludibile poter attestare e condividere fra i soci le prassi più innovative. “Avvertiamo come necessario e improrogabile condividere con i nostri soci le proposte e i servizi più avanzati, perché il loro ruolo di tecnici specialisti possa consolidarsi giorno per giorno, nel fronteggiare le più varie criticità, spesso repentine e di impatto crescente”, conclude Franco Linguerri, Presidente Gruppo Agribologna.
SURGELATI: NEL 2024, OLTRE 652 MILA TONNELLATE CONSUMATE TRA LE MURA DOMESTICHE
I primi dati rilevati in Italia relativi al canale Retail evidenziano come nel 2024, il comparto dei prodotti surgelati abbia confermato la propria solidità, registrando un ulteriore incremento nei consumi tra le mura domestiche, che raggiungono quota 652.643 mila tonnellate (vs. le 645.000 registrate nel 2023).
Un dato positivo e incoraggiante che sottolinea come il consumo di prodotti surgelati in Italia sia aumentato a un ritmo senza precedenti negli ultimi anni, per poi stabilizzarsi su livelli elevati: negli anni della pandemia gli italiani hanno introdotto abitualmente nella propria alimentazione questi prodotti, riconoscendone l’elevato valore qualitativo e apprezzandoli anche in termini di gusto e di risparmio economico, e poi hanno continuato ad aumentarne il consumo.
In termini percentuali, i dati Retail 2024 ci raccontano una crescita a volume del comparto frozen del +1,3% rispetto ai consumi domestici 2023. Un valore che evidenzia una nuova spinta positiva del comparto, dimostrando ancora una volta quanto i prodotti surgelati siano divenuti ottimi alleati dei consumatori in ogni occasione, una spinta che plausibilmente sarà confermata dalla contemporanea crescita nei consumi fuori dalle mura domestiche.
“L’aumento segnato nel Retail nel 2024 evidenzia un apprezzamento costante per le qualità intrinseche in questi prodotti: praticità, disponibilità, ampiezza e varietà dell’offerta, valenze anti-spreco, gusto, elevati contenuti nutrizionali e, non ultimo, di convenienza”, ricorda Giorgio Donegani, Presidente IIAS.
Si confermano sul podio: vegetali, patate e prodotti ittici
Ma quali sono state nel 2024 le categorie merceologiche surgelate più amate dai consumatori italiani? I vegetali si confer-

mano al primo posto, frutto di scelte alimentari sempre più consapevoli ed equilibrate. Con 220.497 tonnellate consumate nel 2024 (rispetto alle 215.695 del 2023), i vegetali sono cresciuti del +2,2%, dimostrandosi un valido alleato di chi guarda al benessere e a elevati contenuti nutrizionali, ma anche di chi è propenso a scegliere sempre più proteine a base vegetale. Seguono, con 107.207 tonnellate, le patate che, pur mantenendo la posizione sul podio, registrano invece una lieve decrescita (-3,1%) rispetto all’anno precedente, in cui i consumi avevano registrato cifre record, raggiungendo quota 110.532 tonnellate. Una oscillazione comunque fisiologica, tenendo conto che la stessa categoria ha segnato un incremento del 31,7% rispetto al 2019.
Al terzo posto si classifica il pesce surgelato (naturale e panato), che con 95.955 tonnellate registra un incremento del +3,9% rispetto alle 92.372 tonnellate del 2023. I prodotti ittici frozen continuano nel loro virtuoso percorso di accreditamento presso i consumatori italiani, che li apprezzano
in quanto sicuri, salutari, nutrienti, sempre disponibili, facili da preparare, convenienti e ‘trasparenti’, grazie alla completezza delle informazioni presenti sulle etichette delle confezioni.
Da evidenziare, nel 2024, la crescita del comparto delle pizze surgelate, che registra l’aumento più significativo in termini percentuali: +3,7%, per un consumo pari a 65.688 tonnellate. Una crescita giustificata anche dalla convenienza economica di questo prodotto.
Anche i piatti pronti surgelati e le specialità salate registrano un trend in crescita nei consumi domestici, rispettivamente del +0,5% e +2,4% sul 2023, per un consumo pari a 66.306 e 31.367 tonnellate. L’alta qualità degli ingredienti, le ricettazioni tradizionali ma innovative, la velocità nelle modalità di preparazione e l’attenzione all’equilibrio nutrizionale sono alcuni dei fattori che hanno fatto di queste categorie la migliore risposta ai nuovi stili di consumo delle famiglie italiane, che hanno sempre meno tempo da dedicare in cucina ma sempre più voglia di piatti gustosi, veloci e vari.
PER LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA
Federalimentare segnala il potenziale inespresso nella filiera agroalimentare e l’arretratezza dell’Italia su questo fondamentale fronte, nonostante il settore pesi circa il 30% dell’intero PIL. L’auspicio è che ci sia un investimento di attenzione e risorse da parte di tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali che hanno a cuore un’accelerazione dell’AgriFoodTech che consenta di mantenere la nostra leadership. Sono alcune delle principali evidenze del primo “Rapporto sulla Trasformazione Tecnologica della Filiera Agroalimentare.
Il Contributo della Startup Economy”, promosso da Federalimentare, sostenuto da Confagricoltura e realizzato dal Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, con la collaborazione degli esperti di Linfa
AgriFoodTech Fund.
I numeri non lasciano spazio a molti dubbi: nonostante la storia e la posizione dell’agroalimentare in Italia, infatti, nel 2024 sono stati investiti in startup AgriFoodTech solo poco più di 100 milioni di euro. Un dato, tra l’altro, in calo rispetto al valore degli investimenti nel 2023 (poco più di 140 milioni di euro; -28%) e nel 2022 (poco più di 150 milioni di euro; -36% il decremento 2024 su 2022).
Lo sguardo al di fuori dei confini nazionali è impietoso: Regno Unito, Germania, Francia e Spagna investono più dell’Italia e, rapportando questo differenziale rispetto al peso che l’agroalimentare ha sul PIL dei diversi paesi, il divario appare davvero abnorme. Confrontando quanto investito in Italia
TUTTOFOOD: 16,4 TONNELLATE DI CIBO SALVATE DALLO SPRECO
Banco alimentare della Lombardia ha recuperato questa quantità al termine della manifestazione. Il cibo è stato poi ridistribuito alle strutture caritative che aiutano persone in difficoltà per essere trasformato in oltre 32.800 pasti equivalenti (un pasto è equivalente a un mix di 500 g di alimenti in base ai LARN-Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana. L’importante risultato è stato raggiunto grazie all’impegno dei quasi 50 volontari, di 14 dipendenti di Number 1 Logistic Group e delle 364 aziende che hanno scelto di aderire e di donare, anziché sprecare i loro prodotti durante Tuttofood, la fiera internazionale dell’agroalimentare che si è svolta a Milano-Rho dal 5 all’8 maggio. In questo modo alimenti ancora in perfetto stato sono stati ridistribuiti ad alcune
con la media di quattro paesi europei di riferimento, emerge che per colmare il gap, per esempio, in rapporto al valore della produzione agricola, il valore degli investimenti AgriFoodTech dovrebbe essere di oltre 500 milioni di euro annui. Ben 5 volte di più rispetto al dato reale del 2024.
La situazione appare ancora più paradossale se si pensa che l’ecosistema dell’AgriFoodTech in Italia cresce ed è effervescente. Nel rapporto sono state mappate ben 550 startup, di cui 280 hanno avuto accesso ad almeno un round di investimento, seppure in gran parte in fase pre-seed o seed. Maggiori capitali e più investitori, sia professionisti del venture capital sia corporate, dovrebbero essere attratti e incentivati.

delle oltre 1.000 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare della
Lombardia che sostengono più di 200.000 persone in difficoltà in tutta la regione.
SOLO 100 MILIONI
I più recenti dati di Ismea mercati segnalano a livello europeo un aumento nel 2024, che segue una precedente crescita nel 2023 che conferma il ribaltamento della situazione degli anni prima caratterizzata da un ripiegamento della produzione.
Il report di Ismea segnala che, con un grado di autoapprovvigionamento del 108%, l’UE conferma la posizione di esportatore netto. In 10 anni la produzione è cresciuta del 22% trainata dai Paesi dell’Est tra cui spicca la produzione europea di carni avicole, dopo la costante crescita nel decennio 2010-2020 e il ripiegamento negli anni 2021 e 2022, torna ad aumentare nel 2023. Circa 11,4 milioni di tonnellate la produzione europea nel 2023 con un grado di autoapprovvigionamento del 108% che le permette così di confermare la posizione di esportatore netto. In 10 anni la produzione è cresciuta del 24%.

Nel 2024 la produzione di carne avicola è tornata ad allinearsi ai livelli precedenti, con un incremento del 4,2% sul 2023. Sono cresciute le esportazioni (+5,3%), così come le importazioni di carne (+7%). Sono aumentate le disponibilità interne e il consumo medio pro-capite, che è arrivato a 21,9 kg, il dato più alto degli ultimi 10 anni. Il tasso di autoapprovvigionamento si attesta al 107% confermando la completa autosufficienza del settore e la predisposizione all’export verso nuovi mercati. Rispetto ai prezzi, quello medio annuo del pollo nel 2024 si è ridotto del 10,5% rispetto a quello del 2023. Anche i costi di produzione nel 2024 hanno subito una contrazione da ascriversi al rientro delle quotazioni delle materie prime utilizzate per l’alimentazione, nonché al leggero cedimento dei prezzi degli energetici. Le aspettative per il 2025 sono positive: il mese di marzo ha portato, infatti, una ripresa delle quotazioni del pollo, che sono superiori del 26% rispetto a quelle di marzo 2024. Al momento l’offerta è scarsa e non si rilevano scorte di vivo in allevamento. Il mercato delle carni avicole, nonostante la completa autosufficienza, nel 2024 ha fatto ricorso a un maggior volume di prodotto estero. Questo fatto è dipeso dalla discontinuità dell’offerta dovuta ai focolai di aviaria; nello stesso tempo sono aumentate le esportazioni verso altri paesi europei che, analogamente a quanto accaduto nel nostro Paese, avevano subito discontinuità di offerta interna.

Il mio ERP. Così ho tutto sotto controllo.
Efficienza, trasparenza, flessibilità – questo è ciò che conta ora. L’IT è la chiave per ottenerlo. Che si tratti di ERP, MES, rintracciabilità o software per la pianificazione intelligente: il CSB-System è la soluzione completa per le aziende del settore alimentare. Così già oggi potete ottimizzare la vostra produzione e domani digitalizzerete l’intera azienda.
Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il settore alimentare: www.csb.com
CRESCE LA PRODUZIONE DI CARNI AVICOLE
NOVEL FOOD: ITALIANI DIVISI TRA APERTURA AL FUTURO E AMORE PER LA TRADIZIONE
Curiosità, cautela, attenzione alla salute e un forte legame con la tradizione: è questo il mix di atteggiamenti che caratterizza il rapporto degli italiani con il novel food, ovvero quei cibi innovativi che includono carne coltivata in laboratorio, proteine derivate da insetti, alghe, meduse e altri prodotti nati dalla ricerca scientifica e dal crescente bisogno di sostenibilità.
A raccontarlo è la ricerca condotta da BVA Doxa nelle scorse settimane su un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da 1.000 uomini e donne tra i 18 e i 65 anni. L’indagine ha esplorato la conoscenza, la propensione al consumo e le barriere percepite rispetto al novel food. Solo il 23% degli italiani si considera informato sul tema. La conoscenza è distribuita in modo omogeneo tra uomini e donne, senza particolari differenze tra le fasce d’età, ma emerge con maggiore intensità tra i giovani dai 18 ai 34 anni, che si distinguono anche per apertura e sperimentazione.
Un potenziale interessante, ma molte resistenze
Alla domanda “Saresti disposto a provare i novel food?”, il 40% degli italiani si dice possibilista, rispondendo “dipende dal tipo di

alimento”. Solo una minoranza (9%) è pronta a provarli subito, mentre il resto esprime dubbi o contrarietà. I 18-34enni sono i più aperti alla sperimentazione, mentre gli over 55 si mostrano i più restii, evidenziando un forte attaccamento alla cucina tradizionale. Il principale ostacolo all’accettazione del novel food è proprio il forte legame con la tradizione alimentare: per il 39% degli italiani, il fatto che questi cibi siano “estranei” alla cultura gastronomica nazionale riduce la disponibilità a provarli. Solo il 34% ritiene che l’innovazione alimentare possa avere un impatto positivo sulla propria dieta.
In termini di esperienza diretta, i cibi plant-based, funzionali e sostenibili sono già stati introdotti nella dieta di una parte della popolazione, in particolare da donne e giovani. Il 36% degli italiani riconosce che il novel food può contribuire alla sostenibilità ambientale, percentuale che cresce tra i più giovani e tra coloro che si dichiarano sensibili ai temi ecologici. Nonostante l’interesse, la propensione a spendere di più per alimenti legati alle nuove tendenze resta bassa: solo 1 italiano su 4 sarebbe disposto a farlo, e solo a seconda del tipo di prodotto.
80.000 tonnellate raccolte: gli oli vegetali e animali esausti vengono poi rigenerati per la produzione di biodiesel di seconda generazione. I dati del CONOE che raggruppa 18 confederazioni e associazioni che rappresentano oltre 300.000 produttori di oli e grassi esausti del settore industriale – artigianale e commerciale; oltre 300 aziende di raccolta e stoccaggio e oltre 60 aziende di rigenerazione.
Il Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali e Animali Esausti (CONOE) ha presentato con soddisfazione gli ultimi risultati della propria attività che comprende un impegno costante per la tutela ambientale e l’economia circolare. I dati precisi dicono che nel corso del 2024 il CONOE ha registrato una raccolta totale di oli e grassi esausti di 80.345 tonnellate, il che corrisponde
alla quasi totalità degli oli esausti prodotti dalle attività professionali e a oltre un quarto del rifiuto prodotto in Italia in un anno. Si tratta di numeri in linea con i risultati dell’anno precedente. La produzione nazionale complessiva di oli e grassi esausti è stata stimata in 300mila tonnellate l’anno, per il 38% prodotti dal settore professionale (industria, ristorazione e artigianato) e per il 62% del totale prodotti da attività domestiche.
I NUMERI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE DEGLI OLI RIGENERATI
Si tratta della prima volta in assoluto per un prodotto che può vantare una lavorazione che ancora oggi avviene in gran parte a mano. La novità principale è legata al peso massimo alla marchiatura, che passa da 5 a 6 chili e tende a favorire le lunghe stagionature. Aggiornati anche i controlli genetici sulla filiera, oltre a ridurre la percentuale di sale.
Come ribadisce Romeo Gualerzi, Presidente del Consorzio di Tutela, l’obiettivo è ben preciso: “La maggior parte del prodotto viene venduto intorno ai 20 mesi, ma gli associati stanno optando per stagionature sempre più lunghe, fino ai 36-48 mesi; ecco perché occorre partire da un prodotto più grasso e quindi più pesante. Questo garantisce che anche nel lungo periodo il Culatello di Zibello mantiene un grado di morbidezza fondamentale, arrivando così a un risultato finale di eccellenza assoluta”.
Il Consorzio ha aggiornato anche diversi parametri, tra cui il valore relativo al sale,

ora ridotto: “Ci siamo accorti - prosegue Gualerzi - che nelle lunghe stagionature il prodotto ha una disidratazione maggiore di quella stimata inizialmente. Ecco per-
98 MILIONI PER L’EXPORT VITIVINICOLO EXTRA UE
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato un nuovo avviso relativo alla misura OCM Vino - Promozione sui mercati dei Paesi terzi col quale mette a disposizione del settore vitivinicolo nuove risorse per finanziare le attività di promozione e informazione nei mercati esterni all’Unione europea.
La misura vuole essere uno strumento strategico per rafforzare la presenza del vino italiano nel mondo, che già nel 2024 ha superato gli 8,5 miliardi di euro in esportazioni. La somma messa a disposizione è pari a un totale di 98.027.879 euro, di cui oltre 22,5 milioni destinati al bando nazionale. Le restanti somme
saranno assegnate attraverso bandi regionali e multiregionali.
Per la prima volta, tutto il procedimento - dalla configurazione della campagna alla valutazione dei progetti - sarà gestito tramite una piattaforma digitale, semplificando l’accesso per gli operatori. È stato inoltre introdotto un tariffario per cinque mercati strategici (Stati Uniti, Cina, Canada, Svizzera e Regno Unito), eliminando l’obbligo di presentare tre preventivi da fornitori esteri.
“Se oggi è ancora possibile promuovere il vino”, ha dichiarato il Ministro Francesco Lollobrigida, “è grazie a nazioni come l’Italia, che si sono battute per non demonizzarlo. Il vino non è un ne -
ché la percentuale minima di cloruro di sodio è passata da 3,40 all’attuale 2,8%”. È stato anche rivoluzionato il metodo di controllo legato alla materia prima.

mico: fa parte della nostra cultura da millenni. Questa misura è fondamentale per sostenere le imprese del settore e migliorare i risultati - già significativiraggiunti nel 2024”.
NUOVO DISCIPLINARE PER IL CULATELLO DI ZIBELLO DOP
VINO,

a cura della Redazione
DOI: 10.1016/j.foodres.2024.114460
Confronto del profilo nutrizionale tra analoghi della carne a base vegetale e carne vera: una revisione incentrata su ingredienti, contenuto nutrizionale, biodisponibilità e impatti sulla salute Comparison of nutritional profile between plant-based meat analogues and real meat: A review focusing on ingredients, nutrient contents, bioavailability, and health impacts. Food Research International, Volume 187, luglio 2024 Y. Xie, L. Cai, G. Zhou, C. Li
Per comprendere appieno l’eterogeneità nutrizionale degli analoghi della carne di origine vegetale e della carne vera, questa revisione ha riassunto le loro somiglianze e differenze in termini di ingredienti, conte-
nuti di nutrienti, biodisponibilità e impatti sulla salute. Gli analoghi della carne di origine vegetale hanno alcune somiglianze con la carne vera. Tuttavia, hanno meno proteine, colesterolo e vitamina B12, ma più fibre alimentari, carboidrati, zucchero, sale e vari additivi alimentari. Inoltre, alcuni nutrienti negli analoghi della carne di origine vegetale, come proteine e ferro, sono meno biodisponibili. Non ci sono prove sufficienti che gli analoghi della carne di origine vegetale siano più sani, il che potrebbe essere correlato agli attributi specifici di questi prodotti come la formulazione e il grado di lavorazione. Allo stato attuale, è necessario fornire informazioni nutrizionali complete sui prodotti a base di carne di origine vegetale in modo che i consumatori possano fare scelte informate in base alle loro esigenze nutrizionali.


DOI: 10.1016/j.fochx.2024.101372
Il trattamento con campo elettrico pulsato migliora la resa dell’olio, la qualità e l’attività antiossidante dell’olio di oliva vergine
Pulsed electric field treatment improves the oil yield, quality, and antioxidant activity of virgin olive oil. Food Chemistry: X, Volume 22, 30 giugno 2024
S. Yang, S. Li, G. Li, C. Li, W. Li, Y. Bia, J. Wei
Il campo elettrico pulsato (PEF) è una tecnica innovativa utilizzata per facilitare l’estrazione degli oli vegetali. Finora non sono state condotte ricerche sugli effetti del PEF sulla qualità dell’olio vergine di oliva (VOO) e sull’attività antiossidante. Questo studio mira ad analizzare gli effetti del PEF sulla resa, sulla qualità e sull’attività antiossidante in vitro dell’olio extravergine di oliva “Koroneiki”. I risultati mostrano che il trattamento PEF ha aumentato la resa in olio del 5,6%, ma non ha avuto effetti significativi sul valore di saponificazione, K232, K270 e sul valore

∆K dell’olio vergine d’oliva. Il trattamento PEF ha ridotto il contenuto di acido oleico del 3,12%, ma non ha avuto effetti significativi sul contenuto di acido palmitico, linoleico, linolenico, arachidonico, stearico, oleico e palmitico. Dopo il trattamento con PEF, i livelli di fenoli e flavonoidi totali e oleuropeina sono aumentati rispettivamente del 7,6%, 18,3% e 76%. Non è stato riscontrato alcun effetto significativo sui livelli di 4 acidi fenolici (acido vanillico, p -cumarico, ferulico e cinnamico), 2 lignani (lignani e apigenina), idrossitirosolo e 3 pigmenti (luteina, clorofilla e carotenoidi). Inoltre, il trattamento con PEF ha aumentato significativamente il contenuto di tocoferoli, con un aumento dei tocoferoli α, β, γ e δ rispettivamente del 9,8%, 10,7%, 13,6% e 38,4%. Anche la capacità di eliminazione dei radicali liberi di DPPH e ABTS è stata migliorata. In conclusione, l’uso del PEF ha aumentato significativamente la resa dell’olio vergine d’oliva nonché i livelli di fenoli e flavonoidi totali, oleuropeina, tocoferolo e attività antiossidante in vitro.
DOI: 10.1016/j.cogr.2024.01.001
Ottimizzazione della manipolazione dei campioni alimentari e del riconoscimento dei pattern di posizionamento con YOLO: tecniche avanzate nel rilevamento robotico degli oggetti
Optimizing Food Sample Handling and Placement Pattern Recognition with YOLO: Advanced Techniques in Robotic Object Detection. Cognitive Robotics, 4 gennaio 2024
S. Koga, K. Hamamoto, H. Lu, Y. Nakatoh
Il Giappone, alle prese con un significativo deficit di manodopera dovuto al calo delle nascite e all’invecchiamento della popolazione, si sta sempre più orientando verso la robotica industriale, in particolare nel settore della produzione alimentare. La natura diversificata dei prodotti alimentari presenta una sfida notevole: la necessità di una programmazione personalizzata per ogni variante di prodotto, che è stata un ostacolo importante all’adozione diffusa della robotica in questo
settore. Questo documento presenta una soluzione innovativa che utilizza l’algoritmo di rilevamento degli oggetti “You Only Look Once” (YOLO), mirato a semplificare il processo di programmazione per i robot industriali. Un miglioramento fondamentale dell’approccio adottato in questo studio è l’integrazione della Non-Maximum Suppression (NMS) per una discriminazione efficace degli oggetti sovrapposti, sfruttando dati critici come il centro di gravità, la profondità e le misurazioni del bounding box. L’incorporazione di sensori RGB-D consente l’acquisizione di dati precisi sull’altezza spaziale, essenziali per valutare l’impilamento e la disposizione degli articoli. La praticità e l’efficacia di questa metodologia sono corroborate da prove empiriche che coinvolgono il posizionamento robotico di oggetti del mondo reale. Questa ricerca non solo dimostra la fattibilità di questo approccio, ma sottolinea anche il suo potenziale per ottimizzare significativamente le operazioni robotiche nella produzione alimentare.

DOI: 10.1016/j.eap.2024.05.021
La progettazione della politica ambientale per il settore dell’olio d’oliva in presenza di aziende eco-compatibili
The design of environmental policy for the olive oil sector in the presence of ecofriendly firms. Economic Analysis and Policy Volume 83, settembre 2024 , pagine 95-117
L. Gautier
Il settore dell’olio d’oliva nell’Unione europea ha recentemente mostrato un aumento nella produzione di olio d’oliva ecologico, il che è coerente con gli obiettivi politici di aumentare la produzione di prodotti ecologici e affrontare il degrado ambientale. In base alle attuali normative della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027, la politica ambientale nell’Unione europea è prevalentemente di tipo command-and-control con meno enfasi sulle politiche basate sul mercato. È stata studiata la progettazione della politica ambientale confrontando una tassa sulle emissioni (politica basata sul mercato) e uno standard vincolante relativo (politica command-and-control) in un settore in

cui le aziende si stanno trasformando in aziende eco-compatibili. I ricercatori sostengono che una tassa sulle emissioni è una politica più flessibile ed efficiente in questo tipo di settore. I risultati sottolineano il ruolo che le politiche ambientali basate sul mercato possono svolgere nel promuovere gli obiettivi politici dell’Unione europea. Inoltre, i risultati sono applicabili ai produttori di olio d’oliva a livello globale, ma anche ad altri settori in transizione verso la produzione di prodotti ecocompatibili.


DOI: 10.1016/j.jafr.2024.101281
Sicurezza alimentare pionieristica: integrazione della blockchain nella sorveglianza della supply chain Pioneering Food Safety: Blockchain’s Integration in Supply Chain Surveillance. Journal of Agriculture and Food Research, 6 luglio 2024
K. Duan, E. Onyeaka, G. Pang, M. Zeyuan
Garantire la sicurezza alimentare in un mondo che affronta una domanda crescente e filiere complesse è una sfida urgente. Nonostante la crescente consapevolezza, ostacoli come la distribuzione delle informazioni, le limitazioni finanziarie e le infrastrutture insufficienti ostacolano

gli sforzi per la sicurezza alimentare. La tecnologia blockchain presenta una soluzione promettente perché migliora la trasparenza e la tracciabilità nelle filiere alimentari, che sono essenziali per affrontare i problemi di sicurezza alimentare. Questo studio esplora l’integrazione della blockchain nei quadri di sicurezza alimentare, sottolineandone la compatibilità e il potenziale per trasformare la produzione e la distribuzione alimentare. Basandosi sulla letteratura, identifica le principali sfide all’adozione della blockchain, tra cui quadri normativi e problemi di interoperabilità, e propone strategie come l’intervento governativo e la standardizzazione per superarli. I ricercatori pensano che la blockchain possa rivoluzionare le pratiche di sicurezza alimentare.
DOI: 10.1016/j.trac.2024.117740
Sviluppi recenti e prospettive future della cromatografia liquida chirale per la sicurezza e la qualità degli alimenti Recent developments and future perspectives of chiral liquid chromatography for food safety and quality. TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 176, luglio 2024
S. Felletti, N. Marchetti, C. De Luca, M. Catani, C. Nosengo, G. Compagnin, D. Bozza, FA. Franchina, L. Pasti, A. Cavazzini
I prodotti alimentari sono fonti importanti di molecole chirali sia endogene che esogene, la cui distribuzione chirale deve essere rigorosamente controllata per garantire e preservare la qualità e la sicurezza degli alimenti stessi. Infatti, ad esempio, i pesticidi chirali vengono spesso somministrati come miscele racemiche alle piante e, mentre un enantiomero è attivo, l’altro può avere effetti sconosciuti sul corpo umano e potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per i consumatori. Pertanto, le informazioni sulla distribuzione chirale dei
composti naturali e di quelli aggiunti artificialmente possono aiutare a valutare la qualità e la tracciabilità degli alimenti. Questo lavoro si concentra sui risultati e le ricerche più rilevanti nel campo della cromatografia liquida chirale per valutare la sicurezza e la qualità degli alimenti, in seguito al successo delle precedenti revisioni pubblicate su questo argomento. Per evitare sovrapposizioni con i report precedenti, l’analisi copre gli ultimi tre anni (2020-2023).
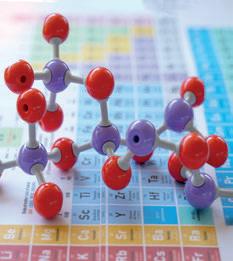


Diletta Gaggia
RISTORAZIONE, IL VALORE DEL MADE IN ITALY
LA RISTORAZIONE COLLETTIVA RIVESTE OGGI UN RUOLO SIGNIFICATIVO NELLE SOCIETÀ MODERNE, NON SOLO COME FORNITURA DI PASTI, MA SOPRATTUTTO COME PROMOZIONE DI SALUTE, SICUREZZA, BENESSERE E SOSTENIBILITÀ
La ristorazione e l’ospitalità rappresentano l’ultima fase della filiera alimentare, quella che impatta direttamente sui consumatori. Le sfide attuali della ristorazione collettiva sono numerose e variegate, spesso influenzate da cambiamenti globali, tendenze culturali, tecnologiche e ambientali che diventano sempre più complesse nell’ottica delle tensioni geopolitiche che influenzano fortemente i mercati alimentari.
La ristorazione collettiva riveste oggi un ruolo significativo nelle società moderne, non solo come fornitura di pasti, ma soprattutto come promozione di salute, sicurezza, benessere e sostenibilità, non solo un mezzo per fornire cibo, ma un servizio complesso che interagisce con aspetti sociali, economici, educativi e ambientali nelle società moderne. Il suo impatto va ben oltre la semplice alimentazione, influenzando la salute pubblica, l’educazione, la sostenibilità e l’economia, con attenzione alla prevenzione e riduzione dello spreco.
IL CIBO È LA PRIMA RICCHEZZA
DEL
NOSTRO PAESE
La filiera agroalimentare italiana occupa 4 milioni di lavoratori in 740 mila aziende agricole, 60 mila imprese di produzione, 330 mila imprese di ristorazione e 230 mila punti vendita al dettaglio. Questi sono alcuni dei dati presentati da Massimo Artorige Giubilesi , Presidente OTALL, durante l’edizione 2024 di AlimentiPiù, convegno digitale di scienza e tecnologia alimentare.
La filiera genera un fatturato di 607 miliardi di euro, pari al 31,8% del PIL nazionale. Mentre i consumi alimentari valgono in Europa 1.541 mld di euro, per il 64,2% nel canale domestico e per il 35,8% nella ristorazione con 552 mld di euro.
L’export agroalimentare è principalmente diretto in Francia (+14%), Germania (+11%) e Gran Bretagna (+11%), arretrando leggermente per la prima volta negli Stati Uniti (-3%).
Un record trainato da un’agricoltura che è la più green d’Europa con 80 mila operatori del biologico, il maggior numero di specialità DOP/IGP/STG riconosciute (325 per l’esattezza).
“Questa rete non può che essere alimentata, sostenuta e valorizzata soprattutto dalle persone, dagli specialisti, dai consulenti, da tutti i lavoratori qualificati a vario titolo nella filiera e tra questi ci sono sicuramente i Tecnologi Alimentari”, sottolinea Giubilesi.
RISTORAZIONE COLLETTIVA
6,5 miliardi di euro di fatturato. 1,5 miliardi di pasti serviti ogni anno. 1.200 aziende.
100.000 occupati, di cui 85% donne.
34% sanità (ospedali, cliniche, RSA).
35% scuola.
31% aziende.
FOTOGRAFIA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
L’industria alimentare è ormai la prima manifattura del Paese con 180 miliardi di euro di fatturato annuo, 60 mila aziende, 464 mila addetti e oltre 50 miliardi di export in valore. Soltanto nell’ultimo decennio il comparto ha messo a segno un aumento del fatturato del 24,7%, che ha portato con sé anche un incremento dell’occupazione del 12,2%. L’industria alimentare italiana dà un poderoso contributo al Paese, sia come valore economico sia come valore sociale: il settore è uno dei più dinamici e robusti dell’industria italiana ed è consapevole di rappresentare un patrimonio nazionale nella produzione di alimenti di qualità, unici e con marchi riconoscibili. (Fonte: Rapporto Federalimentare-CENSIS 2023)
FOTOGRAFIA DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE
La spesa delle famiglie italiane nella ristorazione è risalita a circa 82 miliardi di euro, trainato anche dal turismo internazionale, mentre il valore aggiunto del settore ha superato nel 2022 i 43 miliardi di euro. (Fonte: FIPE 2023)
Il mercato dell’ospitalità, secondo il Rapporto Deloitte-Federturismo 2024, evidenzia un fatturato del settore di 30,5 mld di euro, collocandosi al primo posto in Europa. L’e-commerce di cibo vale in Italia 4,7 miliardi di euro e il food delivery pesa per il 44%.
LA FOOD EXPERIENCE NELLA RISTORAZIONE: CASE 1
“Questo approccio globale ci permette di essere in contatto costante con colleghi da tutto il mondo per scambiarci buone pratiche”, esordisce così Roberta Delmiglio, Food Intelligence Manager presso Sodexo, realtà globale presente in 45 Paesi.
“La sicurezza alimentare è da sempre parte integrante del nostro fare quotidiano”: filosofia che la dott.ssa Delmiglio applica

all’interno del team “food intelligence” di cui fa parte. Un team multidisciplinare che, comprendendo dietisti, tecnologi alimentari, cuochi e nutrizioni, permette di prendere in considerazioni tutti i vari aspetti che legano i processi produttivi. Il team, in collaborazione con l’ufficio acquisti, lavora sul prodotto, testandolo e analizzandolo prima di inserirlo all’interno del menù o utilizzarlo come ingrediente nelle ricette a firma Sodexo. Nel 2024 l’attività è stata certificata dalla norma UNI 11584:2021, la quale regolamenta il processo di elaborazione dei menù della ristorazione collettiva, prendendo in considerazione diversi aspetti come la comunicazione al consumatore, l’utilizzo di marchi di qualità, i valori nutrizionali e la riduzione degli scarti.
RISTORAZIONE COLLETTIVA
E SOCIOSANITARIA: CASE 2
“Il 63% della ristorazione collettiva in Italia deriva da appalti pubblici, che vedono delle centrali di acquisto ricoprire il ruolo di intermediari nell’individuazione dei fornitori”, esordisce Laura Cuni, responsabile dell’Ufficio Gare Marketing di Serenissima Ristorazione, realtà italiana con un fatturato consolidato di 540 milioni di euro. “La
vera sfida delle società di ristorazione”, secondo Laura Cuni, “è riuscire a rimanere sul mercato, perché, in questo momento, la marginalità del settore è veramente ridotta al minimo a causa delle attuali regole”.
Per questo motivo Serenissima Ristorazione ha lavorato a un cambio di paradigma: ristorazione 5.0, in cui l’innovazione tecnologia e digitale si integrano con la flessibilità umana, utilizzando un approccio ESG. La sostenibilità è ormai imprescindibile nel settore della ristorazione collettiva, “la nostra risposta è il ‘cook & chill’, un trattamento che permette a tutti i prodotti di conservare le caratteristiche igienico-sanitarie e organolettiche”, spiega la dott.ssa Cuni. Utilizzo di una cucina sperimentale permette di testare e regolamentare tutte le materie prime. Ad esempio, in ambito sicurezza igienico-sanitaria, “all’interno del nostro centro abbiamo una camera bianca che, studiata per i degenti immunodepressi o ricoverati in reparti critici, rende sterile tutto il materiale e il prodotto che viene confezionato. Questo garantisce quindi una totale igienicità del pasto e garantisce una completa sicurezza del degente per il consumo”.

a cura della Redazione
L’APERITIVO E I VEGETALI CONSERVATI SOTTOLIO
UNIONE ITALIANA FOOD PRESENTA I DATI DI UNO STUDIO CONDOTTO DA ASTRARICERCHE CHE INDAGA LE ABITUDINI DI CONSUMO, TREND E CURIOSITÀ
Dall’aperitivo all’apericena, la parola d’ordine per gli italiani è “ritagliarsi del tempo”. Per 2 italiani su 3 un rito irrinunciabile come minimo una volta al mese; un’abitudine radicata, soprattutto tra i più giovani, con oltre il 50% degli intervistati che si concede un aperitivo almeno 2 volte al mese. Fare un aperitivo non significa solo uscire: gli italiani apprezzano concedersi questo momento anche a casa propria o di altri; infatti, in 3,5 casi su 10 l’aperitivo è organizzato fra le mura domestiche. “I dati Nielsen del 2024 mostrano chiaramente come questi prodotti continuino a essere una scelta vincente per chi cerca soluzioni saporite e funzionali. Rispetto al 2023, infatti, lo scorso anno il comparto ha venduto nel segmento del retail 178.839 tonnellate (+1,3%) generando un valore di 1 miliardo di euro (+3,7%)”, afferma Stefano Pucci, Produttore e Presidente del Gruppo sottoli, sottaceti e salamoia di Unione Italiana Food.
APERITIVO ALL’ITALIANA
Classico all’italiana, con salumi, formaggi, bruschette, sottoli e sottaceti: è questo

l’aperitivo più amato (83,5%). Il 75,3% degli italiani preferisce un aperitivo vario, con assaggi differenti, e il 67,9% apprezza proposte che includano anche una varietà di alimenti, tra cui le verdure, in linea con i trend legati a un’alimentazione equilibrata e salutare.
In oltre 9 casi su 10, infatti, gli italiani consumano vegetali sottolio, sottaceto o in salamoia in accompagnamento agli altri prodotti offerti durante l’aperitivo; a preferire maggiormente questi prodotti sono soprattutto le donne Millennials e le famiglie con 4 o più componenti, specialmente con minorenni.
Nello specifico, per l’89,4% di questi, la proposta di questi vegetali tra l’offerta
dell’aperitivo è ampiamente gradita e per il 29,4% è addirittura importante.
SOTTOLIO, SOTTACETO E SALAMOIA
Se c’è un vincitore tra i vegetali sottolio, sottaceto, in agrodolce o in salamoia più consumati durante l’aperitivo, le olive conquistano sicuramente il podio con il 72% delle preferenze; seguono i pomodori secchi con il 45,3% e le cipolle e i cipollotti con il 40,5%. Fanno parte di questa sfiziosa classifica anche i carciofini (39,6%), i funghi (38,7%), le melanzane (34,7%), i cetrioli (30,7%), i peperoni (30,7%), le zucchine (23,9%) e le carote (22,4%).
I vegetali conservati sono sempre più protagonisti dell’aperitivo non solo perché gustosi e stuzzicanti, come dichiarato dal 44,1% degli intervistati, ma anche perché si prestano facilmente a vari abbinamenti (36,7%), creano un contrasto di sapori (35,1%) e si sposano bene con le bevande consumate durante l’aperitivo (28,5%).
Senza dimenticare le varie proprietà benefiche in termini di basso apporto calorico, proprietà nutrizionali e digeribilità, oltre che la possibilità di poter consumare anche verdure non di stagione.

a cura della Redazione
RISTORAZIONE, MODESTO INCREMENTO DELLA SPESA
LE NORMATIVE PIÙ SEVERE SULLA GUIDA E IL CONSUMO DI ALCOL HANNO AVUTO UN IMPATTO
NEGATIVO SULLE VENDITE DI BIRRA E LIQUORI NEL CANALE ALL’INGROSSO REGISTRANDO UN CALO
RISPETTIVAMENTE DEL -8,6% E DEL -8,0%
Circana Group riporta che l’industria della ristorazione in Europa ha chiuso il 1° trimestre del 2025 in un contesto complesso e volatile caratterizzato dall’aumento dei costi, dall’incertezza economica e dal cambiamento del comportamento dei consumatori.
Sulla base dei dati del panel di consumatori CREST® di Circana, il traffico della ristorazione europea è diminuito del -1% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre la spesa dei consumatori è cresciuta del +1% nonostante il minor numero di visite, trainata da un aumento della spesa media individuale.
Edurne Uranga, VP Foodservice EMEA di Circana, ha dichiarato: “Il settore sta diventando più competitivo ma osserviamo fattori di crescita comuni in Europa che aiutano a compensare parzialmente la diminuzione di traffico e che saranno opportunità di crescita per coloro che ne trarranno vantaggio”:
§ i canali digitali, incluso il Click&Collect e il delivery tramite internet o App,
rappresentano il 7% del traffico totale e crescono del +7%;
§ le cene hanno performato meglio del mercato e sono cresciute del +1%;
§ il 42% delle occasioni nella ristorazione ha incluso almeno una promozione e queste sono cresciute del +2%;
§ il ritorno progressivo in ufficio e alla didattica in presenza ha contribuito a un aumento del traffico del +0,3% nelle mense aziendali e scolastiche.
Il consumo fuori casa ha subito un progressivo rallentamento negli ultimi mesi. Nel primo trimestre dell’anno le visite sono diminuite del -0,7%, accompagnate da un forte comportamento di tradingdown. Le occasioni principali, come pranzo e cena, hanno registrato un calo del -1,5% mentre le occasioni a spesa minore, come la colazione, hanno registrato una crescita positiva.
Matteo Figura, Foodservice Executive Director di Circana Italia, ha dichiarato: “Il consumatore seleziona attentamente le occasioni e i prodotti da consumare fuori casa. In generale, il numero medio di pro-

dotti consumati è diminuito con conseguenti tendenze negative nei componenti accessori come contorni e bevande. Crescono solo i prodotti a basso costo come il caffè, i prodotti da forno e gli snack dolci”. Il primo trimestre dell’anno ha risentito anche delle misure più restrittive imposte dal nuovo codice della strada introdotto a dicembre riguardo guida e consumo di alcol. Le vendite di bevande all’ingrosso registrano un trend negativo in volume per la categoria totale del -4,0% nell’YTD febbraio, trainato da birra (-8,6%) e liquori (-8,0%).

CALANO GLI INVESTIMENTI, MA CRESCE IL NUMERO DI STARTUP a cura della Redazione
L’AGRIFOODTECH IN ITALIA
Il settore AgriFoodTech italiano sta attraversando una fase di trasformazione: mentre gli investimenti subiscono una flessione del 38% rispetto all’anno precedente, cresce il numero di startup, in aumento rispetto al 2023. È quanto emerge dal nuovo Report sullo Stato dell’AgriFoodTech in Italia elaborato da Eatable Adventures per il Verona Agrifood Innovation Hub.
Nel 2024, gli investimenti si sono fermati a 103 milioni di euro, segnando un netto calo rispetto ai livelli record dell’anno precedente. Questo dato riflette una generale contrazione nei grandi round di finanziamento e una maggiore cautela da parte degli investitori. Un calo in linea con il panorama globale ed europeo che subiscono pari merito una contrazione, anche se meno marcata rispetto allo scenario italiano, del 7% a livello mondiale e del 19% in Europa.
Con 407 startup attive, in aumento rispetto alle 341 del 2023, e un focus crescente su tecnologie avanzate come Intelligenza Artificiale, Biotecnologie e IoT, l’AgriFoodTech italiano si conferma terreno fertile per innovazione e sostenibilità.
Segnali di resilienza e un potenziale tecnologico ancora inespresso suggeriscono che il settore può ambire a un ruolo di rilievo sul panorama globale.
DOVE NASCONO LE STARTUP ITALIANE?
Secondo le analisi di VAIH, le startup AgriFoodTech italiane sono concentrate prevalentemente nel Nord Italia, che ospita il 50% delle realtà attive: Lombardia (31%), Piemonte (10%) e Veneto (9,7%) sono in classifica insieme a Emilia-Romagna (11%) e Lazio (9,7%). Al contrario, il Sud Italia fatica a emergere nonostante il suo notevole potenziale agricolo, rivelandosi un ecosistema imprenditoriale ancora poco sviluppato. I fondatori italiani di startup nell’AgriFoodTech si distinguono per un solido bagaglio accademico e tecnologico: il 38% possiede un dottorato di ricerca, mentre circa il 30% ha conseguito una laurea magistrale o un master. Il settore è guidato principalmente da founder con esperienze pregresse nell’imprenditoria (60%) e nell’agroali-
mentare (60%), un vantaggio che permette di affrontare meglio le sfide e di cogliere le opportunità del mercato. Il 73% delle nuove realtà innovative viene lanciato da imprenditori tra i 25 e i 45 anni, mentre solo il 6% riesce a lanciare un’attività prima dei 25 e dopo i 56 anni.
L’ecosistema italiano, dunque, possiede un potenziale straordinario, ma per garantire una crescita sostenibile e decisiva, è fondamentale attrarre e formare nuove generazioni di talenti, così da infondere nuova linfa vitale all’ecosistema.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BIOTECNOLOGIE E IOT
Le startup italiane si concentrano principalmente nei settori della produzione e trasformazione alimentare e dell’AgriTech,
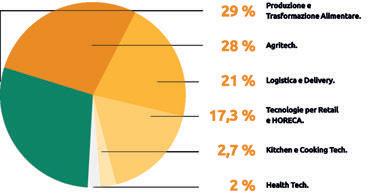

che insieme rappresentano oltre la metà delle attività. In particolare, nell’AgriTech automazione e robotica delle colture (38%) e nuovi sistemi di coltivazione (29%) guidano l’innovazione, mentre nella produzione e trasformazione alimentare l’attenzione è rivolta a prodotti innovativi (44%) e nuovi modelli di economia circolare (20,8%).
Tra i settori in crescita spiccano Logistica e Delivery (21%) – che mostra una forte centralità della categoria delivery&last mile (45%) e packaging (21%) –, seguiti da Retail e Horeca (17%), tecnologie per la Cucina e la Preparazione alimentare (3%) e, infine, Health Tech (2%) di cui fanno parte tecnologie per la nutrizione e la nutraceutica.
Il 77% delle startup sviluppa le tecnologie in-house, con l’intelligenza artificiale al primo posto (43%) per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi settori, seguita da Biotecnologie (32%) e piattaforme digitali (30%). Tuttavia, solo il 15% delle innovazioni deriva da collaborazioni con università, evidenziando la necessità di rafforzare le sinergie tra ricerca accademica e imprenditorialità.
INCLUSIVITÀ E SCALABILITÀ:
LE GRANDI SFIDE DEL FUTURO
Nonostante la crescita del numero di startup il report evidenzia alcune criticità: prima fra tutte una contrazione del numero di dipendenti pari al 27% (2995 ri-
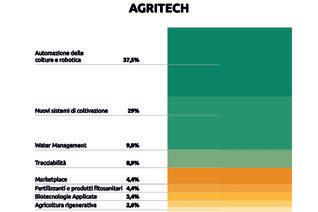
sorse impiegate) dovuta principalmente alla chiusura di realtà nella fase di scaleup e a team di lavoro piccoli.
I grandi round di investimento, superiori a un milione di euro, so no in calo, mentre aumentano i round più piccoli, fino a 350.000 euro (nel 60% dei casi) e i cosiddetti “round mezzanini”. Questa tendenza riflette un approccio più prudente e strategico da parte degli investitori, influenzato anche dall’incertezza macroeconomica globale.
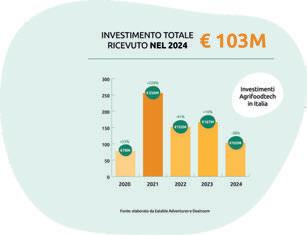
Cresce l’attenzione verso i progetti in fase pre-seed e seed, caratterizzati da requisiti di capitale più modesti e minore rischio per gli investitori.
Attualmente, il 58% delle startup AgriFoodTech si trova nella fase seed, un aumento del 15% rispetto al 2023. Tuttavia, molte di queste realtà faticano a superare le fasi iniziali di sviluppo, e solo il 2,3% raggiunge la fase Serie B o successiva, evidenziando difficoltà nel processo di scalabilità.
Inclusività ancora lontana dall’essere raggiunta. Infatti, solo il 23% delle startup è fondato da donne, e il 36% dei team è
composto da quote femminili. Questi dati evidenziano la necessità di promuovere una maggiore inclusività e diversità nel panorama imprenditoriale italiano. “Nonostante le sfide, l’ecosistema italiano ha tutte le risorse per affermarsi come leader globale dell’AgriFoodtech Made in Italy. La chiave è adottare un approccio sempre più Open all’innovazione, consolidando sinergie tra industria, università e startup. Rafforzare queste reti è essenziale per garantire un futuro più innovativo e sostenibile, attraendo e formando nuovi talenti, incentivando l’inclusività e creando un legame tra mondo accademico e imprenditoriale, così da infondere nuova linfa vitale all’ecosistema italiano”, commenta Alberto Barbari, Regional VP Italy di Eatable Adventures.

Biagio Calcavecchia
Senior Food Technologist www.officinalimentare.it
Valentina Vasta
Tecnologa alimentare consulente iscritta all’Ordine OTA
INNOVAZIONI NELLA DISIDRATAZIONE DEGLI ALIMENTI
La disidratazione è un metodo utilizzato da migliaia di anni per conservare gli alimenti. Con l’avvento dell’era industriale anche questo metodo ha beneficiato di notevoli miglioramenti, eppure i progressi non sono ancora finiti. Il metodo che presentiamo in questo articolo combina la tecnologia del vuoto con la trasmissione del calore tramite onde elet tromagnetiche, tecniche studiate in precedenza ma separatamente. Il vuoto, infatti, consente di abbassare la temperatura di evaporazione, come già ampiamente usato nelle boule di concentrazione. Le onde elettromagnetiche riescono a fornire energia per far evaporare dell’acqua senza incontrare ostacoli come quando il calore viene fornito per conduzione o convezione di aria calda. Inoltre, siccome le onde elettromagnetiche scaldano agendo sulle molecole dipolari come l’acqua, la matrice già secca non è sottoposta a inutile e dannoso riscaldamento. Oltre a ciò lo spessore non è più molto importante, come pure la sua uni-
formità, sia perché lo strato essiccato non rappresenta un ostacolo alla trasmissione del calore, ma soprattutto perché l’energia arriva in modo selettivo solo dove c’è acqua. Questa alta efficienza si traduce in rapidità di disidratazione, possibilità di effettuare il processo a basse temperature, per la preservazione ottimale delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e delle sostanze nutraceutiche termolabili, come per esempio richiesto per i Raw Food. Altra caratteristica peculiare è la possibilità di ridurre la carica microbica modulando la temperatura e il vuoto, ragion per cui durante la disidratazione si può abbattere la contaminazione naturalmente presente in molte matrici alimentari. L’impianto che consente di realizzare questo processo è stato concepito, progettato e realizzato da pochi anni mentre il primo impianto industriale è stato ultimato solamente pochi mesi fa (Foto 1).
Proprio per la giovinezza di questo metodo i benefici appena enunciati sono ancora da studiare approfonditamente: in questo ar-
ticolo saranno presentati i primi risultati di alcune prove sperimentali preliminari.
MATERIALI E METODI
Per tutte le prove di disidratazione sottovuoto a bassa temperatura è stato impiegato un impianto pilota con un cella nella quale vengono introdotti due vassoi forati con il prodotto da disidratare (Foto 2-4).
Per ridurre al minimo il decadimento del prodotto fresco non disidratato (soprattutto per preservare il contenuto di acido ascorbico), i campioni sono stati prelevati poco prima dell’avvio della disidratazione, confezionati sottovuoto e conservati in frigorifero. Inoltre, per minimizzare il tempo prima delle analisi, tutti i campioni sono stati trasportati refrigerati al laboratorio d’analisi immediatamente, così che le analisi iniziassero entro 24 ore.
Le matrici alimentari sono state scelte in base all’alto contenuto di acido ascorbico e polifenoli, mentre la contaminazione batterica è stata artificialmente aumentata immer-

gendo i prodotti in soluzioni di colture microbiche usate in agricoltura per rivitalizzare il suolo (Preparato 500, detto anche cornoletame, Coltura madre Braun e Original), e inoculando una coltura di Listeria innocua. La cubettatura delle matrici è stata eseguita manualmente pertanto i singoli pezzi non sono uniformi.
RISULTATI
In questo articolo condividiamo i risultati di tre prove.
PRIMA PROVA
Disidratazione di kiwi cubettato eseguita in parallelo: con aria calda ventilata e con la tecnologia sottovuoto a bassa temperatura.
Preparazione
e processamento
Dalla totalità dei kiwi sbucciati e cubettati sono state generate 3 aliquote per quanto possibile omogenee:
§ 1 campione confezionato immediatamente in busta sottovuoto e posto in frigo a 4°C.
§ 1 campione dosato su un vassoio di plastica col fondo forellato di cm 36x56cm, spessore 25-30 mm, per l’essicazione a bassa temperatura sottovuoto.
§ 1 campione suddiviso su 4 vassoietti con base forellata, per l’essiccazione con aria calda ventilata.
La disidratazione sottovuoto è durata 4 ore applicando questi parametri:
- 40°C (temperatura max del prodotto con sonda inserita al centro dello strato).
- 30 mbar (pressione all’interno del cabinet).
- 2000 W potenza iniziale (con riduzione automatica fino a valore finale di 500 W).
La disidratazione con aria calda ventilata è stata eseguita con un piccolo essiccatore semiprofessionale impiegando 16 ore:
- 70°C per 6 ore;
- 40°C per 10 ore.
Risultati
Nella Tabella 1 sono riassunti i risultati delle osservazioni interne e delle analisi di laboratorio esterne.
Cubettato fresco Disidratato sottovuoto Essiccato con aria calda ventilata
Durata essiccazione (ore) 0 4 16
Odore tipico
Aspetto visivo
Umidità (%)
*Vitamina C (mg/kg)
*Polifenoli (mg/kg)
*Colore (assorbanza 407 nm)
Tipico del frutto maturo
Ben conservato Attenuato
Ben conservato Virato verso il giallo
*Si prega di notare che queste analisi di laboratorio dei prodotti essiccati sono state eseguite sui prodotti reidratati con una quantità d’acqua tale da ricreare l’umidità iniziale.
Tabella 1. Risultati delle osservazioni interne e delle analisi di laboratorio esterne
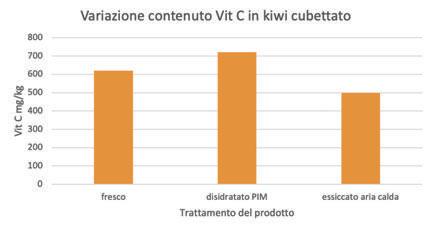


I risultati della vitamina C denotano che la disomogeneità intrinseca del prodotto non è stata completamente eliminata dall’attenzione posta nel creare campioni omogenei, oppure che la vitamina C nel campione fresco (nonostante sia stato confezionato sottovuoto e posto immediatamente in frigo) si sia degradata molto più velocemente che nel prodotto disidratato sottovuoto.
I polifenoli sono stati determinati con metodo spettrofotometrico sul liquido centrifugato, in modo da minimizzare le interferenze della polpa. Il contenuto di Polifenoli è più alto nel campione disidratato sottovuoto, probabilmente per le stesse ragioni addotte per la vitamina C. Il colore è stato determinato misurando l’assorbanza a diverse lunghezze d’onda. Anche in questo caso la polpa può influire sulla misurazione.
Nel grafico, per esemplificare il confronto, è stato indicato il valore medio del range del colore complementare gialloverde. Notare bene che, trattandosi di colore complementare, a un valore più basso corrisponde un colore giallo-verde più intenso.
SECONDA PROVA
Valutazione dell’abbattimento della carica microbica, in basilico fresco contaminato con Preparato 500, mediante disidratazione sottovuoto con oscillazione di vuoto.
Preparazione
Il basilico è stato processato subito dopo la raccolta. È stato privato dei gambi più coriacei e una parte è stata immersa in una soluzione di Preparato 500 e poi centrifugato per rimuovere l’eccesso d’acqua. 1 campione è stato confezionato immediatamente in busta sottovuoto e posto in frigo a 4°C. Mentre un secondo campione è stato dosato su un vassoio di plastica col fondo forellato di cm 36x56cm, spessore dello strato di basilico 25-30 mm.
Il basilico nel vassoio è stato disidratato
Grafico 2
Grafico 3
Grafico 1
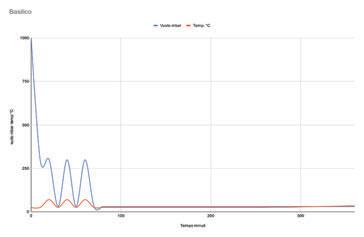
in 6 ore applicando 3 cicli di oscillazione di vuoto (300 mbar – 33 mbar corrispondenti a 70°C - 35°C) nell’arco di 36 minuti, poi si è completata la disidratazione a vuoto costante di 33 mbar (max 35°C). Potenza erogata = 0,2 kw per kg di prodotto fresco.
Il Grafico 4 illustra i parametri dell’intero processo di disidratazione.
Risultati
Sul basilico disidratato sono state eseguite analisi chimiche e microbiologiche i cui risultati sono riassunti nelle Tabelle 2 e 3.

TERZA PROVA
Valutazione dell’abbattimento della carica microbica e della Listeria in radicchio fresco, contaminato con Preparato 500 e Listeria innocua, mediante disidratazione sottovuoto con repentine oscillazioni di vuoto.
Preparazione
Il radicchio è stato tagliuzzato, messo a bagno in una soluzione di Preparato 500 e poi centrifugato per rimuovere l’eccesso d’acqua. La soluzione per la contaminazione è stata preparata sciogliendo 100 g di Preparato 500 in 1 litro di acqua non clorata.
L’inoculo della Listeria innocua è stato eseguito direttamente dal laboratorio d’analisi.
Il prodotto è stato distribuito su 2 vassoi in PP di cm 60 x 40 x 14. A seguire il test di disidratazione è stato eseguito a pieno carico con 6 kg di radicchio ed è durato 4 ore.
All’inizio del processo di disidratazione sono stati eseguiti 3 cicli così articolati:
1. Il prodotto è stato portato a una temperatura di 75°C (pressione 800 mbar) senza estrazione di vapore acqueo. 2. Dopo 15 minuti in queste condizioni
N.B. è stato applicato un fattore 10:1 per tenere conto della concentrazione dovuta alla disidratazione
Tabella 2.
Tabella 3.
Grafico 4
Foto 1. Primo impianto industriale
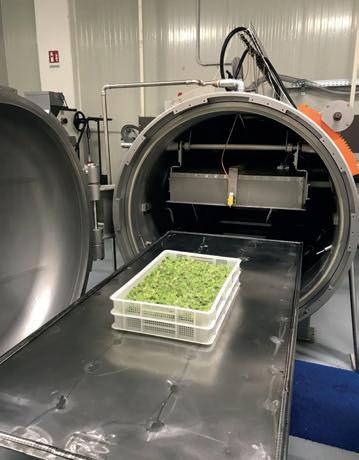
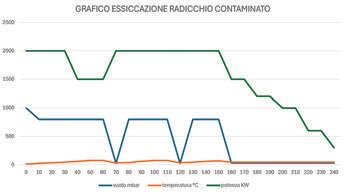
Grafico 5
Grafico 6
N.B. è stato applicato un fattore 10:1 per tenere conto della concentrazione dovuta alla disidratazione
Foto 2. Caricamento vassoi kiwi
Tabella 4. Analisi eseguite sul radicchio

la pressione è stata abbassata più velocemente possibile a 25 mbar (32°C).
3. Dopo 5 minuti in queste condizioni sono stati ripetuti i punti 1 e 2.
Dopo il terzo ciclo, il prodotto è stato mantenuto a 30 mbar (45°C) fino alla completa disidratazione. L’energia fornita inizialmente era 2000 W, poi è automaticamente diminuita fino a 300 W al termine del processo.
Umidità finale del prodotto: 13%.
In dettaglio i dati del processo sono illustrati nel Grafico 5.
Risultati
Le analisi eseguite sul radicchio sono riassunti nella Tabella 4.
COMMENTI E CONCLUSIONI
Le prove sperimentali qui presentate dimostrano che questa innovativa tecnologia può influire molto positivamente sulla qualità dei prodotti.
Per quanto riguarda la qualità del prodotto abbiamo visto che si ha una buona ritenzione delle molecole termolabili come l’acido Ascorbico e i Polifenoli. Un risultato che si avvicina molto alla liofilizzazione, ma con un processo ad alta capacità produttiva e con costi d’investimento e di gestione molto inferiori.
Modulando opportunamente i parametri di processo, è ragionevole aspettarsi che si possa abbassare in modo significativo la carica microbica, compreso i microrganismi patogeni (es. la Listeria), Per ottimizza-

re il processo e disporre di dati quantitativi certi su questa peculiare caratteristica è indispensabile effettuare ulteriori prove, utilizzando matrici di origine vegetale e animale oltre che altri tipi di patogeni (es. Salmonella, E. Coli, sporigeni).
Sono invece da considerare assolutamente certi l’ottimale conservazione delle caratteristiche sensoriali, anche nei prodotti termosensibili, e i notevoli benefici economici e ambientali, dovuti alla notevole riduzione del tempo di disidratazione e alla forte riduzione del consumo di energia (80% circa).
PROSPETTIVE D’IMPIEGO
Le tecnologie di disidratazione mild rappresentano un’opzione innovativa e sostenibile anche per la valorizzazione degli scarti dell’industria alimentare, nell’ottica dell’economia circolare. Questa innovativa tecnologia permette di preservare al meglio le proprietà nutrizionali, sensoriali e funzionali delle biomasse residuali, trasformandole in ingredienti ad alto valore aggiunto.
L’impiego della disidratazione sottovuoto a basse temperature consente di rendere stabili nel tempo i sottoprodotti agroalimentari e di renderli disponibili lungo la filiera per l’estrazione e l’impiego di composti bioattivi, fibre e proteine, riducendo gli sprechi e creando nuove opportunità per l’industria alimentare, cosmetica e nutraceutica, contribuendo così a una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse.
Foto 4. Pannello controllo processo
Foto 3. Interno impianto
COATING A BASE DI CELLULOSA MICRO-NANO FIBRILLATA

IN COLLABORAZIONE CON GSICA
Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO
DI RIVESTIMENTO DI CARTONCINI PER IL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Andrea Feroce1, Fabio Licciardello1, Luciano Piergiovanni2
1 Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, Via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia, Italy
2 CLS Providentia srl - Impresa Sociale, Via Don Volpi 10 21047 Saronno, Italy
La competizione tra materiali cellulosici e materiali plastici nel settore del confezionamento alimentare è sempre più aperta.
Attualmente, il 31% del mercato globale del packaging è rappresentato da imballaggi a base di carta e cartone (Deshwal et al., 2019), una proporzione in peso che li rende la principale soluzione di food packa-
ging a livello mondiale. Tuttavia, gli imballaggi in carta e cartone presentano limiti e criticità che non li rendono utilizzabili per qualsiasi alimento e in qualsiasi condizione, confinandoli in settori specifici come, ad esempio, quello degli alimenti secchi e con breve shelf life. I materiali cellulosici infatti, come noto, mostrano scarse proprietà di barriera ai gas, acqua e grassi e
sono suscettibili ad attacchi fungini. Quelli poi che provengono, anche solo in parte, dal riciclo possono contenere e permettere la migrazione negli alimenti di sostanze pericolose come le resine Polifluoroalchiliche (PFAs), gli idrocarburi degli oli minerali (MOH) o i bisfenoli (BPA, BPS, BPF).
Per quanto riguarda la migrazione degli idrocarburi aromatici (MOAH) e di quelli

saturi (MOSH) sono stati proposti stringenti limiti, specifici per il contatto con gli alimenti: in particolare, per i MOSH il limite è di 0,6 mg/kg di alimento, mentre per i MOAH è di 0,15 mg/kg (European Reccomendation 2017/84; Twenty-second German Regulation). Per migliorarne le proprietà e risolverne le criticità, i materiali cellulosici vengono spesso additivati con sostanze non cellulosiche, sono rivestiti con varie lacche sintetiche o combinati con film plastici o fogli sottili di alluminio. Questi trattamenti non solo riducono o prevengono la migrazione, ma migliorano anche le proprietà tecnologiche e funzionali degli imballaggi. Tuttavia, tutte queste tecnologie apportano componenti che non sono biodegradabili come la carta e rendono il processo di riciclo più difficile e complesso (Mujtaba et al., 2022). Fondamentalmente per queste ragioni, negli ultimi anni, è aumentato l’interesse verso i derivati della cellulosa
e i nanomateriali come la cellulosa micro/nano-fibrillata (M/NFC) e i micro/nano cristalli di cellulosa, per lo più applicati su carta e cartone con processi di rivestimento.
I DERIVATI DELLA CELLULOSA E I NANOMATERIALI
Il primo metodo per produrre cellulosa microfibrillata (MFC) dalla polpa di legno è stato sviluppato più di trent’anni fa da Herrick et al. (1983). Il metodo prevedeva l’applicazione di vari cicli di omogeneizzazione ad alta pressione su una sospensione diluita di fibre, al fine di rompere i legami e aprire la fibra di cellulosa, ottenendo micro e nano-fibrille di cellulosa. Successivamente, è stato dimostrato che un pretrattamento chimico o enzimatico della sospensione ne facilita la defibrillazione (Saito et al., 2009). Generalmente, i metodi convenzionali per rivestire carta e cartone con sospensioni di micro e nano-fibrille di cellulosa includono il rotocalco, la flessografia e il size press coating ed è stato dimostrato che questi metodi garantiscono un’applicazione uniforme del coating solo raggiungendo grammature piuttosto elevate (Lavoine et al., 2011). Più recentemente sono stati investigati altri metodi, come lo spray coating e il foam coating, ottenendo risultati promettenti, legati a un’applicazione più sottile e omogenea. Lo studio qui presentato si è proposto di utilizzare un coating a base di micro-nano fibrille di cellulosa come alternativa sostenibile ai rivestimenti sintetici, con l’obiettivo di ottimizzare il metodo di applicazione su carta e cartone. La ricerca ha confrontato il metodo convenzionale di bar coating, simulante del sistema rotocalco, con un metodo più innovativo, quale lo spray coating, con l’obiettivo di limitare
Gli imballaggi in carta e cartone presentano limiti e criticità che non li rendono utilizzabili per qualsiasi alimento e in qualsiasi condizione
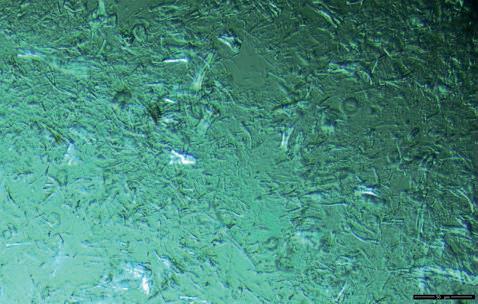
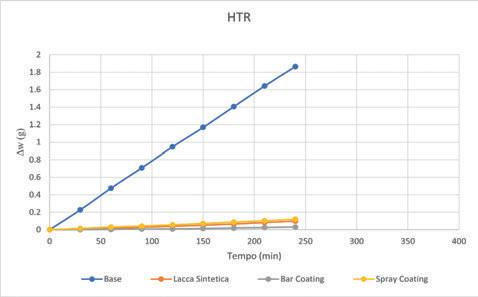
la migrazione di idrocarburi degli oli minerali (MOH) e migliorare la resistenza ai grassi. La sospensione acquosa di micronano cellulosa (M/NFC) è stata fornita da CLS Providentia srl, Impresa Socia-
le (PMI Innovativa di Saronno, MI). Per la sua produzione è stata utilizzata una biomassa contenente il 51% di cellulosa (principale sottoprodotto di una filiera alimentare) e altri ingredienti naturali per
stabilizzare la sospensione e migliorare le proprietà filmogene. La defibrillazione è stata ottenuta, dopo opportuno pretrattamento, attraverso vari cicli di omogenizzazione ad alta pressione (>1000 bar), a temperatura controllata. Prima dell’applicazione su cartoncini commerciali la sospensione è stata osservata al microscopio ottico per verificare la presenza e la morfologia delle micro-fibrille (Figura 1) e caratterizzata misurando il pH, la sostanza secca, il rapporto tra MFC/ NFC, la dimensione delle particelle e la viscosità della sospensione. Successivamente, per ottimizzare il metodo di applicazione della sospensione, sono stati utilizzati due disegni fattoriali LF con tre livelli e due fattori, uno per ogni metodo di applicazione del coating (bar coating e spray coating). Come variabili indipendenti (fattori) sono stati scelti, per il bar coating: i) lo spessore di film trasferito dalle barre dell’applicatore automatico (wet film) (38.1, 63.5 e 101.6 µm ) e ii) la velocità di movimento delle barre (1, 3 e 5 m/min), mentre per lo spray coating: i ) la velocità di avanzamento del cartoncino sotto il dispositivo spraizzante (15, 30 e 45 m/min ) e ii) la pressione dell’ugello diffusore della sospensione (1.5, 2.5 e 3.5 bar). Dopo il trattamento i campioni di cartoncino sono stati asciugati in stufa a 60°C per 1 h e poi posti per 24 h a temperatura ambiente prima di effettuare le analisi. Per ogni condizione sperimentale considerata, al fine di determinare la migliore, è stata misurata la grammatura del coating, la resistenza ai grassi attraverso il metodo TAPPI UM 557 (Kit Test) e valutata la barriera agli idrocarburi da oli minerali, misurando la trasmissione di n-eptano (HTR) in condizioni isostatiche e a 30°C. Sui campioni selezionati come migliori è stato poi valutato l’assorbimento dell’acqua attraverso il metodo ufficiale TAPPI T 441 Cobb Test (COB 500), il
Figura 1. Osservazione al microscopio ottico della sospensioni di micro e nano fibrille di cellulosa
Figura 2. Velocità di trasmissione dell’eptano (HTR) attraverso i cartoncini risultanti dai diversi trattamenti
valore dell’angolo di contatto dell’acqua e dell’olio di ricino ed è stata osservata la superficie del cartoncino tramite analisi SEM e AFM. I risultati hanno mostrato che il processo di omogenizzazione permette di produrre una corretta e uniforme defibrillazione, producendo un forte aumento della viscosità e un’alta concentrazione di nanofibrille ( ~ 72%), che depongono per una omogenea copertura della superficie del cartoncino. Si è osservato, inoltre, che nel caso del metodo convenzionale (bar coating/rotocalco) sono stati necessari due passaggi di sospensione per ottenere un rivestimento che permettesse di ottenere sia alti valori di Kit Test, per superare il valore generalmente considerato come sufficiente resistenza ai grassi (Adibi et. al., 2023), sia valori bassi di trasmissione del n-eptano (HTR) (Figura 2). Nel caso dello spray coating un singolo passaggio è stato sufficiente per ottenere una copertura omogenea in tutte le condizioni sperimentali testate, pur con una maggiore variabilità nei valori di Kit Test e HTR ottenuti. In termini di grammatura entrambi i metodi permettono di applicare una quantità simile ma a parità di grammatura, l’applicazione mediante spray coating minimizza lo spreco di prodotto, permette una copertura più omogenea e sembra più compatibile con i processi industriali. Con il supporto dell’analisi SEM abbiamo confermato che la tecnologia dello spray coating permette di ottenere una superficie più omogenea, informazione che è stata ulteriormente confermata anche dall’analisi AFM con la determinazione della rugosità del rivestimento. È stato osservato che nei campioni laccati mediante bar coating la superficie risultava essere più rugosa, probabilmente per accumuli di materiali in alcune zone rispetto ad altre, mentre i campioni trattati con lo spray coating avevano un valore di ru-
gosità persino più basso dei cartoncini tal quali. Dai valori dell’angolo di contatto abbiamo invece confermato l’ottima resistenza ai grassi, perché i cartoncini rivestiti hanno mostrato un aumento dell’angolo di contatto all’olio di ricino sia al tempo 0, sia dopo 5 secondi dalla deposizione della goccia. Per quanto riguarda i valori dell’angolo di contatto all’acqua, nonostante la sospensione sia a base acqua, non si è osservato un peggioramento nei valori ottenuti. In conclusione, si può affermare che la sospensione impiegata rappresenta un’utile soluzione per avviare una strategia green per migliorare alcune delle criticità legate alle soluzioni di packaging in carta e cartoncini e che entrambi i metodi di applicazione permettono di migliorare le caratteristiche del cartoncino base, aumentandone la resistenza ai grassi e la barriera verso gli idrocarburi degli oli minerali. Il metodo di spray coating, tuttavia, risulta essere più affidabile, determinare un minor impiego di sospensione e condurre a migliori risultati in termini di barriera ai contaminanti e resistenza ai grassi.
BIBLIOGRAFIA
§ Adibi, A., Trinh, B. M., & Mekonnen, T. H. (2023). Recent progress in sustainable barrier paper coating for food packaging applications. Progress in Organic Coatings, 181, 107566.
§ Deshwal, Gaurav Kr; Panjagari, Narender Raju; Alam, Tanweer (2019). An overview of paper and paper based food packaging materials: health safety and environmental concerns. Journal of Food Science and Technology, 56(10), 4391-4403.
§ European Commission. (2017). Commission Recommendation (EU) 2017/84 of 16 January 2017 on the monitoring of mineral oil hydrocarbons in food and in materials and articles intended to come into contact with food. Off J Eur Union, 12 (84), 95-96.
§ Herrick, F., Casebier, R., Hamilton, J. and Sandberg, K. (1983): Microfibrillated Cellulose: morphology and accessibility, J. Appl. Polym. Sci.: Appl. Polym. Symp., 37, 797-813 https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2023.107566
§ Lavoine, N., Desloges, I. and Bras, J. (2011): Impact of different coating processes of MFC on barrier and mechanical properties, J. Mater. Sci., 49 (7), 2879-2893.
§ Mujtaba, M., Lipponen, J., Ojanen, M., Puttonen, S., Vaittinen, H., 2022. Trends and challenges in the development of bio-based barrier coating materials for paper/ cardboard food packaging; a review. Sci. Total Environ. 851, 158328 https://doi. org/10.1016/j.scitotenv.2022.158328.
§ Saito, T., Hirota, M., Tamura, N., Kimura, S., Fukuzumi, H., Heux, L. and Isogai, A. (2009): Individualization of nano-sized plant cellulose fibrils by direct surface carboxylation using TEMPO catalyst under neutral conditions, Biomacromolecules, 10 (7), 1992-1996.
PFAS NEGLI ALIMENTI
SITUAZIONE E PROSPETTIVE

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono un vasto gruppo di sostanze chimiche di sintesi utilizzate per le loro proprietà di resistenza all’acqua, al grasso e alle macchie in prodotti come pentole antiaderenti, imballaggi per alimenti, indumenti idrorepellenti e schiume antincendio. Anche le sostanze attive contenute nei pesticidi possono essere costituite da PFAS.
UN RISCHIO PER SALUTE E AMBIENTE
L’uomo può venire esposto ai PFAS da fonti diverse, ad esempio tramite cibi, beni di consumo e anche l’ambiente. Queste sostanze possono, infatti, essere immesse nell’ambiente da impianti produttivi, discariche o impianti di trattamento delle acque reflue. Noti anche come “sostanze chimiche eterne”, i PFAS sono estremamente persistenti e, una volta introdotti nell’ambiente, resistono alla degradazione a lungo. Il fatto che questi composti possano permanere a lungo nell’ambiente aumenta la probabilità della loro presenza negli alimenti e solleva preoccupazioni circa il loro impatto a lungo termine sulla salute e sull’ambiente. Uno dei modi principali in cui i PFAS conta-
minano gli alimenti è il loro accumulo graduale in acqua, pesci, crostacei, piante e animali. Inoltre i PFAS possono migrare dalla lavorazione di alimenti e dai loro imballaggi. Le autorità pubbliche dell’UE e degli Stati membri stanno lavorando per rendere ancora più stringente la regolamentazione dei PFAS nell’UE e per ridurne la presenza nell’ambiente e nella filiera alimentare. L’obiettivo è mitigare le potenziali conseguenze a lungo termine sulla salute e sull’ambiente associate all’esposizione ai PFAS. Nel 2022 la Commissione ha emanato la Raccomandazione CE 2022/1431 che invita gli Stati membri a monitorare la presenza di PFAS negli alimenti dal 2022 al 2025. In particolare, come si ricorderà, nel provvedimento vengono elencate le sostanze che devono essere verificate, effettuando analisi dell’acqua potabile e di alimenti che rispecchiano le abitudini di consumo, quali: frutta, ortaggi, radici e tuberi amilacei, alghe marine, cereali, frutta a guscio, semi oleosi, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti di origine animale, bevande analcoliche, vino e birra.
La raccomandazione riporta i livelli indicativi per alcune categorie di prodotti,
Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Gaetano Forte
che, laddove vengano superati, fanno scattare ulteriori verifiche per individuare le cause della contaminazione.
PFAS E PPWR
Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation).
Si tratta di una normativa che rappresenta una vera e propria rivoluzione finalizzata ad ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale. Il provvedimento è figlio del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva. È un corpus composto da 188 considerando, 71 articoli e 12 allegati cui si aggiungeranno i numerosi regolamenti delegati e di esecuzione volti alla definizione delle singole prescrizioni
La finalità che si propone è, in particolare, quella di ridurre significativamente la produzione di rifiuti di imballaggio del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica.
L’applicazione del regolamento parte dal 12 agosto 2026 salve, come detto, le

diverse scadenze temporali ivi indicate. Tra i requisiti stringenti del nuovo regolamento Europeo sugli imballaggi PPWR, troviamo quello relativo ai PFAS.
Nell’articolo 5 del provvedimento, si legge che:
“5. A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:
a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 9), 11) e 13), del Regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento,
una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o nonPFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-). Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) n. 1935/2004, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 o del Regolamento (UE) 2019/1021”.
Come prescritto dal paragrafo 6 dell’art. 5 sopra citate “La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII” ossia in base alla procedura di valutazione della conformità. L’allegato VII intitolato “ Modulo A Controllo interno della produzione” afferma infatti che “1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili”. Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettuerà una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il paragrafo 5 sopra citato al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) n. 1935/2004, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 o del Regolamento (UE) 2019/1021.
CONCLUSIONI
I PFAS, noti come “sostanze chimiche permanenti” per la loro elevata persistenza nell’ambiente e nel corpo umano, sono da tempo nell’attenzione della Comunità europea che è intervenuta di recente sul tema, nell’ambito del Regolamento 40/2025/UE (PPWR) al fine di definire specifici limiti da rispettare per l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti.
PFAS: vasto gruppo di sostanze chimiche di sintesi utilizzate per le loro proprietà di resistenza all’acqua, al grasso e alle macchie in prodotti gli imballaggi per alimenti
ALIMENTI E ALLERGENI: ETICHETTE CHIARE PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
L’etichettatura alimentare gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e la trasparenza per i consumatori. Il Regolamento UE 1169/2011, insieme alla Linea guida del 13 luglio 2017 riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha introdotto norme più rigorose in materia di etichettatura, mirate a migliorare l’accessibilità delle informazioni alimentari e la protezione della salute pubblica.
Le nuove disposizioni includono requisiti dettagliati per l’indicazione di ingredienti, allergeni, valori nutrizionali e informazioni relative alla provenienza dei prodotti, con l’obiettivo di facilitare scelte alimentari più consapevoli e sicure per i consumatori. In particolare, il Regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che:
§ gli ingredienti allergenici siano chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti ed evidenziati con caratteri distintivi;
§ anche i prodotti non preimballati riportino indicazioni sugli allergeni;
§ gli ingredienti derivati da allergeni (come il glutine) siano specificati chiaramente.
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE E AMBIENTALE
L’etichettatura nutrizionale, obbligatoria per la maggior parte dei prodotti, deve riportare i valori energetici e i principali nutrienti. Cresce anche l’attenzione verso l’etichettatura ambientale, obbligatoria con l’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020 e fornisce informazioni sulla destinazione di raccolta e smaltimento rifiuti al consumatore.
L’UE attraverso emanazione di direttive comunitarie (es. 825/2024) e il nuovo reg. PPWR punta sempre di più alla sostenibilità dei packaging e alla corretta informazione sulle pratiche ambientali messe in atto dalle aziende e comunicate ai consumatori.
ANALISI DEGLI ALLERGENI NEI LABORATORI
PH DI TÜV ITALIA
I Laboratori pH di TÜV Italia, specializzati nella sicurezza alimentare, utilizzano metodologie accreditate ACCREDIA per analizzare allergeni e contaminazioni. Monitorano costantemente gli allergeni previsti dalla normativa, con tecniche avanzate come:
§ ELISA: test rapido per la rilevazione diretta delle proteine allergizzanti, con possibilità di falsi negativi o positivi in base ai trattamenti subiti dagli alimenti.

§ PCR Real-time (qPCR): identifica il DNA degli allergeni, riducendo il rischio di errori.
“La rilevazione e la quantificazione degli allergeni,” spiega Monica Filippini, Life Science Manager di TÜV Italia, Laboratori pH, “può essere effettuata direttamente tramite la tecnica ELISA, che ricerca la proteina allergizzante, oppure indirettamente con la PCR Real Time, che rileva la presenza di DNA dell’alimento allergizzante. L’utilizzo combinato o alternativo di queste tecniche dipende dal tipo di allergene da analizzare e dal risultato desiderato”.
TÜV ITALIA www.tuvsud.com
UN NUOVO STANDARD PER IL PACKAGING DOLCIARIO
ACMA, parte di Coesia, presenta ufficialmente CW 1400: la nuova macchina avvolgitrice ad alta velocità progettata per ridefinire gli standard del settore dolciario in termini di produttività, qualità e gestione sostenibile dei materiali. Con una velocità operativa che può raggiungere fino a 1.400 pezzi al minuto, la CW 1400 si propone come una soluzione ideale per la gestione di praline, cioccolatini e caramelle. Grazie alla sua versatilità, è in grado di trattare prodotti sia piatti che rotondi, adottando lo stile di confezionamento double twist oppure, nel caso di prodotti con base piana la variante protected double twist e bunch.
Particolare attenzione è stata dedicata alla conduzione della macchina, che avviene in maniera semplice e intuitiva, e alla manutenzione, grazie a un design a sbalzo che rende accessibili tutte le aree della macchina per ispezioni, pulizia e interventi tecnici. La struttura modulare semplifica le operazioni di manutenzione, riducendo i tempi di fermo macchina e aumentando la disponibilità operativa della linea. CW 1400 è inoltre equipaggiata con una funzione intelligente “No Product - No Wrapping”, che consente di evitare sprechi di materiale anche in condizioni di alta produttività.


CW 1400 si distingue anche per la sua forte integrazione digitale. La macchina è predisposta per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni produttive e include funzionalità di manutenzione predittiva supportate da strumenti avanzati basati su intelligenza artificiale. Tra le opzioni disponibili, è possibile integrare un sistema di visione con telecamere per l’ispezione qualità durante il processo e un modulo aggiuntivo con quarto rullo dotato di meccanismo di scarto selettivo.
CW 1400 nasce anche con un’attenzione particolare alla sostenibilità. È perfettamente compatibile con materiali di nuova generazione a base carta e solu-



zioni monomateriali, aiutando i produttori a rispondere alle richieste crescenti di un mercato sempre più attento all’impatto ambientale delle proprie linee di confezionamento.
ACMA www.acma.it
PROCESSING, PACKAGING E NUOVI MATERIALI
LA MANIFESTAZIONE, CONCLUSASI IL 30 MAGGIO DOPO
QUATTRO INTENSE GIORNATE DI BUSINESS, HA REGISTRATO UN INCREMENTO STRAORDINARIO RISPETTO ALL’ULTIMA EDIZIONE DEL 2022, SIA DI ESPOSITORI INTERNAZIONALI, PIÙ CHE RADDOPPIATI (OLTRE 400 AZIENDE), CHE DEI VISITATORI ESTERI (+51%), CONFERMANDO IL SUO RUOLO DI HUB STRATEGICO PER L’INNOVAZIONE INDUSTRIALE
IPACK-IMA 2025, l’evento internazionale che celebra l’arte dell’innovazione nelle tecnologie di processing, packaging e nuovi materiali, si è concluso il 30 maggio scorso. Fiera Milano ha ospitato oltre 1.300 espositori da 28 Paesi con una rappresentanza internazionale del 38%, e una forte presenza da Germania, Turchia, Olanda, Francia e Cina.
IL CENTRO DELL’INNOVAZIONE
Con 8 padiglioni su oltre 60.000 metri


quadri netti, IPACK-IMA ha presentato una panoramica dei trend e delle soluzioni tecnologiche più avanzate.
“Oggi celebriamo l’apertura di IPACK-IMA e Pharmintech, e con loro anche di un ecosistema dove tecnologie all’avanguardia, molte presentate qui in anteprima mondiale, incontrano visione strategica e concrete opportunità di business”, ha dichiarato all’inaugurazione Valerio Soli, Presidente di Ipack Ima. “È questo il luogo ideale per confrontarsi e orientarsi verso il
futuro, trasformando l’incontro in valore”. Più di 400 buyer selezionati da 63 Paesi saranno presenti in fiera, anche grazie alla collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, con India, Armenia, Cina, Messico ed Etiopia tra i mercati più rilevanti.
I principali settori rappresentati includono tecnologie indirizzate al Grain-Based Food (30%), Food, Fresh and Convenience (30%), End of Line (20%), Liquid Food and Beverage (15%) e Pharma & Chemicals (5%).
Diletta Gaggia

Focus sui temi cruciali: sostenibilità, digitalizzazione, intelligenza artificiale. Dalle smart factory alle soluzioni di cybersecurity, dalla food safety e food security al regolatorio
Oltre
1.300
espositori
da 28 Paesi
con una rappresentanza internazionale del 38%
IPACK-IMA COME PIATTAFORMA
STRATEGICA PER L’INDUSTRIA
Focus sui temi cruciali: sostenibilità, digitalizzazione, intelligenza artificiale. Dalle smart factory alle soluzioni di cybersecurity, dalla food safety e food security al regolatorio. In un contesto globale articolato, l’evento evidenzia le opportunità per evolversi e innovare.
“Siamo pronti a offrire un punto di riferimento sicuro in uno scenario macroeconomico complesso, dove l’innovazione è imprescindibile”, afferma Simone Castelli, CEO di Ipack Ima. “La forte adesione ha confermato la volontà dell’industria a
crescere e, grazie a collaborazioni solide e tecnologie all’avanguardia, puntiamo a uno sviluppo sostenibile e competitivo del settore”.
La joint venture con UCIMA e Fiera Milano unisce visione industriale e potenza fieristica, generando una piattaforma unica al servizio dell’innovazione. Sinergie di valore che amplificano la rilevanza e l’impatto della manifestazione a livello internazionale.
“IPACK-IMA”, dichiara Riccardo Cavanna, Presidente di Ucima, “è il punto d’incontro per un’industria che mette al centro persone, tecnologie e visione. Come UCIMA crediamo che la competitività passi oggi dalla capacità di integrare AI, sostenibilità e formazione in modelli industriali connessi”.
“Ipack-Ima è una piattaforma strategica per l’industria del packaging e processing, settore in cui l’Italia eccelle nel mondo. Come Fiera Milano, siamo orgogliosi di essere partner di un progetto che coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità e visione internazionale”, dichiara Roberto Foresti, Vicedirettore Generale di Fiera Milano.
LE NOVITÀ PRESENTATE IN FIERA

AETNA GROUP INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E AUTOMAZIONE AL CENTRO DELLA SCENA
Aetna Group, con uno stand di oltre 800 mq, ha presentato soluzioni all’avanguardia per il settore del packaging industriale e della logistica interna. Allo stand i visitatori hanno potuto scoprire una linea automatizzata progettata interamente dalla Business Unit Robopac Machinery, pensata per il segmento della bassa cadenza. Un settore che punta sempre più all’automazione e che, grazie alla proposta di Aetna Group, vedrà in azione un sistema completo che parte dalla formazione della scatola fino alla gestione a magazzino, offrendo un esempio concreto di innovazione tecnologica. Altra peculiarità di questa linea risiede nell’utilizzo di imballaggi sostenibili: le scatole vengono formate con nastro di carta e adesivi attivati ad acqua, e fino alla fasciatura del pallet tutto il processo impiega materiali cellulosici. Una soluzione che dimostra l’impegno di Aetna Group nel promuovere un’economia circolare e ridurre
l’impatto ambientale. A chiusura del ciclo, il compattatore ReCYCLE per l’invio a riciclo di materiali plastici e cellulosici, massimizzando il recupero di materia prima e contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse.
Presente presso lo stand anche un fine linea completo per il settore food, con soluzioni dedicate alle confezioni in banda stagnata con packaging secondario, palettizzazione robotizzata, fasciatura e logistica interna. Opera delle Business Unit Robopac Packers, OCME e Robopac Systems, impegnate da tempo in un progetto sinergico al servizio dei settori conserviero, petfood ma anche pastifici e bakery. Un’offerta in grado di adattarsi alle esigenze di velocità, formati e peculiarità di ogni segmento. Completa il perimetro dell’offerta l’incartonatrice Sotemapack WA20, specificamente studiata per trattare contenitori flessibili, in funzione allo stand con confezioni doypack di baby food.
AETNA GROUP www.aetnagroup.com
ELESA: INNOVAZIONE E SICUREZZA AL CENTRO DELLA SCENA
A Milano, Elesa ha esposto prodotti innovativi per l’industria delle macchine e delle attrezzature per il packaging e l’imbottigliamento, con un focus sulla sicurezza del confezionamento e il dialogo con il settore.
Presso il proprio stand, l’azienda ha proposto, accanto all’intera gamma, due nuove linee di prodotti per il settore:
§ I componenti per il vuoto, disponibili in diverse mescole (gomma antiolio, silicone, gomma naturale o gomma naturale gialla) e dimensioni, sono progettati per applicazioni ad alta precisione e si adattano a molteplici superfici (irregolari o oleose) e su film plastici per imballaggio. Una soluzione ideale capace di offrire affidabilità e performance in processi automatizzati.
§ La linea Visually detectable, realizzata in tecnopolimero idoneo al contatto con i cibi FDA approved (FDA CFR.21 e EU 10/2011) con inserti in acciaio INOX AISI 304. I componenti, studiati per garantire la massima sicurezza per le diverse preparazioni alimentari o farmaceutiche, si caratterizzano per il colore “Blu segnale” RAL 5005, che consente all’occhio umano di rilevare rapidamente eventuali frammenti o distacchi, riducendo il rischio di contaminazione sulla linea di produzione.
Oltre agli immancabili indicatori di posizione, anche elettronici ed elettronici wireless (senza cavi con trasmissione dati mediante radiofrequenza), unici nel loro genere, Elesa esporrà anche:
§ La Inox - stainless steel, una selezione di componenti in tecnopolimero con inserti in acciaio inox AISI 303, 304 o 316L, o interamente realizzati in acciaio inox, per

una elevata resistenza alla corrosione in ambienti critici.
§ Le maniglie ESC-SFT, con interruttore di sicurezza integrato con sensore a canali ridondanti, sono la scelta ideale per i circuiti di sicurezza che monitorano lo stato dei portelli pericolosi a bordo macchina anche in caso di porte scorrevoli.
ELESA
www.elesa.com
PICK, PACK & PALLET: IL PACKAGING SI FA SMART CON FANUC
Allo stand FANUC, i visitatori hanno toccato con mano la semplicità di utilizzo dei robot collaborativi CRX per il confezionamento e la pallettizzazione del fine linea e il pick and place super veloce e sicuro dei robot SCARA SR e Delta DR, con versioni food grade specifiche per l’utilizzo in ambito food processing.
“In questa occasione abbiamo presentato le nostre soluzioni per l’automazione dei processi delle linee di confezionamento e trasformazione dei prodotti alimentari, dimostrando come i nostri robot riescano a fare la differenza in termini di efficienza, facilità di utilizzo e di installazione e di sicurezza”, commenta Pier Paolo Parabiaghi, Sales Manager Robotics di FANUC Italia. “Senza dimenticare

il risparmio energetico, nell’ottica di una produzione sempre più sostenibile”.
L’azienda ha portato una cella di picking con robot SCARA con payload 6 kg e sistema di visione 3D integrato, che grazie al riconoscimento rapido degli oggetti rende più efficiente il pick and place del robot. Allo stand era operativa anche una cella di palletizzazione con cobot CRX con capacità di carico di 30 kg impegnata in operazioni di packaging secondario.
I robot collaborativi CRX di FANUC rappresentano la nuova frontiera dell’automazione per tutte le imprese, versatili e ideali per operare in sicurezza a fianco degli operatori in spazi condivisi. Picking, palletizzazione, etichettatura e controllo qualità sono operazioni che i cobot FANUC possono svolgere con la massima flessibilità, grazie anche a un ecosistema completo di accessori e pinze di presa per manipolare anche i prodotti più delicati. Disponibili in diverse taglie e modelli adatti all’utilizzo in camere bianche, i robot SCARA SR di FANUC si caratterizzano per un’estrema compattezza e campo di lavoro a 360°, che li rende ideali per l’impiego in linee a spazio ridotto. Inoltre, la facilità di programmazione tramite interfaccia web e la semplicità di integrazione agevolano l’installazione in applicazioni non solo di packaging, ma anche di assemblaggio e ispezione. Estremamente veloci e precisi, i robot Delta DR di FANUC sono perfetti per l’utilizzo nel confezionamento primario alimentare e per il picking secondario di piccoli pezzi. Dotati di protezione IP69K di serie e di un polso cavo in cui vengono instradati i cavi di servizio, questi robot dispongono di un design ricurvo con superfici lisce che agevolano i processi di pulizia, lubrificazione di livello alimentare e rivestimento epossidico bianco.
FANUC www.fanuc.eu
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA MOLITORIA
Omas Industries è un’azienda della provincia di Padova che da oltre 50 anni progetta e realizza soluzioni innovative per l’industria molitoria. Fornisce impianti tecnologicamente avanzati per la produzione di farine destinate a diversi settori con un approccio orientato a efficienza, flessibilità e sostenibilità.

La forte presenza internazionale di Omas Industries e la sua vocazione all’innovazione fanno di essa una delle realtà di punta nel settore industriale molitorio, presente a Ipack-Ima nel segmento pasta e bakery. In questa occasione, verrà presentata in anteprima mondiale la nuova versione del laminatoio Leonardo, che, dopo dieci anni di sviluppo, è oggi smart, flessibile, connesso e pronto a rispondere alle esigenze delle linee di produzione del futuro.
OMAS INDUSTRIES www.omasindustries.com

a cura della Redazione
TECNOLOGIE PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORARE LA SICUREZZA ALIMENTARE
Mettler-Toledo Ispezione Prodotti ha presentato le sue ultime innovazioni a IPACKIMA 2025. Alla fiera, Mettler-Toledo ha messo in evidenza una gamma di soluzioni di ispezione innovative progettate per ottimizzare i processi di produzione e mantenere i più elevati standard di sicurezza alimentare. Le soluzioni in evidenza includono:
- Sistema di ispezione a raggiX X52: offre un rilevamento ad alte prestazioni con modalità a energia singola e doppia, offrendo precisione nel rilevamento dei contaminanti a bassa densità garantendo standard di controlli elevati. Con una sensibilità ai vertici della categoria, l’X52 consente ai produttori di ridurre gli sprechi di prodotto, migliorare l’efficienza produttiva complessiva e contribuire ad aumentare la produttività.
- Metal detector serie R M34: un metal de-
tector di nuova generazione con tecnologia Dual-Simultaneous Frequency (DSF), che offre una sensibilità migliorata fino al 25% per il rilevamento di contaminanti in prodotti confezionati umidi in pellicola metallizzata. La sua costruzione modulare consente di sostituire o aggiornare facilmente le parti, il che significa adattabilità a lungo termine. Inoltre, soddisfa i severi requisiti di conformità dei rivenditori, riducendo il costo totale di proprietà e migliorando al contempo l’efficienza e i processi di sicurezza alimentare.
- Sistema di test automatico (ATS): progettato per applicazioni in verticale, l’ATS migliora il rilevamento dei metalli per prodotti in caduta libera in applicazioni di confezionamento verticale come patatine, cereali e prodotti granulati. Il sistema di test automatico riduce al minimo la


necessità di test manuali, migliorando la sicurezza dell’operatore e confermando al contempo l’accuratezza del rilevamento.
METTLER TOLEDO www.mt.com
BÜHLER E XFARM TECHNOLOGIES INSIEME PER IL MONITORAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ
xFarm Technologies, la tech company svizzera specializzata nella digitalizzazione del settore agroalimentare, annuncia la sua partnership con Bühler, multinazionale svizzera leader nello sviluppo e nella produzione di impianti e attrezzature. L’obiettivo è fornire alle aziende agroalimentari degli strumenti di misurazione ambientale all’avanguardia per tutta la filiera, utilizzando la raccolta di dati primari per monitorare tutti gli impatti.
Nell’industria agroalimentare, il 70-90% dell’impatto ambientale del prodotto finale legato alla CO 2 si verifica a livello del campo. Si tratta delle cosiddette emissioni di scopo 3. Per questo motivo, al fine di avere una panoramica dettagliata della situazione, è fondamentale disporre di dati primari non solo sulla lavorazione degli alimenti, ma anche sulla coltivazione delle materie prime.
Le due aziende svizzere hanno deciso di unire le forze per fornire alle aziende alimentari degli strumenti digitali per monitorare l’impatto ambientale dei loro prodotti, raccogliendo dati lungo l’intera filiera, dal campo allo scaffale, passando per la lavorazione. Ciò consentirà di identificare le principali fonti di emissioni e di mettere in atto delle azioni volte a ridurle. Grazie a questa partnership, xFarm Technologies e Bühler lavoreranno insieme per fornire alle aziende agroalimentari dati primari utili a quan -


tificare l’uso dell’acqua e le emissioni, sia in campo che durante le operazioni di trasformazione alimentare.
BÜHLER www.buhlergroup.com
BLOCKCHAIN E DATA COOLING: INFRASTRUTTURE DIGITALI PIÙ SICURE ED EFFICIENTI
In un contesto di crescente digitalizzazione e trasformazione dei modelli di archiviazione dati, l’ascesa della tecnologia blockchain sta ridefinendo in profondità le infrastrutture IT, ponendo nuove sfide in termini di efficienza energetica, capacità di calcolo e raffreddamento intensivo. BITZER risponde con determinazione a queste sfide rafforzando il proprio impegno nell’ambito del data center cooling, settore che si è rivelato uno dei principali motori della crescita del fatturato nel corso dell’ultimo anno.
“La blockchain, per sua natura distribuita e immutabile, richiede potenza di calcolo elevata e continua, una grande affidabilità energetica e, soprattutto, soluzioni di raffreddamento all’altezza della densità computazionale generata”,
afferma Piero Trevisan, General Manager di BITZER. I sistemi blockchain non possono infatti tollerare downtime o malfunzionamenti, mentre la costante disponibilità dei dati e la resilienza dell’infrastruttura sono imprescindibili. Ed è proprio qui che entra in gioco il know-how dell’azienda tedesca, la cui esperienza nel raffreddamento ad alte prestazioni è oggi più che mai centrale per sostenere lo sviluppo della blockchain.
BITZER www.bitzer.de


PALLET CERTIFICATI IN PLASTICA RICICLATA, LA SCELTA SICURA ED ECOLOGICA
Nel complesso panorama della logistica e del packaging industriale, la crescente attenzione alle certificazioni di sicurezza ambientale e fitosanitaria sta inducendo molte aziende a riflettere sulla sostenibilità dei materiali utilizzati, soprattutto in un contesto di scambi commerciali internazionali. Lo sa bene Relicyc. Uno degli aspetti distintivi tra i pallet in legno e in plastica è la necessità di trattamento fitosanitario per i primi, essenziale per evitare la diffusione di parassiti, insetti e altre minacce che potrebbero danneggiare l’ecosistema dei paesi destinatari. Il Tarlo Asiatico, il Nematode dei Pini, Insetti xilofagi e Funghi patogeni sono infatti soltanto alcuni degli organismi nocivi che possono essere presenti nei pallet in legno. Per questo la normativa ISPM 15 FAO, adottata da oltre 170 paesi, stabilisce l’obbligo di trattarli con metodi come il Trattamento Termico (HT).
In questo scenario, i pallet in plastica riciclata si distinguono come una scelta innovativa e responsabile, particolarmente adatta per le imprese che desiderano garantire sia l’efficienza logistica che la conformità alle normative globali, senza incorrere nelle complesse procedure richieste dai pallet in legno. Le aziende che scelgono la plastica riciclata per i loro pallet possono infatti evitare il trattamento fitosanitario e la marcatura IPPC, semplificando i processi logistici e risparmiando sui costi aggiuntivi legati alla certificazione. Inoltre, il materiale plastico, grazie alla sua resistenza e dura-


bilità, è ideale per cicli di vita più lunghi, riducendo ulteriormente la necessità di sostituzione e il consumo di risorse naturali: in poche parole, la scelta ideale per l’esportazione anche al di fuori dei confini europei.
www.relicyc.com/it/

Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Gaetano Forte
NIS 2: LA CYBERSICUREZZA IN ITALIA
GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE PRONTI A NUOVE SFIDE
Il 1° ottobre 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 138/2024 di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (cosiddetta NIS 2 che ha abrogato e sostituito la NIS 1, Direttiva UE 2016/1148 recepita in Italia con D.Lgs. 65/2018).
La nuova normativa introduce nuovi obblighi di sicurezza informatica e di cybersicurezza ed estende la platea dei soggetti pubblici e privati obbligati, definiti “soggetti critici” e suddivisi a loro volta in due diverse categorie, secondo il grado di criticità.
A CHI SI APPLICA
La normativa effettua la seguente distinzione:
§ soggetti importanti (grado più basso) e
§ soggetti essenziali (grado più alto). A
questi ultimi sono richiesti oneri maggiori in termini di sicurezza e sono soggetti a sanzioni più severe.
Essa è importante per il settore alimentare in quanto nell’allegato II 4 del D.Lgs. 138/2024 (“Altri settori critici”) sono incluse, nell’ambito del Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, le imprese alimentari di cui all’art. 3, punto 2), Reg. (CE) n. 178/2002, che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione.
Per “impresa alimentare”, come noto, si intende ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse a una delle fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione degli alimenti. All’interno delle imprese appartenenti ai settori “altri settori critici” di cui all’allegato II (servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti, fabbricazione/produzione/ distribuzione di sostanze chimiche, produzione/trasformazione e distribuzione di alimenti, fabbricazione, fornitori di servizi digitali, ricerca), gli operatori: § se piccole imprese, non sono soggette all’applicazione della normativa; § se medie o grandi imprese, sono soggetti importanti.
Si ricorda che, in base alla Raccomandazione 2003/361/CE la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 per-

La normativa introduce nuovi obblighi di sicurezza informatica e di cybersicurezza ed estende la platea dei
sone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce:
§ piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
§ media impresa: un’impresa che occupa tra 50 e 250 persone (escluso) e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro;
§ grande impresa: un’impresa che non soddisfa i requisiti della PMI e, pertanto con 250 o più effettivi, un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
L’Autorità di settore NIS, ossia l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore produzione, trasformazione e di-
stribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell’allegato II, è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
SCADENZE
Cosa devono quindi fare gli operatori soggetti alla normativa?
Il primo adempimento è l’auto-segnalazione circa la propria idoneità a essere qualificato come soggetto critico ed è scattato dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025. In tale arco temporale soggetti interessati dalla nuova normativa si sono registrati o hanno aggiornato la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN).
Questi hanno dovuto fornire o aggiornare almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale; b) l’indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
c) la designazione di un punto di contatto, indicando il ruolo presso il sogget-
to e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono; d) ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV del decreto.
Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità nazionale competente NIS redige l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, sulla base delle registrazioni e delle decisioni adottate.
Tramite la piattaforma l’Autorità nazionale competente NIS comunica ai soggetti interessati il loro status di essenziale o importante.
Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite la piattaforma digitale i soggetti che sono stati qualificati essenziali e importanti sopra forniscono o aggiornano le informazioni pertinenti.
ADEMPIMENTI
Ciò posto, la nuova normativa in mate-
soggetti pubblici e privati obbligati

ria di cybersicurezza prescrive in capo ai soggetti critici (a prescindere che siano importanti o essenziali) le seguenti tipologie di obblighi:
a) Incidenti informatici
I soggetti obbligati devono notificare gli incidenti informatici significativi. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano, senza ingiustificato ritardo, al Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia) ogni incidente che ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 30, 31 e 32 (entro 24 ore dall’incidente è necessaria una pre-notifica, entro 72 ore una notifica con una valutazione iniziale dello stesso ed entro un mese una relazione finale sulla gestione dello stesso).
Un incidente è considerato significativo se:
§ ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato;
§ ha avuto ripercussioni o è idoneo a provocare ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli.
Entro un mese dalla trasmissione della notifica dell’incidente i soggetti interessati trasmettono al CSIRT Italia una relazione finale che comprende:
1. una descrizione dettagliata dell’incidente, ivi inclusi la sua gravità e il suo impatto;
2. il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha probabilmente innescato l’incidente;
3. le misure di attenuazione adottate e in corso;
4. ove noto, l’impatto transfrontaliero dell’incidente;
5. in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale, una relazione mensile sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla conclusione della gestione dell’incidente.
Il CSIRT Italia può altresì richiedere relazione intermedie.
Senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 24 ore dal ricevimento della pre-notifica il CSIRT Italia fornisce una risposta al soggetto notificante, comprensiva di un riscontro iniziale sull’incidente significativo e, su richiesta del soggetto, orientamenti o consulenza sull’attuazione di possibili misure tecniche di mitigazione. Su richiesta del soggetto notificante, il CSIRT Italia fornisce ulteriore supporto tecnico.
Il decreto prevede anche la possibilità di effettuare notifiche volontarie per:
§ incidenti non significativi;
§ minacce informatiche potenziali;
§ “quasi-incidenti”.
b) Ge stione dei rischi
L’ulteriore obbligo, in capo agli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, è di adottare adeguate misure di gestione dei rischi di sicurezza informatica. Tra le misure minime elencate
Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità nazionale competente NIS redige l’elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, sulla base delle registrazioni e delle decisioni adottate
all’art. 24, comma 2, si citano, a titolo esemplificativo:
§ approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate;
§ seguire una formazione in materia di sicurezza informatica;
§ promuovere l’offerta periodica di una formazione coerente ai loro dipendenti, per favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti.
Tali soggetti apicali sono altresì responsabili delle eventuali violazioni della nuova normativa.
c) Misure organizzative
I soggetti essenziali e i soggetti importanti adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi. Tali misure:
§ assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto delle conoscenze più aggiornate e dello stato dell’arte in materia e, ove applicabile, delle pertinenti norme nazionali, europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione;
§ sono proporzionate al grado di esposizione a rischi del soggetto, alle dimensioni del soggetto e alla probabilità che si verifichino incidenti, nonché alla loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.
Le suddette misure sono basate su un ap-
proccio multi-rischio, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete nonché il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno i seguenti elementi:
a. politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
b. gestione degli incidenti, ivi incluse le procedure e gli strumenti per eseguire le notifiche;
c continuità operativa, ivi inclusa la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle crisi;
d. sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
e. sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
f. politiche e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
g. pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica;
h. politiche e procedure relative all’uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
i. sicurezza e affidabilità del personale, politiche di controllo dell’accesso e gestione dei beni e degli assetti; j. uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.
PERIODO TRANSITORIO
In fase di prima applicazione i tempi per alcuni ampliamenti sono dilatati:
§ gli obblighi di notifica degli incidenti informatici è dilatato sino a 9 nove mesi dalla ricezione della comunicazione circa l’appartenenza alle liste
di applicabilità del Decreto Legislativo (quindi indicativamente a gennaio 2026);
§ gli obblighi degli organi di amministrazione e direttivi e gli obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatici è dilatato sino a 18 mesi dalla comunicazione di cui sopra (quindi indicativamente ottobre 2026).
ASPETTI SANZIONATORI
Importanti le sanzioni previste. In caso di mancato adeguamento agli obblighi cybersecurity, il D.Lgs. 138/2024 prevede per i trasgressori “essenziali” sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di € 10.000.000 o il 2% del fatturato mondiale annuo mentre per i trasgressori “importanti” sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di € 7.000.000 o dell’1,4% del fatturato mondiale annuo. Una novità introdotta dal Decreto Legislativo è la previsione di un minimo edittale delle sanzioni che è un ventesimo o di un trentesimo del massimo edittale rispettivamente per i soggetti essenziali e quelli importanti.
CONCLUSIONI
Con la NIS 2 le imprese alimentari sono chiamate a una serie di adempimenti per la cybersicurezza. Partendo dalla registrazione alla piattaforma digitale resa disponibile Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) nel corso dei prossimi due anni si articoleranno una serie di obblighi che comporteranno nuove sfide e una nuova organizzazione interna per assicurare la compliance alla normativa.

David Migliori
LA DOP ECONOMY GUARDA CON OTTIMISMO AL FUTURO
LE PRODUZIONI DI ECCELLENZA ITALIANE SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DEL NUOVO RAPPORTO
ISMEA-QUALIVITA. L’ITALIA CON 856 PRODOTTI È IL PAESE CON IL MAGGIOR NUMERO DI FILIERE DOP IGP
STG AL MONDO, DAVANTI A FRANCIA E SPAGNA. UN PRIMATO IMPORTANTE PER UN SETTORE IN BUONA SALUTE, STRATEGICO, CHE SI È LASCIATO DEFINITIVAMENTE ALLE SPALLE LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA E CRESCE IN CONSAPEVOLEZZA E PESO NELL’ECONOMIA NAZIONALE
Quella che in gergo viene definita la DOP economy rappresenta oggi circa un quinto del valore complessivo dell’intera produzione del se tt ore agroalimentare nazionale: una dimostrazione dell’importanza di un sistema fatto di 195 mila operatori tra aziende agricole e trasformatori. A livello complessivo, nel 2023 il valore totale dei prodotti alimentari e dei vini DOP e IGP italiani si è attestato sopra ai 20 miliardi di euro, con un’ulteriore crescita annua, seppur lieve, dello 0,2%, nonostan t e gli effetti dei cambiamenti climatici e degli aumenti dei costi di produzione.
Sono alcune delle più impressionanti evidenze del Rapporto Ismea-Qualivita, giunto alla XXII edizione, che fornisce i
dati produttivi ed economici dei comparti a Indicazione Geografica. Si tratta di un lavoro frutto del connubio tra ISMEA (l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e Qualivita, la fondazione che rappresenta la rete dei Consorzi di tutela del mondo delle IG.
Sergio Marchi, Direttore Generale Ismea, ha ribadito come nei difficili anni post 2020 sia emersa la “straordinaria capacità di reazione degli operatori del settore alle numerose e diverse criticità” e come proprio “grazie ai Consorzi di tutela, negli ultimi anni sono stati avviati numerosi progetti di sviluppo” per le aziende del settore (per la riduzione dei costi, il miglioramento della produzione e delle attività di commercializzazione etc.), anche incentrate sulla ricerca e sulla formazione. E con una cultura aziendale improntata ai valori
della sostenibilità, e un approccio attento alla transizione digitale in atto. Ci sono quindi tutte le ragioni per guardare con ottimismo al futuro perché il mondo delle produzioni certificate mostra segnali di grande vitalità. Come segnala ancora Marchi per il buono stato di salute di questo mondo svolgono un ruolo importante anche misure come il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) italiano, che riserva alle Indicazioni Geografiche un posto importante e due specifici interventi di sviluppo rurale (SRG03 e SRG10) per i quali, nel quinquennio di programmazione, è prevista una spesa pubblica complessiva di oltre 120 milioni di euro.
IL QUADRO GENERALE
Entrando nel dettaglio dei dati del rapporto, il valore totale della produzione certi-

ficata di cibo e vino DOP IGP nel 2023 è rimasto sopra la soglia dei 20 miliardi di euro, con un contributo del 19% al fatturato dell’agroalimentare nazionale. Questi risultati sono il frutto di un andamento opposto fra il comparto cibo in crescita del +3,5%, che raggiunge 9,17 miliardi di euro, e il settore vitivinicolo in calo del -2,3% con un valore di 11,03 miliardi di euro. Il quadro diventa più variegato quando si prendono in considerazione gli impatti territoriali delle filiere DOP IGP. Le quattro regioni del Nord-Est rappresentano il 54% del valore della DOP economy italiana e hanno risultati stabili. Bene nel complesso il Nord-Ovest (+1,5%) e soprattutto l’area sud e Isole che con una crescita del +4% registra il risultato migliore di sempre. Frenano, invece, le regioni del Centro (-3,9%). Passando alle esportazioni il comparto DOP IGP nel 2023 ha raggiunto 11,6 miliardi di euro (-0,1%), con 4,67 miliardi di euro per il cibo, con un +0,7% su base annua e un trend del +90% dal 2013, con andamento opposto nel complesso fra
mercato UE (+6,4%) e mercato Extra-UE (-6,9%), e 6,89 miliardi di euro per il vino. Nel mercato interno la spesa per i prodotti DOP IGP nella GDO è cresciuta del +7,2% su base annua, fino a raggiungere i 5,9 miliardi di euro, con il +9,5% per i prodotti alimentari e il +2,7% per il vino, dati confermati nei primi nove mesi del 2024 (+1,2% rispetto allo stesso periodo del 2023).
Ma quanti sono oggi questi prodotti di eccellenza? Nel 2023, l’Italia ha registrato 856 prodotti DOP, IGP e STG nel settore agroalimentare e vitivinicolo. Le filiere DOP e IGP coinvolgono 194.387 operatori e danno lavoro a 847.405 occupati. Inoltre, sono attivi 317 consorzi di tutela, autorizzati dal Masaf, che garantiscono la protezione e la promozione dei prodotti certificati.
Per quanto riguarda il settore alimentare, l’Italia conta 328 prodotti DOP, IGP e STG registrati. Il valore alla produzione ha raggiunto i 9,17 miliardi di euro, con una crescita annua del 3,5%, mentre il valore al consumo è pari a 17,97 miliardi di euro,
in aumento del 3,6%. Anche l’export del comparto ha segnato una crescita dello 0,7%, arrivando a 4,67 miliardi di euro. Gli operatori delle filiere alimentari certificate sono 87.212, mentre gli occupati nel settore agricolo e dell’industria alimentare raggiungono le 585.543 unità. Il sistema di tutela è garantito da 182 consorzi riconosciuti dal Masaf.
Nel settore vitivinicolo, l’Italia vanta 528 prodotti DOP e IGP. La produzione imbottigliata ha raggiunto i 25,9 milioni di ettolitri, registrando una flessione dello 0,7% su base annua. Il valore alla produzione del vino certificato è di 11,03 miliardi di euro, con una riduzione del 2,3% rispetto all’anno precedente, mentre il valore dell’export si attesta a 6,89 miliardi di euro, con un lieve calo dello 0,6%. Le filiere vitivinicole contano 107.175 operatori, mentre il numero di occupati nel settore vitivinicolo e nell’industria alimentare raggiunge le 332.506 unità. I consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf sono 135, impegnati nella salvaguardia della qualità e nella promozione dei vini certificati.
Il valore alla produzione ha raggiunto i 9,17 miliardi di euro, con una crescita annua del 3,5%, mentre il valore al consumo è pari a 17,97 miliardi di euro, in aumento del 3,6%

A livello globale, più della metà del nostro export resta in Europa (60%). I principali Paesi di sbocco dei nostri prodotti sono di gran lunga la Germania e la Francia anche se per entrambi il peso percentuale è in calo
PRODOTTI ITALIA DOP IGP STG
856 prodotti agroalimentari e vitivinicoli.
20,2 miliardi di euro valore alla produzione (+0,2% annuo).
19% peso del valore IG sul settore agroalimentare.
11,6 miliardi di euro valore all’export (-0,1% annuo).
194.387 operatori nelle filiere IG.
847.405 occupati nel settore.
317 consorzi di tutela autorizzati dal Masaf.
CIBO DOP IGP STG
328 prodotti agroalimentari registrati.
9,17 miliardi di euro valore alla produzione (+3,5% annuo).
17,97 miliardi di euro valore al consumo (+3,6% annuo).
4,67 miliardi di euro valore all’export (+0,7% annuo).
87.212 operatori nelle filiere IG.
585.543 occupati nel settore.
182 consorzi di tutela autorizzati dal Masaf.
VINO DOP IGP
528 prodotti vitivinicoli registrati.
25,9 milioni di ettolitri produzione imbottigliata (-0,7% annuo).
11,03 miliardi di euro valore alla produzione (-2,3% annuo).
6,89 miliardi di euro valore all’export (-0,6% annuo).
107.175 operatori nelle filiere IG.
332.506 occupati nel settore.
135 consorzi di tutela autorizzati dal Masaf.
DOVE VANNO LE NOSTRE ESPORTAZIONI?
Il peso delle esportazioni dei nostri prodotti tipici è davvero importante. Con un valore di 4,67 miliardi di euro a valore e un ragguardevole +90% in 10 anni (era solo di 2,46 miliardi nel 2013), si tratta di numeri che fotografano una crescita davvero imponente, un settore che col tempo è diventato un vero e proprio volano della nostra economia produttiva. A livello globale, più della metà del nostro export resta in Europa (60%). I principali Paesi di sbocco dei nostri prodotti sono di gran lunga la Germania e la Francia anche se per entrambi il peso percentuale è in calo.
Fuori dal nostro continente, dominano le esportazioni verso gli Stati Uniti 819 milioni (con la pesante incognita dei dazi promessi dal neoletto Presidente Trump), la Gran Bretagna e il Canada. Tra i prodotti maggiormente apprezzati fuori dai nostri confini, emerge con forza il peso dei formaggi (con un valore di 2.746 milioni di euro), seguiti dagli Aceti Balsamici a grande distanza (818 mil) e prodotti a base carne (610 mil). Più distanziati paste, ortofrutticoli, olii.
DAL MONDO ALL’ITALIA
È utile a questo punto capire quale sia il peso del Made in Italy certificato rispetto all’insieme dei prodotti su scala mondiale. Iniziamo col dire che a livello globale si contano complessivamente 3.193 prodotti DOP IGP STG nei Paesi UE, di cui 1.564 agroalimentari e 1.629 vitivinicoli. A questi si aggiungono le 236 produzioni
DOP IGP STG registrate in 19 Paesi extra comunitari - dato che include anche la denominazione transnazionale di Irlanda e Regno Unito.
Una sottodivisione a livello del nostro continente dice che in Europa i prodotti agroalimentari sono così ripartiti: 667 DOP, 833 IGP e 64 STG, mentre i vini si dividono in 1.185 DOP e 444 IGP.
E come era lecito attendersi è proprio l’Italia con 856 prodotti il Paese con il maggior numero di filiere DOP IGP STG al mondo, un primato che la colloca davanti a Francia (717), Spagna (366), Grecia (266), Portogallo (195) e Germania (143). Nei primi 10 mesi del 2024 si sono registrati 3 nuovi prodotti IGP. Nell’agroalimentare l’Italia vanta 328 prodotti DOP IGP STG e 2 nuove registrazioni; per il settore vitivinicolo si contano 528 denominazioni. Con una cancellazione e un nuovo ingresso nel 2024. La classifica regionale nazionale vede al primo posto la Toscana con 90 referenze DOP e IGP, subito dopo il Veneto con 89 prodotti e il Piemonte leggermente distanziato con 84. Tutte e tre con una forte dominanza dei vini, rispettivamente
58, 53 e ben 60, soprattutto DOP. Scorrendo l’elenco, troviamo le altre grandi regioni italiane, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, con un maggior equilibrio tra cibi e vini e poi, e via via le altre.
OLTRE 800 MILA OCCUPATI
Se ancora non bastasse esiste un ulteriore dato a confermare il peso di questo settore nell’economia nazionale, ed è quello relativo al numero di persone che, a diverso titolo, sono occupate nelle variegate attività di questa filiera. Per i lavoratori della DOP economy parliamo di un numero non così lontano dal milione di persone. Lo studio stima quasi 850 mila rapporti di lavoro nel 2023, fra quelli del comparto cibo (585.543) e quelli del settore vitivinicolo (332.506).
FORMAGGI E CARNI TRASCINANO IL SETTORE
I 9,17 miliardi di euro raggiunti dal settore agroalimentare sono ancora più “imponenti” se si pensa che la crescita rispetto al 2013 è stata del 44%; i numeri sono da record anche quando si guarda il valore al consumo, che sfiora i 18 miliardi di euro nel 2023.
Tra i diversi comparti si segnala quello dei formaggi, in crescita del +5,3%, che superano per la prima volta i 5,5 miliardi di euro di valore alla produzione e rappresentano il 60% del cibo DOP IGP, seguiti dai prodotti a base di carne che con il +0,7% generano un valore di 2,3 miliardi di euro, per un peso del 25%. Gli ortofrutticoli mostrano nel complesso un calo del -2% con 379 milioni di euro di valore
Tabella 1. Prodotti DOP IGP per regione italiana
alla produzione. Seguono gli aceti balsamici con 358 milioni di euro di valore alla produzione, in calo del -7,6% sul 2022 e le paste alimentari con 274 milioni di euro (+1,9% sul 2022). Fanno un balzo in avanti significativo del +32,6% gli oli di oliva che superano per la prima volta la soglia dei 100 milioni raggiungendo un valore alla produzione di 115 milioni di euro nel 2023. Continuano a crescere i prodotti della panetteria e pasticceria (+9,5% con 115
2. Primi 15 prodotti cibo DOP e IGP (Fonte: Indagine Ismea-Qualivita 2024)
mln di euro) e le carni fresche (+10,3% con 114 mln di euro).
SFIDE, CRITICITÀ E INNOVAZIONI
Come evidenziato da Mauro Rosati, Direttore Generale Fondazione Qualivita, la DOP economy italiana è in buona salute, e lo è in tutto il Paese, in particolare con un trend in crescita nelle regioni del Mezzogiorno.
Tuttavia, il mondo corre veloce e i mutamenti socioeconomici avranno sempre più un forte impatto sul mondo delle eccellenze agroalimentari. Tra gli aspetti a cui guardare per non farsi trovare impreparati Rosati segnala il Regolamento UE 2024/1143 che indirizza il settore delle Indicazioni Geografiche verso la sostenibilità, fissando priorità come la riduzione delle emissioni,
la gestione responsabile delle risorse e l’adattamento ai cambiamenti climatici. I Consorzi assumono un ruolo chiave, diventando i principali promotori di azioni concrete per migliorare l’impatto ambientale, sociale ed economico e con un nuovo ruolo nella gestione del turismo enogastronomico legato alle Indicazioni Geografiche. Tuttavia, Rosati segnala anche alcuni rischi, come ad esempio quello di “musealizzazione” le aziende agricole e l’overtourism, che potrebbero compromettere l’autenticità e la sostenibilità dei territori.
Tra le sfide da affrontare una riguarda il mondo del vino: emergono nuove tendenze di consumo, come i vini dealcolati e i vini in lattina, particolarmente apprezzati dalla Gen Z. Questi cambiamenti potrebbero ridurre il peso del territorio e del concetto
della Valtellina IGP
Tabella
DATI ECONOMICI 2023
Overview Rapporto 2024
Italia DOP IGP STG

856
PRODOTTI DOP IGP STG agroalimentari e vitivinicoli in Italia
328
PRODOTTI
DOP IGP STG agroalimentari registrati in Italia
20,2 mld €
VALORE ALLA PRODUZIONE crescita del +0,2% su base annua
19%
PESO VALORE DOP IGP sul settore agroalimentare*
528
PRODOTTI DOP IGP vitivinicoli registrati in Italia
9,17 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE crescita del +3,5% su base annua
17,97 mld € VALORE AL CONSUMO crescita del +3,6% su base annua
11,6 mld €
VALORE ALL’EXPORT calo del -0,1% su base annua
25,9 mln hl
PRODUZIONE IMBOTTIGLIATA calo del -0,7% su base annua
11,03 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE dell’imbottigliato -2,3% in un anno
4,67 mld €
VALORE ALL’EXPORT crescita del +0,7% su base annua
194.387
OPERATORI FILIERE IG agrolimentari e vitivinicole
6,89 mld €
VALORE ALL’EXPORT calo del -0,6% su base annua
* Il rapporto è calcolato sulla produzione a prezzi di base agricola 2023 + valore aggiunto dell’industria alimentare 2023. [856 prodotti registrati al 31.10.2024. I dati di produzione sono riferiti temporalmente al 31.12.2023] RAPPORTO ISMEA-QUALIVITA 2024
lungo periodo potrebbe incidere profondamente sul settore vitivinicolo.
Invece per il settore degli oli, nonostante un +33% di crescita nel 2023, esiste una certa fatica a ottenere il prestigio e il valore economico desiderati. Le Indicazioni Geografiche hanno trasformato l’olio extravergine in un prodotto premium, ma l’adozione di modelli produttivi intensivi ispirati alla Spagna e la possibile introduzione di un Sistema di Qualità Nazionale standardizzato vengono indicati come rischi che possono compromettere il valore costruito nel tempo e rendere l’Italia meno competitiva rispetto a Paesi con costi più bassi (Spagna, Turchia e Nord Africa).
L’ultimo ma non ultimo tema di fronte alle produzioni di eccellenza legate al territorio è quello dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. Apparentemente un argomento lontano: al contrario, nessuno si può sen-
847.405
OCCUPATI FILERE IG agrolimentari e vitivinicole
87.212 OPERATORI FILIERE IG produttori e trasformatori
585.543 OCCUPATI FILIERE IG settore agricolo e industria alimentare
107.175 OPERATORI FILIERE IG viticoltori, vinificatori e imbottigliatori
332.506 OCCUPATI FILIERE IG settore agricolo e industria alimentare 317 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Masaf 182 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Masaf 135 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Masaf
mondo che corre sempre più veloce? Per i curatori del rapporto oggi è fondamentale investire in un’intelligenza artificiale dedicata al settore agroalimentare, sviluppare un ecosistema digitale per supportare le imprese, migliorare le tecniche produttive e raccontare le storie dei prodotti italiani.
I SINGOLI COMPARTI IN DETTAGLIO
Vale la pena procedere ancora più a fondo nella conoscenza dei singoli comparti certificati, con brevi schede riassuntive di approfondimento.
I formaggi
Nel 2023 il settore dei formaggi italiani DOP, IGP e STG ha registrato una crescita significativa in termini di produzione e valore economico. La produzione certificata ha raggiunto 591.062 tonnellate, segnando un aumento del 2,2% rispetto all’anno
ha raggiunto 9,346 miliardi di euro, con un incremento dell’8%. Anche l’export, come già segnalato poco sopra, ha mostrato un andamento positivo, generando 2,746 miliardi di euro (+3,7%).
Oggi il settore dei formaggi include 57 prodotti (53 DOP, 3 IGP e 1 STG), con il coinvolgimento di 43 consorzi di tutela, 24.598 operatori della filiera e circa 94.950 occupati.
A livello regionale, Lombardia ed EmiliaRomagna guidano l’impatto economico con rispettivamente 1.771 e 1.641 milioni di euro, seguite a molta distanza da Campania (505 milioni) e Veneto (501 milioni). Tra i formaggi con il maggiore valore alla produzione spiccano il Grana Padano DOP (1.885 milioni di euro) e il Parmigiano Reggiano DOP (1.599 milioni di euro), seguiti dalla Mozzarella di Bufala Campana DOP (528 milioni), il Pecorino Romano
Cibo DOP IGP STG
Vino DOP IGP
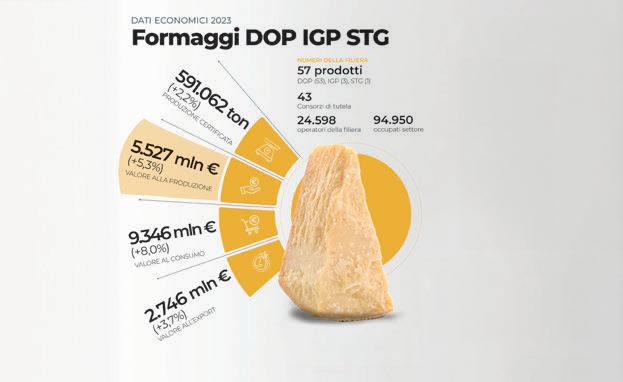
DOP (494 milioni) e il Gorgonzola DOP (430 milioni).
Prodotti a base carne
Nel 2023 il settore dei prodotti a base di carne certificati DOP e IGP ha mostrato risultati abbastanza stabili, con una produzione certificata di 190.976 tonnellate, in calo del 2,7% rispetto all’anno precedente. Il valore alla produzione ha registrato un incremento dello 0,7%, raggiungendo 2,276 miliardi di euro. Tuttavia, il valore al consumo ha subito una leggera contrazione dello 0,5%, attestandosi a 5,589 miliardi di euro. Anche l’export ha registrato una flessione, totalizzando 610 milioni di euro (-3,9%).
La filiera della carne conta 43 prodotti (21 DOP e 22 IGP), supportati da 22 consorzi di tutela e 3.374 operatori, con un totale di 61.299 occupati nel settore. Dal punto di vista dell’impatto economico regionale, l’Emilia-Romagna si conferma leader con 1.345 milioni di euro, seguita dal Friuli-Venezia Giulia (388 milioni), dalla Lombardia (296 milioni) e
dal Trentino-Alto Adige (107 milioni). Tra i prodotti di punta per valore alla produzione si distinguono il Prosciutto di Parma DOP (951 milioni di euro), il Prosciutto di San Daniele DOP (385 milioni), la Mortadella di Bologna IGP (339 milioni), la Bresaola della Valtellina IGP (225 milioni) e lo Speck Alto Adige IGP (107 milioni).
Ortofrutta e cereali
Il comparto degli ortofrutticoli e cereali DOP e IGP si conferma un pilastro dell’agroalimentare italiano, con una produzione certificata che ha raggiunto le 502.919 tonnellate, registrando però un calo del 12,7% rispetto all’anno precedente. Il valore alla produzione si attesta a 379 milioni di euro, con una leggera flessione del 2%, mentre il valore al consumo scende a 1.067 milioni di euro (-3,9%). Anche l’export segna una diminuzione, fermandosi a 156 milioni di euro (-3,4%).
Attualmente, il settore conta 126 prodotti certificati, suddivisi in 38 DOP e 88
IGP, e vede impegnati 66 consorzi di tutela e oltre 21.438 operatori della filiera. Il numero di occupati nel settore è pari a 163.670 persone.
A livello regionale, il Trentino-Alto Adige domina con un impatto economico di 143 milioni di euro, seguito da Sicilia (61 milioni di euro) e Piemonte (39 milioni di euro). Tra le sottocategorie di prodotto, il miele è quello economicamente più rilevante con 157 milioni di euro di valore alla produzione (+6%), seguito dagli agrumi che registrano una crescita del 22%, toccando i 51 milioni di euro. In calo, invece, la frutta in guscio (-24%) e la frutta estiva (-26%).
Aceto balsamico
Il settore degli aceti balsamici DOP e IGP è un’eccellenza nazionale che ha registrato nel 2023 un lieve calo, pur mantenendo un ruolo di primo piano nel panorama agroalimentare italiano.
La produzione certificata si attesta a 87,6 milioni di litri, con una riduzione dell’8,1% rispetto all’anno precedente. Il valore alla produzione è pari a 358 milioni di euro (-7,6%), mentre il valore al consumo si ferma a 905 milioni di euro (-7,3%). Anche l’export ha subito una contrazione, raggiungendo 818 milioni di euro (-7,8%).
Il ristretto comparto è composto da tre prodotti certificati, di cui due DOP e uno IGP, ed è tutelato da tre consorzi di tutela. Complessivamente, la filiera conta 582 operatori e impiega 30.667.
L’Emilia-Romagna è l’unica regione produttrice di aceti balsamici certificati e genera un impatto economico di 358 milioni di euro. Dei tre prodotti, l’Aceto Balsamico di Modena IGP, ha raggiunto un valore alla produzione di 350 milioni di euro, seguito dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP con 6,4 milioni di euro. Per l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP si stimano 0,8 milioni di euro.
Olio di oliva
Il settore degli oli di oliva DOP e IGP il 2023 ha avuto un andamento positivo in termini di valore economico, nonostante una contrazione della produzione certificata. Il volume complessivo si attesta a 12.355 tonnellate, con una riduzione del 6,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il valore alla produzione ha segnato un aumento significativo, raggiungendo 115 milioni di euro (con un balzo del +32,6%). Anche il valore al consumo è cresciuto del 18,1%, toccando quota 168 milioni di euro, mentre l’export ha registrato un forte incremento del 30,5%, attestandosi a 81 milioni di euro.
Attualmente, sono 50 i prodotti certificati (di cui 42 DOP e 8 IGP), gestiti da 25 consorzi di tutela. La filiera coinvolge 25.004 operatori e garantisce occupazione a 110.789 persone, sottolineando l’importanza strategica di questo settore per l’economia agricola italiana. Sono due regioni meridionali a guidare la classifica geografica con la Puglia a dominare con un impatto economico di 37 milioni di euro, seguita dalla Sicilia (29
milioni di euro). Terzo post per la Toscana (27 milioni di euro). Tra i prodotti più rilevanti, il Terra di Bari DOP si conferma il più remunerativo con 34 milioni di euro di valore alla produzione, seguito dal Toscano IGP (26 milioni di euro) e dal Sicilia IGP (14 milioni di euro).
Carni fresche
Nel 2023, la produzione certificata di carni fresche DOP e IGP è stata di 13.800 tonnellate (-2,4%), con un valore alla produzione di 114 milioni di euro (+10,3%). Il valore al consumo ha raggiunto i 256 milioni di euro (+5,5%), mentre l’export è cresciuto del 29%, toccando i 17 milioni di euro. Il settore coinvolge 6 prodotti certificati, di cui 5 IGP, 5 consorzi di tutela e oltre 10.000 operatori, con 158.480 occupati. Delle nove regioni in cui si producono carni fresche, Sardegna e Toscana sono quelle con il maggior valore economico, in particolare la prima con 49 milioni di euro. I due prodotti leader del comparto carni fresche sono il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP (51 mln euro) e l’Agnello di Sardegna IGP (49 mln euro).
Altre categorie
Il valore complessivo 2023 della produzione delle categorie DOP IGP diverse da vino, formaggi e salumi ha raggiunto i 403 milioni di euro (+3,9%). In queste filiere esistono 43 prodotti certificati, 15 consorzi di tutela e quasi 17.000 occupati. La pasta alimentare domina il settore con 274 milioni di euro (+1,9%), seguita da panetteria e pasticceria (115 mln di euro, +9,5%), il cioccolato rappresentato da quello di Modica IGP (6,1 mil di euro, +10,5%) e pesci e molluschi (4,7 mil di euro, +5,9%), con le Trote del trentino IGP che da sole fatturano 4,6 milioni. Tra i prodotti più rilevanti, la Pasta di Gragnano IGP guida con 273 milioni, seguita dalla Piadina Romagnola IGP (62 mln di euro) e dai Cantuccini Toscani IGP (43 mln di euro, +18,2%).
Vino
Ultimo ma certamente non per importanza, il mondo del vino certificato imbottigliato che ha raggiunto 25,9 milioni di ettolitri (con un leggerissimo calo dello 0,7% sull’anno precedente) e un valore alla produzione di 11,03 miliardi di euro

I vini DOP e IGP sono in tutto 528: 409 quelli Denominazione di Origine Protetta, 119 a Indicazione Geografica Protetta. La produzione certificata è stata di 17,78 milioni di ettolitri (-5,1%), mentre il valore del vino sfuso ha raggiunto 3,99 miliardi di euro (-8,1%). I Consorzi di tutela del vino sono ben 135. Oltre 107 mila la stima degli operatori del settore, e più di 332 mila le persone occupate in questo fondamentale comparto dell’economia nazionale.
Come era facile attendersi, è il Veneto a dominare la classifica regionale con un impatto economico di 4,3 miliardi di euro, seguito da Piemonte (1,2 miliardi) e Toscana (1,1 miliardi). Sotto il milione tutte le altre con le produzioni maggiori per Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige.

David Migliori
STRATEGIE DI RIDUZIONE
E DI ARRICCHIMENTO
L’INNOVAZIONE NEL SETTORE DEL BAKERY NEGLI ULTIMI ANNI SI È MOSSA CON L’OBIETTIVO DI MIGLIORARE GLI ASPETTI SALUTISTICI E NUTRIZIONALI E DARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
Il settore del bakery è una filiera in cui sono imprescindibili la qualità degli ingredienti e delle materie prime utilizzate. E che oggi si caratterizza per tre elementi: benessere del consumatore, trasparenza e ricchezza delle informazioni, e una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità.
Alla filiera del bakery, ossia del mondo dei prodotti di pasticceria, biscotti, cereali, pasta e pane, è stata dedicata una sessione dell’ultima edizione di AlimentiPiù, moderata dalla tecnologa alimentare Serena Pironi, nel corso della quale Alessandra Marti, PhD Professore in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) dell’Università degli Studi di Milano è intervenuta sul tema: “L’innovazione nel settore dei cereali e dei prodotti derivati”.
Partendo dal concetto stesso di innovazione, la profesoressa ha ricordato come con questo termine si intenda sempre un processo di trasformazione di un’idea in qualcosa di nuovo e migliorato, sia esso un pro-
dotto, un servizio o un processo. Alla base c’è quindi sempre un’esigenza di miglioramento. Tra i driver principali che svolgono un ruolo importante nel settore dei cereali c’è in primis quello di migliorare gli aspetti salutistici e nutrizionali; non meno trascurabile è l’esigenza di valorizzare la biodiversità e l’attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia della qualità del prodotto. I prodotti da forno sono una famiglia eterogenea, ma possiedono una stessa matrice, la farina. Possono essere suddivisi utilizzando diversi criteri: i principali tendono a considerare il binomio dolci/ salati e quello secchi/morbidi. A prescindere da queste categorizzazioni, l’innovazione negli ultimi anni ha riguardato soprattutto la formulazione dei prodotti, cercando di intervenire dal punto di vista nutrizionale, riducendo grassi, zuccheri o sali, secondo la filosofia del less is more . Contemporaneamente si è assistito a una tendenza e a un processo di arricchimento dei componenti, inserendo, in particolare, fibre e proteine.
TOGLIERE
La riduzione non è un’operazione semplice: si tratta pur sempre di elementi funzionali che svolgono un ruolo importante nel prodotto. La docente ha illustrato le principali strategie che sono state seguite.
Nel caso dello zucchero si è scelto di andare a una riduzione, parziale o totale, dell’ingrediente; in altri casi, si è andati a sfruttare delle interazioni fra altri componenti utilizzando flavor e altri agenti strutturanti. In altri casi ancora si è fatta una distribuzione eterogenea dello zucchero sull’intera massa del prodotto.
Nel caso della riduzione dei grassi, si è operato in maniera simile, in alcuni casi utilizzando sostituti, oppure inserendo sostanze grasse con un ridotto apporto calorico.
Nel caso del sale le strategie adottate sono state altrettanto diversificate: riduzione graduale dell’elemento oppure utilizzo di esaltatori della sapidità o di sostituti del sale. In alcuni casi si è operato per contrasto, ad esempio con l’astringente come alternativa al sapore salato. E anche la strategia del

lievito madre segue questa stessa logica. Ci sono anche dei casi di innovazione tecnologica che seguono la stessa filosofia della riduzione: ad esempio, nel caso della pasta sfoglia si è puntato a prodotti finiti con un minor numero di strati, ma con le stesse caratteristiche sensoriali, ottenendo quindi un minor grasso complessivo.
AGGIUNGERE
Passando ai prodotti arricchiti, molte innovazioni hanno riguardato l’utilizzo di fibre. Gli esempi sono numerosi e comprendono l’uso di sfarinati integrali e semi integrali, oppure grani diversi dal frumento che abbiano un elevato contenuto in fibra, come orzo, avena e segale. Ma anche semicerali e leguminose. Altre strategie prevedono l’utilizzo di fibre isolate, oppure frazioni ricche in fibre.
Per gli arricchiti in proteine le cose sono abbastanza simili. I legumi sono le matrici maggiormente utilizzate in questi casi; in alternativa si possono usare gli isolati proteici, o frazioni arricchite in proteine.
Arricchire un prodotto in fibra ha delle conseguenze non sempre gradite. Di solito quello che avviene è una progressiva riduzione del volume, una mollica più scura e un calo della morbidezza. Questo accade per-
IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITÀ
A richiamare l’importanza che svolgono le certificazioni nelle filiere del pane e della pasta è intervenuta Irene Grigoletto, Responsabile di Schema, Innovazione e Sviluppo CSQA, un ente che ha il proprio core business nel settore agroalimentare.
Nell’ambito della sostenibilità, tra le certificazioni più innovative e interessanti esiste “Made in green in Italy”: ha durata triennale e dà anche diritto ad apporre sui prodotti un apposito logo rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica.
Per essere definiti Made in green in Italy, i prodotti devono garantire il superamento di soglie specifiche stabilite per ognuno di essi, e avere prestazioni ambientali pari o superiori a un benchmark di riferimento, la cui valutazione è fatta seguendo il metodo PEF (product environmental foodprint), che è una metodologia di calcolo delle prestazioni ambientali.
L’analisi è fatta sull’intero ciclo di vita, LCA (Life Cycle Assessment): dalla produzione delle materie prime fino allo
smaltimento, valutando di volta in volta i diversi indicatori di impatto ambientale. Per fare un esempio concreto, nel caso della pasta secca il lavoro a monte della certificazione prevede la raccolta di dati di 1 kg di pasta, partendo dagli ingredienti di base (valutando la coltivazione dei cereali, la trasformazione in semola/ farina di grano tenero, il trasporto dal sito di produzione al sito di lavorazione; e lo stesso poi per le uova e gli altri ingredienti); passando poi alla fase di produzione (analizzando i consumi energetici, quelli idrici e la produzione di rifiuti); al confezionamento (sia l’analisi delle materie prime che il trasporto e la produzione dell’imballaggio); alla distribuzione; la cottura (ancora una volta i consumi energetici e idrici, ma anche quelli di sale e i rifiuti finali; arrivando al cosiddetto fine vita dell’imballaggio utilizzato (i rifiuti finali).
Una volta avuto esito positivo rispetto ai requisiti richiesti dal benchmark di riferimento sarà possibile richiedere la certificazione attraverso un ente accreditato.
Tra i driver principali che svolgono un ruolo importante nel settore dei cereali c’è in primis quello di migliorare gli aspetti salutistici e nutrizionali

ché la fibra influisce sulla formazione della maglia glutinica, che diventa meno coesa e uniforme. A livello molecolare ogni volta che si aggiunge fibra, le proteine si organizzano in maniera diversa, creando una struttura più compatta, caratterizzata da quelli che in gergo vengono definiti foglietti beta. Esistono diverse strategie per minimizzare questi effetti. Ci sono approcci di tipo fisico, che sono molto numerosi e possono essere fatti sulla cariosside, o sullo sfarinato integrale o direttamente sulla crusca del cereale; altri approcci sono invece di tipo biotec-
nologico come la fermentazione, l’utilizzo di enzimi o la germinazione.
Tra i vari sistemi innovativi, la docente ha illustrato quello che considera tra i più interessanti e che è la cosiddetta classificazione ad aria. Si tratta di un’operazione che combina le forze centrifughe delle correnti d’aria che, su uno sfarinato, sono in grado di separare le diverse particelle in funzione sia delle loro dimensioni che, soprattutto, della loro densità: quindi modificando la composizione chimica, ossia il contenuto in proteine e carboidrati. Questa tecnologia viene
L’INNOVAZIONE NELLA FILIERA DEL BAKERY
Secondo la Tecnologa Alimentare Monica Casali, l’innovazione nel settore non ha riguardato la creazione di nuovi prodotti, ma la riscoperta della tradizione, dei tratti umani, “del casalingo”, del fatto a mano, degli aspetti familiari.
Di fronte a un consumatore sempre più interessato al benessere e alla forma fisica e alla ricerca di ingredienti sani, senza conservanti e additivi, gluten free e così via, le aziende alimentari sono andate a recuperare le materie prime e gli ingredienti che più richiamano la naturalità e la sostenibilità.
“Mangiare”, ha spiegato la dottoressa,
“è un atto sempre più personalizzato, e gli alimenti devono farci stare bene.
Dopo aver assunto cibi bakery non bisogna sentirsi appesantiti, con gonfiore di stomaco, ma, al contrario, avere una sensazione di benessere, e avendo presente questo obiettivo si sono mosse le aziende alimentari”.
Tra le novità anche il ruolo delle etichette, oggi ricche di più informazioni (non solo sugli ingredienti, ma anche sul processo).
Parte del lavoro di innovazione ha riguardato gli imballaggi, anch’essi all’insegna della sostenibilità con una forte attenzione al riciclo dei materiali utilizzati.
utilizzata sia per selezionare frazioni ricche in fibra, sia frazioni ricche in proteine.
VERSO LA SOSTENIBILITÀ
La docente ha infine ricordato che le innovazioni non si limitano all’aggiunta o alla riduzione di elementi. Un campo di lavoro molto interessante si spinge verso le colture sostenibili: cereali, semi cereali, leguminose e altri ingredienti legati al territorio come, ad esempio, la farina di castagne, o più recentemente la farina di ghiande. Un ulteriore esempio virtuoso di innovazione riguarda l’utilizzo di sottoprodotti della lavorazione. Si tratta di una buona pratica di economia circolare che utilizza gli scarti di cereali e, in alcuni casi, anche sottoprodotti che derivano da altre trasformazioni, come frutta e verdura.
C’è infine la questione dei nuovi ingredienti, tra cui la farina di insetti. In questo campo bisogna sempre valutare gli aspetti nutrizionali e il loro comportamento; è molto importante poi identificare la loro potenziale destinazione d’uso, la loro accettabilità, i possibili rischi e gli aspetti economici. In ogni caso la riformulazione di un prodotto è sempre una cosa complessa. È come un gioco da incastro, in cui ogni ingrediente influenza tutti gli altri: ha un impatto sui loro comportamenti e sul prodotto finito nel suo insieme.
Un campo di lavoro molto interessante si spinge verso le colture sostenibili
PASTA FRESCA, BOOM DI VENDITE SOLO IN INVERNO?
L’ANALISI DI TUIDI RIVELA LE TENDENZE REGIONALI E LE VARIABILI CHE INFLUISCONO SUL MERCATO.
DA NORD E SUD ITALIA ECCO COME TURISMO, POSIZIONE GEOGRAFICA E PROMOZIONI RIDEFINISCONO
LE PREFERENZE DEI CONSUMATORI
La pasta fresca, simbolo della tradizione culinaria italiana, è generalmente associata al periodo invernale, ma recenti dati raccolti da Tuidi, azienda foodtech che, attraverso modelli basati sull’intelligenza artificiale, automatizza la gestione dello stock dei distributori, mostrano come le dinamiche di vendita di questo prodotto siano influenzate da molteplici fattori, tra cui stagionalità, posizione geografica e presenza turistica.
Un’analisi dettagliata delle vendite in diversi punti vendita distribuiti tra il Nord e il Sud
Italia conferma che, in media, le vendite di pasta fresca aumentano del 28% al nord e del 30% al sud durante la stagione invernale, rispetto alla media delle altre tre stagioni. La settimana che precede Natale e Capodanno registra un picco significativo: al nord le vendite aumentano del 65%, mentre al sud si assiste a un incremento impressionante del 188%.
IN ESTATE, IL SOUVENIR
PREFERITO DA PORTARE IN VALIGIA
L’analisi di due supermercati situati in Puglia, uno ad Alberobello, rinomata meta turistica, e l’altro a Bari, in un quartiere residenziale, ha evidenziato differenze sostanziali: durante l’estate, il punto vendita di Alberobello ha registrato un aumento delle vendite del 91% rispetto a quello di Bari. Questo risultato è dovuto probabilmente all’afflusso di turisti stranieri, i quali acquistano la pasta fresca come souvenir delle loro vacanze, mentre il

Nel contesto dinamico e competitivo della GDO, è cruciale anticipare gli andamenti del mercato, prevedendo come questi impattano ogni volta le vendite
supermercato di Bari, servendo una clientela prevalentemente locale e meno turistica, non mostra lo stesso incremento.
PROMOZIONI, STAGIONALITÀ E
CONDIZIONI METEREOLOGICHE
Anche le strategie promozionali giocano un ruolo significativo: per esempio, una promozione sui sughi pronti può portare a incrementi del 11% nelle vendite di pasta fresca, evidenziando come l’impatto di variabili esogene ed endogene – come le condizioni meteorologiche, la stagionalità e le promozioni – possa essere quantificato in anticipo, consentendo di sapere come agire sulle vendite future. Non tutti i prodotti sono influenzati ogni giorno e nella stessa misura da variabili esogene o da comportamenti particolari di altre referenze, tuttavia, sfruttare un algoritmo di intelligenza artificiale, permette di non tralasciare anche i casi più complessi in cui queste situazioni si verificano.
“Nel contesto dinamico e competitivo della GDO, è cruciale anticipare gli andamenti del mercato, prevedendo come questi impattano ogni volta le vendite”, afferma Andrea Paparella, Responsabile commerciale di Tuidi. “Attualmente, la gestione standard del planogramma non consente di affrontare le fluttuazioni future della domanda e talvolta, potrebbe portare alla presenza di un assortimento non in linea con le richieste di un mercato in continua evoluzione. Questo problema viene superato grazie all’IA, che, prevedendo le vendite future”.
A tal proposito Tuidi ha sviluppato Delphi, una piattaforma innovativa che sfrutta modelli prescrittivi di intelligenza artificiale per automatizzare la gestione del punto vendita. “Le evidenze di un nostro cliente dimostrano che, grazie a una gestione flessibile dell’assortimento, è stato possibile ridurre del 23% la sua giacenza media dal 2021 al 2024, a parità di valore delle vendite. Questo significa che, grazie all’intelligenza artificiale, è possibile venire incontro ad ambo i lati del mondo GDO: domanda dei clienti e offerta dei retail”.
TUIDI www.tuidi.ai

Francesco Fiorente Esperto in Pest Management Sostenibile

Francesco Nicassio Esperto in Pest Management Sostenibile
FRAMEWORK INTEGRATO
PER IL PEST MANAGEMENT SOSTENIBILE
IL VALORE DI UNI 11956 E DELLE BEST PRACTICE DI SETTORE
Il “pest management sostenibile” si pone oggi come elemento chiave per garantire non solo l’efficacia e l’efficienza dei trattamenti e delle attività di disinfestazione e derattizzazione (compresi la prevenzione e il monitoraggio), ma anche la tutela dell’ambiente, della salute umana e del benessere animale, nonché gli impatti sulla società e sui lavoratori. In un contesto globale segnato dalla necessità di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030), le attività di controllo degli infestanti non possono limitarsi alla sola rimozione di parassiti e roditori, bensì devono integrarsi in un modello che consideri l’intero ecosistema e il ciclo di vita dei prodotti utilizzati.
Il Regolamento (UE) 528/2012 (Biocidi) ha introdotto da tempo un quadro normativo volto a promuovere l’uso sostenibile e la valutazione del rischio dei prodotti biocidi, stabilendo criteri rigorosi per l’immissione in commercio e l’impiego di sostanze attive con particolare attenzione all’impatto ambientale e tossicologico. Contemporaneamente, il Regolamento (UE) 848/2018 sulla produzione biologica ha definito i principi per un’agricoltura che privilegia tecniche e sostanze naturali, richiamando l’urgenza di evitare contaminazioni chimiche lungo tutta la filiera agroalimentare. Allo stesso tempo, la Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con il D.Lgs. 150/2012 e il
DM 22 gennaio 2014 (Piano di Azione Nazionale - PAN), che istituisce un quadro comunitario per ridurre al minimo i rischi per la salute umana e l’ambiente derivanti dall’uso dei pesticidi, ha contribuito a costituire il contesto di riferimento specifico.
Integrare tutti questi input significa, per un’azienda di disinfestazione e per i fruitori del servizio, adottare protocolli di trattamento basati su:
1. Valutazione quantitativa del rischio (analisi del pericolo e probabilità di contaminazione).
2. Scelta di prodotti e attrezzature che riducano al minimo l’uso di sostanze pericolose e che consentano un’applicazione appropriata delle stesse.

UNI 11956:2024 definisce un quadro organico in cui i requisiti organizzativi e quelli di servizio si integrano per assicurare interventi di disinfestazione e derattizzazione misurabili, responsabili e in accordo con i principi ESG e l’Agenda 2030
3. Pest proofing e interventi mirati che prevengano l’insorgere di nuove infestazioni.
4. Monitoraggio continuo tramite trappole e tecniche non chimiche ove possibile.
L’inquadramento del tema nel contesto normativo europeo sottolinea come le attività di disinfestazione e derattizzazione debbano evolvere (e lo stiano di fatto già compiendo) da semplici interventi reattivi a processi integrati, trasparenti e misurabili, in linea con i principi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG). In ogni caso, la richiesta e la fornitura di servizi con requisiti di sostenibilità non potranno essere sganciate dall’individuare dei requisiti specifici per
l’organizzazione che li progetta e li eroga in termini di impegni per la sostenibilità. In tempi recenti, l’intero settore del Pest Management italiano si è dotato di alcuni strumenti per determinare e indagare i propri livelli di sostenibilità, anche prendendo spunti e raccogliendo feedback da altri settori e, non di meno, recependo le richieste delle parti interessate.
In particolare, all’interno di questo contributo, sarà svolta una panoramica e un confronto tra la norma UNI 11956:2024 “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) sostenibile - Requisiti”, la prassi di riferimento UNI/ PdR 145:2023 “Pest management nelle imprese del settore agroalimentare della produzione biologica - Requisiti del servizio” e il documento tecnico promosso da
ANID “Gestione degli infestanti con metodi biologici orientati alla sostenibilità”.
NORMA UNI 11956:2024
Lo standard UNI 11956:2024 “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) sostenibile - Requisiti” pubblicato il 26 settembre 2024 ha l’obiettivo di incentivare percorsi sostenibili nel settore della disinfestazione, elevando professionalità, competitività e trasparenza delle organizzazioni e della loro filiera.
La sua redazione è stata promossa in sede UNI da AIDPI, Associazione delle Imprese di disinfestazione professionali italiane.
Si tratta di una norma la cui conformità sarà valutata secondo UNI CEI EN ISO/IEC
Le attività di disinfestazione e derattizzazione devono evolvere da semplici interventi reattivi a processi integrati, trasparenti e misurabili

17065 (valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi).
I requisiti si articolano su vari livelli, mettendo in risalto in particolare:
§ I principi generali: sviluppo di piani di gestione degli infestanti che minimizzino impatti ambientali, sociali ed economici, fondati su un’analisi oggettiva del rischio.
§ I requisiti dell’organizzazione (Cap. 5): politiche, ruoli, processi e formazione interni per supportare la sostenibilità.
§ I requisiti del servizio (Cap. 6): criteri di selezione dei prodotti, tecniche di intervento, pest proofing, monitoraggio e gestione attrezzature.
§ Le appendici informative: guide per l’autovalutazione, matrici di sostenibilità e protocolli tecnici.
Basandosi fortemente sui requisiti di UNI EN 16636:2025, la norma stabilisce in ottica di materialità e facendo proprio il modello di business basato sull’accountability e l’orientamento all’etica e alla trasparenza, i requisiti specifici sia per l’organizzazione che per il servizio, con tre “risorse vitali” – cliente, collaboratori e risorse naturali. Relativamente ai requisiti per l’organizzazione, essi considerano e impegnano l’organizzazione in numerose attività, quali la definizione di una politica aziendale sulla sostenibilità, condivisa con stakeholder, la nomina di un referente di alta direzione per la sostenibilità, la definizione di un protocollo di qualifica dei fornitori in ottica ESG e una attività di risk assessment per ogni aspetto di sostenibilità. Nel pianificare e valutare il rischio delle azioni legate alla sostenibilità sarà, inoltre, necessario identificare gli SDGs rilevanti, pertinenti
al contesto aziendale e al servizio erogato. Relativamente ai requisiti del servizio, UNI 11956 si innesta sul flusso di processo del servizio già introdotto da UNI EN 16636 nel 2015, enfatizzando in ogni passaggio gli aspetti legati alla sostenibilità, pur consentendo all’organizzazione di erogare servizi “convenzionali” o con un grado di sostenibilità anche inferiore. Una novità rilevante è appunto la possibilità di calcolare l’indice di sostenibilità attraverso un modello numerico che integra parametri ambientali, sociali e di efficacia per definire, appunto, il “grado” di sostenibilità di ciascun servizio proposto, con riferimenti oggettivi (per es. al regolamento “CLP” per quanto concerne l’indice di pericolosità per la salute umana e l’impatto ambientale delle sostanze, al D.Lgs. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza delle
Il Regolamento (UE) 848/2018 sulla produzione biologica ha definito i principi per un’agricoltura che privilegia tecniche e sostanze naturali
persone e alle modalità di corretto impiego dei prodotti e dei dispositivi, etc.). Una forte enfasi è inoltre data ai requisiti e le appendici (alcune normative, altre informative) che si occupano di descrivere le attività e i criteri per la formazione del personale, la gestione delle attrezzature, la selezione dei biocidi più favorevoli in termini di sostenibilità e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della sostenibilità, non limitandosi naturalmente ai soli aspetti ambientali, ma anche considerando i temi etico-sociali e di governance. UNI 11956:2024 definisce, pertanto, un quadro organico in cui i requisiti organizzativi e quelli di servizio si integrano per assicurare interventi di disinfestazione e derattizzazione misurabili, responsabili e in accordo con i principi ESG e l’Agenda 2030. Questi elementi forniscono alle aziende non solo linee guida, ma anche strumenti concreti per dimostrare la propria sostenibilità lungo l’intera catena del valore.
PRASSI DI RIFERIMENTO
UNI/PDR 145:2023
La UNI/PdR 145:2023 “Pest management nelle imprese del settore agroalimentare della produzione biologica - Requisiti del servizio”, pubblicata l’11 maggio 2023 e a diffusione gratuita, introduce di fatto buone pratiche in assenza di norme settoriali. Anche in questo caso, l’iniziativa relativa alla sua preparazione in sede UNI è stata promossa da AIDPI. Di fatto, il suo scopo è stato quello di colmare il vuoto applicativo delle norme sulla produzione biologica in ambito agroalimentare (Reg. UE 2018/848), estendendo principi e metodi ai servizi di disinfestazione negli ambienti di lavorazione, con l’obiettivo di garantire la protezione dagli infestanti nel rispetto della normativa sulla produzione biologica. Questo include tutte le fasi, dalla post-raccolta fino alla distribuzione al consumatore finale, anche per ambienti zootecnici e mangimifici.
La prassi presente un ricco sommario che riporta l’approccio alla gestione degli infestanti nel settore agroalimentare della produzione biologica , le modalità di ispezione del sito e la definizione del documento di risk assessment, la definizione del piano di pest management (enfatizzando l’assistenza al cliente, le misure di esclusione degli infestanti, l’adeguata elaborazione di un piano di monitoraggio e la gestione delle non conformità relative agli infestanti), la contaminazione da residui derivante dall’attività di pest management, la tracciabilità e il personale. Completano la prassi tre appendici informative.
Tra i principi operativi, si possono citare senza dubbio l’analisi del rischio e il monitoraggio continuo, il pest proofing e adeguamento dei parametri ambientali, la scelta di attrezzature e prodotti con bassa persistenza e impatto. Altri elementi chiave di rilievo sono:
§ Coinvolgimento attivo di esperti tecnici e Operatori del Settore Alimentare (OSA) nella valutazione dei rischi e nella stesura dei piani di intervento.
§ Focus sul monitoraggio continuo e sull’uso prioritario di metodi alternativi (fisici, biologici, repellenti) prima di ricorrere a metodi chimici o biocidi.
§ Importanza della tracciabilità completa, aggiornamento costante dei dati e comunicazione con il cliente.
§ Formazione interna al personale per garantire una corretta integrazione delle attività di controllo: nell’Appendice C sono descritte le competenze e requisiti per il Tecnico Esperto, il Referente Tecnico e l’Operatore Tecnico nelle filiere bio.
DOCUMENTO TECNICO ANID
Il “Documento tecnico sulla gestione degli infestanti con metodi biologici orientati alla sostenibilità”, elaborato da ANID (Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, versio-
ne corrente di febbraio 2024), in collaborazione con l’ente di certificazione ICEA, mira a stabilire pratiche per la gestione degli infestanti prediligendo metodologie biologiche e orientate alla sostenibilità, non solo nel settore agroalimentare. ANID mette l’accento sulla conformità alle normative UE e sull’integrazione dei principi della sostenibilità. Si tratta, quindi, di un documento che tende ad ampliare gli orizzonti descritti da UNI/PdR 145:2023, sebbene ne ricalchi appieno gli obiettivi e l’approccio. Anche in questo caso, è evidente la necessità della responsabilizzazione degli operatori e dei fruitori verso i nuovi requisiti UE, colmando il vuoto normativo sugli ambienti extra-agricoli e della definizione di modalità di intervento per prevenire residui chimici e per adottare tecniche di prevenzione, monitoraggio, contrasto e contenimento basate su un approccio integrato.
Le fasi di processo descritte nel documento tecnico sono le medesime descritte in UNI EN 16636, fornendo, poi, principi generali relativamente alla prevenzione, al monitoraggio, alla lotta e al contrasto alle infestazioni, alle attività di post-raccolta e ai contaminanti biotici:
§ Il pest-proofing e altre strategie fisiche, strutturali e comportamentali mirano a ridurre al minimo l’accesso e la proliferazione degli infestanti.
§ La sorveglianza regolare degli infestanti con trappole e audit frequenti.
§ Viene enfatizzata la selettività per proteggere le specie non bersaglio.
§ Priorità ai metodi biologici e fisici, come il controllo fisico, biologico e l’impiego di feromoni, evitando l’uso di sostanze chimiche di sintesi quando possibile.
§ Interventi correttivi per gestire infestanti in derrate biologiche con tecnologie ammesse come le atmosfere modificate e le temperature controllate.
§ Strategie per la gestione dei contaminati biotici.

La richiesta e la fornitura di servizi con requisiti di sostenibilità non potranno essere sganciate dall’individuare dei requisiti specifici per l’organizzazione che li progetta e li eroga in termini di impegni per la sostenibilità
Un capitolo specifico è destinato alla gestione delle infestazioni nelle aree verdi urbane ed extra-agricole, in accordo con il PAN.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
Tra i punti comuni tra i documenti emergono:
§ L’enfasi sull’importanza dell’analisi del rischio e del monitoraggio continuo.
§ Cruciale la formazione e lo sviluppo delle competenze delle figure professionali e la condivisione di protocolli chiari con stakeholder e fornitori.
§ Viene privilegiato l’uso di tecniche
che minimizzino l’uso di sostanze chimiche e riducano gli impatti ambientali e sociali.
In tale contesto, emerge che UNI 11956 rappresenti uno strumento completo per affrontare le sfide attuali e future in termini di sostenibilità del comparto del pest management, grazie alla sua visione globale che include, in un percorso piuttosto naturale, le indicazioni della PdR 145 così come del Documento tecnico ANID.
L’esistenza di questi strumenti volontarinorma, prassi e linee guida tecniche - rafforza la capacità del settore di:
CONFRONTO: PUNTI DI CONTATTO E DIFFERENZE
UNI 11956:2024
Tipologia
UNI/PdR 145:2023
§ Standardizzare processi e competenze su base ESG.
§ Innovare attraverso tecniche a basso impatto e digitalizzazione (IoT per trappole, modelli di calcolo, app di monitoraggio).
§ Comunicare in modo trasparente risultati e indicatori di sostenibilità.
Nei prossimi anni, la sfida sarà far convergere in maniera più sistematica questi approcci in un framework integrato, che valorizzi la conformità normativa (UNI 11956), l’adattabilità delle prassi (PdR 145) e l’efficacia delle tecniche biologiche e orientate alla sostenibilità (ANID), per garantire servizi di pest management sempre più responsabili e riconosciuti anche dagli stakeholder esterni.
Non per ultimo, tra le prospettive connesse all’adozione e alla diffusione della norma UNI 11956, vi è l’auspicio che essa possa presto attirare l’attenzione anche degli Enti di Certificazione e di Accredia, con l’obiettivo di renderla quanto prima riconoscibile e certificabile, rafforzandone così la valenza operativa e il potenziale di diffusione nel settore.
Norma di servizio (requisiti oggettivi), certificabile Prassi di riferimento (buone pratiche)
Ambito Tutti i servizi professionali di pest management
Focus
Approccio
Competenze
Strumenti
Calcolo della sostenibilità del servizio; approccio IPM; pianificazione in materia di sostenibilità
Risk assessment, KPI oggettivi, SDGs
Formazione ESG & risk assessment
Politica aziendale, protocollo fornitori, matrice di calcolo dell’indice di sostenibilità
Servizi di disinfestazione in contesti bio-agroalimentari
Applicazione dei principi bio; approccio IPM; competenze tecniche
Risk assessment, monitoraggio, pest proofing
Tecnico Esperto, Referente Tecnico, Operatore
Appendici C, residui, tracciabilità, fasi di processo dettagliate
Documento tecnico ANID
Documento tecnico (linee guida settoriali / buone pratiche)
Tutti i servizi professionali di pest management, con focus particolare al settore agroalimentare bio
Applicazione dei principi bio; approccio IPM;
Prevenzione, monitoraggio, trattamento biologico/fisico
Specializzazione in tecniche biologiche e gestione integrata
UNI EN 16636, trappole smart, pest proofing
LA SICUREZZA ALIMENTARE PARTEDALLA PREVENZIONE
Ogni anno, il 7 giugno, si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2019, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che gli alimenti contaminati o deteriorati possono avere sulla salute delle persone. Rentokil – azienda specializzata nella gestione degli infestanti del gruppo Rentokil Initial – con una lunga esperienza sul campo, è ben consapevole delle gravi minacce che rappresentano gli infestanti per il settore alimentare.
Che si tratti di insetti volanti o striscianti, roditori o infestanti delle derrate alimentari, la protezione degli alimenti è cruciale per salvaguardare la salute e la reputazione delle attività commerciali. Ogni anno sono 600 milioni le persone che, nel mondo, si ammalano a causa di circa 200 tipi diversi di malattie di origine alimentare [1], un dato che evidenzia l’importanza di azioni concrete per prevenire e gestire i rischi di contaminazione, attraverso soluzioni professionali e controlli accurati dei processi di produzione e di stoccaggio degli alimenti, sia negli stabilimenti produttivi che in bar, ristoranti o supermercati.
GLI INSETTI DELLE DERRATE ALIMENTARI
“La sicurezza alimentare inizia molto prima della tavola: parte dai luoghi in cui il cibo viene prodotto, trasformato, stoccato e distribuito. Proteggere questi ambienti dagli infestanti è essenziale per prevenire danni significativi a strutture, attrezzature e scorte”, sottolinea Cristian Cavalletto, Business Unit Pest Control Director di Rentokil Initial Ita-

lia. “La contaminazione del cibo che viene poi consumato, infatti, è quella più dannosa, perché va a influire direttamente sulla salute delle persone”.
Tra gli infestanti più dannosi per la filiera agroalimentare, gli insetti delle derrate alimentari rappresentano una delle principali cause di contaminazione con conseguenti perdite di materie prime e prodotti finiti. Per far fronte alla problematica, Rentokil propone una soluzione ecologica, sicura ed efficace per il settore: il trattamento ad alte temperature. Un servizio innovativo capace di eliminare tutte le fasi vitali degli infestanti – dalle uova agli adulti – senza l’utilizzo di sostanze chimiche o nocive. Questa soluzione consente il riutilizzo immediato dei locali trattati, garantendo la continuità operativa. “Grazie a servizi come il trattamento ad alte temperature, offriamo una soluzione studia-
ta e progettata ad hoc in modo da rispondere efficacemente alle esigenze specifiche di ciascun cliente per contrastare efficacemente gli infestanti delle derrate alimentari”, commenta Cristian Cavalletto.
Oltre ai servizi di disinfestazione e monitoraggio, Rentokil offre anche un’ampia gamma di soluzioni di proofing, studiate per impedire l’ingresso di infestanti – in particolare roditori e insetti striscianti– all’interno dei siti produttivi. Queste soluzioni preventive mirano a sigillare i punti di accesso, riducendo drasticamente la possibilità che topi o altri infestanti entrino in contatto con le materie prime o con i prodotti finiti. Limitandone l’accesso al cibo, si abbassa in modo significativo il rischio di contaminazione e proliferazione.
RENTOKIL INITIAL www.rentokil.com
Diverse CSB web solutions sono state consolidate nell’ERP
SICUREZZA ALIMENTARE E CONTROLLO DEI COSTI
Qualità

Quanto costa oggi introdurre in azienda un sistema per il controllo qualità e uno per la gestione della manutenzione? Ma la domanda giusta forse sarebbe: quanto costa non averli? Il Controllo Qualità e il modulo di Gestione della Manutenzione dell’ERP CSB-System, disponibili anche in app, sono totalmente integrate nel CSB-System, ERP completo, modulare e specifico per il settore alimenti & bevande, e rappresentano il giusto bilanciamento tra un sistema standard preconfigurato e la capacità di adattarsi alle particolarità specifiche dell’azienda.
QUALITÀ DEI PRODOTTI
GARANTITA
CSB-System gestisce con accuratezza non solo le prove obbligatoriamente prescritte dalla normativa ma anche quelle individuali decise dall’azienda: regolamenti UE, BRC,
Global GAP, HACCP, IFS Food e SQF. I responsabili delle varie aree aziendali, in collaborazione con gli esperti CSB-System, individuano una “rete” di punti di informazione e controllo, i cosiddetti Critical Control Points ai quali collegare postazioni fisse, ad esempio i CSB Rack, o eventuali dispositivi mobili per il rilevamento dati. Le informazioni sono così inserite, registrate e analizzate online nel CSB-System, senza soluzione di continuità. Qualora ci siano degli scostamenti dai parametri prestabiliti, è il gestionale stesso a comunicare automaticamente la non conformità al responsabile della qualità per poter avviare poi le azioni correttive.
TUTTE LE ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE IN PUGNO
La gestione della manutenzione serve a ottimizzare la disponibilità e l’impiego a lungo termine di tutti gli impianti, tenendo conto

dei risultati di produzione desiderati. Errori e malfunzionamenti rilevati sono eliminati in modo sistematico e secondo regole stabilite. Nel tempo, il sistema “impara da solo” definendo automaticamente, in base allo storico, nuove attività di manutenzione o modificando gli intervalli di tempo delle azioni ricorrenti. Per questa ragione i costi si riducono e il ciclo di vita degli impianti si allunga.
GESTIONE DI AUDIT
E CERTIFICAZIONI CON UN UNICO ERP
I dati raccolti confluiscono nella Gestione Certificazioni CSB: così facendo il gestionale, in qualsiasi momento, è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sulla struttura organizzativa e sui processi aziendali per gli audit e le certificazioni.
CSB-SYSTEM www.csb.com





Alitest Srl
Soluzioni di Qualità
Contaminazioni alimentari: quali sono le conseguenze?
Ogni anno si contano centinaia di richiami di prodotti alimentari con contaminazione batterica, per la presenza di agenti patogeni pericolosi quali Escherichia Coli, Listeria, Pseudomonas, Salmonella, Sta lococco aureo e molti altri. Le conseguenze di un richiamo possono essere disastrose per le aziende produttrici: -danni alla salute pubblica -costi dovuti a tutte le procedure di richiamo e ritiro previste dalla normativa vigente -blocco della produzione per veri care l’integrità delle linee produttive -danno di immagine per il marchio e per il produttore -cause legali e danni inestimabili -ingenti perdite economiche
Perchè attendere o rischiare tutto questo ? Abbiamo la soluzione
Bioluminometro NOVALUM II X
la soluzione e cace per prevenire le contaminazioni alimentari
L’utilizzo del bioluminometro NLII X, ogni giorno, permette un monitoraggio continuo e tempestivo dell’igiene delle linee di produzione per la rilevazione dell’ATP, riducendo sensibilmente il rischio di contaminazione batterica, Escherichia Coli, Listeria, Pseudomonas, Salmonella, Sta lococco aureo e molti altri. Una prevenzione adeguata che prevede il costante monitoraggio con i tamponi rapidi che rilevano la presenza di ATP (adenosintrifosfato) in soli 5 secondi, consentendo di ridurre i rischi di contaminazione batterica e garantendo la sicurezza e la qualità dei prodotti.






