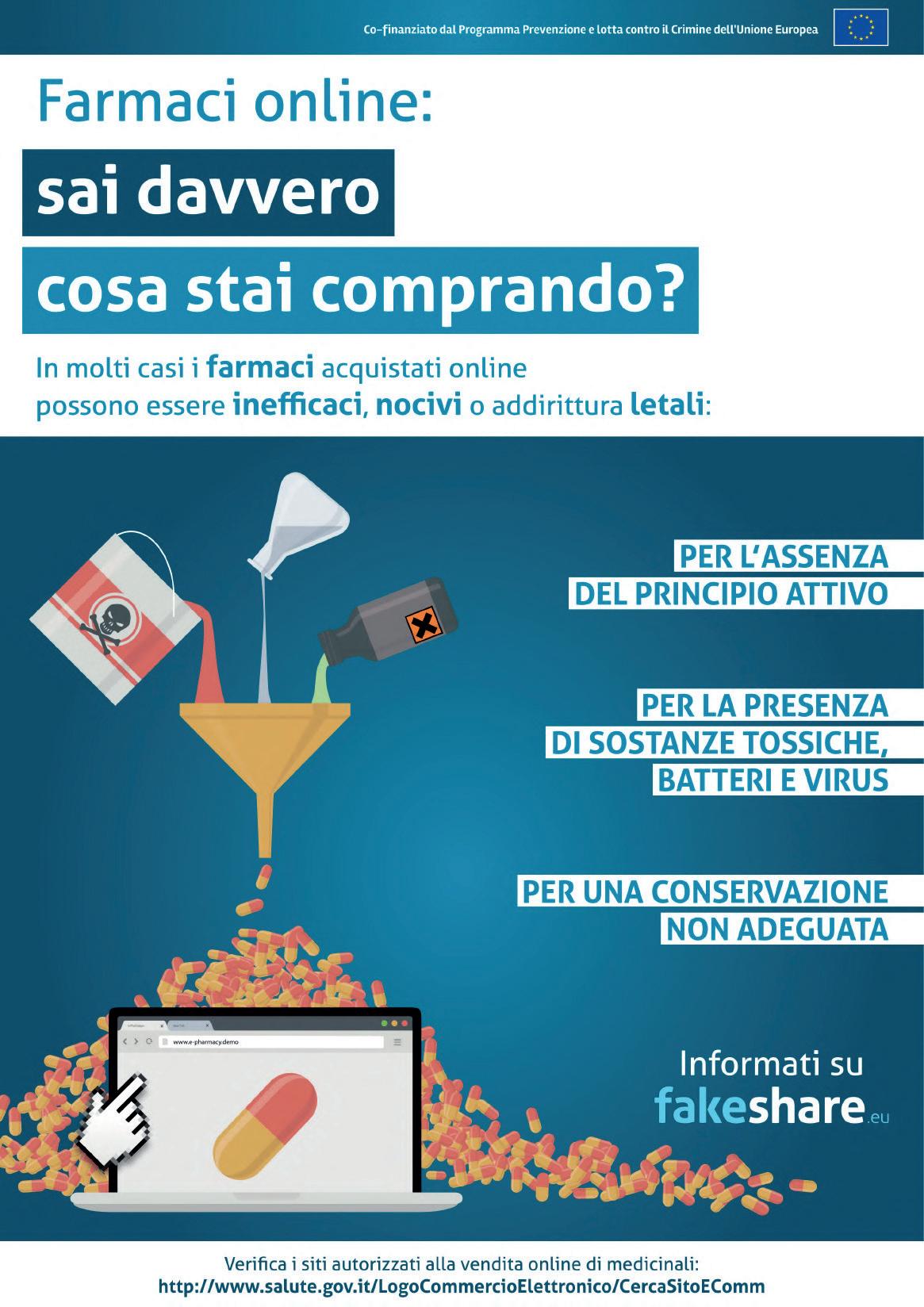4 minute read
L’INCHIESTA
RICERCATORI DI STABILITÀ
I precari della ricerca sanitaria hanno vissuto dei passi in avanti. Ma restano molte criticità
Advertisement
di Stefano Iannaccone
Per lavoro fanno ricerca. E per necessità sono alla ricerca costante di un contratto. È il destino dei ricercatori della sanità italiana, considerati un’eccellenza, come testimonia la visibilità dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Ma non è certo l’unico centro in cui ci sono tanti profili di elevata competenza. Qualità a cui non corrisponde una stabilità contrattuale: la precarietà è il marchio distintivo per i circa 3mila ricercatori. E non va meglio sotto l’aspetto salariale: la busta paga si ferma sui 1.500 euro mensili. Tanto da rendere improponibili i paragoni con gli altri Paesi europei, ancora peggio se si parla di Stati Uniti. Va detto che la condizione è migliorata rispetto solo a qualche anno fa. In alcuni casi lo stipendio raggiungeva a malapena i mille euro. È stata l’ex ministra Beatrice Lorenzin a ottenere un cambio di passo. Ma c’è bisogno di ulteriori interventi.
La questione è legata alla tipologia contrattuale: medici, biologi, farmacisti sono inquadrati con un contratto di comparto, equiparati dunque a figure tecnico-sanitarie, non quello della dirigenza che avrebbe ben altra remunerazione. Questo genera degli squilibri. La questione è stata spiegata dal sindacato medico Anaoo Assomed: “Negli Irccs esiste una parte sanitaria e una di ricerca. I ricercatori lavorano fianco a fianco con i coloro colleghi, ma hanno un contratto diverso”. Così mentre c’è chi inizia il percorso di carriera con un salario sopra 2.500, il ricercatore, se va bene, ne prende circa mille in meno. Con prospettive incerte.
Quando si parla di ricerca sanitaria, il riferimento va agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs): in totale sono 51 sul territorio italiano, di cui 20 pubblici e 31 privati. La questione lavorativa riguarda quelli pubblici. Agli Irccs vanno aggiunti dieci Izs (Istituti zooprofilattici sperimentali) che contano 90 sezioni diagnostiche periferiche. Tra gli Irccs pub-
L’anno scorso, in seguito all’applicazione della riforma “piramide della ricerca”, gran parte del personale precario della ricerca impiegato presso gli Irccs e Izs pubblici è stato inquadrato con contratti a tempo determinato di 5 anni, tramite l’istituzione delle figure professionali del ricercatore sanitario e del collaboratore alla ricerca. blici, oltre allo Spallanzani, ci sono, il Policlinico San Matteo di Pavia, il Policlinico San Martino di Genova, città in cui ha sede anche il Gaslini. Ma anche l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l’Istituto Nazionale Tumori Giovanni Pascale di Napoli, l’Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari. In sintesi: il top della ricerca biomedica italiana.
Qualcosa è stato fatto, si diceva. La riforma Lorenzin ha introdotto il meccanismo della piramide della ricerca, uno strumento che ha reso possibile una piccola, grande rivoluzione: porre fine all’impiego di tipologie contrattuali disparate, su tutte co.co.pro, borse studio e cose simili, in favore della sottoscrizione di contratti a tempo determinato di cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque anni sulla base della valutazione del lavoro svolto. La piramide alla ricerca ha avuto il merito di introdurre dei contratti nuovi sotto questo profilo: prima non era possibile. La riforma, per la sua mole di complessità, ha richiesto tempo: è stata poi messa a regime dall’attuale ministro della Salute, Roberto Speranza.
“L’anno scorso, in seguito all’applicazione della riforma “piramide della ricerca”, gran parte del personale precario della ricerca impiegato presso gli Irccs e Izs pubblici è stato inquadrato con contratti a tempo determinato di 5 anni, tramite l’istituzione delle figure professionali del ricercatore sanitario e del collaboratore alla ricerca”, spiegano a Professione Sanità dall’Associazione ricercatori in Sanità Italia (Arsi). I passi in avanti ci sono stati. Ma permangono delle criticità. Uno dei nodi resta la prospettiva futura, ossia l’inserimento nel mondo del lavoro dopo i dieci anni di ricerca. Bisogna infatti spianare la strada a eventuali problemi, perché il rischio è concreto: al termine del percorso, questi professionisti potrebbero trovarsi in un limbo privo di certezze, in un’età non più giovanissima, tra 45 e i 55 anni. “Le nuove generazioni sono particolarmente colpite: ed è quasi ovvio che poi decidano di andare via, in Paesi dove sono valorizzati oltre che meglio retribuiti”, osserva Alberto Spanò, dell’Anaao Assomed.
Un’altra criticità “è l’inclusione nei nuovi contratti anche dei colleghi che sono stati esclusi dalla riforma per cavilli normativi e lo sblocco dei concorsi per i nuovi ingressi”, sottolineano dall’Arsi. Per questa la richiesta si muove su due fronti: l’istituzione della figura del ricercatore a tempo indeterminato e l’aumento dei finanziamenti per la ricerca. “Difatti - riferisce l’associazione dei ricercatori - nel decreto rilancio sono stati previsti aumenti nei finanziamenti solo per Cnr ed Università”. E fin qui nulla in contrario. Il punto è che così si vanfiiano gli sforzi di ricerca negli Irccs dove si lavora a “nuove terapie e cure volte al miglioramento della salute pubblica”. Il giudizio Spanò è anche più severo: “I ricercatori sono stati grandi protagonisti di questa vicenda pandemica. Mentre altri profili professionali sono stati giustamente riconosciuti come attori fondamentali di questa fase, i ricercatori sono stati in buona parte ignorati”.
Il discorso diventa ancora più doloroso, quando si vede che molti ricercatori italiani sono all’estero, potando le loro competenze altrove. In questo senso basta ascoltare qualche talk show o sfogliare le pagine dei giornali per scoprire che il top della ricerca negli istituti stranieri porta la firma di professionisti italiani. Risulta, peraltro, difficile realizzare una mappatura di quanti siano “scappati” oltre i confini. Perché questa può maturare in vari passaggi della vita da ricercatore. Ma, al di là dei vari aspetti, resta il problema centrale: la scarsa valorizzazione, economica e di stabilità, delle professionalità favorisce le partenze. Per questo viene rivolto un appello al governo e in particolare al ministro Speranza: “Il patrimonio, rappresentato dai nostri ricercatori è enorme e non va disperso. Per evitare che ciò accada c’è la necessità di rendere la ricerca italiana più competitiva”, sintetizzato dall’Arsi.