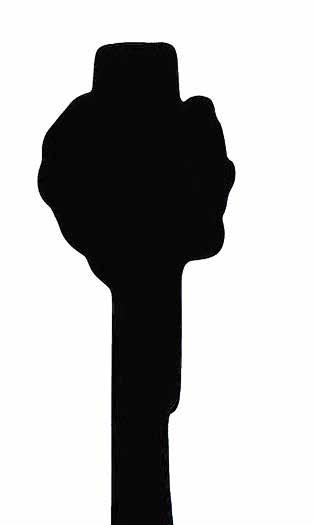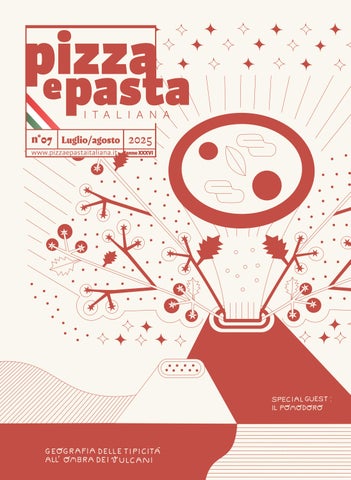





















storie

storie di
Agostino Coppola, Presidente
Marco D’Arrigo
di Giusy Ferraina

storie di pizza
Tutte donne
tranne me

Vianello
di Noemi Caracciolo
Alfonso Del Forno
aziende informano cmp '25
Demetra p. 30
5 Stagioni p. 60
aziende informano
Il Faggetto p. 74
Osservatorio Host p. 84
Scuola Italiana Pizzaioli p. 29
luglio/agosto 2025
COLOPHON
Antonio Puzzi
Sono nato a Napoli e lo rivendico sempre con orgoglio. Napoli è, infatti, una città che ha valicato i termini dell’essere un semplice “luogo dell’abitare” per diventare un “fatto sociale”. E non si tratta di dimensioni o di densità abitativa ma di una condizione che poche altre città nel mondo hanno. Forse, la chiave del successo di questo “luogo culturale” sta nel fatto di rappresentare una coincidenza degli opposti che ha alimentato per secoli e millenni la fantasia dei pensatori, degli artisti e della gente comune. Napoli è terra di miti (le Sirene, 'o munaciello, Maradona), luogo comune (tanti sono gli stereotipi legati alla napoletanità) e stato d’animo. Pensate che la cantante Serena Brancale ha recentemente dichiarato: «Io sono orgogliosa, tanto, di essere pugliese. Ma, come disse una volta Lucio Dalla: “Se dovessi tornare a nascere, vorrei nascere napoletana”». Nei miei ormai 44 anni, ho sviluppato alcune considerazioni su questa mia città, che vorrei condividere con voi. La prima è che Napoli la si ama o la si odia, sentimento tanto più accentuato dal fatto che qualsiasi cosa accada qui ha una eco almeno nazionale: dall’andare in motorino senza casco allo scudetto. La seconda è che non si smette mai di essere napoletani: ci si può trasferire, cambiare lavoro e città, parlare altre lingue ma la napoletanità non ti abbandona, a partire dalla cadenza che, indelebile, accompagna ogni parola che esce dalla nostra bocca.
E, in tutto questo discorso, una menzione a parte meritano la pizza e la gastronomia partenopee: i cibi riconosciuti come “italiani” nel resto del mondo hanno un legame particolare con Napoli. Ma, proprio per l’amore / odio che citavo prima, provate a chiedere a una persona che vive in un’altra provincia della Campania o nel resto del Sud Italia cosa pensa di Napoli e delle sue tipicità. Se vi va bene, vi dirà che è fagocitante, dominante ed egocentrica: il suo peso schiacciante non riesce a far emergere le bellezze meno sfacciate di altri territori. Allora, noi, in questo numero, vogliamo provare ad andare oltre il velo del cielo di Napoli e guardare nella complessità al preunitario “regno delle Due Sicilie”: posso garantirvi che è un viaggio che vale la pena fare. Allacciate le cinture e partite con noi!
Buona estate!
PIZZA E PASTA ITALIANA
Mensile di Pizza, Pasta, Enogastronomia e Cultura
Edito da PIZZA NEW S.p.A.
Autorizzazione Tribunale di Venezia n.1019 del 02/04/1990
Anno XXXVI - n.7 luglio - agosto 2025 - Repertorio ROC n. 5768
DIRETTORE EDITORIALE DIRETTORE ONORARIO
Massimo Puggina Giampiero Rorato
DIRETTORE RESPONSABILE
Antonio Puzzi
PUBBLICITÀ
Caterina Orlandi
REDAZIONE
Via Sansonessa, 49 - 30021 CAORLE (VE) Tel. 0421/ 212348 - Fax 0421/81007 - E-mail: redazione@pizzaepastaitaliana.it www.pizzaepastaitaliana.it
PROGETTO GRAFICO
Manuel Rigo, Paola Dus, Elena Cazzuffi — Mediagraf lab
DIGITAL PUBLISHING
Maura Trolese — Mediagraf lab
IN COPERTINA illustrazione di Chiara Palandri
STAMPA MEDIAGRAF S.p.A.
Noventa Padovana (Pd)
COMITATO TECNICO E REDAZIONALE
Marisa Cammarano, Gianandrea Rorato, Caterina Vianello, Alfonso Del Forno, Luciano Cescon.
AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI
Pete La Chapelle (N.A.P.O. - Pizza Today, U.S.A.), P.M.Q. Steve Green (U.S.A.).
PER INFORMAZIONI, SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO O RICHIEDERE UN ARRETRATO:
TELEFONARE AL NUMERO 0421 212348 dal lun. al ven.: 10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00
INVIARE UN FAX A 0421 83178
Servizio abbonamenti Pizza e Pasta Italiana
INVIARE UNA MAIL A: abbonamenti@pizzaepastaitaliana.it L’abbonamento può avere inizio in qualsiasi momento dell’anno e dà diritto a ricevere 11 numeri della rivista. L’abbonamento andrà in corso dal primo numero raggiungibile.

PER LA PUBBLICITÀ SULLE RIVISTE:
ITALIA Pizza e Pasta Italiana; U.S.A. Pizza Today, P.M.Q.
TEL 0421.83148 — FAX 0421.81007

Satiné Tradizionali
Satiné Rosmarino
I grissini monoporzione Valledoro Satiné e Satiné Rosmarino : un tocco di raffinata originalità per la tua tavola.
Ondulati e salati al punto giusto, per un benvenuto che lascia il segno.
Scegli l'eleganza che distingue, scegli la bontà dei grissini Valledoro Satiné.

Dal 4 all’8 ottobre torna a Colonia l’edizione 2025 di Anuga. Con circa 8.000 espositori da 120 paesi e oltre 150.000 visitatori attesi da 200 paesi, Anuga si conferma il principale appuntamento al mondo per il settore Food & Beverage. La manifestazione proporrà un focus dedicato a trend e temi chiave decisivi per il mondo attuale: cibo personalizzato, sostenibilità, fonti proteiche alternative e la crescente influenza del private label saranno infatti al centro dell'attenzione. Tra i paesi esteri che espongono ad Anuga, l’Italia sarà ancora una volta grande protagonista: rappresentata con oltre 1.000 aziende, offrirà un’ampia panoramica sulla varietà dell’offerta Made in Italy.
Koelnmesse Italia
Viale Sarca 336/F info@koelnmesse.it tel: 02 8696131


Primo obiettivo, la Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026, in vista della finale mondiale del 2027
Chiamata importante per tutti i Pasticcieri italiani: al via le candidature per formare la squadra che parteciperà alla competizione europea, qualificante per la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027
Il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie annuncia ufficialmente l’apertura delle candidature per la Selezione Nazionale Italiana 2025, tappa fondamentale per comporre la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026, in programma il 19 e 20 gennaio 2026 a Parigi. La competizione continentale fungerà da selezione ufficiale per accedere alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, prevista nel gennaio 2027.
La selezione italiana si svolgerà giovedì 11 settembre 2025 presso CAST Alimenti, a Brescia, sede storica del Club Italia e centro d’eccellenza della formazione pasticcera italiana.
La competizione si terrà in forma individuale ed è aperta a tutti i professionisti del settore, da nord a sud.


Quando il pomodoro è più che buono

Verrebbe da pensare che il pomodoro sia sempre stato nostro. In fondo è parte del cuore della cucina italiana, basti pensare alla pasta al sugo, alla pizza, al ragù… difficile immaginare la nostra tavola senza. E, invece, viene da lontano e ha dovuto aspettare per diventare quello che è oggi. Il Sud, però, ha saputo accoglierlo bene, trasformandolo in ricchezza e identità; partendo dal Sudamerica, passando per la Spagna, fino ad arrivare a noi, dal San Marzano al Piennolo, al Ciliegino, al Cuore di Bue, il pomodoro è un must.
Ma la storia più potente è quella che racconta oggi. Il pomodoro, infatti, è diventato un frutto del riscatto. Oggi è al centro di progetti che parlano di giustizia, lavoro dignitoso, legalità e sostenibilità. È il fulcro di cooperative e iniziative che lo hanno reso simbolo di un impegno collettivo, fatto di scelte coraggiose. Perché sì, purtroppo non è un
segreto che dietro una passata a basso costo, troppo spesso si nascondono sfruttamento e illegalità. Oltre 180.000 lavoratori – in gran parte migranti – sono impiegati in condizioni irregolari, sotto il sole cocente, per meno di 3 euro l’ora. Un sistema disumano, fondato sul caporalato, che calpesta diritti e dignità, inquinando l’intera filiera.
Ecco perché questi progetti contano. Perché dimostrano che un’alternativa è possibile. Che il pomodoro può essere simbolo di bellezza ma anche di rispetto, giustizia e cambiamento.
C’è chi coltiva terreni confiscati alla mafia, come Libera Terra, le cui cooperative lavorano con metodi biologici, rispettando ambiente e diritti dei lavoratori (Sicilia e Puglia). Raccogliendo e lavorando manualmente, custodiscono i sapori autentici del Sud, coltivando pomodoro e altri prodotti biologici su terreni confiscati alla mafia, e restituendo così alle comunità ciò che era stato sottratto. Il progetto – con coraggio – riporta dignità e speranza a territori profondamente segnati. Da tempo, questa realtà rappresenta un modello concreto di economia etica e sostenibile, dove il lavoro agricolo diventa uno strumento di riscatto sociale e legalità. Attraverso la creazione di aziende cooperative autonome e durature, promuove sviluppo, occupazione e un sistema economico fondato su valori autentici.
Anche altre cooperative – mediante il pomodoro – hanno puntato
a promuovere la giustizia sociale ed economica attraverso un’agricoltura sostenibile e libera dalle logiche mafiose, come Pietra di Scarto a Cerignola, in Puglia.

Che ha scelto di diffondere una cultura della legalità e del consumo critico, credendo nella terra come strumento di riscatto. Il cui impegno è rivolto a offrire opportunità di lavoro a chi proviene da situazioni di fragilità o vive ai margini, trasformando i campi in luoghi di dignità, inclusione e rinascita.

E ancora, c’è SfruttaZero (progetto di “Diritti a Sud”, associazione che si batte per i diritti umani), sempre in Puglia, tra Nardò e Bari, nato dall’incontro tra precari e migranti: un altro progetto cooperativo che produce pomodoro senza sfruttamento. Ogni fase – dalla coltivazione alla trasformazione – è autogestita, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti di chi lavora.
Anche realtà come VaZapp, un hub rurale nato in Puglia, lavora per dare voce e rappresentanza agli agricoltori che operano nella filiera del pomodoro. Non producono direttamente ma promuovono un’agricoltura etica, mettendo in rete i giovani contadini e sensibilizzando sui temi del lavoro agricolo giusto, della sostenibilità e del prezzo equo. Il loro impegno si concentra sul creare connessioni e far emergere il valore umano di chi coltiva la terra. Nel 2024, VaZapp ha organizzato numerosi workshop e campagne a riguardo e continua a sostenere i giovani agricoltori con percorsi formativi e momenti di confronto collettivo.
Agrigenus, invece, è una cooperativa agricola campana che ha scelto di valorizzare il territorio con un modello sostenibile e di qualità. Produce, tra le altre cose, il Pomodoro San Marzano DOP e aderisce ai Presìdi Slow Food, come quello dell’Antico Pomodoro di Napoli. Unisce tradizione, tutela ambientale e attenzione al lavoro locale, con un approccio improntato al rispetto e alla valorizzazione delle risorse umane. Nel 2024, ha partecipato a fiere internazionali, promuovendo il pomodoro campano come esempio virtuoso. Tra le novità, ha anche avviato la produzione di grissini al San Marzano da filiera corta e sostenibile, mostrando come innovazione e tradizione possano convivere.
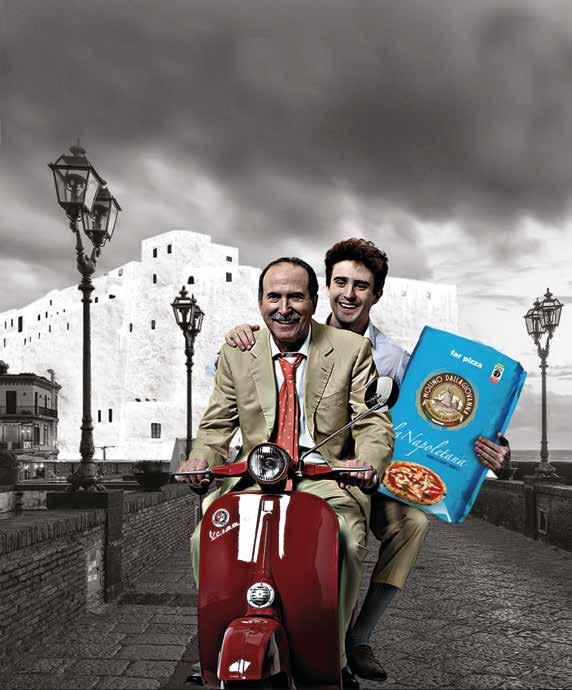

ai17507738418_PIZZA E PASTA_LUGLIO 2025_MEZZA PAGINA.pdf 1 24/06/2025 16:04:01

E proprio i Presìdi Slow Food raccontano un’altra storia possibile: quella di piccole produzioni locali che difendono la biodiversità, l’identità territoriale e il lavoro contadino. Preservando antiche varietà di pomodoro e valorizzando il lavoro delle comunità, rappresentano un modo concreto per unire qualità del prodotto e giustizia sociale. Un altro esempio è il Pomodoro Regina di Torre Canne, Presidio Slow Food coltivato tra Fasano e Ostuni, in Puglia. Questa varietà antica è valorizzata da cooperative agricole locali e dalla rete Slow Food, che nel 2024 hanno partecipato insieme a fiere nazionali e internazionali per promuovere biodiversità, tradizioni e sostenibilità. Un modello di agricoltura
che coniuga tutela ambientale, sviluppo sociale e valorizzazione delle tradizioni.
Anche grandi aziende possono farsi motore di cambiamento.
La Doria, ad esempio, storico gruppo industriale del Sud Italia, ha avviato progetti per garantire una filiera del pomodoro più equa e trasparente. Affidandosi a cose come il Worker Voice Project per dare voce a chi lavora nei campi, indagando condizioni lavorative e consapevolezza dei propri diritti. Ma anche cercando di offrire reali opportunità occupazionali ai giovani, come per esempio con il progetto Rosso d’Estate, grazie al quale, dal 2010, oltre 370 giovani sono stati assunti.
Questi progetti dimostrano come il pomodoro, oltre a essere un elemento fondamentale della cucina italiana, versatile, immancabile sulle nostre tavole e buonissimo, sia diventato un potente strumento di cambiamento sociale. Attraverso il lavoro cooperativo, la valorizzazione delle risorse locali e il rispetto dei diritti umani, queste iniziative contribuiscono a costruire un futuro più equo e sostenibile. Più umano e inclusivo.
Il pomodoro racconta una nuova storia. Non più solo simbolo della cucina italiana ma di un’agricoltura che vuole essere etica e giusta, soprattutto che trasmetta valori importanti, che non dovrebbero mai affievolirsi. Si può cambiare il mondo (o almeno l’Italia) attraverso un frutto? La risposta è sì. Almeno, ci si può provare.

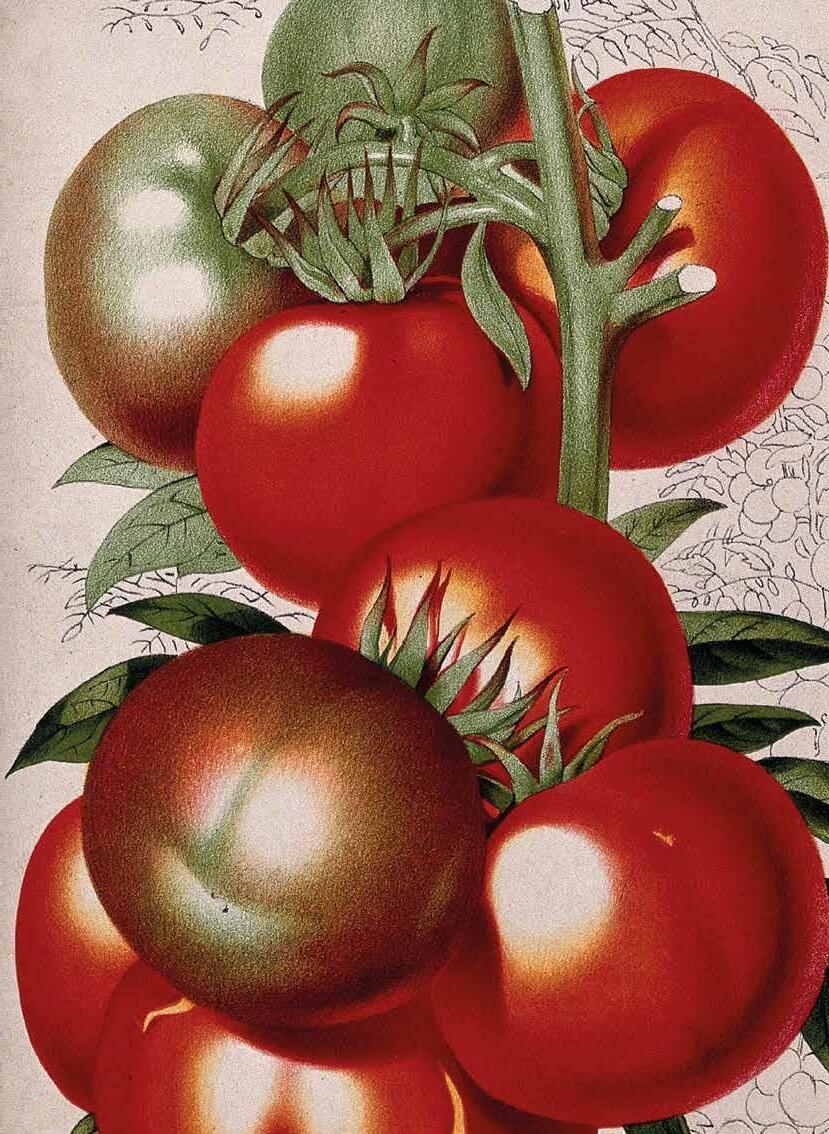
il pomodoro è un prodotto di grande interesse alimentare e gastronomico e può essere considerato uno dei grandi emblemi della globalizzazione.
L’umanità fin dall’inizio si è sempre guardata attorno e, col passare del tempo, anche lontano, alla ricerca di tutto ciò che poteva essere utile a migliorare le condizioni di vita, a cominciare dall’alimentazione.
Oggi, il pomodoro è presente negli orti e nei campi di tutto il mondo, consolidando la convinzione che senza la globalizzazione saremmo molto più poveri e chi la combatte, puntando sul sovranismo nazionale, è contro la storia. Come insegna, per l’appunto, il pomodoro, assieme a tanti altri prodotti alimentari, tra cui le patate, i fagioli, i peperoni, le zucche ed ancora lo stoccafisso, la frutta esotica, le spezie, ecc.
Ma veniamo ora alla storia.
Già nel 500 a.C. veniva coltivato nel Messico meridionale. La varietà grande del pomodoro, una mutazione di un frutto più liscio e più piccolo, ha avuto origine in Mesoamerica e potrebbe essere l’antenato diretto di alcuni moderni pomodori coltivati. In Italia, da parecchio tempo esistono molte varietà di pomodoro dalla forma molto piccola, come anche dal formato gigante, come il “pomodoro nasone”, coltivato nel comune Cavallino Tre Porti, in provincia di Venezia. Tutte queste varietà hanno comunque origine da dei prototipi originari dell’America centrale.
Il pomodoro è una bacca nativa della zona dell’America centrale, del Sudamerica e della parte meridionale dell’America Settentrionale. Si dice che i più importanti coltivatori di pomodoro in epoca precolombiana siano stati gli Aztechi, i quali coltivavano diverse varietà di pomodoro, tra cui i pomodori rossi chiamati xitomatl e tomatillo chiamati tomatl Il pomodoro era parte integrante della cucina azteca. Si affermava anche che il pomodoro avesse proprietà afrodisiache e sarebbe questo il motivo per cui i francesi
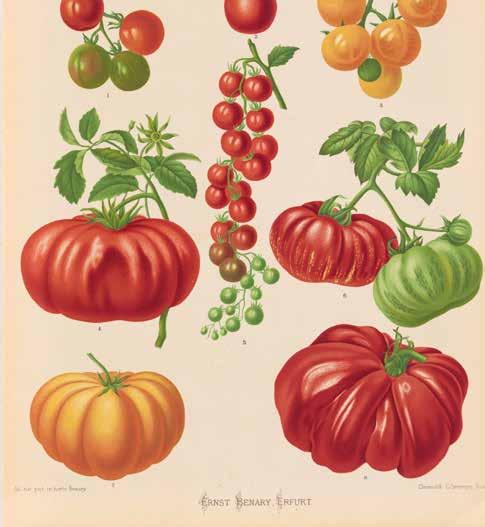
originariamente lo definivano pomme d’amour, “pomo d’amore”. Si dice, inoltre, che, dopo la sua introduzione in Europa, il nobile inglese sir Walter Raleigh abbia donato una pianta di pomodoro carica dei suoi frutti alla regina Elisabetta, battezzandola con il nome di apples of love (“pomi d’amore”).
La data del suo arrivo in Europa è il 1540, quando il condottiero spagnolo Hernán Cortés, il conquistatore del Messico rientrò in patria con alcune piantine, la cui coltivazione diffusa si ebbe tuttavia solo nella seconda metà del XVII secolo.
In Italia, la storia documentata del pomodoro inizia a Pisa il 31 ottobre 1548, quando Cosimo de’ Medici ricevette dalla sua tenuta fiorentina di Torre del Gallo un cesto dei pomodori nati da semi regalati alla moglie, Eleonora di Toledo, dal padre, viceré del Regno di Napoli. Gli storici affermano che quello riferito a Cosimo de’ Medici sia un episodio isolato, perché la prima reale presenza del pomodoro in Italia è avvenuta in Sicilia, come è avvenuto anche per il cacao arrivato a Modica che riproduce ancora oggi un cioccolato speziato di origine spagnola, per la diretta influenza della Spagna sull’isola; sembra infatti che da lì provengano le ricette italiane a base di pomodoro più antiche.

Il motivo per cui il pomodoro impiegò parecchio tempo a diffondersi e ad essere accettato come ottimo prodotto alimentare è dovuto al fatto che inizialmente si pensava che fosse una pianta velenosa. Difatti, di fronte al dubbio, venne adottata assieme alla patata e a quella americana, come pianta decorativa. I più ricchi situavano questi vegetali stranieri in bei vasi che ornavano le finestre e i cortili. I primi pomodori che arrivarono in Spagna furono piantati nell’orto del medico e botanico Nicolàs Monardes Alfaro.
Tronando alla nostra storia ricordiamo che il frutto della pianta di pomodoro in Perù veniva mangiato, mentre in Europa all’inizio della sua introduzione aveva, come abbiamo visto, valore ornamentale, viste le bacche color oro- da cui il nome pomo d’oro-. Nel 1640 la nobiltà di Tolone regalò al cardinale Richelieu, come atto di ossequio, quattro piante di pomodoro, e sempre in Francia era usanza per gli uomini offrire piantine di pomodoro alle dame, come atto d’amor gentile. Così, la coltivazione del pomodoro, come pianta ornamentale, dalla Spagna, forse attraverso il Marocco o più probabilmente attraverso il Regno di Napoli, allora di monarchia spagnola, si diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo, trovando il clima adatto per il suo sviluppo, soprattutto in Italia.
Antonio Latini, nel suo Lo scalco alla moderna del 1692, descrive la ricetta della “salsa di pomodoro alla spagnuola” diffusa nella cucina napoletana. Soltanto alla fine del Settecento la coltivazione a scopo alimentare del pomodoro conobbe un forte impulso in Europa.
Nel 1762 ne furono definite le tecniche di conservazione in seguito agli studi di Lazzaro Spallanzani, che, per primo, notò come gli estratti fatti bollire e posti in contenitori chiusi non si alterassero. In seguito, nel 1809, un cuoco parigino, Nicolas Appert, pubblicò l’opera L’art de conserver les substances alimentaires d’origine animale et végétale pour pleusieurs années, dove fra gli altri alimenti era citato anche il pomodoro.
Nel corso del ‘900, il pomodoro ebbe grande diffusione nell’Italia centro-settentrionale, soprattutto nei territori di Parma e di Piacenza e dopo la prima guerra mondiale fu conosciuto anche nelle regioni settentrionali cominciando ad essere coltivato negli orti casalinghi dopo la metà del secolo scorso. Intanto, si era diffuso anche nel continente asiatico e la Cina è ancor oggi uno dei grandi produttori di pomodoro che le navi trasportano poi attraverso il Mar Rosso anche in Europa sottoforma di salsa e passata.
oggi, dunque, il pomodoro, nelle sue tantissime varietà dovute anche a selezioni e a incroci, sia spontanei che programmati, è diventato ingrediente indispensabile di moltissime cucine sia dell’emisfero nord che di quello sud.

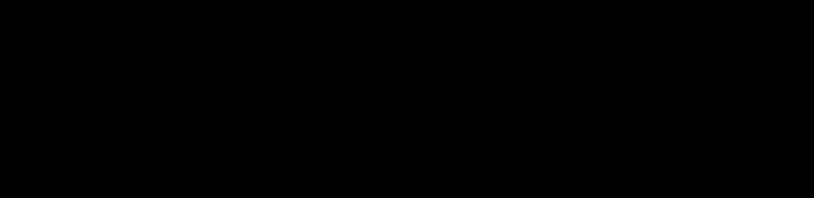
la pizza, da qualsiasi posto arrivi, è simbolo di tradizione e si lega indissolubilmente alla cultura di un popolo e del suo territorio. ed è proprio questa la sua grande bellezza.
Se, poi, vogliamo andare indietro nel tempo, alla ricerca delle sue origini, bisogna viaggiare verso sud: andare prima a Napoli e dopo spostarsi nella provincia di Salerno, a Tramonti.
Sono queste le coordinate geografiche intorno a cui si può annoverare la nascita e il successo della pizza: patrie di artigiani, di impastatori e creativi, di gente che ha saputo costruirsi un mestiere ma ancora di più un prodotto identitario ad alto impatto culturale. Ma questo lo si è capito solo dopo.La pizza napoletana e la pizza di Tramonti sono due esemplari che ricoprono la stessa importanza: se la prima è la pizza per antonomasia, la matrice da cui sono nate versioni moderne e alternative, la pizza della Co-

stiera Amalfitana è la pizza che ha valicato i confini regionali e ha avuto il potere di diffondersi come prodotto e concetto al Nord Italia prima e poi all’estero. È proprio da Tramonti, piccolo borgo dei Monti Lattari, che prende vita l’epopea della pizza, grazie ai tanti emigranti che andavano a cercare fortuna al nord, seguendo l’esempio di Luigi Giordano (figura simbolo di questa migrazione, che nel 1947 si trasferì a Novara, prima aprendo un caseificio e poi una pizzeria chiamata “A’ Marechiaro”) e portando con sé l’antica arte della pizza tramontana.
Ora non staremo qui a ripercorrere in dettaglio le vicissitudini storiche di questi due prodotti, ma vogliamo raccontarle oggi nella loro valenza di “tradizione contemporanea” con l’aiuto di due pizzaioli: Vincenzo Mansi, titolare de “La pizza di Vincenzo Mansi” a Salerno e vincitore nel 2023 della categoria Pizza napoletana Stg al Campionato Mondiale della Pizza di Parma e Francesco Maiorano, pizzaiolo di Tramonti, titolare della pizzeria “San Francisco”.

Una visione condivisa che riconosce la tradizione come elemento originario e identitario, assolutamente da conoscere, studiare, rispettare e traghettare nel futuro, ma anche un punto di partenza da cui dar vita a qualcosa di nuovo.
la napoletana stg secondo vincenzo mansi
“La Pizza napoletana è identità, è la pizza delle origini, la pizza che sopravviverà a tutte le mode” – risponde Vincenzo Mansi quando gli chiediamo cosa rappresenta la pizza napoletana nel 2025 e continua: “Ed è proprio per tutelare queste origini che nasce il Disciplinare, che impone delle regole e stabilisce, congelando nel tempo, tecnica e lavorazione di questa tipologia di pizza”.
«La tradizione deve essere il nostro punto di riferimento, dunque, se vogliamo esprimere bene la nostra identità. Sono anche dell’avviso che, nel cammino personale di ogni pizzaiolo, ci sono poi le variazioni sul tema, gli aspetti creativi che vanno alimentati, perché spesso si sente il bisogno di uscire dallo spazio del “classico” per addentrarsi in quello delle variazioni e sperimentazioni, ma senza stravolgimenti. A mio avviso
in futuro la pizza vivrà un ritorno alle origini sotto più punti di vista».
vincenzo, tu hai vinto il campionato mondiale di parma nella categoria stg e quest’anno sei stato giurato ai forni: secondo te quanto si conosce veramente il disciplinare?
Da quanto osservato direttamente, posso dire che solo una parte dei pizzaioli in gara rispetta il disciplinare: il resto
pensa di conoscerlo ma sbaglia e basta veramente poco per essere squalificati. Pensate che la media di questi ultimi si aggira tra il 30 e 35% degli iscritti alla categoria.
ci fai qualche esempio per capire meglio?
Molti commettono banalmente degli errori nella fase del condimento, la maggior parte sbagliano la cottura. C’è per esempio chi non mette il sale sul pomodoro ma lo mette a fine farcitura o dentro il pomodoro; stessa cosa per l’olio o il basilico che mettono in uscita e non in cottura. Se sbagli questi passaggi, significa che il Disciplinare non lo hai studiato. E poi si tende a sbagliare la cottura


essere legato ad un disciplinare per un pizzaiolo può essere limitativo o è una sfida?
Applicare il Disciplinare è un atto di rispetto ma ci sono anche le revisioni personali. Io ho scelto la pizza napoletana, ho vinto il campionato per la categoria STG e mi reputo anche un creativo. Poi dipende cosa ricerca il pizzaiolo nel suo prodotto: tutti vogliamo un prodotto altamente digeribile e spesso si dice che la pizza napoletana non lo è o è eccessivamente gommosa. Può essere anche vero ma dipende da come tu hai lavorato gli ingredienti, dalla forza della farina scelta, dalle proteine e da quanto tempo dedichi alla lievitazione: sono tutti elementi che fanno la differenza. ci fai ancora un esempio per capire meglio?
Il disciplinare dice che si deve usare una farina 0 o 00 con forza che va da un minimo di 240 a un massimo di 380 W, con una percentuale totale di proteina pari al 11-12%. Il calcolo rientra perfettamente se ci manteniamo su un W entro i 300 ma, se già li superi, la percentuale proteica aumenta a 14 e sei fuori dagli schemi. Inoltre, più alta è la forza della
farina, più abbiamo bisogno di acqua e di ore di lievitazione se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di digeribilità. Pertanto, è evidente che il disciplinare ha dei limiti: la pizza napoletana può essere sì digeribile ma non in tutte le opzioni che propone.
a questo punto, dicci: com’è la tua pizza?
Oltre a fare la napoletana Stg, la mia versione di pizza napoletana prevede un impasto con farina da 300W, 75% di idratazione, tra le 18-24 ore di lievitazione. In questo modo, do all’impasto la possibilità di maturare meglio ed essere più leggero. Facciamo anche impasti alternativi, come quello integrale ai semi o con la farina di riso Venere. E, per il condimento, mi diverto a creare sempre cose nuove; tra le novità di questa stagione, per esempio, c’è la Costiera con provola, fiori di zucca e basilico, in uscita zest di limone sfusato amalfitano e noci di Giffoni o, ancora, la pizza che ho dedicato a mia moglie, la Ci ha pensato lei con pesto di pinoli italiani, mozzarella di bufala, fiori di zucca e lardo agli agrumi e, in uscita, cialde di Parmigiano Reggiano e basilico cristallizzato.
la pizza di tramonti secondo francesco maiorano
Parliamo ora della pizza nera di Tramonti, così definita per il suo colore più scuro dovuto alle farine integrali e ne parliamo con Francesco Maiorano che, nella sua pizzeria, ha addirittura dedicato una parte del menu alla pizza tramontana, proprio quella della tradizione.
cosa differenzia la pizza di tramonti dalla napoletana?
Prima di tutto, la tipologia dell’impasto che utilizza lievito madre - come si faceva nelle case e nei forni locali per il pane - e una farina integrale macinata a pietra. Tocco distintivo: un’aggiunta di finocchietto selvatico, che conferisce freschezza. La stesura la rende un po’ più bassa e anche la cottura differisce, perché la nostra pizza tipica viene cotta in un forno a cupola con una temperatura più bassa rispetto alla napoletana (intorno ai 350°C) e con tempi più lunghi. Il risultato finale è una pizza più asciutta e croccante rispetto alla classica tonda partenopea.
quanto è importante per voi pizzaioli tramontani essere fedeli alla tradizione e parlare ancora di pizza di tramonti?
Per noi è qualcosa di davvero importante, soprattutto per chi è rimasto a vivere a Tramonti. Non che non lo sia anche per chi è andato via, anzi, ma per noi che continuiamo a vivere quotidianamente questa tradizione, sentirci legati alle nostre radici è fondamentale. Portare avanti con orgoglio il valore autentico della nostra terra è una responsabilità che sentiamo profondamente. Proprio per questo, anche nel menù della mia pizzeria, ho voluto dedica-
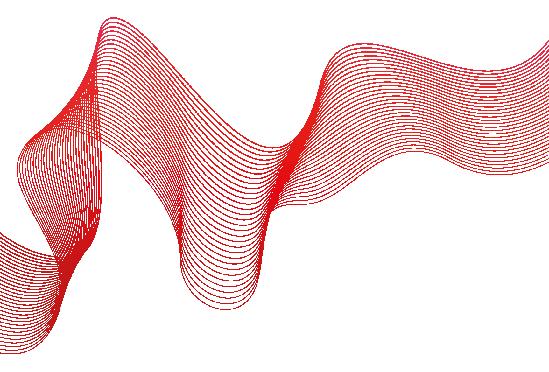




re un’intera pagina alla pizza di Tramonti, intitolandola
“Integralmente Tramonti”. Presentiamo tre tipologie di pizze, ognuna delle quali rende omaggio a figure storiche del nostro paese: la Luchetto, la Fra Serafino e la Nonna Argentina, tre personaggi simbolo che rappresentano la storia e l’identità della nostra comunità.
com’è la tua pizza? quanta tradizione c’è e quanta modernità?
Se parliamo della classica, la mia pizza ha un impasto personale con farina tipo 0, non segue la moda della “contemporanea” ma resta fedele alla tradizione, con una lievitazione di 24 ore e un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime. Come accennavo prima, abbiamo inaugurato il nuovo menù, che include sia le pizze classiche che quelle speciali, abbiamo anche dedicato una pagina intera alla pizza che racconta il nostro territorio, valorizzando soprattutto i prodotti a km zero. Abbiamo infatti la fortuna di vivere in una zona ancora ricca di produzioni eccellenti: dal fiordilatte ai salumi, dai pomodori ai formaggi, collaboriamo con aziende locali che rappresentano l’eccellenza e che ci accompagnano in questo percorso gastronomico.
cosa significa oggi continuare a fare questo tipo di
pizza e come viene percepita dai
Continuare a proporre questa tipologia di pizza per noi significa davvero tantissimo, è un modo per perpetuare il legame profondo con le nostre radici, un modo concreto per rimanere connessi alla nostra terra. L’obiettivo è far sì che, attraverso questa pizza, si possa riconoscere Tramonti nella sua identità più autentica.
Io ho una mia idea: è giusto rendere omaggio a Napoli ma noi pizzaioli di Tramonti rivendichiamo il merito di aver portato la pizza nel mondo e, in particolare nel Nord Italia, da est a ovest. Abbiamo contribuito a trasformare la cultura gastronomica di intere regioni, facendola evolvere anche grazie alle nostre pizzerie, che hanno fatto conoscere un prodotto diverso, autentico, che oggi ci permette di distinguerci. La nostra è una pizza che sa raccontare una storia e oggi, insieme a tanti colleghi del territorio, continuiamo con orgoglio a proporre questa tradizione.
Dal punto di vista della clientela, riscontriamo molta positività: oggi Tramonti fa parte di un circuito sempre più internazionale e questo ci dà la possibilità di proporre qualcosa di diverso rispetto alla classica pizza napoletana. La nostra è una pizza con un’identità ben precisa, che sentiamo profondamente nostra e che portiamo avanti con orgoglio. Per noi non si tratta solo di servire un piatto ma di raccontare una storia. Raccontare chi ha fatto la storia della pizza di Tramonti e chi, oggi, continua a scriverla. Onoriamo il passato, viviamo il presente e guardiamo al futuro, sempre con fierezza. Il nostro passato non deve mai essere dimenticato: se oggi siamo qui, lo dobbiamo a chi ha creduto in questa tradizione prima di noi, a chi è partito, a chi è rimasto, a chi con tanti sacrifici ha lasciato un’eredità concreta.
forse non tutti sanno che…
Oggi, in Italia, si contano circa 3000 attività che si riconoscono nella scuola di Tramonti e nel 2010 la pizza di Tramonti ha ottenuto la De.Co. (Denominazione Comunale), riconoscimento ufficiale che ne tutela la tipicità. Oggi Tramonti è impegnata a valorizzare il proprio patrimonio gastronomico grazie anche al lavoro dell’Associazione Pizza Tramonti, nata dall’antica Corporazione dei Pizzaioli e oggi presieduta da Vincenzo Savino, storico e politico locale, che conta circa 90 affiliati distribuiti in 15 Paesi del mondo.


Scansiona il QR code e accedi a contenuti esclusivi al
Riscaldamento rapido e ottimo isolamento termico.
Risparmio enegetico e organizzativo.
Comando digitale facile e intuitivo.

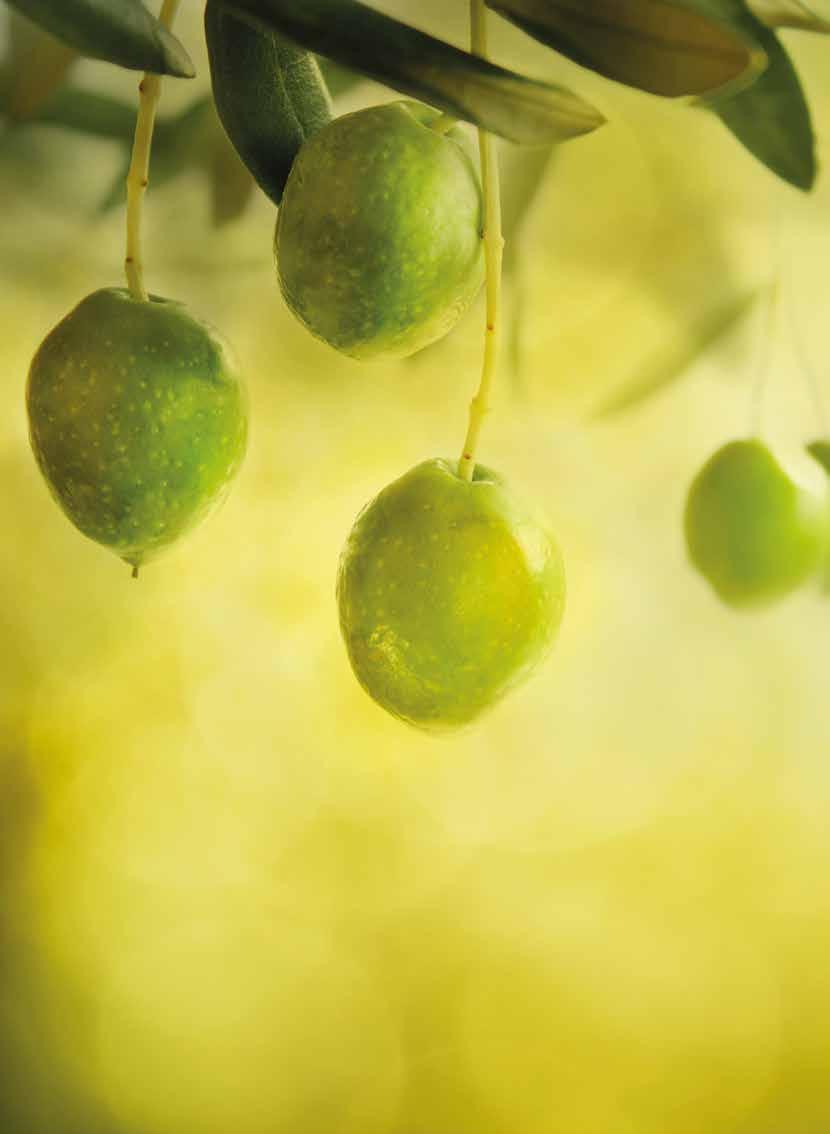

SECONDO LA GUIDA AGLI EXTRAVERGINI DI SLOW FOOD
L’estate ormai è iniziata nel Sud Italia: qui arriva, come sempre, un po’ prima del solito e, tra mare, sole, profumi freschi e cibo buono, non può mancare la nostra top 10 degli oli da usare per i vostri piatti, scelti dalla Guida agli Extravergini di Slow Food: una guida indipendente (non vengono chiesti infatti contributi ai produttori per far recensire i loro oli) che quest’anno ha festeggiato i suoi primi venticinque anni, attestandosi come la guida più longeva d’Italia sugli oli extravergini.
di Massimiliano Bruno Gallo e Angelo Lo conte
Questa top 10 - sia chiaro - non è una classifica ma un elenco dei migliori oli del Sud (secondo noi), delle loro caratteristiche sensoriali e dei consigli su quali cibi abbinarli, perché con l’olio extravergine di qualità, ogni cibo è più buono.
Azienda: Il Cappero, Anacapri (NA)
Nome dell’olio: Cru Pino de’ Monaci
Cultivar: Minucciola
Caratteristiche sensoriali: Erbaceo di grande complessità. Potente e molto espressivo al gusto. Esemplare persistenza aromatica. Abbinamenti consigliati: Zuppe di legumi, verdure amare, carni molto grasse alla griglia.

Azienda: Baglio Ingardia, Paceco (TP)
Nome dell’olio: Alberelli, Grand Cru
Cultivar: Cerasuola
Azienda: Vincenzo Marvulli, Matera
Nome dell’olio: Cenzino
Cultivar: Coratina
Caratteristiche sensoriali: fruttato intenso con nitide note di vegetale amaro, cardo. Amaro e piccante perfettamente calibrati. Abbinamenti consigliati: Zuppe complesse di verdure e legumi, stracotti di carne rossa e carni molto grasse alla griglia.
Caratteristiche sensoriali: Sentori verdi intensi che rievocano il carciofo fresco e riportano al gusto l’amaro e il piccante. Abbinamenti consigliati: Zuppe di legumi, insalate amare di stagione e carni di suino alla griglia.

Azienda: De Carlo, Bitritto (BA)
Nome dell’olio: Felice Garibaldi
Cultivar: Ogliarola
Caratteristiche sensoriali: Il fruttato è medio, con note di mandorla verde. Amaro e piccante intensi, in fresco equilibrio Abbinamenti consigliati: Verdure amare saltate in padella, frittate, carni di suino stracotte o alla griglia.


Azienda: Arcaverde, Cosenza
Nome dell’olio: Spezzanese
Cultivar: Spezzanese
Caratteristiche sensoriali: Forte personalità gustativa e freschezza olfattiva data da erba di sfalcio, carciofo e rucola.
Abbinamenti consigliati: Verdure saltate in padella o cotte al forno, carni rosse alla griglia e insalate amare di stagione.
Azienda: Fontana Madonna, Frigento (AV)
Nome dell’olio: Regio
Cultivar: Ravece
Caratteristiche sensoriali: Perfetta interpretazione varietale. Estremamente complesso sia all’olfatto che al gusto. Potente. Abbinamenti consigliati: Zuppe di legumi, verdure amare, insalate a base di pomodori, carni mediamente grasse alla griglia.
Azienda: Olearia San Giorgio, San Giorgio morgeto (RC)
Nome dell’olio: L’ottobratico
Cultivar: Ottobratica
Caratteristiche sensoriali: Palato dolce, delicato ed elegante, con avvolgenti e freschi odori floreali, di erba e cardo.
Abbinamenti consigliati: Pesce cotto al forno o in acqua, tartare di tonno e verdure delicate saltate in padella.
Azienda: Tenuta Cavasecca, Siracusa
Nome dell’olio: Siracusana
Cultivar: Zaituna

Caratteristiche sensoriali: Di bella coerenza gusto-olfattiva: freschi aromi di oliva e pomodoro, piacevolissimo sapore. Abbinamenti consigliati: Insalate fresche di stagione, formaggi freschi, mozzarella e carni bianche.

Azienda: Frantoio Romano, Ponte (BN)
Nome dell’olio: Racioppella
Cultivar: Racioppella
Caratteristiche sensoriali: Freschi e nitidi sentori di erba campestre e frutta dolce. Armonico e lungo, al palato avvolgente.
Abbinamenti consigliati: Pesce alla griglia, formaggi freschi, mozzarella, carni bianche e di suino.

Azienda: Mandwinery, Cerignola (FG)
Nome dell’olio: Addurè
Cultivar: Bella di Cerignola
Caratteristiche sensoriali: Fruttato intenso e balsamico, vivo amaro officinale, piccante leggero e persistente
Abbinamenti consigliati: Insalate fresche, complesse e amare, carni di suino e di pollo ruspante, passate di verdure e di legumi.

di Enrico Bonardo, Direttore commerciale e marketing di Scuola Italiana Pizzaioli
In alcuni luoghi, la pizza non è solo un piatto: è un fatto sociale, culturale ed economico. Nasce a Napoli, tra Settecento e Ottocento, come cibo urbano, semplice e veloce, venduto per strada o nei primi forni. Nel 1889, simbolica "data di nascita" della Margherita, diventa simbolo nazionale e identitario. Nel Novecento, l’emigrazione italiana la trasforma in fenomeno globale. A New York nasce lo stile “slice”, adatto al ritmo della metropoli. In Argentina, la pizza si fa spessa e ricca, mentre da Tokyo a Città del Messico si moltiplicano le versioni ispirate al modello italiano. Ma la vera cultura della pizza non vive solo nella ricetta: è un sistema territoriale complesso, un ecosistema che tiene insieme materie prime, saperi artigianali, tecnologie e identità locali. In Italia esistono intere filiere legate alla pizza: aziende agricole, caseifici, molini, forni, pizzerie e ristoranti. Regioni come Campania, Lazio, Puglia e Veneto hanno costruito ecosistemi produttivi che legano pizzaioli, produttori e formazione professionale. Sempre più operatori conoscono l’origine delle materie prime e ne fanno parte attiva del proprio racconto. La cultura pizzaiola è oggi anche consapevolezza ambientale, scelta etica, rigore tecnico. Un ruolo chiave lo ha la farina. L’Italia ha sviluppato uno stile molitorio distintivo: selezione dei grani, moliture calibrate, classificazioni precise, trasparenza di filiera hanno conquistato il mondo dei professionisti e oggi chi vuole fare pizza in autentico stile italiano si approvvigiona dai mulini italiani. È chiaro, dunque, che dalla scelta del grano alla tecnica di impasto, ogni fase è cultura. Oggi, dove ci sono un pizzaiolo consapevole, una comunità che consuma e una materia prima rispettata, la pizza diventa cultura. Non solo da gustare, ma da comprendere e raccontare.
www.scuolaitalianapizzaioli.it info@scuolaitalianapizzaioli.it
MONDIALE
DELLA PIZZA
DEMETRA srl
Via Roma, 751 - 23018 TALA MONA (SO) - ITALY tel. 0342 674011 info@demetrafood.it
1. Squadra che vince non si cambia: che cos’è per te il Campionato mondiale della pizza?
Il Campionato mondiale della pizza, per noi, è molto più di una gara: è un appuntamento fondamentale per chi vive la pizza come passione e mestiere. Qui si incontrano i migliori pizzaioli, si respira innovazione e si celebra la tradizione italiana. È un’occasione preziosa per confrontarsi, lasciarsi ispirare e portare a casa nuove idee. Ogni anno torniamo arricchiti, con nuovi stimoli e la certezza che la crescita passa dal confronto e dalla condivisione di esperienze tra professionisti.
2. Qual è la richiesta più strana che hai ricevuto nei giorni del Campionato?
Durante il Campionato non mancano richieste particolari, ma una delle più insolite è stata quella di preparare una pizza che unisse ingredienti dolci e salati. All’inizio ci è sembrato un abbinamento azzardato, ma ci siamo messi in gioco con entusiasmo, sfruttando l’occasione per sperimentare e dimostrare la versatilità della pizza. La soddisfazione di chi ha assaggiato quella creazione ci ha confermato che la voglia di innovare non deve avere limiti.
3. Quale ricordo ti è rimasto impresso di questa edizione? Il ricordo più forte di questa edizione è l’energia positiva che si respirava tra i partecipanti. Ogni pizzaiolo ha portato non solo la propria tecnica, ma anche storie di dedizione e passione. È stato emozionante vedere la collaborazione tra colleghi, lo scambio di consigli e il tifo reciproco, segno che la vera forza del nostro settore è il senso di appartenenza a una grande famiglia. Questi momenti di condivisione sono ciò che rende il Campionato davvero speciale.
4. La tua azienda e il futuro della pizza: quali progetti per domani?
Guardando avanti, per noi il futuro della pizza significa innovare senza perdere di vista la tradizione. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per offrire ingredienti e soluzioni che aiutino i pizzaioli a esprimere la propria creatività, semplificando il lavoro e garantendo sempre la massima qualità. La nostra Food Academy resta un punto di riferimento per la formazione, con corsi aggiornati e collaborazioni con le migliori scuole. Vogliamo continuare a supportare la crescita dei professionisti del settore, contribuendo insieme a scrivere nuove pagine nella storia della pizza.


La condivisione delle idee, la conoscenza del mondo HORECA, l’interazione tra rete commerciale, distributori e professionisti della ristorazione rappresentano l’essenza di Demetra.
Questa visione ci guida verso il futuro e il miglioramento continuo. Essere innovativi è un’attitudine naturale, alimentata da passione, autenticità e coraggio.
Questa è Demetra.

In occasione di Tuttofood, presso lo spazio di “Pasta Armando”, Alessandro Borghese e la sua squadra di lavoro hanno presentato il brand di pasta 100% naturale ed italiano, preparando 3 primi piatti regionali diversi. Borghese è nato a San Francisco nel 1976, è uno dei cuochi più famosi d’Italia e protagonista indiscusso del successo della cucina in televisione. Esempio di un nuovo approccio alla materia prima, ha rinnovato il concetto di cultura e professionalità nel settore della ristorazione. Definito lo chef «Rock&Social», è stato premiato più volte per la sua cucina, legata alla qualità, dove tradizione e innovazione diventano metodo, stile, arte e gusto. I suoi ristoranti si trovano a Milano e a Venezia: quest’ultimo è una new entry nella guida Michelin.

Abbiamo fatto allo chef alcune domande. Alessandro, in questi giorni ha lavorato molto con la pasta mista: come nasce?
L'idea di creare questa pasta mista con Pasta Armando nasce da un presupposto: in cucina non esistono ingredienti di serie A e serie B. Quando la qualità incontra la creatività, si crea sempre un piatto che sa valorizzare al massimo ogni elemento. Ho voluto chiamare questo nuovo formato "ReMix" perché credo che pasta e musica abbiano molto in comune. I grandi classici di entrambe sanno emozionare e raccontare storie... E, nella nostra Pasta Mista, il Remix, ogni frammento di pasta, pur diverso, contribuisce a creare un sound unico. Tanti piccoli pezzi, tondi, larghi, storti, lisci, ruvidi: una varietà di formati che insieme danno vita a un nuovo sound. Come la abbina?

La Pasta Mista è un formato estremamente versatile. Ovviamente si presta benissimo a minestre e zuppe, come ci insegna la tradizione (quella che non spreca nulla e che vedeva nella pasta mista una geniale soluzione anti-spreco). Ma si esprime in modo fantastico anche in piatti più originali e ricercati. Personalmente, la trovo eccezionale con il ragù di pesce. La diversità di dimensioni e forme dei vari pezzi permette di giocare con le consistenze e creare piatti davvero gustosi e creativi!
Quella italiana! La mia cucina preferita è quella sincera, preparata con materie prime di qualità e senza troppi fronzoli ma con una grande conoscenza del piatto e degli ingredienti che vengono utilizzati. Mi piace la cucina verace e quella dei ricordi, dove ogni morso o boccone ti evoca una sensazione e ti riporta a un momento particolare vissuto in passato.


Se dovessi indicare un paio di pietanze in particolare, sicuramente direi la pasta e patate preparata da mio zio Tonino e il ragù alla napoletana della domenica con la carne al sugo che cucinava sempre mio papà. I piatti della mia memoria sono perlopiù associati ai ricordi della mia infanzia ma, in realtà, poi, col tempo sono anche cambiati. Penso, per esempio, ai piatti mangiati con mia moglie in un’occasione speciale, con le mie figlie o con mia suocera, che è una cuoca eccellente e prepara ricette memorabili.


Mi sono formato con tanta gavetta e tanto duro lavoro, ho imparato questo mestiere sul campo. Non mi sono mai mancate la determinazione e la voglia di raggiungere gli obiettivi che mi prefissavo, con tanta umiltà e spirito di sacrificio. Ringrazio i miei genitori che mi hanno permesso di frequentare scuole estere e mi hanno fatto crescere con una visione cosmopolita della società e del mondo, insegnandomi che per ottenere dei risultati nella vita bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare duramente. Mi sono formato facendo quello che più mi piace: cucinare!

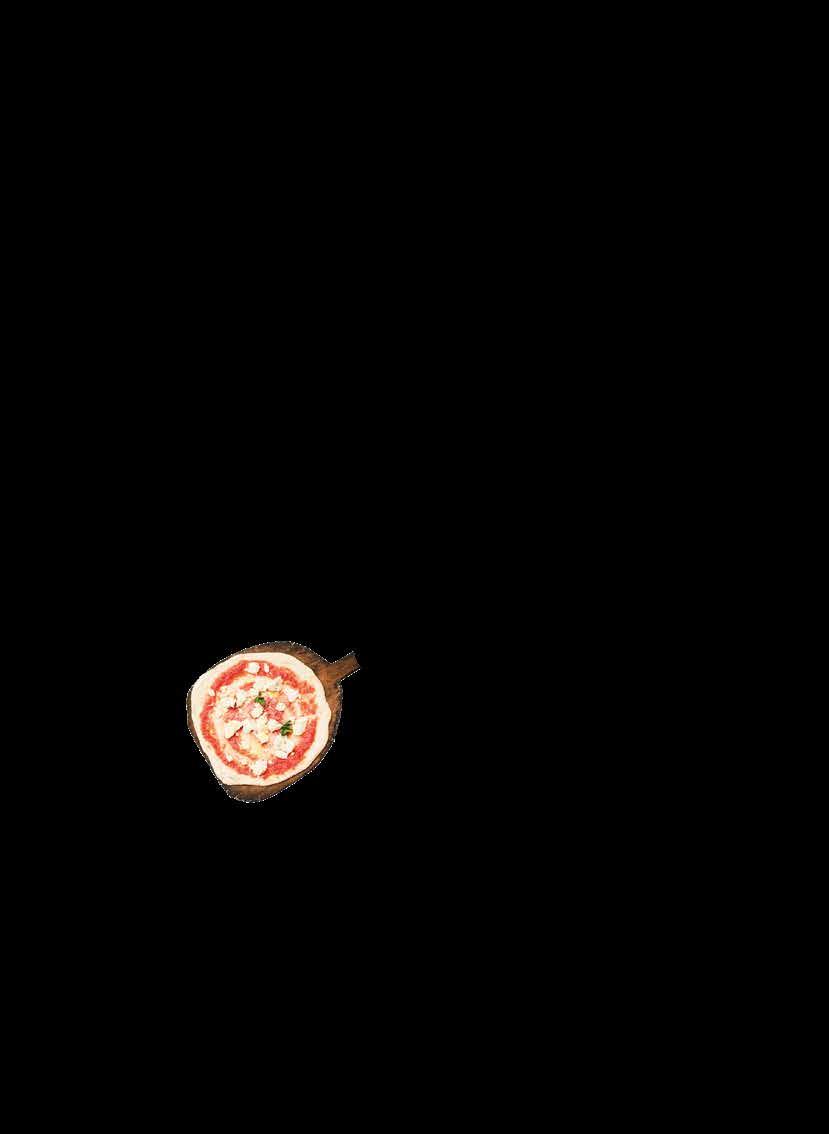
“Fratelli La Cozza” e “Sfashion Café” sono due tra le mete preferite degli amanti della pizza a Torino. Tra le prime pizzerie al mondo ad essere state certificate per la “pizza napoletana STG”, continuano ad investire in formazione ed aggiornamento continuo con proficui risultati.
Oggi hanno il piacere di poter annoverare nelle pizzerie del gruppo due tra i 10 migliori pizzaioli al mondo; infatti, Francesco Papagna (pizzaiolo di “Fratelli la Cozza”) e Juri Prato (pizzaiolo storico dello “Sfashion”) che si sono classificati rispettivamente quarto ed ottavo nell’ultimo Campionato del Mondo della Pizza di Parma nella categoria pizza classica su oltre 280 concorrenti provenienti da tutto il mondo.

L’azzardo del 1998: portare Napoli nel Cuore del Piemonte
Nel 1998, la famiglia Ferrari compie una scommessa che molti consideravano destinata al fallimento: introdurre la pizza napoletana autentica nel tessuto gastronomico torinese. Un’operazione che richiedeva non solo coraggio imprenditoriale ma una profonda comprensione delle dinamiche culturali che regolano l’accettazione di tradizioni culinarie regionali in contesti geograficamente distanti. La strategia adottata dai fondatori rivela un approccio metodico: il reclutamento
di Aldo Brandi, pronipote dell’inventore della pizza Margherita, rappresentava non solo l’acquisizione di competenze tecniche ma l’importazione di un patrimonio culturale napoletano autentico. Brandi, affiancato da Gennaro Ranieri - tuttora attivo nel gruppo dopo 27 anni - ha trasferito a Torino non semplicemente una tecnica ma un’intera filosofia produttiva che il tempo ha saputo riconoscere e premiare. L’ubicazione iniziale scelta in Corso Giampartino a Torino, area allora periferica e non sviluppata, amplificava il rischio dell’operazione. Ancora oggi il locale, ospitato nella storica prima fabbrica “Basicnet”, crea un ambiente post-industriale
che fonde elementi napoletani e newyorkesi, riflettendo una visione estetica ancora oggi moderna e capace di anticipare di anni le tendenze contemporanee del design di interni per la ristorazione.
Il fenomeno dell’influenza culinaria e il trasferimento di competenze
Il fondatore de “L’Oreal”, Eugène Schueller esordì in un memorabile discorso con questa frase: “Un’azienda non è fatta di muri e macchine ma di Persone, Persone, Persone”. Nel caso dei “Fratelli La Cozza”, la capa-

cità di attrarre competenze specializzate da un territorio geograficamente e culturalmente distante rivela un approccio strategico che va oltre la semplice acquisizione di know-how tecnico. Si tratta di un vero e proprio trasferimento di patrimonio culturale, dove la tecnica napoletana della lavorazione dell’impasto si sposa con l’approccio imprenditoriale piemontese, creando una sintesi innovativa.
L’introduzione dell’abbinamento pizzacozze, oggi considerato standard nel settore, rappresenta un esempio paradigmatico di come l’integrazione di elementi gastronomici tradizionali possa generare nuovi paradigmi gastronomici riconosciuti nel tempo. Questo accostamento, all’epoca percepito come azzardato, ha successivamente influenzato l’offerta di numerosi locali, diventando un marker identitario della ristorazione italiana contemporanea che unisce mare e territorio in un’unica proposta culinaria.
Filosofia produttiva e posizionamento nel panorama competitivo
Nel tessuto gastronomico torinese, dove la cultura culinaria piemontese si confronta quotidianamente con le contaminazioni della globalizzazione alimentare, “Fratelli La Cozza” ha sviluppato una metodologia operativa che costituisce una vera e propria dichiarazione di principi. La scelta dell’artigianalità quotidiana non rappresenta semplicemente una strategia commerciale ma l’affermazione di una filosofia che riconosce nel tempo e nella competenza umana i fattori irrinunciabili della qualità gastronomica.
L’utilizzo sistematico di ingredienti stagionali crea un ponte tra il ritmo naturale della produzione agricola e la tavola del consumatore, in un’epoca dove l’industria alimentare tende sempre più verso l’omogeneizzazione e la standardizzazione dei sapori. Questa scelta comporta sfide logistiche e operative considerevoli:
richiede relazioni consolidate con fornitori locali, flessibilità nella gestione del menu e una formazione continua del personale per adattarsi alle variazioni qualitative degli ingredienti. Questo approccio posiziona “Fratelli La Cozza” e “Sfashion Cafè” in un segmento premium del mercato, dove la qualità delle materie prime e la competenza tecnica rappresentano i fattori competitivi primari. L’evoluzione del menu, che preserva l’identità napoletana originale integrandola con impasti contemporanei e nuove tecniche di lievitazione, dimostra una capacità di adattamento che risponde alle evoluzioni del gusto contemporaneo senza tradire l’autenticità del prodotto.
La partecipazione al Campionato
Mondiale della Pizza
Il risultato più significativo in termini di validazione tecnica arriva dai recenti risultati al Campionato Mondiali della Pizza a Parma, dove Francesco Papagna (4° posto) e Juri Prado (8° posto) hanno ottenuto posizionamenti eccellenti nella categoria pizza classica, superando oltre 280 concorrenti internazionali. Questo risultato rappresenta una delle poche qualificazioni nelle quali due pizzaioli della stessa catena hanno raggiunto simultaneamente la “top ten” mondiale. Il dato conferma che la metodologia formativa e la qualità degli standard operativi di Fratelli La Cozza hanno raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.
Due esperienze diverse al servizio della stessa azienda
JURI PRATO
Il Custode della Tradizione Ventennale
Percorso professionale e origini
Piemontese, nato a Moncalieri nel 1977, Juri Prato ha iniziato la carriera di pizzaiolo sotto la guida di Gennaro Esposito, completando la formazione attraverso esperienze in diverse pizzerie come “extra”. Nel 2004, a 29 anni, entra nel gruppo Ferrari presso lo “Sfashion Cafè”, dove attualmente ricopre il ruolo di capopizzaiolo dopo vent’anni di servizio continuativo. Ha conseguito qualifiche come istruttore dell’associazione “La Piccola Napoli” e attestati in grani alternativi presso l’Accademia Luigi Stamerra.
Passione per il settore
La sua dedizione ventennale alla famiglia Ferrari testimonia un legame professionale che trascende il semplice rapporto lavorativo, evolvendosi in una partnership basata sulla condivisione di valori qualitativi e metodologie operative.
Ingrediente e pizza preferiti
Juri ama tutto della sua creatura: le farine che si combinano con acqua e lievito, la lavorazione dell’impasto, la dolcezza del pomodoro e la sapidità della mozzarella. Il suo tocco si legge nella ricerca del massimo risultato a partire dagli ingredienti
Aneddoto caratterizzante
La sua progressione da pizzaiolo a capopizzaiolo e istruttore, mantenendo per due decenni la fiducia della proprietà, rivela una personalità caratterizzata da affidabilità tecnica e capacità di preservare standard qualitativi nel tempo. È l’elemento di continuità che garantisce la coerenza della proposta gastronomica.

L’Innovatore degli Impasti
Percorso professionale e origini Pugliese, originario di Barletta, ha iniziato l’attività imprenditoriale aprendo una pizzeria d’asporto successivamente venduta prima del trasferimento a Torino. La formazione tecnica è avvenuta presso l’Accademia Formazione Professionale di Luigi Stamerra, dove ha ottenuto qualifiche come pizzaiolo professionista e istruttore. A Torino ha lavorato prevalentemente con la famiglia Ferrari, approdando a “Fratelli La Cozza” dallo “Sfashion Cafè”.
Passione per il settore
L’interesse per questo mestiere nasce dalla possibilità di trasformare la farina, ingrediente base apparentemente semplice, in prodotti finali diversificati attraverso
tecniche e gestioni dell’impasto differenziate. Questa visione rivela un approccio scientifico-sperimentale alla panificazione.
Ingrediente e pizza preferiti
Non manifesta preferenze specifiche, privilegiando la sperimentazione e in particolare la trasposizione di piatti della cucina tradizionale in formato pizza.
Aneddoto caratterizzante
Il suo percorso include un approccio curioso e sperimentale. Questa dinamica, unita alla sua specializzazione negli “impasti speciali” e alla passione per la reinterpretazione culinaria, evidenzia una personalità orientata verso l’esplorazione di nuove frontiere tecniche e mai paga dei risultati.



Siciliano di Catania, città che ha dato i natali alla “pasta alla Norma” e dove regnano l’arancino, la granita e la Scacciata, Marco D’Arrigo con la sua terra ha un forte legame e lo si capisce subito ascoltando i suoi racconti: da quelli della cucina della mamma a quelli delle giornate passate al mare a pescare o in campagna, dalla bellezza ai sapori con cui è cresciuto e con cui ogni giorno convive.

Siciliano di Catania, città che ha dato i natali alla “pasta alla Norma” e dove regnano l’arancino, la granita e la Scacciata, Marco D’Arrigo con la sua terra ha un forte legame e lo si capisce subito ascoltando i suoi racconti: da quelli della cucina della mamma a quelli delle giornate passate al mare a pescare o in campagna, dalla bellezza ai sapori con cui è cresciuto e con cui ogni giorno convive. Marco D’Arrigo, pizzaiolo di “Al Vicolo Pizza&Vino” fa parte di quella generazione che riscopre la tradizione e la vuole trasportare nel futuro. «Per me la tradizione è tutto e per questo cerco di portare la tradizione nelle mie pizze: è una sfida fondamentale, un impegno che ho preso con me stesso». Ed è proprio con l’amore per la Sicilia e le sue tradizioni che Marco nel 2023 vince l’ottava edizione di MasterPizza Champion, ritagliandosi negli ultimi due anni una
sfera di attività di successo e una buona dose di visibilità.
Marco, nonostante la giovane età, ha alle spalle un percorso variegato in cui la voglia di provarci e riuscire, accompagnata dallo studio, lo hanno fatto crescere. Da piccolo imprenditore e pizzaiolo autodidatta, oggi fa parte del progetto di “Al Vicolo Pizza&Vino” che possiamo definire a tutti gli effetti un progetto di riqualificazione urbana e di valorizzazione. Ci siamo fatti raccontare un po’ di lui e ovviamente della sua pizza.
Marco, quando inizia il tuo rapporto con la pizza?
Fin da piccolo, ero un vero mangione di pizza. Mia madre era una cuoca straordinaria e preparava una pizza in teglia che
ti segna (soprattutto se scegli di fare il pizzaiolo). Tredici anni fa ho avuto la fortuna (e sfortuna) di incontrare un forno a legna, di quelli usati per il pane e, senza grandi conoscenze, decido di rimetterlo in funzione. All’inizio, mi facevo preparare i panetti per la pizza da un forno amico, poi, vedendo che la cosa funzionava, decido di lavorare anche sull’impasto e mi metto a studiare. Sono da sempre un autodidatta e, col tempo, la cosa è diventata sempre più interessante e appassionante. Poi, è arrivata una chiamata da Lucio Ferlito di “Al Vicolo Pizza & Vino”, ho lasciato il locale che avevo e ho iniziato un percorso nuovo, interamente dedicato alla pizza. Nei primi tre anni, mi sono dedicato alle farciture; poi, ho iniziato a mettere le mani in pasta e a fare le pizze e qui ho scoperto (non solo io) di avere una certa dote, un talento naturale.

Cos’è per te la pizza? Cosa rappresenta?
Per me la pizza è come un quadro per un pittore: riflette ciò che sei. In ogni impasto, in ogni farcitura, ci metto tutto me stesso. Se sai davvero leggerla, una pizza può raccontarti la personalità di chi l’ha creata. È espressione di cultura, di territorio, di popolo.
Nel 2023, vinci il talent “MasterPizza Champion”: come è nata l’idea di partecipare a questo programma e cosa ti ha portato questa vittoria?
Premetto che non avevo mai partecipato a nessuna gara, a parte il Campionato Mondiale della Pizza a Parma, dove il mio titolare organizzava un team. Una sera,
mentre scorrevo Instagram, vedo la presentazione di questo programma e, d’istinto, mi iscrivo tramite un contest online. Ero ignaro delle dinamiche e, rispetto ad altri concorrenti che tornavano da edizioni precedenti, io ero lì per giocare, per fare esperienza. E, con questa leggerezza mi ritrovo a passare le varie fasi, arrivare alla finale e vincerla, quasi senza crederci. Dopo 13 anni di lavoro, quella è stata una soddisfazione personale immensa. All’inizio, vieni travolto dall’adrenalina: ti chiamano, ti cercano, ti invitano… Ma poi, una volta passata la “bolla”, capisci che è il momento di prendere una direzione precisa e oggi mi riconosco totalmente nel mio lavoro e, nella mia città, oltre ad aver sposato il progetto del Pizzaiolo del Cambiamento de “Le 5 Stagioni” e ad essere diventato anche ambassador per la Sicilia di “Moretti Forni”.
È venuto il momento di parlare della tua pizza. Ci racconti qualcosa del tuo impasto e che tipologia di pizza fai?
“Al Vicolo” ha la particolarità di essere un marchio che ingloba più realtà, tutte lungo la stessa strada. Dalla pizzeria classica alla bakery, decliniamo la pizza nelle sue diverse forme: classica, padellino, trancio, pizza in pala, con cui mi diverto molto e anche la versione senza glutine.
Il primo forno elettrico a platea rotante

Il più versatile forno elettrico touch screen sovrapponibile

La mia è una pizza di ispirazione contemporanea ma molto più asciutta, non gommosa e con un morso croccante. Lavoro con grani autoctoni come la Tumminia ma anche farine multicereali, il kamut e, per la pizza classica, lavoro i miei impasti con la semola, proprio come vuole la tradizione siciliana e, in particolare, catanese dove la pizza si fa con un 50% di semola e il resto tipo 0 e 00.
Per quanto riguarda i topping, ti ritieni un “classico” o un innovatore?
Caratterialmente sono o bianco o nero ma, in questo caso, scelgo di stare al centro e di lavorare con le sfumature. L’ispirazione la prendo dalla tradizione, sono molto legato al territorio e alle ricette di casa e ai piatti e prodotti tipici, che amo far rivivere sulle mie pizze. Come la pizza con la caponata, con la Vastedda del Belice, nocciole tostate e cioccolato di Modica per dare un tocco creativo.
Anche le pizze con cui ho vinto la finale di “Masterpizza Champion” erano un omaggio alla mia Sicilia: un padellino al cannolo siciliano con impasto al cioccolato,
nocciole e pistacchio, asciugato a bocca di forno, poi farcito con ricotta di pecora e granella di pistacchio e nocciole o l’altra pizza con verdure, esclusivamente del mio territorio, che ho chiamato “Terra senza spreco”, per raccontare l’importanza di valorizzare ciò che la terra offre senza scarti.
La Capricciosa: per me è quella combinazione di sapori e odori perfetta che rappresentano di più la mia idea di pizza.
Da anni la tua casa professionale è
“Al Vicolo Pizza&Vino”: mi racconti la storia che c’è intorno a questo luogo?
Possiamo parlare di riqualificazione urbana e di valorizzazione?
“Al Vicolo Pizza&Vino” rappresenta la scommessa più grande di un pizzaiolo imprenditore, Lucio Ferlito, che ristruttura una vecchia lavanderia in un piccolo
vicolo, senza illuminazione, del centro storico di Catania, non distante dall’anfiteatro romano, uno dei simboli della città etnea. Grazie alla caparbietà di Lucio e alla pizza formato gigante che aveva pensato e con cui ha saputo conquistare Catania, ora “Al Vicolo Pizza&Vino” (che era un piccolo spazio con una ventina di posti a sedere) è diventato una realtà imprenditoriale innovativa, un gruppo che comprende “Vinicolo Hub”, una bakery, la pizzeria, il ristorante, un cocktail bar e di cui sono orgoglioso di far parte. Come hai ben detto, è stato un grande progetto di riqualificazione urbana: attraverso il cibo e la pizza, quel vicolo di Catania ha trovato nuova forma e nuova vita ed è un punto di riferimento per turisti e per gli stessi catanesi.
Guardando il menu di “Al Vicolo Pizza&Vino”, tutte le pizze in carta hanno i nomi delle vie di Catania, disegnando una sorta di “Tuttocittà gastronomico”: come mai questo omaggio?
Una cosa pensata fin dagli esordi, sicuramente un modo per distinguerci dalle altre pizzerie ma anche un tributo ad una città che abbiamo nel cuore. Abbiamo creato così una mappa del gusto dove ogni pizza non è solo qualcosa da mangiare, ma anche un posto da vedere e da scoprire.



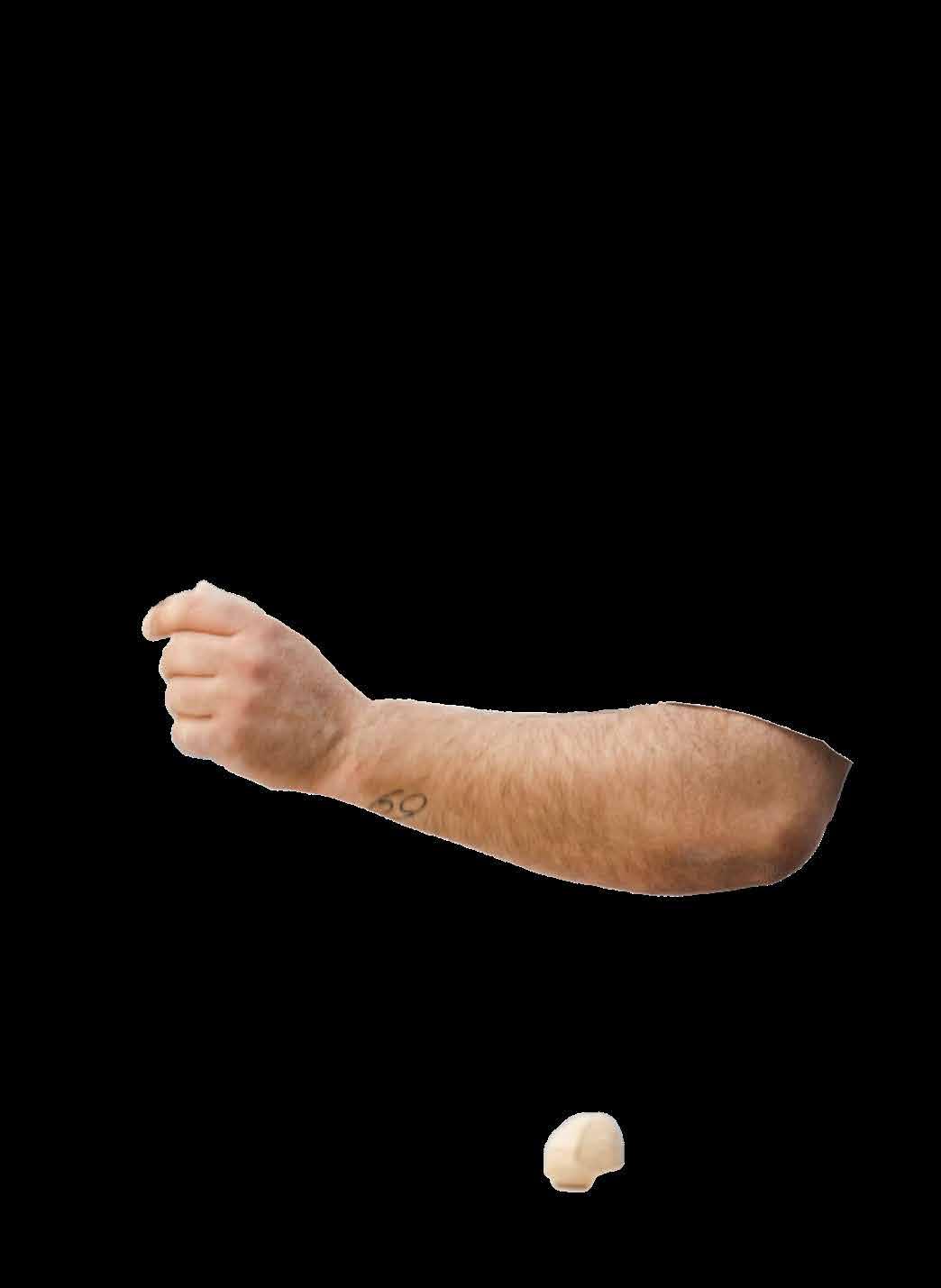
“Le radici profonde non dubitano mai che la primavera arriverà.”
(Marty Rubin)
E Francesco Arena – proprietario dell’omonimo forno nel centro di Messina – ha scelto di non dubitare della primavera. Mastro fornaio e creatore di bontà, porta nel cuore una storia iniziata nel 1939, tra le mani di sua nonna e poi di suo padre. È cresciuto respirando il profumo del pane appena sfornato, imparando che tempo, pazienza e amore sono gli ingredienti più veri. Quelle radici, solide e vive, gli hanno dato forza per crescere e visione per cambiare. Non le ha mai rinnegate ma ha saputo trasformarle in spinta, perché evolversi è necessario. Nel suo mondo, tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno, tra grani antichi, lievito madre, rispetto per la filiera e un’energia tutta femminile che dà forma, con gentilezza e passione, a ogni impasto. Ogni pane racconta la sua terra, la sua identità, e quella sfida di restare sé stesso, pur continuando a evolversi continuamente.
Francesco, parlami di te, raccontami chi sei. Vieni da una storica tradizione familiare: com’è stato crescere tra farine, pani e lievitazione? Hai sempre voluto seguire questa strada?
Crescere in una famiglia di fornai significa respirare ogni giorno il profumo del pane appena sfornato e imparare fin da piccolo che il tempo, la pazienza e l’amore sono gli ingredienti fondamentali. Mia nonna prima, e mio padre poi, mi hanno trasmesso un sapere antico fatto di gesti ripetuti, di albe trascorse davanti al forno e di mani sporche di farina.

La mia azienda ha una storia iniziata nel 1939, che sento la responsabilità di preservare, custodire e raccontare. Anche quando le radici sono solide, evolversi è necessario. Ma farlo richiede coraggio, visione e soprattutto equilibrio. Innovare senza rompere il legame con la propria storia è la vera sfida. E le strade per farlo sono diverse. Una di queste è sicuramente la ricerca continua. Scoprire nuovi prodotti, studiarli, saperli valorizzare. La mia personale esperienza con i grani antichi mi ha portato a instaurare un dialogo più profondo con i clienti. Perché oggi, chi entra in panificio non cerca solo pane: vuole sapere cosa compra, da dove viene, quale valore rappresenta. È nostro dovere spiegare, raccontare, confrontarci. Perché non possiamo dimenticare che la conoscenza genera fiducia. Non nego che ho vissuto alcuni momenti
in cui ho pensato di allontanarmi da questa strada ma, alla fine, ho capito che il pane era il mio destino. È il mio modo per parlare al mondo, per raccontare la mia terra, la mia storia e l’eredità che porto dentro.
Nella tua nuova “casa” in centro, hai fatto la scelta di panificare con grani antichi e lievito madre: cosa ti ha spinto a farlo? Qual è il filo che lega la memoria della tua famiglia con la sperimentazione di oggi? E qual è la tua filosofia?
La mia nuova “casa” è un laboratorio a cielo aperto, un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano ogni giorno. Ho

scelto i grani antichi perché raccontano la verità della terra siciliana: Tumminia, Russello, Perciasacchi non sono solo farine ma identità e valorizzazione della filiera, dal contadino alla tavola, passando per il mugnaio. Il lievito madre è un organismo vivo, come la nostra memoria: cambia, evolve ma mantiene un legame profondo con le origini.
La mia filosofia è chiara: essere contemporaneo senza tradire le radici, sperimentare con rispetto.
Ogni pagnotta deve avere un’anima, una storia da raccontare.
Tradizione e innovazione possono coesistere soltanto rispettando le origini e i prodotti, integrando le tecnologie moderne che ci aiutano nello sviluppo e nella programmazione della produzione. La qualità resta il fulcro. Selezionare materie prime eccellenti e inserirle in proces-
si produttivi che rispettino la tradizione ma siano aggiornati ai tempi: è la chiave per restare competitivi. Le tecnologie, dal caldo al freddo, ci permettono di organizzare meglio la produzione, ridurre i costi e limitare gli sprechi.
Qual è il “pane della tua anima” e cosa racconta di te? Proponimi due prodotti che mi faresti assaggiare per farmi capire chi sei davvero. E, dimmi, perché proprio quelli?
Il “pane della mia anima” è quello che faccio con Tumminia e Russello, lievito madre e lunga fermentazione: è rustico, intenso, profuma di Sicilia e ha una crosta che canta quando lo tagli. Racconta la mia
terra, il mio amore per ciò che è autentico. Ti farei assaggiare la focaccia messinese: un omaggio alla cultura mediterranea, con materie prime di prossimità e gusto netto; ma anche il “pane nero” con semi misti, grani antichi e fermentazione spontanea, perché è imperfetto, vivo, in continua trasformazione, proprio come me.
So che usi pomodorini Pachino o pomodori locali freschi; cosa cerchi nella materia prima per esaltare davvero il tuo prodotto?
Cerco verità e stagionalità. Un pomodoro dev’essere quello giusto, raccolto al momento giusto, nel luogo giusto. Quando uso i Pachino IGP o i pomodori coltivati da piccoli agricoltori locali, cerco sapore, dolcezza, acidità e struttura: elementi che devono integrarsi con gli impasti e non coprirli. La materia prima non deve fare scena, deve dialogare con i miei prodotti, non urlare.

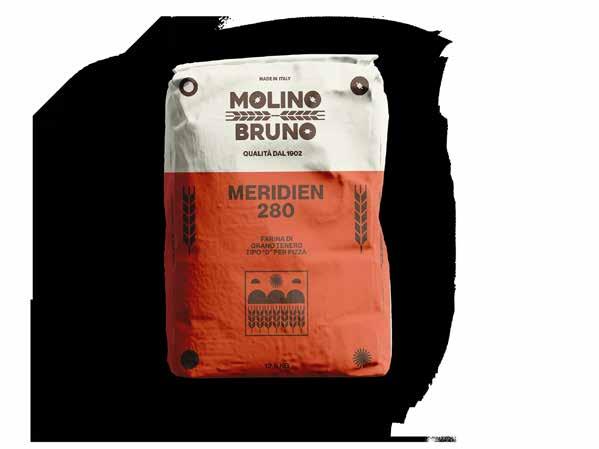


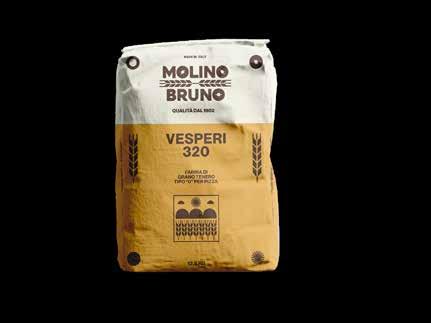




So anche che hai voluto una squadra al femminile: che energia ti dà lavorare accanto a donne in questo mondo dominato dagli uomini?
Nel mio forno c’è un’energia gentile e potente, fatta di precisione, cura e creatività. Ho scelto una squadra al femminile non per provocazione ma per omaggiare mia nonna in primis e perché credo che la sensibilità femminile sia una risorsa fondamentale in un mestiere che richiede ascolto e presenza. Ogni giorno imparo qualcosa da loro e insieme stiamo dimostrando che la qualità non ha genere, ha solo passione.
Hai vinto diversi premi, riconoscimenti importanti. Come hai vissuto quei momenti?
Ogni riconoscimento è stato un’emozione ma anche una responsabilità. Non cerco premi, cerco connessioni vere con le persone ma quando arrivano riconoscimenti da realtà importanti, come quelli che ho
ricevuto, sono una conferma che il lavoro silenzioso e costante ha un valore. Li vivo con gratitudine, pensando a mio padre, a mia nonna, a mia moglie e alle mie figlie che spesso e volentieri hanno subito la mia assenza per il lavoro ed infine - ma non per importanza - a tutte le persone che ogni giorno mettono le mani in pasta con me.

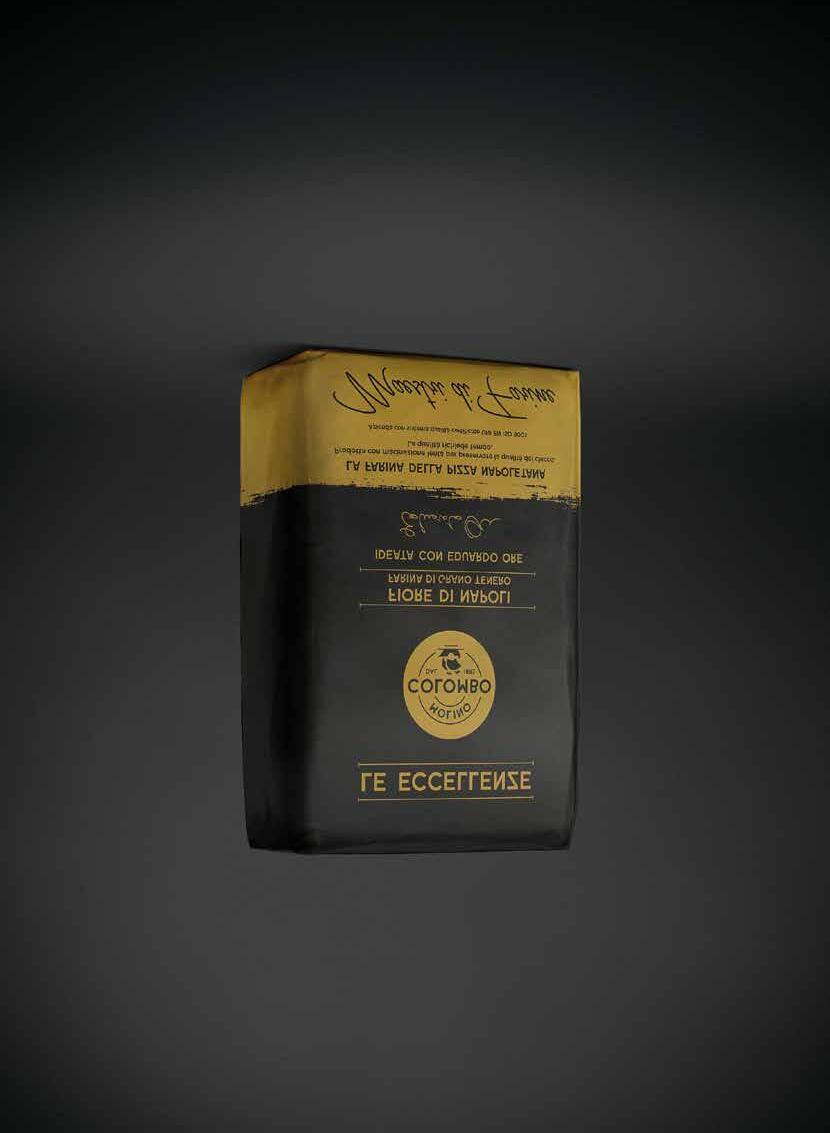
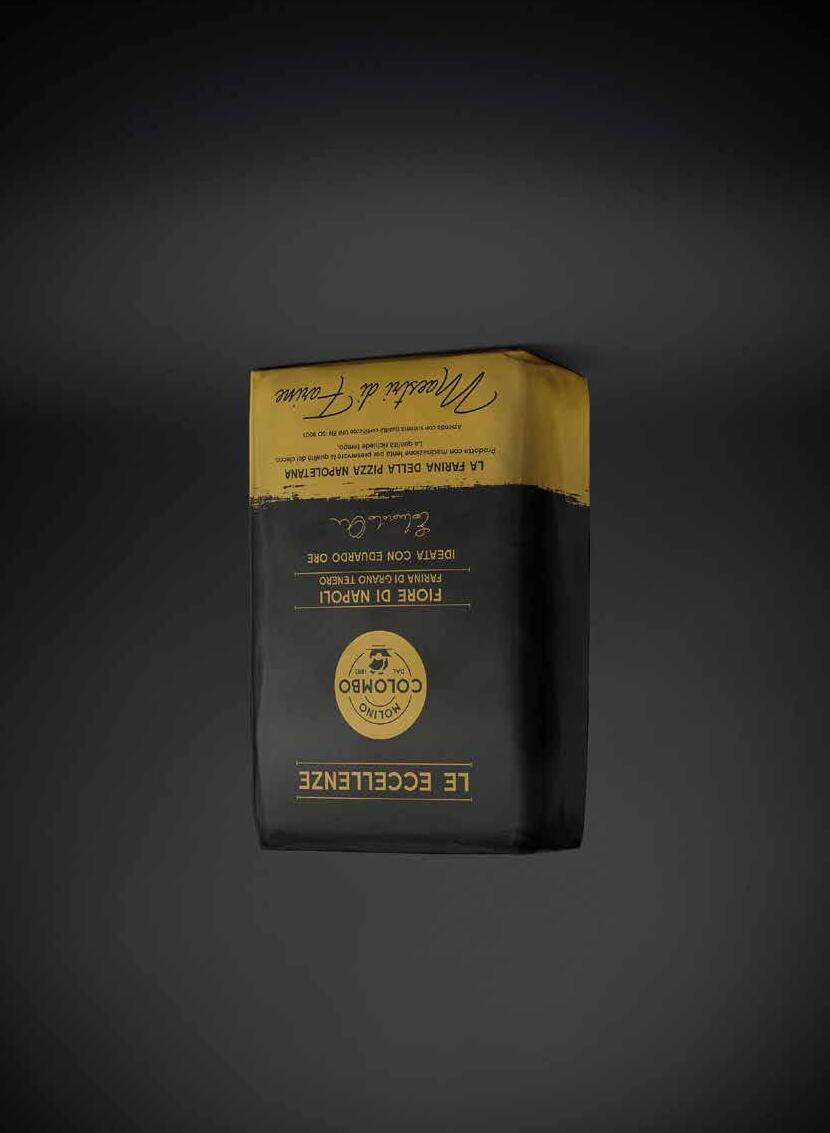
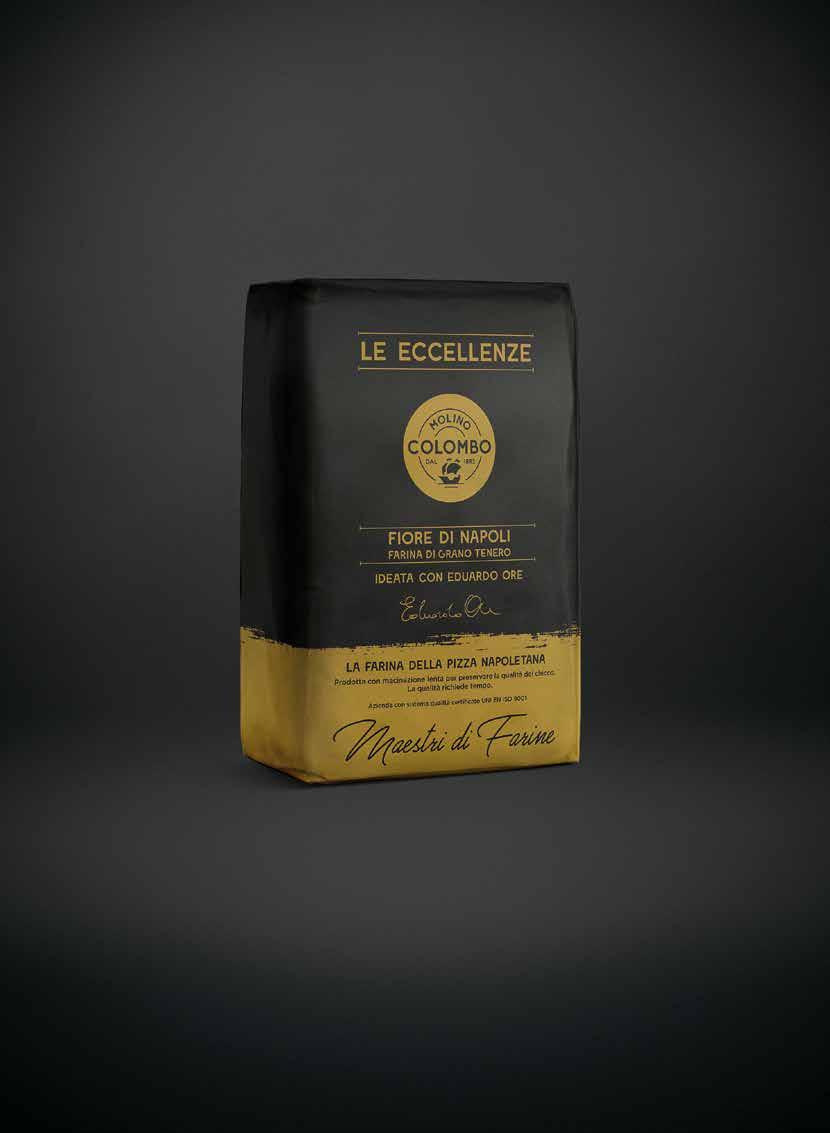
PER LA TUA PIZZA NAPOLETANA SCEGLI LE ECCELLENZE DI MOLINO COLOMBO, LA FARINA IDEATA IN COLLABORAZIONE CON IL MAESTRO PIZZAIOLO EDUARDO ORE.
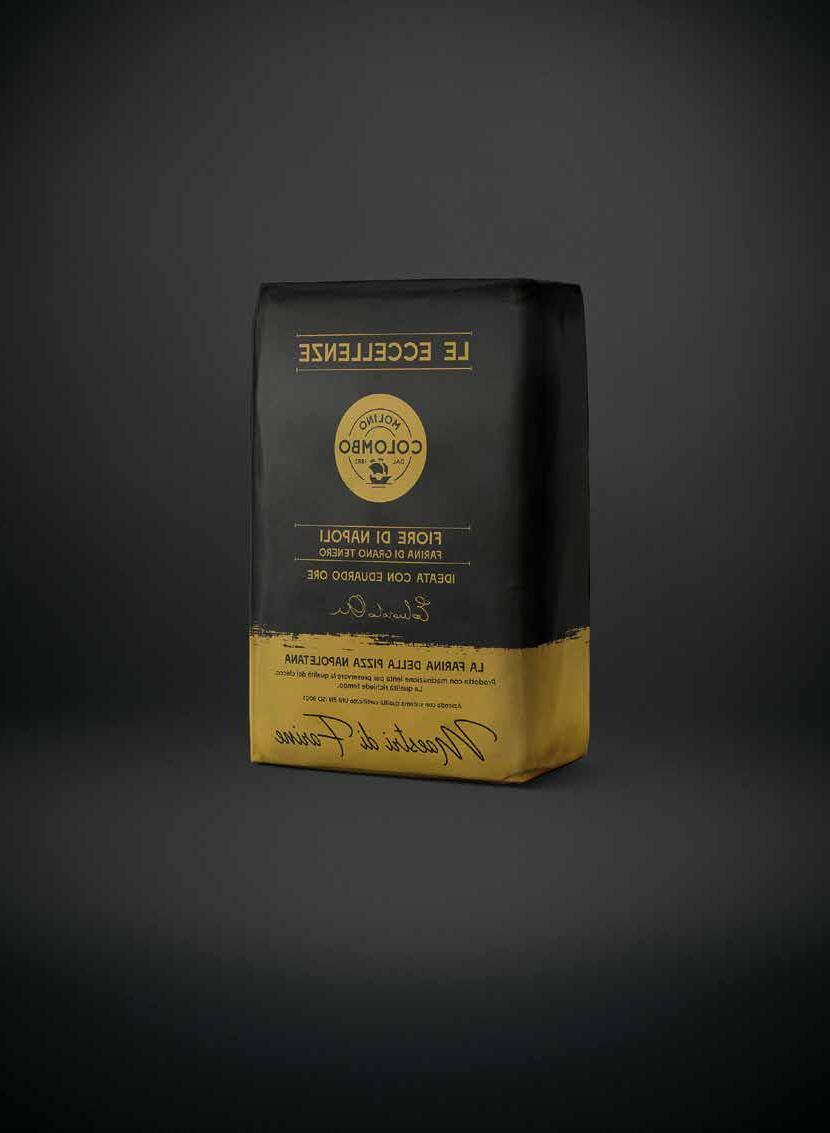
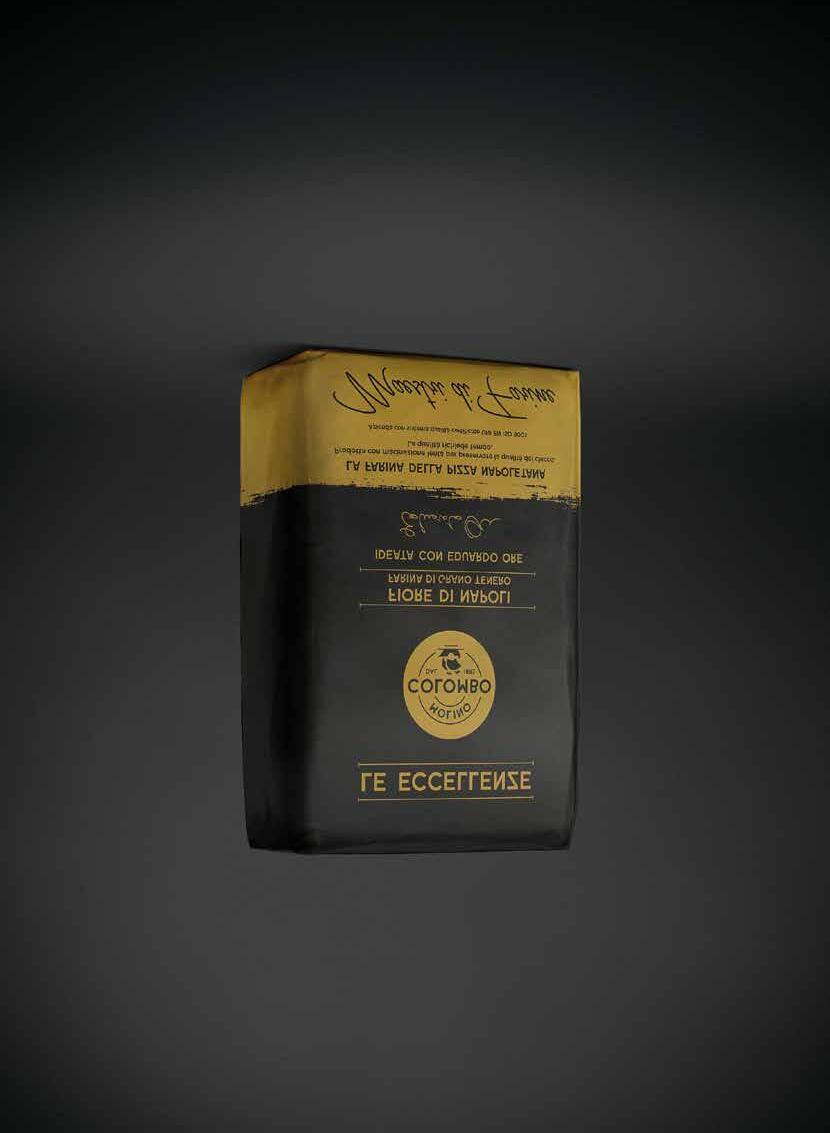
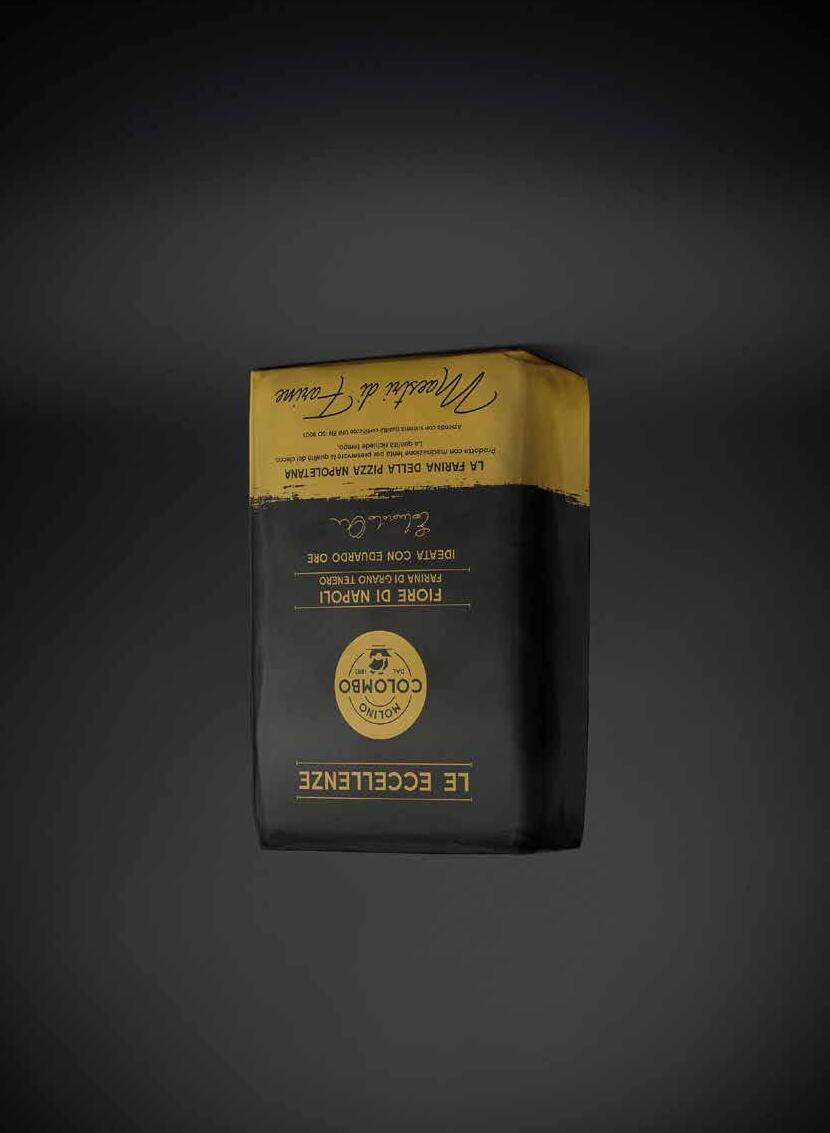

Classe 1975, nato il 20 marzo, Agostino Coppola è originario della Campania e, all’alba del suo cinquantesimo compleanno, è più che mai convinto della superiorità della cucina italiana di fronte a tutte le altre gastronomie del mondo. Non a caso, è Presidente della Federazione Italiana Cuochi in Francia, tra le delegazioni più attive (se non la più attiva) della confederazione fuori dai confini dello Stivale.
Agostino si definisce “uno a cui piace la cucina e che ama portare i valori dell’Italia, ovunque, non solo all’estero”. Ha cominciato a lavorare in pizzeria quando era ancora molto giovane ma, come dichiara lui stesso: “Lo facevo per perdere un po’ di tempo con zii, cugini e amici”. Non ha frequentato l’alberghiero, bensì l’ITIS e allora la prima domanda di questa chiacchierata sorge spontanea.
Come ti sei appassionato al mondo della cucina?
Merito di mio padre. Sia chiaro: non era un cuoco ma cucinava ogni tanto e, quando cucinava, mi trasmetteva una bella sensazione. Avevamo alcuni terreni a Battipaglia e spesso andavamo lì, anche senza mia madre. Così, all’età di 11-12 anni ho iniziato anche io a cucinare, per gioco, per stare con lui facendo cose semplici.

E la tua prima vera esperienza in cucina qual è stata?
Sicuramente, quella del 1994 con Annamaria Nocera all’Isola d’Elba. Prima di allora, ero solo andato spesso a far visita al mio padrino di battesimo che aveva un ristorante a Crema che si chiamava “Marechiaro”.
Beh, un nome, una garanzia: era originario di Tramonti? So, infatti, che quasi tutte le pizzerie nate grazie a pizzaioli di Tramonti fuori dalla Costiera Amalfitana si chiamano così.
No, non lui ma il proprietario che faceva di cognome Giordano. Poi, lo ha rilevato lui e ora non è più attivo.
E, invece, come ti avvicini alla Federazione Italiana Cuochi?
Mi sono avvicinato alla FIC a fine anni ’90 grazie a Fabio Tacchella, che era lo chef della Nazionale Italiana Cuochi. Sin da giovane, io amavo molto Vissani che era legato alla Federazione; poi, seguendo la Federazione, mi sono avvicinato alla Nazionale italiana cuochi e così sono rimasto affascinato da questo mondo. Dal 2003 al 2006 sono stato iscritto alla sezione di Castellammare perché lavoravo a Sorrento; successivamente, mi sono trasferito in Belgio e lì non sono stato più socio.

E dal Belgio sei arrivato in Francia.
Sì, a fine 2011: ho avuto 4 attività che ho poi interrotto nel periodo del Covid, soprattutto però per la difficoltà di gestire il personale. Dal 2018, però, ho iniziato a partecipare ai Campionati di cucina e, dunque, mi sono riavvicinato alla FIC.
So che oggi, nel tuo lavoro, porti anche gli associati della Federazione: perché?
Quattro anni fa ho iniziato a collaborare con Carniato, un importante distributore di prodotti italiani per alcune degustazioni di gastronomia “tricolore” in Francia. Successivamente, Carniato mi ha chiesto se volessi diventare responsabile qualità della selezione dei prodotti e iniziare un percorso di affiancamento ai ristoratori per comprendere con loro quali prodotti scegliere per le loro referenze e come utilizzarli al meglio. Con Carniato, come FIC, collaboriamo inoltre al Roland Garros, al parco Disneyland e anche in altri appuntamenti importanti. Ho coinvolto la Federazione perché credo molto nell’associazionismo e lo porto sempre con me, nelle mie collaborazioni professionali.
Come coinvolgi gli associati in Francia?
La FIC in Francia è sempre esistita ed è la più attiva di tutte le associazioni estere: basti pensare che ha realizzato 22 eventi nel 2024. La maggior parte del recluta-
mento è facile: si avvicinano loro a me perché si sente il desiderio di team. Poi, quando arrivano i riconoscimenti, è ancora più semplice. Quest’anno a Rimini abbiamo vinto la medaglia d’oro ai Campionati di cucina e lo abbiamo fatto con chef italiani. In passato, si vinceva comunque ma con una differenza: c’era un cuoco italiano in squadra e poi tutti gli altri erano docenti di cucina e chef stellati; io, invece, nella mia nazionale ho solo un cuoco francese e tutti italiani. Come dire: non mi piace vincere facile!


Beh, però, se dici così, vuol dire che pensi che i Francesi tutto sommato cucinino meglio…
Ovviamente no (sorride, ndr). Ma quando tu metti un cuoco francese a fare cucina gourmet ed è uno chef stellato, come fa a non vincere in una competizione? Noi, invece, le stelle le vediamo solo in cielo!
Lo dici perché sei innamorato della nostra cucina?
Sicuramente, ma lo dico anche perché l’ho sperimentato come cuoco e come imprenditore: la cucina italiana all’estero è la più amata, perché è semplice, semplicissima. Arrivi in un posto e puoi far mangiare 100 persone in poco tempo e farli star bene.
Qual è secondo te il futuro della cucina italiana?
Dipende da noi, solo da noi. Se veramente ci teniamo e riusciamo a farla restare semplice, continuerà a brillare.


storie di dolci
di Noemi Caracciolo
C’è un luogo, nel cuore di Napoli, dove fare impresa significa restare fedeli a un’idea, senza compromessi. Parlo di “Taverna Santa Chiara”, un locale che rappresenta più di una cucina. È una scelta di vita, un atto politico, un gesto d’amore quotidiano.
Tutti elementi che Nives Monda - una donna che ha trasformato il proprio cammino in resistenza gentile e determinata - insieme ad altri tre soci, lo Chef Potito Izzo, Antonio Russo, e Giovanna D’Alonzo, racconta attraverso il sapore di cose buone e autentiche. La loro è una proposta che segue il ritmo delle stagioni, fondata sulla qualità della materia prima e su una narrazione del territorio che rifiuta scorciatoie. Portano in tavola un’ospitalità schietta, piatti della tradizione ma mai scontati e la volontà chiara di restare fedeli a un’identità precisa, senza bisogno di effetti speciali. Una storia bellissima, fatta di rispetto per la biodiversità, per l’essere umano e la cultura gastronomica.
Nives, raccontami la tua storia: chi sei tu? So che hai cambiato completamente lavoro e “Taverna Santa Chiara” è arrivata nel 2014. Cosa ti ha spinto a questo cambiamento così netto? Qual è la storia di questa bella realtà? Ho iniziato il mio percorso professionale dopo una laurea in Economia e Pianificazione territoriale, lavorando prima al Patto del Miglio d’Oro –un’unione di Comuni – e poi alla Lega delle Cooperative, occupandomi di consulenze per lo sviluppo locale.
Parallelamente, ho fatto volontariato con i bambini dei bipiani di Barra, toccando con mano l’impatto della marginalità e dell’insicurezza abitativa. Successivamente, ho lavorato con una cooperativa per l’attuazione dei fondi strutturali europei, come project manager in Campania, Sardegna e poi Lombardia e Piemonte e anche come animatrice per le pari opportunità alla Regione Campania. Con un team misto di uomini e donne ci occupavamo di politiche di genere e monitoraggi. Era un lavoro importante ma sempre più lontano dalla realtà concreta delle persone a cui quei fondi erano destinati. Troppo tecnico, troppo burocratico. Per motivi personali, ho scelto di abbandonare. Poi ho incontrato la Taverna. Mi avevano chiesto un supporto nell’organizzazione aziendale e ho capito che volevo restare. Nel 2014 l’ho rilevata. Oggi ho due figli, viviamo a Napoli, anche se io ho trascorso periodi a Londra e in Germania, prima di tornare definitivamente.
Ti sei sempre mostrata coerente con le tue idee, “controcorrente” per così dire. So che non ti sei piegata alle logiche turistiche, difendi la nostra “lingua” e la cucina delle origini, non rincorri il consenso facile. Tu come ti racconteresti a chi non ti conosce?
Ho sempre avuto passione per le persone e una curiosità “antropologica”. Ho affrontato realtà diverse. Dal volontariato alla militanza politica ed eventi culturali, anche nel tempo libero. Sono una lettrice accanita, amo le librerie indipendenti: sono luoghi in cui ci può e ci si deve perdere. Inoltre, mi affascinano le culture gastronomiche. A Londra, ho lavorato in un ristorante italiano, nel quale ho sco-

perto quanto si apprezzava il nostro cibo e che c’era tanta curiosità intorno ad esso, quando ancora – negli anni ‘90 – in Italia mancava attenzione alle materie prime. Poi mi sono avvicinata a Slow Food grazie al libro Cibo e libertà di Petrini. Mi definisco assolutamente antifascista, grazie ai valori che mi ha trasmesso la mia famiglia. Mia madre mi ha insegnato lo spirito critico, mio padre - dapprima operaio e poi lavoratore dell’Enel - l’etica del lavoro. Ho origini semplici, ho sempre saputo cos’è giusto e pensare a ciò che avevamo in senso laico e non buonista; consapevole che i privilegi vadano condivisi, non usati per contraffazioni. La mia coerenza è la spina dorsale che la mia famiglia mi ha dato, anche mio fratello e tutti i miei cugini, siamo tanti. E ci sono sempre stati scambi di questo tipo in famiglia. In casa si parlava di politica come di vita: essere cittadini coscienziosi è un dovere.
Potito Izzo è il tuo compagno in questa avventura. Com’è nata la vostra collaborazione e cosa condividete, dentro e fuori dalla cucina?
Potito era già dipendente quando ho conosciuto la Taverna nel 2013. Ci siamo intesi subito. Lui ha una formazione da cuoco, tecnica, da alberghiero, la “vecchia scuola” del sacrificio, della disciplina. Un giorno del dicembre 2013, mentre preparavamo pizze di scarole per il 24, abbiamo capito che era tempo di unirci. Da allora, siamo soci e non ci siamo mai fermati. Ci rispettiamo nel lavoro: lui cucina, io mi occupo di sala e amministrazione, ci confrontiamo ma nessuno sovrasta l’altro. Nel 2021, dopo la pandemia, si è unito a noi Antonio Russo, nostro giovane aiuto cuoco e da sempre presenza morale concreta, diventato socio, insieme a Giovanna D’Alonzo, un’amica che ci sosteneva negli eventi. Abbiamo pensato: “perché non allargare la squadra?”. Oggi siamo quattro soci.
Come scegliete i prodotti? Mi incuriosisce capire dove nasce la vostra cucina, ancor prima che entri in pentola. E come descriveresti la filosofia di Taverna Santa Chiara?
Due sono i nostri capisaldi: territorialità e stagionalità, in linea con il mantra di Slow Food: buono, pulito, giusto. Per territorialità, intendo che usiamo solo prodotti campani: dalle materie prime ai vini e ai liquori. Per stagionalità, il rispettare la biodiversità, evitare prodotti fuori stagione che danneggiano ambiente e culture locali. Siamo attivi nella lotta contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e sosteniamo campagne come “Fuori Mercato” e lo “Scugnizzo Liberato”, dove abbiamo organizzato laboratori di educazione alimentare. Insieme a Slow Food, al centro storico, abbiamo creato una Comunità resistente, di cui fanno parte un bar, una libreria, un orafo, una docente in pensione, studenti e musicisti di musica barocca, con iniziative ideate intorno al cibo per restare lontani dalla turistificazione.
Quali sono i piatti che più vi rappresentano e perché? Cosa consiglieresti subito a chi entra per la prima volta?
Direi sicuramente la Genovese, che mescola tradizione e innovazione, preparata con cipolla di Airola, un prodotto che rischia di sparire. La carne alla pizzaiola, un piatto popolare che spesso viene dimenticato, ma importante per noi. Il Baccalà fritto in pastella con cipolla caramellata in riduzione di Aglianico. Ovviamente il Migliaccio antico, un dolce napoletano che trasformiamo con ricotta di fuscella (vaccina) e più uova, una sorta di soufflé. Per le bevande, consiglierei il vino della casa del consorzio sociale del Taburno (Torrecuso), un Fiano di Ciro Picariello, un rosso Aglianico “Primalaterra” di Salvatore Magnoni e i rosoli artigianali dei fratelli Santangelo di Ischia (malvarosa, limoncello,

nocino). La materia prima proviene da piccoli produttori e prendiamo pochissimi articoli nei cash & carry. Molto spesso sono loro o i clienti a proporci prodotti inaspettati, in sintonia con le nostre scelte. I Presìdi Slow Food da noi usati includono il lupino gigante di Vairano di “Masseria del Sesto”, la papaccella del Vesuvio di Vincenzo Egizio, il caprino “Le Starze” del Cilento, la cipolla di Airola di “Masseria della Contessa”. Altri importanti fornitori per noi sono la “Fattoria Muccio” e l’azienda agricola “Giovanni Pucciarelli”. Proponiamo inoltre il pane artigianale, quello dei fratelli Troisi, fatto con lievito madre e farine di grani antichi. Anche la pasta è di produzione artigianale: portiamo avanti un progetto che si chiama “dal grano alla pasta”, in cui viene usata solo farina proveniente da grani tradizionali come Senatore Cappelli e Gentil Rosso. La raccolta e la macina sono organizzate dal produttore Ciro Pirone di Dugenta, in provincia di Benevento e la lavorazione della pasta viene effettuata presso la “Casa del Tortellino” di Angri (Salerno) di Gioacchino Orlando.
Negli ultimi tempi, il tuo nome ha girato molto, anche fuori dal mondo del cibo. Come hai vissuto tutto questo rumore e cosa ti tiene ancora salda, ogni giorno, nel tuo lavoro?
Quando lavoravo a Mariglianella e In “Taverna Santa Chiara” non abbiamo mai cercato visibilità. Sosteniamo cause civiche e sociali, difendiamo sfrattati, aiutiamo i senza fissa dimora, lottiamo per il verde pubblico e l’accessibilità delle spiagge. Siamo contro ogni ingiustizia e discriminazione. Abbiamo preso posizione contro il genocidio palestinese, aderito al boicottaggio BDS, rigettando prodotti e comportamenti che contribuiscono a quella crisi umanitaria. Questo ci ha esposti a una vera e propria gogna mediatica: haters e accuse di antisemitismo da chi era venuto nel locale. È assurdo. Veniamo da una cultura antifascista e abbiamo profondo rispetto per l’olocausto. Non abbiamo mai ritrattato.
Oggi più che mai sosteniamo la necessità di fermare i criminali che affamano e uccidono civili, soprattutto bambini, a Gaza. Anche se siamo persone normali, abbiamo scelto di restare uniti e continuare, nonostante gli attacchi che ci hanno colpito in modo brutale, dalla nostra salute mentale, all’attività, alla famiglia. Io stessa sono stata denunciata per incitamento all’odio ma la denuncia, non sussistendo il fatto, è stata archiviata. Stiamo ricevendo solidarietà da clienti, da Slow Food e da persone di ogni parte del mondo, qualsiasi religione o etnia. Ieri è venuta anche una signora di Varese, di origine ebraica, i cui parenti sono stati vittime ad Auschwitz: ci ha detto che i manifestanti non la rappresentano. Anche molti Ebrei sono preoccupati per i crimini compiuti dal sionismo contro civili inerti. La situazione si è un po’ calmata ma resta la cosa più triste l’attacco da parte di mass media, giornalisti, politici, personaggi tv. Su questo siamo fermi. Non possiamo permettere la gogna mediatica su chi esprime una propria opinione. Siamo stati travolti da polemiche che hanno messo a rischio la nostra salute mentale, la nostra attività, la nostra famiglia. L’attacco alla popolazione palestinese ci riguarda in prima persona. Mette in discussione gli organismi internazionali di tutela del diritto umanitario. E, per questo, siamo ancora in prima linea in questa battaglia per la democrazia internazionale.

- 125 di semola di grano duro
- 3 etti di ricotta di fuscella
- 2 uova intere e 3 tuorli
- 3 etti di zucchero semolato
- zucchero a velo
- 2 limoni
- la punta di un cucchiaino di semini di vaniglia
- 750 ml di latte nobile
- acqua di fiori di arancio
- mezzo bicchiere di limoncello (o altro liquore)
- una noce di burro e sale
- Portate il latte a ebollizione, incorporate la semola, un pizzico di sale e cuocete per qualche minuto, rimestando per non creare grumi. A parte, sbattete le uova e i tuorli con lo zucchero semolato, quindi unite la ricotta passata al setaccio.
- Aggiungete l'aroma di fiori di arancio, il limoncello, i semini di vaniglia e la scorza dei limoni grattugiata al composto con il latte e, una volta intiepidito, unitelo alla miscela di ricotta e uova.
- Ungete i 2 pirottini, riempiteli poco più della metà con il composto, infornate a 180°C per 20 minuti, poi abbassate la temperatura a 160°C e cuocete per altri 20. Servite i dolcetti tiepidi, cosparsi di zucchero a velo.
Lo chef Potito Izzo della Taverna utilizza la ricotta vaccina, invece di quella di pecora, per dare leggerezza al composto.
Tempo di esecuzione: un’ora.
I PARTNER DEL CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA
1. Squadra che vince non si cambia: che cos’è per te il Campionato mondiale della pizza?
AGUGIARO & FIGNA MOLINI
Società Benefit
Strada Dei Notari 25/27 Collecchio 43044, Parma 5stagioni@agugiarofigna.com
Tel. 0521301701
Il Campionato Mondiale della Pizza è molto più di una competizione: è un appuntamento che ci accompagna da oltre trent’anni e che, anno dopo anno, conferma quanto questo mestiere sia in continua evoluzione. A Parma, per tre giorni, si concentra tutta l’energia, la creatività e la determinazione di centinaia di pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo. Per noi è una grande occasione per osservare da vicino i trend che stanno nascendo, confrontarci con chi utilizza ogni giorno le nostre farine e capire quali sono le nuove esigenze del settore. È un luogo di dialogo e ispirazione, dove si consolidano relazioni e si costruiscono visioni condivise sul futuro della pizza.
2. Qual è la richiesta più strana che hai ricevuto nei giorni del Campionato? Durante il Campionato capita spesso di ricevere richieste fuori dall’ordinario, ma è proprio questo il bello: la varietà di culture, esperienze e approcci che ogni pizzaiolo porta con sé rende ogni edizione unica. Tra le più curiose, ricordo chi ci ha detto di aver di portato la farina in valigia intercontinentale per paura di non trovarla al Campionato Mondiale a disposizione per gli impasti. Episodi che raccontano l’attenzione quasi maniacale per i dettagli e la passione autentica che anima chi partecipa.
3. Quale ricordo ti è rimasto impresso di questa edizione?
Più che un singolo episodio, ciò che colpisce ogni anno è il cambiamento nel profilo dei partecipanti. Negli ultimi anni, e in modo ancora più evidente in questa edizione, abbiamo visto una presenza crescente di donne che si fanno spazio con competenza, determinazione e personalità nel mondo della pizza. Questo contribuisce ad arricchire il settore con sensibilità diverse, nuovi approcci e una visione più ampia del mestiere. È un’evoluzione che stiamo vivendo con interesse e che conferma come la pizza sia oggi un linguaggio aperto, capace di accogliere e valorizzare storie e percorsi diversi.
4. La tua azienda e il futuro della pizza: quali progetti per domani?
Guardando al futuro, crediamo fortemente nella formazione come leva strategica per sostenere il mondo della pizza. Con il progetto Pizzaiolo per il Cambiamento, ad esempio, stiamo lavorando insieme all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per costruire un nuovo modello di gestione della pizzeria, basato su criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È un percorso che nasce dall’ascolto dei pizzaioli, si sviluppa con il loro coinvolgimento diretto e punta a creare strumenti concreti come gli indicatori dei SIA, Studio di Impatto Ambientale, che aiuta a misurare l’impatto della propria attività a livello sociale e ambientale.
Intervistato Riccardo Agugiaro – Amministratore Delegato

Dai migliori grani nord americani, appositamente selezionati, per qualità e forza, nasce TipoZero Manitoba, per accompagnarti in impasti strutturati e indiretti, garantendoti la resa migliore, grazie alla qualità delle sue proteine.
Le 5 Stagioni, natura ad alta prestazione.
UNA NUOVA FARINA TIPO ZERO CON GRANI 100% NORD AMERICANI. le5stagioni.it

NELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO, L’ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE È SPESSO LEGATA A MODE RECENTI O A ESIGENZE
MODERNE DI SALUTE MA, NEL
CUORE DELL’ITALIA MERIDIONALE
– NELLE TERRE CHE UN TEMPO FORMAVANO IL REGNO DELLE DUE
SICILIE – ESISTE UNA LUNGA
TRADIZIONE GASTRONOMICA NATURALMENTE PRIVA DI GLUTINE, SEDIMENTATA NELLA
CULTURA POPOLARE, NELLE RISORSE DEL TERRITORIO E NEI METODI DI LAVORAZIONE TRAMANDATI DA SECOLI.
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia condividono un patrimonio agroalimentare straordinario, dove legumi, mais, riso, patate e farine alternative hanno rappresentato per secoli la base dell’alimentazione quotidiana, soprattutto nelle aree rurali e montane.

Una questione di geografia, storia e cultura
Il Regno delle Due Sicilie, fiorente tra il 1816 e il 1861, unificava l’Italia meridionale peninsulare e insulare sotto una stessa bandiera. Ma molto prima ancora, queste regioni avevano sviluppato un rapporto profondo con la terra e il mare, favorendo un’alimentazione fondata su ciò che era disponibile localmente e con tecniche di conservazione e trasformazione oggi riscoperte come “virtuose”. L’uso delle farine di legumi, del mais, delle castagne, del riso e di alcuni pseudocereali locali era molto diffuso in quanto rappresentava un’alternativa economica al grano, spesso più costoso o difficile da reperire in determinate aree interne.
LA PATRIA DEL MAIS, DELLE PATATE E DEI LEGUM
Nel cuore dell’Appennino campano, la polenta di mais era un piatto comune già ben prima che il Nord Italia ne facesse simbolo nazionale. In zone come l’Alta Irpinia o il Matese casertano, la “pizza di granone” (una sorta di focaccia rustica a base di farina di mais cotta nel forno a legna) o la “polenta con i broccoli” erano pietanze contadine, semplici ma nutrienti.
Un forte legame con la tradizione è quello della preparazione di piatti con il quinto quarto di bovini e suini. Trippa, zuppa forte, soffritto e ‘O Pere e ‘o Musso sono solo alcune delle preparazioni storiche presenti nella cucina popolare campana.
La Campania è anche terra di fagioli, cicerchie e ceci: basti pensare alla zuppa di legumi tipica dell’area del Cilento (dove la Dieta Mediterranea è nata) o alla “lagane e ceci”, una pasta che oggi può essere reinterpretata in versione senza glutine mantenendo l’autenticità dell’accostamento. La patata Ricciona di Napoli e la Nera del Matese venivano utilizzate per gnocchi e impasti semplici, perfetti per chi segue una dieta gluten free

PANE SENZA GLUTINE PRIMA DEL GRANO MODERNO
Sebbene la Puglia sia nota per il suo pane di grano duro e per la pasta, nelle aree murgiane e garganiche si utilizzavano spesso farine di legumi, soprattutto di ceci e fave. Le “fave e cicoria”, uno dei piatti simbolo della regione, sono una preparazione naturalmente priva di glutine, così come lo sono le polpette di fave e patate, diffuse soprattutto nel Salento. La forte presenza di crudo di pesce sulle tavole pugliesi è un altro esempio di cucina naturalmente priva di glutine: dalle tagliatelle di seppia alle cozze pelose, passando per i ricci di mare.
Ancora oggi, molte famiglie conservano ricette di dolci realizzati con mandorle, uova e zucchero – ingredienti perfetti per una cucina senza glutine. Il “Biscotto di Ceglie Messapica” è un dolce tradizionale pugliese, riconosciuto come Presidio Slow Food. Questo biscotto è caratterizzato dalla sua pasta di mandorle, un impasto fatto con mandorle locali, zucchero, miele, scorza di limone, rosolio di agrumi e uova, farcito con marmellata di ciliegie o uva.

Calabria
LA CASTAGNA REGINA DELLA MONTAGNA
La Calabria, con le sue aree montane come la Sila e l’Aspromonte, ha fatto della castagna una risorsa alimentare fondamentale per secoli. La farina di castagne, naturalmente dolce e priva di glutine, veniva utilizzata per preparare pani, focacce e dolci.
Non mancano piatti salati che si prestano perfettamente all’alimentazione senza glutine: le zuppe di fagioli rossi della Piana di Gioia Tauro, i piatti a base di peperoni secchi (come i “cruschi”), le polpette di melanzane, realizzate in origine con patate e le conserve sott’olio, che rappresentano un autentico scrigno gastronomico, oggi rivalutato anche nell’ambito dell’alimentazione funzionale.
ISOLA DELLE MANDORLE, DELLE PANELLE E DELLE GRANITE
L’isola più grande del Mediterraneo ha una cultura culinaria stratificata e ricchissima, che include una moltitudine di preparazioni naturalmente senza glutine. Le panelle palermitane, fatte con farina di ceci, sono uno street food storico che ancora oggi affascina per semplicità ed efficacia. Le “minestre di lenticchie di Ustica” o di ceci neri sono piatti antichi e senza glutine.
I dolci siciliani, poi, rappresentano un universo a parte. Molti sono naturalmente privi di farine di frumento: pensiamo alla cassata di mandorle, alla pasta reale, alle granite (limone, mandorla, gelsi, caffè), alla frutta martorana. La Sicilia ha, inoltre, una lunga tradizione nella produzione di pasta di riso e di mais, diffusasi soprattutto nel secondo dopoguerra ma già presente in alcune comunità legate alla cultura araba ed ebraica.


Una lezione dalla storia per il futuro del gluten free
Risulta evidente come la tradizione del Sud Italia, nel periodo che corrispondeva al Regno delle Due Sicilie, abbia offerto un repertorio gastronomico ricco e naturale, spesso “inconsapevolmente” gluten free. È un patrimonio da riscoprire non solo per chi deve seguire una dieta senza glutine per motivi di salute ma per chiunque voglia riappropriarsi di una cucina legata al territorio, equilibrata, sostenibile.
La riscoperta di queste ricette non deve essere letta in chiave nostalgica ma piuttosto come un’ispirazione contemporanea: per valorizzare le filiere locali, recuperare le varietà agricole storiche e proporre nei ristoranti, nelle mense e nei menù quotidiani alternative più sane e inclusive.
In un’epoca in cui il “senza glutine” rischia di diventare un’etichetta commerciale vuota, guardare alla cultura gastronomica del Regno delle Due Sicilie ci ricorda che esiste un modo autentico, saporito e identitario di vivere senza glutine, che affonda le sue radici nella storia e guarda dritto al futuro.
Campionato della Pasta Fresca Fatta a Mano
DOMENICO PASTENA, 35 ANNI, PATRON DEL RISTORANTE
“PASTÈNA” NEL CENTRO STORICO DI NAPOLI, HA CONQUISTATO LA SECONDA
EDIZIONE DEL CAMPIONATO
DELLA PASTA FRESCA FATTA
A MANO, DISPUTATO DAL 30
MAGGIO AL 1° GIUGNO AL NEXT DI CAPACCIO-PAESTUM DURANTE
IL DMED – SALONE DELLA
DIETA MEDITERRANEA.
Il cuoco partenopeo ha trionfato con “Giovedì Santo”, un raviolo tricolore che rievoca la tradizionale zuppa di cozze del Giovedì Santo napoletano: polpo, gamberi, vongole e lupini racchiusi in una sfoglia colorata, completati da salsa di polpo, bisque di carapaci, caviale di acqua di vongole e polvere di teste di gambero, nel segno della sostenibilità. Oltre al trofeo “Pettorello”, Pastena riceverà una fornitura di farine Molini Pizzuti, un corso di alta formazione “InCibum” e uno shooting negli studi di “GialloZafferano”.
Il podio dei professionisti è completato da Carolina Campitelli di Pagani, che si aggiudica anche i premi Miglior Impasto e Sostenibilità e da Anna Maione di Sorrento. Premi speciali a Francesca Buontempo (Equilibrio Nutrizionale) e ad Alice Bosco (Tradizione Italiana). Tra gli “Amanti” della pasta fresca, spicca la vittoria di Cristina Pavlyuk, ucraina trapiantata a Reggio Emilia, con un tortello ispirato ai calanchi reggiani; seguono Francesca Fabbri e Cristina Colì. Il Campionato, ideato da BTL Prod con Consorzio Edamus, proseguirà in autunno con un tour itinerante per celebrare gli artigiani della pasta. Giuria di chef stellati, giornalisti food e nutrizionisti di fama nota.
LA BIRRA
Nel campionato di calcio 2024/2025, il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto e l’intera città ha vibrato all’unisono in un’esplosione di gioia che ha attraversato quartieri, generazioni e classi sociali. Ma questa vittoria non è solo un evento sportivo: è un atto collettivo di rinascita, un simbolo potente di riscatto per un popolo che troppo spesso è stato narrato solo attraverso stereotipi e cronache riduttive. Napoli, invece, ha risposto con ciò che sa fare meglio: trasformare la passione in arte, la festa in cultura, il calcio in identità. E stavolta lo ha fatto anche con la birra.



ha celebrato lo scudetto con la birra “Afammokk Natavota”, una lager da dal nome che è un grido di gioia in dialetto. L’etichetta, realizzata da Luca Carnevale, mostra un moderno San Gennaro accanto a un guerriero scozzese, che raffigura il calciatore scozzese Scott McTominay, metafora della fusione tra tradizione e modernità, fede e combattività, Napoli e il mondo. È una birra che parla la lingua del popolo, che si beve nei vicoli, nei cortili, nelle feste improvvisate: dove Napoli esprime tutta la sua veracità.
Il birrificio Màgifra, da Vitulazio, ha voluto osare: ha creato una pilsner colorata di , la PartenoPilsner “N4”, un richiamo cromatico diretto alla maglia del Napoli, alla città vista dal mare, al cielo limpido sopra il Vesuvio. Non è solo una birra: è un esperimento sensoriale ed emozionale, pensato per un popolo che vive di simboli. Leggera, fresca, con note di pane e miele, questa birra è già un piccolo fenomeno.

Birrificio delle Cave
– Orgogliosamente napoletana
Anche il Birrificio delle Cave ha deciso di partecipare al brindisi collettivo con una birra dedicata, la “Orgogliosa”. Birra semplice e grande bevuta, mostra parte del suo carattere nell’etichetta — curata e carica di significato — che da sola è bastata per conquistare i collezionisti e gli amanti del calcio. In una città dove ogni dettaglio ha valore simbolico, questa birra diventa un pezzo di storia, una dichiarazione d’amore imbottigliata.
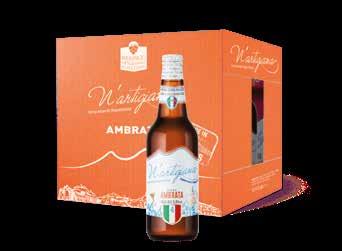


Chiude il quartetto il Birrificio Artigianale Napoletano, che ha lasciato il segno con la presenza di una “Ambrata Scudetto” tra le sue edizioni limitate. Forse la più classica tra le birre celebrative, ma anche quella che richiama un gusto pieno, avvolgente, radicato: proprio come il legame tra Napoli e la sua squadra.
A Napoli il calcio non è intrattenimento. È cultura popolare, religione civile, riscatto esistenziale. È la forza con cui una città spesso marginalizzata trova la voce per raccontarsi, per ribaltare narrazioni stantie e rivendicare bellezza, dignità, talento. Quando il Napoli vince, vince anche chi non ha mai smesso di credere nella possibilità di riscatto. Ogni scudetto è un atto politico, un inno alla città viva che si reinventa, che fa turismo, musica, cinema, impresa — e ora anche birra artigianale.
Negli ultimi anni, Napoli ha vissuto una profonda trasformazione urbana, sociale e culturale: è tornata al centro del turismo internazionale, ha conquistato le classifiche gastronomiche, ha fatto scuola nel cinema e nella moda. La vittoria del Napoli nel 2025 è diventata l’emblema di questa rinascita. E le birre commemorative sono il simbolo liquido di questo momento magico: prodotti curati, identitari, fieramente locali ma capaci di parlare a tutti.
Queste birre non sono nate solo per essere bevute. Sono nate per essere condivise, raccontate, ricordate. Sono il modo con cui una città intera ha voluto fissare nel vetro e nel gusto l’orgoglio di un popolo che ha saputo trasformare il dolore in arte, la fatica in sapore, la fede calcistica in cultura materiale.
Nel brindisi con una “Afammokk”, nel colore acceso della PartenoPilsner, nell’etichetta orgogliosa della birra Delle Cave o nell’ambrata di quartiere, c’è tutta la Napoli che vince, non solo in campo, ma anche nel cuore e nell’immaginario del mondo.
E allora sì: afammokk natavota! Perché Napoli, quando alza un trofeo, brinda col mondo.





















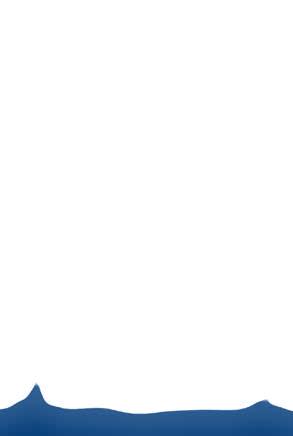
























di Caterina Vianello

Campania e Sicilia sono un’autentica miniera di eccellenze
gastronomiche: ne abbiamo scelte alcune, che in pizzeria possono regalare grandi soddisfazioni e consentono ancora di sperimentare molto
Non servirebbero presentazioni per la regina dei prodotti caseari della Campania, un formaggio che parla da solo e che riassume secoli di storia, tra particolari caratteristiche ambientali del territorio e peculiarità fisiche degli animali. Le prime tracce “gastronomiche” dei derivati della lavorazione del latte di bufala risalgono al XII secolo e sono affidate alla documentazione di ordini religiosi. I monaci del monastero di San Lorenzo in Capua erano soliti offrire un formaggio denominato mozza o “provatura” (quando affumicato) ai pellegrini componenti del Capitolo Metropolitano, che ogni anno si recavano in processione al Convento. Un prima e timida commercializzazione dei derivati del latte risale al XIV secolo, ma per la codifica del nome “mozzarella” si dovrà aspettare il 1570 quando il termine appare per la prima volta nell’opera di Bartolomeo Scappi, cuoco della corte papale. È il secolo XVIII tuttavia a rappresentare un periodo di svolta, con i Borbone che di fatto trasformano la mozzarella in un prodotto di largo consumo attraverso la realizzazione, a margine

Erede del garum, un piatto che affonda le sue radici nella storia romana e che ci è stato descritto da Plinio e Orazio, la colatura di alici di Cetara è un liquido prezioso, ottenuto dalla maturazione delle alici sotto sale. Per ottenerla, si segue un procedimento tramandato dai pescatori locali, di padre in figlio. La colatura rappresenta di fatto un derivato della lavorazione delle alici sotto sale: il pesce, appena pescato in tutto il periodo primaverile, viene privato della testa e delle interiora e poi adagiato in un contenitore, cosparso di sale marino abbondante per 24 ore. Dopo la prima salatura, viene sistemato in una piccola botte, il terzigno, con la tecnica “testa-coda” a strati alternati al sale. Il terzigno viene quindi coperto con un disco in legno, sul quale si collocano dei pesi. Questi, combinati alla maturazione del pesce, determinano l’affioramento progressivo del liquido secreto dalle alici.
di un grosso allevamento di bufale, di un caseificio sperimentale per la trasformazione del latte, nel sito della Reggia di Carditello, la tenuta reale in provincia di Caserta della dinastia spagnola. Incremento della quantità del prodotto e miglioramento selettivo della razza, furono gli elementi che consentirono alla mozzarella di varcare i confini regionali. La lavorazione è quella tipica delle paste filate, che vede alla fine ottenere un impasto lucido ed omogeneo. La forma viene data manualmente, da due operatori, di cui uno stacca (“mozza”) con il pollice e l’indice dei pezzi di pasta filata da una massa di circa 2-3 Kg, sostenuta dall’altro operatore. Dopo un primo passaggio in
vasche di acqua fredda, la mozzarella viene sottoposta a salatura con l’immersione in soluzioni saline a diversa concentrazione. Oltre alla forma tradizionale, compaiono anche trecce, ciliegine, bocconcini e nodini. Il colore è inconfondibile - bianco perlaceo, porcellanato – mentre la superficie deve essere liscia e lucente. Sotto una crosta sottilissima che difende la pasta sottostante, il cuore si schiude dopo il taglio e rivela una struttura a foglie sottili sovrapposte, che tendono a scomparire man mano che ci si avvicina al centro. Elastica e fondente, la mozzarella rilascia al palato un sapore di latte dall’aroma intenso, leggermente acidulo, quindi di panna e di muschio.

Raccolto progressivamente, viene inserito in grandi bottiglie di vetro ed esposto a fonte di luce diretta del sole per circa quattro o cinque mesi, affinché l’acqua evapori e aumenti la concentrazione. Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, si assiste all’ultima fase: il liquido raccolto e conservato viene versato nuovamente nel terzigno dove le alici sono rimaste in maturazione. Colando tra gli strati di pesce, ne raccoglie il meglio. Viene quindi recuperato attraverso un foro praticato appositamente nel con-
tenitore, trasferito in un altro recipiente e filtrato con l’uso di teli di lino.
Ciò che se ne ricava è un liquido di colore ambrato carico, quasi bruno-mogano, dall’odore persistente e intenso, che richiama il salmastro e dal sapore deciso e corposo, con una sapidità che guarda all’umami. Tradizionalmente cibo povero, è oggi considerato un condimento prezioso, che oltre ad arricchire spaghetti, bruschette e verdure, può conferire anche alle pizze a tema marino un guizzo in più.
Deve il suo nome, secondo la tesi più accreditata, al fatto che i casari che sbarcavano all’alba nel porto di Napoli con il loro carico di provoloni provenienti dalle varie località della penisola sorrentina, per proteggersi dal freddo e dall’umidità erano soliti coprirsi con un mantello di tela di sacco, simile al saio indossato dai monaci. Eccellenza casearia Dop, è prodotto nella Penisola Sorrentina e nella zona dei Monti Lattari, esclusivamente con latte crudo di vacche di razza Agerolese, che produce poco latte ma di altissima qualità. La lavorazione è complessa, in particolare la fase della filatura che, in alcuni casi - per attorcigliare la cagliata – richiede l’intervento di due persone. Una volta data la forma – a pera o a melone allungato – i formaggi sono legati a coppie e appesi su appositi supporti e fatti stagionare, prima a temperatura ambiente dai 10 ai 20 giorni, poi fra 8-15°C per un periodo non inferiore ai

6 mesi e che può arrivare a 18. Con il passare dei mesi, la buccia di colore giallognolo tende a scurirsi fino a raggiungere la tipica colorazione di nocciole mature. Le insenature longitudinali che la contraddistinguono si devono ai legacci di rafia usati per il sostegno a coppia. La pasta ha color crema con toni giallognoli ed è elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, di consistenza morbida e con tipiche occhiature. Il sapore, inconfondibile, è dolce e butirroso, con piacevoli e leggere note piccanti. Se la “pasta e patate” è il piatto simbolo dell’utilizzo in cucina del Provolone del Monaco, anche sulla pizza può dare il meglio di sé.


Unico formaggio di pecora a pasta filata italiano, veniva storicamente prodotto dai casari della Valle del Belice nel periodo estivo. Deve il nome, infatti, al dialetto “vasta” cioè guasta, andata a male, poiché l’idea che ne è all’origine era quella di recuperare i pecorini mal riusciti rilavorandoli e facendoli filare ad alta temperatura. Nella fase finale della filatura, quando la pasta raggiunge la giusta consistenza, la massa viene tagliata in porzioni che vengono lavorate manualmente e a cui viene data la forma di una sfera. Le forme vengono poi collocate in un piatto fondo di ceramica, dove in breve tempo assumono la tipica forma ovoidale appiattita, simile ad una pagnotta piatta.
Il sapore richiama quello del latte di pecora e con note lievemente acidule e mai piccanti; il profumo è delicato e al palato prevale una nota di burro, con sottofondo di erbe. Il colore esterno è bianco avorio e la superficie è liscia e compatta; la pasta è bianca, non granulosa, senza occhiature. Va consumata freschissima: dopo circa un’ora dalla formatura è pronta per essere gustata, in genere tagliata in grosse fette e condita con olio, pomodoro e origano, o come ingrediente del timballo di maccheroni ma è perfetta anche sulla pizza tanto che è stata oggetto di occasioni di valorizzazione da parte dei pizzaioli locali.

L’isola di Pantelleria si è affermata come uno dei centri della produzione italiana di capperi di qualità, cui nel 1996 è stato riconosciuto il marchio Igp. La cultivar più diffusa è la Tondina (o Nocellara), dai capperi più sodi e pesanti. La raccolta si effettua da fine maggio a tutto agosto. I capperi vengono stesi ad asciugare su teli di juta, al fresco, per impedire loro di sbocciare. Dopo qualche ora, si separano i capperi (di dimensioni minori e i migliori) dai capperoni, i bottoni più grandi sul punto di sbocciare. Si procede quindi alla salatura che avviene in fusti (cugniettu), utilizzati anche per le acciughe, o in tinedde, ricavate da botti vecchie tagliate a metà. Nei giorni seguenti i capperi vengono travasati da una tinedda all’altra, per evitare che sale e calore possano rovinarli. Dopo circa un mese sono pronti per il consumo, che li vede in protagonisti di piatti a cui apportano un carattere inconfondibile: dai primi ai secondi, interi o tritati, sono ovviamente ingredienti immancabili anche in pizzeria.


Si deve agli Arabi la coltivazione dell’oro verde in Sicilia, in particolare alle pendici dell’Etna, dove esiste una combinazione felice tra la pianta ed il terreno lavico che dà origine a frutti della più pregiata qualità di un bel colore verde smeraldo, ricercati ed usati in pasticceria e gastronomia. I pistacchieti (per i brontesi, i “lochi”) si coltivano prevalentemente su quasi 3.000 ettari di terreno lavico, con limitatissimo strato arabile, con pendenze scoscese ed accidentate e non facilmente accessibili. La pianta ha chioma folta e ampia, radici profonde e corteccia gialla-rossastra che diventa grigia quando la pianta è adulta. I frutti, le drupe, dalla buccia coriacea color perla contengo-
no i semi caratteristici dal pericardio rosso violaceo e mandorla verde smeraldo. La raccolta avviene in genere ogni due anni, a partire dalla prima settimana di settembre. Appena raccolto, il pistacchio deve essere privato della pelle che ricopre il guscio, il malleolo, ed asciugato al sole per almeno tre/quattro giorni, per evitare infezioni di parassiti. Dopo l’asciugatura si procede alla prima commercializzazione e quindi alla sgusciatura, con macchinari moderni che hanno sostituito quella manuale. In ambito gastronomico, il pistacchio si muove con disinvoltura tra pasticceria, cucina e pizzeria: in crema, come ingrediente del pesto, oppure sbriciolato, riesce a conferire carattere e personalità ai piatti a cui è aggiunto.






SI T TA SR L
SI T TA SR L
Via Cascina Rinaldi 37
SITTA SRL
Via Cascina Rinaldi 37
33048 San Giovanni al Natisone – Italia
+39 0432 756883
info@sittasrl.com
info@sittasrl.com
Via Cascina Rinaldi 37 33048 San Giovanni al Natisone Italia +39 0432 756883 info@sittasrl.com
Via Cascina Rinaldi 37 33048 San Giovanni al Natisone – Italia +39 0432 756883 info@sittasrl.com
33048 San Giovanni al Natisone – Italia +39 0432 756883



II bricchetti SITTA sono una soluzione pratica, ecologica e vantaggiosa per una cottura a regola d’arte, con un’igiene e qualità garantita da rigorose e costanti analisi chimiche e batteriologiche. Il loro alto potere calorifico permette di raggiungere velocemente la temperatura ideale e di mantenerla a lungo. L’umidità inferiore all’ 8%, permette di raggiungere la temperatura perfetta in minor tempo, il suo essere ECOLOGICO ci permette ridurre le emissioni di monossido di carbonio nell’atmosfera e la fuliggine del camino. La soluzione ottagonale assicura maneggevolezza e stabilità evitando il rotolamento in platea, a parità di peso ed ingombro supera di gran lunga in resa la miglior legna tradizionale, rendendolo cosi molto conveniente. Il suo alto potere radiante è ideale per la cottura nel forno
I bricchetti SITTA sono una soluzione pratica, ecologica e vantaggiosa per una cottura a regola d’arte, con un’igiene e qualità garantita da rigorose e costanti analisi chimiche e batteriologiche. Il loro alto potere calorifico permette di raggiungere velocemente la temperatura ideale e di mantenerla a lungo. L’umidità inferiore all’ 8%, permette di raggiungere la temperatura perfetta in minor tempo, il suo essere ECOLOGICO ci permette ridurre le emissioni di monossido di carbonio nell’atmosfera e la fuliggine del camino. La soluzione ottagonale assicura maneggevolezza e stabilità evitando il rotolamento in platea, a parità di peso ed ingombro supera di gran lunga in resa la miglior legna tradizionale, rendendolo cosi molto conveniente. Il suo alto potere radiante è ideale per la cottura nel forno
I bricchetti SITTA sono una soluzione pratica, ecologica e vantaggiosa per una cottura a regola d’arte, con un’igiene e qualità garantita da rigorose e costanti analisi chimiche e batteriologiche. Il loro alto potere calorifico permette di raggiungere velocemente la temperatura ideale e di mantenerla a lungo. L’umidità inferiore all’ 8%, permette di raggiungere la temperatura perfetta in minor tempo, il suo essere ECOLOGICO ci permette ridurre le emissioni di monossido di carbonio nell’atmosfera e la fuliggine del camino. La soluzione ottagonale assicura maneggevolezza e stabilità evitando il rotolamento in platea, a parità di peso ed ingombro supera di gran lunga in resa la miglior legna tradizionale, rendendolo cosi molto conveniente. Il suo alto potere radiante è ideale per la cottura nel forno
bricchetti SITTA sono una soluzione pratica, ecologica e vantaggiosa per una cottura a regola d’arte, con un’igiene e qualità garantita da rigorose e costanti analisi chimiche e batteriologiche. Il loro alto potere calorifico permette di raggiungere velocemente la temperatu-ra ideale e di mantenerla a lungo. L’umi-dità inferiore all’ 8%, permette di raggiungere la temperatura perfetta in minor tempo, il suo essere ECOLOGICO ci permette ridurre le emissioni di monossido di carbonio nell’atmosfera e la fuliggine del camino. La soluzione ottagonale assicura maneggevolezza e stabilità evitando il rotolamento in platea, a parità di peso ed ingombro supera di gran lunga in resa la miglior legna tradizionale, rendendolo cosi molto conveniente. Il suo alto potere radiante è ideale per la cottura nel forno refrattario perché permette di cuocere
refrattario perché permette di cuocere non solo per conduzione e induzione, ma anche per irraggiamento. Rende molto di più della legna tradizionale perché è pura essenza di legna vergine di faggio permettendo cosi una temperatura costante. Testato e certificato da analisi chimiche e batteriologica per la cottura di alimenti. Lo stoccaggio poi diventa semplificato in quanto in ogni confezione/scatola dal peso di 18 kg contiene 8 bricchetti il faggetto permettendo facilità di stoccaggio, ordine e pulizia sotto il forno.
refrattario perché permette di cuocere non solo per conduzione e induzione, ma anche per irraggiamento. Rende molto di più della legna tradizionale perché è pura essenza di legna vergine di faggio permettendo cosi una temperatura costante. Testato e certificato da analisi chimiche e batteriologica per la cottura di alimenti. Lo stoccaggio poi diventa semplificato in quanto in ogni confezione/scatola dal peso di 18 kg contiene 8 bricchetti il faggetto permettendo facilità di stoccaggio, ordine e pulizia sotto il forno.
non solo per conduzione e induzione, ma anche per irraggiamento. Rende molto di più della legna tradizionale perché è pura essenza di legna vergine di faggio permettendo cosi una temperatura costante. Testato e certificato da analisi chimiche e batteriologica per la cottura di alimenti. Lo stoccaggio poi diventa semplificato in quanto in ogni confezio-ne/scatola dal peso di 18 kg contiene 8 bricchetti il faggetto permettendo facilità di stoccaggio, ordine e pulizia sotto il forno.
Requisiti dei bricchetti di Classe di Qualità Biomassplus A1 (Norma ISO 17225-3)
refrattario perché permette di cuocere non solo per conduzione e induzione, ma anche per irraggiamento. Rende molto di più della legna tradizionale perché è pura essenza di legna vergine di faggio permettendo cosi una temperatura costante. Testato e certificato da analisi chimiche e batteriologica per la cottura di alimenti. Lo stoccaggio poi diventa semplificato in quanto in ogni confezione/scatola dal peso di 18 kg contiene 8 bricchetti il faggetto permettendo facilità di stoccaggio, ordine e pulizia sotto il forno.
Requisiti dei bricchetti di Classe di Qualità Biomassplus A1 (Norma ISO 17225-3)
Scopri di più: ilfaggetto.com
Requisiti dei bricchetti di Classe di Qualità Biomassplus A1 (Norma ISO 17225-3)
Requisiti dei bricchetti di Classe di Qualità Biomassplus A1 (Norma ISO 17225-3)







di Caterina Vianello
Prodotto simbolo della tradizione gastronomica italiana, versatile in cucina – che lo trasforma polpa, passata, conserva, concentrato, pelato – il pomodoro conta innumerevoli varietà, superando il numero di 5000, differenti per forma (tonda, allungata, a pera, ciliegino, costoluto, ecc.), grandezza e colore (dal rosso al giallo, dal verde e al nero).

Guardando al contesto italiano, molte sono quelle che vantano riconoscimenti di eccellenza: un bel traguardo per il frutto originario dell’America Centrale, il cui arrivo in Europa si deve agli Spagnoli e che inizialmente veniva guardato con diffidenza, credendo che fosse una
Fu grazie agli stretti rapporti esistenti tra i Borbone e le famiglie regnanti dell’epoca e ai domini spagnoli su territorio italiano, che dalla Spagna il pomodoro fece il suo ingresso in Italia. Il primo libro di ricette che ne prevede l’impiego fu scritto a Napoli nel 1692 a firma di Antonio Latini, “Lo scalco alla moderna”. Per una sua diffusione più ampia, bisognerà aspettare l’Ottocento, complici anche i progressi in fatto di conservazione.
Ecco una carrellata delle varietà più note.
Re indiscusso del sugo, il San Marzano dell’Agro SarneseNocerino Dop è coltivato tra le province di Salerno, Napoli e Avellino. Simbolo dell’industria conserviera, è ingrediente imprescindibile per ragù, passata per pizza e altri piatti napoletani. Ha forma sinuosa, non perfettamente regolare e apice pronunciato, il cosiddetto “pizzo”, che lo rende riconoscibile e lo distingue dall’apice “tondo”, che invece possiede il classico tipo Roma. Soltanto il prodotto in scatola può fregiarsi del marchio Dop, che

esclude quindi il prodotto appena raccolto, fresco. La trasformazione deve avvenire in tempi brevi e il periodo ideale di raccolta è dalla metà di luglio fino a settembre inoltrato, per un totale di 3, massimo 4 raccolti. Chi, tra gli altri, l’ha reso protagonista in pizzeria è Pier Daniele Seu, che propone una Marinara Plus con stracotto di San Marzano, confettura di pomodoro, salsa verde, olio all’aglio, chips di aglio nero e alici.
È una grande famiglia, che conta oltre 30 ecotipi della tipologia San Marzano ed è Presidio Slow Food. Si caratterizzano per forma allungata, colore

rosso vermiglio con diverse sfumature, buccia sottile e un sapore dolce e aromatico. Si coltivano nelle pianure dell’agro nocerino sarnese, nell’agro acerrano nolano e nei comuni di Striano, Poggiomarino, Boscoreale, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant’Antonio Abate, Castellamare di Stabia, Gragnano, Casola, Lettere e Pimonte. Ciro Salvo li esalta nella pizza Antica Margherita, insieme a mozzarella di bufala e Conciato romano.
È il tipico pomodoro rosso italiano, da orto, che può essere coltivato sia in serra che in campi aperti e rappresenta forse il tipo di frutto più versa tile in cucina, utilizzato sulla bruschetta, tagliuzzato a crudo su primi piatti, pizze e focacce e ottimo anche in insalata.
Ha buccia non troppo spessa, forma regolare e il periodo di maturazione va solitamente da febbraio a giugno.

Ecco l’altra grande Dop campana, dai grappoloni inconfondibili che decorano i muri del napoletano. Deve il nome alla tecnica di conservazione, quella del piennolo, ovvero del pendolo. Per realizzarlo i pomodorini vengono raccolti in estate e legati insieme con filo di canapa a cerchio, formando così un unico grande grappolo che attraverso una maturazione lenta, riesce a mantenersi perfettamente fresco fino alla primavera seguente. Ha buccia coriacea, che aiuta la conservazione, e polpa soda e compatta, dal sapore distintamente dolce con retrogusto acidulo. Diventa dorato nella variante Pomodorino giallo del Cilento. Rosso o giallo è molto versatile in cucina: se ne fanno conserve, intingoli, bruschette o insalate. Diego Vitagliano lo propone nella “Conciaciccia”:

Dalla forma piccola e ovale, ha un sapore dolce e intenso, polpa soda e non troppo acquosa, buccia sottile e pochi semi all’interno. È frutto di un incrocio di provenienza asiatica, forma grappoli a lisca di pesce e si conserva a lungo, e proprio per queste caratteristiche si è inserito ben presto nel mercato italiano riscontrando notevole gradimento, soprattutto per la versatilità in cucina. Da Concettina ai tre Santi eccolo in una versione “accesa”, insieme a peperoncino verde, provola affumicata, basilico e cacioricotta del Cilento.

Piccolo e sferico, si coltiva in quasi tutte le regioni, ma ha trovato il suo ambiente ideale nella zona sud-est della Sicilia, dove le caratteristiche climatiche ed ambientali sono più idonee. Sviluppa i suoi frutti a grappoli: la polpa è succosa ed il sapore dolcissimo. Indubbiamente la varietà più nota è il pomodoro di Pachino Igp, varietà che è stata introdotto sull’isola come cultivar selezionata da parte di una multinazionale israeliana alla fine degli anni Ottanta. Francesco Martucci, nella sua I Masanielli, ne ha fatto uno degli ingredienti della sua Assoluto di pomodoro, con appunto crema di pomodoro ciliegino arrosto, pomodoro del Piennolo a pacchetelle saltato, pomodoro giallo da serbo saltato, mousse di pomodoro san Marzano Dop, pomodorino del Piennolo secco, cialda di datterino rosso, confettura di pomodoro del Piennolo.
Riconoscibile grazie alle pieghe che ne rendono la superficie ondulata e spicchi quasi regolari, ha colore intenso e polpa saporitissima e molto consistente. Può essere usato sia come componente di freschissime insalate sia come per farne sughi e salse. Il più diffuso è il fiorentino, ma noti sono anche il pomodoro costoluto di Rotonda, esemplare lucano dalla polpa dolce e carnosa, il pomodoro sorrentino, di colore rosa e sapore delicato e il grinzoso sanminiatese dalla provincia di Pisa, perfetto per condire la tipica panzanella.

La zona di coltivazione di questa varietà “appuntita” è proprio quella intorno al Vesuvio, molto fertile e con bassissima irrigazione, ma si coltiva anche basso Lazio, alta Calabria e Sicilia. Ha polpa soda e carnosa e rende benissimo in passate, salse e sughi. Due i nomi da segnare: Siccagno della Valle del Bilìci, zona dal microclima arido e famosa per la produzione di astrattu, il concentrato di pomodoro, e il pizzutello delle Valli Ericine, prodotto tipico della provincia di Trapani. Davide Civitiello l’ha esaltato in una versione di pizza ai tre pomodori: Antichi di Napoli, pizzutello e datterino giallo.
Grosso e irregolare, di media si aggira intorno ai 300 grammi, ma può raggiungere tranquillamente gli 800: ha polpa carnosissima e molto saporita, mentre la buccia è liscia e sottile.
Tra i più famosi ci sono il bovaiolo toscano, il pomodoro di Albenga coltivato in provincia di Savona e il pomodoro a pera d’Abruzzo. Grazie al gusto dolce e alla consistenza da mordere come un frutto appena colto dall’albero, è ottimo crudo in insalata, sulle bruschette e come condimento.


Se quelli appena ricordati sono i tipi più noti e consumati, ci sono tuttavia delle rarità poco note che merita conoscere. È il caso del Regina di Torre Canne, dal Salento, che è coltivato davanti al mare su terreni salmastri e che deve il suo nome alla “coroncina” formata dal peduncolo È tondo, con buccia spessa e resistente, ottimo per condire focacce e insaporire sughi. Coltivato sulle pendici del Vesuvio è il Verneteca sannita, saporitissimo ciliegino dalla forma schiacciata, con polpa rosa e buccia di un giallo aureo. Ecco poi il Canestrino di Lucca, un costoluto dalla forma a canestro, dal colore rosso con una punta di verde anche a piena maturazione e gusto dolcissimo, e il Giallorosso di Crispiano, pomodoro di forma tondeggiante della provincia di Taranto dal colore giallo aranciato, con buccia spessa, sapore erbaceo e a lungo conservabile. Ecco poi il Fiaschetto di Torre Guaceto, dalle dimensioni ridotte, forma ovale e un sapore dolce. È un’eccellenza brindisina e presidio Slow Food. Tondo, liscio e striato di verde è il Camone di Sardegna, riconoscibilissimo per la polpa soda e croccante e il gusto bello pieno che bilancia perfettamente dolcezza, acidità e sapidità. Infine, menzione per una pizza che è nata con l’obiettivo di esaltare il pomodoro riccio di Caiazzo, una cultivar risalente alla metà dell'Ottocento che assomiglia al cuore di bue sorrentino ma è grande come un ciliegino: è ovviamente la Margherita sbagliata di Franco Pepe. Semplicissima, con olio e mozzarella di bufala campana Dop in cottura, e in uscita passata di pomodoro riccio cruda e riduzione di basilico.



Forno con alimentazione elettrica, dalle dimensioni contenute, concepito per la cottura di 1 o 2 pizze da 33 cm














p p pinse.
p p pinse.









Forni a tunnel con tappeto di cottura in refrattario. Montato su ruote e configurabile per ogni esigenza. Disponibile anche con tecnologia Industria 4 0
Forni a tunnel con di cottura in refra Montato su ruote configurabile per esigenza. Disponi anche con tecnolo Industria 4.0.









a cura della Dott.ssa
Marisa Cammarano, biologa nutrizionista
Quanto bene fa il pomodoro e come cucinarlo al meglio I pomodori vengono solitamente utilizzati nella preparazione di piatti saporiti, nonostante botanicamente siano considerati come frutta, ma in una prospettiva culinaria sono definiti come verdura. Il pomodoro, dunque, è un alimento che difficilmente manca sulla tavola degli italiani. Si può mangiare crudo, si può utilizzare in tantissime ricette oppure si può gustare sotto forma di salsa. Il pomodoro è un alimento ricco di nutrienti, tra cui il licopene, un potente antiossidante che può contribuire alla salute del cuore ed alla prevenzione di alcune forme di cancro.
La cottura aumenta la biodisponibilità del licopene, quindi è consigliabile consumare il pomodoro sia crudo che cotto. I pomodori fanno parte integrante della nostra alimentazione. Durante la bella stagione siamo soliti consumarli principalmente crudi mentre nel resto dell’anno, se vogliamo seguire la stagionalità degli ortaggi, possiamo optare, invece, per una passata di pomodoro, polpa o pelati, da consumare cotti. Le proprietà fitoterapiche dei pomodori sono molto note.

Le principali sono:
• proprietà antiossidanti, grazie alla presenza di vitamine tra cui E, C, D e B.
• proprietà remineralizzanti contro i radicali liberi grazie all’associazione dei sali minerali del pomodoro con citrati, tartrati e nitrati.
• proprietà digestive perché i pomodori diminuiscono il pH dello stomaco, è quindi, sconsigliato a chi soffre di gastrite o di bruciore di stomaco.
• alti contenuti di acidi organici come malico, citrico, succinico e molteplici sali minerali come fosforo, calcio, selenio, zinco e ferro.
• spiccata capacità di stimolare la diuresi, importante per eliminare le scorie in eccesso.
• stimolano la motilità intestinale, combattendo la stipsi e l’intestino pigro grazie alle fibre, concentrate, soprattutto, nella buccia.


Il pomodoro è composto da: acqua 94% carboidrati 3%
proteine 1,2%
fibre all'1%
grassi 0,2%
Inoltre, il pomodoro rappresenta un alimento base della dieta mediterranea in quanto ipocalorico: 100 grammi di pomodoro apportano solo 17 Kcal. Questi preziosi alimenti contengono un’alta dose di vitamina C e vitamina K, fibre e sostanze dal potere antiossidante come licopene, beta-carotene e vitamina E. Ma a livello di benefici per la salute è meglio mangiare pomodoro crudo o cotto? In realtà, non c’è un modo migliore di consumare i pomodori, vanno bene entrambi e la scelta può dipendere, oltre che da un fattore di gusto o stagionalità, anche da che tipo di nutriente vogliamo assorbire maggiormente.
Nel caso del pomodoro crudo assumeremo più vitamine termolabili, come ad esempio la vitamina C, che con la cottura, almeno in parte, si perderebbero. Inoltre, i pomodori maturi e di stagione sono migliori anche dal punto di vista dei nutrienti in quanto, sempre ad esempio la vitamina C, è maggiore se il pomodoro è arrivato a corretta maturazione grazie all’esposizione al sole.



Nel caso del pomodoro cotto, invece, sfrutteremo di più i benefici del licopene, un potente antiossidante che alcuni studi hanno scoperto essere maggiormente biodisponibile per il nostro organismo, nel senso che si riesce ad assorbire meglio dopo la cottura.
Il sugo di pomodoro è, dunque, particolarmente benefico per chi vuole fare il pieno di licopene. Il licopene nel pomodoro aiuta a ridurre il colesterolo LDL (il "cattivo") e la pressione sanguigna, contribuendo a prevenire malattie cardiovascolari. Il licopene è un antiossidante che può aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, riducendo il rischio di sviluppare alcune forme di cancro, tra cui il cancro alla prostata, ai polmoni e allo stomaco. Il licopene ed altri carotenoidi presenti nel pomodoro sono importanti per la salute degli occhi.


Uno studio di qualche anno fa aveva scoperto che un sugo semplice, realizzato con un leggero soffritto a base di olio extravergine di oliva, aglio o cipolla, contiene carotenoidi, vitamina C e circa 40 sostanze antiossidanti, utili al benessere del nostro cuore ed a prevenire gravi malattie come il tumore. In questo caso, ad essere fondamentale, non è solo il pomodoro cotto, piuttosto la sinergia tra i vari ingredienti utilizzati che, sempre secondo quanto scoperto dallo studio, permetterebbe di aumentare la quantità di polifenoli e carotenoidi presenti nel nostro piatto per effetto, appunto, della sinergia e scambio dei nutrienti facendo, così assumere alla la pietanza un effetto nutraceutico.


Pasta e pizza sono sempre più amate – e acquistate – nel mondo. Secondo l’Osservatorio di Host 2025, a fine decennio il mercato globale della pizza supererà i 70 miliardi di dollari (fonte: Technavio), grazie ai mercati emergenti e al delivery. A sua volta, il mercato mondiale della pasta sfiorerà i 93 miliardi di dollari (fonte: IMARC Group) puntando sulle tendenze salutistiche e naturali.
Evoluzioni pronte a diventare anche opportunità di business. Con questo obiettivo Host 2025, la manifestazione leader mondiale nell’ospitalità, il fuoricasa e il food retail, rinnova profondamente MIPPP – Milano Pane Pizza Pasta, lo storico salone dedicato all’Arte Bianca.
Il nuovo format si avvarrà della partnership con il Consorzio SIPAN, che porterà le aziende italiane leader nei sistemi e le tecnologie consolidando un già ricco parterre di top player italiani ed esteri affiancati da realtà di nicchia e d’eccellenza. Il rinnovato MIPPP intercetterà così nuovi target di visitatori italiani ed esteri nel food retail, la GDO e il fuoricasa, valorizzando aree geografiche con una forte tradizione.
Un mix che rafforzerà l’attenzione alle tecnologie innovative e le soluzioni sostenibili, integrate da dimostrazioni live, talk e show-cooking. Da non perdere, il Panettone World Championship 2025 e gli show-cooking di A.P.Pa.Fre.
ORGANIZZATA DA FIERA MILANO, HOST 2025 SI TERRÀ DAL 17 AL 21 OTTOBRE A FIERA MILANO - RHO.
Per informazioni aggiornate: host.fieramilano.it; @HostMilano.
OTTOBRE 2025 fieramilano 17-21
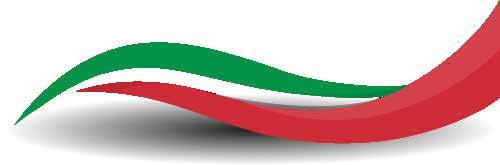


SPITFIRE, il bruciatore a gas perfetto per esaltare il sapore della tua pizza mantenendo inalterato il gusto, l’aspetto e la fragranza di sempre. Ideale per tutti i tipi di pizza.
FINO AL 70% di risparmio sui costi di gestione del tuo forno.




Per segnalazioni, potete scrivere all’indirizzo redazione@pizzaepastaitaliana.it
“Un'esperienza gastronomica di alto livello in un ristorante che conquista il cuore e il palato. Conoscevo questo ristorante da tempo, grazie ai racconti entusiasti di amici, ma solo oggi ho avuto il piacere di provarlo di persona. Da vegano, sono rimasto colpito dalla cura con cui è stato pensato il menù vegetale: il tofu in crosta è stato una rivelazione per equilibrio e sapore, e il tiramisù vegano e gluten-free, leggerissimo e goloso, ha conquistato tutti. […] Un'esperienza da ripetere sicuramente, magari provando anche la pizza, disponibile anche in versione gluten-free […]! ”.

Recensione lasciata su Tripadvisor per Verdechiaro a Palermo – di Nello Occhipinti – nel mese di aprile 2025
a cura di N.C.
“L’inclusività a tavola non è una concessione, ma una scelta di valore. Nel mondo della ristorazione contemporanea, includere non è solo una responsabilità etica ma un’opportunità creativa e culturale. Alla base della nostra filosofia, c’è la convinzione che tutti abbiano diritto a vivere un’esperienza gastronomica appagante, indipendentemente dalle loro scelte alimentari o necessità.”
È con queste parole che Nello Occhipinti, chef e titolare di "Verdechiaro", commenta la recensione del mese, che apre un argomento meritevole di attenzione. Ma cosa significa davvero inclusività in cucina? Quanto è difficile elaborare un menu “diverso” mantenendo la qualità intatta? Quali sono le difficoltà? Viceversa, cosa prova chi si sente “diverso”? Proviamo a metterci per un attimo nei panni di chi, per scelta o per necessità, non può mangiare tutto. Di chi vive con intolleranze, allergie, patologie alimentari. O di chi ha fatto una scelta etica (come il regime veg) e si trova a sfogliare un menù dove l’unica opzione è un’insalata scarna o un contorno arrangiato. Come ci si sente? A volte esclusi. Altre volte invisibili. E troppo spesso si finisce per rinunciare a una serata in compagnia, pur di non dover spiegare, chiedere, giustificare o, semplicemente, mangiare poco o male. Dunque, “inclusività” significa, prima di tutto, considerare le persone. Tutte. Un tema, questo, che tocca la libertà di vivere momenti di convivialità senza doversi sentire diversi, fuori posto, “complicati”. È qui che entrano in gioco realtà come “Verdechiaro”, che fanno la differenza.
Il punto è proprio questo: proporre alternative adatte a tutti non è un favore che si fa a qualcuno. È una forma di rispetto. È riconoscere il diritto di ogni persona a vivere un’esperienza gastronomica completa, piena, bella. Senza compromessi. Eppure, ancora oggi, non è scontato. Fermo restando che non sia semplice, per un ristoratore, elaborare un menù completo a favore di un diverso tipo di cucina, considerando anche che le richieste ormai sono innumerevoli.
«Coniugare inclusività e qualità non è facile ma è possibile se si parte da un presupposto fondamentale: non esistono clienti di “serie B”. L’inclusività non deve essere “tollerata” come un’eccezione ma accolta come un valore aggiunto. Questo significa investire tempo nella formazione, nella sperimentazione, nella selezione delle materie prime, nella cura di ogni dettaglio, proprio come si farebbe per qualsiasi altro piatto», racconta lo chef Nello. Serve tempo, serve dedizione.

Serve anche cambiare mentalità. Perché il vero ostacolo non è solo tecnico, è culturale. È l’idea – ancora radicata in tanti, troppi – che chi mangia “diverso” debba accontentarsi. Che l’alternativa sia per forza una versione sbiadita dell’originale. Ma quali sono le difficoltà che un ristoratore può incontrare? «Mancano spesso prodotti adeguati, le alternative vegetali o senza glutine richiedono lavorazioni differenti e i margini sono più stretti. Noi crediamo che proprio lì si giochi la vera sfida. Dare dignità gastronomica a ogni piatto, a prescindere dalle restrizioni».
L’inclusività, a dispetto delle difficoltà, può diventare terreno fertile per la creatività. Una sfida e un’occasione per far sentire ogni cliente al centro. Capita però che molti si concentrino più sul “dover” proporre che sul “voler” proporre. E la creatività diventa relativa. Ma perché? «Spesso per abitudine, o per mancanza di conoscenza. In altri casi, perché si pensa che “tanto chi mangia vegano o ha intolleranze si deve accontentare”. È una visione miope e, purtroppo, ancora diffusa. Ma le cose stanno cambiando, anche grazie a una clientela sempre più attenta e consapevole», dice lo chef e continua: «In cucina nessuno deve sentirsi escluso. Sappiamo che mangiare diversamente non significa voler rinunciare al piacere, al gusto, alla tradizione ma volerli vivere in modo diverso».
Forse è da qui che può (e dovrebbe) nascere una nuova idea di ristorazione più consapevole, più sensibile, più coraggiosa. Più aperta. Un’idea dove la bellezza del cibo non sta solo nel piatto ma in tutto ciò che quel piatto rappresenta. L’inclusività, in cucina, è una forma di rispetto. È accoglienza e calore. E quando la si pratica davvero, si sente. Anzi, si gusta!
UN LIBRO AL MESE

Da quando l’Unesco ha riconosciuto come Patrimonio Immateriale dell’Umanità
l’Arte del Pizzaiuolo napoletano, è stato raggiunto un altro traguardo significativo nella valorizzazione non solo di un prodotto identitario ma della figura artigianale che lo lavora con sapienza che, come sottolinea Paolo Masi, curatore del volume “L’arte del pizzaiuolo napoletano tra tradizione e innovazione”, è la «tecnologia con cui viene prodotta la pizza napoletana».


Questo libro nasce con l’intento di dare delle risposte ai tanti quesiti che gli estimatori della pizza si pongono di fronte alle novità che sono state introdotte su temi come farine, lievitazioni e maturazioni, condimenti, forni, consumi, impatto ambientale e sostenibilità.
Si torna, dunque, a parlare di pizza napoletana ma con un approccio rigorosamente scientifico e proiettato verso il futuro. Il prof. Paolo Masi, emerito in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università “Federico II” di Napoli, ha coordinato e raccolto i risultati di una ricerca multidisciplinare che ha visto la collaborazione di cinque università italiane e di un team di 20 tra docenti e ricercatori, un lavoro durato quattro anni, che fa luce con dati concreti e analisi approfondite.
a cura di G. F.
Il libro offre un contributo essenziale per andare oltre il folklore e le credenze tramandate, con l’obiettivo di fornire risposte chiare e rigorose sugli aspetti tecnici, sensoriali e salutistici della pizza, colmando un vuoto nella letteratura accademica dedicata ai processi produttivi dell’arte bianca. Oltre a fornire strumenti concreti alla nuova generazione di pizzaioli, sempre più chiamata a unire tradizione e competenza, l’opera valorizza l’artigianalità non solo come abilità manuale ma come forma di pensiero, cultura e ora anche scienza.
Lo studio coordinato dal prof. Masi ha analizzato in dettaglio ogni fase della produzione — dalla scelta delle materie prime alle modalità di preparazione e cottura — con particolare attenzione all’impatto sulla qualità finale del prodotto e al dispendio energetico, tenendo in considerazione molteplici aspetti della pizza napoletana: dalla tecnica alla nutrizione, fino all’innovazione.
Tra i contributi, c’è quello di Mauro Moresi, docente di Tecnologie Alimentari all’Università della Tuscia, che ha approfondito le differenze tra i tre principali sistemi di cottura — forno a legna, a gas ed elettrico — valutandone efficienza energetica e impatto ambientale. Un tema cruciale, soprattutto oggi, in un contesto che include non solo il consumo in loco ma anche il crescente mercato dell’asporto; quello di Marisa Di Matteo sulla shelf life degli alimenti e dell’innovazione dei processi dell’industria agroalimentare o di Alessio Cimini su sostenibilità ambientale dei processi alimentari per citarne alcuni.
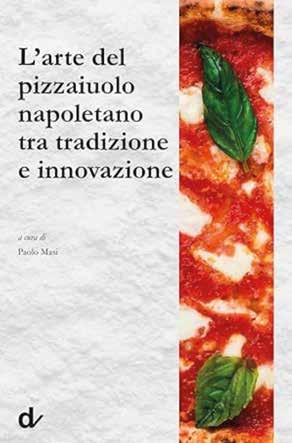



Determinante nella ricerca anche il contributo del maestro pizzaiolo Enzo Coccia, che ha messo a disposizione dati concreti e conoscenze operative per rendere lo studio applicabile alla realtà delle pizzerie.
Editore: Doppiavoce
Autore: Paolo Masi
(a cura di)
Pagine: 160
Anno edizione: 2024
Prezzo di copertina: 25 euro