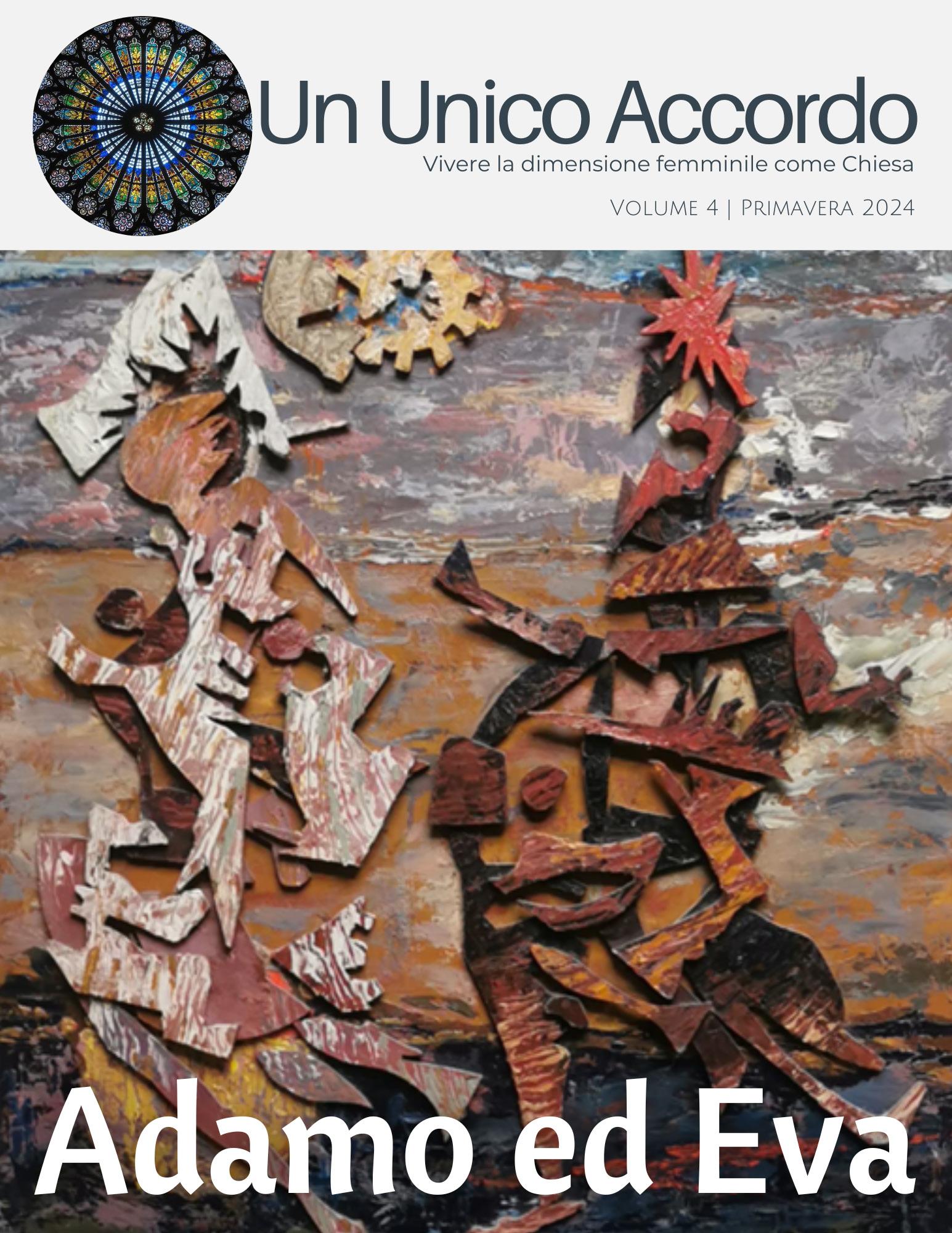
Volume 4, numero 2

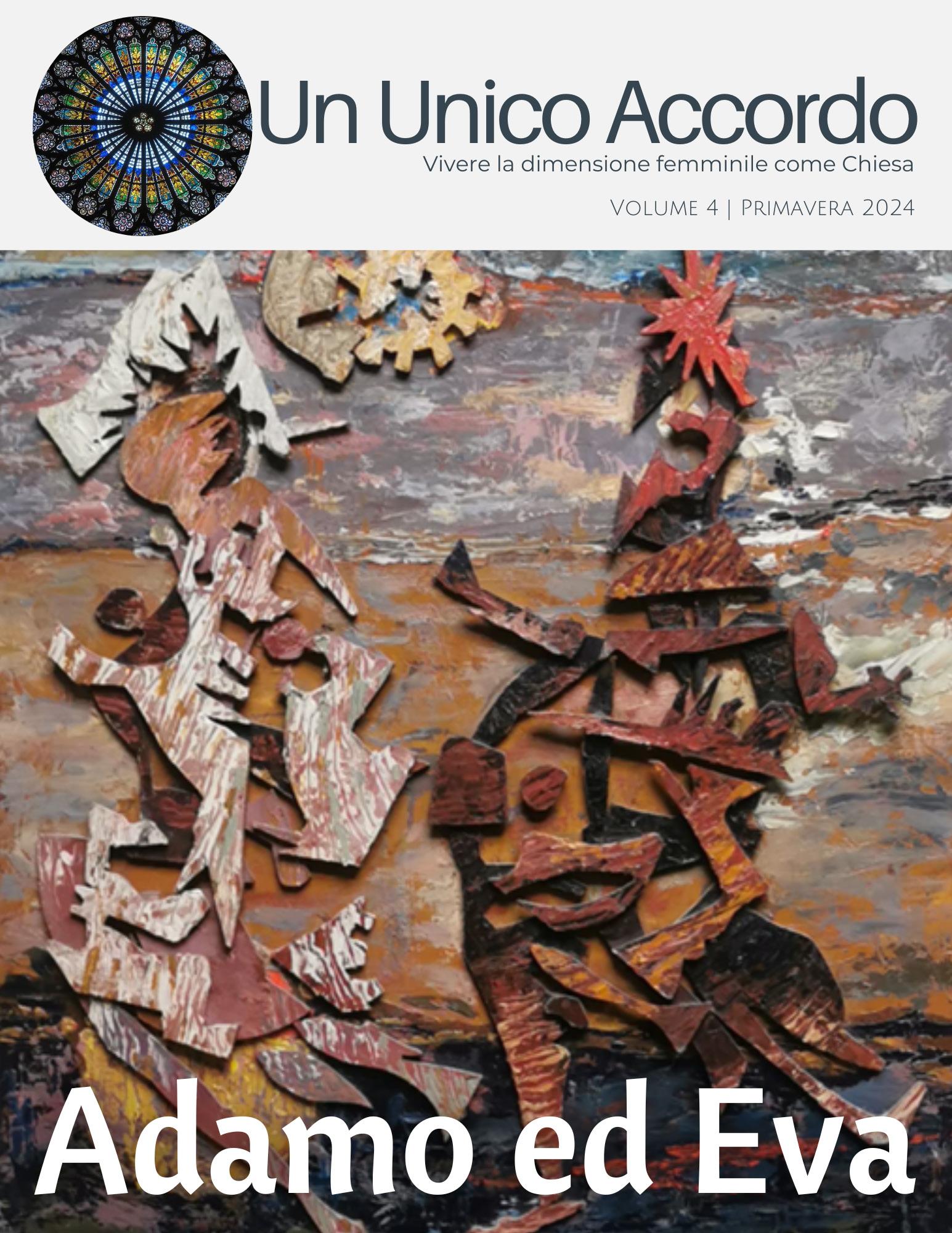
Volume 4, numero 2
EDITORIALE
Lucinda M. Vardey
RISCOPRIRE ADAMO ED EVA
Anne-Marie Pelletier
LA SIMPLICITÀ DI DIO E LA RICERCA DI DIO PER NOI
Yamai Bature O.C.D.
LA FERITA ORIGINALE
John Dalla Costa
RITORNO AL GIARDINO
Lucinda M. Vardey
ADAMO REDENTO
Scott Lewis S.I.
Joanne Mosley
È indubbio che la storia di Adamo ed Eva sia stata fonte di molte interpretazioni errate. Anne-Marie Pelletier spiega come dovrebbe essere letto il racconto scritturale e perché gli stereotipi riguardo a questo abbiano rovinato il modo in cui ci relazioniamo gli uni agli altri e la visione che abbiamo delle differenze tra i sessi.

In questo numero esploriamo le basi della comprensione scritturale e introduciamo alcune delle interpretazioni che sono state trasmesse nel corso dei secoli. Tra queste, il ruolo di Eva, intesa come dissidente piuttosto che come compagna di vita. A causa delle sfumature che emergono—o sono limitate—nei testi tradotti, percepiamo solo una parte della questione, e gli articoli di questo numero affrontano proprio tali argomenti. Tuttavia, tra le varie interpretazioni, a prevalere è quella secondo cui Eva abbia subito il disprezzo del tradimento, e ne sia divenuta l’archetipo all’interno della coscienza umana. Un archetipo vive quindi con la stessa forza del mito in cui è di solito inserito. E il mondo del mito non è un mondo di finzione, ma è portatore di quell’esperienza comune, la cui narrazione si rivolge ampiamente alla maggior parte delle persone, indipendentemente dal loro credo o dalla loro cultura.
L’archetipo di Adamo ed Eva costituisce la struttura portante su cui è stato costruito molto. Come ha spiegato lo psicoanalista svizzero Carl G. Jung, gli archetipi sono attivi nell’inconscio collettivo. Ovviamente le loro distorsioni nel tempo si trasformano in una struttura di credenze, un atteggiamento che diventa una posizione e una logica. Questo è più che mai evidente nell’assunto comunemente diffuso secondo cui l’uomo sia stato creato per primo e che quindi sia naturalmente superiore alla donna, il cosiddetto “pensiero successivo” di Dio. Questo presupposto ha portato a credere che la creazione della donna, esemplificata dalla personalità di Eva che dà retta al serpente, metta seriamente a rischio la posizione e il rapporto dell’uomo con Dio.
Come abbiamo affermato più volte nei numeri passati di questa rivista, non esiste alcuna prova teologica solida che giustifichi qualsiasi forma di disuguaglianza tra uomini e donne. Entrambi sono creati uguali a immagine e somiglianza di Dio. In questo numero mostriamo come questo rapporto di uguaglianza si sviluppi all’interno della relazione stessa con Dio.
Nella storia di Adamo ed Eva, Eva è chiaramente quella che ha sofferto di più l’incomprensione. La Chiesa la riscatta riferendosi a Maria come “la nuova Eva,” la madre di tutti. Ma anche con questo sviluppo, non è certo esagerato dire che ogni donna credente, che ne sia consapevole o meno, viva una tensione nella sua anima. La tensione è causata da un lato dal forte smarrimento dovuto all’appartenenza a un ambiente privo di valori
www.magdalacolloquy.org
femminili naturali, e dall’altro dallo stigma ereditato di Eva come archetipo negativo. Tale fardello è reso più pesante dal fatto che l’archetipo negativo di Eva ha alimentato la falsa opinione secondo cui la maggior parte delle donne sia inattendibile, ribelle e inaffidabile e debba essere tenuta a distanza per non minacciare il comfort, lo status, il benessere e il futuro dell’uomo. D’altra parte, esiste un abisso tra l’archetipo negativo di Eva e quello positivo di Maria, ritenuta simbolo di purezza e perfezione femminile. Raggiungere la santità di Maria e il suo rapporto con Dio non è immaginabile, né tantomeno praticabile dalla maggior parte delle donne. Questa tensione tra gli archetipi femminili negativi e positivi che si sono affermati nell’inconscio collettivo contribuisce quindi alla sofferenza invisibile che le donne hanno sopportato interiormente in quello che è stato definito “un mondo di uomini”. Non possiamo, come Chiesa di oggi, sottovalutare la necessità di curare e cambiare le idee e gli atteggiamenti del passato e di aprire il cuore nell’accogliere e sostenere i doni e i carismi delle donne.
A questo proposito, il punto di vista di Edith Stein sulle vocazioni femminili a partire dall’eredità vivificante di Eva è introdotto da Joanne Mosley, e Gesù, come “Nuovo Adamo,” guarisce e riscatta ciò che è stato perso nella cacciata. In sintesi, l’attenzione alla relazione tra Dio e l’altro—e all’interno del mondo naturale—è primaria ed essenziale. E, come invita Scott Lewis, potremmo “raccontare la storia usando l’immaginazione sacra.”
Lucinda M. Vardey

Anne-Marie Pelletier insegna da alcuni anni Sacra Scrittura ed Ermeneutica biblica presso la facoltà Notre Dame del Collège des Bernardins, a Parigi, dopo essere stata professoressa di Letteratura nelle università francesi e aver insegnato all’Istituto Europeo di Scienze delle Religioni (IESR). La sua ricerca si estende all’ebraismo, al cristianesimo e al mondo monastico. Ha pubblicato numerose opere. Nel campo dell’ermeneutica e dell’esegesi biblica ricordiamo “Lectures du Cantique des Cantiques. De l’enigme du sens aux figures du lecteur,” “Lectures bibliques. Aux sources de la culture occidentale,” “D’age en age les Ecritures. La Bible et l’hermeneutique contemporaine” e “Le livre d’Isaie, l’histoire au prisme de la prophetie.” Per quanto riguarda la questione delle donne nel cristianesimo, ha scritto due libri: “Le christianisme et les femmes. Vingt siecles d’histoire,” “Le signe de la femme” e “L’´Eglise, des femmes avec des hommes” (Parigi, Cerf 2019) recentemente pubblicato. È stata insignita del Premio Ratzinger 2014 per la teologia, prima donna teologa a ricevere il premio, e più recentemente del premio 2023 della Judeo/Christian Fellowship of France. Nel 2017 ha scritto la Via Crucis per la preghiera del Venerdì Santo di Papa Francesco al Colosseo. È membro della Pontificia Academia pro Vita e della nuova commissione vaticana per lo studio del Diaconato femminile.
Immortalati nelle culture del passato, la coppia formata da Adamo ed Eva vive ancora oggi nel nostro mondo più secolarizzato. I luoghi comuni su di loro tendono a non avere nulla a che fare con le scritture bibliche: entrambi sono visti come la fonte della misoginia che ha segnato secoli di cristianesimo e contro cui continuiamo a lottare. Inoltre, il modo in cui i lettori credenti alludono ad Adamo ed Eva non fa che perpetuare confusione. Spesso ci si riferisce a loro come “i nostri primi genitori,” senza preoccuparsi del fatto che questo tipo di riferimento implica che Adamo ed Eva condividano la stessa esistenza fattuale di Davide e Betsabea, per esempio. Questo è sufficiente per esporre le Scritture alla derisione dei nostri contemporanei, anche di quelli con lontane conoscenze di paleontologia.
La prima necessità, quindi, è riconoscere che i capitoli iniziali della Genesi parlano un linguaggio mitico. Il mito è l’unico linguaggio pertinente per esaminare le nostre origini, evidentemente inaccessibili, e
per interrogarsi sul significato e sulla posta in gioco della relazione fondamentale tra uomo e donna, con il suo carico di felicità così come di prove e tribolazioni. Vale anche la pena notare la differenza della tradizione biblica rispetto agli altri miti delle origini che circolavano nell’antichità intorno a Israele nel Vicino Oriente.
La Bibbia assegna uno sviluppo particolare alla creazione dell’uomo e della donna. Lo fa in modi diversi, prima nel capitolo 1, poi ancora nella narrazione dei capitoli 2 e 3. Sappiamo che il primo capitolo descrive la creazione nella sequenza dei giorni di una settimana. La creazione dell’uomo e della donna appare nel sesto giorno, come culmine dell’atto creativo. In mezzo alle tante sottigliezze del testo che vanno approfondite, notiamo il versetto 27: “E Dio creò gli uomini a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.”
In poche parole, il testo definisce l’umanità come un’unità differenziata. L’umanità condivisa da un uomo e da una donna è
quindi articolata da una differenza che si imprime all’interno della relazione, essendo il tutto legato al tema dell’immagine di Dio. In questo modo, apprendiamo la verità cruciale che la differenza tra i sessi non degrada l’umanità a immagine di Dio, come sostengono alcuni punti di vista convenzionali. Al contrario, questa differenza è un segno intrinseco dell’identità del Creatore, l’unico Dio che la fede cristiana confessa essere in sé il Dio Trino.
Il consenso a un incontro faccia a faccia con l’altro sesso avrà quindi a che fare con il consenso alla nostra identità di creature esistenti attraverso e per la relazione, l’una con l’altra e insieme con Dio. Il resto del testo biblico non nega in alcun modo questa verità essenziale. Essa è espressa nella storia del Giardino dell’Eden, che attraversa i due capitoli successivi. Qui la messa in scena della creazione è diversa. Un Dio giardiniere, che è anche vasaio, fa uscire dalle sue mani un”umano” (haadam), plasmato dalla terra (haadamah), essendo questo il primo passo per diventare pienamente umano. Questo “umano” è ancora una versione inferiore dell’uomo e della donna. Questo “umano” sarà l’essenza che subirà uno strano intervento chirurgico, dal quale nascerà una controparte (questo è il significato della parola kenegdo nel versetto 20), e solo in seguito si parlerà di una donna (ishah) e di un uomo (ish) che ne usciranno. Il testo è pieno di sottigliezze con cui l’interpretazione più convenzionale, ossessionata com’è dalla disuguaglianza e dalla misoginia, non ha ovviamente voluto appesantirsi. Questa lettura convenzionale sembra ignorare anche le dense parole teologiche, in particolare quando si parla di un “aiutante (ezer) che gli corrisponda.” Questa parola non va interpretata nel senso che una donna debba essere usata da un uomo o essere sua subordinata, ma come viene usata altrove nella Scrittura per designare Dio, e precisamente l’aiuto che l’uomo riceve da Dio. Si tratta infatti di riconoscere che, secondo l’economia biblica, la relazione tra uomo e donna si basa sulla differenza, che ogni sesso costituisce un aiuto vitale per la vita dell’altro. È quindi l’esatto contrario della mentalità più convenzionale che la rende sfavorevole alle donne. In contrasto con questo, ci sono anche le posizioni dei lettori più fondamentalisti del testo della Genesi, che continuamente mettono in secondo piano le donne, negano loro l’accesso all’autorità e le mantengono in ruoli che proteggono il privilegio maschile, falsamente ritenuto “naturale.”

L’opportunità del nostro tempo è quella di riappropriarsi del testo biblico uscendo dai confini dei costrutti misogini convenzionali. In altre parole, liberarsi da interpretazioni stereotipate e riscoprire un testo pieno di sottigliezze che copre un terreno più ampio di una semplice antropologia diseguale. Una recente lettura ravvicinata del capitolo 2 in ebraico sostiene addirittura che il testo biblico si impegna a rimproverare e a ribaltare i pregiudizi che svalutano le donne.1
Tuttavia, non possiamo ignorare la contraddizione del capitolo 3, quando il serpente tentatore contesta il comando divino di utilizzare i frutti del giardino rivolgendosi alla donna, non all’uomo che aveva ricevuto il comando divino. Questo significa che il testo biblico parla irrevocabilmente contro le donne? Anche in questo caso, naturalmente, dobbiamo lavorare con l’intelligenza del testo per interpretare
correttamente la messa in scena della trasgressione. Diciamo che, lungi dall’essere una riproposizione del noto mito della donna pericolosa per l’uomo, il racconto biblico medita sulla realtà di un’umanità che sfida Dio, che vive il rapporto con Dio come un ostacolo, un’alienazione. Va sottolineato che questa realtà non è la prima e l’ultima verità della creazione, come tenderebbe ad affermare l’errata teologia del “peccato originale.” Ciò che il testo biblico assume è il mistero della frattura tra l’umanità e Dio, che riguarda enigmaticamente tutte le generazioni umane, suggerendo precisamente di concentrarsi sul ruolo della donna come madre, cioè il più vicino possibile all’atto di trasmettere la vita. In un certo senso, sostiene anche che il femminile è chiamato ad annunciare il giorno della vittoria sul serpente e all’interno dell’umanità stessa, attraverso un discendente della donna.
Infine, vale la pena notare la correlazione tra il rapporto dell’umanità con Dio e il rapporto tra i sessi. Dopo che la disobbedienza è stata ispirata dal serpente e si è consumata, essa ha testimoniato un rapporto distorto con
Dio (ad esempio, se Dio proibisce l’accesso a un albero nel giardino, è perché Dio è un Dio geloso che considera gli esseri umani in competizione!) La relazione tra l’uomo e la donna ne subisce immediatamente le conseguenze. Genesi 3:15 descrive quindi una relazione tra i sessi ormai segnata dalla violenza e dalla seduzione malvagia. Le due relazioni sono però interdipendenti. Per questo motivo, quello che teologicamente viene chiamato eschaton (l’evento finale del piano divino) non è visto nella Bibbia come il superamento o l’annullamento della differenza tra i sessi. Al contrario, è visto come la trasfigurazione di questa differenza nell’armonia felice e giubilante celebrata nel Cantico dei Cantici, il piccolo libro in cui, in un altro giardino rispetto a quello della Genesi, il desiderio e la celebrazione di un uomo e di una donna fanno risuonare tutta la creazione.
“Vieni, amato mio, andiamo nei campi…andremo nelle vigne; vedremo se germoglia la vite, se le gemme si schiudono, se fioriscono i melograni: là ti darò il mio amore!”
(Cantico Dei Cantici 7:12-14).

Yamai Bature O.C.D. nato in Nigeria, è entrato nella missione nigeriana della Provincia anglo-irlandese dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi nel 2008. Dopo la prima professione nel 2010, ha completato gli studi di filosofia e teologia presso l’Istituto domenicano di Ibadan e ha conseguito le lauree rispettivamente presso l’Università di Ibadan e l’Angelicum (Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino) a Roma. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 2018, Yamai è stato assegnato al Priorato carmelitano di Oxford, in Inghilterra, dove è stato coinvolto nel ministero dell’insegnamento e dei ritiri presso il Centro di spiritualità carmelitana applicata (CACS). Ama le passeggiate nella natura e ha un forte interesse per la valutazione estetica della filosofia e della teologia e per la loro complementare influenza sulla storia e sulle identità culturali. Recentemente è stato trasferito al Centro carmelitano di Avila a Dublino, in Irlanda.
Une Riflessione Spirituale
“Dove siete?” chiede Dio ad Adamo ed Eva (cfr. Genesi 3, 8-9) , e lo chiede oggi a ciascuno di noi. Dio, che è onnisciente e sempre presente, pone questa domanda a coloro che sa che si stanno già nascondendo. Perché, dunque, Dio lo chiede? Proprio per la comunione che Dio intende avere con noi. Dio lo desidera in eterno, il che suggerisce di portare avanti questo desiderio continuamente. Dio è sempre alla ricerca di noi. In cerca di noi dove? Ovunque ci siamo allontanati dalla presenza di Dio. Nel racconto scritturale primordiale di Adamo ed Eva nel loro nascondiglio, riconosciamo come Dio abbia sempre portato avanti questa ricerca per ciascuno di noi fin dall’inizio.
Il Giardino è un simbolo dell’anima, lo spazio stesso che Dio richiede di coltivare per portare frutto. Il Giardino è anche un simbolo di ogni situazione che ha il potenziale di portare frutto per Dio e questo significa la totalità dell’esperienza umana e tutto ciò che plasma la vita umana.
Dio fece [...] anche l’albero della vita in mezzo al giardino. (Gen 2:9)
L’Albero della Vita è il punto di riferimento centrale per tutto il resto nel Giardino; è la presenza vitale di Dio assolutamente necessaria per il proseguimento dell’ esistenza. Nel giardino dell’anima, il simbolo dell’Albero della Vita si riferisce proprio a Cristo. Questo informa il carattere cristocentrico dell’interpretazione dell’esperienza umana. L’Albero della Vita simboleggia anche la soglia dell’eternità: mangiarne comporta la conferma della propria condizione/stato attuale per sempre (Gen 3,22).

L’albero della conoscenza del bene e del male è il confine assegnato alla libertà umana (Gen 2,16-17). San Giovanni Paolo II ha scritto che “il potere di decidere del bene e del male non appartiene all’uomo, ma a Dio solo. L’uomo è certamente libero […] Ma questa libertà non è illimitata: deve arrestarsi di fronte all’«albero della conoscenza del bene e del male», essendo chiamata ad accettare la legge morale che Dio dà all’uomo.” (Veritas
n. 35).
Mangiare da quest’albero implica: primo, l’abuso della libertà: la persona umana non è libera di manipolare le parole di Dio; secondo, l’esperienza del morire (schiavitù del peccato) e infine della morte. A quanto pare, la conoscenza del bene e del male ha fatto sì che l’umanità diventasse come Dio. Allora perché questa punizione per aver mangiato dall’albero?
La conoscenza del bene e del male da parte di Dio non è partecipativa e questo rende necessario il comando di Dio: “Non ne mangerai” (Gen 2, 17). È giusto che, avendo la somiglianza con Dio, anche la conoscenza del male da parte dell’umanità sia non partecipativa. Mangiando dall’albero contro l’amore protettivo di Dio, l’umanità ha conosciuto il male in modo partecipativo.
È importante notare che l’Albero della Conoscenza del Bene e del Male era l’unico ad essere evitato. Ciò dimostra che questo albero era isolato dagli altri, e in particolare dal fondamentale Albero della Vita. Così che il pronunciamento: “Morirai” doveva essere l’unica conseguenza appropriata per abbracciare questo isolamento, questa separazione dalla vita. Ogni altro albero del giardino simboleggia la vastità della libertà assegnata all’umanità. Di ogni altro albero è stato detto in Gen 2,9 che era “gradito alla vista e buono da mangiare.” Ora, questo fascino di essere “gradito alla vista e buono da mangiare” era posseduto anche dall’Albero della conoscenza e del male (Gen 3,6). Qual era dunque la differenza tra questo e tutti gli altri alberi? La separazione e la presenza del serpente, simbolo della sfida a Dio e dell’inganno nei confronti dell’umanità. È proprio il rapporto tra Dio e gli esseri umani il bersaglio finale di questa sfida e di questo inganno, che derivano entrambi da una linea d’azione coerente, che consiste nel distorcere le parole di Dio. Questa distorsione o manipolazione del messaggio di Dio è una caratteristica distintiva della tentazione e l’obiettivo di questa manipolazione è di compromettere quella relazione che conferma l’umanità
nella semplicità che Dio vuole per essa; la semplicità di conoscere solo la presenza di Dio. Dio è il principio di questa semplicità e quindi vediamo brevemente cosa significa.
La semplicità di Dio si riferisce alla
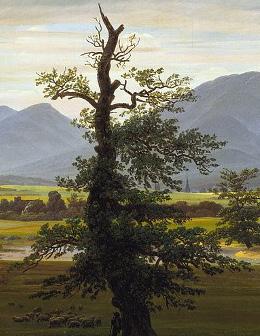
semplicità della natura, il che significa che Dio non è costituito da nulla e non dipende da nulla per essere chi è.
Questa semplicità contrasta con la nostra natura complessa di esseri con intelletti discorsivi, che richiedono l’uso di vari attributi di Dio per parlare di ciò che è Dio. “Qualunque cosa sia Dio [Amore, Bontà, Santo, Misericordioso e così via] Dio è completamente e simultaneamente questo.”1 – ecco quanto è semplice Dio.
A questo punto è sufficiente dire che, mentre la semplicità di Dio è concettualmente inesauribile, essa è sperimentabile e accessibile nella relazione, proprio a causa dell’autorivelazione di Dio come Dio trino—una comunione di tre
persone divine distinte. Questa è quindi la nostra lente preferita con cui considerare la semplicità di Dio.
Dio è semplice, Dio è amore, e la caratteristica dell’amore è il suo traboccare al di là di sé stessi verso un altro o verso gli altri. La semplicità della relazione tra le persone della Trinità si esprime nella loro generosa donazione reciproca: Il Padre, il Figlio e lo Spirito sono assolutamente poveri perché si donano completamente, e così ognuno si arricchisce della generosità dell’altro.”2 La semplicità di Dio conserva questa realtà comunionale (Padre, Figlio e Spirito) di Dio completamente e simultaneamente, e questa comunione nella vita di Dio si estende all’umanità attraverso l’incarnazione di Cristo che “svuotò se stesso” (Filippesi 2,7) per diventare presente in mezzo a noi, affinché anche noi possiamo svuotarci per diventare presenti davanti a Dio.
Dio è infinito, Dio è semplice. Noi siamo finiti, siamo esseri costituiti e quindi complessi. Ma siamo anche creature di Dio e se Dio ha trovato buono tutto ciò che ha creato, allora anche la nostra complessità è buona e tende al bene. La nostra conoscenza partecipativa del male, invece, fa sì che la nostra complessità possa degenerare nel caos. La nostra complessità, quindi, si colloca da qualche parte nello spettro tra la semplicità e il caos, tra la presenza di Dio e il male, tra l’albero della vita e l’albero della conoscenza del male.
La nostra complessità assume le sembianze della semplicità quando cresce verso un’integrazione armoniosa, l’incontro delle parti costitutive della nostra natura in un’unità di completezza che assomiglia alla semplicità dell’unità in Dio.
Alla luce di ciò, iniziamo a riflettere sulla nostra natura complessa e permettiamo alla semplicità di Dio di toccare la realtà della nostra condizione umana. La nostra dipendenza dai numerosi bisogni legati
alla sopravvivenza, siano essi spirituali, materiali, biologici o psicologici, incarna la nostra natura complessa. E quando la ricerca del soddisfacimento di questi bisogni ci fa sprofondare nell’ansia dell’insaziabilità, la nostra complessità può deteriorarsi nel caos—un caos in cui il peccato e l’imperfezione svelano il loro volto in noi e mascherano quella semplicità della comunione che Dio ha stabilito con noi fin dall’inizio. Ma prima della caduta, prima dell’inizio del peccato, la relazione dell’umanità con Dio era assolutamente semplice, e questa semplicità aveva la forma della presenza reciproca.
Nell’attaccamento alle nostre tendenze peccaminose, siamo chiamati a passare dall’egocentrismo all’essere centrati sugli altri.
Nell’attaccamento alla nostra volontà, siamo chiamati a passare dall’ostinazione alla volontà.
Nell’attaccamento alle passioni, siamo chiamati a passare dalla dipendenza alla moderazione.
Nell’attaccamento all’intelletto, siamo chiamati a superare il nostro ego e arrivare a Cristo.
Nell’attaccamento al senso di colpa, siamo chiamati a crescere dalla fissazione sulla nostra memoria alla speranza e alla fiducia in Cristo.
Semplicità significa eliminare il superfluo, ovvero tutto ciò che appartiene a Dio. Per raggiungere questo obiettivo, è importante adottare la pratica della presenza di Dio. Questo significa fare tutto alla presenza di Dio e, mantenendo una semplice coscienza della presenza di Dio, ci rendiamo semplicemente presenti a Dio.

John Dalla Costa è esperto di etica, teologo e autore di cinque libri. Per maggiori informazioni su di lui, visitate il nostro sito web.
Tutta la Bibbia si dispiega come il racconto della redenzione di Dio nella storia dopo la cacciata dell’umanità dal Giardino dell’Eden. Considerata la posta in gioco, gli scrittori della Genesi hanno dato un’importanza notevolmente ridotta al tradimento che ha portato all’espulsione dell’umanità dal cospetto di Dio nel Giardino: meno di una pagina di testo nella mia Bibbia di 1.404 pagine. Anche se i versetti sono pochi, molte delle ipotesi fatte e perpetuate non rendono giustizia dell’esatto contenuto. Non solo la sequenza è confusa o mescolata, ma spesso lo sono anche i dettagli testuali. In questo processo, è facile confondere sia l’antropologia che la teologia, proiettandoci nella storia senza affrontare l’ambiguità (e l’incompletezza) di una narrazione troppo breve e troppo decisiva.
Ad esempio, non furono Adamo ed Eva a commettere il primo peccato. Hanno ricevuto il loro nome solo dopo che la litania delle sofferenze è stata pronunciata come giudizio per aver trasgredito il comando di Dio di non mangiare “dell’albero della conoscenza del bene e del male.” Questo lascia perplessi, non è vero? Implica che l’identità umana pienamente formata si basa sulla capacità di affrontare, comprendere e giudicare il bene e il male. Possiamo considerarci umani senza distinguere tra ciò che è giusto e sbagliato, tra morale e immorale? E soprattutto, è possibile essere in relazione—dare e ricevere amore autentico—senza questa capacità etica inscritta nel cuore?
Altri tre dettagli della narrazione mi hanno fatto allontanare dalla mia condanna nei confronti di Adamo ed Eva e hanno fatto aumentare la mia simpatia per loro. Uno è che Dio li creò come adulti, con corpi maturi che ospitavano personalità prive di qualsiasi esperienza o formazione. Per quanto ho potuto cercare nella letteratura rabbinica e nei commentari teologici, non ho trovato alcuna spiegazione di questo enigma. Non conoscendo (ancora) il bene e il male, si può ritenere che l’uomo e la donna abbiano avuto piena facoltà di scegliere in modo sbagliato?
Un altro dettaglio è che solo l’uomo ricevette il comando di Dio riguardo al frutto proibito. Il serpente “astuto” ha attaccato la coppia nel suo punto più vulnerabile, rivolgendosi alla donna che, a questo punto della narrazione, avrebbe sentito il divieto di Dio solo in seconda battuta. Sebbene sia stato detto di evitare di mangiare il frutto che illuminava il bene e il male, non c’è alcuna prova nel testo che il primo uomo e la prima donna siano stati avvertiti che il male fosse già libero e strisciante nel Giardino. Essi disobbedirono, ma in un certo senso, in modo frivolo, come bambini, piuttosto che con premeditazione e calcolo a sangue freddo.
Il terzo aspetto da sottolineare è che Dio era assente. Le creature vulnerabili, ancora nuove alla creazione, furono lasciate da sole. In un certo senso, questa fu la prima esperienza della “notte oscura dell’anima”, il primo caso in cui gli esseri umani, creati a immagine e somiglianza di Dio, furono lasciati senza la presenza del loro Santo Genitore e prototipo. Che cosa pensava e implicava Dio allontanandosi?
Quale poteva essere il piano di Dio nell’esporre i primi esseri umani alla tentazione, vietando loro proprio il frutto che avrebbe potuto informare moralmente la loro risposta?
Ovviamente, la brevità e l’ambiguità di questo testo di importanza fondamentale possono essere il punto esatto. Le origini e il male restano misteri che non possono non essere riconosciuti, anche se compresi in modo incompleto. Non si può negare la capacità umana di peccare. Leggendo questo passo della Genesi non posso fare a meno di chiedermi se la delusione di Dio fosse dovuta al fatto di aver previsto un rito di passaggio diverso per l’uomo e la donna che Dio aveva creato. Forse il piano prevedeva una sorta di direzione spirituale individuale, con Dio che formava questi adulti innocenti per ricevere una saggezza commisurata alla loro capacità di essere creati a immagine e somiglianza di Dio. O forse la vulnerabilità sfruttata dal serpente faceva parte del più ampio piano di Dio per la redenzione, attraverso l’incarnazione di Gesù Cristo che non solo ha salvato l’umanità, ma ha portato ciascuno di noi nel progetto del respingimento il male e della costruzione del regno di Dio. Forse la ferita è il punto: Dio come amore genera la creazione, la distrugge e continuamente la restaura e la rinnova con misericordia, perdono, ispirazione e scopo.
Il teologo gesuita Edward Vacek spiega alcune delle dimensioni prenatali dell’amore creativo di Dio. “L’amore genitoriale è (o può essere) inizialmente un atto d’amore per un essere non ancora esistente. I genitori si impegnano a portare all’esistenza un essere che, quando sarà reale, non sarà e non dovrà essere del tutto conforme al loro progetto, ma che si realizzerà in modi imprevedibili grazie alla sua libertà.”4 Parte della ragione

dell’assenza di Dio potrebbe essere stata quella di dare inizio a questa liberazione. Nell’amore, Dio ha rischiato per ciò che “non è ancora, ma può essere.” La disobbedienza che avrebbe causato sofferenza agli esseri umani ha ferito Dio per primo, e forse più profondamente.
Questa ferita originaria permea la Bibbia ed ha il suo apice nella croce di Cristo. La Scrittura è spesso considerata come il mezzo della rivelazione di Dio, e lo è. Ma ancora più precisamente, il testo che consideriamo
sacro rivela il desiderio struggente di Dio per l’umanità. Per quanto possiamo cercare Dio, proprio quel desiderio di ricerca è un dono impiantato da Dio nelle nostre anime per aver sentito la mancanza di ognuno di noi con tale angoscia e fervore. Dio ha parlato, Dio ha chiamato, e Dio ha mandato i profeti mossi dal desiderio dell’amore di vedere che la persona amata sta bene e per attirare la persona amata nell’abbraccio. Può sembrare che Dio sia inadeguato nell’essere così bisognoso del riconoscimento e della risposta dell’umanità, ma questa qualità rivela l’assoluta e infinita offerta di sé dell’amore. Separandosi dalla donna e dall’uomo che Dio aveva creato, la libertà si realizza pienamente, in modi di crescita che implicano la saggezza duramente conquistata nei fallimenti come nei successi, nei peccati come nel pentimento.
La sezione più lunga del capitolo della Genesi che tratta di questa ferita originaria descrive in dettaglio le sofferenze che gli esseri umani dovranno affrontare una volta espulsi dal Giardino (3,14-19). Ancora una volta, per quanto cupa sia questa punizione, un’indicazione del desiderio genitoriale e della misericordia di Dio per l’umanità è resa evidente in un solo versetto prima della cacciata. Ci viene detto che “il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì” (Genesi 3:21). In primo luogo, dobbiamo riconoscere questa creazione di vesti come un atto primordialmente materno. In secondo luogo, presuppone una grande intimità, tagliando e cucendo insieme materiali che saranno indossati a contatto con la pelle. In terzo luogo, fare le vesti e “vestirli” significa una protezione che sarà indossata a lungo dopo la separazione: una manifestazione pratica e tangibile di vicinanza che non sarà ostacolata nemmeno dall’affissione di “cherubini... con una spada fiammeggiante” alle porte di un Eden ormai proibito. Come il padre in attesa nella parabola del “Figliol Prodigo” di Gesù, il fatto che Dio abbia confezionato l’abito per rivestire Adamo ed Eva, prima che fossero costretti a partire, rivela un cuore ferito, che tuttavia desidera con amore genitoriale che siano al sicuro, che sentano Dio tangibilmente vicino e che un giorno ritornino.
Lucinda M. Vardey

Lucinda M. Vardey è la caporedattrice di “Un unico accordo.” Per maggiori informazioni su di lei, si rimanda la sito web
Comunque si interpreti la storia della cacciata di Adamo ed Eva dal Giardino dell’Eden, essa deve essere percepita come una tragedia per l’anima umana. Quando i due coniugi se ne andarono, la loro rottura con la comunità dell’Eden avrebbe avuto ripercussioni sui cuori e sulle anime di tutte le creature che si
erano lasciati alle spalle. È stato dimostrato che le piante provano emozioni, quindi che ne fu dei fiori che stendevano il loro tappeto di bellezza che un tempo confortava i piedi nudi di Adamo ed Eva? La cacciata segnò la fine dell’unità non solo con Dio, ma anche con la creazione di Dio così come era stata data, e con essa giunse la fine dell’innocenza: un’innocenza nutrita dall’essere circondati da tutto ciò che è necessario per nutrire corpo e anima. Quando Adamo ed Eva lasciarono l’Eden per un mondo diverso, si lasciarono alle spalle l’innocenza. Altri stati dell’essere presero il suo posto, allevando i loro figli che,
col tempo, svilupparono una vita competitiva in relazione a Dio, al punto che Caino uccise suo fratello Abele. Si scatenò una vita di violenza, la sofferenza era garantita, la mancanza di una casa era un dato di fatto e le lotte causate dalla differenza e dall’invidia divennero la norma per la vita umana oltre il giardino.
Nel corso del tempo, e soprattutto negli ultimi secoli, abbiamo continuato a essere lontani dal rapporto con il mondo naturale. Di conseguenza, Dio non è così facile da trovare e da pregare all’esterno. È interessante notare, tuttavia, che in tutte le Scritture Dio è sempre apparso tra le nuvole, in cima alle montagne, all’imboccatura delle grotte, nei deserti aridi, persino in un roveto ardente, invitandoci sempre a stare vicini. Spostandoci sempre più nelle città—soprattutto per motivi economici o politici—abbiamo perso quella coscienza primaria, l’innocenza che ci lega alla terra. La vita di città, con tutte le sue attrazioni e distrazioni, rende più difficile vivere in accordo con i ritmi delle stagioni e in intimità con le creature che ci circondano, persino guardare il cielo notturno in tutta la sua gloria. La nostra lontananza dalla natura ha invece scatenato solo danni all’ambiente e a tutta la vita che è sostenuta dalle forze armoniche della potenza creatrice di Dio.
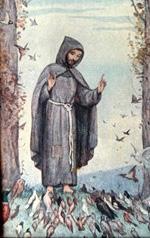
con la vita non umana e con ciò che essa può insegnarci su Dio.
Il riconoscere la terra come sacra e chiamarla “Madre,” è stato portato alla nostra coscienza cristiana da San Francesco d’Assisi. Poiché la Chiesa istituzionale era diventata corrotta dal potere, egli si recava nei campi, indossando una semplice veste marrone dello stesso colore dei passeri. Predicava il Vangelo non solo alle persone troppo povere (e analfabete) per frequentare le chiese, ma anche agli uccelli e glorificava Dio nel sole, nella luna, nelle stelle, nel fuoco e nell’acqua, in tutti gli elementi. Quando il suo fratello monaco, Sant’Antonio da Padova, non veniva ascoltato dalla gente di Rimini—dove era andato a predicare su Dio—si rivolgeva ai pesci della foce del fiume che sfociava nel mare. Essi tiravano fuori la testa dall’acqua, rimanevano immobili e ascoltavano con riverenza ogni sua parola. Alla vista dei pesci, gli abitanti del luogo provavano un grande rimorso, cambiavano idea e i loro cuori si convertivano.
Le strutture “fatte dall’uomo,” come i templi e poi le chiese, sono i luoghi che frequentiamo per pregare Dio, per fare richieste, per adorare, per onorare, per ricevere. Abbiamo abusato del nostro ruolo di amministratori della creazione e abbiamo considerato il “dominio” che ci è stato dato come segno di superiorità. Nel processo del cosiddetto progresso, non solo abbiamo abbandonato l’innocenza e la meraviglia, ma anche il tempo per entrare in comunicazione
È chiaro che, anche con questi esempi della nostra tradizione, siamo diffidenti—e a volte timorosi—nel fidarci dell’innocenza e della saggezza insita nella creazione. Durante le ricerche per un libro che ho appena completato sulla scoperta di Dio nella natura, ho scoperto che è diffuso credere che gli animali e la vita non umana siano esseri inferiori, privi di anima, di coscienza, di intelligenza, di capacità linguistiche, di logica e di ragionamento, di immaginazione e di memoria, persino di spiritualità. Tuttavia, recenti ricerche hanno dimostrato che le nostre supposizioni potrebbero essere errate e che la vita non umana opera invece a un livello diverso. La comunicazione non verbale tra le specie è un aspetto di cui sappiamo
poco. Sappiamo però che la comunicazione verbale e non verbale con Dio è possibile per noi e potrebbe esserlo anche per le creature, per tutto ciò che è vita. Solo che non ha lo stesso aspetto, né può essere spiegata completamente.
“...Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (Matteo 18:3).
Alcuni di noi hanno avuto il privilegio di crescere avendo accesso a giardini, prati, boschi e foreste. La nostra immaginazione è stata nutrita con storie di misteriosi mondi di spiriti che abitavano la terra o il mare o che volavano di notte sul dorso dei gufi. La sfida della nostra maturità è quella di concederci un po’ più di quell’ambiente infantile, trascorrendo più tempo nella natura, senza alcuna intenzione se non quella di essere presenti, di lodare Dio nella bellezza e nell’armonia e di creare uno spazio nella nostra anima per essere nutriti da quello che è sempre stato il nostro ambiente naturale fin dall’inizio. Potremmo trovarci più vicini a Dio quando mettiamo da parte le nostre responsabilità e preoccupazioni, tutto ciò che ci addolora, tutto ciò che desideriamo, e cominciamo a considerare invece come potrebbe essere un giglio in un campo (Cf. Matteo 6:28). Inoltre, amando Dio e amando la Terra, potremmo contribuire a dare un po’ di luce e di cura all’angosciante esperienza del cambiamento climatico.
Ricordo di aver letto una storia in una rivista molti anni fa che mi è rimasta impressa. Parlava di una giovane donna gravemente depressa al punto di contemplare il suicidio. Uno zio la portò in campagna per aiutarlo a piantare ortaggi. Mentre preparavano il terreno, lui le chiese di far cadere i semi nei solchi della terra e di coprirli a mani nude. Mentre lo faceva, un sorriso apparve sul suo volto, il suo umore cambiò e fu sollevata dalla sua depressione. La storia si concludeva con l’intuizione che abbiamo bisogno di tornare alla terra, di maneggiare la terra, di far sì che essa tocchi la nostra pelle, come fece con Adamo ed Eva quando vissero senza vestiti e felici con Dio nell’Eden.
Le nostre anime possono essere riempite lasciando che il mondo naturale ci insegni la semplicità: le colombe e gli altri uccelli l’innocenza, e i serpenti, non siano visti come tentatori o come il diavolo, ma come portatori di saggezza (Cf. Matteo 10:16). Allora faremmo un passo indietro, o in avanti, per partecipare alla bellezza e all’unità conosciute un tempo nell’Eden.


Scott Lewis S.I. è professore associato emerito presso il Regis College dell’Università di Toronto e attualmente fa parte della facoltà del Campion College di Regina, Saskatchewan. Ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti per diversi anni ed è entrato nella Provincia della California della Compagnia di Gesù nel 1979. Dopo l’ordinazione nel 1987, ha studiato Sacra Scrittura a Roma, conseguendo la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e il dottorato in Sacra Teologia presso l’Università Gregoriana. Ha insegnato e lavorato per due anni a Gerusalemme prima di arrivare a Toronto nel 1997. È esperto di Vangelo di Giovanni, Lettere di Paolo, Bibbia e violenza religiosa e storia dell’esegesi. Dal 2008 al 2014 è stato direttore del Jesuit Spiritual Renewal Centre di Pickering, Ontario. Oltre all’insegnamento, presenta approfondimenti settimanali sulle letture del Vangelo della domenica nel Catholic Register, tiene conferenze sulle Scritture e ritiri in Canada e all’estero. Autore di numerosi libri, il suo ultimo è “How Not to Read the Bible” (Novalis/Paulist Press, 2019).

La storia di Adamo ed Eva e del giardino dell’Eden in Genesi 2,5-3,24 ha esercitato nel corso dei secoli un’influenza potente—e alcuni direbbero negativa— sulla teologia e sulla cultura. È la radice della dottrina del peccato originale e, in alcune correnti teologiche, di una visione estremamente negativa della natura umana.
Ma la tradizione teologica è molto più sfumata e niente affatto univoca. L’interpretazione del testo dell’evento del Giardino dell’Eden non deve essere necessariamente statica. La tradizione midrashica ebraica era malleabile e le interpretazioni potevano essere dilatate e modellate in molti modi, pur mantenendo sempre la loro forma fondamentale e la loro connessione con il testo. Nel corso del tempo, l’immaginario sacro collettivo ha affrontato la storia con le questioni del peccato, della morte e della redenzione.1 Da un lato, è stata tradizionalmente vista come catastrofe primordiale e fonte di ogni male e sofferenza. Ma ci sono state altre voci che hanno visto la “caduta” come un’esperienza di apprendimento e un passo necessario per l’umanità nel suo viaggio e nella sua lotta per raggiungere l’unità con Dio.
Adamo è una figura piuttosto passiva nella narrazione e non parla fino a quando lui ed Eva non si trovano di fronte a Dio. Lui dava la colpa a Eva; lei dava la colpa al serpente; il serpente (non più il diavolo) non aveva nessuno a cui dare la colpa. Eva è stata ritratta in modo molto negativo nel Siracide e in 1 Tim 2, 13-14: “Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva; e non Adamo fu ingannato, ma chi si rese colpevole di trasgressione fu la donna.” Nel Siracide e nella Sapienza, Adamo è raffigurato come il primo della specie umana e il fondatore dell’umanità, in possesso di una gloria presente fin dall’inizio.2
Nelle tradizioni teologiche ebraiche Adamo non è rappresentato come la fonte e la causa del male umano – l’azione umana è quasi sempre enfatizzata. L’omicidio di Abele da parte di Caino è sempre stato considerato molto più grave. Dopo la storia del Giardino dell’Eden, Adamo ed Eva sono raramente menzionati nelle scritture ebraiche. Adamo stesso appare in opere apocrife come l’Apocalisse di Mosè e la Vita di Adamo ed Eva. In queste opere, la speranza nel perdono e nella riparazione è estesa ad Adamo: non tutto è perduto. La Scrittura riscritta, il Libro dei Giubilei, tratta molto bene Adamo, addossando la colpa e la furia di Dio a Eva e al serpente e omettendo i passaggi che evidenziavano la colpevolezza di Adamo.3
Adamo appare nella letteratura apocalittica come trasgressore, ma non come causa di peccato e di morte in alcun senso trasmesso. Ad esempio, in 2 Baruch—un’opera apocalittica pseudoepigrafica ebraica scritta dopo la distruzione del tempio nel 70 d.C.—l’enfasi è posta sulla responsabilità umana: “Sebbene Adamo abbia peccato per primo e abbia portato su tutti la morte prematura, tuttavia, tra coloro che sono nati da lui, ognuno di loro ha preparato per la propria anima il tormento a venire e, ancora, ognuno di loro ha scelto per sé le glorie a venire... Infatti, le Sue opere non vi hanno insegnato, né l’abilità della Sua creazione, che è in ogni momento, vi ha persuaso.” Adamo non è dunque la causa, se non della propria anima, mentre ciascuno di noi è stato l’Adamo della propria anima (2 Baruch 54).4
Adamo irrompe nuovamente sulla scena nel Nuovo Testamento. Anziché iniziare la genealogia di Gesù con Abramo, come in Matteo, la genealogia di Luca inizia con Adamo. Ciò segnala che l’opera redentrice di Gesù è destinata a tutta l’umanità e, in effetti, l’universalismo era un tema chiave in Luca.
Negli scritti di Paolo, la trasgressione di Adamo faceva parte del piano divino. Egli era la prefigurazione di colui che doveva venire, Gesù il Cristo. Nessuno dei due può essere compreso isolatamente. È nelle lettere paoline del Nuovo Testamento che si manifesta il pieno significato di Adamo. In Rm 5,12-21 , il peccato di Adamo ha portato il peccato e la morte nel mondo, colpendo tutta l’umanità. Piuttosto che il peccato come colpa trasmessa attraverso la procreazione - come insisterà la successiva dottrina del peccato originale - il peccato è un’energia negativa che viene trasmessa alle generazioni future attraverso le scelte umane e seguendo l’esempio di disobbedienza di Adamo. Il Vecchio Adamo rappresenta l’antico sistema e il mondo che si sta spegnendo. I primi seguaci di Gesù credevano di essere sulla soglia della Nuova Era, rappresentata da Cristo, dallo Spirito e dalla nuova creazione.
Paolo sviluppa questa idea dell’universalità del peccato come controparte dell’ universalità della salvezza in Cristo. In 1 Cor 15,21-49 Cristo è il Nuovo Adamo e uno spirito vivificante. Il contrasto tra il Vecchio Adamo e il Nuovo è tra il mortale e corruttibile da un lato e l’immortale e incorruttibile dall’altro. L’enfasi non è sulla cancellazione del peccato, ma sulla trasformazione ed elevazione spirituale. Il Nuovo Adamo trasforma e spiritualizza l’individuo e lo dota di immortalità. Questo è rappresentato in forma visiva nelle icone
della Discesa agli inferi. Dopo aver abbattuto le porte dell’inferno, Gesù scende in un pozzo di fuoco e afferra Adamo per il polso per tirarlo fuori. Il Vecchio Adamo e il Nuovo Adamo si incontrano e il ciclo è completo. La tradizione vuole che Adamo sia stato sepolto sul Calvario. Molte icone mostrano un teschio sotto la croce, unendo così il Vecchio e il Nuovo Adamo.
Secondo Ireneo, la caduta è stata una disgrazia, ma faceva parte del piano di Dio da sempre. Adamo stesso è incompleto e ancora in evoluzione. 5 È solo scegliendo e anche sbagliando che impariamo a scegliere e a seguire il bene. Dio ha permesso la disobbedienza nel Giardino perché l’umanità potesse crescere nella gratitudine e nell’umiltà. 6

“O felice colpa, o necessario peccato di Adamo, che ci ha guadagnato un così grande Redentore!”
(Messale Romano).
Il grido di esultanza del Messale Romano (sopra) comincia ad avere un senso solo guardando indietro all’intera tradizione riguardante Adamo, sia ebraica che cristiana. La storia della caduta di Adamo non deve necessariamente essere un’ombra oscura sulle nostre tradizioni teologiche. Alla maniera midrashica, potremmo raccontare di nuovo la storia, usando la sacra immaginazione.

Joanne Mosley è redattrice, conferenziera e scrittrice, esperta di spiritualità carmelitana. Si è formata come linguista e dopo la laurea in francese e tedesco ha conseguito il dottorato nell’area della biografia francese, specializzandosi nel periodo delle guerre di religione. Inizialmente ha insegnato a studenti universitari, ma ha cambiato carriera nel 2001, da allora è stata associata ai Carmelitani. Ha curato numerosi articoli e libri e ha tenuto diverse conferenze sui santi carmelitani, in particolare per il Centre for Applied Carmelite Spirituality di Oxford, in Inghilterra. È autrice di “Edith Stein: Woman of Prayer,” pubblicato da Gracewing nel 2004 (anche da Paulist Press nel 2006, con il titolo “Edith Stein: Modern Saint and Martyr”), tradotto in quattro lingue, e della biografia in due volumi “Elizabeth of the Trinity: The Unfolding of Her Message” (2012, Teresian Press, Oxford).
Quando pensiamo alla vocazione di una donna, sicuramente ci viene in mente una chiamata specifica, come il matrimonio o la vita religiosa. Oppure, come la filosofa tedesca e santa carmelitana Edith Stein, possiamo allargare il quadro alle professioni, che a volte definiamo “vocazionali.” In effetti, Edith usa la parola Beruf (da berufen, che significa “chiamare”) per indicare tutte queste chiamate.1 Secondo Edith, però, ogni donna ha due vocazioni che si intrecciano: una chiamata specifica e una vocazione in quanto donna. Quest’ultima, in particolare, sembrerebbe, dagli scritti di Edith, quella primaria: è infatti essenziale alla nostra natura ed è una costante, indipendentemente dal percorso di vita in cui viene vissuta. Per comprendere la vocazione della donna, è necessario prima comprendere la natura della donna, e per questo Edith si è rivolta a Eva.
Eva, al momento della sua creazione, rappresentava l’ideale di femminilità di Dio, e gli appellativi che le vengono dati nella Genesi sono profondamente significativi. Nel secondo racconto della creazione (Gen 2,23) viene chiamata donna perché è stata tratta dall’uomo; Edith sottolineerà il fatto che Eva è stata tratta dal fianco dell’uomo. A Eva vengono inoltre assegnati due ruoli. Il primo è quello di compagna o “aiutante” (Gen 2, 18-20); Edith ne dà il termine ebraico (Eser kenegdo) e descrive Adamo ed Eva come coloro “che si completano a vicenda come una mano fa con l’altra.” Il secondo ruolo è quello di madre: dal nome “Eva,” che significa “madre di tutti i viventi” (Gen 3,20). In sintesi, quindi, Eva deve essere compagna e madre, 2 il che rappresenta la natura essenziale della donna. Lo sforzo di Edith è stato quello di esplorare come le donne, in quanto “figlie di Eva,” possano vivere questa vocazione.

Il modo più letterale per farlo è il matrimonio e la maternità. Qui la donna può sostenere il marito “al suo fianco”—posizione che ricorda la creazione di Eva dal fianco dell’uomo—e
come madre, con i suoi doni naturali di sensibilità ed empatia, può favorire la crescita dei figli. La natura, tuttavia, ha bisogno di essere perfezionata dalla grazia. Se il naturale interesse di una donna per le persone viene portato all’eccesso, può diventare possessivo e causare danni. Edith indica Maria, la nuova Eva, come correttivo: “Al centro della sua vita c’è suo figlio,” ma poiché Maria ha vissuto come servitrice del Signore, “è per questo che non considera il figlio come una sua proprietà,” ma lo rimette nelle mani di Dio.
La donna consacrata è chiamata a consegnare tutta sé stessa al suo Sposo, per essere riempita del suo amore e farlo traboccare nel servizio agli altri. In termini che evocano la maternità, Edith descrive questo stato religioso come “pronto a servire, [...], a risvegliare e a promuovere la vita,” come l’amore misericordioso di Dio che “si china su chiunque abbia bisogno [...], proteggendo, custodendo, nutrendo, insegnando e formando.” Edith commenta in modo incoraggiante che “le altezze dell’ethos vocazionale” sono accessibili a qualunque donna, purché sia completamente abbandonata a Dio.
Il contesto poco esaltante di un ufficio o di una fabbrica permette a Edith di mettere in evidenza la vocazione della donna. Voleva mostrare alle lavoratrici (molte delle quali single e non per scelta) che possono realizzare il loro destino di donna in senso spirituale, attraverso i due ruoli di Eva:
Ovunque [questa donna] si metta al fianco di una persona sola, soprattutto se in difficoltà fisica o psicologica, sostenendola e comprendendola con amore, consigliandola e aiutandola, è una compagna di vita che aiuta “perché l’uomo non sia solo” [Cfr. Gen 2, 18]. Ovunque aiuti un’anima, che è in
fase di sviluppo, a raggiungere la sua meta, nella sua evoluzione fisica, spirituale, psicologica, è una madre.3
Edith invita le donne ad accorgersi veramente dei loro compagni di lavoro; a rivolgere una parola amichevole o una domanda comprensiva, permettendo a coloro che hanno “cuori carichi di problemi” di aprirsi. “Ovunque [una donna] incontri un essere umano, troverà l’opportunità di sostenere, consigliare, aiutare.” Il loro modello è la nuova Eva: la Madre della Misericordia o Maria a Cana, che risolve i problemi dietro le quinte— “il prototipo di donna nella vita professionale.” Una donna così, dice Edith incoraggiante, “come uno spirito buono diffonderà benedizione ovunque.”
La nuova Eva è anche la Chiesa, nata sul Calvario dal fianco del nuovo Adamo, e la Chiesa “sta al suo fianco come Sposa di Cristo e collabora con lui nella sua opera.” Qui si intravede una teologia della Chiesa profondamente femminile.
Edith mostra come possiamo imitare Maria, la nuova Eva. Affidandoci a Cristo, diventiamo libere di “camminare al fianco del Salvatore,” come Maria che era “sempre al fianco del Signore.” Ancora più profondamente: essendo in intima relazione con Cristo, Maria “intercede presso di Lui per l’umanità; riceve dalle sue mani le grazie da elargire” ed “è la madre dei viventi non perché da lei discendono tutte le generazioni successive, ma perché il suo amore materno abbraccia tutto il Corpo Mistico con a capo Gesù Cristo.”
La donna, ci dice Edith, assume la vocazione cristiana “in modo speciale, grazie alla sua speciale relazione con il Signore che
l’ha destinata ad essa.” In questa luce di fede, la vocazione della donna è eccezionalmente ricca e veramente nobile: è quella di essere “immagine della Madre di Dio, sposa di Cristo, apostola del Cuore divino.”

Le descrizioni di Edith sulla ricchezza della natura femminile erano accompagnate dal suo stesso esempio. Con calore materno si prendeva cura dei suoi nipoti, incoraggiava i suoi studenti e dava ascolto e aiuto pratico a chi ne aveva bisogno. Il suo direttore spirituale, Raphael Walzer OSB, notò la sua “tenera, persino materna, sollecitudine per gli altri.” Forse questo fu più evidente che nel campo di transito di Westerbork, dove Edith andava in mezzo alle altre donne prigioniere, “come un angelo, confortandole, aiutandole e consolandole;” e quando le madri non potevano occuparsi dei loro figli, Edith lo faceva, pettinandoli e cercando di assicurarsi che fossero nutriti e curati.
Nella sua vita, Edith ha esemplificato la santità come lei stessa l’ha descritta: l’interezza in cui la natura di una donna si combina con “l’audacia virile” o la natura di un uomo con “la sollecitudine materna.” È la pienezza di Cristo stesso, nel quale “le virtù maschili e femminili sono unite.”

O Dio, nostro Creatore, Tu, che ci hai fatto a Tua immagine, donaci la grazia di essere accolti nel cuore della Tua Chiesa.
R: In un unico accordo, preghiamo.
Gesù, nostro Salvatore, Tu, che hai ricevuto l’amore delle donne e degli uomini, cura ciò che ci divide, e benedici ciò che ci unisce.
R: In un unico accordo, preghiamo.
Spirito Santo, nostro Consolatore, Tu, che guidi il nostro lavoro, provvedi per noi, come noi ti chiediamo di provvedere per il bene di tutti.
R: In un unico accordo, preghiamo.
Maria, madre di Dio, prega per noi. San Giuseppe, resta accanto a noi. Divina Sapienza, illuminaci.
R: In un unico accordo, preghiamo. Amen.
BiBliografia
Anne-Marie Pelletier: Riscoprire Adamo ed Eva
1 Hélène de Saint Aubert, Sexuation, parité et nuptialité dans le second récit de la Création, Genèse 2, (Paris, Editions du Cerf, Lectio divina 282, 2023).
Yamai Beture, O.C.D.: La semplicità di Dio e la ricerca di Dio per noi
1 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics: God and Creation, vol. 2 (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2004), 118.
2 Iain Matthew, The Impact of God: Soundings from St. John of the Cross, (Londra: Hodder & Stoughton, 2010), p. 120.
John Dalla Costa: La ferita originale
1 Edward C. Vacek, S.I., Love Human and Divine, Washington D.C: Georgetown University Press, 1994, 95.
Scott Lewis, S.I.: Adamo redento
1 Anderson, G. A. (2001). The Genesis of Perfection. Adam and Eve in Jewish and Christian Imagination (Louisville, KY, Westminster John Knox) pp.1,8.
2 Bouteneff, P. C. (2008). Beginnings: Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives, Baker Academic. p.28.
3 Bouteneff, Beginnings, p. 29.
4 Bouteneff, Beginnings, p.31.
5 Bouteneff, Beginnings, p. 78; AH 4:37-38.
6 Bouteneff, Beginnings, p. 81.
Joanne Mosley: Figlie di Eva: Edith Stein e la vocazione della donna
1 Quando “Beruf” si riferisce alla “professione,”può anche significare “occupazione” o “commercio.” Oggi “Berufung” è il termine più comune per “vocazione.”
2 Si veda anche Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem (ad esempio MD 7 e 18), scritta nel 1988, l’anno successivo alla beatificazione di Edith Stein.
3 Edith Stein, “Die Bestimmung der Frau” [Il destino della donna], in Die Frau (Friburgo: Herder [ESGA 13], 2000), p. 50; corsivo mio.
4 Waltraud Herbstrith, Edith Stein: A Biography (San Francisco: Ignatius Press, 1985), p. 94.
5 Ibid., p. 183.
Se non diversamente indicato, le citazioni sono tratte da “Edith Stein, Essays on Woman” (Washington, DC: ICS Publications, 1996) pp. 59-60, 61, 257, 78, 82, 47, 53, 264, 51, 239, 56, 200, 239, 54, 84.
Accogliamo i vostri commenti e le vostre riflessioni (o feedback) e considereremo la possibilità di condividerli nelle prossime edizioni o sul nostro sito web.
Se volete contribuire, si prega di inviare a editor@magdalacolloquy.org
Se non siete ancora abbonati, potete farlo in qualsiasi momento gratuitamente grazie al generoso sostegno dei Padri Basiliani della Congregazione di San Basilio.
Basta visitare il nostro sito web www.magdalacolloquy.org dove potrete anche leggere i precedenti numeri della nostra rivista ed essere informati sui nostri progetti e le nostre attività.
La rivista Un unico accordo viene pubblicata in italiano, inglese e francese. Per accedere alle versioni nelle altre lingue si prega di visitare il nostro sito web.
Immagini presenti in questo numero:
Copertina: “Adamo ed Eva” di Lewis G. Vardey, olio e collage di legno 1958.
Pagina 2 Particolare di “Venus Verticordia” di Dante Gabriel Rossetti (1828-1882).
Pagina 3 Particolare di “Adamo ed Eva” di Jan Gossaert (1478-1532).
Pagina 5 Particolare di “Il giardino dell’Eden” di Nicolas Poussin (1594-1665).
Pagina 7 “Adamo ed Eva espulsi dal Paradiso” dal circolo di William Blake (1757-1827).
Pagina 7 “Olmo” di John Constable (1776-1837).
Pagina 8 “Albero solitario” di Caspar David Friedrich (fine del XIX secolo).
Pagina 11 “Adamo ed Eva allontanati dal giardino” (colorati) di Gustav Doré (1832-1883).
Pagina 14 Particolare di “Il giardino dell’Eden” di Jan van Kessel (1626-1679).
Pagina 15 “La Creazione di Adamo,” particolare del soffitto della Cappella Sistina di Michelangelo (1475-1564).
Pagina 20 Particolare di “Scienza e carità” di Pablo Picasso (1881-1973).
In questo numero
Copyright © 2024 Parrocchia di San Basilio, Toronto, Canada. Per contattare la redazione scrivere a: editor@magdalacolloquy.org ISSN 2563-7940
EDITORE
Morgan V. Rice CSB.
CAPOREDATTRICE
Lucinda M. Vardey
REDATTORE ASSOCIATO
Emily VanBerkum
TRADUTTRICE ITALIANA
Elena Buia Rutt
COORDINATORE DI PRODUZIONE
Michael Pirri
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI PROGETTO
Margaret D’Elia