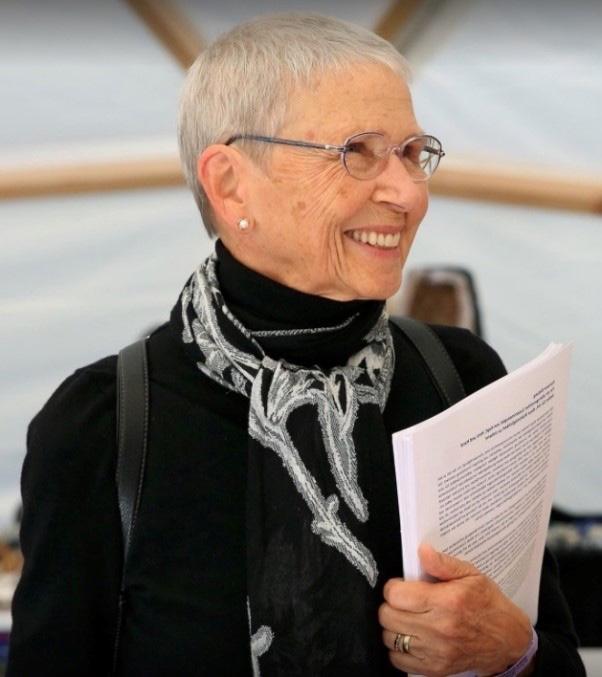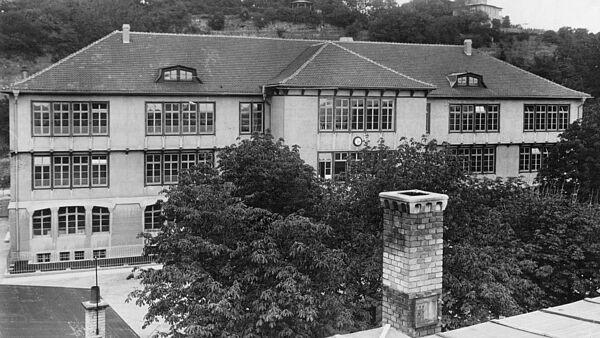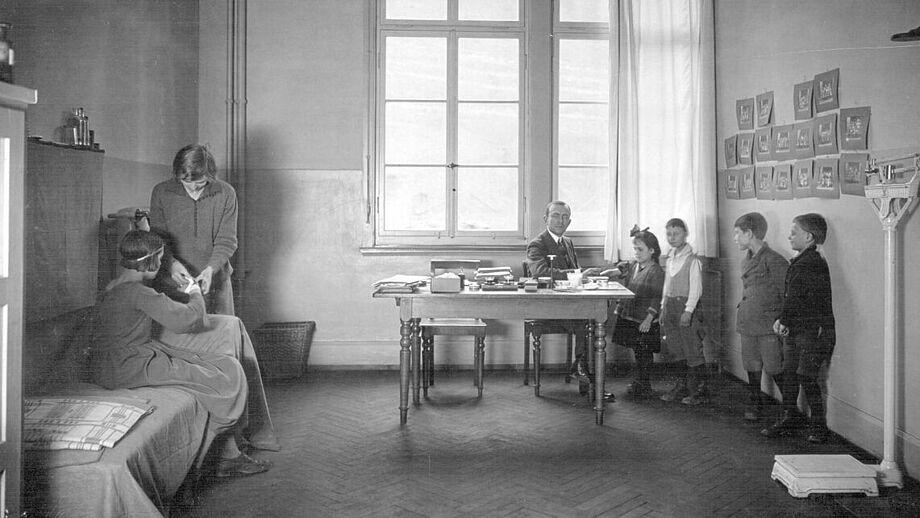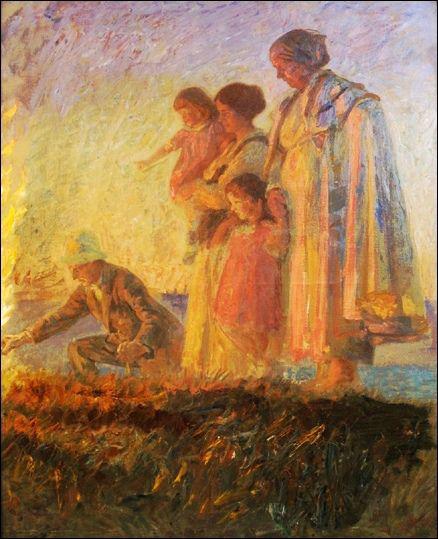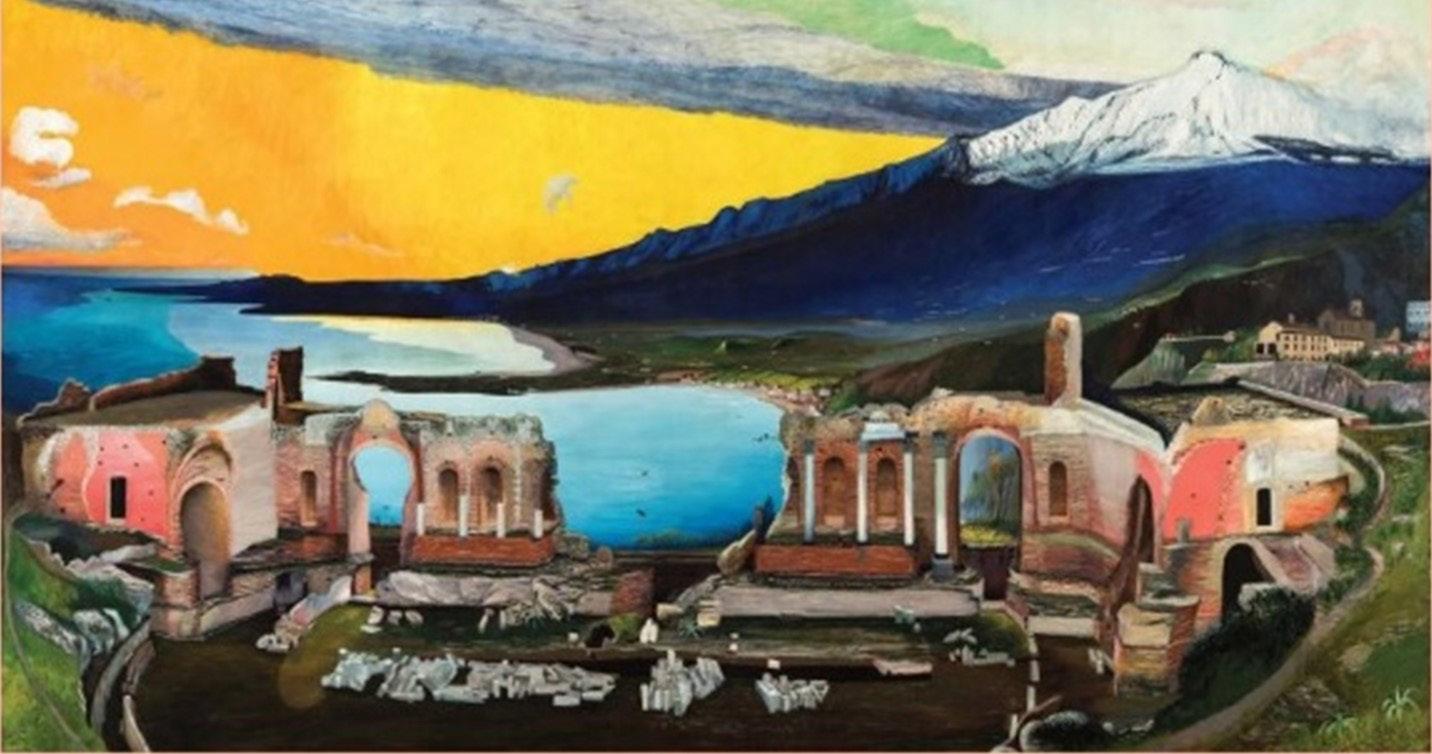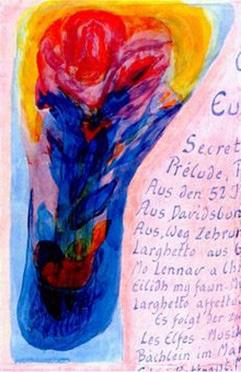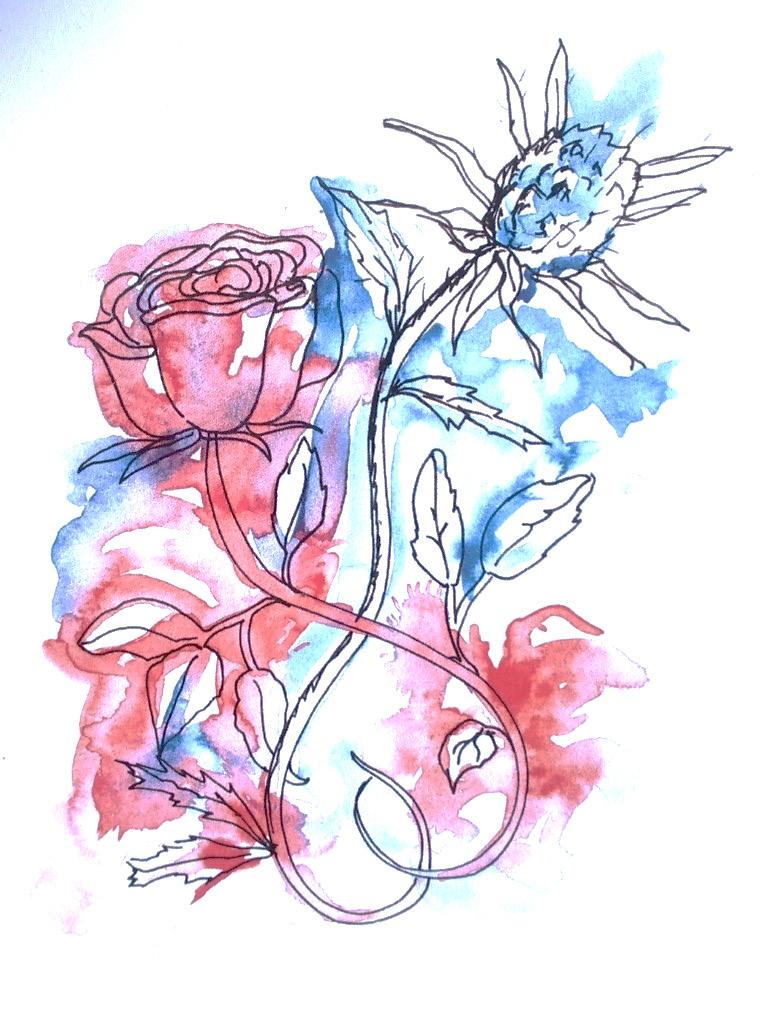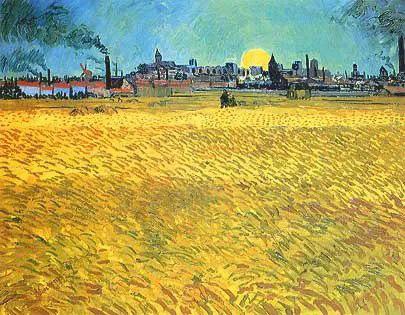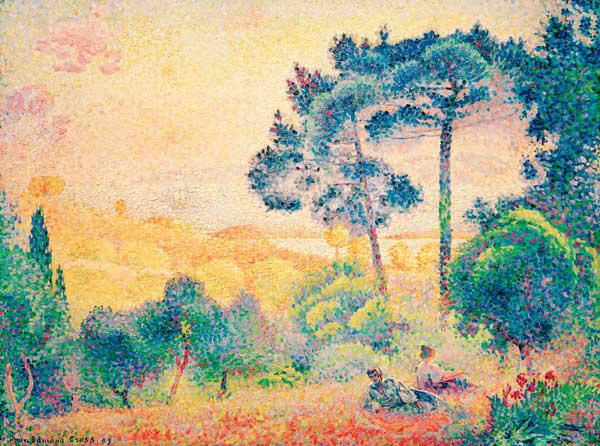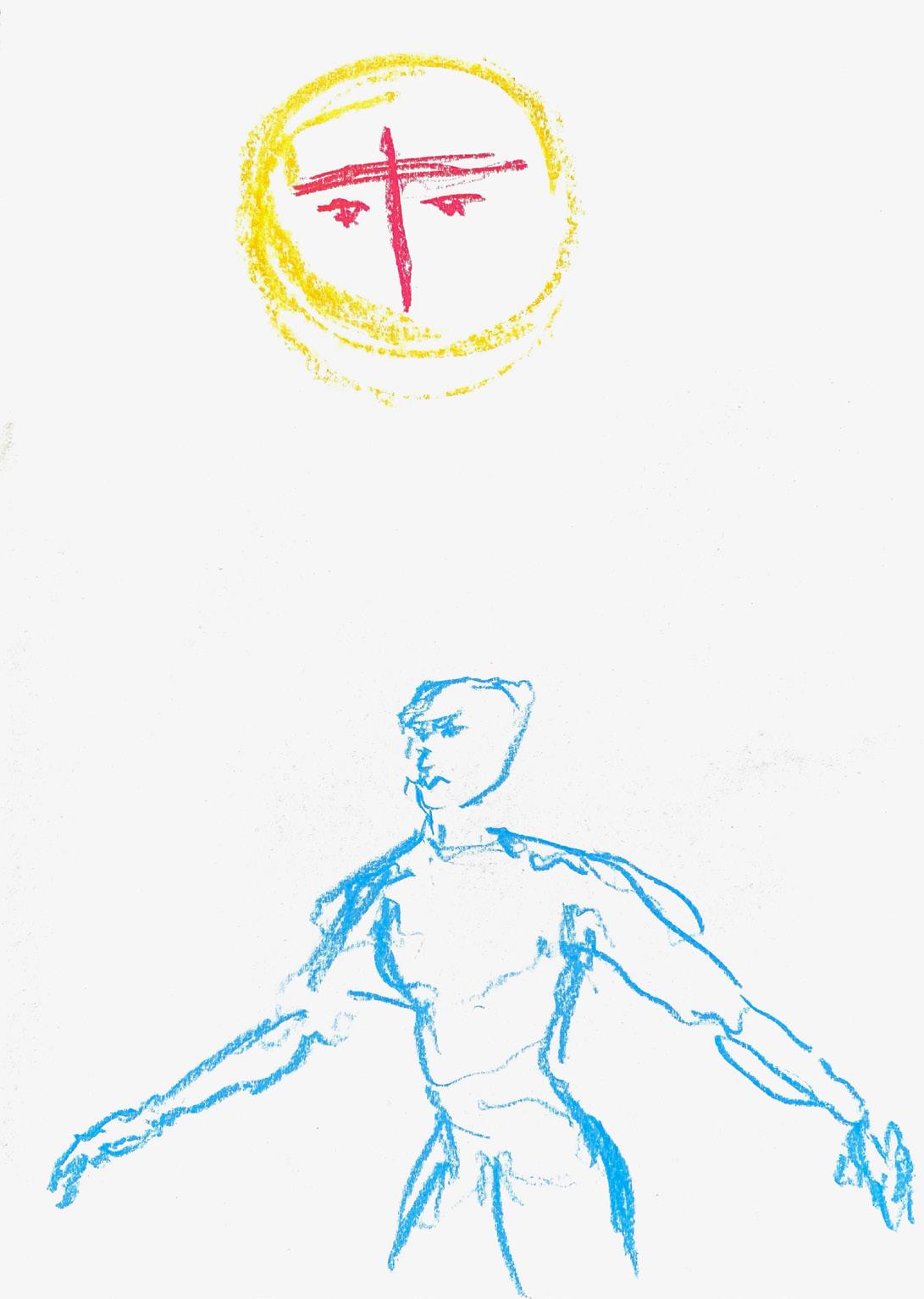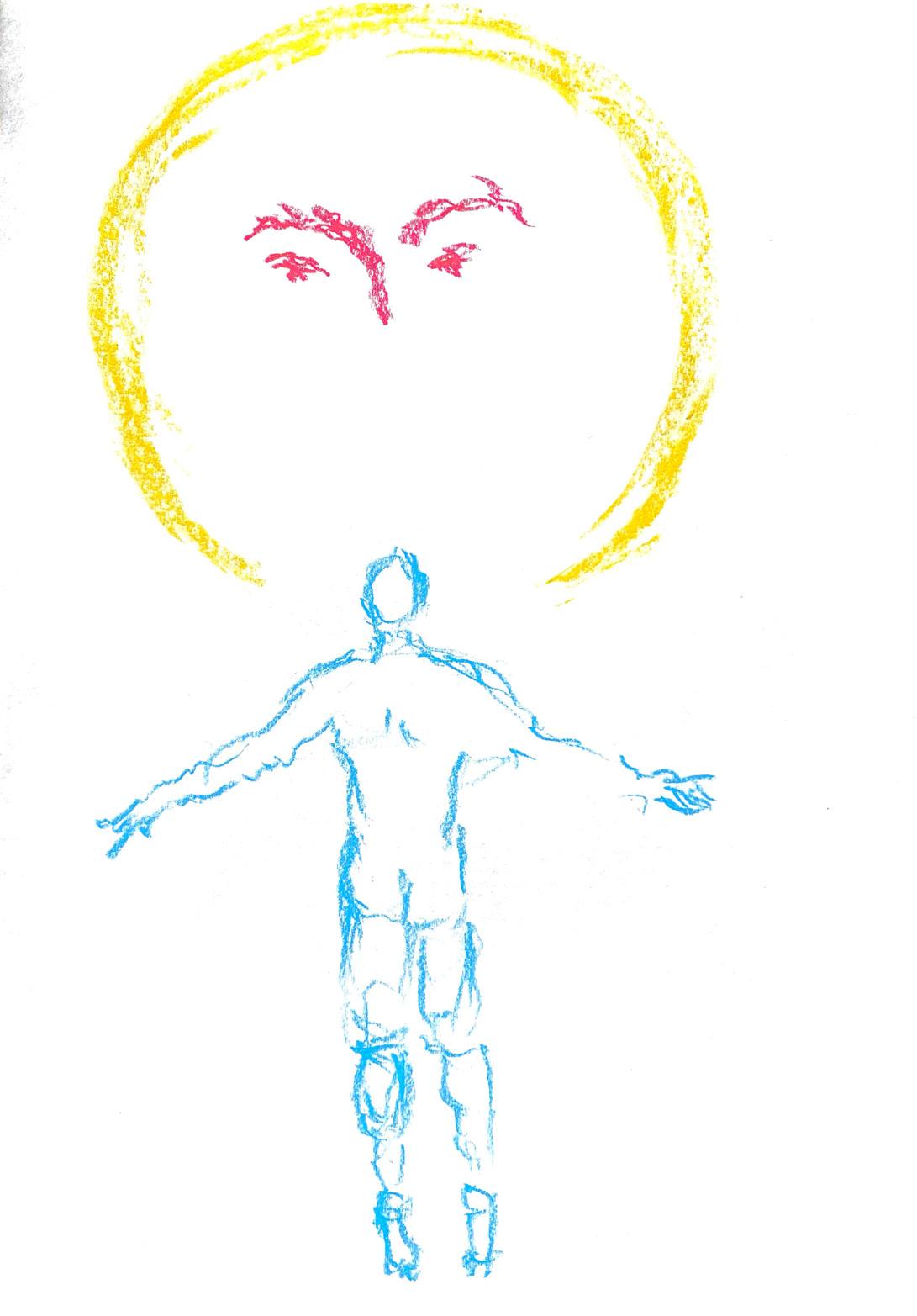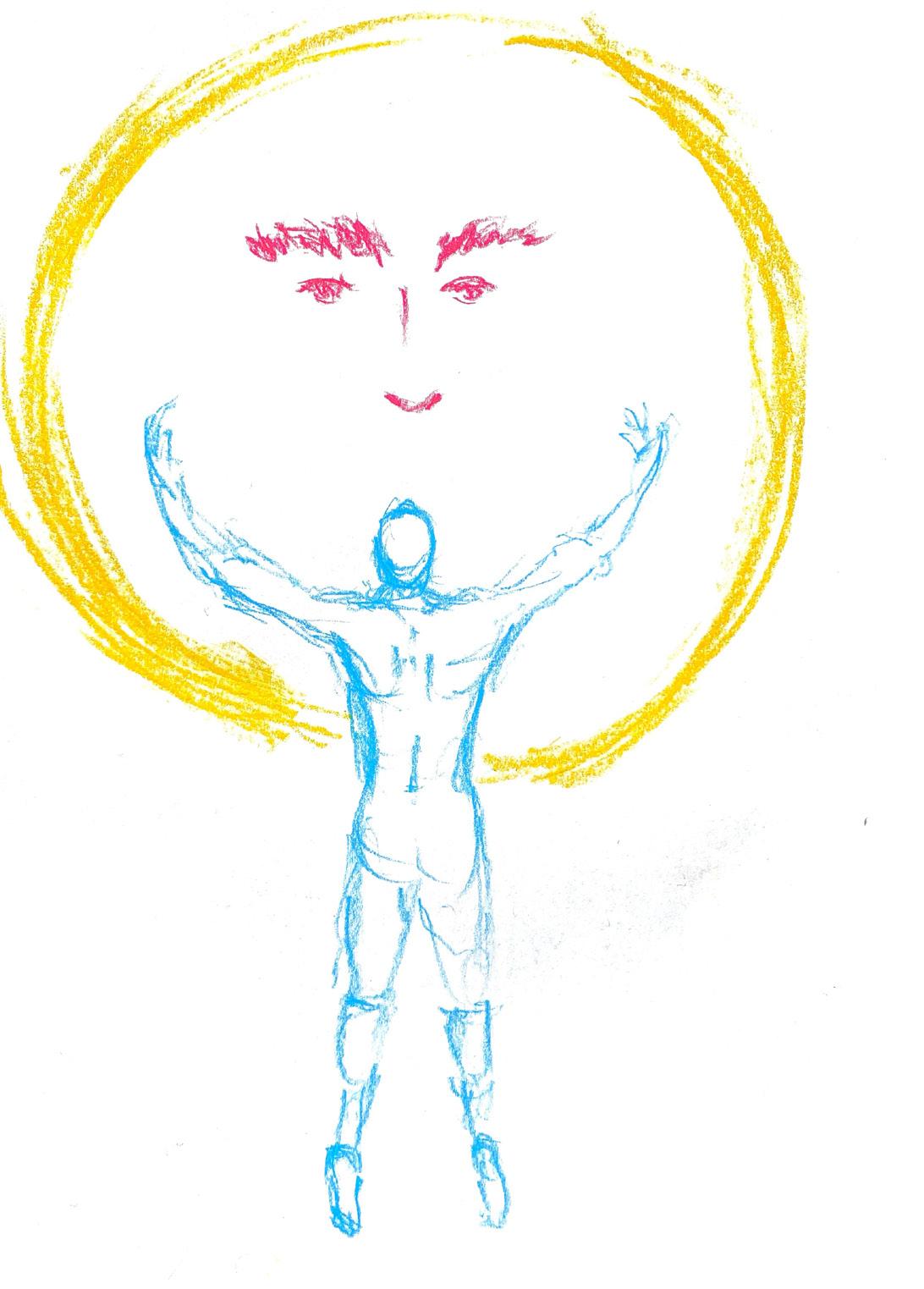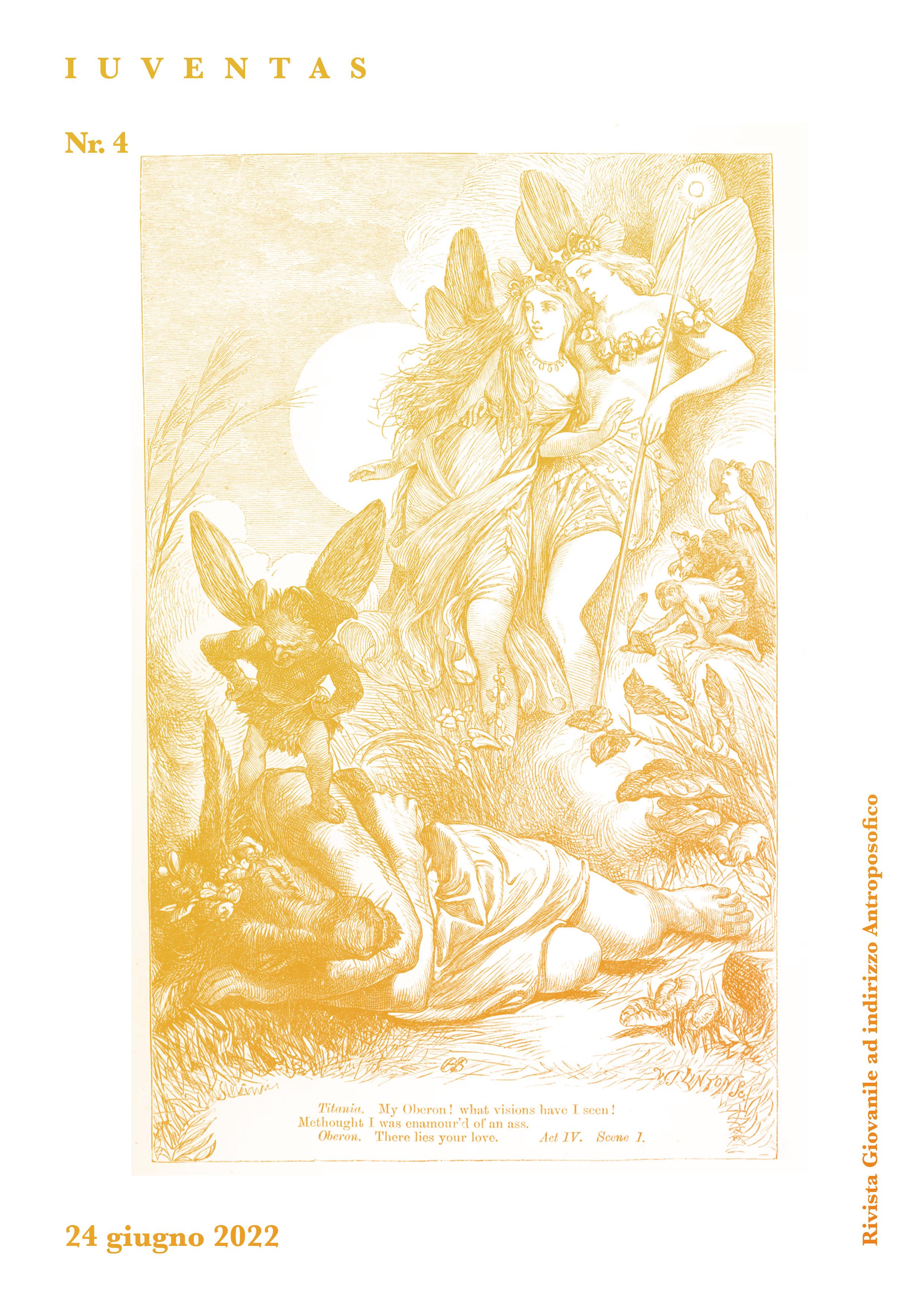
© 2023 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ALL’AUTRICE, KATA SZABADOS
È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata dall’autrice.
Per qualsiasi domanda scrivere alla redazione: iuventasredazione@gmail.com
Impaginazione grafica di Massimo Piutti
Hendi ilma: merkúr
rUdOlF STeiner

SiGillO PlaneTariO di merCUriO
Astra inclinant, non necessitant.
Johannes Kepler
Ideák csillagakrobatája
Diplomaták, orvosok
Nemzetközi űrállomása
Ész, szellemesség planétája, Juttass fényeddel megértést
Sárrá vált, fekete
Földanyánkra!
dalla raccolta di poesie Rózsa óra (L’ora della rosa) di Ilma Hendi (1947-2022), Idahegyi Editore, Genf-Budapest, 2003.
ilma Hendi, merCUriO
Astra inclinant, non necessitant.
Johannes Kepler
Acrobata stellare di idee Stazione spaziale internazionale di diplomatici e medici, Pianeta della mente, dell’arguzia, Fa’ che arrivi, con la tua luce, comprensione Sulla nostra Madre Terra
Divenuta paludosa e nera!
Traduzione della poesia a cura di Kata Szabados
“O saggi che state nel fuoco sacro di Dio Come nel mosaico dorato d’una parete scendete dal sacro fuoco, discendete in una spirale, e siate i maestri di un canto della mia anima.”
W.B. Yeats, da Navigando verso Bisanzio, 1927
Ho questo ricordo molto bello dell’ultimo giorno di scuola, la consegna delle pagelle per tutta la classe: una vera atmosfera di festa, solenne, che animava l’intera comunità scolastica - non solo perché di solito coincideva con il giorno di San Giovanni. Rivedo l’immagine dei bambini, tutti in vestiti bianchi, seduti sul prato come delle piccole fate, a ricevere la loro poesia, scritta dalla maestra di classe: il primo incontro con la poesia che poi si recitava ogni settimana nel giorno in cui si è nati, era un momento assai importante, accompagnato dalla commozione dei genitori. Ma il momento altrettanto atteso è arrivato dopo: il salto del fuoco, il grande falò appena acceso!
E’ interessante osservare come nelle varie tradizioni popolari collegate a San Giovanni, tutti gli elementi siano presenti e siano parte fondamentale delle usanze: fuoco e aria, acqua, ma anche terra, con le sue piante, fiori.

Questa nuova edizione estiva di Iuventas, con tutto il processo di creazione, per i temi e forme che presenta, credo rispecchi in modo fedele il periodo dell’anno in cui siamo un po’ tutti immersi e forse anche dispersi. Tanta poesia, accompagnata da pittura da accesi colori estivi, con rimandi letterari, lo studio sull’ osservazione della natura goetheanistica, immagini e storie di fiori popolano le seguenti pagine.
Sono particolarmente contenta di poter dare in mano al lettore anche un’intervista con la dottoressa Glöckler, realizzata appositamente per questo numero di San Giovanni e tradotta in italiano, ricca di contenuti, toccando anche temi più caldi e molto attuali, con risposte dal tono a volte veramente personale.
Vorrei richiamare alcuni pensieri che Rudolf Steiner condivide nelle conferenze de Il corso dell’anno come respiro della Terra e le quattro grandi festività, parlando delle caratteristiche della festa di Giovanni. Credo siano immagini che aiutano ad avvicinarci all’essenza di questo tempo dell’anno e forse di tutta l’estate,
ma anche a comprendere meglio certe nostre abitudini e atteggiamenti animici tipici del periodo estivo.
“Tutto l’elemento animico della Terra si è riversato nello spazio cosmico, gli si è donato, e si compenetra con la forza del Sole, con la forza delle stelle. Il Cristo, che è legato all’elemento animico della Terra, unisce pure la propria forza con le forze del Sole e delle stelle che ora fluiscono nell’elemento animico della Terra donatasi al tutto cosmico. E’ il tempo di San Giovanni. La Terra ha tutto espirato , e nella fisionomia esteriore, nella superficie con cui si rivolge all’universo, non mostra la forza propria, come la mostrava in sé nel solstizio d’inverno, ma la forza riflettente del Sole, delle stelle e di tutto ciò che nel cosmo le è esterno.
Soprattutto nel nord dell’Europa gli antichi iniziati sentivano con vivezza l’intimo sigificato e lo spirito di giugno. Sentivano la loro anima dedita alle ampiezze cosmiche insieme all’anima della Terra; si sentivano vivere non nella sfera della Terra, ma nelle lontananze cosmiche.” (pp. 17-18)
“Così, attraverso lo svolgimento della festa di Giovanni, a coloro che vi prendevano parte si illuminava la coscienza dell’io appunto nel periodo della piena estate. Nello stesso periodo gli uomini potevano arrivare a percepire la sfera minerale, almeno fino al punto da avere, grazie a quella percezione, una specie di coscienza dell’io, comunque in modo che l’io apparisse giungere nei sogni da fuori. Per ottenere tutto ciò, in quelle antichissime feste estive, nelle feste del solstizio estivo divenute poi per noi la festa di San Giovanni, veniva introdotto anche un elemento poetico-musicale accompagnato da canti e da danze in cerchio ben ritmate. In certe rappresentazioni vi erano particolari recitativi musicali, accompagnati da strumenti primitivi. Questa festa era immersa nell’elemento poetico-musicale. Era come se gli uomini facessero fluire il contenuto della loro coscienza sognante nel cosmo, fra musica, canti e danze. [...]
4 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023 INTRODUZIONE
Tutto era teso a che gli uomini, mentre facevano i loro girotondi con i loro canti primitivi e poetici, entrassero in un’atmosfera nella quale appunto avvenisse quel che prima ho detto: l’illuminarsi dell’io nella sfera umana. Se agli antichi che guidavano quelle feste fosse stato chiesto come in effetti si formassero quei canti e quelle danze, grazie alle quali nasceva quel che ho descritto, avrebbero di nuovo dato una risposta paradossale per l’uomo moderno. [...] ” Lo si impara da canto degli uccelli”. In senso profondo avevano appunto compreso tutto il significato del canto degli uccelli.
Da molto tempo l’umanità ha dimenticato perché gli uccelli cantano. Nel tempo in cui l’intelletto domina tutto, in cui gli uomini sono diventati intellettuali, essi hanno sì conservato l’arte del canto e della poesia, ma con l’intellettualismo hanno dimenticato il nesso del canto con tutto l’universo. [...]
Avviene dunque che gli usignoli e le allodole inviino le loro voci nel cosmo, e che ciò che da loro è stato inviato ritorni a loro etericamente in uno stato che non è più canto, ma contenuto permeato dall’elemento divino-spirituale. Le allodole inviano il loro canto nel cosmo, e la sfera divinospirituale che partecipa alla formazione e alla strutturazione del mondo animale, fluisce di nuovo sulla Terra sulle onde di ciò che ritorna dal canto inviato fuori nel cosmo dalle allodole e dagli usignoli. [...] Si dovrebbe dire: “Io canto come l’uccello che dimora in mezzo ai rami. Il canto che irrompe dalla gola nelle lontananze cosmiche ritorna come benedizione della Terra, fecondando la vita terrestre con gli impulsi divinospirituali che poi continuano a operare nel mondo degli uccelli della Terra, e che vi possono operare solo perché trovano la via sulle onde del canto a loro inviato nel cosmo”. [...]
In quelle feste vi era anche dell’altro: non soltanto danza, musica e canto, ma anche successivamente un attento ascolto. Prima le feste si svolgevano attivamente, poi i partecipanti venivano spinti ad ascoltare quel che tornava loro incontro. Avevano inviato grandi domande al cosmo divino-spirituale con le loro danze, con i loro canti e con le loro poesie. In un certo senso tutto ciò era salito alle ampiezze del cosmo, come vi sale l’acqua a formare le nuvole per gocciolare poi in forma di pioggia. Si elevavano così gli effetti delle festività umane e ora ritornavano, naturalmente non come pioggia, ma come qualcosa che si manifestava agli uomini come potenza dell’io. Essi avevano così un senso sottile per la particolare trasformazione che avveniva appunto attorno alla festività di San Giovanni, con l’aria e il calore attorno alla Terra. [...]
Gli uomini avevano un senso sottile per tutto ciò che si sviluppava con le piante, che viveva in esse. [...] Quelle feste avevano un magnifico, intimo contenuto umano. Erano una domanda inviata all’universo divino-spirituale. Si aveva la risposta perché, come si sentiva il “profumo di verde”, il fiorire e il maturare della Terra, così si sentiva anche scendere dall’alto qualcosa di vegetale nell’aria, altrimenti solo minerale. Così nel sogno dell’esistenza, in quell’antica coscienza sognante, entrò anche il sogno dell’io.
Passata la festa di San Giovanni, quando ritornavano il luglio e l’agosto, gli uomini avevano il sentimento: ora abbiamo
un io che però rimane in cielo, in alto, e parla a noi soltanto nel tempo di San Giovanni. Allora sappiamo però di essere collegati con il cielo, che protegge il nostro io. Il cielo ci mostra l’io, quando si apre la grande finestra celeste; lo mostra al tempo di San Giovanni! Dobbiamo però pregare affinché ciò avvenga organizzando le feste del tempo di San Giovanni, in quelle feste ci si ritrovi in quell’incredibile e intima comunione di musica e di poesia. Così quelle antiche festività servivano a stabilire una comunicazione, un legame fra sfera terrestre e quella celeste. “ (pp. 56-61)
Con il quarto numero di Iuventas stiamo concludendo questo suo primo anno di vita, augurandoci che possa continuare ad essere anche nel futuro. Per questo ci rivolgiamo ad ogni lettore con una richiesta: vi chiediamo di comunicare alla Redazione il vostro eventuale interesse per seguire le future uscite della rivista, speriamo cartacea, e se foste interessati ad averla in quel modo (che richiederebbe anche un costo per poter sostenere i costi di stampa e di spedizione). Per il nostro lavoro futuro sarebbe fondamentale capire quanto esiste un coinvolgimento dalla parte dei lettori e saremo grati per qualunque conferma.

Desidero ringraziare anche questa volta tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del presente numero con i loro aiuti, idee, suggerimenti, contributi e collaborazione!
Augurando una buona estate, senza mai dimenticarci di quella massima che negli antichi misteri venne data ai discepoli per il colmo dell’estate: “Ricevi la luce”!
Buona lettura.
5
Kata Szabados, San Giovanni 2023
1 - Johannes - Stimmung /Atmosfera di San Giovanni di Rudolf Steiner, 1924 tratto dal Calendario dell’anima
2 - L’impulso dell’Antroposofia, tra presente, passato e futuro Intervista a Michaela Glöckler, di Kata Szabados, giugno 2023
3 - “Da Atene... via Solare” di Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919)
pg. 8
pg. 9
pg. 18
4 - Qual’è il ruolo degli Ostacolatori nel nostro tempo? Lo sguardo che apre la volta del cielo di Yarince Vicenzo, marzo 2023 pg. 20
5 - Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, traduz. di Antonio Calenda e Giorgio Melchiori
6 - Faust: Una tragedia I-II. di Johann Wolfgang von Goethe, 1808 /1832
7 - La scienza organica di Goethe conferenza e testo di Elio Biagini, 2005
8 - Nyár /Estate di Lőrinc Szabó
9 - „Von Rosen und Disteln“
Ein Märchen von Johannes Rosenstock, 2021
10 - Sommerabend /Sera d’Estate di Rainer Maria Rilke
11 - Agosto di Adam Bittleston/Traduzione Elio Biagini, 1993/2019
IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
pg. 25
pg. 28
pg. 30
pg. 38
pg. 39
pg. 44
pg. 45
INDICE
 Acquerello di Kaspar Hauser, 1830
Acquerello di Kaspar Hauser, 1830
12 Der Welten Schönheitsglanz
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden; Mich selber zu verlassen, Vertrauend nur mich suchend In Weltenlicht und Weltenwärme.
12 La bellezza splendente dei mondi
Mi costringe dal profondo dell’anima
A liberare le forze divine della mia propria vita Per il volo nei mondi; Ad abbandonare me stesso, Soltanto cercandomi fidente Nella luce dei mondi e nel calore dei mondi.
Antroposofischer Seelenkalender – Calendario dell’anima di Rudolf Steiner (traduzione in italiano di Kaspar Appenzeller)

8 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
Johannes-Stimmung (24. Juni) ESTATE Atmosfera di San Giovanni
SOMMER
Rudolf Steiner, Immaginazione di San Giovanni, pastello, 1923
In questa intervista* per San Giovanni abbiamo posto qualche domanda alla dottoressa Michaela Glöckler, subito disponibile e disposta a rispondere, nonostante i suoi numerosi impegni - e le nostre numerose domande.
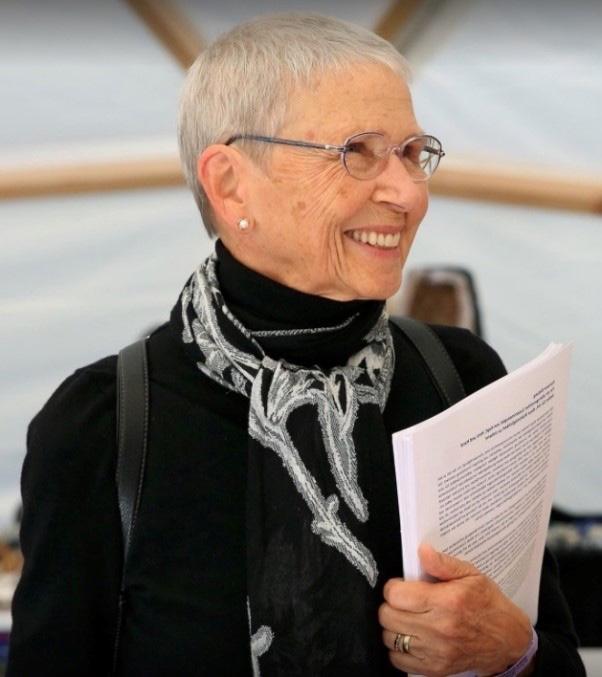
Come e quando ha conosciuto l’antroposofia?
Nata a Stoccarda nel 1946, studia Medicina all’Università di Tübingen e Marburg, si specializza in Pediatria all’Ospedale di Herdecke. Per vari anni è attiva come medico scolastico alla Scuola Rudolf Steiner di Witten. Dal 1988 al 2016 ha assunto la direzione della Sezione Medica della Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum. Autrice di numerosi libri e scritti medico-pedagogici, è fondatrice e presidente di ELIANT Attualmente è docente ospite di vari seminari di formazione steineriana e relatrice di conferenze.
Alla casa paterna, grazie alla mia famiglia. Mia nonna si avvicinò all’antroposofia dopo la prima guerra mondiale e sentì Rudolf Steiner a Berlino. Poiché suo marito era caduto in guerra, si trasferì a Stoccarda con le due figlie affinché potessero frequentare la scuola Waldorf. Dopo aver terminato le scuole superiori tornarono a Berlino per proseguire gli studi, dove mia madre poi conobbe mio padre. Si sposarono durante la seconda guerra mondiale, alla quale mio padre, giornalista, partecipò come corrispondente di guerra. Dopo la fine della guerra, cercò un nuovo incarico, divenne insegnante Waldorf a Stoccarda e fu attivo nella rinascita del lavoro antroposofico che fu vietato dal regime nazionalsocialista. Di conseguenza, sono cresciuta con quattro sorelle in una casa antroposofica, il che naturalmente non significa che poi si diventi antroposofi.
9
*
l’imPUlSO dell’anTrOPOSOFia Tra PaSSaTO, PreSenTe e FUTUrO inTerviSTa a miCHaela GlöCkler di Kata
2023
Szabados, giugno
Michaela Glöckler nel 2019 , alla celebrazione centenaria della Pedagogia Waldorf a Berlino
Le è sempre stato chiaro, ha sempre sentito che questa era la sua strada?
Ho avuto un’infanzia meravigliosa e i momenti culminanti dell’anno erano le festività cristiane. In questo senso, la domanda sulla realtà del cristianesimo è diventata centrale per me, man mano che crescevo. E a questo si collega la questione del male. Perché un Dio si incarna volontariamente come uomo, per poi morire sulla croce a seguito di violenza e martirio? Cosa significa un Dio “impotente”? Perché Dio permette una cosa come il terrore nazista tra gli esseri umani?
A volte tutto questo mi rubava il sonno e ricordo ancora esattamente come una notte, quando avevo 15 o 16 anni, ebbi l’idea di intrufolarmi nello studio di mio padre per vedere se avesse qualche libro su questo argomento. Sulla sua scrivania c’era infatti un’unica conferenza di Rudolf Steiner intitolata “Christus und die widerstrebenden Mächte – Luzifer, Ahriman, Asuras”1. Mi sedetti a leggere questa conferenza e questo fu il mio primo incontro con l’antroposofia. Ero indicibilmente sollevato dal fatto che ci fosse una persona, Rudolf Steiner, in grado di dare informazioni chiare sul Cristo e sulle potenze demoniache e che l’essere umano deve decidere quali potenze vuole seguire. E che l’enigma del male è il lato oscuro della libertà e dell’amore. Naturalmente, all’epoca non potevo capire tutto quello che leggevo lì. Ma ricordo ancora bene come improvvisamente sentii una pace profonda nel mio cuore, perché apparentemente era possibile conoscere e capire quello che per me erano i grandi enigmi. E speravo che “da grande” l’ avrei capito anche io. Una mia compagna di classe più grande mi diede allora l’ottuplice sentiero del Buddha nella descrizione di Rudolf Steiner (gli esercizi per lo sviluppo del “fiore di loto a sedici petali” in Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? 2) e questi furono i primi esercizi che provai a fare. Qualche anno dopo ho iniziato a leggere anche il libro Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? Gli esercizi di calma interiore, di retrospettiva e del coltivare degli ideali descritti nel primo capitolo divennero poi l’orientamento di base per la mia condotta di vita.
Come è presente l’antroposofia nella sua quotidianità?
La mia vita quotidiana a scuola, all’università e al lavoro è sempre stata segnata da domande concrete sulla vita, sul destino e sullo sviluppo. Sono estremamente grata di essere sempre stata in grado di darmi la risposta a queste domande attraverso lo studio dei fondamentali scritti antroposofici e grazie a tante conferenze, nella misura necessaria per mantenere o recuperare la mia gioia di vivere - e per aiutare gli altri in questo.
Ha trovato i suoi maestri spirituali, il suo percorso è stato difficile?
All’inizio del mio 24° anno ho avuto una vera e propria crisi e improvvisamente non ero più sicura se l’antroposofia fosse davvero la mia strada o se dovessi orientarmi diversamente. In qualche modo mi sentivo mancare il terreno sotto i
piedi e, per di più, in vista dell’imminente esame di stato in germanistica e storia - la mia prima laurea con l’obiettivo di diventare insegnante Waldorf - mi sentivo stressata e anche sopraffatta dall’abbondanza di fatti che dovevo affrontare. Mi sarebbe piaciuto avere qualcuno con cui discutere di questa mia situazione. Ma non c’era nessuno che fosse disponibile per questo. Così ho preso in mano il libro Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? e ho voluto leggerlo con la domanda: è davvero questa la mia strada o meno? Se sì, allora questa strada deve aiutarmi anche questa volta. Come prima cosa, ho letto l’indice e ho scoperto che c’era un epilogo che non avevo ancora letto. Quindi l’ho letto subito. Lì Rudolf Steiner parla di quanto sia difficile, al giorno d’oggi, trovare un maestro spirituale adeguato. In questa situazione, si potrebbe anche considerare questo libro come una conversazione tra l’autore e il lettore. Questa frase mi ha toccato profondamente e ho subito provato a fralo, cercando di descrivere al meglio le mie crisi e le mie domande, nella speranza di ottenere risposte a queste domande durante la lettura del libro. Ed è esattamente quello che è successo. Le singole frasi e soprattutto il primo e il quinto capitolo del libro mi hanno parlato con forza e mi hanno mostrato chiaramente, dove mi trovo e dove non mi trovo sul mio cammino e che non ha alcun senso spingersi in alcun modo. Che è molto più importante essere completamente onesti con se stessi e andare avanti a partire dal punto in cui ci si trova al momento. Che è importante fare ciò che è possibile e non impantanarsi nell’impossibile. Così ho affrontato allora anche i miei esami in modo più “sportivo” e giocoso e mi sono detta che ora mi sarei concentrata sui temi con cui posso instaurare un legame e che mi danno gioia, e che avrei atteso cosa succedeva. In questo periodo, però, è anche maturata la mia decisione di studiare medicina. Anche l’incertezza sul fatto che la professione di insegnante e la scelta di quelle materie fossero davvero adatte a me aveva contribuito alla crisi. È interessante notare che, davvero sorprendentemente, mi sono laureata con il massimo dei voti in entrambe le materie e ho avuto la fortuna di ricevere una borsa di studio dalla Fondazione accademica nazionale tedesca3 per i miei studi di medicina. Si tratta della borsa di studio meglio retribuita, quindi da quel momento in poi ho potuto vivere e studiare senza problemi finanziari. Oltre a questa prova personale, però, per ottenerla avevo bisogno anche di due esperti accademici con i quali dovevo sostenere un colloquio. E qui devo proprio all’antroposofia il fatto di aver ottenuto una buona raccomandazione da entrambi gli studiosi (uno di genetica umana e uno di microbiologia, le materie dei quali io non conoscevo) e di essere stata accettata per l’intero corso di studio. Peché nella mia domanda di ammissione avevo elencato tra gli hobby tutte le mie attività antroposofiche e i gruppi di studio. In realtà avevo pensato che questo potesse essere un ostacolo alla procedura, ma decisi di farlo comunque perché era vero. E con mio grande stupore, entrambi i professori universitari mi fecero la stessa domanda: come può una persona che ha una formazione accademica e ha superato bene un esame, essere appassionata di una cosa così folle come l’antroposofia? E si vede ero che in grado di rendere la cosa plausibile, poiché entrambi i docenti mi hanno raccomandata per il finanziamento...
10 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
Quali sono state le letture (non solo antroposofiche) più influenti nella sua vita?
Nella mia gioventù le sono state le opere di Richard Wagner, che hanno avuto una forte influenza sul mio sviluppo dell’anima, perché tutte le grandi emozioni e moti dell’animo sono per così dire rappresentati sul palcoscenico e ti sfidano a confrontarti con essi: nella tetralogia “L’anello del Nibelungo” è il conflitto tra potere e amore, le emozioni dell’invidia, dell’odio, della violenza, della costrizione, la lotta per la libertà e la dignità; in “Lohengrin” e “Parzival” l’anelito alla redenzione, al Graal, al divino e ai misteri del cristianesimo; in “Tristan und Isolde” la dinamica della libertà e dell’amore; in “Tannhäuser” l’essenza dell’amicizia; nell’”Olandese volante” il sacrificio, la dannazione e la redenzione; e nei “Meistersingern” l’amore per la musica e le persone. In generale, andavo spesso all’opera e a teatro perché c’erano biglietti per studenti estremamente economici per gli spettacoli. Ho anche guadagnato la mia prima paghetta al teatro, dove aiutavamo a costruire le scenografie e a dipingere le brochure su ordine dello scenografo. In cambio, ricevevamo anche biglietti gratuiti “come dipendenti” per gli spettacoli che non erano ancora esauriti. Mi interessavano anche poeti come Goethe, Schiller, Hölderlin e i grandi filosofi. La letteratura contemporanea mi interessava, ma non mi coinvolgeva più di tanto. Ma le pubblicazioni sul nazionalsocialismo e il romanzo 1984 di Orwell sì, perché questi argomenti erano direttamente collegati alle mie questioni vitali.
risposta.
Come vede il futuro del movimento antroposofico tra 10, 20, 50 anni? Quali sono le sfide più grandi e le necessità più urgenti?
Ora che negli ultimi anni abbiamo festeggiato molti 100° anniversari e che mancano solo due anni di giubileo - 1924 e 25 - mi sembra che la sfida più grande sia quella di rinnovare l’impulso antroposofico afferrandolo con maggiore autonomia e autenticità. Se ci riusciremo, tra 50 anni il movimento antroposofico potrà diventare un movimento culturale che irradia ed è di portata ancora maggiore di quanto sia stato possibile finora. Che cos’è, infine, l’antroposofia? La conoscenza di sé, cioè del corpo, dell’anima e dello spirito, e una comprensione dell’essere umano e del mondo che affonda le sue radici in questa consapevolezza. Per questo riesce a parlare a persone di ogni colore della pelle, cultura e tradizione religiosa, perché si tratta ovunque di come la vita possa diventare più umana, più serena e ricca di pace interiore e più sensata. Ed è proprio qui che l’antroposofia può aiutare a tutti i livelli. Tuttavia, uno sviluppo così positivo è sempre ostacolato quando questa conoscenza di sé viene meno, l’interesse e la comprensione per gli altri ne risentono e si diventa sostenitori di opinioni o dogmi. Naturalmente, contro ciò urtano anche coloro che non conoscono l’antroposofia, con la relativa risonanza nei media.
Forse Lei ha conosciuto antroposofi che avevano ancora conosciuto personalmente Rudolf Steiner, che erano suoi allievi. Può parlarci un po’ di queste personalità? Cosa ha imparato da loro?
Queste persone sono state dei modelli per me: Herbert Hahn, Ernst Lehrs, Kurt von Westinghausen, Rudolf Frieling, Friedrich Hiebel e altri. Avevano in comune il fatto che si aveva l’impressione: sono persone buone. Con loro, ci si poteva sentire - come diremmo oggi - considerati alla pari, da uomo a uomo, per così dire. Herbert Hahn, uno dei primi insegnanti Waldorf, ci ha insegnato religione dalla prima alla dodicesima classe alla Scuola Waldorf di Stoccarda. Sapeva raccontare meravigliosamente. E ogni anno, nel periodo dell’Avvento, non vedevamo l’ora di sentire la sua storia del cassettino d’oro 4. Si tratta di una storia di iniziazione sotto forma di fiaba che lui raccontava ogni anno in modo nuovo affinché fosse adatta alla nostra età del momento. Rudolf Frieling, il terzo Erzoberlenker della Comunità dei Cristiani dopo Emil Bock e Friedrich Rittelmeyer, mi ha colpito per la sua ineffabile modestia, obiettività e profonda umanità. Quando ascoltavi una sua conferenza o quando celebrava l’Atto di Consacrazione dell’Uomo, ti sentivi in qualche modo connesso alla realtà dello spirito. E si sentiva in tutte queste persone la grande gratitudine e il legame interiore con Rudolf Steiner - senza però che uno avesse l’impressione di vedere un seguace. Quello che dicevano era autentico e impregnato di individuale - non si sentivano troppe citazioni o l’esposizione di conoscenze antroposofiche. Tutto nasceva organicamente nel dialogo e dove non c’era domanda non è arrivata neanche
Come vede il ruolo e il compito dei giovani?
I giovani hanno sempre il compito, prima di tutto, di diventare figli del loro tempo e di trovare il loro posto in esso, cioè di trovare se stessi. L’antroposofia può aiutare in modi molto diversi e diventare la base per amicizie che durano tutta la vita, per la creazione di nuovi rapporti di lavoro e per iniziative e forme di costruzione di comunità. All’interno del movimento antroposofico esiste infatti una Sezione giovanile che ha il suo centro al Goetheanum nella Libera Università di Scienza dello Spirito. Essa può essere fondata e formata in ogni paese e in ogni città dagli stessi giovani direttamente sul luogo, come una piccola sottosezione, per così dire. Gazie ai social media, possono crearsi reti internazionali di giovani che si impegnano e del loro lavoro possono poi nascere connessioni, che possono di seguito irradiare positivamente anche le forme di vita e di lavoro della Società Antroposofica.
E la responsabilità della generazione più anziana? Come si può colmare il divario tra le generazioni?
Dove c’è un buco tra le generazioni, può essere chiuso soltanto con l’interesse reciproco o con la proposta di fare attività comuni. Perché fondamentalmente l’antroposofia è completamente indipendente dall’età – è un bene spirituale che cura soprattutto il rapporto con il prossimo e promuove l’interesse per lo sviluppo. In altre parole, più ci si confronta in modo
11
antroposofico, meno il cosiddetto conflitto generazionale gioca un ruolo. Quando ero studentessa a Friburgo, c’erano diversi gruppi antroposofici5 che lavoravano in modo strettamente separato l’uno dall’altro e i cui membri per la maggior parte non si conoscevano personalmente. A quel tempo volevamo fondare un gruppo studentesco antroposofico e la nostra prima iniziativa fu quella di invitare tutti i Zweige a venire a parlarci del loro lavoro. L’iniziativa ebbe un tale successo e divenne una celebrazione così calorosa dell’ incontro e della gioia che da allora in poi decidemmo di celebrare le grandi feste annuali sotto forma di eventi organizzati insieme. L’iniziativa e le buone idee sono, per così dire, le forze motrici del movimento antroposofico, attraverso le quali esso può diffondersi in modo benefico in ogni contesto di vita. Tuttavia, ciò richiede anche la tecnica morale6 e la conoscenza degli istinti antisociali7 in modo da non essere attivi dove questo non è desiderato, ecc. – questo significa che senza osservare le regole di base del cammino di conoscenze antroposofico in realtà non si può essere veramente efficaci per l’antroposofia.
Secondo Lei, qual è la ragione per cui solo una piccola percentuale del pubblico di un evento antroposofico medio è composta da ventenni o trentenni? Cosa manca?
A vent’anni e a trenta’anni si è spesso molto impegnati con gli studi, la vita di coppia e la carriera professionale. Se uno non ha già portato con se gli interessi spirituali fin da giovane, non è così facile svilupparli a quest’età. D’altra parte, ho visto durante il mio periodo all’ospedale comunitario di Herdecke che le persone proprio di questa età - spesso giovani genitoriaccorrono alle conferenze e bisogna prenotare sale sempre più grandi per le conferenze quando uno sceglie i temi tenendo conto delle domande delle persone. A questa età, le persone hanno molte preoccupazioni e molte domande: se ci si interessa
di questo e se ne parla, anche la generazione più giovane verrà. Il mio collega pediatra Wolfgang Göbel e io abbiamo tenuto per oltre 15 anni una volta al mese una serata pubblica aperta ai genitori, durante la quale i genitori hanno sempre decico in modo democratico il tema della serata successiva. Io dovevo fare l’introduzione e Wolfgang Göbel conduceva la discussione successiva e dava le risposte essenziali. Ma come è nata l’iniziativa? Come giovane medico assistente, soffrivo del fatto che nella routine quotidiana dell’orario di visita non avevo abbastanza tempo per rispondere alle domande dei genitori. Inoltre, se passavi troppo tempo con un bambino, la sala d’attesa si riempiva e avevi un problema anche lì. Ne ho parlato con la nostra infermiera dell’ambulatorio pediatrico e con il nostro capo, Wolfgang Göbel. Lui ha suggerito di affiggere un avviso nella sala d’attesa e di invitare i genitori a una serata pubblica aperta a loro. Abbiamo scritto un piccolo testo in cui dicevamo che volevamo affrontare le domande che vengono tralasciate nell’orario di visita e che le persone dovevano iscriversi a una lista, in modo da capire di quanto spazio avremmo avuto bisogno. Dopo che più di 80 persone si erano iscritte, ci siamo resi conto che avremmo dovuto rivolgerci direttamente alla sala più grande dell’ospedale, che ha 150 posti. Quando non è stato più sufficiente, ci siamo spostati nella sala grande della Scuola Waldorf di Dortmund.
Forse dovrebbe essere un compito e un obiettivo delle scuole Waldorf educare i bambini in modo tale che possano arrivare all’antroposofia, o l’antroposofia a loro, il prima possibile?
Il compito dell’educazione Waldorf è, in fondo, quello di far conoscere tutte le visioni del mondo e le religioni, come questo poi si riflette pienamente nel piano di studi della dodicesima classe. Parlare di antroposofia non è certo il compito della
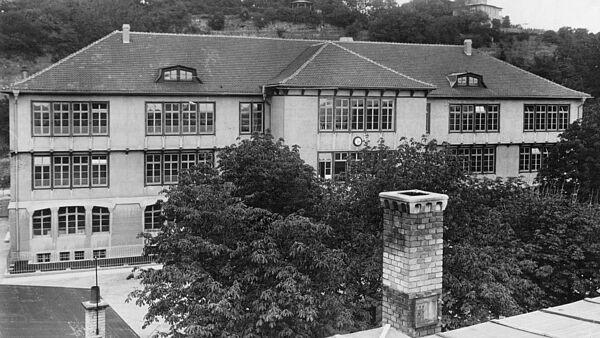
12 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
La prima Scuola Waldorf al mondo, 5 anni dopo l’apertura del 1919, Uhlandshöhe, Stoccarda
pedagogia Waldorf. Tuttavia, è fondamentale che i bambini e i ragazzi percepiscano nei loro insegnanti l’effetto che l’antroposofia ha sulla loro vita e sul loro lavoro. Chi da allievo si sente di essere preso sul serio, sostenuto e considerato, risponde a questa esperienza con fiducia nell’adulto. Su questa base di fiducia si pongono poi anche le domande e, dove ci sono domande, si può anche rispondere senza riserve. In questo modo, nelle superiori si formano sempre, attorno a certi personaggi del collegio degli insegnanti i gruppi di lavoro su questioni filosofiche, antroposofiche e anche religiose. Purtroppo nella maggior parte dei centri di formazione degli insegnanti è un tema profondamente trascurato quello di fare del cammino di conoscenza antroposofico la base della pedagogia steineriana. Si dimentica che i primi insegnanti nominati da Rudolf Steiner erano tutti antroposofi attivi. Questo era il prerequisito del tutto ovvio! Oggi invece molti la considerano una questione privata, un po’ come avviene anche con la religione. Ma il fatto che sia una necessità professionale spesso non viene detto abbastanza chiaramente. Occorre una rivoluzione nella formazione degli insegnanti Waldorf in questa direzione. Le giovani generazioni possono contribuire a questo! Possono nascere anche nuove iniziative di formazione, anche per chi sta già lavorando - in realtà ogni scuola Waldorf ha bisogno di una propria formazione in servizio, lì del luogo. Ed è anche molto bello quando alcuni di coloro che hanno fatto questa formazione, ma poi per qualsiasi motivo non vogliono diventare insegnanti Waldorf, rimangono nel sistema scolastico pubblico, ma ora insegnano lì con un atteggiamento umano e una competenza diversi. In Svizzera ci sono quasi più insegnanti Waldorf nelle scuole pubbliche che nelle scuole Waldorf. Il motivo principale è la grande differenza di stipendio, cioè la situazione finanziaria delle scuole Waldorf ancora non regolata in modo soddisfacente.
Lei ha frequentato la Scuola Waldorf di Stoccarda come allieva, come sono stati lì i suoi anni di scuola, c’era ancora qualcosa dello spirito e dell’atmosfera della prima Scuola Waldorf fondata nel 1919?
Sì, rappresentato da un lato da qualche singolo insegnante, personaggi che uno notava che erano veri rappresentanti della pedagogia steineriana. Ma anche nella meravigliosa cultura della Scuola Waldorf di Stoccarda, dove ogni Natale gli insegnanti mettono in scena per gli alunni tutte e tre le recite natalizie di Oberüfer8. Vedere come i propri insegnanti si dedichino a questa rappresentazione e come quelli che ricoprono determinati ruoli diventino sempre più bravi nel corso degli anni - è profondamente impressionante e di tanto in tanto può persino guarire i rapporti disturbati tra insegnante e allievo, perché improvvisamente si percepisce l’insegnante in questione da un punto di vista completamente diverso. Un altro elemento è la cultura delle festività annuali nelle classi e anche nell’intera comunità scolastica, così come la coltivazione dei tre servizi domenicali che Rudolf Steiner ha dato per i bambini, per i ragazzi confirmandi e per quelli delle superiori. Queste festività religiose hanno avuto un grande impatto su di me durante gli anni della scuola. In particolare, nelle elementari mi ha colpito la gentilezza con cui i maestri ti salutavano la domenica, indipendentemente da come ti eri comportato durante la settimana. Al centro della pedagogia Waldorf c’è l’antropologia dell’uomo, la conoscenza dell’ uomo9 capace di evolversi. Ma cos’è questa conoscenza dell’uomo? È l’insegnamento dell’archetipo dell’essere umano sano: l’Io capace di autonomia, l’anima piena di saggezza che spazia nel mondo, la propria vita e poi il miracolo del corpo fisico, che tra la nascita e la morte è portatore dello sviluppo fisico, animico e spirituale. Poiché il Cristo ha vissuto questo archetipo tra gli uomini, la conoscenza dell’uomo antroposofica è allo stesso tempo conoscenza del Cristo e la pedagogia Waldorf è un avvicinamento a questo sano archetipo, nella misura in cui ciò è possibile nei singoli casi. Ciò è espresso anche nello Spruch
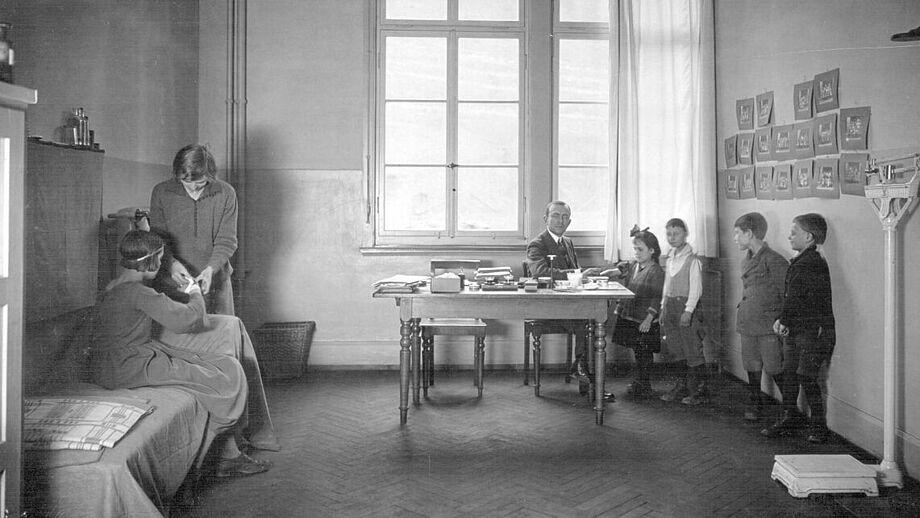
13
Sala del medico scolastico, Scuola Waldorf di Stoccarda, 1920
della Pietra di fondazione della pedagogia steineriana, secondo il quale gli insegnanti devono svolgere il loro lavoro “nel nome di Cristo”. È questa atmosfera profondamente umano-cristiana che ho potuto vivere sempre più spesso nella Scuola Waldorf di Stoccarda durante il mio periodo scolastico. Guardando indietro, direi che queste esperienze hanno avuto molto a che fare con l’impulso originario della Scuola Waldorf, sperando che esse possano essere vissute anche dalle generazioni future.
In Germania le scuole Waldorf si trovano in una fase di sviluppo molto diversa rispetto all’Italia, per esempio, e quindi devono spesso affrontare problemi molto diversi. Prima di decidere di diventare medico, lei si è formato come insegnante e poi ha visitato molte scuole come medico scolastico.
Cosa fa oggi di una scuola Waldorf, “Waldorf”, ovunque si trovi nel mondo?
Non importa se si trova in una scuola delle aree urbane township in Sudafrica, nella grande scuola di Nairobi, a Bangkok, in Giappone, nell’America del Nord o del Sud, in Cina o a Taiwan: lo studio dell’essere umano e il voler rendere giustizia ai bambini nel loro sviluppo è il legame spirituale comune. L’euritmia è anche un meraviglioso linguaggio di comunicazione internazionale perché lavora con i suoni della parola e della musica che sono comuni a tutte le lingue e a tutti gli stili musicali. Perché là si esprime, dappertutto, l’universale umano, di cui si stratta poi. Poiché il cristianesimo non è solamente una forma di confessione o una religione, ma la rivelazione dell’universalmente umano, è compatibile con ogni

religiosità popolare, grande tradizione religiosa o religione naturale. Tuttavia, è decisivo comprendere il carattere orientato allo sviluppo del piano di studi. Molti pensano tanto a questo invece che alle tematiche o alle materie, a ciò che vogliono risvegliare nel bambino. Ecco perché, ad esempio, non si può semplicemente scambiare una fiaba dei fratelli Grimm con una fiaba dell’Altiplano delle Ande peruviane. Non tutte le fiabe sono uguali: le immagini e i contenuti hanno un effetto molto diverso a seconda che siano orientate allo sviluppo del bambino, che si adattino o meno all’età del bambino. Purtroppo, lì ci sono sempre dei fraintendimenti - compresi certi nazionalismi e ideologie - che poi non contribuiscono al bene dei bambini.
Fortunatamente, però, in tutto il mondo esistono dei singoli grandiosi insegnanti Waldorf che sono sempre in grado di stabilire nuovi criteri e di rappresentare l’impulso in modo fedele alle sue origini. Ma per questo occorre avere la capacità di servire un impulso e di saper rinunciare ad alcune passioni e abitudini.
Perché negli ambienti Waldorf e antroposofici tedeschi il citare Rudolf Steiner viene sempre più spesso equiparata all’ essere dogmatici?
Perché purtroppo c’è il vizio di difendere le proprie opinioni con citazioni di Steiner. Così si crea una conflitto di opinioni che è l’opposto del costruttivo. Non si dovrebbe avvalersi di Rudolf Steiner come autorità - la gente giustamente si oppone a questo. Ma colui che ha interiorizzato qualcosa degli insegnamenti di Rudolf Steiner ed è in grado di portarli,
14 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
L’edificio nuovo delle superiori della Libera Scuola Waldorf Uhlandshöhe di Stuttgart, progettato dall’architetto Stefan Behnisch, l’inaugurazone è avvenuta il 16 giugno 2023. Il Neubau si trova di fronte al vecchio edificio di cent’anni fa, tutt’oggi in uso. Foto: behnisch.com/David Matthiessen
spontaneo o nel contesto di un problema, con le proprie parole come messaggio del suo Io, allora può naturalmentese questa è il caso - indicare la fonte in Rudolf Steiner che lo aveva ispirato a questa visione. Ad ogni modo, se la lettura di conferenze pedagogiche o degli scritti fondamentali di Steiner non è più possibile in un collegio di maestri perché egli è ormai ritenuto una figura storica e i suoi scritti sono cosiderati difficili, allora questo significa la fine della pedagogia Waldorf e l’inizio di una scuola alternativa privata. Il rinnovo degli impulsi antroposofici dopo 100 anni può avvenire soltanto attraverso un energico lavoro interiore e l’acquisizione personale del bene spirituale. Non attraverso l’attenersi a ciò che è diventato caro o attraverso il citare dogmatico di certi contenuti.
“Iuventas” è in parte organizzata tematicamente intorno al corso annuale delle festività: qual è il significato delle diverse festività nella sua vita, come si prepara per esse?
Ha qualche pensiero sulla festa di San Giovanni che vorrebbe condividere con noi?
Le anime che si incarnano nel mondo di oggi devono essere molto forti e determinate. Allo stesso tempo, i bambini piccoli sono molto vulnerabili agli impulsi nocivi degli sviluppi tecnologici odierni, e spesso i loro genitori sono già cresciuti a loro volta nell’era digitale. In che misura pensa che gli insegnanti e i genitori siano consapevoli di questa vulnerabilità e dove risiede la protezione, c’è una consapevolezza della necessità di curare e educare con piena coscienza queste anime forti?
Fortunatamente ci sono genitori ed educatori che offrono ai loro bambini e ragazzi la protezione necessaria. Dopo tutto, il buon senso ci dice che l’organismo e soprattutto gli organi sensoriali e il cervello sono entità biologiche analogiche e non computer! Il loro sviluppo avviene nel modo più sano nello spazio e nel tempo del mondo analogico e attraverso tanta attività autonoma e creativa. Quando il lobo frontale si è completamente sviluppato tra i 15 e i 17 anni, e con esso le funzioni di controllo delle emozioni e delle pulsioni, i media digitali non rappresentano più un pericolo, se prima si è provveduto ad un’educazione all’autonomia. Per questo motivo l’Alleanza Europea delle Iniziative di Antroposofia Applicata/ ELIANT 10 , insieme all’europeo Forum per la Pedagogia Waldorf di Bruxelles, si impegna per un’educazione ai media adeguata all’età nei comitati responsabili della digitalizzazione. Siamo felici di poter collaborare qui e di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla dipendenza dall’età dei processi di sviluppo. A tal fine, abbiamo indicato sul sito web di ELIANT la guida ai media “Crescere in modo sano nel mondo dei media digitali” („Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt“), pubblicata in Germania e tradotta in 18 lingue sul sito con il sostegno di ELIANT. Anche i video sull’argomento sono lì ritrovabili in otto lingue11, per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Le anime forti spesso si proteggono da sole! Conosco bambini che effettivamente sono più interessati alla natura, all’arte, al gioco e allo sport e trovano noioso stare sui loro smartphone nei social network. Ma i bambini che non sono forti, la stragrande maggioranza, sono in grave pericolo. Vale la pena di fare ogni sforzo per raggiungere loro e i loro genitori ed educatori.
Le feste dell’anno hanno un ruolo importante nella mia vita. Per me rappresentano importanti qualità dell’anima che possiamo acquisire. La preparazione consiste in realtà nel rendere chiare a me stesso queste qualità, questi motivi e immagini delle festività, con riferimento al loro retroterra spirituale: pazienza e attesa nell’Avvento; la nascita, nella propia anima, della realtà superiore, futura e guidata dalla speranza, a Natale; la grazia con l’Epifania; l’onesta conoscenza di sé nella Quaresima; la gioia e la gratitudine per l’unione del proprio Io con l’Io eterno del Risorto a Pasqua; il sentirsi connessi a tutti gli esseri viventi e l’imparare a percepire il Logos in tutta la Creazione con l’Ascensione; poi Pentecoste come festa della comunità degli spiriti liberi, il passaggio dall’io al noi. Il giorno di San Giovanni, invece, secondo l’antica tradizione è la festa della purificazione - nel fuoco di San Giovanni si bruciano i vizi. Per me San Giovanni è la festa della nascita della coscienza umana e della fiducia nel destino. Ma la festa di San Michele è decisiva. Perché qui possiamo renderci conto che il materialismo, con tutte le sue tragedie, le catastrofi ecologiche e le guerre economiche, può essere vinto solamente da un pensare che prende coscienza della propria natura spirituale e della propria forza creatrice. L’Arcangelo Michele così può essere un “annunciatore di Cristo” („Christuskünder“) perché ha sconfitto il drago dell’egoismo mettendolo sotto i piedi. Ogni superamento di sé, per quanto piccolo, ci permette di rimanere con i piedi per terra, di essere più onesti e spiritualmente più consapevoli nella vita. In sostanza, oggi tutte le feste dell’anno hanno bisogno di un carattere micheliano. Perché celebriamo e mettiamo in risalto certi giorni dalla vita quotidiana? Perché vogliamo avvicinarci al divino presente in noi e nel mondo e portare gioia agli altri. È in questi giorni di festa che di solito mostriamo il nostro lato “ideale”, ben sapendo che spesso non sappiamo mantenerlo nella vita di tutti i giorni. Per questo è ancora più importante esercitarlo ancora e ancora...
Qual è il suo messaggio ai nostri giovani lettori?
Non lasciatevi spaventare, manipolare e intimidire! Inoltre, sostenete ciò che ritenete giusto e ciò che volete fare – anche se il vostro ambiente aspetta da voi qualcos’altro. All’età di giovane adulto è importante trovare la propria identità e non conformarsi alle aspettative! Il modo in cui lo si fa è un po’ diverso in ogni tempo e per ogni generazione. Utilizzate proprio la vostra giovinezza per questa ricerca della propria strada e concedetevi dei momenti in cui potete conoscere il mondo. Unitevi in buone iniziative e imparate ciò che vi interessa e che è utile per la vita.
15
E al pubblico dei lettori italiani in generale?
Studiate la vostra storia e impegnatevi per l’Europa e i suoi valori culturali cristiani!
A quali progetti sta lavorando nel prossimo futuro?
Ha un legame personale con l’Italia e con lo spirito italiano?
Sì! Dopo la maturità, ho passato 6 settimane in Italia con Cristina Pederiva, una compagna di classe che era venuta dall’Italia per trascorrere gli ultimi anni di scuola con noi nella nostra classe Waldorf a Stoccarda. Con lo zaino in spalla, autostop e in treno siamo arrivate fino a Napoli, andate in giro per la Sicilia, per poi tornare a Milano dove era casa sua. Abbiamo visitato molte chiese, opere d’arte e templi e ci siamo godute la natura e la nostra libertà.
È stato nei quartieri poveri di Napoli che mi è apparso chiaro: in questo mondo non puoi fare teatro (perché avevo iniziato a fare una formazione per attori appena dopo la maturità), ma devi diventare una insegnante e aiutare le persone a imparare a pensare e a sentire in modo diverso, che non possano più sopportare di vivere in palazzi di marmo mentre nel quartiere vicino c’è la miseria. In questo senso, l’Italia è il Paese in cui sono diventata ”adulto”. E ancora oggi ho ancora una piccola pietra proveniente dalle catacombe dei primi cristiani al tempo delle persecuzioni romane.
Al momento sto lavorando all’introduzione del volume 15 della Steiner Kritischen Ausgabe (SKA) Band 15. E’ il libro di Steiner e Wegman: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst Poi c’è la nuova stesura completa di Kindersprechstunde, una guida medico-pedagogica che esiste (o almeno esisteva) anche in italiano. Quel lavoro dovrebbe essere terminato entro settembre. E negli ultimi mesi di quest’anno spero di avere pronta la terza edizione del mio libro Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung. In esso ho descritto le mie esperienze da medico scolastico e sono molto felice che sia tanto apprezzato da genitori e da insegnanti Waldorf senza formazione, per conoscere l’antropologia, il piano di studi e la pedagogia Waldorf.
Grazie mille per aver dedicato il Suo tempo per rispondere a queste domande! Tanti auguri per il futuro!
Grazie per l’interesse, cara Kata Szabados!
NOTE
* - traduzione del testo tedesco in italiano a cura di K.Sz.
1 - “Influssi luciferici, arimanici, asurici” in Antropologia Scientifico-Spirituale, O.O. 107;
2 - “Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten” - L’iniziazione, O.O. 10;
3 - “Studienstiftung des deutschen Volkes”
4 - Herbert Hahn, Das goldene Kästchen. Erzählungen – Legenden – Märchen
5 - “Zweig” in tedesco, letteralmente ‘ramo’, viene usato per denominare i gruppi presenti in territorio tedesco formati dai membri della Società Antroposofica di una specifica città, i quali si riuniscono regolarmente (di solito il mercoledì sera) per un lavoro spirituale, per gruppi di studio, discussioni, conferenze, eventi artistici. (N.d.R.)
6 - “moralische Technik”; Steiner descrive la tecnica morale nel capitolo “La fantasia morale” in La filosofia della libertà (N.d.R.)
7 - “Antisozialen Triebe”; Steiener parla degli istinti antisociali in Istinti sociali e antisociali nell’uomo – conferenze tenute a Dornach il 6.12.1918 e a Berna il 12.12.1918. (N.d.R.)
8 - I tre drammi di Natale provenienti da Oberüfer, “L’Albero del Paradiso”, “La nascita di Cristo”, “I tre Re”, furono raccolti, trascritti e pubblicati da Karl Julius Schröer (Deutsche Weihnachtspiele aus Ungarn - Recite popolari tedesche di Ungheria, 1858) (N.d.R.)
9 - L’Antropologia (Arte dell’educazione Vol.I) in tedesco si intitola Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik - Vol.I - GA 293, di cui Menschen-Kunde è letteralmente ’conoscenza dell’uomo’. (N.d.R.)
10 - ELIANT: European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy - www.eliant.eu
11 - https://eliant.eu/en/news/for-the-right-to-screen-freeday-care-institutions-kindergartens-and-primary-schools
16 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
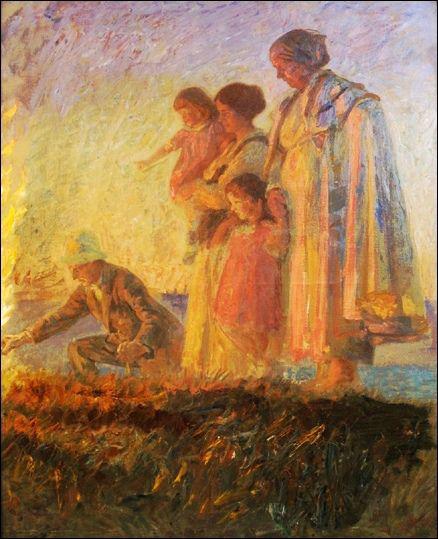
17
Laurits Tuxen, At the Johannisfeuer in Skagen, 1920
“Da Atene mi sono diretto verso Taormina, dove mi aspettava un tramonto tale da farmi capire: quello sarà la pittura più colorata al mondo che presenti la Via Solare.”

18 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
dall’Autobiografia di Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919)
Tivadar Csontváry Kosztka, Fioritura del mandorlo a Taormina, 1902
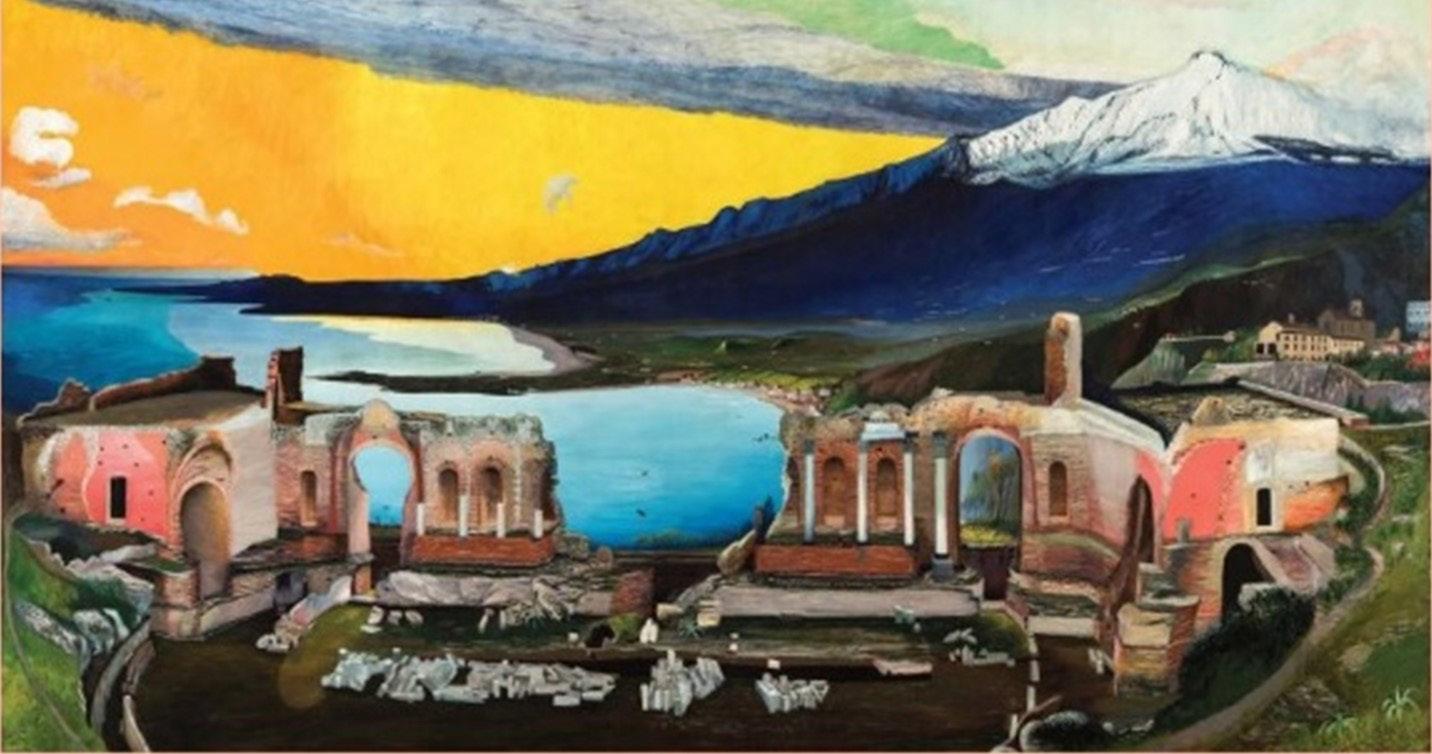
19
Tivadar Csontváry Kosztka, Le rovine del Teatro Greco di Taormina, 1904-05, olio su tela, 302 x 570 cm, Galleria Nazionale Ungherese, Budapest

20 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
San Uriele, vetrata, Chester Cathedral
Abbiamo già evidenziato nei precedenti articoli come i ritmi, le modalità e le scoperte della vita moderna, in particolare in ambito culturale, tecnologico e scientifico, abbraccino spesso l’azione degli Ostacolatori. Purtroppo è difficile che l’individuo abbia spazio per poter incidere anche soltanto in minima parte in questi ambiti, e proprio per questo abbiamo tentato finora soprattutto di stimolare osservazioni e riflessioni e di mostrare le possibilità che restano comunque al singolo anche in un ambiente così desolante e ostile. Vogliamo però adesso entrare in un nuovo campo di considerazioni, cioè quello dell’azione degli Ostacolatori nella vita interiore di ciascuno e nelle relazioni personali, un ambito nel quale ognuno di noi può fare una differenza significativa. L’essere umano è per lo più convinto di essere l’attore protagonista della propria vita e di essere il soggetto dei propri pensieri, sentimenti e impulsi volitivi e non si rende conto in quanta parte è invece indirizzato da condizioni e circostanze esteriori. In varie lezioni esoteriche (per esempio O.O. 266/3 pp. 70-72 e 87-89) Steiner fece notare come perfino le parole utilizzate quotidianamente siano ingannevoli: non è corretto affermare Io penso, Io sento, Io voglio, ma soltanto Io sono; non
solo perché l’essere umano non è cosciente dell’influenza del proprio ambiente su di sé, ma proprio perché in realtà non è lui all’origine di queste attività.
Riguardo al pensare “in realtà più di due terzi dei pensieri [oggi possiamo stimare circa l’80%] provengono da Lucifero. È lui che pensa nell’uomo. Gli esseri umani si fanno un’idea totalmente falsa del pensiero. Il valore del pensiero non sta nella quantità di cose imparate, comprese o sapute, ma nel progresso che permette di compiere, nelle forze che permette di sviluppare. [...] Non si dovrebbe dire: Io penso, ma Lucifero pensa in me. Se Lucifero non fosse intervenuto, gli uomini che avessero desiderato qualche cosa nello stato di veglia avrebbero potuto ricorrere a ricordi immaginativi, che li avrebbero guidati così come ora sono condotti dalle circostanze esteriori. Quando l’essere umano diventa cosciente che degli esseri pensano in lui, può anche dire: Esso mi pensa o Esso pensa in me. Questo pensiero può esercitare su di lui un’azione benefica quando viene accompagnato da un sentimento appropriato, ovvero la devozione.”
Riguardo al sentire anche “le pulsioni e i desideri che vivono in noi non sono prodotti da noi stessi, ma perlopiù ci dominano.
21
QU
O
nOSTrO TemPO
lO SGUardO CHe aPre la vOlTa del CielO di Yarince Vicenzo, giugno 2023
al è l’azi
ne deGli OSTaCOlaTOri nel
?
Due terzi di questi sentimenti [oggi possiamo stimare circa il 95%] provengono da esseri luciferici e arimanici, tramite la Maya del mondo sensibile esteriore.” Altrimenti l’essere umano avrebbe potuto contemplare le immagini archetipiche e le forze eteriche che agiscono nel mondo. Per ristabilire coscientemente la connessione con queste forze si può usare la seguente parola mantrica: Esso mi tesse, accompagnandola con un sentimento di gratitudine. Per quanto riguarda gli impulsi volitivi, appare evidente perfino a uno sguardo profano e superficiale come la frase Io voglio sia un’illusione. Questa è collegata all’influenza dell’entità asuriche, arimaniche e luciferiche, le quali fanno in modo che l’essere umano si percepisca come separato dal Cosmo. Per ristabilire coscientemente la connessione con gli esseri cosmici si possono meditare le parole: Esso agisce in me, accompagnate da un sentimento di venerazione. L’unico verbo che Steiner afferma l’essere umano possa giustamente e degnamente attribuire a se stesso è il verbo essere, cioè: Io sono. Questa osservazione ci fa interrogare sulla natura dell’Essere e quella dell’Io: l’essere umano infatti vive nel respiro, nello spazio tra il soggetto puntiforme e la coscienza cosmica, e in questo senso si può affermare che l’Io non è un soggetto che si pone di volta in volta in relazioni sempre nuove con gli oggetti, bensì che l’Io è costituito dalla relazione stessa. Infatti il centro dell’esperienza umana non si trova nell’interiorità, ma fuori, nello spazio tra noi e gli altri. Per questo è importante distinguere gli estremi e i predicati di questo respiro: innanzitutto la coscienza cosmica divina, poi l’Io, che è costituito dalla relazione e unisce gli opposti complementari, e infine l’Ego, cioè la coscienza ordinaria puntiforme che fa aggrappare a ciò che si possiede per sfuggire alla vacuità.
Per il nostro lavoro sugli Ostacolatori è fondamentale osservare l’Ego più nel dettaglio poiché è su questa parte della coscienza umana che agiscono gli Ostacolatori, ed Esso non abbandona l’individuo finché egli non ha il coraggio di riconoscere il nulla su cui si fonda. Esso infatti si compone dell’insieme delle esperienze e degli incontri che lo hanno formato e non sarebbe niente se non ci fossero gli altri, se non fosse inserito in una corrente storica, genealogica, una corrente Cosmica. Inoltre il suo atto d’essere ha due impulsi: il sapere tutto (l’onniscienza) e il potere su di sé e sul mondo come volontà d’azione e di conquista (onnipotenza), entrambi frutto dell’azione degli Ostacolatori (la saggezza di Lucifero e la forza di Arimane) e come tali anche destinati allo scacco della morte. Infatti per l’Ego la morte è l’annuncio rimandato del limite ultimo della sua esperienza ed esistenza, ma è anche incredibilmente liberatoria, poiché lo fa uscire dalla sua solitudine, dal suo isolamento solipsistico. La morte annuncia l’Altro inaccessibile, mentre gli altri sono la versione accessibile della morte. Infatti riconoscere gli altri come altri esseri permette di confrontarsi con la morte, poiché si esce dall’Ego e si vive nel tra, cioè nell’Io, nel respiro tra la propria coscienza puntiforme e quella degli altri, poiché l’Altro è il rappresentante del tutto, la finestra attraverso cui sperimentare il tutto e aprirsi alla coscienza Cosmica. È dunque contemporaneamente esperienza di morte e di nascita.
Per questo diventa essenziale come l’essere umano si pone in relazione con gli altri e in questo modo sperimenta il proprio Io nel respiro tra sé e l’Altro.
Per esempio Martin Buber caratterizza due tipi di relazione:
la relazione Io-Esso, di comune conoscenza, dove si fa esperienza dell’altro e lo si inserisce all’interno di un sistema di categorie per servirsene, e la relazione Io-Tu, eccezionale e immediata, dove ci si apre e si incontra l’Altro in un reciproco dono: Io dono te a te stesso e Tu doni me a me stesso L’incontro con il Tu è incomparabile e incommensurabile, è un atto d’Amore che spalanca la volta del cielo e permette di entrare in comunione col mistero dell’Altro. Mentre l’Esso è la modalità che usiamo per orientarci nel mondo, definendo e caratterizzando, poiché la vera relazione fa paura (in quanto presuppone un confronto con la morte). Viviamo dunque in un’alternanza: percepiamo esseri o esseri come cose, azioni o azioni come processi. L’Esso si lascia prendere, ma non si dà. Crediamo di conoscerlo, perciò ci dà sicurezza. La relazione Io-Tu invece è inaffidabile, poiché è sempre nuova.
Come è possibile dunque esercitarsi in questo nuovo modo di intendere la realtà?
Innanzitutto aprendo gli occhi davanti al fatto che tutto ciò che ci circonda è in realtà un mondo di Esseri con cui entrare in relazione con l’Io e non un mondo di oggetti da utilizzare secondo i capricci dell’Ego.
Possiamo prendere le mosse da una semplice considerazione di ambito linguistico: in italiano la forma di cortesia (dare del Lei) permette, attraverso la sostituzione della seconda persona singolare con la terza, un allontanamento dell’interlocutore che porta all’oggettivazione e al distacco emotivo, propri della relazione Io-Esso. Come sarebbe invece per contrappasso cominciare a dare del Tu a tutti quegli Esseri sconosciuti che tessono dietro alla Maya degli oggetti che ci circondano?
Ciò non basterebbe ancora per bilanciare l’azione degli Ostacolatori, ma può essere un inizio per indirizzare l’Io umano verso la realtà spirituale di Esseri che abitualmente ignora e che invece col tempo possono cominciare a parlargli se egli vi si rivolge interiormente con la silenziosa domanda: Chi sei tu?
Non importa cosa, dove, quando o in che situazione ci si trova, è sempre il momento adatto di rivolgere a qualcuno questa domanda, che si tratti di un essere umano incontrato per strada o conosciuto da una vita, degli esseri elementari che tessono nei muri o nel tetto di una casa, in piatto e in bicchiere o nel loro contenuto, degli esseri spirituali che tessono nel cosmo, nella terra e nel destino umano.
Questa domanda apre le porte dei mondi dello spirito e dischiude le labbra dei Maestri invisibili che attendono pazientemente che qualcuno si rivolga a loro.
Possiamo collegare questo approccio conoscitivo a quello indicato da Steiner nelle prime conferenze del ciclo Il mondo dei sensi e il mondo dello Spirito (O.O. 134), dove parla di quattro passi per la conoscenza: innanzitutto l’apertura, la meraviglia, il silenzio interiore che permettono al singolo di diventare domanda, di cui abbiamo già parlato. Poi abbiamo la venerazione, il riconoscimento del sacro Mistero che ci circonda: il Mistero dell’Altro e la sua incomparabilità. In seguito abbiamo l’armonia, cioè la capacità empatica di mettersi in accordo e di risuonare, sospendendo i giudizi della propria anima per addormentarsi nell’Altro e lasciare che cominci a parlare. Infine la devozione, cioè la capacità di non investigare la Verità per virtù propria bensì di attendere la rivelazione proveniente dagli Esseri delle cose, lavorando su di sé per diventare maturi per accogliere e penetrare la verità, in una paziente attesa della
22 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
Possiamo dunque cercare di mettere in questa luce anche i tre mantra di Steiner che abbiamo riportato all’inizio della rubrica:
• Esso pensa in me. Chi può pensare in me al posto di Lucifero se mi immergo in questo pensiero con devozione?
• Esso mi tesse. Chi può tessere nel mio sentire al posto di Lucifero e Arimane se mi immergo in questo pensiero con gratitudine?
• Esso agisce in me. Chi può agire in me al posto di Lucifero, Arimane e Asura se mi immergo in questo pensiero con venerazione?
Torneremo su queste domande la prossima volta. Cerchiamo adesso di approfondire il tema del rapporto degli Ostacolatori con l’Ego e quello dell’Ego con la morte: tra gli esercizi meditativi dati da Steiner all’interno della prima scuola esoterica ce n’è uno molto antico che si richiama all’episodio biblico del vitello d’oro e che risulta fondamentale per riconoscere e per superare l’azione degli Ostacolatori nella propria interiorità e in particolare per la trasformazione dell’Ego e di tutti i corpi inferiori. Steiner afferma che senza questa esperienza il popolo ebraico non sarebbe mai stato capace di accogliere il Cristo. Riportiamo qui la trascrizione di una lezione esoterica:
“Il discepolo immaginerà che il suo insegnante o maestro stia in piedi davanti a lui sotto le spoglie di Mosè [...] e che il profeta gli domandi: - Così desideri sapere perché non progredisci sulla via esoterica? - Sì - Te lo dirò: perché adori il vitello d’oro. - Dopo queste parole il discepolo contempla il vitello d’oro che si trova accanto a Mosè. Mosè quindi fa sorgere della terra un fuoco che comincia a divorare il vitello d’oro, riducendolo in una polvere di cenere. Getta quest’ultima in un’acqua chiara che si trova a disposizione nei pressi e fa bere il discepolo. [...]
Quando risaliamo indietro con i ricordi giungiamo ad un punto della nostra infanzia in cui non ricordiamo niente; è il punto in cui comincia la coscienza di sé. Ciò che si trova prima di questo, è ciò che abbiamo fatto di noi nelle nostre precedenti incarnazioni e che abbiamo portato con noi in questa incarnazione. È il vitello d’oro, che veneriamo senza saperlo, è la nostra natura di involucro.
Nell’immagine, ora il discepolo sostituisce il vitello d’oro con lui stesso bambino, ancora privo della coscienza di sé. Si compenetra della seguente coscienza: sente che il suo io non è nient’altro che un effetto luciferico; perché l’ordinaria coscienza di sé poggia sul ricordo, e questo è una forza luciferica. [...] Il discepolo si rappresenta realmente che il fuoco divora la sua forma infantile, che è la sua propria; egli è diventato solo un po’ più grande ma in realtà è sempre rimasto questa natura di involucro quale era da bambino, sia solo aggiunta l’illusione dell’io. Vede che la forma diventa polvere e questo deve dargli la forte coscienza che tutto ciò che, in questo involucro, è fisico, eterico e astrale gli è indifferente come un mucchio di cenere, come l’argilla per lo scultore prima di eseguire la sua opera. Con il pensiero bisogna sgomberare, come si fa con un mucchio di cenere, il corpo fisico che dona la forma esteriore, il corpo eterico con la sua memoria e anche il corpo astrale con le sue simpatie e antipatie. [...]
La cenere è gettata nell’acqua pura della sostanza divina, qual era prima dell’operare della forza luciferica. È così che deve essere sacrificata l’essenza dell’involucro affinché ritorni nella sostanza divina. Ma l’esoterista capisce presto che tutto quello che ora è solo un mucchietto di cenere, è stato formato a partire dallo spirito. [...] Quindi ora dobbiamo riprenderci ciò che lo spirito ha fatto dell’involucro. Dobbiamo bere l’acqua nella quale è stata sciolta la cenere. Così la riassumiamo in noi allo stato puro, dopo che il vitello d’oro è stato consumato nel fuoco e la sua cenere disciolta. Se lo si fa si sentirà dapprima che una intera parte di sé si svuota; è il luogo su cui generalmente poggia l’Io; lo si sente svuotarsi. Si può allora diventare buddista e giungere in un luogo che però l’essere umano non dovrebbe stimare degni di lui: il Nirvana, una sfera extraterrestre. Oppure si può accedere a una nuova coscienza dell’impulso cristico e farla colare nella vacuità del proprio io.” (O.O. 266/2 pp. 261-270)
Concludiamo le nostre considerazioni riportando le indicazioni di Steiner per il terzo degli esercizi complementari, quello che riguarda il controllo del sentire e la quiete interiore.
“Nel terzo mese, si porrà al centro della vita un nuovo esercizio, mirante ad educare a un certo equilibrio rispetto alle oscillazioni tra piacere e sofferenza, tra gioia e dolore. Il lanciarsi con gioia verso il cielo, turbati sino alla morte deve essere consapevolmente sostituito da una equilibrata disposizione dell’anima. Si badi a non farsi trascinare da una gioia, o abbattere da un dolore, a non farsi trasportare all’ira o alla collera smisurata da alcuna esperienza, a non farsi riempire d’angoscia o di paura da nessuna attesa, che nessuna situazione ci sconvolga, e così via. Non si tema che questo esercizio renda aridi o apatici. Si noterà invece come al posto dei vecchi sentimenti sorgano qualità dell’anima maggiormente purificate; grazie a una sottile attenzione, si potrà un giorno avvertire in sé una quiete interiore. Come nei due casi precedenti, si riversi questo sentimento nel corpo, facendolo irradiare dal cuore alle mani, poi ai piedi e infine alla testa. Non lo si potrà ovviamente fare ogni volta, poiché in fondo non si ha a che fare con un singolo esercizio, ma con una continua attenzione alla propria vita interiore dell’anima. Almeno una volta al giorno si dovrà richiamare davanti all’anima questa quiete interiore, e poi intraprendere l’esercizio per farla fluire dal cuore. Con gli esercizi del primo e del secondo mese, ci si comporti come con quelli del primo nel secondo.”
(Rudolf Steiner, Indicazioni per una Scuola Esoterica, O.O. 245, p.17)
Questo esercizio, insieme ai due precedenti, risulta intimamente connesso al tema dell’azione degli Ostacolatori nel pensare, nel sentire e nel volere, ma soprattutto alla possibilità di ricollegarsi attraverso la meditazione agli alti Esseri spirituali, dei quali gli Ostacolatori hanno preso il posto per donare all’essere umano il libero arbitrio e la possibilità del male e dell’errore. Proprio questa serie di esercizi permette di portare maggior coscienza del come si svolgono i processi di pensiero, di sentimento e di volontà nell’anima umana, innanzitutto mettendo l’Io umano di fronte all’enorme difficoltà o addirittura all’incapacità di realizzare dei compiti apparentemente così piccoli e insignificanti. Nella maggior parte dei casi l’individuo non ha alcun controllo su queste facoltà della propria anima, ma si
23
Grazia.
trova piuttosto come su una barchetta senza timone, in balia delle onde: finché è bel tempo la velocità può anche dare una certa ebbrezza e un’illusione di controllo, ma quando si avvicinano iceberg, uragani o isole dalle bocche di fuoco le cose cambiano velocemente. Con questi esercizi non si tratta semplicemente di domare la tempesta, ritrovare la bussola e orientarsi, ma di passare a un altro ordine di significati, come direbbe Ernst Junger di passare al bosco, cioè operare una vera e propria rivoluzione interiore per affondare le radici nel terreno originario: il mondo della spirito.
L’autore invita caldamente i lettori a condividere riflessioni, critiche e considerazioni o porre domande, contattandolo via mail oppure per lettera “per chi sa accontentarsi di una comunicazione più lenta”. Indirizzo elettronico e/o fisico dell’autore possono essere richiesti contattando la Redazione.
24 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
SOGnO di Una nOTTe di mezza eSTaTe
di William Shakespeare, 1595-96
Traduzione di Antonio Calenda e Giorgio Melchiori
Con illustrazioni originali di Arthur Rackham pubblicate nell’ edizione del 1908 (Original illustration for A Midsummer Night’s Dream)

Atto II, 1° Scena
Entrano una FATA da una parte, e Robin Goodfellow [PUCK] dall’altra
PUCK: Ehi, spirito, dove te ne vai?
FATA: Per colli e per valli, per rovi e cespugli, per prati e steccati, per fiamme e per flutti, ovunque m’aggiro più presta e leggera della luna nella sua sfera. Io servo la regina delle fate, irroro di rugiada i suoi cerchi d’erba. Le primule alte le fanno da scorta; le macchie sui loro mantelli dorati sono rubini, doni di fate, nèi che diffondono profumi inebrianti. Ora vado a cogliere stille di rugiada, perle da appendere all’orecchio di ogni primula. Addio, spirito zotico, ora devo andarmene. Verrà qui la regina col suo seguito etereo.
PUCK: È il re che farà festa qui stanotte: bada che la regina stia lontana. Oberon è furibondo perché lei ha preso come paggio un ragazzo bellissimo, rapito a un re indiano. Mai vi fu fanciullo più dolce scambiato dalle fate. Il geloso Oberon avrebbe voluto fare di lui un cavaliere al suo seguito per battere le foreste selvagge. Ma Titania trattiene l’amato ragazzo, lo incorona di fiori, ne fa la sua gioia. Ora quando s’incontrano nei boschi o sui prati, presso chiare sorgenti o al vivido brillare delle stelle, s’accapigliano, tanto che i loro elfi per paura si rimpiattano nei gusci delle ghiande e se ne stanno nascosti.
25
Atto V, Scena finale
PUCK: Ora rugge il leone affamato e il lupo ùlula alla luna; russa il contadino addormentato stanco della sua greve fatica. Ora i tizzi consunti rosseggiano e la civetta col suo stridulo grido ricorda all’infelice sofferente il freddo abbraccio del sudario. È l’ora della notte in cui ogni tomba, spalancata, lascia vagare gli spettri lungo i sentieri bui del cimitero. È l’ora in cui noi spiriti, fuggendo la presenza del sole, come staffette del carro trionfale di Ecate triforme e inseguendo le tenebre come un sogno, andiamo folleggiando. Neppure un topolino disturbi questo palazzo incantato. Mi hanno mandato avanti con la scopa a spazzare la polvere dietro la porta.
Entrano il re [OBERON] e [TITANIA,] la regina delle fate, con il loro seguito
OBERON: Per tutta la casa andate come lucciole accanto alle braci sonnolente. Ogni spirito, elfo o fata, saltelli leggero come uccello sul ramo e, danzando sulle punte dei piedi, cantate con me questa filastrocca.
TITANIA: Proviamo prima la melodia, accompagnando ad ogni parola una nota; poi con aerea grazia, qui, con il nostro canto, tenendoci per mano, operiamo l’incanto. [Canto e danza]
OBERON: E così di stanza in stanza ogni spirito si aggiri fino allo spuntar dell’alba. A ogni talamo nuziale recheremo buoni auspici, che la prole generata sia felice e fortunata, e le tre coppie di amanti sempre ai voti sian costanti. Nessun scherzo di natura tocchi i figli di costoro: siano immuni da ogni neo, labbro leporino, sfregio, da ogni voglia mostruosa aborrita dalla nascita. Ogni spirito rechi con sé la rugiada consacrata che diffonda dolce pace del palazzo in ogni stanza: e sicuro sia il riposo del signore della casa. Presto, su, non indugiate, ed all’alba a me tornate.
Escono tutti tranne PUCK
PUCK: Se noi ombre vi abbiamo irritato, non prendetela a male, ma pensate di aver dormito, e che questa sia una visione della fantasia. Non prendetevela, miei cari signori, perché questa storia di ogni logica è fuori: noi altro non v’offrimmo che un sogno; della vostra indulgenza abbiam bisogno. Come è vero che sono un Puck onesto, se abbiam fallito vi prometto questo: che, per fuggire le lingue di serpente, faremo assai di più, prossimamente. Se no, chiamatemi bugiardo e mentitore. Per ora buonanotte, signori e signore. Non siate avari di mano: siamo amici, e in cambio Robin vi farà felici.
26 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

27

28 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
FaUST: Una TraGedia i-ii.
di Johann Wolfgang von Goethe, 1808 /1832
Traduzione di Giuseppe Gazzino
Parte II, Atto 1°
FAUST, sdraiato sull’erba fiorita, affranto, inquieto, avido di sonno. CREPUSCOLO.
Ronda di spiriti e di apparizioni graziose che gli svolazzano intorno.
ARIELE (canto accompagnato dalle arpe eolie). Quando il cielo in primavera dona ai campi la pioggia, e le bionde spiche allietano gli sguardi degli uomini, stuoli di silfi gentili volano colà ove sono dolori da lenire, arrecando a tutti, senza distinzione, il vigore e la vita. Ogni misero che gema oppresso dalla sventura, sia esso reo od innocente, ha diritto alla loro pietà. Ecco, o aerei silfi, che aleggiate intorno al suo capo, una bella occasione per fare onore al vostro nome.
- Calmate l’ardente inquietudine dell’animo suo; sviate da esso l’acuto strale del cocente rimprovero che lo tortura, e sgombrate la sua coscienza dai terrori onde s’affanna l’umana esistenza. Provvedete solleciti affinchè i quattro periodi, che la notte beata attraversa sul suo carro, scorrano soavemente per lui. E dapprima adagiategli la fronte su guanciali di rose, poi la bagnate nell’acqua di Lete; fate che le sue membra intorpidite ritrovino la salute nella calma di questo sonno in braccio al quale s’avvia verso la nuova aurora; indi compirete la più cara delle opere vostre, riaprendogli le pupille alla santa luce del giorno.
29
la SCienza OrGaniCa di GOeTHe
conferenza e testo di Elio Biagini, 2008
La via di conoscenza antroposofica è fondata sulle basi filosofiche che Rudolf Steiner adottò proprio per creare un metodo conoscitivo adatto ad indagare l’intera realtà, sia quella materiale che quella spirituale. Premessa e preparazione per Steiner nel definire la propria filosofia e la propria via è la concezione goethiana delle scienze organiche, del rapporto tra idea ed esperienza o tra spirito e realtà percepibile. Di questo cercheremo di occuparci oggi, approfondendo questa concezione goethiana, e preparando così il prossimo incontro sulla filosofia antroposofica. Entrando nello specifico del nostro tema diremo subito cosa non è, o non dovrebbe essere, una scienza dell’organico, del vivente. Cioè cercheremo di mostrare come una concezione materialistica, meccanicistica, non possa costituire la base per un metodo di indagine adatto alla realtà del vivente. Poi passeremo ad illustrare la visione goethiana che costituisce invece la base per una oggettiva relazione con il vivente e con gli organismi che ne fanno parte.
Cominciamo allora con un breve riferimento storico. Nel secolo XV si produce un brusco cambiamento nel rapporto tra uomo e realtà. Esso determina radicali trasformazioni nella maniera in cui l’uomo di rappresenta il mondo. Sino a quell’epoca il mondo esteriore, il mondo degli oggetti nello spazio poggiava su una realtà metafisica trascendente, che l’uomo, però, sperimentava come affine alla propria interiorità: il mondo poggiava su una realtà trascendente legata al destino e alla vicenda interiore dell’uomo (si pensi alla cosmologia dantesca). Da quel momento l’osservazione dello spazio di acuisce e si dilata: l’esperienza dello spazio si fa più intensa. Il mondo degli oggetti nello spazio si fa più nitido, acquisisce per l’esperienza uno spessore e un’intensità che prima non aveva. Una delle conseguenze di questo nuovo impossessarsi dello spazio terrestre sono le scoperte geografiche. E anche la scoperta delle leggi della prospettiva testimonia di questa nuova facoltà di rappresentarsi lo spazio con tale precisione da poterlo riprodurre in immagine in tutta la sua profondità. Dietro tutte queste scoperte, dietro le scoperte geografiche, dietro le leggi della prospettiva, sta un fatto rivoluzionario, sta un’unica grande scoperta: la scoperta dell’oggetto. La scoperta cioè di qualcosa che sta (o sembra stare) nettamente, separatamente e individualmente fuori dell’uomo. Con essa avviene l’interruzione, o almeno l’inizio di questo processo, di quel legame tra il mondo e l’interiorità dell’uomo cui abbiamo accennato. Il mondo non viene più percepito come affine o contiguo, ma come realtà separata, a sé stante e poggiante su se stesso. Uno dei prodotti di questo mutamento è il pensiero e
il metodo scientifico moderno.
L’oggetto nello spazio si spoglia da quel legame con la vicenda interiore dell’uomo ed emerge nitidamente nella sua nudità. Si vuole considerare l’oggetto “così com’è”, come si da nello spazio. Il dato empirico assume la funzione di fondamento e di presupposto del conoscere.
Nello stesso momento sorge la necessità di dare un fondamento durevole, stabile, al dato empirico, di ricondurre l’immediata caoticità dell’esperienza sensibile ad un ordine e ad una regolarità. L’esperienza sensibile deve essere resa trasparente, comprensibile, riconducendola ad una regolarità di leggi.
La realtà dell’oggetto viene ricondotta ad elementi semplici le cui relazioni ed azioni reciproche vengono rese intelligibili in base a concetti matematici.
Tutto questo produce un lento e profondo mutamento nella maniera di osservare l’oggetto rispetto all’esigenza scientifica originaria. Si insinua lentamente l’idea della realtà come costruzione matematica ed essa finisce per divenire un’ideologia dell’oggetto che si frappone all’osservazione e ne diventa così un presupposto imprimendosi nel modo stesso di indagare la realtà.
Il modo di indagare la realtà assume così la forma dell’analisi, della dissezione, dell’esperimento. Il metodo d’indagine assume la forma del metodo scientifico-analitico e da esso deriva la concezione meccanicistica della natura.
Questo metodo si differenzia con sempre maggiore chiarezza nei tre momenti fondamentali dell’Ipotesi, dell’Osservazione e del Modello. Il primo momento risente in maniera fondamentale dell’indirizzo assunto progressivamente dall’indagine scientifica.
L’ipotesi riflette in sé una concezione, una teoria dell’oggetto che viene presupposta acriticamente all’osservazione. Si presuppone sempre che l’oggetto sia espressione di leggi fisico-meccaniche; di conseguenza l’ipotesi prende una forma che conduce sempre alle seguenti due domande: qual’è la struttura di questo oggetto-fenomeno? qual’è il meccanismo d’azione di questo processo? Prima ancora dell’osservazione si presuppone dunque che esso sia un meccanismo. L’ipotesi così formulata autorizza ad intervenire sull’oggetto prima ancora di osservarlo, ad alterarlo fino a renderlo un altro oggetto da quello che si offre all’osservazione. Esso viene ridotto in parti semplici.
Non si osserva allora l’oggetto così com’è, secondo l’esigenza originaria della scienza, ma lo si osserva così come è diventato in seguito all’intervento dell’osservatore, ad un intervento soggettivo che introduce un elemento soggettivo secondo l’opinione acritica dell’osservatore. L’oggetto viene costretto
30 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
ad obbedire alle opinioni del soggetto che osserva e viene, come già detto, ridotto ad un altro oggetto.
Dunque: Ipotesi e Osservazione = distruzione dell’oggetto Si vede allora solo ciò che si vuole vedere, il resto viene espulso dall’oggetto attraverso una previa manipolazione.
L’indagine scientifica prende in considerazione solo leggi fisico-meccaniche perché il resto viene estromesso dall’oggetto prima di osservarlo. Si restringe lo sguardo solamente a quello strato di realtà che obbedisce a leggi fisico-meccaniche.
L’indagatore viene costretto, a causa della sua posizione acritica, a negare ogni realtà a ciò che non è riconducibile a leggi fisico-meccaniche. Affinché gli oggetti appaiano “chiari e distinti” vengono falsificati in modo tale da obbedire ad una “chiarezza” presupposta.
L’ipotesi, come espressione di un’ ideologia acritica della realtà, ha così costretto l’osservatore a disgregare l’oggetto ed il fenomeno in parti semplici; si rende allora necessario il terzo momento, quello del modello. In esso l’oggetto che è stato distrutto, viene ipoteticamente ricostruito.
Dunque i tre momenti dell’indagine si risolvono come segue: Ipotesi, Osservazione – ovvero distruzione dell’oggetto e sua riduzione a misura dell’osservatore Modello interpretativo – ovvero ricostruzione dell’oggetto secondo i presupposti dell’ipotesi
E poiché l’oggetto, con la violenza del processo analitico, è stato ridotto all’obbedienza, riesce agevole ricomporlo secondo le premesse dell’ipotesi. In esso infatti tutto il resto è stato messo a tacere. Qui sta il motivo per cui lo scienziato contemporaneo è portato a negare tutto ciò che non è fisico meccanico: egli ha eliminato tutto questo dal fenomeno e quindi non lo puo’ vedere.
Da un riassemblaggio dell’oggetto partendo dai suoi pezzi, non può risultare altro che l’oggetto come macchina, come automa. Questa nuova costruzione non rispecchierà dunque le caratteristiche, o le leggi, del primo oggetto, che non c’è più, quanto quelle del secondo oggetto ricostruito. Il secondo oggetto, ricostruito a partire dalle parti semplici e dalle leggi fisico-meccaniche, sarà assai dissimile dal primo, ma ugualmente il modello interpretativo deriverà da esso. Qui sta il vero elemento di fragilità della concezione scientifica moderna, quello per il quale la scienza diviene una vera e propria falsificazione della realtà, un falso ontologico. Quando dunque questa ricomposizione pretenderà di diventare una teoria della realtà non avrà nessun valore e anzi avrà l’unico effetto di sviare la realtà e di trasformare la scienza in un sistema ottuso e arrogante di dogmi acritici.
Ciò avviene perché una parte delle leggi naturali, quelle che operano come leggi fisico-meccaniche, viene elevata abusivamente a rappresentare l’intera realtà, impedendo un ulteriore sviluppo e ampliamento dell’indagine scientifica.
Ciò da luogo alla concezione scientifica moderna come fenomeno acritico e ascientifico, come dogma ontologico e metodologico. Le determinazioni della scienza moderna valgono solo per gli oggetti che, tolti dal loro stato originario, sono stati tradotti in altri oggetti intelligibili per la scienza. In pratica: se lo strumento di conoscenza non è adeguato all’oggetto, invece di modificare lo strumento, si modifica l’oggetto per adeguarlo allo strumento. L’atteggiamento critico della scienza è rivolto ad ogni tipo di oggetto d’indagine tranne
che a se stesso come metodo e come presupposti. D’altra parte il metodo scientifico analitico è un valido attrezzo per scrutare quella parte di realtà che obbedisce alle leggi fisicomeccaniche, quelle leggi che, una volta conosciute, possono essere applicate e utilizzate. Ciò avviene nella costruzione delle macchine e nella tecnica. La macchina è la più eloquente verifica del metodo scientifico-analitico, come l’organismo ne è la più evidente smentita.
METODO INTUITIVO (GOETHEANISTICO)
Viene ad essere così tracciato sommariamente ciò che una scienza organica non dovrebbe essere, quali metodi non dovrebbe utilizzare.
L’operazione di scomposizione analitica deriva da un presupposto che il soggetto immette abusivamente nell’oggetto. Si tratta di un’operazione in contrasto con ciò che l’oggetto da di se stesso. Il mondo organico non permette di essere indagato come un meccanismo pena la totale perdita della sua verità oggettiva.
Dunque il metodo analitico si mostra del tutto inadeguato nell’ambito dell’osservazione degli organismi perché non è in grado di mettere a fuoco l’oggetto. L’organismo, infatti, non si presta ad essere disgregato senza cessare di essere se stesso. Con la disgregazione analitica si crea una reale modificazione dell’organismo la quale corrisponde alla sua morte.
L’organismo cessa di essere tale per diventare un’altra cosa. Non per nulla ciò che connota l’organismo, ciò che è il suo presupposto per la sua stessa esistenza è la sua unità, la sua integrità. L’organismo le presuppone da sé senza che noi facciamo nulla.
L’unità (come svolgimento) rappresenta l’elemento determinante dell’organismo. Questa unità dell’organismo e’ un dato oggettivo, il presupposto della propria esistenza. Questo dato oggettivo deve essere assunto nell’indagine con un grado di concretezza pari a tutti gli altri dati empirici. L’organizzarsi, lo strutturarsi dell’organismo è un processo oggettivo che avviene senza il nostro intervento. L’organismo stesso produce la propria unità come svolgimento. Noi dobbiamo limitarci a riconoscerla e a considerarla oggetto d’indagine.
In questo consiste il metodo d’indagine goetheanistico, e per questo esso è adeguato alla realtà degli organismi. Vi è dunque l’esigenza di tornare all’elemento originario dell’impulso scientifico: conoscere l’oggetto per quello che è.
Nel metodo goetheanistico vengono infatti a cadere tanto l’ipotesi che il modello e questo determina una profonda trasformazione anche del momento dell’osservazione. Essa assume una posizione centrale per il fatto che ad essa non viene anticipato il giudizio implicito nell’ipotesi. La riflessione dell’osservatore non viene utilizzata allo scopo di formulare ipotesi da anteporre all’oggetto e questo modifica la relazione tra osservazione e pensiero, modifica la reciproca posizione tra indagine dell’osservatore ed evidenza dell’oggetto. Questo viene messo nelle condizioni di mostrare ciò che gli è proprio, cioè di porsi ed esplicarsi come organismo.
L’osservazione assume dunque la forma dell’”osservazione pura”. Essa si trova così nelle condizioni di indagare l’oggettoorganismo nella sua immediatezza e nella sua autenticità.
Nel caso dell’organismo, è l’oggetto che deve svolgere se stesso come teoria. Esso, come svolgimento oggettivo di una
31
teoria, presenta una serie di particolari la cui sintesi avviene all’interno di se stesso come oggetto che si va ponendo nello spazio. L’osservatore deve cogliere questa unità sintetica oggettiva dell’oggetto. L’organismo porta in sé il principio che lo fa differenziare e organizzare. La sua struttura non è già data nello spazio (come nell’oggetto minerale), ma si va producendo, va emergendo nello spazio, e nell’emergere trae da sé la forza di differenziarsi.
Nell’ambito inorganico il soggetto che osserva organizza i fenomeni per ricondurli ad un ordine ideale, li ricostruisce per condurli al loro ordine. L’organismo invece presenta già dentro di sé il principio del proprio ordine e lo dispiega davanti all’osservatore. Questi deve assumere tale ordine come già dato dall’organismo, deve assumerlo come concreta realtà che opera nell’oggetto, come teoria interna (o idea interna) che raccoglie intorno a sé i processi organici. Nell’organismo l’idea (o se vogliamo, la teoria) va osservata oggettivamente. L’organismo è una unità che si attua nella differenza. L’osservazione deve cogliere la differenza come espressione dell’unità. Il pensiero, che nel metodo analitico viene utilizzato per la produzione di teorie e modelli, deve invece cogliere l’unità interna dell’organismo.
Prendendo come modello ciò che si osserva, ovvero il contenuto interno dell’organismo si fa venir meno, come detto, il terzo momento del metodo analitico, quello appunto della costruzione del modello. Dei tre momenti rimane così solo il secondo:
Osservazione – Idea come auto-movimento e modello interno
Fare l’esperienza dell’unità dell’organismo significa pensare nell’oggetto e non intorno all’oggetto.
Nel metodo goetheanistico si trasforma radicalmente il concetto di esperimento e la sua funzione. Nel metodo analitico, con l’esperimento si creano delle condizioni o delle premesse. Attraverso di esse vengono osservati aspetti semplici di un fenomeno complesso, aspetti poi che, alle stesse condizioni, sono riproducibili. L’esperimento è lo strumento per disaggregare la realtà concepita come ingranaggio. Attraverso di esso l’indagatore penetra negli oggetti e nei fenomeni individuando l’operare di leggi regolari. Nell’ambito inorganico, di ciò che giace nello spazio, tutto questo ha una sua legittimità. Lo spazio infatti è l’ambito di ciò che può essere osservato a livello sperimentale allo stato di semplicità. Questo modello cade però se entriamo nell’ambito organico. Qui l’elemento indivisibile e’ costituito dall’organismo stesso. Questo infatti non può essere diviso senza perdersi; la divisione è dunque cessazione o riproduzione, ma comunque è perdita dell’organismo originario. L’organismo invece si divide in se stesso, nel campo della propria unità. Mantiene se stesso come unità nella differenza. Esso si esplica in questa relazione tra unita’ e differenza. L’organismo possiede in sé il campo di esplicazione di leggi uniformi e riproducibili, è in sé, già nel proprio essere, il modello di esperimento nel quale (alle condizioni di esistenza dell’organismo stesso, intese come campo di eventi) si esplicano leggi in maniera regolare e riproducibile.
L’esperimento, nell’ambito organico, è presentato allora dall’organismo stesso e in questo senso la prima condizione da porre è che esso sia integro. Dato un organismo, si manifestano dei fenomeni e dei processi che sono espressione di leggi regolari. Poi occorre la condizione che esistano le circostanze esterne
che permettano all’organismo di mostrare tali fenomeni (es. nel caso di una pianta, terreno, luce etc.). Ogni volta che tali condizioni sono date l’esperimento riesce, l’organismo cioè si mostra come sede di processi regolari e ripetibili, riconducibili a leggi costanti. L’esperimento può essere sottoposto a “controlli intersoggettivi”. Le condizioni sono create della natura stessa, è essa che permette all’organismo di esistere con la relativa costanza delle variabili ambientali (basterebbe spostare di poche decine di gradi la temperatura per cancellare ogni organismo).
L’organismo manifesta allora, in maniera regolare e ripetibile, i processi che gli sono propri traendoli da se stesso. Dunque di fronte all’organismo assistiamo ad un capovolgimento del concetto di causalità rispetto all’ambito fisico-meccanico. L’organismo ha la causa della propria esistenza dentro se stesso, dove “dentro” significa fuori dallo spazio esteriore. Tutto ciò che agisce dall’esterno viene abbassato dalla posizione di causa a quella di “circostanza”, affinché quello che opera dall’interno possa manifestarsi.
Il principio causale di esistenza dell’organismo non appartiene allo spazio esteriore. Il suo rapporto con lo spazio esteriore è l’apparire. Con l’apparire l’organismo entra in relazione con le condizioni esterne.
L’elemento causale che opera nell’organismo deve quindi considerarsi indeterminabile nello spazio. Non giace nello spazio; nello spazio appare come modello interno, come auto-movimento che regge il processo di auto-organizzazione. Questo processo, non appartenendo allo spazio, non è dato nella forma. Anzi comporta un’instabilità della forma, potremmo dire una crisi della forma, una sua catastrofe. Questa crisi della forma, dell’esserci nello spazio, questa latente instabilità, apre un varco oltre lo spazio che, essendo invisibile come teoria, è però visibile nel processo morfogenetico. Questo farsi oggetto di osservazione da parte dell’organismo comporta incentrare l’osservazione in questo trapasso, dall’invisibile all’oggettività, come processo di produzione di forme.
Entro un determinato campo di fenomeni, cioè, l’idea rimane invariata, quel che varia è la sua manifestazione, la sua proiezione sul piano fisico, soggetta ad assumere di volta in volta caratteristiche diverse. Ma quel che si modifica è una forma fondamentalmente soprasensibile. Questa scoperta aveva colmato Goethe di una grande gioia. Negli studi di botanica quella forma fondamentale gli era apparsa come “l’archetipo, il modello ideale in base al quale la Natura crea tutte le piante”. Era questa la “pianta primordiale” (Urpflanze), la spirituale essenza archetipica del regno vegetale.
Il quadro dei meccanismi occulti mediante i quali la Natura procede nelle sue creazioni, si definisce nella concezione dell’essenza dell’organismo. Il modo in cui è considerato l’essere vivente permette di penetrare direttamente “nella sfera della vita organizzata dove le idee degli organi singoli scaturiscono da un’idea centrale”.
La più grande conquista di Goethe in ambito scientifico, e allo stesso tempo la più importante scoperta nel campo della biologia, è stata l’aver pensato le creazioni della Natura non in forme rigide, ma in perenne processo di trasformazione. Con l’idea della metamorfosi egli ha fornito una nuova chiave di lettura del divenire del mondo e dell’uomo. Ha mostrato concretamente come l’idea nella sua qualità di “forza divina
32 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
formatrice della Natura” operi fin nella struttura degli organismi viventi. Ha rivelato la possibilità, insita nello spirito umano, di cogliere quel lato della realtà inaccessibile ai sensi. Ma ha anche indicato come l’essere umano possa “riconoscere l’ideale nel reale e placare la sua inevitabile insoddisfazione del finito con l’innalzare questo all’infinito”. Non si tratta di verificare la coincidenza o meno dei due termini, ma di elevare l’esperienza sensibile fin dove diventa idonea a cogliere l’impronta dello Spirito. Questa posizione, tipicamente goethiana, non può essere giustamente compresa e apprezzata nel suo valore se non si tiene conto dell’ambito culturale entro cui è sorta, alla svolta tra il XVIII e il XIX secolo. La corrente del pensiero scientifico si stava orientando verso una rappresentazione del mondo che prescindeva da ogni elemento morale-spirituale.
L’evoluzione della specie umana e dell’intera natura poteva essere pensata dall’inizio alla fine senza alcun intervento di forze o potenze di ordine superiore. La contrapposizione tra Spirito e Natura si presentava ancora una volta nell’inconciliabilità dei due termini. Anche in ambito religioso la proposizione di fede, sostenendo la priorità dei valori dello Spirito, finiva per creare un distacco dalla sfera sensibile-naturale senza tuttavia poter dare, intorno a quelle superiori realtà, quelle certezze alle quali poteva giungere il modo di pensare scientifico. In duplice modo, e quasi inavvertitamente, l’uomo andava perdendo il giusto rapporto con la natura: in virtù di una spiritualità falsamente intesa o in difetto della stessa arbitrariamente eliminata. Nella coscienza umana Spirito e Natura risultavano in ogni caso divisi.
In questo difficile contesto solo Goethe ha compiuto il grande passo. Osservando il procedere della Natura dal gradino dell’inorganico all’organico ha trovato quel punto nel quale l’elemento fisico-sensibile trapassa nello spirituale soprasensibile: ha mostrato come nella natura corporea permeata di vita, si manifesti l’azione di un mondo spirituale anch’esso pienamente vivente. Ha così riannodato il sottile filo che congiunge la Natura allo Spirito ed ha restituito al mondo dei sensi e al mondo delle idee la loro originaria unità, di cui l’uomo è parte integrante e punto di coscienza. Il mondo fisico, illuminato dalla luce dello Spirito, può risorgere infatti, come più alta realtà compiuta in se stessa, solo nella coscienza umana. Gli esseri spirituali non possono avere coscienza della natura, così come gli esseri naturali, ad eccezione dell’uomo, non possono avere coscienza dello spirito. L’uomo come cittadino dei due mondi è di fatto il loro anello di congiunzione e porta la responsabilità di far sorgere questa consapevolezza nella chiarezza della propria coscienza. E Goethe è stato il primo che ha avviato questo cammino di ricongiunzione basato però, appunto, sulla coscienza e non su una vaga e trascendente sensazione di appartenenza.
LO SVOLGERSI DELLE RICHERCHE DI GOETHE
Prima di Goethe la scienza naturale non conosceva l’essenza dei fenomeni della vita e studiava gli organismi semplicemente secondo la composizione delle parti e i caratteri esteriori come si studiano anche gli oggetti inorganici. I particolari, considerati come tali, non portano con sé il loro principio esplicativo; solo la natura dell’insieme li spiega, poiché è l’insieme che da loro essenza e significato.
Ne scaturisce la grandiosa costruzione di pensiero di un vivente complesso di leggi formative interagenti il quale per forza
propria determina i particolari, le singole tappe dello sviluppo. Quando Goethe giunse all’università di Lipsia, vi regnava negli studi naturali quello spirito caratteristico del XVIII secolo che divideva la scienza in due settori: da una parte la filosofia di Christian Wolf che si muoveva in una sfera del tutto astratta, e dall’altro i singoli rami della scienza che si perdevano in una miriade di particolari. Questi non avevano l’aspirazione a cercare nel mondo dei loro oggetti un principio superiore, quella non riusciva a trovare il passaggio dai suoi concetti generali al regno della realtà immediata. Stavano di fronte, senza possibilità di conciliazione una dottrina dei principi, alla quale faceva difetto il contenuto vivente, l’amorevole adesione alla realtà immediata, e una scienza senza principi, priva di contenuto ideale. Ciascuna era infeconda per l’altra. La sana natura di Goethe veniva a trovarsi ugualmente respinta da queste unilateralità.
Per questi motivi si sviluppò per primo in Goethe il concetto della vita, ovvero quello che meno di ogni altro poteva venir afferrato da quei due punti di vista estremi.
Un essere vivente ci mostra una serie di particolari che costituivano appunto l’oggetto di una estesa trattazione da parte della seconda delle due correnti prima accennate. In questo modo però si potrebbe anche descrivere un meccanismo; si dimenticava completamente che nell’organismo di manifesta un principio interiore e che in ogni organo agisce il tutto. Quell’apparenza esteriore, quella contiguità tra le varie parti può essere osservata anche quando l’organismo è morto, ma a quel punto esso non è più un organismo perché ne è scomparso il principio.
A questa maniera di osservare Goethe contrappone la possibilità e necessità di un’altra osservazione più elevata. Ne parla anche nel Faust:
Chi brama di conoscere qualcosa di vivente e di descriverlo, cerca prima di scacciar lo spirito; così le parti ha in mano, e non gli manca, ahimè, che l’essenziale: il nesso spirituale!
Egli matura l’idea di un essere nel quale ogni parte vivifica le altre e un principio compenetra tutti i particolari. Questa entità è pensata soggetta nel tempo a trasformazioni costanti, ma, in tutti i gradini della trasformazione, si manifesta sempre come unica e si afferma come duratura e stabile nella mutazione. Goethe scriverà poi, nel 1807, nella sua Teoria della metamorfosi: “Ma se osserviamo tutte le forme, e particolarmente le organiche, non troveremo mai alcunché di duraturo, quiescente e delimitato, anzi tutto ondeggia in perpetuo movimento”.
A questo ondeggiare egli contrappone, quale elemento costante, l’idea, ovvero “un quid tenuto fermo nell’esperienza solo per un attimo”.
In questi anni Goethe espose per esteso nel saggio La Natura le sue idee che si andavano formando sempre più chiaramente. Questo saggio ha un’importanza speciale perché vi si trovano coordinate tutte le idee che Goethe aveva solo accennato qua e là. Vi incontriamo l’idea di un essere in continuo mutamento eppure sempre identico a se stesso: “Tutto è nuovo, e pur sempre lo stesso”.
Linneo aveva provveduto a classificare le piante per poter
33
trovare facilmente il loro posto nel sistema. Egli metteva in evidenza soprattutto i caratteri distintivi, considerando come peculiari i caratteri esteriori. Le piante risultavano così in un certo ordine, che però si sarebbe potuto applicare anche a corpi inorganici. Tali caratteri si mostravano in una contiguità esteriore, senza un intimo nesso necessario. Goethe non poteva contentarsi di questo modo di considerare gli esseri viventi, poiché nel sistema di Linneo non si cercava mai l’essenza della pianta. Egli invece si chiedeva in cosa consiste il quid che fa di un essere naturale una pianta e che si ritrova in tutte le piante, e ciò non di meno v’era tutta l’infinita varietà degli esseri singoli che chiedeva una spiegazione. Come avviene che quell’uno si manifesti in forme tanto svariate?
Contemporaneamente all’incontro con le opere di Linneo avviene anche quello con le opere di Rousseau. L’attività botanica di Rousseau fece una profonda impressione su Goethe perché si svolgeva in un senso che gli andava più a genio, soprattutto la freschezza e l’immediatezza dell’osservazione che si rivolgeva alla pianta per amore di quest’ultima, prescindendo affatto da principi utilitari. Entrambi avevano in comune l’essere arrivati allo studio delle piante, non attraverso un’aspirazione scientifica coltivata specialisticamente, ma per motivi umani generali.
Anche Darwin prese lo spunto da osservazioni simili, e da questa variabilità corroborò i propri dubbi sulla costanza dei caratteri esteriori di genere e di specie. Però i due scienziati pervennero a risultati del tutto diversi. Mentre Darwin considera esaurita l’essenza dell’organismo nelle proprietà suddette e ne deduce che non vi sia nulla di costante nella vita delle piante, Goethe si spinge più a fondo e conclude: se quelle proprietà non sono costanti, allora l’elemento costante va cercato in qualcosa di differente, che sta alla base di quelle esteriorità variabili. Goethe si pone la meta di sviluppare l’elemento costante, mentre Darwin si sforza di indagare nei particolari le cause di quella variabilità.
La concezione goethiana è molto più ampia e comprende due aspetti:
a. la legge che si manifesta nell’organismo, la vita che si svolge da se stessa e possiede la forza e la capacità di svilupparsi (grazie alle possibilità insite in essa) in molteplici forme esteriori.
b. l’azione reciproca tra organismo e natura inorganica nonché tra i vari organismi (adattamento e lotta per l’esistenza).
Darwin svolge solo quest’ultimo aspetto della scienza degli organismi. La teoria darwiniana è quindi lo sviluppo di un solo aspetto delle idee fondamentali di Goethe. Sviluppando solo uno dei lati non si potrà giungere a una teoria completa degli organismi.
Gli organismi si lasciano influenzare dall’ambiente che li circonda, assumono, sotto la sua azione, condizioni diverse, ma lo fanno in modo corrispondente alla loro natura essenziale, a quel quid che ne fa appunto degli organismi. Solo chi è dotato di comprensione per questa essenza degli organismi sarà in grado di comprendere perché essi rispondano a determinati stimoli in un determinato modo e in nessun altro.
L’idea della pianta-tipo si delinea sempre più definita e chiara nello spirito di Goethe. Il 27 settembre 1786, nel giardino botanico di Padova gli “si venne facendo sempre più vivo il pensiero che forse tutte le forme vegetali si potessero sviluppare da una sola”. Il 19
febbraio 1787, essendo a Roma, scrive di trovarsi in procinto di “scoprire alcune nuove e belle vie per le quali la natura compie il prodigio, così insignificante in apparenza, di sviluppare il molteplice dal semplice”. Il 17 aprile 1787, da Palermo, scrive ancora della pianta tipo: “Essa deve pur esistere; come potrei altrimenti riconoscere che questa o quella formazione è una pianta, se non fossero tutte formate secondo un solo modello?” Egli intende parlare del complesso di leggi formative che organizza la pianta e ne fa ciò che essa è; ciò per cui, di fronte ad un determinato oggetto di natura, ci rendiamo conto che si tratta di una pianta; ecco che cos’è la pianta-tipo. E’ un quid ideale, afferrabile solamente con il pensiero, che acquista una certa forma, grandezza, colore, numero di organi, ecc. Questa figura esteriore non e’ nulla di fisso, al contrario puo’ subire innumerevoli modificazioni tutte conformi a quel complessi di leggi formative, tutte derivanti da esso con necessita’. Questo quid è posto dalla natura a fondamento di ogni singolo individuo vegetale. Il 17 maggio 1787 scrive a Herder: “Debbo confidarti che sono vicinissimo al mistero della generazione dei vegetali e che si tratta della cosa più semplice che si possa pensare....Con il mio modello si possono inventare piante all’infinito e piante coerenti che, se anche non esistono, potrebbero però esistere, e non sono ombre o fantasmi poetici, ma hanno, al contrario, una loro intima verità e necessità. La stessa legge potrà venir estesa a tutti i viventi”. Qui si può scorgere la profonda differenza tra la concezione di Darwin e quella di Goethe. Per il primo gli influssi esterni agiscono sulla natura di un organismo come cause meccaniche e come tali lo modificano. Per Goethe invece le singole modificazioni sono l’estrinsecazione dell’organismo primordiale il quale ha in sé la capacità di assumere molteplici aspetti e assume quello più appropriato alle condizioni ambientali. Queste condizioni ambientali sono soltanto l’occasione perché le forze formative intrinseche si manifestino in modo particolare, e solamente queste ultime sono l’elemento creativo della pianta. Ecco perché Goethe, il 6 settembre 1787, lo chiama έν και παν (uno e tutto).
L’IMPORTANZA DI GOETHE SCIENZIATO
I lavori morfologici di Goethe hanno importanza per il fatto che essi pongono le basi teoretiche e il metodo per lo studio delle nature organiche.
Per una giusta valutazione di ciò è necessario tener presente la grande differenza che passa tra i fenomeni della natura inorganica e quelli della natura organica. I primi permettono di essere penetrati concettualmente e, nelle stesse condizioni, i fenomeni si producono di necessità, sempre uguali a se stessi. Quello che si offre ai nostri sensi è una necessaria conseguenza di quello che abbiamo presupposto idealmente. Non c’è niente nel fenomeno che non sia nel concetto e niente nel concetto che non sia anche nel fenomeno.
I processi della natura inorganica vengono determinati da condizioni che appartengono anch’esse al mondo dei sensi. Le circostanze percepibili con i sensi si condizionano l’una con l’altra. La comprensione concettuale di tali processi non è altro che la deduzione di realtà sensibili da altre realtà sensibili. Non abbiamo bisogno di uscire dal mondo dei sensi: nel suo seno deduciamo un fenomeno dall’altro. Possiamo percepire tutto quello che vogliamo comprendere. Questa è l’essenza della natura inorganica: possiamo spiegarla per se stessa senza varcarne i confini. Non si è mai esitato a spiegare i fenomeni nel modo descritto, cioè a partire dalla natura del loro proprio
34 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
essere.
In un vivente invece i rapporti sensibili non appaiono conseguenza di altri rapporti percepibili dai sensi. Le qualità sensibili appaiono piuttosto come conseguenze di una condizione che non è più percepibile dai sensi, di una unità superiore al di sopra dei processi sensibili. L’osservazione allora non basta più, dobbiamo afferrare l’unita’ concettualmente, se vogliamo spiegare i fenomeni. L’oggetto non appare più spiegabile da se stesso (cioè dalla sua parte fisico-sensibile), perché il suo concetto è tolto non da esso medesimo, ma da qualcos’altro.
Nel mondo organico non è un membro di un essere che determina l’altro, ma il tutto (l’idea) produce ogni particolare da se stesso, conforme alla propria essenza. Questo elemento autodeterminantesi possiamo chiamarlo con Goethe ENTELECHIA; esso è la forza che per virtù propria chiama se stessa alla vita. Quel che compare nel fenomeno ha pure vita propria, ma questa è determinata dalla forza dell’entelechia.
E’ però anche spiegabile che un organismo sia esposto agli influssi del mondo dei sensi come qualunque altro corpo. Non essendo quindi soggetto solo alle proprie leggi formative, ma anche alle condizioni del mondo esteriore, esso non appare mai completamente adatto a se stesso e obbediente unicamente alla sua propria essenza. Se immaginiamo allora un organismo soggetto solo agli influssi del suo principio troviamo l’idea dell’organismo primordiale, del tipo di Goethe.
Si vede l’alta legittimità di questa idea. Non è un semplice concetto logico, è ciò che in ogni organismo costituisce il vero elemento organico senza il quale esso non sarebbe un organismo. è persino più reale di ciò che in ogni singolo organismo si manifesta, esprime più pienamente, più puramente l’essenza dell’organismo di qualunque singolo organismo.
Il concetto del processo inorganico è derivato astrattamente dalla realtà, non è attivo in essa; l’idea dell’organismo, invece, è attiva e operante nell’organismo stesso. Non sintetizza l’esperienza, ma produce gli oggetti dell’esperienza. Goethe, nei Detti in prosa, lo riassume così: “Il concetto è somma, l’idea è risultato dell’esperienza; a compiere quella ci vuole l’intelletto, per afferrare questo occorre la ragione”.
Questo metodo goethiano è manifestamente l’unico possibile per penetrare nell’essenza del mondo degli organismi.
Nell’inorganico il fenomeno non è identico alla legge che lo spiega, ma la indica semplicemente. La percezione, l’elemento materiale, e il concetto, l’elemento formale, si contrappongono come due elementi che si postulano reciprocamente, ma in modo che il concetto non sta nei singoli elementi ma nel rapporto di questi tra di loro. Questo rapporto è fondato nelle singole parti del dato, ma nella sua totalità non assurge a manifestazione reale. All’esistenza esteriore pervengono solo i membri del rapporto; l’unità, il concetto, si manifesta solo nel nostro intelletto. Esso riassume la varietà fenomenica e si comporta rispetto a questa come somma.
Nella natura organica le parti di uno stesso essere non stanno tra loro in tale rapporto esteriore. L’unità si realizza nell’oggetto percepito: il rapporto tra i singoli membri è divenuto qualcosa di reale. Non assurge più a manifestazione concreta solo nel nostro intelletto, bensì nell’oggetto stesso. Il concetto non ha più funzione di somma che abbia il suo oggetto fuori di sé, ma si è con esso completamente unificato. Quel che vediamo non è diverso dal mezzo con cui pensiamo il veduto. La spiegazione
(cioè la parte formale della conoscenza), il concetto, e ciò che viene spiegato (la parte materiale) sono identici. L’idea dunque non riassume semplicemente, come una somma, una molteplicità data, ma estrinseca da sé il proprio contenuto. Essa è il risultato del dato: è fenomeno concreto.
Nell’inorganico spieghiamo i fatti per mezzo delle leggi naturali, nell’organico lo facciamo per mezzo dei tipi. La legge non si identifica con l’osservato, ma ne sta al di sopra; nel tipo l’ideale e il reale sono divenuti unità. Nella conoscenza di questo rapporto tra la scienza dell’inorganico e quella dell’organico sta l’importanza della ricerca goethiana.
Nella natura organica l’unità ideale estrinseca da sé una serie di organi sensibili in sequenza temporale e in contiguità spaziale, genera i suoi vari stati dalla propria interiorità; un essere organico è comprensibile solo nel suo divenire; il corpo inorganico è invece in sé conchiuso, rigido, eccitabile solo dal di fuori, ma internamente immobile. L’organismo è l’irrequietezza stessa, trasformantesi da dentro a fuori in continue metamorfosi. Per questo Goethe dice: ”La ragione (dell’organico) è rivolta al divenire, l’intelletto (dell’inorganico) al divenuto; quella non chiede ‘a che?’, questo non chiede ‘donde?’. Quella si compiace dello sviluppo, questo vuol tutto consolidare affinché serva”.
L’entelechia della pianta appare come forza formativa dei singoli organi, i quali sono tutti configurati secondo uno stesso tipo formativo: appaiono come modificazioni di un organo fondamentale, come sua ripetizione a diversi gradi di sviluppo. Così ogni organo appare identico agli altri e anche alla pianta intera. La formazione della pianta progredisce di gradino in gradino e forma organi, ogni organo è identico a qualunque altro, cioè è identico al principio formativo, sebbene fenomenicamente differente. L’interiore unità della pianta si dilata nello spazio, si estrinseca nella varietà, sinché non raggiunge un’esistenza concreta dotata di una certa indipendenza, che si contrappone, come centro vitale, alla varietà degli organi e li adopera quali intermediari col mondo esteriore.
Sorge spontanea la domanda: da che cosa viene prodotta questa varietà fenomenica degli organi della pianta, i quali, secondo il principio interiore, sono identici? La diversità, nella vita della pianta che si svolge completamente nell’interiorità, può poggiare anch’essa su elementi spaziali. Goethe considera come tali un’ordinata espansione e contrazione. Il principio dell’entelechia entrando nell’esistenza si manifesta come spaziale: le forze formative operano nello spazio, generano organi di forma spaziale determinata. Queste forze o si concentrano tendendo verso un unico punto (concentrazione) o si allargano allontanandosi l’una dall’altra (espansione). Nella vita totale della pianta si concentrano tre espansioni e tre contrazioni.
Seme – foglia espansione
Foglia – calice contrazione
Calice – corolla espansione
Corolla – pistilli contrazione
Pistilli – frutto espansione
Frutto – seme contrazione
Il seme è allora il punto nel quale la pianta è contratta (concentrata) al massimo. Con le foglie si ha il primo sviluppo, il primo espandersi delle forze formative. Ciò che nel seme è
35
concentrato in un punto, si espande spazialmente nelle foglie. Nel calice le forze si contraggono di nuovo verso un punto assiale. La corolla è il risultato dell’espansione successiva, gli stami e il pistillo sono l’ulteriore concentrazione, mentre il frutto è l’ultima (terza) espansione, prima della nuova concentrazione nel seme. In esso tutta la forza vitale della pianta (questo principio di entelechia) si cela nuovamente nella sua massima contrazione. Goethe non considera l’espansione e la contrazione come conseguenze della natura, dei processi inorganici derivanti dalla pianta, bensì le considera il modo in cui quell’interiore principio dell’entelechia si configura.
La vita delle piante viene sostenuta dal ricambio materiale; rispetto ad esso si manifesta una diversità fondamentale tra quegli organi che sono più vicini alle radici, che assorbono i nutrimento dalla terra, e quelli che ricevono le materie nutritive già passate per altri organi. I primi appaiono immediatamente dipendenti dal loro contorno organico esterno, i secondi dalle parti organiche che li precedono. La natura procede dal seme al frutto in un seguito di posizioni che è detto da Goethe un procedere su di una scala spirituale.
Quel che in un organismo vivente si presenta in forma definita, conclusa, circoscritta, costituisce per Goethe una delle possibili manifestazioni di un “ente primordiale, ideale che vive in tutte le forme”. La natura non realizza mai pienamente, in un singolo essere, le sue intenzioni. Ha bisogno dell’intera cerchia della creazione, della linea ascendente delle sue creature per avvicinarsi sempre più alla meta. Egli vede la Natura impegnata in un continuo sforzo ascensionale, nella creazione di forme che “portino sempre meglio alla luce, fin nell’aspetto esterno, le idee delle cose”.
CONOSCENZA E FILOSOFIA
Fino a Goethe l’abisso incolmabile tra idea ed esperienza era generalmente ammesso dalla scienza. Alla natura organica si fermava la possibilità della conoscenza umana. Kant riconosceva all’intelletto umano la proprietà di poter pensare all’unità, al concetto di una cosa, ma solo come derivante della collaborazione delle parti. Un universo analitico, cioè, acquisito mediante astrazione, non tale però che ogni singola parte appaia in forma intuitiva quale estrinsecazione di una determinata (sintetica) unità, di un concetto. Così stavano le cose quando Goethe cominciò ad occuparsi di scienze organiche. Egli si accinse a studiarle dopo ripetute letture del filosofo Spinoza. Goethe aveva incontrato le sue opere per la prima volta nel 1774. Spinoza riconosce tre generi di conoscenza. Il terzo, il più elevato, è quello per cui, da una sufficiente conoscenza di alcuni attributi di Dio, progrediamo ad una sufficiente conoscenza dell’essenza delle cose. Egli la denomina scientia intuitiva. A quest’ultimo, supremo genere, Goethe aspirava. Il Dio di Spinoza è il contenuto ideale del mondo, il principio motore che tutto spinge, sostiene e guida. Filosoficamente il principio primordiale si può rappresentare come un essere indipendente, per sé stante, separato dagli esseri finiti, che ha accanto a sé le cose finite, le domina e le pone in azione reciproca. Questa concezione considera il mondo finito come manifestazione dell’infinito, ma questo infinito rimane sussistente nel proprio essere, non prodiga nulla di sé. Non esce da se stesso, rimane quello che era prima della sua manifestazione.
Altrimenti ci si rappresenta questo essere effuso nelle cose finite, sì da esistere non più sopra o accanto ad esse, ma solo in
esse. Durante la creazione esso ha donato se stesso al mondo e vive quindi nella creazione. Questa concezione non nega il principio primordiale, ma lo considera EFFUSO nel mondo. Considera anch’essa il mondo finito come manifestazione dell’infinito, ma presuppone che questo infinito, nel suo manifestarsi, sia completamente uscito da se stesso, abbia deposto se stesso, la propria essenza e vita nella sua creazione, sicché ormai esista solo in questa.
Allora, poiché il conoscere è manifestamente uno scoprire l’essenza delle cose, e potendo questa solo consistere in quella parte che un essere finito ha del principio primordiale di tutte le cose, conoscere significa scoprire quell’infinito nelle cose. Prima di Goethe, non potendo riconoscere nella natura organica l’essenza che si manifesta nell’oggetto, la si presupponeva fuori dall’oggetto. Spinoza aveva dimostrato la necessità di una conoscenza unitaria, ma egli era troppo filosofo per estendere questa esigenza teoretica alla natura organica. Questo compito spettava a Goethe.
Goethe ha fondato le basi teoretiche per la scienza organica. Ha trovato l’essenza dell’organismo. Per chiunque abbia compreso quel “formarsi da sé per forza propria” del principio dell’entelechia, questo rappresenta la soluzione del problema della vita. Mentre il darwinismo deve presupporre un organismo primordiale (intendendo con esso una cellula primordiale “protocitode”), si può dire di Goethe che egli ha scoperto l’essenza di quell’organismo. Egli ruppe il semplice allineamento di generi e specie uno accanto all’altro e intraprese la rigenerazione della scienza organica in base all’essenza dell’organismo.
Tanto nel regno animale che in quello vegetale domina una serie ascendente di stadi evolutivi. Con organismi che si dividono in perfetti ed imperfetti. Quando la forma reale sensibile si manifesta essa può corrispondere più o meno completamente a quella ideale; ciò significa che il tipo può giungere al suo completo sviluppo o no. Gli organismi inferiori sono tali poiché la loro forma fenomenica non corrisponde compiutamente al tipo organico. Quanto più fenomeno e tipo organico corrispondono in un determinato essere, tanto più esso è perfetto.
Le idee di Goethe non sono solo una profezia poetica di scoperte successive, ma sono scoperte teoretiche indipendenti da cui la scienza naturale dovrà trarre alimento per molto tempo. Quando i fatti empirici da lui utilizzati saranno superati, e in parte persino confutati, da più esatte ricerche particolari, le idee proposte rimarranno fondamentali per la scienza organica poiché indipendenti da quei fatti empirici. Il cielo stellato si vedeva molto tempo prima di Keplero e Copernico, ma essi ne scoprirono per primi le leggi, così molto prima di Goethe si osservava il regno naturale organico, ma egli ne scoprì le leggi.
Egli non fu subito cosciente di questo lato della sua teoria, ma essa divenne obbiettiva per lui dopo i colloqui con Schiller. Questi riconobbe subito la natura ideale della pianta primordiale di Goethe e sosteneva che nessuna realtà poteva esserle commisurata. Goethe fu così stimolato a riflettere sul rapporto tra il tipo e la realtà empirica. Si imbatté così in uno dei più significativi problemi dell’indagine umana: quello del rapporto tra idea e realtà tra pensiero ed esperienza. Quello che nel normale processo di conoscenza si offre all’osservatore, rappresenta solo una parte della realtà; l’altra può’ manifestarsi allo spirito umano in quanto questo
36 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
muova incontro alla realtà stessa e vi si contrapponga. Ciò che giunge da fuori deve unirsi a quel che sorge da dentro, perché possa formarsi un’immagine unitaria e veritiera della realtà. Diversamente ogni esperienza risulterà frammentaria e incompleta.
Per essere valido un processo di conoscenza deve comprendere ambedue gli elementi che lo compongono e trovare dove essi si incontrano e si unificano.
Goethe era convinto che quanto si rivela allo spirito umano, allorché si rivolge alla Natura, esprima le leggi oggettive dell’ordinamento naturale. Il dubbio sull’attendibilità del processo conoscitivo umano e sul valore dei risultati conseguiti si rivela privo di significato. Soggettivo e oggettivo vengono infatti a coincidere “quando il mondo oggettivo delle idee rivive nel soggetto, quando nello spirito dell’uomo vive ciò che è attivo anche nella Natura”. “Non è l’uomo – in tal caso – che parla della Natura, ma la Natura che parla all’uomo di se stessa”.
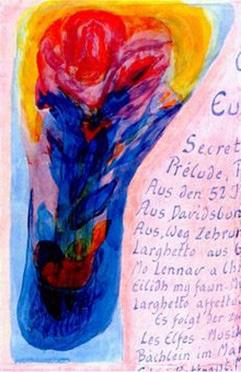
La via da percorrere passa attraverso l’esperienza, intesa non solo nel suo ruolo di “mediatrice tra soggetto e oggetto”, ma come strumento atto a congiungere i dati stessi dell’esperienza con
l’idea. Sta all’uomo trovare il passaggio dall’una all’altra. Ogni reale possibilità di conoscenza risulta in definitiva dalla continua oscillazione, da un “movimento alternante” fra esperienza e idea.
Questo pensiero, chiaramente formulato, fa cadere la separazione tra l’esperienza e l’idea, o la distinzione fra il mondo dei sensi e il mondo dello Spirito, ma lascia intendere che l’umana conoscenza, varcando i consueti limiti, può continuare oltre la soglia del sensibile. Se infatti il mondo reale è la “manifestazione di una essenza ideale”, è implicito che l’uomo si trova già in quella sfera dove le superiori forze creatrici diventano percettibili attraverso il loro stesso operare. Ciò non comporta comunque che, nella comune esperienza, l’idea possa offrirsi direttamente alla percezione; è pur sempre lo spirito umano che deve spingersi fino a cogliere l’essenza ideale delle cose. Ed è in grado di farlo perché lo spirito umano e l’essenza delle cose fanno parte dello stesso mondo spirituale. Goethe ha dimostrato coi fatti che all’uomo è concesso questo genere di conoscenza.
37
Rudolf Steiner, Urpflanze, acquerello, 1924
Nyár. Kert. Csönd. Dél. Ég. Föld. Fák. Szél. Méh döng. Gyík vár. Pók ring. Légy száll. Jó itt. Nincs más csak a kis ház. Kint csönd és fény. Bent te meg én.
Estate. Giardino. Silenzio. Mezzogiorno. Cielo. Terra. Alberi. Vento. L’ape ronza. La lucertola aspetta. Il ragno dondola. La mosca vola. E’ bello qua. C’è solo la casetta. Fuori: silenzio e luce. Dentro: io e te.

38 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
Szabó Lőrinc: nyár
Lőrinc Szabó: EStatE
Claude Monet, I papaveri, 1873. Olio su tela, 50x65 cm, Parigi, Musée d’Orsay.
traduzione di K.Sz.
vOn rOSen Und diSTeln“
„
Ein Märchen von Johannes Rosenstock, 2021
I.
Es war einmal ein Mädchen, das lebte im Land der Rosen. Hier war der Himmel immer heiter und die Sonne lachte den langen Tag. Die Menschen hatten große Herzen und sangen, tanzten und freuten sich gern und viel. Das Mädchen war die Tochter des Rosenkönigs und liebte sein Leben sehr. Jeden Tag wandelte sie glücklich durch den Garten des Palastes, sprach mit den vielen Rosen und sang für sie.
Doch eines Nachts träumte sie, dass der Himmel ganz dunkel wurde und alle Rosen im Land verwelkten, und ihr Blick ging weit in eine große Ferne, wo in einer kalten, grauen Gegend einsam eine goldene Rose stand. Sie erwachte mit bangem Herzen und wusste nicht, was der Traum bedeuten sollte. Draußen aber lächelte der lichte Tag sie an, Rosenduft wehte in ihre Kammer herein, und bald hatte sie den schrecklichen Traum vergessen.
Kaum war ein Jahr vergangen, da zogen große Wolken am Himmel herauf, die verdunkelten den Tag und raubten dem Rosenland das Licht der Sonne. Die Rosen begannen zu welken, und Angst sowie Trauer ergriffen die Rosenmenschen, die sonst so reich mit Glück gesegnet waren. Bald erkrankte der König, doch die Dunkelheit wollte nicht weichen und die Sonne freigeben. Niemand vermochte die Angst der Menschen zu stillen oder ihre Krankheit zu heilen.
Da weissagte der Älteste im Rosenlande, der in einem Dornbusch im Walde lebte, dass es einen Menschen im Rosenvolk gebe, der das Rosenland retten könne. Dieser werde einen Traum haben, darin er eine goldene Rose in der Ferne schaue, und müsse dann ausziehen, um diese besondere Rose zu finden und heimzubringen.
“Die Menschen lieben die ROSEN aus dem Grunde -sie wissen es nur nicht-, weil die Rosen die allerersten Kindheitserinnerungen aufnehmen.”
“(...) jenes Seelische, das wir entwickelt haben während der ersten Kindheit, indem wir zum Beispiel grausam waren, das steckt auch in uns; das nimmt aber die DISTEL auf.”
Rudolf Steiner
Als das Mädchen von der Weissagung erfuhr, erschrak es, denn es erinnerte sich seines Traumes vor einem Jahr. Doch sie glaubte nicht, dass sie, ein Kind noch, dieser Mensch sein könne, und dass ein anderer sich melden werde, ein Ritter vielleicht, der die goldene Rose im Traum erblickt habe, und losziehen werde, sie zu holen. Tage vergingen und Wochen, doch niemand im Rosenvolk träumte von der goldenen Rose.
Der König sprach mit traurigem Blick zu seiner Tochter: „Es ist aus, mein liebes Kind. Das Rosenreich wird untergehen, ehe du zu seiner neuen Königin geworden bist. Es bricht mir das Herz“. Da nahm das Mädchen allen Mut zusammen und antwortete: „Nein, geliebter Vater, noch blüht ein wenig Hoffnung in der Ferne für uns, denn ich habe die goldene Rose im Traum gesehen und werde ausziehen, sie zu suchen.“
II.
Sie wanderte weit und immer weiter und durchquerte das ganze Rosenreich. Jede Nacht träumte sie von der goldenen Rose und wusste andren Tags, in welche Richtung sie zu gehen habe. Als einige Zeit verstrichen war, sah sie vor sich ein von Nebeln durchzogenes Gebirge aufragen, und betrat es zwischen zwei Felsen hindurch, die zusammen ein Tor bildeten. Mit großer Mühe bestieg und durchquerte sie das felsige Gebirge- nie zuvor hatte sie sich so anstrengen müssen.
Jenseits des Gebirges aber erkannte sie die fremde, raue Landschaft, welche sie in dem verheißungsvollen Traum gesehen hatte, und wusste nicht, ob sie sich freuen sollte oder weinen. Denn kalt war es hier, der Himmel hing schwer und grau herab, und schroff und abweisend wirkte das steinige Land. Diese Landschaft war so recht das Gegenteil von ihrer herrlichen Heimat, und sie fragte sich, wie hier eine Rose wachsen solle.
39
Was aber viel in diesem Lande wuchs, das waren Disteln. Mit ihren stachelbewehrten Stängeln und zackigen Blättern standen sie überall am Wegesrande und auf den kargen Feldern und stachen und kratzten jeden unerbittlich, der ihnen zu nahe kam. Selbst der Wind schien sie nicht streifen zu wollen. Das Rosenmädchen schritt furchtsam umher, bemaß jeden Schritt, hielt die Arme dicht am Leib und den Atem fast still, dass bloß keine Distel sie berühren möge. Sie war furchtbar erschöpft und durstig und hungrig wie noch nie in ihrem Leben. Doch nirgendwo fand sie eine Quelle, die ihr Wasser, oder einen Baum, der ihr seine Früchte schenken konnte. In ihrer Heimat hatte sie solch einen Mangel nie gekannt, dort war alles immer für alle im Überfluss vorhanden gewesen. Hier im Distelland aber herrschte bittere Armut. Bald traf sie auf die Distelmenschen, die ihr so abweisend wie die Disteln und das karge Land begegneten. Ihr Blick hing meist am Boden, ihre Schritte waren schwer und ihre Bewegungen grob, ein Lächeln schienen sie nicht zu kennen. Die meiste Zeit des Tages verrichteten sie harte Arbeit und mühten sich dabei ab, große Felsblöcke und Steine zu zerschlagen, von denen das Land einen unerschöpflichen Vorrat hatte. Tagaus, tagein ergaben sie sich in dieses schweigsame, seltsame Werk. Das zarte Mädchen mit seinen offenen, strahlenden Augen konnte ihr entbehrungsreiches Tun nicht begreifen. Doch wenn sie sich nach dessen Sinn erkundigte, bekam sie nur immer wieder dieselbe unfreundliche Antwort: „Die Königin will es so. Frag nicht mehr, zerschlag die Steine!“ Es interessierte sich auch niemand für ihre Geschichte, und als sie nach der goldenen Rose fragte, schauten die Distelmenschen sie mit leeren Augen an.
So musste sich das arme Kind nun selbst in das harte Tagewerk ergeben, denn niemand schenkte hier dem anderen etwas. Wollte sie etwas essen oder trinken, musste sie schwere Arbeit dafür verrichten. Im Rosenland hatte jeder gerne von dem gegeben, was in seiner Hand oder in seinem Hause war. Hier aber musste man alle Kraft seines Leibes aufbringen, um nur spärliche Gaben zu bekommen. Und immer stieß man bei der Arbeit irgendwo an eine Distel und trug Kratzer und Wunden davon.
Die Rosentochter wäre sofort aus diesem Land geflohen, wenn sie nicht insgeheim wusste, dass sich hier irgendwo die goldene Rose verbarg, um derentwillen sie die geliebte Heimat verlassen hatte. Jede Nacht streifte sie in den wilden Disteln umher, auf der Suche nach der Rose ihres Traumes. Doch nirgendwo in dieser unfreundlichen Welt konnte sie das Bild ihres Traumes wieder entdecken.
Je mehr Zeit verging und je länger sie sich den rauen Gesetzen der Distelwelt unterwarf, ohne eine Spur von der goldenen Rose zu finden, umso trauriger wurde sie. Ihr Gesicht wurde bleich, der Glanz ihrer Augen verlosch. Ihre Schritte wurden schwerer und immer weniger kümmerte sie, was um sie herum geschah. Am Ende eines langen ermüdenden Tages wollte sie nur noch schlafen und vergessen, wer sie war. So war sie bald selbst zu einem Distelmensch geworden und hatte das sanfte kindliche Lächeln verloren, das allen Rosenmenschen eigen war. Auch die Erinnerung an die einstige Heimat verblich immer mehr, schien ihr selbst nur ein Traum gewesen zu sein. Jeden Tag zerschlug sie die harten Steine, ohne zu wissen oder zu fragen, warum. „Die Königin will es so. Frag nicht mehr“ dachte auch sie mittlerweile.
Eines Nachts aber kam der alte Traum wieder zu ihr, deutlich und erschreckend wie beim ersten Mal, aber nun schien die goldene Rose ganz nahe, ja ihren Händen greifbar zu sein. Sie schrak auf, erinnerte sich ihrer Aufgabe und lief in die kalte Nacht hinaus. Überall suchte sie nach ihrer Rose, rief nach ihr, und rannte umher ohne anzuhalten. Dunkelgraue Nebel umfingen, unheimliche Schatten umspielten sie und überall stellten sich ihr Disteln feindlich entgegen.
Sie meinte, dass sie der Rose näher kam, aber die Umgebung wurde immer unwegsamer und gespenstischer. Hier und da glaubte sie im Zwielicht der Nacht ihre Rose zu erblicken, aber kaum trat sie näher heran, war es doch eine Distel, die sie stach. Tränen rannen ihre Wangen herab und sie musste einsehen, dass sie nur noch ahnungslos umherirrte.
Verzweifelt fiel sie auf die Knie und rief: „Die Rose, die ich suche, gibt es nicht. Nicht hier, in diesem wüsten Land! Könnte ich doch heimkehren in mein geliebtes Rosenreich, zu meinem Vater, meinen Freunden. Könnte ich das warme Sonnenlicht auf meiner Haut doch wieder spüren, die weichen, grünen Hügel wieder sehen meiner Heimat, im Garten wieder wandeln unter den immer lächelnden Rosen!“ Und sie weinte bitterlich.
Sie wollte nun nicht mehr nach der goldenen Rose suchen, sondern nur noch zurückkehren in das Reich ihres Vaters und in seinen Armen ruhen- wenn er denn noch lebte! Mochte ein anderer kommen und das Distelland nach der Rose durchkämmen- sie war doch noch ein Kind und keine Retterin! Sie war es, die gerettet werden musste aus dieser schrecklichen Gegend.
Sie erhob sich und rannte wieder los, immer weiter in die felsiger werdende Landschaft hinein, die sie schon einmal durchquert hatte, als sie ins Distelland gekommen war. In dieser Richtung ging es heimwärts, zu den geliebten Rosen! Die ganze Nacht lang kletterte sie durch das Gebirge, bis sie kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Als der Himmel etwas heller wurde und der Morgen zu dämmern schien, gelangte sie an das Felsentor, durch das sie einst geschritten war.
Doch in dem fahlen Licht des anbrechenden Tages sah sie eine große Gestalt zwischen den beiden Felsblöcken stehen, die ihr den Weg versperrte. Es war der alte Weise aus dem Rosenland, der die Schwelle bewachte und sie mit ernster Stimme ansprach: „Hast du die goldene Rose gefunden, Königstochter? Deine Heimat liegt noch immer ohne Sonnenlicht in schwerem Schlaf, und der König und die Rosenmenschen warten auf deine Rückkehr. Der dunkle Schleier wird erst vom Rosenland weichen, wenn du die goldene Rose heimbringst!“
Da erkannte das Mädchen, dass es keinen Weg zurück in ihre Heimat gab, wie sie sie in seliger Erinnerung gesehen hatte. Sie senkte ihren Blick zu Boden und sprach beschämt: „Ich komme mit leeren Händen, und ich habe die Suche aufgegeben…das Rosenreich ist verloren.“ Weinend fiel sie vor dem Alten auf die Knie.
Da spürte sie seine sanfte Hand auf ihrer Schulter, und seine Stimme drang mit weichem Ton an ihr Ohr: „Steh auf,
40 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
III.
Rosenkind, und folge mir!“ Sie erhob sich mit neuer Kraft, nahm des Weisen Hand und folgte ihm zurück ins Gebirge hinein. Sein Schritt war ruhig und sicher, als kenne er jeden Weg in aller Welt. Eine lange Zeit gingen sie schweigend durch die Felsen hindurch, dann setzte der Alte sich nieder und gebot ihr, neben ihm Platz zu nehmen.
„Das Rosenreich ist noch nicht verloren. Es wartet noch immer auf deine Tat. Wozu du einst ausgezogen bist, das vollende. Finde die goldene Rose!“ Das Mädchen schaute den Alten traurig an und sprach: „Ich habe schon überall nach ihr gesucht! Aber dieses Land ist so kalt und grau und hart, wie soll eine Rose da wachsen? Es gibt nur Disteln hier, nur spitze, kratzige Disteln!“ Der weise Mann sah sie lange bedächtig an, aber so sanft, wie sie es noch nie bei ihm gesehen hatte. Dann sprach er langsam zu ihr: „Hör mir gut zu, Kind, und lasse meine Worte in deinem Herzen wachsen. Wenn du die Rose nicht findest, nach der du überall suchst, so musst du eben selbst zu dieser Rose werden. In dir und deinen Taten lebe das Rosenreich weiter“
Und während er so sprach, fuhr er sanft mit seiner Hand über die Augen des Mädchens und sie schlief ein. Sie schlief lange und tief und träumte nichts.
IV.
Als sie erwachte, waren drei Distelkinder um sie und schauten sie verwundert an. Nach einigen Momenten des Schweigens fragte sie eines: „Wer bist du? Und warum hast du auf der Erde geschlafen?“ Das Mädchen verstand erst gar nicht, dass es gemeint war und wusste nicht, was es antworten sollte. Doch sie sah in den Augen der Distelkinder etwas, das sie bisher noch nicht in den Augen der Distelmenschen gesehen hatteeinen zarten, unscheinbaren Glanz.
Sie erinnerte sich der Worte des Weisen: „…so musst du selbst die Rose werden, die du suchst!“ In ihrem Herzen fühlte sie die Worte wachsen. Mit einem Mal stand sie auf und sagte lächelnd: „Wer ich bin, fragst du? Eine Rose bin ich! Ja, eine Rose. Und ich wachse langsam empor. Ich bin die erste Rose, die im Distellande wächst!“ Mit sanften, bedeutsamen Gesten begleitete sie ihre Worte. Sie spielte, sie sei eine Blume, die langsam aus der Erde wächst und zu blühen beginnt. „Ich habe in der Erde geschlafen, doch nun erhebe ich mich langsam gen Sonne und schenke der Welt meine schönste Blüte!“
Da fiel ihr das alte Lied ein, das ihr der Vater gesungen hatte, als sie selbst noch wie eine zarte Rosenknospe in der Wiege gelegen hatte. Es war ein Lied, das alle Rosenmenschen kannten und liebten, und es erfüllte sie mit heimatlichem Wohlgefühl, während sie, immer mehr lächelnd, sang:
„Du bist eine Rose Zart und stark zugleich
Schenkst dein Herz den Anderen
Und das macht dich so reich“
Die Kinder schauten zu Beginn noch etwas verlegen, aber je mehr das Mädchen sang und lächelte, umso größer wurde der Glanz in ihren Augen und ein zartes Lächeln zeigte sich in ihren Gesichtern. Wie gebannt lauschten und schauten sie,
und schließlich nahm die Rosensängerin die Kinder bei der Hand und ging mit ihnen freudig singend in das Distelland hinein.
Immer mehr Kindern des Distellandes erzählte sie ab diesem Tage vom Rosenreich, von den wunderschönen
Rosen ihrer Heimat, von ihrem Aussehen, ihren Blüten, ihrem Duft. Sie sang das Rosenlied für sie, bis die Kinder mitsingen konnten, und zeigte ihnen Rosentänze, die sie gemeinsam tanzten. Viele bekamen rosige Wangen dabei und fanden das Lachen, welches sie in dem kalten, unerfreulichen Leben des Distellandes nie hatten entfalten können.
Doch auch die anderen Distelmenschen begannen, das Rosenmädchen gern um sich zu haben. Denn bei der harten Arbeit des Tages hatte sie immer ein Lächeln auf den Lippen, und half jedem gern, den einmal die Kräfte verließen. In ihrer Nähe wurde das schwere Tagewerk leichter, und ihre Sanftmut machte manch groben Distelmenschen freundlicher. Hier und da halfen sich Distelmenschen nun gegenseitig oder teilten Speise und Trank miteinander. Ja, selbst die Sonne schien nun öfter zwischen den Wolken hindurch auf die Erde schauen zu wollen.
Wenn sie den Distelmenschen das Rosenlied sang, und sie sang es mit jedem Mal schöner und mit tieferer Hingabe, dann war es, als wenn sich warmer Sonnenschein auf das dicke Eis eines zugefrorenen Sees legte, und nach und nach schmolz das Eis und gab das quirlige Wasser frei, das sich nach Leben und Bewegung sehnte. Wer dem Lied gelauscht hatte, ging darauf unbeschwerter durch das harte Distelleben. Es war fast, als wandelte sich um das Mädchen das Distelleben selbst, als wurde es leichter, heller, freundlicher.
Eines Tages aber begab es sich, dass die Königin des Distellandes mit einem Gefolge durch das Distelland ritt, um zu prüfen, ob ihre Untertanen der strengen Arbeit nachgingen, wie sie es befahl. Als sie an eine Gruppe von Distelmenschen kam, die lächelnd bei ihren Steinen saß und in deren Mitte das Rosenmädchen von ihrer schönen Heimat erzählte, wurde sie wütend und trat mit finsterem Blick hinzu. Die Distelmenschen erschraken ob ihres Anblicks und liefen rasch zu ihren Werkzeugen und begannen, mit ernster Miene ihre Steine zu zerschlagen.
Auch unsere kleine Heldin war von der strengen Erscheinung der Distelkönigin eingeschüchtert, doch schaute sie mutig an, als diese sprach: „Wer bist du, fremdes Ding, und was ist in dich gefahren, dass du hier faul herum stehst und die Menschen von ihrer Arbeit abhältst? Weißt du nicht, dass ihr tagaus, tagein die Steine schlagen sollt?“ Das kleine Mädchen zitterte ein wenig, doch sie antwortete mit ruhiger Stimme: „Man nennt mich die Rosenprinzessin, und ich bin eine Botin aus dem Rosenreich, meiner sonnigen Heimat“.
Die Distelkönigin erschrak bei ihren Worten, fasste sich jedoch schnell wieder und fuhr das Kind zornig an: „Du hast dich heimlich in mein Reich geschlichen, ohne mich um Erlaubnis zu bitten, und stiftest nun Unfrieden und widersetzt dich meinem Befehl?“
„Verzeiht mir, eure Hoheit“, entgegnete die Rosenprinzessin,
41
„verzeiht mir, wenn ich gegen Euer Gesetz verstoßen hab. Ich tat es nicht mit bösem Willen, sondern folgte nur meinem singenden Herzen. Das Lied, das ich Eurem Distelreich und seinen Menschen singe, schenkt denen, die es hören wollen, Sonnenschein, und verwandelt trübe Gesichter in lächelnde, finstere Himmel in strahlende.“
Da lachte die Königin laut und höhnisch auf. Sie verzog missgünstig das Gesicht, schaute das Mädchen böse an und zischte: „Du wagst es, ungebeten ins Distelreich zu kommen und seine steinerne Ordnung außer Kraft zu setzen? Du sagst, dein Lied könne seine strengen Gesetze verwandeln? Du wirst deinen Hochmut bitter bereuen und für deine Frechheit büßen! Ich will dich Gehorsam gegenüber meinen Befehlen lehren und dir zeigen, dass du keinerlei Macht über die Distelwelt hast!“ Und sie ließ das arme Rosenkind von ihren Soldaten fesseln und nahm sie mit in ihr Schloss.
V.
Rings um das Schloss der Distelkönigin standen die Disteln so dicht und hoch beieinander, dass es kaum ein Durchkommen gab. Und der Himmel lag grau und schwer darüber wie eine steinerne Platte. Dem Mädchen wurde es kalt und bang beim Anblick des düsteren Ortes. Sie wurde in den Hof des Schlosses gebracht, wo es unheimlich still war und, mitten in einem ausgetrockneten Brunnen, die Statue eines Jünglings stand, der traurig zu Boden blickte. Hier sprach die Königin mit eisiger Stimme zu ihr: „Nun stehst du nahe bei der Quelle meines Landes, und kannst uns die Macht deines Liedes beweisen! Sing, und verwandle die Statue in einen lebendigen Menschen, und lass das Wasser des Brunnens wieder fließen!“ Darauf lachte sie bitter und gequält. Das Mädchen verstand die Worte nicht und fühlte sich schwach und verloren. Die leeren Blicke der Königin und ihrer Soldaten umher lähmten sie wie ein schweres Gewand.
Sie wollte etwas sagen, doch sie wusste nicht was. Sie versuchte zu singen, doch es war, als hätte sie alles wieder vergessen, was sie von sich und Ihrer Heimat wusste. Ihr Rosenlied schien versiegt wie das Wasser in dem Brunnen, vor dem sie stand. Traurig ließ sie den Kopf hängen und ergab sich. Da lachte die Königin wieder höhnisch und sagte: „Was nun, freche Prinzessin? Das war dein Lied? Vergiss es endlich! Du bist nicht willkommen in der Distelwelt, und niemand hier will dich hören! Der harte Stein lässt sich nicht verwandeln, nur zerschlagen. Und die raue Distel zeigt dir, wie du zu sein hast! Füge dich diesem Gesetz, oder kehre zurück in deine Heimat!“
Das Mädchen wurde in eine Kammer gebracht, in der es weder Fenster noch Stuhl oder Tisch gab. Sie kauerte sich in eine Ecke, zitterte durch lange dunkle Stunden und hörte die Worte der Königin in sich widerhallen: „Füge dich diesem Gesetz, oder kehre zurück in deine Heimat!“ Ohne die goldene Rose. Ohne Hoffnung für das Rosenreich. Das Dunkel des Raumes wurde immer tiefer um das arme Mädchen, und bald wusste sie nicht mehr, ob sie noch wachte oder bereits schlief.
Nach drei Tagen und Nächten wurde sie wieder in den Schlosshof vor die Königin gebracht. Sie konnte kaum aufrecht stehen und alle Glieder taten ihr weh, sie konnte kaum sehen, denn selbst das fahle Licht des Distellandes stach jetzt in ihren Augen. Nur langsam wurde sie wach und vernahm die kalte Stimme der Königin: „Willst du dich nun fügen und ein Distelmensch
sein wie alle anderen? Oder sollen meine Wächter dich aus dem Land jagen? Sprich!“
Das Mädchen wusste nicht gleich zu antworten und sah an der Königin vorbei auf die Statue in dem Brunnen. Der Blick des steinernen Jünglings fiel direkt in ihre Augen, und seine tiefe Trauer ging ihr bis ins Herz. Sie wusste nicht, wer er war und warum er so traurig schaute, aber sie fühlte so sehr mit ihm. Sie dachte an all das Leid, das sie erduldet hatte seit dem Tag, da der Himmel über ihrem Rosenreich dunkel geworden war. All das, um die goldene Rose zu finden und ihre Heimat zu erlösen.
„Sprich!“ schrie die Königin sie an, die ob ihres Schweigens zornig geworden war. Da schaute sie der Königin fest ins Auge und sprach: „Ich bleibe hier bis ich die goldene Rose finde!“ Und während sie so sprach, kamen ihre Kräfte zurück und das leichte Lächeln wieder in ihr Gesicht. Im Blick der seltsamen Statue hatte sie wie in einem Spiegel sich selbst wieder gefunden. Die Königin tobte nun vor Zorn und befahl ihren Soldaten, das Mädchen wegzubringen und aus dem Distelland zu jagen. Doch als diese sie fassen wollten, begann sie mit klarer Stimme das Lied zu singen, das ihre Heimat rings um sie erstehen ließ:
„Du bist eine Rose Zart und stark zugleich“
Ihr Gesang war so fein und unschuldig, dass die Soldaten wie erstarrt waren und nicht Hand an sie legen konnten, wenngleich die wütende Königin sie immer wieder schreiend dazu aufforderte. Das Rosenkind sang aus tiefstem Herzen und alle Furcht und alles Weh wichen von ihr wie Schnee, der im Sonnenlicht schmilzt. Ihr Blick ging dabei wieder zu dem steinernen Jüngling, und ihr war es, als würde die Statue ihr lauschen. Ja, je mehr sie in seine Richtung, für ihn sang, umso mehr schienen seine Augen zu leben, ihren Blick zu erwidern, zu blinzeln. Sie trat noch näher heran und sang ihre Zeilen wie für einen, der lange geschlafen und schwer geträumt hat und den man in einen neuen, sonnigen Tag ruft:
„Schenkst dein Herz den Anderen Und das macht dich so reich“
Da schlug der Jüngling seine Augen langsam auf, und das Mädchen sah, wie eine Träne zu Boden fiel. Auch sein Kopf begann sich zu bewegen, die Arme regten sich sacht, und nach und nach wurde aus der ganzen steinernen Statue wieder ein Mensch. Wo aber die Träne den Boden berührt hatte, da ging ein Riss durch den Brunnenstein, und aus dem Riss wuchs eine Rose empor, die war ganz aus Gold und strahlte so hell wie zwölf Morgensonnen.
Als das Mädchen die Rose sah, hörte sie auf zu singen, und weinte vor Freude, und stieg in den Brunnen, um die Rose zu beschauen. Da erst merkte die Königin, was geschehen war, erblickte den Jüngling, der auf sie zu kam und wurde ganz blass und rief: „Mein Sohn! Mein Sohn! Du bist erlöst!“ Und sie lief ihm entgegen und umarmte ihn herzlich. Da flossen reichliche Tränen des Glücks, und als die Rosenprinzessin die goldene Rose gepflückt hatte, quoll Wasser aus dem Riss empor und
42 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
füllte allmählich wieder das Becken.
„Wir sind dir zu unendlichem Dank verpflichtet“, sprach nun die Königin. „Du hast meinen Sohn und mich von dem Bann erlöst, der uns viele Jahre gefangen hielt. So wie mein Sohn versteinert war, so war mein Herz erfroren, und ich ließ alle Freude im Land verbieten und alle Steine zerschlagen. Die Freude und das Lächeln, das du mit deinem Lied brachtest, konnte mein Herz nicht ertragen. Jetzt aber ist es voller Glück und Dank.“
Da wurde ein großes Fest gefeiert, wie es das Distelland noch nicht gesehen hatte. Und das Rosenmädchen kehrte, begleitet von vielen neuen Distelfreunden, zurück in ihre Heimat. An
dem steinernen Felsentor erwartete sie der alte Weise still lächelnd, und als sie mit der goldenen Rose in der Hand das Rosenreich betrat, da zogen sich die Wolken am Himmel zurück und gaben die Sonne wieder frei. Der König, von der goldenen Rose berührt, kam wieder zu Kräften, und alles Leben, alle Rosenmenschen und alle Rosen blühten wieder auf.
Von diesem Tag an gab es einen regen Austausch zwischen dem Rosenreich und dem Distelland, die Menschen vermischten sich und lernten voneinander, und seither haben die Rosen ihre Dornen und die Disteln ihre schönen Blüten.
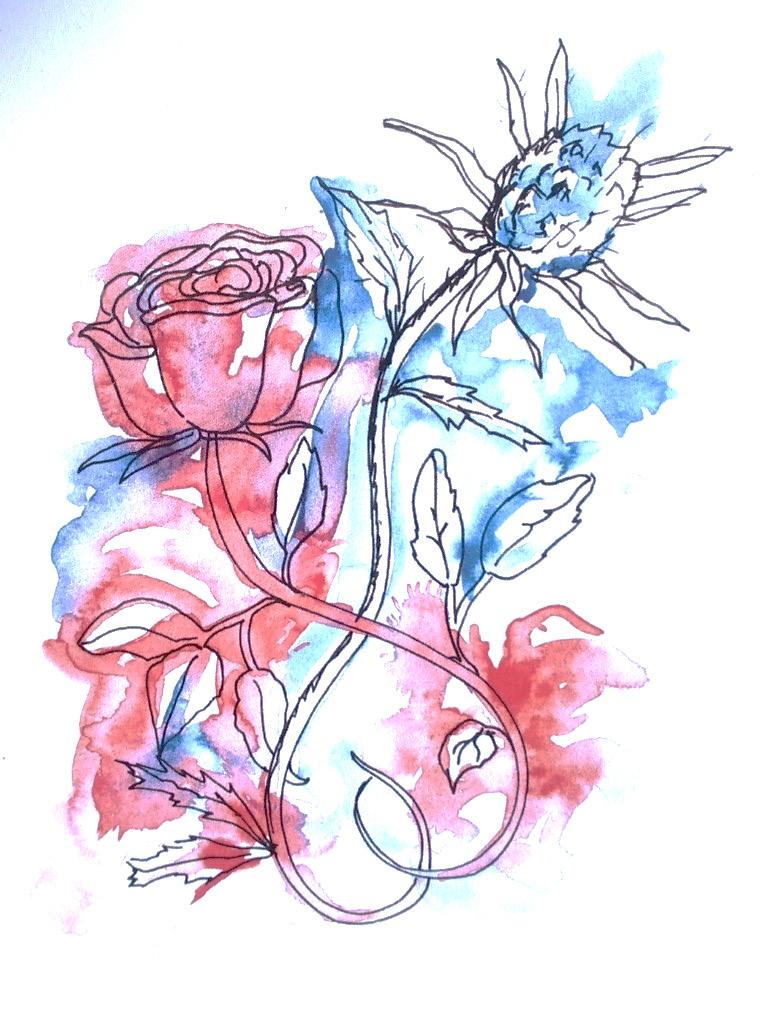
43
Illustration von Kathrin Silber
Die große Sonne ist versprüht, der Sommerabend liegt im Fieber, und seine heiße Wange glüht. Jach seufzt er auf: “Ich möchte lieber …” Und wieder dann: “Ich bin so müd …” Die Büsche beten Litanein, Glühwürmchen hangt, das regungslose, dort wie ein ewiges Licht hinein; und eine kleine weiße Rose trägt einen roten Heiligenschein.
S’è sciolto in spruzzaglia il gran sole. La sera d’estate, divampa; riarde di febbre nel volto. Sospira di schianto: « Vorrei.... »; ma quindi ripete - « Son stanca... »
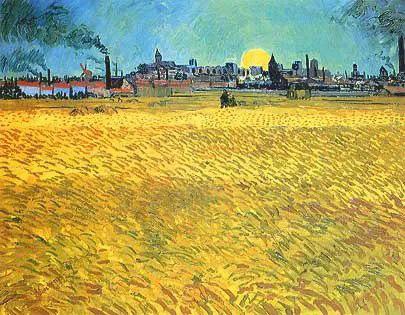
Sussurran preghiere i cespugli. Nel folto, una lucciola splende (eterna fiammella) a mezz’aria.
Recinge ogni candida rosa, vermiglia raggiera - il tramonto.
44 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
rainer maria rilke: SOmmerabend rainer maria rilke: Sera d’eSTaTe
Vincent Van Gogh, Sommerabend bei Arles (Sera d’estate a Arles), Arles, 1888
Sui i campi e i frutteti che sentono l’autunno, là guardano benedicendo gli Spiriti del cielo, e il loro sguardo cerca i nostri cuori che maturano.
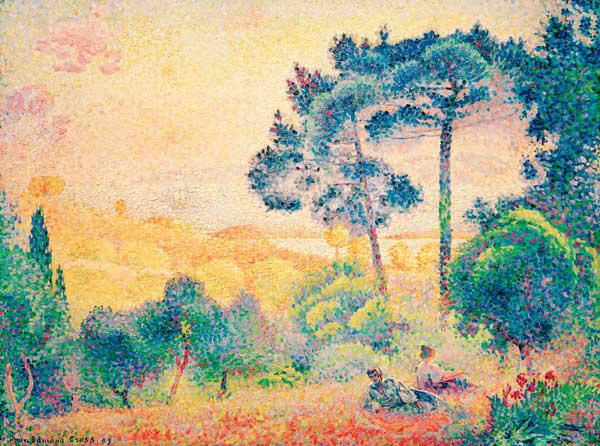
Essi vivono il loro compito negli intimi intrecci dei multiformi destini.
Al grande Tessitore, il Signore del destino, noi inviamo i nostri pensieri.
Traduzione dall’edizione inglese di Elio Biagini, in Adam Bittleston, Preghiere meditative per il nostro tempo, Editrice Novalis, 2019
Egli guarisce nel corpo, l’ottusità dei sensi.
Egli risveglia nell’anima il volere dello spirito.
Possa la Sua Comunità lavorare nel mondo riscaldata dalla Sua grazia –unendo ciò che è separato dove, all’altare, i nostri destini si incontrano.
45
adam biTTleSTOn: aGOSTO
Henri Edmond Cross, Paysage de Provence, 1898
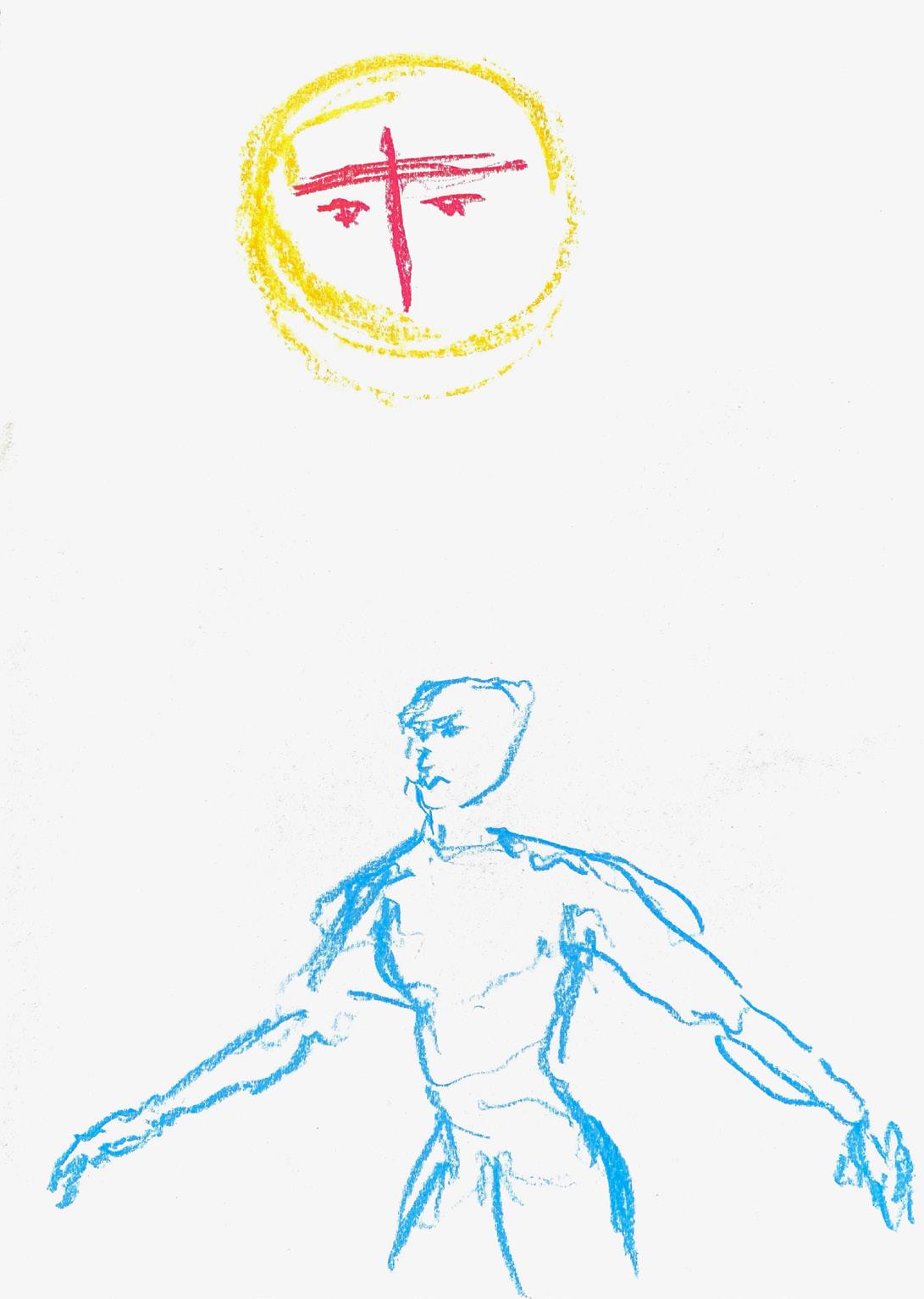
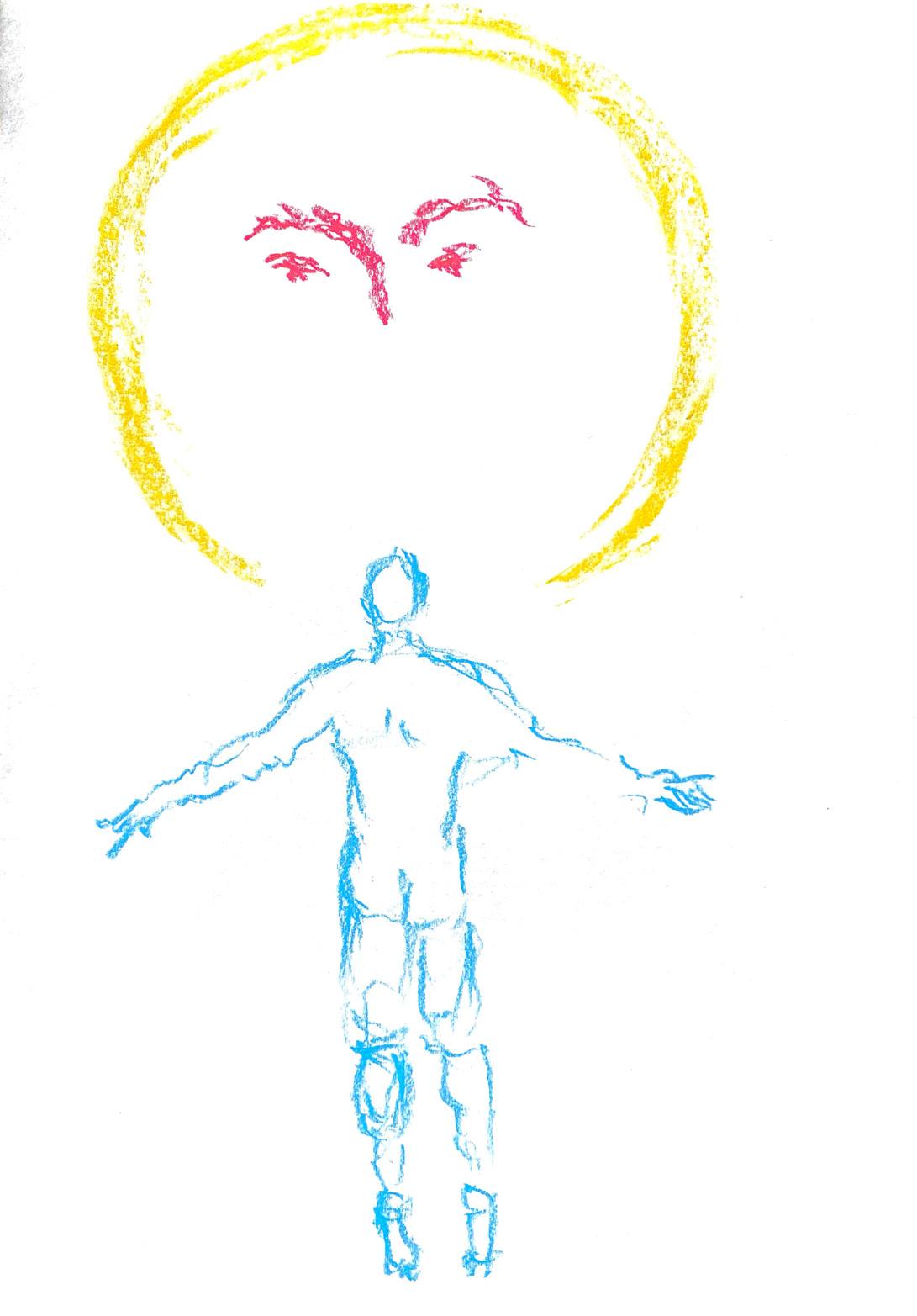
46 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023
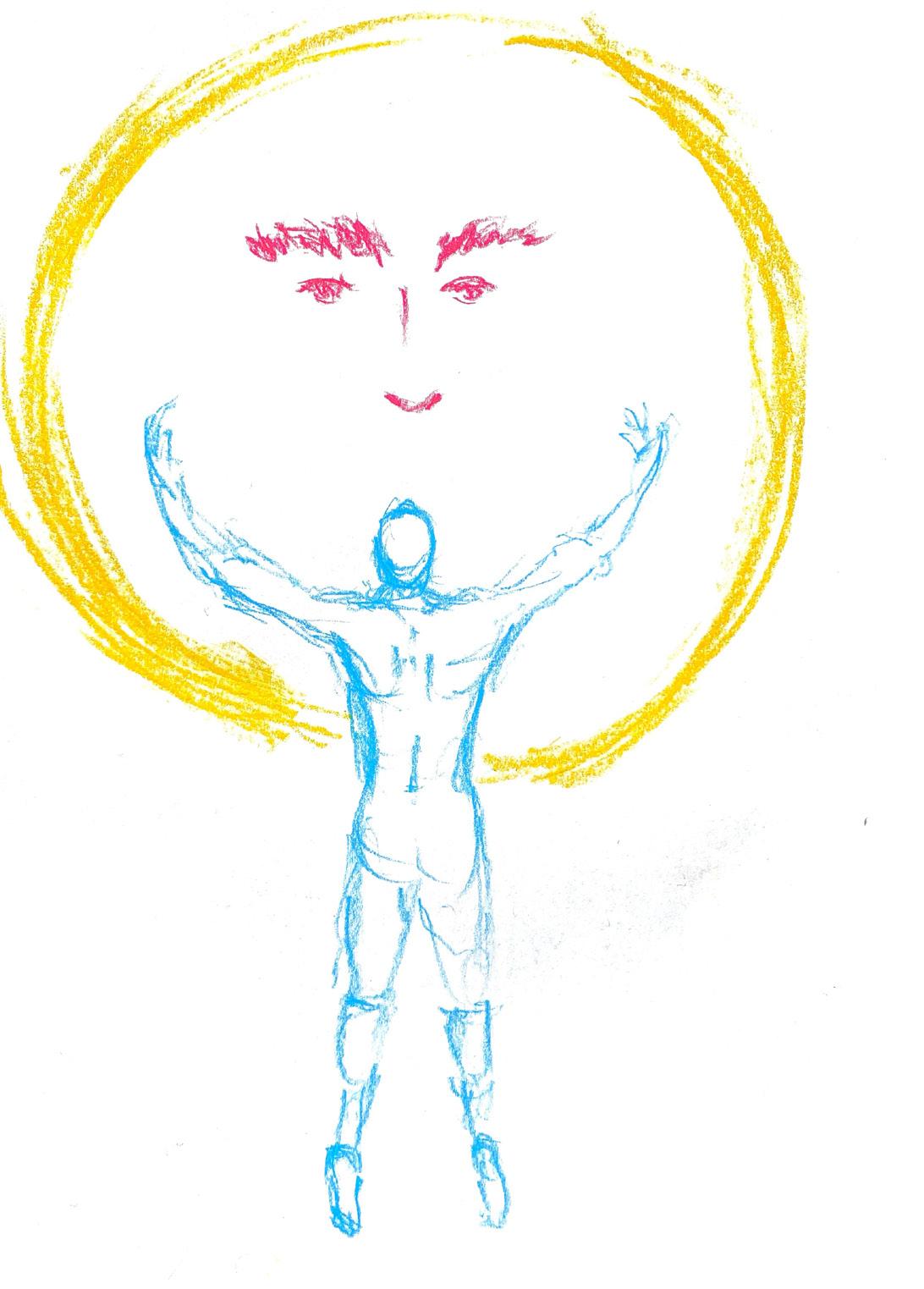

47
Disegni di Nicolás Jaime Gemelli, per San Giovanni
2023

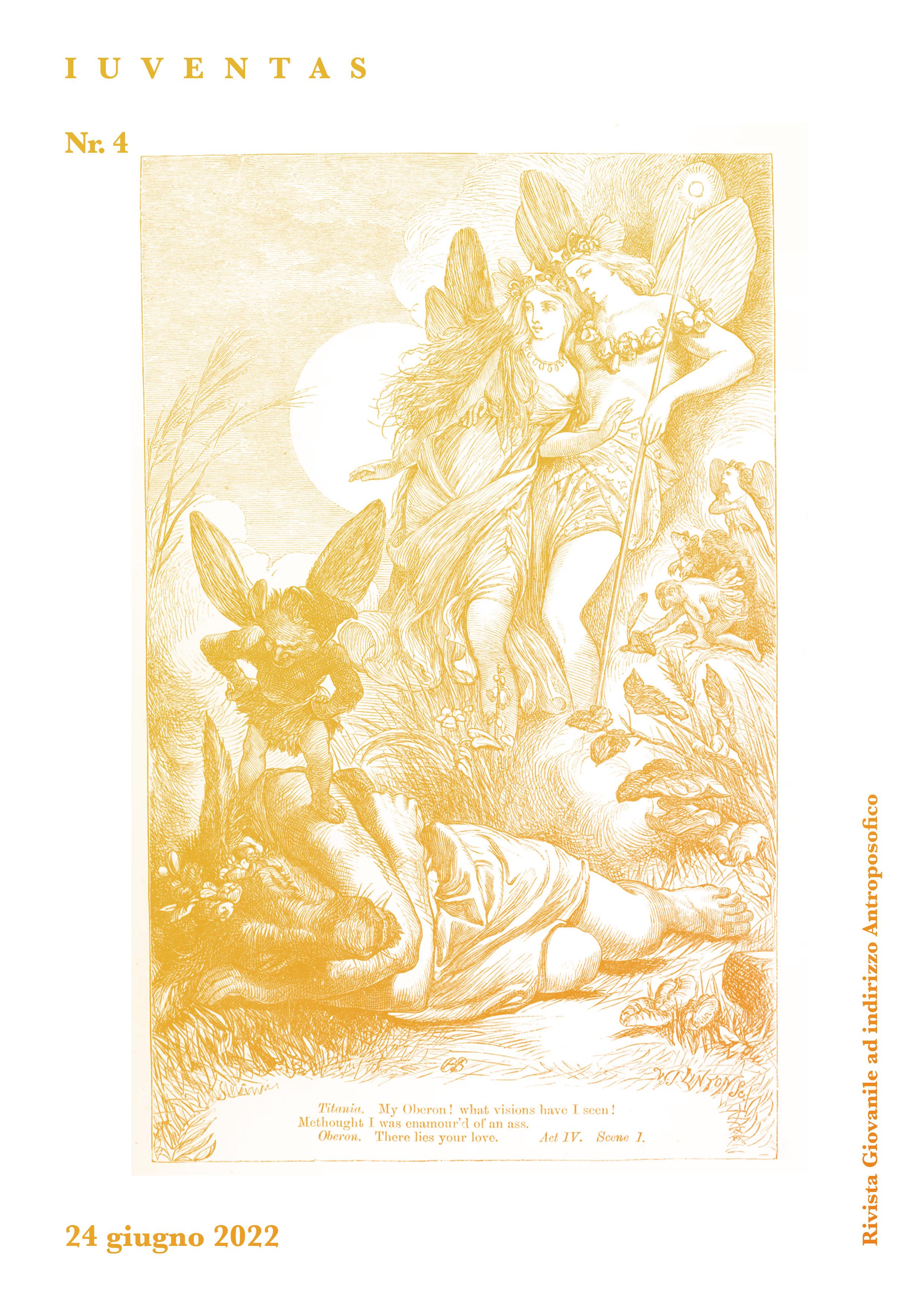



 Acquerello di Kaspar Hauser, 1830
Acquerello di Kaspar Hauser, 1830