Guida didattica per la scuola primaria

Italiano
Matematica
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Educazione civica
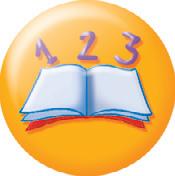

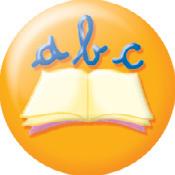



















ibiscus

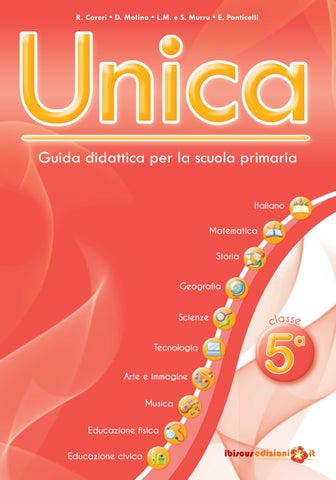

Italiano
Matematica
Storia
Geografia
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Educazione civica
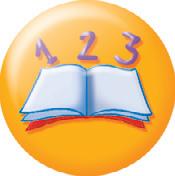

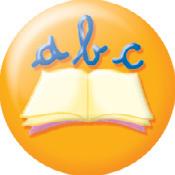



















ibiscus

Nome
Cognome

Indicazioni metodologiche
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
SETTEMBRE
Pronti per la quinta
Proposte metodologiche
Italiano
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 112
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente 112
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 112
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche dei principali generi di narrazione 113
Produrre testi sostanzialmente corretti, legati a scopi concreti 114
Riconoscere le fondamentali convenzioni di scrittura e le principali parti del discorso 115
Storia
Conoscere le fonti della Storia 117
Ricavare e produrre informazioni da fonti di tipo diverso 117
Esporre conoscenze utilizzando il linguaggio specifico della Storia 118
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 118
Usare una carta geo-storica 119
Conoscere la struttura di un quadro storico di civiltà 119
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 119
Geografia
Conoscere e utilizzare il metodo di lavoro del geografo 121
Conoscere e utilizzare gli strumenti di lavoro del geografo 121
Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 122
Le schede contrassegnate dal simbolo n. ... sono state elaborate sulla base della metodologia INVALSI
Riconoscere e analizzare i principali caratteri fisici di un territorio 122
Conoscere gli elementi caratteristici dei principali paesaggi geografici 123
Ricavare informazioni geografiche da tabelle e grafici 124
Matematica
Usare i quantificatori logici
125
Attribuire valore di verità a enunciati logici 125
Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci fino alle centinaia di migliaia, indicando il valore di ogni cifra 125
Rappresentare, leggere e scrivere la frazione di una grandezza
126
Individuare la frazione complementare di una frazione data 126
Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa
126
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri decimali 126
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali e decimali
Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali e decimali
Risolvere problemi con due domande e due operazioni
Distinguere retta, semiretta e segmento
Classificare gli angoli
Classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli
Classificare i quadrilateri convessi
126
127
127
128
128
128
128
Conoscere le unità di misura del sistema metrico decimale 128
Scienze
Esplorare i fenomeni naturali con metodo scientifico 130
Conoscere e servirsi di strumenti per unità di misura convenzionali
130
Sperimentare e schematizzare passaggi di stato della materia 130
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale 131
Riconoscere le relazioni tra le componenti di un ecosistema 132
Antologia
Atmosfera di settembre
Brani da
n. 16 Le frazioni 153
n. 17 Frazioni e numeri decimali 154
n. 18 Addizioni e sottrazioni 155
n. 19 Moltiplicazioni e divisioni 156
n. 20 Problemi 157
n. 21 Retta, semiretta, segmento e angoli 158
n. 22 Triangoli e quadrilateri 159
n. 23 Unità di misura 160 Scienze
n. 24 Come uno scienziato 161
n. 25 Sperimento… i passaggi di stato 162
n. 26 Cinque regni per i viventi 163
n. 27 Nemici nell’ecosistema 164
Mitici Greci!
Proposte metodologiche Italiano
• Ascolto e parlato 166
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 166
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 167
• Lettura 168
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 168
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 169
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: il mito 169
Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo: la narrazione di paura 170
Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto: le sequenze 171
Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 172
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 172
Leggere testi argomentativi individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee 173
Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parare personale 174
• Scrittura 174
Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche 174
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 175
Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: le istruzioni 175
Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze personali 176
Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su argomenti di studio: la ricerca 176
Scrivere testi per argomentare 177
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 177
Sperimentare tecniche per riassumere testi 179
Sperimentare tecniche per parafrasare testi: la parafrasi del testo poetico 180
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 180
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 180
Utilizzare adeguatamente il dizionario 181
Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura 181
Riconoscere e rispettare le funzioni sintattiche ed espressive dei principali segni interpuntivi 182
Riconoscere e utilizzare adeguatamente le tecniche del discorso diretto e indiretto 182
Storia
• Uso delle fonti 183
Produrre informazioni da manufatti greci 183
Produrre informazioni da antiche monete greche 183
Produrre informazioni dall’Olpe Chigi 183
Produrre informazioni dai Bronzi di Riace 184
• Organizzazione delle informazioni 184
Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà greca 184
Usare cronologie per rappresentare la storia greca 184
• Strumenti concettuali 185
Conoscere la nascita della civiltà dei Greci 185
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei greci: l’età “oscura” 185
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la nascita delle póleis 185
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la grande colonizzazione 186
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: le guerre persiane 186
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la guerra del Peloponneso 187
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: l’età ellenistica 187
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Greci 187
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale e politica di Sparta 187
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale e politica di Atene 188
Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Greci 188
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Greci 189
Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Greci 189
Conoscere le principali attività economiche dei Greci
190
Conoscere il sistema di scrittura dei Greci 190
Conoscere le principali innovazioni culturali dei Greci 190
Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Greci 190
Conoscere la funzione e la struttura del teatro dei
Greci 191
Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Macedoni 191
• Produzione scritta e orale 192
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà greca del passato con quella attuale 192
Elaborare oralmente e per iscritto quadri storici della civiltà greca 192
Geografia
• Orientamento 193
Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 193
Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando le coordinate geografiche 193
Leggere immagini satellitari del globo terrestre e dell’Europa 193
• Linguaggio della geograficità 193
Localizzare sul globo e sul planisfero la posizione
dell’Italia nel mondo 193
Localizzare sulle carte geografiche la posizione dell’Italia in Europa 194
Realizzare carte geografiche evidenziando la posizione dell’Italia nel mondo e in Europa 194
Leggere, interpretare e completare grafici
sull’estensione dell’Europa e dell’Italia 194
Analizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione nel mondo 194
Analizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione in Europa 195
Realizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione in Italia 195
• Paesaggio 195
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali della Terra 195
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali dell’Europa 196
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali dell’Italia 196
Conoscere paesaggi culturali della Terra 197
Conoscere paesaggi culturali dell’Europa 197
Conoscere paesaggi culturali dell’Italia 197
• Regione e sistema territoriale
Conoscere e descrivere le fasce climatiche della Terra 197
Conoscere e descrivere le aree climatiche dell’Europa 198
Conoscere e descrivere le regioni climatiche dell’Italia 198
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Terra 199
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Europa 199
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Italia 199
Matematica
• Relazioni, dati e previsioni 200
Comprendere il significato dei connettivi logici “e”, “non”, “e/o”, “o” 200
Usare correttamente il linguaggio degli insiemi nell’operazione di unione di insiemi disgiunti e non disgiunti 202
Comprendere il significato logico di “se… allora” e di “se e solo se” 206
Classificare in base a tre attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 208
• Numeri 209
Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti di 3° ordine) ed esprimere la quantità in numeri seguendo il criterio posizionale 209
Indicare con le potenze il valore di ogni cifra in un numero scritto in basi diverse 212
Indicare con le potenze il valore di ogni cifra di un numero scritto in base dieci con le potenze 215
Scomporre, sotto forma di polinomio con le potenze, un numero scritto in basi diverse 216
Scomporre, sotto forma di polinomio con le potenze, un numero scritto in base dieci 218
Leggere e scrivere i numeri naturali oltre il milione 218
Confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il milione 220
Leggere e scrivere i numeri romani, confrontando il sistema di scrittura posizionale con quello additivo 221
Confrontare le operazioni di addizione e sottrazione 222
Conoscere il comportamento dello zero nell’addizione e nella sottrazione 224
Riconoscere e applicare le proprietà dell’addizione per semplificare il calcolo 224
Riconoscere e applicare la proprietà della sottrazione per semplificare il calcolo 225
Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 225
Individuare i dati essenziali, sottintesi, mancanti per la risoluzione di un problema 226
Riconoscere le domande implicite, “nascoste”, nel testo di un problema
Risolvere problemi con una o più operazioni
• Spazio e figure
227
227
Consolidare il concetto di retta, semiretta, segmento 227
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di incidenza, perpendicolarità, parallelismo
Classificare gli angoli in base all’ampiezza
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti
Consolidare il concetto di poligono
Riconoscere e rappresentare i poligoni convessi e concavi
Individuare vertici, lati e angoli di un poligono
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni
Individuare il concetto di forza
• Osservare e sperimentare sul campo
Sperimentare la composizione di un osso
Sperimentare la contrazione dei muscoli
• L’uomo i viventi e l’ambiente
Conoscere la struttura della cellula
Conoscere le fasi della vita della cellula
Conoscere i diversi tipi di tessuto cellulare
Conoscere la struttura di un organismo
Conoscere l’apparato locomotore
Conoscere l’apparato scheletrico
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato scheletrico
Conoscere l’apparato muscolare
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato muscolare
Musica
227
228
228
231
231
232
233
233
233
233
234
234
234
235
235
235
236
236
237
237
238
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 239
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 239
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 239
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 240
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali e collettive
241
241
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 241
Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 241
Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini
• Osservare e leggere le immagini
Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte
241
242
242
242
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 242
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 243
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 243
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 244
Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva 244
Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé e agli altri 245
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 246
Sperimentare la comunicazione con il corpo ed esprimersi attraverso esso 246
• Il gioco, lo sport, e il fair play 247
Partecipare a vari giochi organizzati anche in forma di gara 247
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 248
Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza in palestra 248
Tecnologia
• Vedere e osservare 249
Conoscere e utilizzare le leve 249
Rappresentare macchine semplici con il disegno 249
• Prevedere e immaginare 250 Organizzare una gita usando internet 250
• Intervenire e trasformare 250
Realizzare una maschera greca con il cartoncino 250
Cercare e selezionare in internet un programma di utilità 250
Antologia
Bentornato, autunno! (1)
Poesie… della paura
Brani da ascoltare
Poesie e… televisione 256
Poesia… nell’ortografia (1) 257
Schede operative
Italiano
n. 28 Io e la TV
n. 29 La nascita di Venere
n. 30 Alessandro doma Bucefalo (1)
n. 31 Andromeda (1) 262
n. 32 Il pianoforte misterioso 264
n. 33 Ulisse e le sirene 266
n. 34 La TV in sicurezza 268
n. 35 Tutti a teatro (1) 270
n. 36 La TV è un bene o un male?
n. 37 Telemania e fantasia
n. 38 Un’esperienza da brivido
n. 39 Descrivo il teatro greco
n. 40 La zucca luminosa
n. 41 Il programma televisivo preferito 280
n. 42 Le mie idee sulla TV 281
n. 43 Anagrammi (1) 282
n. 44 Ulisse e le sirene (3) 284
n. 45 Tutti a teatro (2) 285
n. 46 Trasformo… i libri 286
n. 47 L’ordine alfabetico (1) 287
n. 48 Il dizionario 288
n. 49 Ortografia: doppie da… da brivido 289
n. 50 Ortografia: i gruppi con C e G (1) 290
n. 51 Ortografia: CHI, CHE, GHI, GHE, SCI, SCE 291
n. 52 Ortografia: GN e GL 292
n. 53 Ortografia: CU, QU, CQU, QQU 293
n. 54 Ortografia: la divisione in sillabe
294
n. 55 Ortografia: Uso dell’H 295
n. 56 Ortografia: l’H e l’apostrofo (1)
296
n. 57 Ortografia: l’H e l’apostrofo (2) 297
n. 58 Ortografia: l’accento (1)
298
n. 59 Ortografia: l’apostrofo 299
n. 60 Ortografia: il troncamento 300
n. 61 Ortografia: il troncamento con l’apostrofo 301
n. 62 La punteggiatura (1) 302
n. 63Discorso diretto e indiretto (1) 303
Storia
n. 64 Vasi greci: forme e colori 304
n. 65 La storia greca in linea
305
n. 66 Una vittoria epica: Maratona 306
n. 67 La guerra del Peloponneso
n. 68 La pólis
307
308
n. 69 Gli opliti: formidabili guerrieri 309
n. 70 L’invincibile trireme 310 n. 71 Il pàntheon greco 311
n. 72 Il tempio greco 312 n. 73 Le Olimpiadi 313
n. 74 La scrittura dei Greci 314
n. 75 I Greci: innovatori e inventori 315
n. 76 Come vestono i Greci? 316
n. 77 A casa dei Greci 317
n. 78 I Greci a teatro 318
n. 79 Cruci… greco! 319
Geografia
n. 80 Mi oriento nel reticolato geografico
320
n. 81 La Terra e l’Europa dal satellite 321
n. 82 L’Italia nel planisfero 322
n. 83 L’Italia in Europa 323
n. 84 L’Europa in percentuale 324
n. 85 Superfici d’Europa 325
n. 86 La popolazione italiana in cartogramma 326
n. 87 La Terra e i suoi biomi 327
n. 88 Rilievi d’Europa
n. 89 Acque d’Europa
n. 90 L’Italia e i suoi biomi
n. 91 Paesaggi culturali della terra
n. 92 Paesaggi culturali dell’Europa
n. 93 Il Nord e il Sud del mondo
n. 94 I settori produttivi in Italia
Matematica
n. 95 Rifletto sul vero o falso
n. 96 Enunciati semplici e composti
n. 97 Enunciati composti
n. 98 “e” oppure “o”
n. 99 Gli enunciati e i connettivi logici “e/o”, “o”
n. 100 Unione d’insiemi(1)
n. 101 Unione d’insiemi (2)
n. 102 Unione d’insiemi (3)
n. 103 “Se… allora”
n. 104 “Se e solo se…”
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
n. 105 Rappresento le classificazioni (1) 345
n. 106 Basi diverse (1)
n. 107 Rappresento basi diverse con il B.A.M.
n. 108 Rappresento base dieci con il B.A.M
n. 109 Basi diverse e valore delle cifre (1)
n. 110 Basi diverse e potenze
n. 111 Le potenze (1)
n. 112 Le potenze (2)
n. 113 Le potenze di 10
346
347
348
349
350
351
352
353
n. 114 Il polinomio con le potenze 354
n. 115 Il polinomio numerico
355
n. 116 Scompongo con le potenze
n. 117 Quiz sulle potenze
n. 118 Mi esercito sulle potenze
n. 119 Leggo e scrivo i numeri oltre il milione (1)
n. 120 Milioni e miliardi
n. 121 Per difetto o per eccesso
n. 122 Confronto e ordino (1)
n. 123 I numeri romani (1) 363
n. 124 La tabella dell’addizione
n. 125 Addizioni spiritose
n. 126 Le tabelle della sottrazione
n. 127 Lo zero nell’addizione e nella sottrazione 367
n. 128 Le proprietà dell’addizione 368
n. 129 La proprietà della sottrazione 369
n. 130 Addizioni e sottrazioni con i numeri interi 370
n. 131 Analizzo il testo di un problema
n. 132 Problemi con dati sottintesi
n. 133 Problemi con dati mancanti
n. 134 Domanda nascosta (1)
n. 135 Problemi con le quattro operazioni 375
n. 136 Rette, semirette, segmenti (2) 376
n. 137 Incidenza, perpendicolarità, parallelismo 377
n. 138 Classifico gli angoli
n. 139 Misuro e confronto gli angoli
n. 140 Il goniometro
n. 141 Opero con gli angoli
n. 142 I poligoni
n. 143 I poligoni convessi e concavi
Scienze
n. 144 Che forza!
n. 145 Sperimento… la composizione di un osso!
n. 146 Un test sulla cellula
n. 147 Dalla cellula all’organismo
n. 148 Funzioni vitali dell’uomo e apparati
n. 149 L’apparato locomotore
n. 150 A che cosa serve lo scheletro 390
n. 151 Lo scheletro e le sue ossa 391
n. 152 Lo scheletro e le sue parti
392
n. 153 Lo scheletro del capo 393
n. 154 Lo scheletro del tronco 394
n. 155 Lo scheletro degli arti 395
n. 156 A che cosa servono i muscoli? 396
n. 157 Muscoli e movimenti 397
n. 158 Ogni muscolo al posto giusto 398
Musica
n. 159 A lezione di Musica!... o di Storia? 399
n. 160 Il canto degli italiani 400
Arte e immagine
n. 161 La nascita di Venere 401
n. 162 Il teatro di Taormina 402
Educazione fisica
n. 163 Invento un percorso con i miei compagni 403
n. 164 Patata bollente 404
Tecnologia
n. 165 Conosco le leve 405
n. 166 Un viaggio ad Atene 406
DICEMBRE • GENNAIO
Viaggio in Italia
Proposte metodologiche
Italiano
• Ascolto e parlato 408
Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione 408
Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per regolare comportamenti 408
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente 408
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 409
Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 409
• Lettura 409
Acquisire il piacere di leggere 409
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 410
Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo: l’autobiografia 411
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria della realtà 411
Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 412
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 412
Leggere testi argomentativi, individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee
Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale
• Scrittura
Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche: il racconto autobiografico
413
413
414
414
Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche: il racconto fantastico 414
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 415
Scrivere testi regolativi: le regole di comportamento in un museo 415
Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze 415
Scrivere testi per argomentare 416
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 416
Sperimentare tecniche per riassumere testi 417
Sperimentare tecniche per parafrasare testi 417
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 417
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 417
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: sinonimi, omonimi, contrari e campi semantici 417
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 419
Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 420
Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 420
Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: gli aggettivi qualificativi, i gradi dell’aggettivo, gli aggettivi numerali 422
Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: i pronomi personali e relativi 422
Distinguere gli aggettivi e i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli
opportunamente: aggettivi e pronomi possessivi, indefiniti, dimostrativi, interrogativi ed esclamativi 423 Storia
• Uso delle fonti 424
Produrre informazioni da costruzioni della civiltà nuragica 424
Produrre informazioni dal Guerriero di Capestrano 424
Produrre informazioni dal Disco di Magliano 424
Produrre informazioni dal Sarcofago degli Sposi 424
Rappresentare informazioni che scaturiscono da tracce etrusche presenti sul territorio vissuto 425
• Organizzazione delle informazioni 425
Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppano le civiltà italiche 425
Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà etrusca 425
Usare cronologie per rappresentare la storia dei popoli italici 425
• Strumenti concettuali 425
Conoscere le civiltà palafitticola e terramaricola 425
Conoscere i principali popoli italici 426
Conoscere la civiltà dei Camuni 426
Conoscere la civiltà dei Liguri 426
Conoscere la civiltà dei Sardi 426
Conoscere la civiltà dei Villanoviani 426
Conoscere la civiltà dei Celti 427
Conoscere le colonie fenicie in Italia 427
Conoscere le colonie greche in Italia 427
Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Etruschi 427
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Etruschi 427
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Etruschi 428
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità degli Etruschi 428
Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso gli Etruschi 428
Conoscere e analizzare la funzione e la struttura delle necropoli degli Etruschi 428
Conoscere le principali attività economiche degli Etruschi 429
Conoscere il sistema di scrittura degli Etruschi 429
Conoscere aspetti della vita quotidiana degli Etruschi 429
• Produzione scritta e orale 429
Produrre informazioni da reperti della civiltà celtica 429
Produrre informazioni da opere architettoniche delle colonie greche in Italia 429
Produrre informazioni da reperti della civiltà etrusca 430
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: i popoli italici 430
Geografia
• Orientamento 431
Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia settentrionale utilizzando i punti cardinali 431
Leggere immagini satellitari dell’Italia settentrionale 431
• Linguaggio della geo-graficità 431
Localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia 432
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Valle d’Aosta 432
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Piemonte 432
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Liguria 433
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Lombardia 433
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Trentino-Alto Adige 434
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Veneto 435
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Friuli-Venezia Giulia 435
Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Emilia Romagna 436 • Paesaggio 436
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Valle d’Aosta 437
Conoscere il patrimonio naturale e culturale del
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della
Conoscere il patrimonio naturale e culturale del
Conoscere il patrimonio naturale e culturale del
Conoscere il patrimonio naturale e culturale del FriuliVenezia Giulia
e descrivere i settori produttivi
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Piemonte 439
Conoscere e descrivere i settori produttivi
dell’economia della Liguria 440
Conoscere e descrivere i settori produttivi
dell’economia della Lombardia 440
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Trentino-Alto Adige 440
Conoscere e descrivere i settori produttivi
dell’economia del Veneto 440
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Friuli-Venezia Giulia 441
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Emilia Romagna 441
Matematica
• Relazioni, dati e previsioni
442
Individuare i criteri di una classificazione rappresentata mediante diagrammi e tabelle 442
Stabilire relazioni d’ordine e di equivalenza riconoscendo le proprietà simmetrica, transitiva e riflessiva 443
Intuire regolarità e costruire progressioni aritmetiche 444
• Numeri 446
Confrontare le operazioni di moltiplicazione e divisione 446
Conoscere il comportamento dello zero e dell’uno nella moltiplicazione 448
Conoscere il comportamento dello zero nella divisione 449
Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione 449
Applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione 450
Applicare la proprietà invariantiva della divisione 450
Estendere la conoscenza dei numeri all’insieme dei numeri relativi 450
Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 452
Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre con i numeri naturali 452
Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una e di due cifre con i numeri naturali 452
Eseguire in colonna divisioni con il divisore di tre cifre con i numeri naturali 453
Prevedere il risultato di un’operazione eseguendo un calcolo approssimato 453
Calcolare multipli e divisori di un numero 454
Riconoscere alcuni criteri di divisibilità 455
Ricercare i numeri primi utilizzando il crivello di Eratostene 456
Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita 457
• Spazio e figure 458
Classificare i triangoli rispetto ai lati 458
Classificare i triangoli rispetto agli angoli 458
Classificare i quadrilateri convessi 458
Consolidare i concetti di base, altezza e diagonale nei triangoli e nei quadrilateri 458
Classificare e denominare i poligoni con più di quattro lati 461
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 461
Consolidare i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria 462
Calcolare il perimetro dei triangoli e dei quadrilateri 462
Risolvere problemi geometrici (perimetro) 462
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni 463
Costruire il concetto di energia 463
• Osservare e sperimentare sul campo 463
Individuare gli alimenti contenenti i grassi 463
Sperimentare la funzione della saliva nella digestione 463
Sperimentare i danni prodotti dal fumo ai polmoni 464
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 464
Comprendere la funzione della nutrizione 464
Conoscere i nutrienti 464
Conoscere la struttura e la funzione dei carboidrati 465
Conoscere la struttura e la funzione dei grassi 465
Conoscere la struttura e la funzione delle proteine 465
Conoscere la struttura e la funzione delle vitamine 466
Conoscere la struttura e la funzione dei sali minerali 466
Conoscere la funzione dell’acqua 466
Acquisire il concetto di fabbisogno energetico 467
Conoscere l’apparato digerente 467
Conoscere le ghiandole annesse all’apparato digerente 468
Conoscere la struttura, lo sviluppo e la funzione dei denti 469
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato digerente 469
Conoscere l’apparato respiratorio 470
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato respiratorio 471
Musica
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 472
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 472
Riconoscere gli usi, le funzioni e i concetti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione e computer) 472
Musica popolare e danza: aspetti storici e spunti operativi 472
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 473
Gli strumenti ad arco 473
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare 474
Elaborare creativamente produzioni personali e collettive 474
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 474
Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 474
Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 474
• Osservare e leggere le immagini
475
Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato 475
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 475
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte
475
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 476
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 476
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 477
Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea 477
Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione agli oggetti e/o agli attrezzi 477
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 478
Usare il corpo e il viso per esprimere azioni e stati d’animo 478
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 479
Rispettare le regole in una competizione sportiva 479
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 480
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 480
Tecnologia
• Vedere e Osservare 481
Descrivere la funzione dei principali apparecchi elettrodomestici ed elettronici 481
Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un frigorifero 481
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: il legno 482
• Prevedere e immaginare 482
Prevedere le conseguenze di comportamenti personali: il risparmio energetico 482
Pianificare la fabbricazione di un oggetto di legno 482
• Intervenire e trasformare 482
Utilizzare la corretta procedura per preparazione del pane 482
Antologia
Bentornato, inverno! (1) 484
Natale in… poesia 486
Brani da ascoltare 488
Schede operative
Italiano
n. 167 Libri straordinari
490
n. 168 Leggere comodamente (1) 492
n. 169 Alessandro Magno e il vermetto 494
n. 170 Gli scorpioni (1) 496
n. 171 Il GGG 498
n. 172 Regole di primo soccorso 500
n. 173 Il museo 502
n. 174 Libri di carta o elettronici? 504
n. 175 Attenzione attenzione 506
n. 176 La mia autobiografia 508
n. 177 Descrivo la biblioteca 509
n. 178 Regole al museo 510
n. 179 Il mio comune 511
n. 180 Un regalo gradito 512
n. 181 La forma delle parole 513
n. 182 Gli scorpioni (3) 514
n. 183 I sinonimi 515
n. 184 Gli omonimi 516
n. 185 I contrari 517
n. 186 I campi semantici 518
n. 187 Le parti variabili e invariabili del discorso 519
n. 188 Radici e desinenze 520
n. 189 Prefissi e suffissi 521
n. 190 Gli articoli 522
n. 191 I nomi 524
n. 192 Gli aggettivi qualificativi (1) 525
n. 193 I gradi dell’aggettivo (1) 526
n. 194 Gli aggettivi numerali (1) 527
n. 195 I pronomi personali 528
n. 196 I pronomi relativi 530
n. 197 Aggettivi e pronomi possessivi (1) 531
n. 198 Aggettivi e pronomi indefiniti 532
n. 199 Aggettivi e pronomi dimostrativi 534
n. 200 Aggettivi e pronomi esclamativi e interrogativi 535
Storia
n. 201 Il Guerriero di Capestrano 536
n. 202 Il Sarcofago degli Sposi 537
n. 203 Palafitte e terramare 538
n. 204 I popoli italici 539
n. 205 I Sardi 540
n. 206 La Magna Grecia 541
n. 207 Gli Etruschi: un’origine misteriosa 542
n. 208 Il lucumone 543
n. 209 Auguri e aruspici 544
n. 210 Il tempio etrusco 545
n. 211 Le necropoli etrusche 546
n. 212 Le abitazioni degli Etruschi 547
n. 213 L’abbigliamento degli Etruschi 548
n. 214 Grandezze greche in Italia 549
n. 215 Cruci… italico! 550
Geografia
n. 216 Carta d’identità della regione… 551
n. 217 La Valle d’Aosta: la popolazione 552
n. 218 In giro per… Torino 553
n. 219 La Liguria: il territorio 554
n. 220 In giro per… Milano 555
n. 221 Il Trentino-Alto Adige: la popolazione 556
n. 222 Il Veneto: la popolazione 557
n. 223 Il Friuli-Venezia Giulia: il territorio 558
n. 224 In giro per… Bologna 559
n. 225 La Valle d’Aosta: parchi e castelli 560
n. 226 La Liguria: grotte e borghi 561
n. 227 Il Trentino-Alto Adige: cime e ghiacciai 562
n. 228 Il Veneto: arte e natura 563
n. 229 Il Friuli-Venezia Giulia: grotte e “stelle” 564
n. 230 Il Piemonte: l’economia 565
n. 231 La Lombardia: l’economia 566
n. 232 L’Emilia Romagna: l’economia 567
Matematica
n. 233 Diagrammi e classificazioni (1) 568
n. 234 Stabilisco relazioni (1) 569
n. 235 Stabilisco relazioni (2) 570
n. 236 I numeri di Fibonacci 571
n. 237 Confronto le operazioni di moltiplicazione e divisione 572
n. 238 Pari e dispari nella moltiplicazione 573
n. 239 Commuto e associo nella moltiplicazione 574
n. 240 La proprietà distributiva nella moltiplicazione 575
n. 241 La proprietà invariantiva nella divisione 576
n. 242 I numeri relativi (1) 577
n. 243 I numeri relativi (2) 578
n. 244 Opero con i numeri relativi (1) 579
n. 245 Moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 580
n. 246 Moltiplicazioni in colonna con i numeri interi 581
n. 247 Divisioni in colonna con i numeri interi (1) 582
n. 248 Divisioni in colonna con i numeri interi (2) 583
n. 249 Calcolo approssimato 584
n. 250 I multipli di un numero 585
n. 251 Multipli comuni 586
n. 252 I divisori di un numero 587
n. 253 I criteri di divisibilità (1) 588
n. 254 I numeri primi 589
n. 255 Costi - ricavi - guadagni (1) 590
n. 256 Costi - ricavi - guadagni (2) 591
n. 257 Classifico i triangoli rispetto ai lati 592
n. 258 Classifico i triangoli rispetto agli angoli 593
n. 259 Classifico i triangoli rispetto ai lati e agli angoli 594
n. 260 Trapezi e parallelogrammi 595
n. 261 I parallelogrammi 596
n. 262 Quadrato - rettangolo - rombo - romboide 597
n. 263 I trapezi 598
n. 264 Classifico i quadrilateri 599
n. 265 Le altezze e le basi nei triangoli e nei quadrilateri (1) 600
n. 266 Le altezze e le basi nei triangoli e nei quadrilateri (2) 601
n. 267 Le diagonali dei poligoni 602
n. 268 Poligoni con più di quattro lati 603
n. 269 Il disegno geometrico 604
n. 270 Congruenza ed equiestensione 605
n. 271 Isoperimetria 606
n. 272 Congruenza, equiestensione, isoperimetria 607
n. 273 Calcolo il perimetro (1) 608
n. 274 Calcolo il perimetro (2) 609
n. 275 Risolvo problemi geometrici 610
Scienze
n. 276 Energia intorno a te! 611
n. 277 Sperimento… la funzione della saliva! 612
n. 278 Sperimento… i danni del fumo! 613
n. 279 La nutrizione e gli alimenti 614
n. 280 I nutrienti 615
n. 281 Acqua: un bene essenziale! 616
n. 282 Cibo ed energia 617
n. 283 Una piramide per una settimana 618
n. 284 L’apparato digerente 619
n. 285 Funzioni e organi dell’apparato digerente 620
n. 286 Quiz sull’apparato digerente 621
n. 287 L’apparato respiratorio 622
n. 288 Gli organi dell’apparato respiratorio 623
n. 289 I movimenti respiratori 624
n. 290 Quiz sull’apparato respiratorio 625
Musica
n. 291 In viaggio per l’Italia: il Trentino 626
n. 292 Gli strumenti ad arco 627
Arte e immagine
n. 293 In biblioteca 628
n. 294 L’arte degli Etruschi 629
Educazione fisica
n. 295 Invento un percorso 630
n. 296 Proverbi da mimare 631
n. 297 Regole e sanzioni 632
Tecnologia
n. 298 Conosco il frigorifero 633
n. 299 Stella di Natale 634
Alla scoperta delle tradizioni
Proposte metodologiche
Italiano
• Ascolto e parlato 636
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 636
Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per regolare comportamenti 636
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 636
Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 637
• Lettura 638
Acquisire il piacere di leggere 638
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 639
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione: il mito 639
Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi: il racconto comico 640
Leggere testi letterari narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore: l’Eneide 640
Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto 641
Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 642
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 643
Leggere testi argomentativi usando strategie per analizzare il contenuto 643
Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale: le figure di suono 643
• Scrittura 644
Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche 644
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 645
Scrivere testi per regolare comportamenti: il rapporto con gli animali 645
Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze e argomenti di studio: la relazione 646
Scrivere testi per argomentare 646
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 647
Sperimentare tecniche per riassumere testi 647
Sperimentare tecniche per parafrasare testi 648
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 648
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 648
Riconoscere la variabilità della lingua nello spazio
geografico: i dialetti 648
Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 648
Storia
• Uso delle fonti 653
Produrre informazioni dalla Lupa Capitolina 653
• Organizzazione delle informazioni 653
Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà romana 653
Usare cronologie per rappresentare la storia romana 653
• Strumenti concettuali 654
Conoscere la nascita della civiltà dei Romani 654
Conoscere l’origine mitologica della civiltà dei Romani 654
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età monarchica 655
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età repubblicana 655
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la conquista dell’Italia 655
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le guerre puniche 656
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le riforme dei Gracchi 656
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le guerre civili 657
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: Gaio Giulio Cesare 657
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la fine dell’età repubblicana 658
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Romani nell’età monarchica 658
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Romani nell’età repubblicana 658
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei territori conquistati dai Romani 659
Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: la flotta 659
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Romani nell’età monarchica 660
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Romani nell’età repubblicana 660
Conoscere e analizzare l’organizzazione della famiglia romana 660
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Romani 661
Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: le abitazioni 661
Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’alimentazione 661
Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’abbigliamento 661
• Produzione scritta e orale 662
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: la Roma dei re 662
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: la Roma repubblicana 662
Geografia
• Orientamento 663
Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia centrale utilizzando i punti cardinali 663
Leggere immagini satellitari dell’Italia centrale 663
• Linguaggio della geo-graficità 663
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Toscana 664
Analizzare i principali caratteri fisici e politici delle Marche 664
Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Umbria 664
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Lazio 665
Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Abruzzo 665
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Molise 665
• Paesaggio 666
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Toscana 666
Conoscere il patrimonio naturale e culturale delle Marche 666
Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Umbria 666
Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Lazio 666
Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Abruzzo 667
Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Molise 667
• Regione e sistema territoriale 667
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Toscana 667
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia delle Marche 667
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Umbria 667
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Lazio 668
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Abruzzo 668
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Molise 668
Matematica
• Numeri 669
Rappresentare e denominare frazioni di figure 669
Individuare l’intero conoscendo il valore dell’unità frazionaria 669
Individuare la frazione complementare di una frazione data 670
Riconoscere e denominare frazioni proprie, improprie, apparenti 670
Riconoscere frazioni equivalenti 673
Confrontare e ordinare frazioni 673
Calcolare frazioni di quantità numeriche 675
Calcolare l’intero della parte frazionaria 675
Riconoscere le frazioni decimali 676
Scrivere le frazioni decimali sotto forma di numeri decimali e viceversa 676
Scomporre e comporre i numeri decimali 678
Confrontare e ordinare numeri decimali 679
Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione 679
• Relazioni, dati e previsioni 680
Conoscere e utilizzare le principali unità del Sistema
Internazionale di misura 680
Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità), espressa in una data unità, a un’altra a essa equivalente 682
Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità anche con le equivalenze 683
Conoscere e operare con le misure di tempo 684
Risolvere problemi con le misure di tempo 686
Risolvere problemi su peso lordo, peso netto e tara 687
Rappresentare e leggere dati rilevati con vari tipi di grafici 687
Rappresentare e leggere sul diagramma cartesiano l’andamento di un semplice fenomeno 690
• Spazio e figure 691
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 691
Conoscere le caratteristiche fondamentali del cerchio 692
Classificare poligoni in regolari e non 695
Acquisire il concetto di apotema 695
Riconoscere le trasformazioni isometriche 697
Individuare gli assi di simmetria nei poligoni 699
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni
Costruire il concetto di suono
• Osservare e sperimentare sul campo
Sperimentare suoni
Sperimentare i battiti del cuore
• L’uomo, i viventi e l’ambiente
Conoscere l’apparato circolatorio
700
700
700
700
700
701
701
Conoscere la struttura e la funzione del sangue 702
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato circolatorio 703
Conoscere la struttura e la funzione del sistema linfatico 704
Conoscere l’apparato escretore 704
Conoscere la struttura e la funzione della pelle 705
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute della pelle 707
Conoscere la struttura e la funzione del sistema immunitario 707
Musica
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione 708
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 708
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 708
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 708
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 709
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare 710
Elaborare creativamente produzioni personali 710
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 710
Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 710
Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 710
• Osservare e leggere le immagini 710
Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato 710
Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva 711
Conoscere il linguaggio dei fumetti 711
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 711
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 711
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 712
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 712
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 713
Riconoscere e valutare traiettorie e distanze 713
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 714
Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee attraverso varie forme di danza 714
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 715
Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare 715
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 716
Acquisire consapevolezza della funzione fisiologica cardio-respiratoria 716
Tecnologia
• Vedere e osservare 717
Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di una lavatrice 717
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: la carta 717
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: le fibre tessili 718
• Prevedere e immaginare 718
Pianificare la fabbricazione di un oggetto di tessuto 718
• Intervenire e trasformare 718
Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una maschera di cartapesta 718
Antologia
Bentornata, primavera! 720 I suoni in… poesia 723
La scuola in… poesia 724
Animali in… poesia 725
Schede operative
Italiano
n. 300 I sette re di Roma: come si chiamavano? 726
n. 301 Io e il teatro 727
n. 302 Un orso bruno e Letti… speciali 728
n. 303 Amore e Psiche 730
n. 304 Un pranzetto tra amici (1) 732
n. 305 Eurialo e Niso 734
n. 306 L’invenzione di Totò Sapore (1) 736
n. 307 Regole a teatro 738
n. 308 La moda a Roma 740
n. 309 L’uomo e il cane 742
n. 310 I suoni della poesia 744
n. 311 Un episodio divertente 746
n. 312 Descrivo un teatro italiano 747
n. 313 L’amico migliore 748
n. 314 Le regole per tenere un animale in casa 749
n. 315 Spettacolo a teatro 750
n. 316 Animali in casa: idee a confronto 751
n. 317 Poesia e suoni 752
n. 318 Un pranzetto tra amici (2) 753
n. 319 L’invenzione di Totò Sapore (3) 754
n. 320 I verbi 755
n. 321 Verbi derivati e alterati (1) 756
n. 322 I verbi essere e avere (1) 758
n. 323 I modi dei verbi 759
n. 324 Il modo indicativo 760
n. 325 Il modo congiuntivo (1) 762
n. 326 Il modo condizionale
763
n. 327 Il modo imperativo 764
n. 328 I modi indefiniti (1) 765
n. 329 I verbi transitivi e intransitivi 766
n. 330 Le forme del verbo 767
n. 331 La forma attiva e passiva 768
n. 332 La forma riflessiva 769 Storia
n. 333 Roma e il fiume Tevere 770
n. 334 I sette re di Roma 771
n. 335 Roma nell’età repubblicana 772
n. 336 La conquista dell’Italia: sconfitte e vittorie 773
n. 337 Le guerre puniche 774
n. 338 Silla e Mario 775
n. 339 Tre uomini al potere: il primo triumvirato 776
n. 340 Cesare e Pompeo: la guerra civile 777
n. 341 Ottaviano e Antonio: l’ultima guerra 778
n. 342 La monarchia romana 779
n. 343 La repubblica romana: le funzioni 780
n. 344 La nave romana 781
n. 345 Le classi sociali nella Roma dei re 782
n. 346 Il pàntheon romano 783
n. 347 Entro in una… domus 784
n. 348 Abiti romani 785
n. 349 In gioco con la Roma dei re 786
Geografia
n. 350 Le regioni dell’Italia centrale 787
n. 351 In giro per… Firenze 788
n. 352 Le Marche: la popolazione 789
n. 353 In giro per… Perugia 790
n. 354 In giro per… Roma 791
n. 355 In giro per… l’Aquila 792
n. 356 Il Molise: il territorio 793
n. 357 Le Marche: palazzi e grotte 794
n. 358 Il Lazio: parchi e monumenti 795
n. 359 Il Molise: riserve naturali e campane 796
n. 360 La Toscana: l’economia 797
n. 361 L’Umbria: l’economia 798
n. 362 L’Abbruzzo: l’economia 799
Matematica
n. 363 Frazioni di figure 800
n. 364 Rappresento frazioni 801
n. 365 L’unità frazionaria 802
n. 366 Frazioni complementari 803
n. 367 Calcolo la frazione complementare 804
n. 368 Frazioni proprie, improprie e apparenti 805
n. 369 Frazioni proprie, improprie e apparenti sulla linea dei numeri (1) 806
n. 370 Frazioni equivalenti 807
n. 371 Riconosco frazioni equivalenti 808
n. 372 Confronto frazioni con numeratori diversi e denominatori uguali (1) 809
n. 373 Confronto frazioni con numeratori uguali e denominatori diversi (1) 810
n. 374 Confronto e ordino frazioni 811
n. 375 Calcolo frazioni di quantità numeriche 812
n. 376 Dall’intero alla frazione (2) 813
n. 377 Dalla frazione all’intero 814
n. 378 Frazioni decimali (1) 815
n. 379 Frazioni decimali sulla linea dei numeri 816
n. 380 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (1) 817
n. 381 Frazioni decimali e numeri decimali (1) 818
n. 382 Dai numeri decimali alle frazioni decimali 819
n. 383 Scompongo i numeri decimali (1) 820
n. 384 Compongo i numeri decimali 821
n. 385 Numeri decimali a confronto 822
n. 386 Ordino i numeri decimali 823
n. 387 Dividendi e divisori: attenti a quei due…! (1) 824
n. 388 Il Sistema Internazionale di misura 825
n. 389 Lunghezza, peso e capacità 826
n. 390 Misura maggiore e misura minore 827
n. 391 Equivalenze 828
n. 392 Misuro, peso e… calcolo (1) 829
n. 393 Quanto impiego a… 830
n. 394 Ore e minuti 831
n. 395 Linea del tempo, calendario e orologio… alla mano (1) 832
n. 396 Pesi… trasparenti! (1) 833
n. 397 L’ideogramma 834
n. 398 L’istogramma 835
n. 399 Areogramma e istogramma 836
n. 400 Leggere il diagramma cartesiano 837
n. 401 La circonferenza e il cerchio (1) 838
n. 402 La circonferenza e il cerchio (2) 839
n. 403 La circonferenza 840
n. 404 Diametro e circonferenza 841
n. 405 Diametro, raggio e circonferenza 842
n. 406 Poligoni equilateri e poligoni equiangoli 843
n. 407 Poligoni regolari e non 844
n. 408 Poligoni regolari e tanti triangoli 845
n. 409 Figure traslate 846
n. 410 Rotazioni 847
n. 411 Alla ricerca di simmetrie 848
n. 412 Assi di simmetria nei poligoni 849
Scienze
n. 413 Il suono 850
n. 414 Altezza, intensità e timbro 851
n. 415 Sperimento… i suoni! 852
n. 416 L’apparato circolatorio 853
n. 417 I vasi sanguigni 854
n. 418 Il cuore 855
n. 419 Ciclo cardiaco 856
n. 420 Grande e piccola circolazione 857
n. 421 Il sangue 858
n. 422 I gruppi sanguigni 859
n. 423 Il sistema linfatico 860
n. 424 L’apparato escretore 861
n. 425 La pelle 862
n. 426 Peli, ghiandole cutanee e unghie 863
n. 427 Il sistema immunitario 864
Musica
n. 428 In viaggio per l’Italia: Roma! 865
n. 429 A ognuno il suo… timbro! 866
Arte e immagine
n. 430 Il teatro italiano (1) 867
n. 431 Amore e Psiche in… arte 868
Educazione fisica
n. 432 L’hully-gully 869
n. 433 La respirazione 870
Tecnologia
n. 434 Il viaggio della carta 871
n. 435 Abiti in miniatura! 872
APRILE • MAGGIO
Verso la scuola secondaria
Proposte metodologiche
Italiano
• Ascolto e parlato 874
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 874
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 874
• Lettura 875
Acquisire il piacere di leggere 875
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 875
Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo: il racconto poliziesco 875
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca 876
Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto: le sequenze 877
Leggere testi narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore 877
Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 878
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 878
Leggere testi argomentativi, individuando le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee 879
Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale 879
• Scrittura 880
Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche: il diario, il racconto autobiografico 880
Scrivere lettere adeguando le forme espressive ai destinatari e alle situazioni: la lettera personale e la lettera formale 881
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 881
Scrivere testi per regolare comportamenti 882
Scrivere testi per argomentare 882
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 883
Sperimentare tecniche per riassumere testi 883
Sperimentare tecniche per parafrasare testi 883
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 884
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 884
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: il linguaggio figurato 884
Riconoscere le parti invariabili del discorso, conoscerne i tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni 885
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 885
Storia
• Uso delle fonti 890
Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli archi di trionfo 890
Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli acquedotti 890
Produrre informazioni dall’Ara Pacis 890
Produrre informazioni dalla Colonna Traiana 890
Produrre informazioni dal Pàntheon 891
Produrre informazioni da antiche monete romane 891
• Organizzazione delle informazioni 891
Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa l’Impero romano 891
Usare cronologie per rappresentare la storia dell’Impero romano 891
• Strumenti concettuali 892
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: il principato di Augusto 892
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età imperiale 892
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la decadenza dell’Impero 892
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la divisione e la fine dell’Impero 893
Conoscere e analizzare la nascita e lo sviluppo del cristianesimo 894
Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: l’esercito 894
Conoscere la funzione e la struttura dell’anfiteatro presso i Romani 894
Conoscere la funzione e la struttura del circo presso i Romani 895
Conoscere la funzione e la struttura delle terme presso i Romani 895
• Produzione scritta e orale 895
Produrre informazioni da testi storici 895
Elaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati: l’Impero romano 895
Geografia
• Orientamento 896
Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia meridionale utilizzando i punti cardinali 896
Leggere immagini satellitari dell’Italia meridionale 896
• Linguaggio della geo-graficità 896
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Campania 897
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Basilicata 897
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Puglia 897
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Calabria 898
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Sicilia 898
Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Sardegna 899
Confrontare i principali caratteri fisici delle regioni italiane 899
Confrontare i principali caratteri politici delle regioni italiane 899
• Paesaggio 900
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Campania 900
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Basilicata 900
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Puglia 900
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Calabria 901
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Sicilia 901
Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Sardegna 902
Confrontare il patrimonio culturale delle regioni italiane 902
• Regione e sistema territoriale 902
Conoscere e descrivere i settori produttivi
dell’economia della Campania 902
Conoscere e descrivere i settori produttivi
dell’economia della Basilicata 902
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Puglia 903
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Calabria 903
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Sicilia 903
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Sardegna 903
Confrontare le caratteristiche dell’economia delle regioni italiane 903
Matematica
• Numeri 904
Riconoscere e utilizzare la frazione come percentuale 904
Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali 905
Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000 905
Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali 906
Eseguire in colonna divisioni con i numeri decimali 907
Trasformare una frazione non decimale in un numero decimale 909
Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di operazioni 909
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, descrivere il procedimento seguito per la risoluzione di un problema e confrontarsi con il punto di vista degli altri 910
• Relazioni, dati e previsioni 911
Risolvere problemi che implicano anche il calcolo di percentuali 911
Risolvere problemi mediante diagrammi ed espressioni 911
Costruire, dato un algoritmo risolutivo, il testo di un problema 913
Conoscere il rapporto dell’euro con altre monete 913
Conoscere le misure di superficie 913
Risolvere problemi geometrici (area) 914
Intuire il rapporto esistente tra spazio, tempo e velocità 914
Conoscere le misure di volume 915
Individuare moda, media, mediana 916
Rappresentare, elencare e numerare tutti i possibili casi in semplici situazioni combinatorie e calcolarne le probabilità 916
• Spazio e figure 916
Calcolare l’area dei principali poligoni 916
Calcolare l’area dei poligoni regolari 919
Calcolare l’area del cerchio 920
Riconoscere figure piane simili 922
Riprodurre in scala una figura assegnata 924
Classificare e denominare le principali figure solide 924
Saper costruire e sviluppare sul piano il cubo e il parallelepipedo 927
Calcolare l’area del cubo e del parallelepipedo 927
Acquisire il concetto di volume 928
Calcolare il volume del cubo 930
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni 931
Costruire il concetto di luce 931
• Osservare e sperimentare sul campo 931
Sperimentare la luce 931
Sperimentare illusioni ottiche 932
Sperimentare la sensibilità del corpo umano 932
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 932
Conoscere l’apparato riproduttore 932
Conoscere le caratteristiche della pubertà 933
Conoscere la fecondazione 933
Conoscere le fasi della gravidanza 934
Conoscere le fasi del parto 934
Conoscere la struttura e la funzione degli organi di senso 934
Conoscere la struttura e la funzione del sistema nervoso 935
Conoscere la struttura e la funzione del il sistema endocrino 936
Musica
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 937
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 937
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 937
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 937
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare 939
Elaborare creativamente produzioni personali 939
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 939
Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 939
• Osservare e leggere le immagini 939
Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato 939
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 940
Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, individuando il loro significato espressivo 940
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 940
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 940
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 941
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 941
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 942
Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali di azioni motorie 942
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 942
Trovare e mantenere l’equilibrio 942
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 943
Partecipare a giochi sportivi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta e manifestando senso di responsabilità 943
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 944
Conoscere le regole di comportamento da tenere durante le manifestazioni sportive 944
Tecnologia
• Vedere e osservare 946
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti 946
Descrivere la funzione e la struttura di un televisore 946
Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un telefono 946
Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di una calcolatrice 947
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: le ceramiche 947
• Prevedere e immaginare 947
Pianificare la costruzione del disco di Newton 947
Pianificare la fabbricazione di un telefono 947
• Intervenire e trasformare 947
Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una mattonella 947
Antologia
Aspettando l’estate! 950
Bentornata, estate! 951
Poesia per tutti i gusti... 953
Poesia in... libertà 954
Brani da ascoltare 955
Schede operative
Italiano
n. 436 La Via Lattea 956
n. 437 Io e la scuola 957
n. 438 Un giorno a Pompei (1) 958
n. 439 Una famosa eruzione (1) 960
n. 440 L’articolo di giornale 962
n. 441 Giulietta e Romeo (1) 964
n. 442 Il signor B. compera il C... 966
n. 443 Regole per navigare in internet 968
n. 444 Il Parlamento dei bambini (1) 970
n. 445 Il panda (1) 972
n. 446 Similitudini e metafore 974
n. 447 Caro diario 976
n. 448 Descrivo il mercato 977
n. 449 Poesia a... buon mercato 978
n. 450 In caso di terremoto... 980
n. 451 Il panda (2) 981
n. 452 Trasformo la... domenica 982
n. 453 Espressioni figurate (1) 983
n. 454 Le preposizioni semplici e articolate (1) 984
n. 455 Gli avverbi (1) 985
n. 456 Le congiunzioni 986
n. 457 Le esclamazioni 987
n. 458 Frase semplice e frase complessa 988
n. 459 Il soggetto 989
n. 460 Il predicato verbale 990
n. 461 Il predicato nominale 991
n. 462 Il complemento oggetto 992
n. 463 I complementi indiretti (1) 993
n. 464 I complementi indiretti (2) 994
Storia
n. 465 L’Ara Pacis 996
n. 466 Ottaviano Augusto 997
n. 467 La dinastia Giulio-Claudia 998
n. 468 La dinastia Flavia 999
n. 469 Traiano e Adriano 1000
n. 470 La fine dell’Impero romano d’Occidente 1001
n. 471 Gesù e il cristianesimo 1002
n. 472 Il castrum 1003
n. 473 La legione romana 1004
n. 474 Il legionario romano 1005
n. 475 L’anfiteatro 1006
n. 476 Una giornata all’anfiteatro 1007
n. 477 I ludi circenses 1008
n. 478 Le terme 1009
n. 479 Alla ricerca degli imperatori 1010
Geografia
n. 480 L’Italia meridionale dal satellite 1011
n. 481 In giro per... Napoli 1012
n. 482
La Basilicata: il territorio 1013
n. 483 La Puglia: la popolazione 1014
n. 484 La Calabria: il territorio 1015
n. 485 In giro per... Palermo 1016
n. 486 La Sardegna: la popolazione 1017
n. 487 Regioni, territorio e numeri 1018
n. 488 La Basilicata: parchi, sassi e castelli 1019
n. 489 La Puglia: foreste, grotte e trulli 1020
n. 490 La Sicilia: fuoco e storia 1021
n. 491 Regioni tra cultura e maschere 1022
n. 492 La Campania: l’economia 1023
n. 493 La Calabria: l’economia 1024
n. 494 La Sardegna: l’economia 1025
Matematica
n. 495 La percentuale 1026
n. 496 Dalla frazione decimale alla percentuale 1027
n. 497 Addizioni con i numeri decimali 1028
n. 498 Sottrazioni con i numeri decimali 1029
n. 499 Moltiplicazioni con i numeri decimali 1030
n. 500 Divisioni in colonna con i numeri decimali (1) 1031
n. 501 Frazioni, quozienti e percentuali 1032
n. 502 Le espressioni 1033
n. 503 Eureka!... ci siamo riusciti! (1) 1034
n. 504 Percentuali... sotto osservazione (1) 1035
n. 505 Dal problema... all’algoritmo (1) 1036
n. 506 Dall’algoritmo... al problema (1) 1037
n. 507 Valute e valori 1038
n. 508 Le unità di misura di superficie (1) 1039
n. 509 L’area del rettangolo(1) 1040
n. 510 L’area del quadrato (1) 1041
n. 511 L’area del triangolo 1042
n. 512 L’area dei poligoni regolari 1043
n. 513 L’area del cerchio 1044
n. 514 Ragionamenti e formule (1) 1045
n. 515 Spazio, tempo, velocità 1046
n. 516 Figure simili 1047
n. 517 Ingrandimenti in scala 1048
n. 518 Le figure solide 1049
n. 519 Poliedri e solidi di rotazione 1050
n. 520 Lo sviluppo del cubo 1051
n. 521 La superficie del cubo 1052
n. 522 Il volume di un solido 1053
n. 523 Le misure del volume 1054
n. 524 Il volume del cubo 1055
n. 525 Moda, media, mediana 1056
n. 526 Combinazioni perfette 1057
Scienze
n. 527 La luce 1058
n. 528 Giochi di luce 1059
n. 529 Illusioni ottiche... 1060
n. 530 A che cosa serve la riproduzione? 1061
n. 531 L’apparato riproduttore maschile 1062
n. 532 L’apparato riproduttore femminile 1063
n. 533 Il ciclo ovarico 1064
n. 534 La pubertà: diventare grandi 1065
n. 535 Nella pancia della mamma... un bimbo 1066
n. 536 Nove mesi e... un bambino 1067
n. 537 I gemelli 1068
n. 538 Recettori per i cinque sensi 1069
n. 539 Il tatto e la pelle 1070
n. 540 Il sistema nervoso centrale 1071
n. 541 Il sistema nervoso periferico 1072
n. 542 Il sistema nervoso autonomo 1073
n. 543 Il sistema endocrino 1074
Musica
n. 544 In viaggio per l’Italia: la Sicilia! 1075
n. 545 C’è percussione e percussione! 1076
Arte e immagine
n. 546 Giulietta e Romeo da dipingere 1077
n. 547 La memoria visiva 1078
Educazione fisica
n. 548 L’equilibrio 1079
n. 549 Il codice di comportamento 1080
Tecnologia
n. 550 Dal telefono allo smartphone 1081
n. 551 Una mattonella per la mamma 1082
Diversi e insieme!
Proposte metodologiche
Educazione civica
• Costituzione e diritti 1084
Riconoscere i valori fondamentali della Costituzione 1084
Identificare pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi per contrastarli 1087
Conoscere le principali istituzioni della Repubblica italiana 1088
Conoscere l’inno nazionale 1091
Conoscere l’organizzazione amministrativa della Regione, della Provincia e del Comune 1092
Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza territoriale 1092
Riconoscere il ruolo della cooperazione e della solidarietà come strategia per migliorare le relazioni interpersonali e sociali 1092
Accettare e accogliere le diversità, impiegandole come risorse per compiti o progetti comuni 1092
Individuare i servizi offerti dal territorio e comprenderne la funzione 1093
Comprendere la funzione e il valore delle regole dei diversi ambienti di vita quotidiana 1093
Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale 1093
Schede operative
Educazione civica
n. 552 Nasce la Costituzione italiana 1094
n. 553 I have a dream 1095
n. 554 Repubblica e Costituzione 1096
n. 555 Fratelli 1097
n. 556 Se vuoi la pace... 1098
n. 557 Signor Sindaco... 1099
n. 558 … in giro per Allegropoli! 1100
n. 559 Filastrocche antibullo 1102
n. 560 Sono un buon pedone 1103
n. 7
n. 8
n. 9
i gruppi con c - g (1)
n. 10 Ortografia: chi, che, ghi, ghe, sci, sce
n. 11
n. 12
nell’ortografia (2)
diretto e indiretto
n.
31
32
33 Gli abachi
n. 34 I numeri romani
n. 35 Retta, semiretta, segmento
n. 36 Vertici, angoli e lati di un poligono
Scienze
n. 37 La struttura della cellula eucariote
n. 38 I tessuti cellulari
n. 39 Lo scheletro e i suoi tessuti
n. 40 Lo scheletro e le sue parti
n. 41 Le articolazioni
n. 42 Le deformazioni dello scheletro
n. 43 I tessuti muscolari
n. 44 I muscoli del corpo umano
Arte e immagine
n. 45 Produzioni creative
n. 46 La rielaborazione del Ritratto della principessa de Broglie di J.A. Ingres
n. 47 Stili grafici al computer
n. 48 L’osservazione di immagini
n. 49 La nascita di Venere di S. Botticelli
n. 50 Il Partenone di Atene
Educazione fisica n. 51 Le Paraolimpiadi
Italiano
n. 52 La famiglia
n. 53 I libri
n. 54 Tecniche di lettura
n. 55 Bentornato inverno! (2)
n. 56 Scrivere testi informativo-espositivi
n. 57 Le parole della poesia
n. 58 Gli articoli
n. 59 L’Italia
n. 60 L’Italia dal paleolitico ai popoli italici
n. 61 I popoli italici
n. 62 I Celti
n. 63 I Greci in Italia
n. 64 La storia degli etruschi
n. 65 La città-stato etrusca
n. 66 La società etrusca
n. 67 Il pàntheon etrusco
n. 68 Le necropoli etrusche
n. 69 La vita quotidiana degli Etruschi
Geografia
n. 70 la Valle d’Aosta
n. 71 Il Piemonte
n. 72 La Liguria
n. 73 La Lombardia
n. 78 Le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione 154
n. 79 La proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione 156
n. 80 La proprietà invariantiva della divisione 157
n.81 Le moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 158
n. 82 Le moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore di due o più cifre con i numeri naturali 159
n. 83 Le divisioni in colonna con il divisore di una e di due cifre con i numeri naturali 161
n. 84 Le caratteristiche dei triangoli e la loro classificazione rispetto ai lati e agli angoli 165
n. 85 Le caratteristiche dei quadrilateri e la loro classificazione 168
n. 86 La classificazione e la denominazione di poligoni con più di quattro lati 173
n. 87 Il disegno geometrico 174
n. 88 I concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria 177 Scienze
n. 89 L’energia 180
n. 90 I carboidrati 183
n. 91 I grassi 184
n. 92 I sali minerali 185
n. 93 L’apparato digerente 187
n. 94 L’apparato respiratorio 190 Arte e immagine
n. 95 Produzioni creative 193
n. 96 Addobbi natalizi 194
n. 97 Il padiglione d’oro di Kyoto 195
n. 98 La tomba dei leopardi di Tarquinia 196
3° BIMESTRE
Italiano
n. 99 Il percorso scolastico 197
n. 100 La narrazione fantastica
n. 101 La cronaca
n. 102 Onomatopee per tutti i gusti 201 Storia
n. 103 La fondazione di Roma: la storia 202
n. 104 La fondazione di Roma: la leggenda 204
n. 105 I sette re di Roma 205
n. 106 La conquista dell’Italia 208
n. 107 Le guerre puniche
n. 108 Le riforme sociali dei Gracchi
n. 109 La guerra sociale e la cittadinanza romana
n. 110 Mario e Silla
n. 111 Il primo triumvirato 219
n. 112 Cesare e la conquista della Gallia 221
n. 113 La guerra civile tra Cesare e Pompeo 223
n. 114 Cesare padrone di Roma 224
n. 115 La congiura e la morte di Cesare 225
n. 116 Il secondo triumvirato 226
n. 117 La battaglia di Azio e la fine della repubblica
n. 118 La monarchia a Roma
n. 119 La repubblica a Roma
n. 120 Colonie, municipi, città federate e province 235
n. 121 La flotta romana
n. 122 La società romana nell’età monarchica 239
n. 123 Le lotte e le conquiste dei plebei
n. 124 La religione e le divinità dei Romani
n. 125 Le abitazioni dei Romani
n. 126 L’alimentazione dei Romani 249
n. 127 L’abbigliamento dei Romani 250
Geografia
n. 128 La Toscana
n. 129 Le Marche
n .130 L’Umbria
n. 131 Il Lazio
n. 132 L’Abruzzo
n. 133 Il Molise
Matematica
n. 134 Il piano cartesiano
n. 135 Gli assi di simmetria nei poligoni
Scienze
n. 136 Il suono
n. 137 I vasi sanguigni
n. 138 Il cuore
n. 139 Il ciclo cardiaco
n. 140 la grande circolazione
n. 141 Il sangue
n. 142 I gruppi sanguigni
n. 143 il sistema linfatico 293
n. 144 L’apparato escretore 295
n. 145 La depurazione del sangue
n. 146 La pelle
n. 147 La protezione della pelle
n. 148 Il sistema immunitario
Arte e immagine
n. 149 Produzioni creative
n. 150 Uova decorative
n. 151 Stili grafici al computer
n. 152 I fumetti
n. 153 La statua della libertà a New York
n. 154 Le ville palladiane in Veneto
Educazione fisica
n. 155 I giochi popolari
n. 156 La funzione respiratoria
Italiano
n. 157 La macchina del tempo 310
n. 158 Un giorno a Pompei (2) 311
n. 159 Poesia in... musica
n. 160 La lettera personale e la lettera formale
n. 161 Ottaviano Augusto
n. 162 La dinastia Giulio-Claudia
n. 163 La dinastia Flavia
n. 164 Gli imperatori adottivi 320
n. 165 La dinastia dei Severi
n. 166 Gli imperatori illirici 323
n. 167 Costantino
n. 168 La divisione dell’Impero 326
n. 169 La fine dell’Impero romano d’Occidente 328
n. 170 I Germani 330
n. 171 Gli Unni 331
n. 172 Il Cristianesimo 333
n. 173 L’esercito romano 336
n. 174 L’anfiteatro e i gladiatori 340
n. 175 Le terme 342
Geografia
n. 176 La Campania 344
n. 177 La Basilicata
n. 178 La Puglia
n. 179 La Calabria
n. 180 La Sicilia
n. 181 La Sardegna 376
Matematica
n. 182 Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali
382
n. 183 Moltiplicazioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000 383
n. 184 Dall’algoritmo al testo del problema
n. 185 Il rapporto dell’euro con altre monete
n. 186 Le misure di superficie
n. 187 Spazio, tempo, velocità
385
386
388
390
n. 188 La moda, la media e la mediana 391
n. 189 I possibili casi in semplici situazioni combinatorie e il calcolo delle probabilità
n. 190 La Luce
n. 191 La riproduzione
n. 192 L’apparato riproduttore maschile
n. 193 L’apparato riproduttore femminile
n. 194 Il ciclo ovarico
393
395
397
398
400
402
n. 195 La gravidanza 403
n. 196 Il parto 405
n. 197 I recettori sensoriali
407
n. 198 La vista e l’occhio 408
n. 199 L’udito e l’orecchio 410
n. 200 L’olfatto e il naso 412
n. 201 Il gusto e la lingua 413
n. 202 Il tatto e la pelle 415
n. 203 Il neurone 416
n. 204 Il sistema nervoso centrale 418
n. 205 Il sistema endocrino 420
Musica
n. 206 Gli strumenti 421
Arte e immagine
n. 207 Biglietto d’auguri 422
n. 208 Osservazione dell’aula di Montecitorio 423
n. 209 Apollo e Dafne del Bernini 424
n. 210 La moschea blu di Istanbul
425
n. 211 L’Anfiteatro Flavio 426
SETTEMBRE
Italiano
n. 1 Indovino il genere
n. 2 Alla ricerca delle parole corrette
Storia
n. 3 Tante fonti!
n. 4 Chi è?
n. 5 Sulla linea del tempo
n. 6 Il quadro storico di civiltà 434 Geografia
n. 7 Tante carte per il geografo
n. 8 Orientarsi in Italia
n. 9 Paesaggi e parole
n. 10 Grafici d’Italia
Scienze
n. 11 Tante misure!
n. 12 Viventi o non viventi?
n. 13 I viventi nell’ecosistema
n. 14 Amici nell’ecosistema
OTTOBRE • NOVEMBRE
Italiano
n. 15 Ti piace l’horror?
n. 16 La leggenda degli scacchi
n. 17 Andromeda (2)
n. 18 Ulisse e le sirene (2)
n. 19 Una storia terrificante
n. 20 Le Olimpiadi 453
n. 21 Il logogrifo 454
n. 22 Anagrammi (2) 455
n. 23L’ordine alfabetico (2) 456
n. 24 Ortografia: i gruppi con c e g(2) 457
n. 25 Ortografia: l’accento (2) 458
n. 26 La punteggiatura (2) 459
n. 27 Discorso diretto e indiretto (2) 460
Storia
n. 28 Monete greche: simboli e città 461
n. 29 L’Olpe Chigi: un vaso di guerrieri 462
n. 30 I magnifici Bronzi di Riace 463
n. 31 La Grecia 464
n. 32 Gli Elleni 465
n. 33 L’età oscura 466
n. 34 L’età arcaica 467
n. 35 La grande colonizzazione greca 468
n. 36 La fondazione di una colonia 469
n. 37 Le Termopili e Salamina: eroismo e astuzia 470
n. 38 L’Ellenismo 471
n. 39 Tante póleis 472
n. 40 Sparta: un pólis oligarchica 473
n. 41 Sparta: una società in tre classi 474
n. 42 Atene: dalla monarchia all’oligarchia 475
n. 43 Atene: un’evoluzione democratica 476
n. 44 Le divinità minori 477
n. 45 Gli eroi greci 478
n. 46 I Greci: eccellenti artigiani e mercanti 479
n. 47 La diffusione della moneta 480
n. 48 L’educazione a Sparta e ad Atene 481
n. 49 Le donne a Sparta e ad Atene 482
n. 50 Che cosa mangiano i Greci? 483
n. 51 Filippo II e la falange macedone 484
n. 52 Alessandro Magno 485
n. 53 I regni ellenistici 486
n. 54 La Grecia oggi 487
n. 55 Póleis a confronto 488
Geografia
n. 56 Mi oriento in... Europa! 489
n. 57 Mi oriento in... Italia! 490
n. 58 La terra in... linea! 491
n. 59 Latitudine e longitudine 492
n. 60 L’Italia nelle carte mute 493
n. 61 La popolazione nel mondo 494
n. 62 La popolazione in Europa 495
n. 63 L’Europa e i suoi biomi 496
n. 64 Paesaggi naturali d’Europa 497
n. 65 Rilievi d’Italia 498
n. 66 Acque d’Italia
n. 67 Paesaggi naturali d’Italia
499
500
n. 68 Paesaggi culturali dell’Italia 501
n. 69 Le fasce climatiche della Terra 502
n. 70 Le aree climatiche dell’Europa 503
n. 71 Le regioni climatiche dell’Italia 504
n. 72 I settori produttivi in Europa 505
Matematica
n. 73 Uso il “non” 506
n. 74 Ragiono sulle proposizioni 507
n. 75 Ho un dubbio! 508
n. 76 Rappresento le classificazioni (2) 509
n. 77 Rappresento le classificazioni (3) 510
n. 78 Basi diverse (2) 511
n. 79 Basi diverse (3) 512
n. 80 Basi diverse e valore delle cifre (2) 513
n. 81 Basi diverse e valore delle cifre (3) 514
n. 82 Leggo e scrivo i numeri oltre il milione 515
n. 83 Mi esercito sui numeri grandi 516
n. 84 Confronto e ordino (2) 517
n. 85 I numeri romani (2) 518
n. 86 Addizioni e sottrazioni 519
n. 87 Domanda nascosta (2) 520
n. 88 Rette, semirette, segmenti (1) 521
n. 89 Vertici, lati e angoli di un poligono 522
Scienze
n. 90 Attrito e inerzia
523
n. 91 Sperimento... i movimenti dei muscoli! 524
n. 92 La cellula eucariote 525
n. 93 Il ciclo vitale della cellula 526
n. 94 Tante cellule... quattro tessuti 527
n. 95 Lo scheletro e i suoi tessuti 528
n. 96 La colonna vertebrale 529
n. 97 Le articolazioni 530
n. 98 Curo il mio scheletro 531
n. 99 I tessuti muscolari 532
n. 100 Un corpo di muscoli 533
n. 101 Curo i miei muscoli 534
Arte e immagine
n. 102 Ulisse, secondo me... 535
n. 103 Paesaggio da brivido 536
n. 104 Creo un ritratto 537
n. 105 Calligrammi sonori 538
n. 106 Moda greca 539
n. 107 Ombre sull’Olimpo 540
n. 108 I Bronzi di Riace 541
n. 109 Il Partenone 542
Educazione fisica
n. 110 Regole di comportamento in palestra 543
Tecnologia
n. 111 Le leve del corpo umano 544
n. 112 Macchine in aiuto dell’uomo 545
n. 113 Realizzo una maschera greca 546
n. 114 Cerco in internet 547
Italiano
n. 115 Io e i libri 549
n. 116 Leggere... comodamente (2) 550
n. 117 Gli scorpioni (2) 551
n. 118 Storia della biblioteca (1) 552
n. 119 Una notte al museo 554
n. 120 Storia della biblioteca (2) 555
n. 121 La biblioteca dei sogni 556
n. 122 Nomi comuni e propri 557
n. 123 Nomi concreti e astratti 558
n. 124 Nomi collettivi 559
n. 125 Il genere dei nomi 560
n. 126 Il numero dei nomi 561
n. 127 Nomi primitivi, derivati e alterati 562
n. 128 Nomi composti 564
n. 129 Analisi grammaticale dei nomi 565
n. 130 Gli aggettivi qualificativi (2) 566
n. 131 I gradi dell’aggettivo (2) 568
n. 132 Gli aggettivi numerali (2) 569
n. 133 Aggettivi e pronomi possessivi (2) 570
n. 134 Analisi degli aggettivi 573
n. 135 Analisi dei pronomi 574 Storia
n. 136 Nuraghi misteriosi 575
n. 137 Il Disco di Magliano 576
n. 138 Archi etruschi 577
n. 139 L’Italia 578
n. 140 L’Etruria 579
n. 141 L’Italia paleolitica 580
n. 142 Inizio del Neolitico in Italia 581
n. 143 Popoli italici nel tempo 582
n. 144 Popoli italici nello spazio 583
n. 145 I Camuni 584
n. 146 I Liguri 585
n. 147 I Villanoviani 586
n. 148 I Celti 587
n. 149 La colonizzazione fenicia in Italia 588
n. 150 Gli Etruschi: espansione e declino 589
n. 151 La società etrusca 590
n. 152 La religione degli Etruschi 591
n. 153 Gli Etruschi: celebri artigiani 592
n. 154 La scrittura etrusca 593
n. 155 L’alimentazione degli Etruschi 594
n. 156 Tesori celtici 595
n. 157 Raffinatezze etrusche 596
Geografia
n. 158 Le regioni dell’Italia settentrionale 597
n. 159 L’Italia settentrionale dal satellite 598
n. 160 La Valle d’Aosta: il territorio 599
n. 161 In giro per... Aosta 600
n. 162 Il Piemonte: il territorio 601
n. 163 Il Piemonte: la popolazione 602
n. 164 La Liguria: la popolazione 603
n. 165 In giro per... Genova 604
n. 166 La Lombardia: il territorio 605
n. 167 La Lombardia: la popolazione 606
n. 168 Il Trentino-Alto Adige: il territorio 607
n. 169 In giro per... Trento 608
n. 170 Il Veneto: il territorio 609
n. 171 In giro per... Venezia 610
n. 172 Il Friuli-Venezia Giulia: la popolazione 611
n. 173 In giro per... Trieste 612
n. 174 L’Emilia Romagna: il territorio 613
n. 175 L’Emilia Romagna: la popolazione 614
n. 176 Il Piemonte: costruzioni nella storia 615
n. 177 La Lombardia: laghi e monumenti 616
n. 178 L’Emilia Romagna: natura e costruzioni 617
n. 179 La Valle d’Aosta: l’economia 618
n. 180 La Liguria: l’economia 619
n. 181 Il Trentino-Alto Adige: l’economia 620
n. 182 Il Veneto: l’economia 621
n. 183 Il Friuli-Venezia Giulia: l’economia 622
Matematica
n. 184 Diagrammi e classificazioni (2) 623
n. 185 Relazioni e proprietà 624
n. 186 Uno e zero nelle moltiplicazioni 625
n. 187 Lo zero nella divisione 626
n. 188 Opero con i numeri relativi (2) 627
n. 189 I criteri di divisibilità (2) 628
n. 190 Costi - ricavi - guadagni (3) 629
n. 191 Scompongo e ricompongo figure equiestese 630 Scienze
n. 192 L’energia 631
n. 193 Sperimento... i grassi nei cibi! 632
n. 194 Carboidrati: un pieno di energia! 633
n. 195 Grassi: una riserva di energia! 634
n. 196 Proteine: mattoni dell’organismo! 635
n. 197 Vitamine: una tabella pratica! 636
n. 198 Sali minerali: un prezioso aiuto! 637
n. 199 Dalla bocca allo stomaco 638
n. 200 Dallo stomaco all’intestino 639
n. 201 Dall’intestino all’apertura anale 640
n. 202 Fegato e pancreas 641
n. 203 I denti e il cibo 642
n. 204 Curo il mio apparato digerente 643
n. 205 Dal naso alla trachea 644
n. 206 Dalla trachea ai polmoni 645
n. 207 I polmoni e lo scambio gassoso 646
n. 208 Curo il mio apparato respiratorio 647
Arte e immagine
n. 209 Copertine 648
n. 210 Pezzi da museo 649
n. 211 Creo una natura morta 650
n. 212 Calligrammi natalizi 651
n. 213 Parole e forme 653
n. 214 Decori natalizi 655
n. 215 Il bibliotecario 656
n. 216 Il padiglione d’oro 658
Tecnologia
n. 217 Conosco gli elettrodomestici 659
n. 218 Conosco gli apparecchi elettronici 660
n. 219 Dall’albero alla sedia 661
n. 220 Frigorifero a risparmio energetico 662
n. 221 Facciamo il pane! 663
Italiano
n. 222 Io e i miei compagni
665
n. 223 L’invenzione di Totò Sapore (2) 666
n. 224 Barzellette per tutti i gusti 667
n. 225 Verbi derivati e alterati (2) 668
n. 226 Le coniugazioni dei verbi 669
n. 227 Verbi essere e avere (2) 670
n. 228 Il modo congiuntivo (2) 671
n. 229 Condizionale e congiuntivo 672
n. 230 I modi indefiniti (2) 674
n. 231 Analisi del verbo 675
Storia
n. 232 La lupa Capitolina 676
n. 233 La storia romana in linea 677
n. 234 La fondazione di Roma: la storia 678
n. 235 L’origine della civiltà romana: la leggenda 679
n. 236 La fondazione di Roma: la leggenda 680
n. 237 Il “ratto delle Sabine” 681
n. 238 Dai re sabini e latini... 682
n. 239 … ai re etruschi 683
n. 240 La conquista dell’Italia: date e luoghi 684
n. 241 La prima guerra punica 685
n. 242 La seconda guerra punica 686
n. 243 La terza guerra punica 687
n. 244 I Gracchi e le riforme sociali 688
n. 245 Mario e la riforma dell’esercito 689
n. 246 La rivolta di Spartaco 690
n. 247 Cesare e la conquista della Gallia 691
n. 248 Cesare padrone di Roma 692
n. 249 La congiura contro Cesare 693
n. 250 Il secondo triumvirato 694
n. 251 La riforma di Servio Tullio 695
n. 252 La Repubblica romana: la struttura 696
n. 253 Colonie, municipi, città federate e province 697
n. 254 Le lotte e le conquiste dei plebei 698
n. 255 Il pater familias 699
n. 256 Il culto pubblico e il culto domestico 700
n. 257 L’insula 701
n. 258 Menu a confronto! 702
n. 259 Toghe a colori 703
n. 260 Identikit repubblicani 704
Geografia
n. 261 L’Italia centrale dal satellite 705
n. 262 La Toscana: il territorio 706
n. 263 La Toscana: la popolazione 707
n. 264 Le Marche: il territorio 708
n. 265 In giro per... Ancona 709
n. 266 l’Umbria: il territorio 710
n. 267 L’Umbria: la popolazione 711
n. 268 Il Lazio: il territorio 712
n. 269 Il Lazio: la popolazione 713
n. 270 L’Abruzzo: il territorio 714
n. 271 L’Abruzzo: la popolazione 715
n. 272 Il Molise: la popolazione 716
n. 273 In giro per... Campobasso 717
n. 274 La Toscana: verde e piazze 718
n. 275 L’Umbria: boschi, cascate e borghi 719
n. 276 L’Abruzzo: natura e medioevo 720
n. 277 Le Marche: l’economia 721
n. 278 Il Lazio: l’economia 722
n. 279 Il Molise: l’economia 723
Matematica
n. 280 Quanto manca per formare l’intero? 724
n. 281 Classifico le frazioni 725
n. 282 Rifletto sulle frazioni 726
n. 283 Scompongo le frazioni improprie e trasformo le frazioni apparenti 727
n. 284 Frazioni proprie, improprie e apparenti sulla linea dei numeri (2) 728
n. 285 Rifletto sulle frazioni equivalenti 729
n. 286 Tutte frazioni equivalenti 730
n. 287 Confronto frazioni con numeratori diversi e denominatori uguali (2) 731
n. 288 Confronto frazioni con numeratori uguali e denominatori diversi (2) 732
n. 289 Frazioni da confrontare 733
n. 290 Dall’intero alla frazione (1) 734
n. 291 Calcolo l’intero (1) 735
n. 292 Calcolo l’intero (2) 736
n. 293 Frazioni decimali (2) 737
n. 294 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (2) 738
n. 295 Frazioni decimali e numeri decimali (2) 739
n. 296 Scompongo i numeri decimali (2) 740
n. 297 Numeri decimali da scomporre 741
n. 298 Rifletto sui numeri decimali 742
n. 299 Dividendi e divisori: attenti a quei due! (2) 743
n. 300 Rifletto sulle unità di misura 744
n. 301 Misuro, peso... e calcolo (2) 745
n. 302 Misuro, peso... e calcolo (3) 746
n. 303 Durate brevi e lunghe 747
n. 304 Operazioni in tempo 748
n. 305 Le misure di tempo 749
n. 306 Calcolo il tempo 750
n. 307 Linea del tempo, calendario e orologio... alla mano (2) 751
n. 308 Pesi... trasparenti! (2) 752
n. 309 Rappresento l’istogramma 753
n. 310 Areogrammi circolari e quadrati 754
n. 311 Indagini e areogrammi 755
n. 312 Costruisco il diagramma cartesiano (1) 756
n. 313 Costruisco il diagramma cartesiano (2) 757
n. 314 Il piano cartesiano 758
n. 315 Misurare la circonferenza 759
n. 316 Disegno circonferenze 760
n. 317 Costruisco un poligono regolare 761
n. 318 Poligoni regolari e apotema 762
n. 319 L’ochetta in movimento 763
n. 320 Assi di simmetria 764
n. 321 Assi di simmetria verticali, orizzontali, obliqui 765
Scienze
n. 322 I fenomeni sonori 766
n. 323 Sperimento... i battiti del cuore! 767
n. 324 Funzioni e organi dell’apparato circolatorio
768
n. 325 Il sistema arterioso 769
n. 326 Il sistema venoso 770
n. 327 Conosci l’apparato circolatorio? 771
n. 328 Com’è fatto il sangue? 772
n. 329 Curo il mio apparato circolatorio! 773
n. 330 Funzioni e organi del sistema linfatico 774
n. 331 Funzioni e organi dell’apparato escretore 775
n. 332 La depurazione del sangue 776
n. 333 Com’è fatta la pelle? 777
n. 334 Curo la mia pelle 778
Musica
n. 335 Qui qualcuno è di troppo 779
Arte e immagine
n. 336 Enea, secondo me... 780
n. 337 Carnevale a Rio 781
n. 338 Baci d’artista 782
n. 339 Quanti caratteri! 783
n. 340 Uova in vetrina 785
n. 341 Rumori e suoni a fumetti 786
n. 342 La statua della libertà 788
n. 343 Le ville palladiane 789
Tecnologia
n. 344 Conosco la lavatrice
790
n. 345 Carte di tutti i tipi 791
n. 346 Tessuti naturali 792
n. 347 Fibre tessili intono a me 793
n. 348 Carnevale in maschera! 794
Italiano
n. 349 Un giorno a Pompei (2) 796
n. 350 Una famosa eruzione (2) 797
n. 351 Indagine e... tiramisù 798
n. 352 Tazio e Laika 800
n. 353 Il Parlamento dei bambini (2) 803
n. 354 Mi ricordo: il primo giorno della scuola primaria 804
n. 355 La lettera personale 805
n. 356 La lettera formale 806
n. 357 Vivere nell’antica Roma 807
n. 358 Giulietta e Romeo (2) 808
n. 359 Espressioni figurate (2) 809
n. 360 Le preposizioni semplici e articolate (2) 810
n. 361 Gli avverbi (2) 811
n. 362 La frase 813
n. 363 Frasi attive e passive 814
n. 364 Esercizi di riepilogo 817
Storia
n. 365 Gli archi di trionfo 820
n. 366 Gli acquedotti romani 821
n. 367 La Colonna Traiana 822
n. 368 Il Pàntheon 823
n. 369 Ottaviano Augusto e le monete 824
n. 370 L’Impero romano ai tempi di Augusto 825
n. 371 L’Impero romano in linea 826
n. 372 Le riforme di Ottaviano Augusto 827
n. 373 Caligola e Nerone: imperatori eccentrici 828
n. 374 Gli imperatori adottivi 829
n. 375 La dinastia dei Severi 830
n. 376 Diocleziano e la tetrarchia 831
n. 377 Costantino 832
n. 378 Le invasioni barbariche 833
n. 379 Teodosio e la divisione dell’Impero 834
n. 380 I Germani 835
n. 381 Gli Unni 836
n. 382 Il cristianesimo e l’impero 837
n. 383 Autobiografia di Augusto 838
n. 384 Germani e Unni a confronto 839
Geografia
n. 385 Le regioni dell’Italia meridionale 840
n. 386 La Campania. il territorio 841
n. 387 La Campania: la popolazione 842
n. 388 La Basilicata: la popolazione 843
n. 389 In giro per... Potenza 844
n. 390 La Puglia: il territorio 845
n. 391 In giro per... Bari 846
n. 392 La Calabria: la popolazione 847
n. 393 In giro per... Catanzaro 848
n. 394 La Sicilia: il territorio 849
n. 395 La Sicilia: la popolazione 850
n. 396 La Sardegna: il territorio 851
n. 397 In giro per... Cagliari 852
n. 398 Regioni, popolazione e numeri 853
n. 399 La Campania: vulcani, scavi e chiese 854
n. 400 La Calabria: pinete, mare e antichità 855
n. 401 La Sardegna: monumenti e animali tipici 856
n. 402 La Basilicata: l’economia 857
n. 403 La Puglia: l’economia 858
n. 404 La Sicilia: l’economia 859
n. 405 Regioni ed economia 860
Matematica
n. 406 Dalla percentuale alla frazione decimale 861
n. 407 Un po’ di sconti 862
n. 408 Calcolo l’interesse 863
n. 409 Dalla frazione non decimale alla percentuale 864
n. 410 Moltiplico e divido i numeri decimali per 10, per 100, per 1000 865
n. 411 Divisioni in colonna con i numeri decimali (2) 866
n. 412 Divisioni che continuano 867
n. 413 Le espressioni con le parentesi (1) 868
n. 414 Le espressioni con le parentesi (2) 869
n. 415 Eureka!.. ci siamo riusciti! (2) 870
n. 416 Eureka!.. ci siamo riusciti! (3) 871
n. 417 Percentuali... sotto osservazione (2) 872
n. 418 Dal problema... all’algoritmo (2) 873
n. 419 Dal problema... all’algoritmo (3) 874
n. 420 Dall’algoritmo... al problema (2) 875
n. 421 Dall’algoritmo... al problema (3) 876
n. 422 Dall’algoritmo... al problema (4) 877
n. 423 Dall’algoritmo... al problema (5) 878
n. 424 Le unità di misura di superficie (2) 879
n. 425 Opero con le misure di superficie 880
n. 426 Equivalenze con le misure di superficie 881
n. 427 L’area del rettangolo (2) 882
n. 428 L’area del quadrato (2) 883
n. 429 L’area del quadrato (3) 884
n. 430 L’area del romboide 885
n. 431 L’area del rombo 886
n. 432 L’area del trapezio 887
n. 433 L’area dei principali poligoni 888
n. 434 L’area di poligoni irregolari 889
n. 435 Scopri l’area di un... 890
n. 436 Ragionamenti e formule (2) 891
n. 437 Ragionamenti e formule (3) 892
n. 438 Figure ingrandite 893
n. 439 Figure rimpicciolite (1) 894
n. 440 Figure rimpicciolite (2) 895
n. 441 Riduzioni in scala 896
n. 442 Le caratteristiche dei solidi 897
n. 443 Lo sviluppo del parallelepipedo 898
n. 444 La superficie del parallelepipedo 899
n. 445 Calcolare i volumi 900
n. 446 Media e mediana 901
n. 447 Le parole magiche della probabilità 902
n. 448 La probabilità 903
n. 449 Calcolo di probabilità 904
Scienze
n. 450 I fenomeni luminosi 905
n. 451 La luce e i colori 906
n. 452 Sensibilità diverse 907
n. 453 La fecondazione: nasce una vita 908
n. 454 Il parto: ecco il bambino 909
n. 455 La vista e l’occhio 910
n. 456 L’udito e l’orecchio 911
n. 457 L’olfatto e il naso 912
n. 458 Il gusto e la lingua 913
n. 459 Il sistema nervoso 914
n. 460 Il tessuto nervoso 915
n. 461 L’encefalo 916
n. 462 Il cervello 917
n. 463 Il midollo spinale 918
Arte e immagine
n. 464 Un’artistica piazza 919
n. 465 L’aula di Montecitorio 920
n. 466 La casa romana 921
n. 467 Inquadrature 922
n. 468 Apollo e Dafne 923
n. 469 La moschea blu 924
n. 470 Il Colosseo dentro e fuori 925
Tecnologia
n. 471 Disegno e tecnica 927
n. 472 Televisione e televisore 928
n. 473 Una macchina per calcolare 929
n. 474 Un mondo di argilla 930
n. 475 Un disco di luce 931
n. 476 Telefoni in classe 932
Annuale
Educazione civica
n. 477 Lo Stato e la Repubblica 934
n. 478 Lo Stato e i suoi poteri 935
n. 479 La Costituzione italiana 936
n. 480 La Costituzione e i principi fondamentali 937
n. 481 Costituzione e libertà 940
n. 482 Uomo di colore
941
n. 483 Il Parlamento italiano 942
n. 484 Il presidente della Repubblica 943
n. 485 Il Governo della Repubblica 944
n. 486 L’Inno d’Italia 945
n. 487 La Regione 946
n. 488 Città metropolitane, Province e Comuni 947
n. 489 Bandiere e stemmi intorno a me! 948
n. 490 Il nonno a tavola 949
n. 491 Macedonia di amici 950
n. 492 Chi cerca forza per vivere è già forte 951
n. 493 Lettera al Sindaco 953
n. 494 Cattivissimo 954
n. 495 Segnali stradali intorno a me! 956
n. 496 Sono un buon ciclista 957
Verifica e Valutazione 959
1° QUADRIMESTRE
n. 1 Verifica di Italiano (1) 964
n. 2 Verifica di Italiano (2) 967
n. 3 Verifica di Italiano (3) 969
n. 4 Verifica di Storia 970
n. 5 Verifica di Geografia 973
n. 6 Verifica di Matematica 976
n. 7 Verifica di Scienze 983
n. 8 Verifica di Italiano (1) 986
n. 9 Verifica di Italiano (2) 989
n. 10 Verifica di Italiano (3) 992
n. 11 Verifica di Italiano (4) 993
n. 12 Verifica di Storia 994
n. 13 Verifica di Geografia 997
n. 14 Verifica di Matematica 1000
n. 15 Verifica di Scienze 1009
n. 1 J.A. Ingres, Ritratto della principessa de Broglie
n. 2 S. Botticelli, Nascita di Venere
n. 3 I Bronzi di Riace
n. 4 Il Partenone ieri
n. 5 Il Partenone oggi
n. 6 Il teatro di Taormina
n. 7 G. Morandi, Natura morta
n. 8 G. Arcimboldo, Il bibliotecario
n. 9 Il padiglione d’oro di Kyoto
n. 10 Tomba dei leopardi a Tarquinia
n. 11 Carnevale a Rio de Janeiro
n. 12 F. Hayez, Il bacio
n. 13 Il teatro Regio di Parma
n. 14 A. Canova, Amore a Psiche
n. 15 Statua della Libertà a New York
n. 16 La Rotonda in Veneto
n. 17 G. De Chirico, Piazza d’Italia
n. 18 Palazzo Montecitorio e Aula di Montecitorio
n. 19 G. Bernini, Apollo e Dafne
n. 20 La moschea blu di Istanbul
n. 21 Il Colosseo oggi
n. 22 Il Colosseo ieri
n. 23 Palazzo Madama
n. 24 Il Quirinale

La Guida Unica è stata impostata e redatta secondo le ultime Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, ponendo l’accento, in questa sua nuova edizione, sulla definizione degli obiettivi di apprendimento e sui traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave alla cui realizzazione, valutazione e certificazione è chiamata la scuola.
La Guida Unica rappresenta un prezioso strumento e offre un contributo operativo e metodologicodidattico di spessore, grazie alla concretezza e all’operatività della sua impostazione. Nella convinzione che una guida didattica debba sempre coniugare sapere, saper fare e saper far fare (elementi inseparabili per una corretta funzione docente), la Guida Unica offre un grande numero di piste di lavoro e di proposte didattiche, attraverso una serie di schede logicamente ed epistemologicamente coerenti con l’impianto programmatico e tra loro connesse da un sotteso filo inter e pluridisciplinare.
Le attività di apprendimento di tutte le discipline prevedono, accanto a un’educazione intellettiva in tutti i suoi aspetti (da quello linguistico-espressivo a quello percettivo-motorio; da quello logicomatematico a quello storico-geografico e scientifico), anche lo sviluppo di un percorso di educazione ai valori nell’ambito di un consapevole esercizio di una nuova cittadinanza attiva, in un’ottica interculturale e multietnica. Si tratta di un percorso trasversale che mira ad assicurare al nostro progetto la promozione di un’educazione integrale della personalità dell’alunno attraverso la conquista dell’autonomia, l’assunzione di responsabilità, la cultura dell’impegno personale e della solidarietà, lo sviluppo dell’identità e il rispetto della legalità, dell’ambiente e delle istituzioni.
Il quinto volume della Guida Unica si pone in linea di continuità con quelli precedenti. Tutte le discipline di studio, anche in questo volume, vengono, di conseguenza, impostate su:
◆ un solido impianto programmatico e curricolare;
◆ una ragionata selezione di contenuti e di attività capaci di stimolare e mantenere vivo il piacere dell’esplorazione e della scoperta;
◆ un percorso cognitivo che dal fare conduca l’alunno in modo progressivo e graduale a concettualizzazioni formalizzate e generative;
◆ un processo di costruzione del sapere centrato sulla sua unitarietà mediante un approccio interdisciplinare;
◆ una strategia metodologica e didattica che privilegi la sperimentazione, la ricerca-azione e la didattica laboratoriale;
◆ un costante abbinamento tra obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze elencati nelle Indicazioni e da realizzare al termine della Scuola Primaria. Tali traguardi, per comodità del docente, sono integralmente riportati in un apposito riquadro al termine delle Indicazioni metodologiche di ogni disciplina.
Il quinto volume della Guida Unica mantiene la stessa struttura degli altri volumi ma prevede per ciascuna disciplina, accanto a più impegnative proposte metodologiche, un potenziamento sia delle piste di lavoro sia dei suggerimenti operativi riservati ai docenti e un notevole arricchimento sia in termini quantitativi sia qualitativi delle schede di lavoro riservate agli alunni. Questi ampliamenti, approfondimenti e miglioramenti troveranno spazio, previ opportuni richiami, anche nel supporto elettronico allegato al volume.
Al termine di ogni quadrimestre è presentato un agile strumento di verifica/valutazione (presente nella Pen drive) corredato di proposte operative (quiz, questionari, brevi esercizi ecc.) che mirano a misurare i livelli di apprendimento di conoscenze, abilità e competenze raggiunti dagli alunni.
ITALIANO

Periodo: SETTEMBRE
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
T1
T2
T3
T3
T1
T6
T8
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente.
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche dei principali generi di narrazione.
• Produrre testi sostanzialmente corretti, legati a scopi concreti.
• Riconoscere le fondamentali convenzioni di scrittura e le principali parti del discorso.
• Le vacanze: – ascolto della lettura dell’insegnante;
completamento di testi; – espressione di stati d’animo e opinioni.
• La narrazione: – completamento di cloze con lista di parole; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• I generi della narrazione:
individuazione e riconoscimento delle caratteristiche fondamentali.
• I vissuti personali:
discussione guidata; – produzione di descrizioni e storie con il supporto di modelli guida.
• Le principali difficoltà ortografiche e le parti del discorso:
individuazione di errori ortografici; – riconoscimento e classificazione delle principali parti del discorso; – soluzione di giochi di parole.
ITALIANO Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità
Competenza chiave
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Ascolto e pArlAto
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
T2
T1
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente.
• I giochi matematici: – ascolto della lettura dell’insegnante; – memorizzazione delle informazioni; – completamento di testi con l’opzione giusta.
• L’horror e il rapporto con la TV: – questionari conoscitivi; – dibattiti in classe e confronto di idee ed esperienze.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Unità di
Mitici Greci!

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
letturA
T3
T4
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• I miti greci:
Contenuti e attività
esercizi di lettura del testo dal basso verso l’alto; – esposizione orale del contenuto del testo.
• Il racconto storico: – ricostruzione logica di una storia;
arricchimento lessicale; – distinzione vero/verosimile/fantastico; – soluzione di questionari a scelta multipla. T3 T4
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
• Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo.
• Il mito:
– completamento di testi con l’opzione giusta;
– esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di uno schema;
soluzione di un questionario con risposte a scelta multipla;
– individuazione delle informazioni vere/false che si possono ricavare dalla lettura del testo.
• La narrazione di paura:
– ascolto della lettura dell’insegnante;
lettura espressiva;
– esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di uno schema; – espressione degli stati d’animo provocati dalla lettura del testo;
– dibattito e confronto di opinioni; – individuazione degli elementi caratteristici del genere. T3
• Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto.
T3
• Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi.
• L’Odissea:
– individuazione di sequenze;
– esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di uno schema;
– soluzione di questionari con risposte a scelta multipla e a risposta aperta.
• Le istruzioni per regolare comportamenti: l’uso della televisione.
– Associazione di immagini al testo;
esposizione orale del contenuto del testo con il supporto delle immagini.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Mitici Greci!
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
T4
T3
T3
T9
• Leggere testi argomentativi, individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee.
• Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.
• Il teatro greco:
– individuazione di blocchi di informazioni;
– individuazione delle informazioni che si possono/ non si possono ricavare dal testo;
– esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di uno schema e delle immagini; – arricchimento lessicale.
• L’uso della televisione:
– individuazione della struttura del testo argomentativo;
– esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di uno schema;
– soluzione di questionari con risposte a scelta multipla.
• L’uso della televisione.
– Lettura espressiva;
– esposizione orale del contenuto del testo con domande guida;
– individuazione delle caratteristiche formali della poesia: le rime;
– arricchimento lessicale;
– soluzione di questionari a risposta aperta.
scritturA
• Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche.
• Il racconto del brivido: – lettura di poesie e/o racconti del brivido;
T3
T6
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
T6
– racconto orale di esperienze vissute;
– elaborazione del testo con il supporto di un modello guida.
• Il teatro greco: – osservazione di immagini; – descrizione orale;
– arricchimento lessicale;
– produzione del testo descrittivo con il supporto di un modello guida.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività scritturA
• Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività.
T6
T4
T6
• Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze personali.
• Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su argomenti di studio.
• Scrivere testi per argomentare.
T1
T6
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Le istruzioni per realizzare la lanterna di Halloween:
– realizzazione in classe della lanterna; – verbalizzazione delle fasi della realizzazione del manufatto;
– produzione del testo con il supporto delle immagini.
• La relazione sul programma televisivo preferito.
– La ricerca sulle Olimpiadi;
– ascolto, lettura di testi;
– elaborazione del testo con il supporto di un modello guida.
• Pregi e difetti della televisione:
– discussioni guidate e confronto di opinioni;
– arricchimento lessicale;
– elaborazione del testo con il supporto di un modello guida.
• Il logogrifo e l’anagramma:
– ascolto/lettura di poesie;
T2
T9
• Sperimentare tecniche per riassumere testi.
T6
T6
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi.
– esecuzione di giochi linguistici in classe, individuali/a squadre; – arricchimento lessicale.
• Le tecniche per riassumere il testo narrativo e il testo informativo:
– individuazione di sequenze e blocchi di informazioni;
– elaborazione del riassunto orale e poi scritto, con il supporto di modelli guida.
• La versione in prosa del testo poetico:
– elaborazione della parafrasi orale e poi scritta, con il supporto di domande guida.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Mitici Greci!
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
T8
• Utilizzare adeguatamente il dizionario. A • Osservazione e consultazione del dizionario: – l’ordine alfabetico delle parole.
• Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura. B
T8
T8
T8
• Riconoscere e rispettare le funzioni sintattiche ed espressive dei principali segni interpuntivi.
A B
• Riconoscere e utilizzare adeguatamente le tecniche del discorso diretto e indiretto. A B
ITALIANO
• Le principali convenzioni ortografiche: raddoppiamenti di consonante, digrammi, trigrammi e gruppi di lettere, la divisione in sillabe, uso dell’h, dell’apostrofo e dell’accento, il troncamento. – Esercizi di completamento, riordinamento, trascrizione, individuazione, correzione, classificazione, produzione, inserimento; – ascolto, lettura, copia, scrittura sotto dettatura, memorizzazione di filastrocche contenenti parole che presentano difficoltà ortografiche.
giochi linguistici.
• La funzione dei principali segni di punteggiatura: – esercizi di intonazione della voce;
esercizi di inserimento.
• Le tecniche per riportare le parole dei personaggi: – confronti, completamenti e trasformazioni dal discorso diretto all’indiretto e viceversa, prima oralmente, poi per iscritto.
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Ascolto e pArlAto T2
• Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione.
• I libri e il piacere della lettura: – ascolto della lettura dell’insegnante; – memorizzazione delle informazioni; – completamento di testi bucati senza alcun supporto.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Unità di lavoro

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
Ascolto e pArlAto
T2
T1
T1
T4
• Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per regolare comportamenti.
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente.
• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato.
• Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato.
• Acquisire il piacere di leggere.
T1
T2
T2
Contenuti e attività
• Il primo soccorso e il comportamento a teatro: – esposizione orale di regole di comportamento con il supporto delle immagini.
• I libri e il piacere della lettura: – questionari conoscitivi; – dibattiti in classe e confronto di idee ed esperienze.
• Le esperienze personali: – racconto orale di vissuti personali con il supporto di domande guida e schemi.
• Esposizione di argomenti di studio con il supporto di schemi, tabelle, grafici.
letturA
• Le preferenze di lettura: – lettura di testi;
– discussione guidata e confronto di opinioni;
– giochi linguisitici.
T6
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
• Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo.
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
• Il racconto umorisitico:
– lettura silenziosa/a voce alta di testi intrecciati;
– soluzione di questionari a risposta aperta;
– gare di lettura a cronometro.
• L’autobiografia:
– individuazione del finale giusto tra varie opzioni;
– soluzione di questionari a risposta aperta e a risposta multipla;
– trasformazione della persona e del tempo del testo;
– riassunto orale, guidato, del contenuto del testo.
• Il racconto fantasy:
– lettura espressiva del testo;
– individuazione del significato di termini non noti dal contesto;
– riassunto orale;
– arricchimento lessicale.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi.
• Le istruzioni per regolare comportamenti: il primo soccorso.
– Completamento del testo, individuazione di termini superflui;
T2
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
– esposizione orale del contenuto del testo;
associazione del testo alla corrispondente immagine;
– arricchimento lessicale.
• Il museo, la biblioteca: – completamento di schemi;
associazione dei blocchi di informazioni ai corrispondenti titoli;
– esposizione orale e riassunto del contenuto del testo, con il supporto di uno schema;
– arricchimento lessicale. T2
• Leggere testi argomentativi, individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee.
• Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.
• Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche.
• Libri di carta ed elettronici:
– individuazione della struttura del testo argomentativo; – completamento di mappe;
– discussione guidata e confronto di opinioni.
• Le figure di suono: – lettura espressiva del testo poetico; – individuazione di suoni e parole che si ripetono; – individuazione di termini non noti.
scritturA
• Il racconto autobiografico e il racconto di fantasia:
– lettura di autobiografie e racconti fantastici; – visione di film; – discussioni guidate e confronto di opinioni; – racconto orale di esperienze personali; – produzione di testi narrativi con il supporto di modelli guida.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Unità di lavoro

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
T6
• Scrivere testi regolativi.
T1
T6
• Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze.
T4
T6
T1
T6
T6
T9
• Scrivere testi per argomentare.
T6
T6
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi.
• La biblioteca:
– osservazione dell’immagine di una biblioteca; – descrizione orale con il supporto di domande stimolo;
– elaborazione del testo con il supporto di un modello guida;
– arricchimento lessicale.
• Le regole di comportamento in un museo:
– visita guidata in un museo; – discussione guidata sulle regole da rispettare in un museo;
– elaborazione del testo con il supporto di immagini.
• Il comune di appartenenza:
– ricerca di informazioni;
esposizione orale delle informazioni con il supporto di schemi, tabelle, grafici;
– produzione del testo con il supporto di schemi guida.
• Il Natale:
– discussione guidata e confronto di opinioni;
– produzione del testo con il supporto di un modello guida.
• Il Natale:
– lettura di poesie e imitazione delle tecniche usate; – giochi linguistici;
– arricchimento lessicale.
• Le tecniche per riassumere il testo narrativo e il testo informativo:
– individuazione di fasi e blocchi di informazioni; – elaborazione del riassunto con il supporto di modelli guida.
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi. – La versione in prosa del testo poetico.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
T7
T8
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole.
• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole.
T8
• Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
T8
• Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
• Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
T8
T8
• Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
• Campi semantici, sinonimi, omonimi e contrari: – giochi linguisitici, sostituzioni, trasformazioni, individuazione di elementi intrusi, arricchimento lessicale.
• Le parti variabili e invariabili del discorso, radici e desinenze, prefissi e suffissi: – completamenti, trasformazioni, classificazioni di parole, arricchimento lessicale;
esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
• Gli articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. Esercizi di:
– associazione, sostituzione, manipolazione, correzione, evidenziatura, riconoscimento;
– esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
• I nomi: significato, forme e struttura. Esercizi di:
– classificazione, completamento, correzione, trasformazione, composizione, arricchimento lessicale;
– esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
• Gli aggettivi qualificativi, i gradi dell’aggettivo, gli aggettivi numerali: forma, genere, numero, funzione, concordanza con il nome. Esercizi di: – completamento di poesie, frasi e tabelle, sostituzione, trasformazione e arricchimento lessicale;
– esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
• I pronomi personali e relativi. Esercizi di: – completamento di tabelle, riconoscimento, sostituzione;
– esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
• Distinguere gli aggettivi e i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
T8
Unità di lavoro
Competenza chiave
• Aggettivi e pronomi possessivi, indefiniti, dimostrativi, interrogativi ed esclamativi. Esercizi di: – completamento di tabelle, correzione, scelta di opzioni, trasformazione;
esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
ITALIANO Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Ascolto e pArlAto
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
T2
T4
T2
T1
T1
• Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per regolare comportamenti.
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente.
• Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato.
• La storia di Roma: – ascolto della lettura dell’insegnante; – memorizzazione delle informazioni e dell’ordine in cui sono fornite; – completamento di testi bucati.
• Il comportamento a teatro e il rapporto con gli animali. – esposizione orale di regole di comportamento con il supporto delle immagini.
• L’innamoramento e l’amicizia: – questionari conoscitivi; – dibattiti in classe e confronto di idee ed esperienze.
• Il racconto comico: – racconto orale di vissuti personali con il supporto di domande guida e schemi.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Unità di lavoro
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività letturA
• Acquisire il piacere di leggere.
T3
T1
T3
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• L’Eneide:
– ascolto della lettura a puntate, a voce alta dell’insegnante;
– discussioni, confronti, formulazione di ipotesi, invenzione di finali alternativi; – rappresentazioni grafiche.
• La poesia buffa e le barzellette:
– lettura silenziosa/a voce alta di testi mescolati a versi alterni;
– esposizione orale, guidata del contenuto dei testi.
• Il mito:
– completamento di testi bucati con il supporto di una lista di parole e un termine superfluo;
– completamento del testo con l’opzione giusta;
ricerca lessicale; – riassunto orale, guidata del contenuto del testo.
• Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi.
T6
T3
T9
T10
T6
T9
T3
T7
• Leggere testi letterari narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore.
• Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto.
• Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi.
• Il racconto comico:
– lettura espressiva del testo;
– associazione dei titoli alle corrispondenti sequenze;
– riordino di sequenze; – riassunto orale e scritto;
– ricerca lessicale.
• L’Eneide: Eurialo e Niso.
– Lettura attiva del testo;
– formulazione di ipotesi, anticipazioni, previsioni; – riassunto orale.
• Il testo teatrale in rima: – esercizi di pronuncia di battute; – lettura espressiva a più voci del testo; – individuazione delle caratteristiche fisiche, caratteriali e comportamentali dei personaggi; – parafrasi orale e scritta.
• Le regole di comportamento a teatro: – associazione del testo alla corrispondente immagine; – esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di immagini;
– ricerca lessicale.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
T3
T8
T9
• Leggere testi argomentativi usando strategie per analizzare il contenuto.
• Civiltà romana: l’abbigliamento.
Associazione di informazioni alle corrispondenti immagini;
– esposizione orale e riassunto del contenuto del testo con il supporto di uno schema; – ricerca lessicale.
• Il rapporto con gli animali:
– lettura attiva del testo;
formulazione di ipotesi, anticipazioni, previsioni; – individuazione della struttura del testo argomentativo;
esposizione orale del contenuto del testo;
– soluzione di questionari a risposta aperta;
– discussione guidata e confronto di opinioni.
T6 T7
• Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.
• Le figure di suono: allitterazioni e onomatopee.
– Lettura espressiva del testo poetico;
– completamento di poesie con le onomatopee adatte;
– individuazione di suoni e parole che si ripetono;
– individuazione di termini non noti;
– ricerca lessicale.
• Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche.
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
• Il racconto comico:
– lettura di racconti comici;
– visione di film;
– discussioni guidate e confronto di opinioni; – racconto orale di esperienze personali; – produzione di testi narrativi con il supporto di modelli guida.
• Il teatro moderno e il migliore amico.
– Osservazione dell’immagine di un teatro; – descrizione orale con il supporto di domande stimolo;
– elaborazione del testo con il supporto di un modello guida; – ricerca lessicale.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Unità di lavoro
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Scrivere testi per regolare comportamenti.
T6
• Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze e argomenti di studio.
T4
T6
T9
• Scrivere testi per argomentare.
T1
T6
T2
T6
T7
T6
T6 T7
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi.
• I comportamenti corretti verso gli animali: – discussione guidata sul comportamento da assumere con gli animali; – elaborazione del testo con il supporto di immagini.
• La relazione su uno spettacolo teatrale: – visita a un teatro per assistere a una rappresentazione; – esposizione orale dell’esperienza vissuta con il supporto di uno schema guida; – ricerca lessicale; – produzione del testo con il supporto di schemi guida.
• Gli animali in casa:
discussione guidata e confronto di opinioni; – produzione del testo con il supporto di un modello guida.
• Le onomatopee: – lettura di poesie e imitazione delle tecniche usate; – giochi linguistici; – ricerca lessicale.
• Le tecniche per riassumere il testo: – individuazione di sequenze; – elaborazione del riassunto con il supporto di modelli guida.
T8 T9
T8
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi.
• La versione in prosa del testo teatrale in rima.
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
• Riconoscere la variabilità della lingua nello spazio geografico.
• Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
• Confronto di termini ed espressioni dialettali.
• Struttura del verbo: persona, numero, modi e tempi, coniugazioni, genere, forme. Esercizi di: – classificazione, completamento di frasi, testi e tabelle, correzione, scelta di opzioni giuste, trasformazione, ricerca lessicale, analisi grammaticale; – esposizione orale di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Ascolto e pArlAto
T2
T4
T1
T3
T4
T3
T4
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente.
• La Via Lattea: – ascolto della lettura dell’insegnante; – memorizzazione delle informazioni; – individuazione di informazioni intruse.
• La scuola primaria e la scuola secondaria: – questionari conoscitivi; – dibattiti in classe e confronto di idee ed esperienze. letturA
T3
T7
• Acquisire il piacere di leggere.
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
• Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo.
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca.
T3
• Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto.
T3
T6
T3
T4
• Leggere testi narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore.
• La storia di Roma antica: – associazione di informazioni alle corrispondenti immagini.
• La storia di Roma antica:
– lettura silenziosa/a voce alta di testi scritti con diversi caratteri e modalità;
soluzione di questionari con risposte a scelta multipla;
– esposizione orale del contenuto.
• Il racconto poliziesco:
– individuazione degli elementi caratteristici del genere;
– soluzione di questionari a risposta aperta;
– esposizione orale del contenuto;
– ricerca lessicale.
• L’articolo di cronaca: – individuazione degli elementi caratteristici del genere;
– soluzione di questionari a risposta aperta/a scelta multipla;
– esposizione orale del contenuto.
• Romeo e Giulietta di W. Shakespeare:
– individuazione dell’inizio giusto tra varie opzioni;
– ordinamento di sequenze; – esposizione orale del contenuto;
– riassunto guidato, orale e scritto.
• Il racconto umoristico:
formulazione di ipotesi, anticipazioni, previsioni; – soluzione di questionari con risposte chiuse/a scelta multipla.
esposizione orale del contenuto.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi.
T3
T3
T7
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere testi argomentativi individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee.
T4
T6
T5
T8
T6
T6
• Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.
• Le regole di comportamento in internet:
– completamento di un testo bucato con parole scelte tra varie opzioni;
– soluzione di quesiti con risposta a scelta multipla;
– ricerca lessicale.
• Il Parlamento italiano:
– soluzione di questionari con risposte a scelta multipla;
– esposizione orale del contenuto con il supporto di uno schema;
– ricerca lessicale.
• Gli animali:
– formulazione di ipotesi, anticipazioni, previsioni;
– individuazione della struttura del testo argomentativo;
– soluzione di questionari a risposta aperta;
– esposizione orale del contenuto;
– riassunto guidato, orale e scritto;
– discussione guidata e confronto di opinioni.
• Le figure di significato: similitudini e metafore.
– Lettura espressiva del testo poetico;
– individuazione di similitudini e metafore;
– ricerca lessicale.
scritturA
• Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche.
• Scrivere lettere adeguando le forme espressive ai destinatari e alle situazioni.
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
• Il diario, il racconto autobiografico: la scuola primaria.
– Racconto orale di esperienze personali;
– discussioni guidate e confronto di opinioni;
– produzione di testi narrativi con il supporto di modelli guida.
• La lettera personale e la lettera formale: – elaborazione guidata con il supporto di modelli guida.
• La descrizione di un ambiente noto: il mercato. – Osservazione dal vero; – descrizione orale con il supporto di domande stimolo; – individuazione dei dati sensoriali; – elaborazione del testo con il supporto di un modello guida;
– arricchimento lessicale.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Scrivere testi per regolare comportamenti.
T6
T1
T4
T6
T6
T9
T6
T6
• Scrivere testi per argomentare.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi.
• I comportamenti corretti durante un terremoto:
– discussione guidata; – elaborazione del testo con il supporto di immagini.
• La storia di Roma antica:
– discussione guidata e confronto di opinioni; – produzione del testo con il supporto di un modello guida.
• I dati sensoriali:
– lettura di poesie e imitazione delle tecniche usate; – ricerca lessicale.
• Le tecniche per riassumere il testo narrativo e quello argomentativo:
– individuazione di sequenze e argomentazioni;
– elaborazione del riassunto orale e scritto con il supporto di modelli guida.
T8
T9
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi.
• La versione in prosa del testo poetico.
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole.
• Riconoscere le parti invariabili del discorso, conoscerne i tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente.
T8
T8
T10
• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase.
• Il significato letterale e il significato figurato delle parole:
– associazioni di frasi alle corrispondenti immagini; – completamento di frasi.
• Preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni. Esercizi di:
– completamento di frasi e testi, individuazione e scelta di opzioni esatte/errate;
– esposizione orale di regole grammaticali con il supporto di tabelle; – ricerca e arricchimento lessicale.
• Frase semplice e frase complessa, i sintagmi, il soggetto, il predicato verbale e nominale, i complementi:
– completamento di frasi, individuazione di frasi semplici e frasi complesse, delle caratteristiche del soggetto, dei sintagmi, delle funzioni del verbo essere.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
T2 T5
T2
T8
T3
T7
T5 T9
T9
• Conoscere le fonti della Storia.
• Ricavare e produrre informazioni da fonti di diverso tipo.
• Esporre conoscenze utilizzando il linguaggio specifico della Storia.
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico.
• Usare una carta geo-storica.
• Conoscere la struttura di un quadro storico di civiltà.
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate.
chiave
• Classificazione delle diverse tipologie di fonti storiche: materiali, iconografiche, orali e scritte.
• Produzione di informazioni storiche attraverso l’analisi di fonti di diverso tipo.
• Completamento di frasi sugli specialisti delle scienze ausiliarie della Storia.
• Collocazione di eventi in ordine cronologico.
• Esercitazioni sulla linea del tempo.
• Individuazione di luoghi in una carta geo-storica.
• Riflessione sulla connessione tra territorio ed economia.
• Definizione di civiltà e di quadro storico di civiltà.
• Descrizione degli indicatori tematici di civiltà.
• Osservazione e descrizione di immagini delle civiltà fluviali e delle civiltà che si svilupparono lungo le coste del Mar Mediterraneo.
STORIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Mitici Greci!
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività uso delle fonti
T2
T2
T2
T2
T7 T9
T10
T3
• Produrre informazioni da manufatti greci.
• Produrre informazioni da antiche monete greche.
• Produrre informazioni dall’Olpe Chigi.
• Produrre informazioni dai Bronzi di Riace.
• Osservazione di vasi greci e riconoscimento dei tipi di pittura: “a figura rossa “ e “a figura nera”.
• Osservazione e colorazione di vari tipi di vasi greci.
• Osservazione e descrizione di monete dell’antica Grecia: i simboli e le città.
• Osservazione e descrizione dell’Olpe Chigi: la falange oplitica.
• Osservazione e descrizione dei Bronzi Di Riace: due raffinate statue di guerrieri.
orgAnizzAzione delle informAzioni
• Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà greca.
• Usare cronologie per rappresentare la storia greca.
• Osservazione e descrizione della carta geo-storica della Grecia.
• Collocazione sulla linea del tempo dei periodi della storia greca: l’età oscura, l’età arcaica, l’età classica e l’età ellenistica.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
strumenti concettuAli
• Conoscere la nascita della civiltà dei Greci.
T7
T6 T9
T6 T9
T7 T9
T7 T9
T6 T9
T6 T9
T6 T9
T6 T9
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: l’età oscura.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la nascita delle póleis.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la grande colonizzazione.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: le guerre persiane.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la guerra del Peloponneso.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: l’età ellenistica.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Greci.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale e politica di Sparta.
• Conoscere ed analizzare l’organizzazione sociale e politica di Atene.
T6 T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Greci.
T6 T9
T6 T9
T6 T9
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Greci.
• Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Greci.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Osservazione di una carta geo-storica della Grecia antica e completamento di testi sull’Ellade e gli Elleni.
• Individuazione degli effetti del periodo denominato “Medioevo ellenico”.
• Completamento di testi sulle caratteristiche dell’età arcaica e la nascita delle póleis.
• Uso di carte geo-storiche e completamento di testi sulla grande colonizzazione greca; completamento di un dialogo sui riti di fondazione di una colonia.
• Uso di carte geo-storiche, collocazione di sequenze in ordine cronologico e completamento di testi sulle guerre contro i Persiani.
• Titolazione e collocazione geografica delle tre fasi della guerra del Peloponneso.
• Lettura e completamento di un testo sull’età ellenistica.
• Lettura e completamento di un testo sulla struttura della pólis.
• Analisi delle diverse forme di governo delle póleis greche.
• Lettura e completamento di un testo sull’organizzazione sociale di Sparta.
• Osservazione e completamento di uno schema sull’organizzazione politica di Sparta.
• Lettura e completamento di testi e illustrazioni sull’organizzazione sociale e politica di Atene nel periodo della monarchia e dell’oligarchia.
• Lettura di testi sulle riforme democratiche di Solone e di Clistene.
• Descrizione dei compiti delle istituzioni democratiche di Atene.
• Descrizione e completamento di un’illustrazione di un oplita.
• Lettura di un testo dello storico Plutarco.
• Osservazione e completamento di un’illustrazione della trireme.
• Osservazione e descrizione delle principali divinità greche.
• Lettura e completamento di testi sugli eroi greci.
• Osservazione e completamento di un’illustrazione del tempio greco.
• Individuazione in illustrazioni delle diverse gare praticate durante le Olimpiadi.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

STORIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
T6 T9
T6 T9
T6 T9
• Conoscere le principali attività economiche dei Greci.
• Lettura e completamento di testi sulle attività economiche dei Greci.
• Completamento di testi cloze e di illustrazioni sulla diffusione della moneta e la coniazione.
T6 T9
• Conoscere il sistema di scrittura dei Greci.
• Conoscere le principali innovazioni culturali dei Greci.
• Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Greci.
• Lettura e completamento di un testo sull’origine e le caratteristiche dell’alfabeto greco.
• Lettura delle lettere dell’alfabeto greco e traduzione dei nomi delle principali divinità.
• Lettura di testi e osservazione di immagini su Talete e la filosofia, Erodoto e la storiografia, Pitagora e la geometria e Ippocrate e la medicina.
• Completamento di un testo sulla funzione delle più note invenzioni di Archimede di Siracusa.
• Lettura e individuazione in testi delle diverse fasi dell’educazione a Sparta e Atene.
• Lettura di testi sulla condizione della donna a Sparta e Atene e questionario vero/falso.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione sull’abbigliamento e le calzature dei Greci.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sull’alimentazione dei Greci.
• Osservazione e descrizione di un affresco raffigurante un simposio.
• Completamento di testi e illustrazioni sulle abitazioni dei Greci.
T9
T6 T9
T9
T8
• Conoscere la funzione e la struttura del teatro presso i Greci.
• Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Macedoni.
• Osservazione, descrizione e completamento di un’illustrazione del teatro greco.
• Lettura e completamento di testi sui Macedoni e Filippo II.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione della falange macedone.
• Questionario vero/falso sulla figura, le imprese e la politica di Alessandro Magno.
• Lettura, completamento di testi e osservazione di una carta geo-storica dei regni ellenistici.
produzione scrittA e orAle
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà greca del passato con quella attuale.
• Elaborare oralmente e per iscritto quadri storici della civiltà greca.
• La Grecia oggi: osservazione e lettura di una carta geografica; lettura e completamento di testi; riproduzione e descrizione della bandiera.
• Completamento di tabelle e risposte a domanda aperta sulle póleis Sparta e Atene e di un cruciverba storico sulla civiltà greca.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
uso delle fonti
T2 T10
• Produrre informazioni da costruzioni della civiltà nuragica.
• Osservazione di immagini e individuazione in un testo delle diverse funzioni del nuraghe.
• Osservazione e descrizione della fortezza di Barùmini.
T8 T9
T6 T9
T10
T2 T6 T10
T2 T6 T10
T7 T9 T10
T7
• Produrre informazioni del Guerriero di Capestrano.
• Produrre informazioni dal Disco di Magliano.
• Produrre informazioni dal Sarcofago degli Sposi.
• Rappresentare informazioni che scaturiscono da tracce etrusche presenti sul territorio vissuto.
• Osservazione, completamento di didascalie e descrizione della statua del Guerriero di Capestrano.
• Osservazione e completamento di un testo sul Disco di Magliano.
• Lettura, riconoscimento e scrittura delle lettere dell’alfabeto etrusco.
• Osservazione, descrizione e questionario vero/ falso sul Sarcofago degli Sposi della necropoli di Cerveteri.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sulla condizione sociale della donna etrusca.
• Lettura e completamento di un testo sull’arco etrusco.
• Osservazione e descrizione di immagini di archi etruschi nel territorio italiano.
orgAnizzAzione delle informAzioni
• Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppano le civiltà italiche.
• Osservazione e descrizione della carta geo-storica dell’Italia: crocevia tra Oriente e Occidente.
• Completamento di frasi sui fattori che favoriscono l’insediamento nella penisola italica.
• Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà etrusca.
• Uso di una carta geo-storica dell’Etruria.
• Completamento di frasi sulle caratteristiche ambientali ed economiche del territorio in cui si sviluppa la civiltà etrusca.
T3
T6 T9
T10
T6 T9
T10
• Usare cronologie per rappresentare la storia dei popoli italici.
• Collocazione sulla linea del tempo dei periodi di insediamento in Italia dell’Homo erectus e dell’Homo sapiens.
• Colorazione di una carta geo-storica per evidenziare i diversi periodi di insediamento dei popoli italici. strumenti concettuAli
• Conoscere le civiltà palafitticola e terramaricola.
• Conoscere i principali popoli italici.
• Lettura e completamento di testi e domande sulla civiltà palafitticola e sulla civiltà terramaricola in Italia.
• Osservazione di e colorazione di una carta geostorica dell’Italia preromana.
• Lettura di una tabella con le caratteristiche dei popoli italici.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Unità di lavoro traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
T6 T9 T10
T2 T9
T10
T2 T9 T10
T2 T9 T10
T6 T9
T7 T9 T10
T6 T9 T10
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
• Conoscere la civiltà dei Camuni.
• Conoscere la civiltà dei Liguri.
• Conoscere la civiltà dei Sardi.
• Conoscere la civiltà dei Villanoviani.
• Conoscere la civiltà dei Celti.
T6 T7
T9 T10
• Conoscere le colonie fenicie in Italia.
• Conoscere le colonie greche in Italia.
• Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Etruschi.
• Lettura della carta d’identità del popolo dei Camuni e completamento di un testo.
• Osservazione e descrizione di incisioni rupestri.
• Lettura della carta d’identità del popolo dei Liguri e completamento di un testo.
• Osservazione e descrizione delle statue stele della Lunigiana.
• Lettura della carta d’identità del popolo dei Sardi e completamento di un testo.
• Osservazione e descrizione dei “bronzetti nuragici”.
• Lettura della carta d’identità del popolo dei Villanoviani e completamento di un testo.
• Osservazione e descrizione di reperti archeologici: l’askòs e la tomba di Badia.
• Lettura della carta d’identità del popolo dei Celti e completamento di un testo.
• Lettura di un brano del “De Bello Gallico” di Gaio Giulio Cesare.
• Osservazione di una carta geo-storica e completamento di un testo sulla colonizzazione fenicia in Italia.
• Lettura di un testo sulle caratteristiche della colonizzazione greca in Italia e individuazione in una carta geografica delle colonie greche in Italia.
• Confronto tra un testo dello storico Erodoto e uno dello storico Dionigi da Alicarnasso sull’origine della civiltà etrusca.
• Osservazione di una carta geo-storica dell’Etruria e individuazione delle principali città fondate dagli Etruschi nella loro espansione territoriale.
• Ricostruzione in ordine cronologico delle fasi del declino della civiltà etrusca.
T6 T9 T10
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Etruschi.
• Lettura e completamento di un testo sull’organizzazione politica degli Etruschi.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sulla figura del lucumone e i simboli del suo potere.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Unità di lavoro
Competenza chiave

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
strumenti concettuAli
T9 T10
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Etruschi.
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità degli Etruschi.
T9 T10
T2 T9 T10
T2 T9 T10
T6 T9 T10
T2 T9 T10
T6 T9
T10
• Conoscere e analizzare la funzione e la struttura del tempio presso gli Etruschi.
• Conoscere e analizzare la funzione e la struttura delle necropoli degli Etruschi.
• Conoscere le principali attività economiche degli Etruschi.
• Conoscere il sistema di scrittura degli Etruschi.
• Conoscere gli aspetti della vita quotidiana degli Etruschi.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di frasi descrittive delle classi sociali etrusche.
• Completamento di testi sulla religione degli Etruschi.
• Osservazione e descrizione di illustrazioni di un augure e di un aruspice.
• Osservazione, descrizione e completamento di un’illustrazione del tempio etrusco.
• Lettura e completamento di un testo sulle necropoli etrusche.
• Osservazione e abbinamento di illustrazioni e didascalie dei diversi tipi di tombe etrusche.
• Lettura e completamento di testi sulle attività economiche degli Etruschi.
• Completamento di un testo sulla tipica ceramica etrusca.
• Lettura e completamento di un testo sull’origine e le caratteristiche dell’alfabeto etrusco.
• Individuare le informazioni ricavabili dalle “Lamine di Pyrgi”.
• Lettura di un testo e completamento di un’illustrazione della casa etrusca.
• Lettura di un testo e completamento di domande a risposta aperta della sull’alimentazione etrusca.
• Osservazione e descrizione di illustrazioni dell’abbigliamento etrusco. produzione scrittA e orAle
T9
T2 T10
T2 T10
T9
• Produrre informazioni da reperti della civiltà celtica.
• Produrre informazioni da opere architettoniche delle colonie greche in Italia.
• Produrre informazioni da reperti della civiltà etrusca.
• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: i popoli italici.
• Osservazione e descrizione di oggetti della civiltà celtica.
• Osservazione, descrizione e ricerca di informazioni su opere architettoniche delle colonie greche in Italia.
• Osservazione, descrizione e ricerca di informazioni su reperti della civiltà etrusca.
• Completamento cruciverba e crucipuzzle storici sui popoli italici.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
uso delle fonti
• Produrre informazioni dalla Lupa Capitolina.
T2
T7
T10
T3
T7
T10
T6
T10
• Osservazione e descrizione della Lupa Capitolina e redazione di un testo sulla leggenda ricordata dalla scultura.
orgAnizzAzione delle informAzioni
• Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà romana.
• Osservazione e descrizione della carta geografica del territorio in cui sorge Roma.
• Lettura e completamento di testi sulla posizione geografica privilegiata di Roma per i commerci.
• Usare cronologie per rappresentare la storia romana.
• Collocazione sulla linea del tempo dei periodi della storia romana.
strumenti concettuAli
• Conoscere la nascita della civiltà dei Romani.
• Conoscere l’origine mitologica della civiltà dei Romani.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età monarchica.
• Osservazione di una carta geo-storica di Roma antica.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sulla storia della fondazione di Roma.
• Lettura di un testo e collocazione in ordine cronologico di sequenze sull’origine mitologica della civiltà romana.
• Lettura di un testo sulla fondazione di Roma come narrata dallo storico Tito Livio nella raccolta Ab Urbe Condita e completamento di domande a risposta chiusa.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di didascalie sui sette re di Roma.
T6
T9
T10
T3
T9
T10
T3
T6
T9
T10
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età repubblicana.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la conquista dell’Italia.
• Lettura di un testo sul “ratto delle Sabine” come narrato dallo storico Tito Livio nella raccolta Ab Urbe Condita e domande a risposta aperta.
• Lettura e completamento di testi, questionari e domande a risposta aperta sui re di Roma.
• Lettura e completamento di un testo sulla nascita della repubblica a Roma.
• Collocazione sulla linea del tempo dei principali eventi della storia di Roma nell’età repubblicana.
• Collocazione in ordine cronologico dei principali eventi della conquista dell’Italia da parte dei Romani.
• Osservazione e colorazione di una carta geo-storica dell’espansione di Roma in Italia.
• Lettura e completamento di testi sulle principali sconfitte e vittorie dei Romani nell’espansione in Italia: la battaglia delle Forche Caudine contro i Sanniti e la battaglia di Maleventum contro Pirro.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Competenza chiave
Unità di lavoro traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
T9
T10
T6
T9
T10
T6
T9
T10

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le guerre puniche.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le riforme dei Gracchi.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le guerre civili.
• Letture, questionari, completamento di testi sulle guerre puniche.
• Osservazione e colorazione di una carta geo-storica dell’espansione di Roma nel Mar Mediterraneo.
• Lettura e completamento di testi sulle riforme sociali dei Gracchi.
• Conversazione sulla c.d. “guerra sociale” e l’attribuzione della cittadinanza romana ai popoli italici.
• Lettura e completamento di testi sull’ascesa di Gaio Mario e la riforma dell’esercito.
• Lettura, completamento di testi e domande a risposta aperta sull’inizio della guerra civile a Roma: il conflitto tra Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla e le “tavole della proscrizione”.
• Lettura di un testo e abbinamento di domande e risposte sulla rivolta di Spartaco.
T9
T10
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: Gaio Giulio Cesare.
• Abbinamento di immagini e didascalie sui tre triumviri.
• Osservazione e colorazione di una carta geo-storica della conquista della Gallia da parte di Cesare e lettura e completamento di frasi e testi.
• Lettura di fumetti e completamento di testi sulla guerra civile tra Pompeo e Cesare.
• Lettura e completamento di testi e frasi su Cesare padrone assoluto di Roma.
• Lettura e completamento di testi e frasi sulla congiura contro Cesare e il suo assassinio.
T6
T9
T10
T6
T9
T10
T9
T10
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la fine dell’età repubblicana.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Romani nell’età monarchica.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Romani nell’età repubblicana.
• Lettura e completamento di testi e frasi sul secondo triumvirato.
• Lettura e individuazione di frasi vere in coppie di frasi sulla guerra tra Antonio e Ottaviano.
• Lettura e completamento di un testo sull’organizzazione politica di Roma nell’età monarchica.
• Lettura e completamento di testi e frasi sulla riforma di Servio Tullio.
• Lettura di uno schema, completamento di frasi e questionario vero/falso sulla struttura dell’organizzazione di Roma nell’età repubblicana.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie sulle magistrature della Roma repubblicana e le loro funzioni.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Unità di lavoro
Competenza chiave
STORIA Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
strumenti concettuAli
T6 T9
T10
T6 T9
T10
T9 T10
T9 T10
T9 T10
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei territori conquistati dai Romani.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: la flotta.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Romani nell’età monarchica.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Romani nell’età repubblicana.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione della famiglia romana.
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Romani.
T6 T9 T10
T6 T9
T10
T6 T9
T6 T9
T10
• Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: le abitazioni.
• Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’alimentazione.
• Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’abbigliamento.
• Lettura e completamento di testi sull’organizzazione politica dei territori conquistati dai Romani: colonie romane, colonie latine, municipi, città federate e province.
• Completamento con didascalie di un’illustrazione di una nave romana.
• Lettura e completamento di un testo sulle caratteristiche della flotta romana.
• Lettura e abbinamento di didascalie a illustrazioni delle classi sociali a Roma nell’età monarchica e repubblicana.
• Lettura e completamento di un testo sulla secessione della plebe del 494 a.C.
• Completamento di didascalie sulle principali conquiste normative della plebe.
• Associazione di domande e risposte in un testo sulla struttura della famiglia romana e il ruolo del pater familias
• Osservazione di illustrazioni, lettura e completamento di didascalie sul pàntheon romano.
• Lettura e completamento di testi sul culto pubblico e i collegi sacerdotali.
• Associazione di domande e risposte in un testo sul culto domestico presieduto dal pater familias.
• Lettura di una descrizione della domus romana e completamento di un’illustrazione.
• Lettura e completamento di testi sull’ insula romana.
• Lettura e completamento di una tabella sui cibi dei tre pasti principali dei Romani più ricchi.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di didascalie dei principali abiti maschili e femminili dei Romani.
• Lettura di didascalie e colorazione di illustrazioni di diversi tipi di toghe.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
produzione scrittA e orAle
T8
T8
• Elaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati: la Roma dei re.
• Elaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati: la Roma repubblicana.
Unità di
• Completamento di cruciverba e crucipuzzle sull’età monarchica e sulla leggenda della fondazione di Roma.
• Completamento di identikit sui principali personaggi della Roma repubblicana.
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95) Competenza chiave
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività uso delle fonti
T2
T2
T2
T2
T2
T9 T10
T7
T3
• Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli archi di trionfo.
• Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli acquedotti.
• Produrre informazioni dall’Ara Pacis.
• Produrre informazioni dalla Colonna Traiana.
• Produrre informazioni dal Pàntheon.
• Produrre informazioni da antiche monete romane.
• Lettura di descrizioni e completamento di didascalie di immagini di archi di trionfo.
• Lettura di un testo e abbinamento di domande e risposte sugli acquedotti romani.
• Osservazione e descrizione di Port du Gard.
• Osservazione di immagini dell’Ara Pacis, lettura e completamento di testi.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sulla Colonna Traiana.
• Osservazione di immagini e lettura e completamento di un testo sul Pàntheon.
• Osservazione di immagini di monete dell’epoca di Ottaviano Augusto e completamento di testi. orgAnizzAzione delle informAzioni
• Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa l’Impero romano.
• Usare cronologie per rappresentare la storia dell’Impero romano.
• Indicazione della data dei principali eventi della storia dell’Impero romano e colorazione di una linea del tempo. STORIA Periodo: APRILE-MAGGIO
• Osservazione e colorazione di una carta geo-storica dell’Impero romano ai tempi di Augusto.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
T6 T9
T10
T9
T10
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: il principato di Augusto.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età imperiale.
T9
T10
T6 T9
T10
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la decadenza dell’Impero.
• Lettura e completamento di testi e di frasi su Ottaviano Augusto e il suo principato.
• Lettura e completamento di testi e di frasi sulle riforme politiche e sociali di Ottaviano Augusto.
• Lettura di una linea del tempo e completamento di frasi sugli imperatori della dinastia Giulio-Claudia.
• Lettura di un testo su Caligola e abbinamento di domande e risposte.
• Lettura e completamento di un testo su Nerone.
• Lettura e completamento di frasi sugli imperatori della dinastia Flavia.
• Lettura e completamento di testi e frasi sugli imperatori adottivi.
• Lettura e completamento di un testo sugli imperatori Traiano e Adriano.
• Lettura e completamento di frasi sugli imperatori della dinastia dei Severi.
• Lettura e completamento di testi e frasi e questionario vero/falso sugli imperatori illirici, Diocleziano e la tetrarchia.
• Lettura, completamento di testi e domande a risposta multipla su Costantino e l’Editto di Tolleranza.
T6 T9
T10
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la divisione e la fine dell’Impero.
• Conoscere e analizzare la nascita e lo sviluppo del cristianesimo.
• Lettura di testi e completamento di domande a risposta aperta sull’invasione dei Goti.
• Uso di una carta geo-storica, lettura e completamento di testi e di frasi su Teodosio e la divisione dell’Impero.
• Abbinamento di eventi e date e completamento di un testo sulla fine dell’Impero romano d’Occidente.
• Lettura e completamento di testi, di frasi e di didascalie sui Germani.
• Questionario vero/falso sugli Unni e completamento di un testo su Attila.
• Colorazione di frasi vere e completamento di un testo su Gesù di Nazaret.
• Completamento di un testo sugli apostoli Pietro e Paolo e domande a risposta multipla sui rapporti tra il cristianesimo e l’Impero.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Unità di lavoro
Competenza chiave

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
strumenti concettuAli
• Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: l’esercito.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sulla struttura della legione romana.
T9
T10
T2 T10
T2
T10
T2 T10
T6 T8
T8
• Conoscere la funzione e la struttura dell’anfiteatro presso i Romani.
• Conoscere la funzione e la struttura del circo presso i Romani.
• Conoscere la funzione e la struttura delle terme presso i Romani.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di una tabella sull’uniforme del legionario romano.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sul castrum.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di didascalie sull’anfiteatro dei Romani.
• Lettura di descrizioni e completamento di illustrazioni dei diversi tipi di gladiatori.
• Lettura e completamento di un testo sui ludi circenses.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di didascalie sul Circo Massimo.
• Abbinamento di descrizioni a nomi degli ambienti delle terme e completamento di un’illustrazione.
produzione scrittA e orAle
• Produrre informazioni da testi storici.
• Elaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati: l’Impero romano.
• Lettura e riflessione su un adattamento del I Capitolo delle Res Gestae divi Augusti.
• Lettura e confronto di testi storici di Tacito e di Ammiano Marcellino.
• Risoluzione di un crucipuzzle sugli imperatori romani.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Unità di lavoro
Competenza chiave
GEOGRAFIA Periodo: SETTEMBRE
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
T3
T7
T2
T2
T4
T5
T3
• Conoscere e utilizzare il metodo di lavoro del geografo.
• Conoscere e utilizzare gli strumenti di lavoro del geografo.
• Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
• Riconoscere e analizzare i principali caratteri fisici di un territorio.
• Conoscere gli elementi caratteristici dei principali paesaggi geografici.
• Ricavare informazioni geografiche da tabelle e grafici.
• Il metodo di lavoro del geografo e le sue fasi.
• Osservazione e descrizione di elementi geografici fisici, naturali e antropici.
• Osservazione e descrizione di carte geografiche di vario tipo.
• I punti cardinali e i punti intermedi.
• Lettura e completamento di carte.
• Osservazione, denominazione e descrizione di immagini con elementi fisici: mare, fiume, lago, montagna, collina e pianura.
• Illustrazione e descrizione degli aspetti caratterizzanti paesaggi montani, fluviali e marini.
• Lettura di un istogramma su dati dell’economia italiana e di areogrammi sui rilievi d’Italia.
GEOGRAFIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Mitici Greci!
Competenza chiave
Unità di lavoro traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività orientAmento
T2
T2
T3
T2
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
• Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
• Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando le coordinate geografiche.
• Leggere immagini satellitari del globo terrestre e dell’Europa.
• Individuazione in carte geografiche dell’Europa degli Stati e delle capitali e completamento di tabelle.
• Individuazione in carte geografiche dell’Italia di regioni e capoluoghi di regione.
• Lettura e completamento di un testo sulle linee immaginarie della Terra.
• Individuazione delle coordinate geografiche di un luogo in un globo terrestre.
• Osservazione e descrizione di immagini satellitari della Terra e dell’Europa.
linguAggio dellA geo-grAficità
• Localizzare sul globo e sul planisfero la posizione dell’Italia nel mondo.
• Individuazione su un planisfero politico della posizione dell’Italia nel mondo.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Competenza chiave
traguardi competenze Obiettivi
T2
T2
T3
T2
T2
T2
T5
T5
T5
T6
T6
T6
T5
T5
T5
T6 T7
T6 T7
T6 T7
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
linguAggio dellA geo-grAficità
• Localizzare sulle carte geografiche la posizione dell’Italia in Europa.
• Realizzare carte geografiche evidenziando la posizione dell’Italia nel mondo e in Europa.
• Leggere, interpretare e completare grafici sull’estensione dell’Europa e dell’Italia.
• Analizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione nel mondo.
• Analizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione in Europa.
• Realizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione in Italia.
• Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali della Terra.
• Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali dell’Europa.
• Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali dell’Italia.
• Osservazione di carte geografiche e individuazione della posizione dell’Italia in Europa.
• Completamento di carte mute con indicazione di continenti e Stati.
• Completamento di istogrammi e areogrammi sulle superfici dei continenti e di alcuni Stati europei.
• Osservazione e interpretazione di un cartogramma sulla densità demografica nel mondo.
• Osservazione e interpretazione di cartogrammi sulla densità demografica in Europa.
• Lettura di una tabella e completamento di un cartogramma sulla densità demografica in Italia.
pAesAggio
• Domande a risposta aperta e a risposta multipla sui biomi terrestri.
• Descrizione e completamento di carte geografiche e tabelle sull’orografia e sull’idrografia dell’Europa.
• Descrizione e completamento di carte geografiche e tabelle sull’orografia e sull’idrografia dell’Italia.
• Conoscere paesaggi culturali della Terra.
• Conoscere paesaggi culturali dell’Europa.
• Conoscere paesaggi culturali dell’Italia.
• Osservazione e descrizione di immagini del patrimonio culturale della Terra.
• Osservazione e descrizione di immagini del patrimonio culturale dell’Europa.
• Completamento di domande a risposta multipla sul patrimonio culturale dell’Italia. regione e sistemA territoriAle
• Conoscere e descrivere le fasce climatiche della Terra.
• Conoscere e descrivere le aree climatiche dell’Europa.
• Conoscere e descrivere le regioni climatiche dell’Italia.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Terra.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Europa.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Italia.
• Completamento di frasi a risposta multipla e vero/falso sulle fasce climatiche della Terra.
• Osservazione e descrizione di una carta tematica sulle aree climatiche dell’Europa.
• Completamento di una carta tematica e di un testo-cloze sulle regioni climatiche dell’Italia.
• Osservazione e descrizione di una carta tematica e di un istogramma sull’economia mondiale.
• Osservazione e descrizione di una carta tematica e di un areogramma sull’economia europea.
• Osservazione e descrizione di una carta tematica e di un areogramma sull’economia italiana.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orientAmento
T2
T3
T2
T5
T6
T5
T6
T5
T6
• Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia settentrionale utilizzando i punti cardinali.
• Leggere immagini satellitari dell’Italia settentrionale.
• Individuazione in carte geografiche dell’Italia delle regioni dell’Italia settentrionale.
• Osservazione e descrizione di immagini satellitari dell’Italia settentrionale.
linguAggio dellA geo-grAficità
• Localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Valle d’Aosta.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Piemonte.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Liguria.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Lombardia.
T5
T6
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Trentino-Alto Adige.
T5
T6
T5
T6
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Veneto.
• Completamento di una “carta d’identità” delle regioni d’Italia.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici della Valle d’Aosta e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, domande a riposta aperta e osservazione di immagini sulla città di Aosta.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici del Piemonte e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini e didascalie sulla città di Torino.
• Completamento di una carta geografica della Liguria e lettura e comprensione di un testo e tabelle sui caratteri fisici e politici della regione.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini e completamento di didascalie sulla città di Genova.
• Completamento di una carta geografica della Lombardia, di un questionario vero/falso sui caratteri fisici e di una tabella sulle caratteristiche della popolazione.
• Completamento di frasi e didascalie sulla città di Milano.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici del Trentino-Alto Adige e completamento di una carta geografica.
• Osservazioni di immagini, lettura e completamento di testi sulla città di Trento.
• Completamento di una carta geografica del Veneto, completamento di testi e comprensione di tabelle sui caratteri fisici e politici della regione.
• Completamento di un testo, abbinamento di immagini a didascalie sulla città di Venezia.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Unità di lavoro
Competenza chiave

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
linguAggio dellA geo-grAficità
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Friuli-Venezia Giulia.
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Emilia Romagna.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici del Friuli-Venezia Giulia e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini a descrizioni sulla città di Trieste e i suoi dintorni.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici dell’Emilia Romagna e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini a didascalie sui monumenti della città di Bologna.
pAesAggio
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Valle d’Aosta.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Piemonte.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Liguria.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Lombardia.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Trentino-Alto Adige.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Veneto.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Friuli-Venezia Giulia.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Emilia Romagna.
• Lettura e questionario sul Parco Nazionale del Gran Paradiso.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie sui castelli della Valle d’Aosta.
• Lettura e completamento di testi e didascalie su alcune costruzioni famose del Piemonte.
• Lettura e completamento di un testo sul Parco Nazionale della Val Grande.
• Osservazione di immagini e completamento di testi sulle Grotte dei Balzi Rossi e le Grotte di Toirano.
• Lettura e completamento di un testo sul Parco Nazionale delle Cinque Terre.
• Osservazione di immagini e completamento di didascalie su località turistiche dei laghi lombardi.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie su monumenti della Lombardia.
• Osservazione di immagini e completamento di testi sul Parco naturale dell’Adamello Brenta.
• Individuazione delle principali località turistiche del Trentino-Alto Adige.
• Lettura e completamento di un testo sul Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
• Completamento di un cruciverba e di didascalie sul patrimonio culturale del Veneto.
• Lettura e domande a risposta aperta sul Carso.
• Individuazione della giusta didascalia per immagini del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.
• Lettura e completamento di un testo sul Parco Regionale del Delta del Po.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie su monumenti dell’Emilia Romagna.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Unità di

GEOGRAFIA Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
regione e sistemA territoriAle
T7
T7
T7
T7
T7
T7
T7
T7
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Valle d’Aosta.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Piemonte.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Liguria.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Lombardia.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Trentino-Alto Adige.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Veneto.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Friuli-Venezia Giulia.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Emilia Romagna.
• Interpretazione di un areogramma, lettura e completamento di testi, questionario vero/falso sull’economia valdostana.
• Comprensione di un istogramma, abbinamento di immagini e didascalie e completamento di un cruciverba sull’economia piemontese.
• Lettura e spiegazione di un istogramma e lettura e completamento di un testo sull’economia ligure.
• Interpretazione di un areogramma, questionario vero/falso e risoluzione di un crucipuzzle sull’economia lombarda.
• Comprensione di un istogramma e di un testo sull’economia del Trentino-Alto Adige.
• Lettura e completamento di testi e di un areogramma sull’economia veneta.
• Lettura di un testo sull’economia del FriuliVenezia Giulia, individuazione delle parole chiave e colorazione di un areogramma.
• Comprensione di un istogramma e risoluzione di un cruciverba sull’economia dell’Emilia Romagna.
GEOGRAFIA Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività orientAmento
T2
T3
• Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia centrale utilizzando i punti cardinali.
• Leggere immagini satellitari dell’Italia centrale.
• Individuazione in carte geografiche dell’Italia delle regioni dell’Italia centrale.
• Osservazione e descrizione di immagini satellitari dell’Italia centrale.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
GEOGRAFIA Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza chiave
traguardi competenze
T5 T6
T5
T6
T5
T6
T5 T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
linguAggio dellA geo-grAficità
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Toscana.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici delle Marche.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Umbria.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Lazio.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Abruzzo.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Molise.
• Lettura, comprensione e completamento di testi, tabelle e questionari sui caratteri fisici e politici della Toscana e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini e didascalie sulla città di Firenze.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici della Marche e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi e didascalie e abbinamento a immagini della città di Ancona.
• Completamento di una carta geografica dell’Umbria, di un questionario vero/falso sui caratteri fisici e di una tabella sulle caratteristiche della popolazione.
• Completamento di testi e descrizione di un’immagine sulla città di Perugia.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici del Lazio e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini e didascalie sulla città di Roma.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici dell’Abruzzo e completamento di una carta geografica.
• Completamento di frasi e didascalie sulla città di L’Aquila.
• Completamento di una carta geografica del Molise, di un questionario vero/falso sui caratteri fisici e di una tabella sulle caratteristiche della popolazione.
• Completamento di testi e abbinamento di immagini a didascalie sulla città di Campobasso.
pAesAggio
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Toscana.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale delle Marche.
• Osservazione di immagini e completamento di testi sull’Antro del Corchia e sul Parco della Maremma.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie su piazze della Toscana.
• Lettura di un testo e riconoscimento di monumenti delle Marche.
• Lettura e completamento di un testo sulle Grotte di Frasassi.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Unità di lavoro

GEOGRAFIA Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
pAesAggio
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T7
T7
T7
T7
T7
T7
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Umbria.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Lazio.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Abruzzo.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Molise.
• Lettura e completamento di didascalie sul Parco Regionale del Trasimeno e sulla Cascata delle Marmore.
• Completamento di didascalie su città dell’Umbria.
• Lettura e completamento di un testo sul Parco Nazionale del Circeo.
• Completamento di un cruciverba sul patrimonio culturale del Lazio.
• Completamento di didascalie sul patrimonio naturale e culturale dell’Abruzzo.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sul Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
• Lettura di un testo e abbinamento a immagini di alberi delle Riserve Naturali del Molise.
• Lettura di un testo e domande su Agnone e la produzione di campane.
regione e sistemA territoriAle
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Toscana.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia delle Marche.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Umbria.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Lazio.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Abruzzo.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Molise.
• Comprensione di un istogramma e completamento di un cruciverba sull’economia toscana.
• Completamento di tabelle e di un areogramma quadrato sull’economia marchigiana.
• Comprensione di una tabella e colorazione di un areogramma a torta sugli occupati in Umbria.
• Lettura e spiegazione di un istogramma e lettura e completamento di un testo sull’economia laziale.
• Completamento di una tabella e di un crucipuzzle sull’economia abruzzese.
• Comprensione di un istogramma e risoluzione di un cruciverba sull’economia molisana.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Unità di lavoro
Competenza chiave

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orientAmento
T2
T3
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
T5
T6
• Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia meridionale utilizzando i punti cardinali.
• Leggere immagini satellitari dell’Italia meridionale.
• Individuazione in carte geografiche dell’Italia delle regioni dell’Italia meridionale.
• Osservazione e descrizione di immagini satellitari dell’Italia meridionale.
• Individuazione di “oggetti” geografici fisici in carte satellitari dell’Italia meridionale.
linguAggio dellA geo-grAficità
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Campania.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Basilicata.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Puglia.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Calabria.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Sicilia.
• Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Sardegna.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici della Campania e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi, abbinamento di immagini e didascalie sulla città di Napoli.
• Completamento di una carta geografica, di un questionario vero/falso e di tabelle sui caratteri fisici e politici della Basilicata.
• Completamento di testi e descrizione di un’immagine della città di Potenza.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici della Puglia e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi e didascalie e abbinamento ad immagini della città di Bari.
• Completamento di una carta geografica del Calabria, di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici della regione.
• Osservazione di immagini e completamento di testi e didascalie sulla città di Catanzaro.
• Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici della Sicilia e completamento di una carta geografica.
• Completamento di testi e didascalie sulla città di Palermo.
• Completamento di una carta geografica, di un questionario vero/falso e di tabelle sui caratteri fisici e politici della Sardegna.
• Osservazione di immagini e completamento di didascalie sulla città di Cagliari.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
linguAggio dellA geo-grAficità
T5 T6
T5 T6
T5 T6
• Confrontare i principali caratteri fisici delle regioni italiane.
• Confrontare i principali caratteri politici delle regioni italiane.
T5 T6
T5 T6
T5 T6
T5 T6
T5 T6
T5 T6
• Completamento di tabelle e di areogrammi sui principali caratteri fisici delle regioni italiane.
• Completamento di tabelle e di sequenze sui principali caratteri politici delle regioni italiane.
pAesAggio
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Campania.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Basilicata.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Puglia.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Calabria.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Sicilia.
• Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Sardegna.
• Confrontare aspetti del patrimonio culturale delle regioni italiane.
• Lettura e completamento di un testo sul Parco Nazionale del Vesuvio.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie su luoghi della Campania.
• Lettura e completamento di un crucipuzzle sulla flora e la fauna del Parco Nazionale del Pollino.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie su monumenti della Basilicata.
• Lettura e completamento di testi sulla Foresta Umbra e sulle Grotte di Castellana.
• Completamento di didascalie su monumenti della Puglia.
• Lettura di un testo sulle aree protette della Calabria.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie su monumenti della Calabria.
• Lettura di un breve testo e completamento di didascalie sui parchi regionali della Sicilia.
• Completamento di didascalie e abbinamento a immagini di monumenti della Sicilia.
• Abbinamento di didascalie a immagini di monumenti della Sardegna.
• Lettura e completamento di un testo e di didascalie sui Parchi Nazionali della Sardegna.
• Completamento di didascalie di illustrazioni delle maschere della Commedia dell’Arte.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
traguardi competenze Obiettivi
T7
T7
T7
T7
T7
T7
T7

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
regione e sistemA territoriAle
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Campania.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Basilicata.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Puglia.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Calabria.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Sicilia.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Sardegna.
• Confrontare le caratteristiche dell’economia delle regioni italiane.
• Colorazione di un areogramma e completamento di un cruciverba sull’economia campana.
• Lettura e completamento di testi e domande a risposta aperta sull’economia lucana.
• Lettura e completamento di testi, areogrammi e frasi sull’economia pugliese.
• Lettura di un areogramma e completamento di un cruciverba sull’economia calabrese.
• Colorazione di un areogramma e risoluzione di un crucipuzzle sull’economia siciliana.
• Lettura e completamento di un testo e di un cruciverba sull’economia sarda.
• Completamento di tabelle sull’economia delle regioni italiane.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Competenza chiave
Competenza matematica (A) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
T7
T1
T1 T10
T1 T10
T1 T10
T1 T10
T1 T10
T1 T10
T8
T2
T3
T3
T3
T1 T3
• Usare i quantificatori logici.
• Attribuire valore di verità a enunciati logici.
• Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci fino alle centinaia di migliaia, indicando il valore di ogni cifra.
• Rappresentare, leggere e scrivere la frazione di una grandezza.
• Individuare la frazione complementare di una frazione data.
• Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.
• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri decimali.
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali e decimali.
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali e decimali.
• Risolvere problemi con due domande e due operazioni.
• Distinguere retta, semiretta e segmento.
• Classificare gli angoli.
• Classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli.
• Classificare i quadrilateri convessi.
• Conoscere le unità di misura del sistema metrico decimale.
• Rappresentazioni grafiche e situazioni problematiche per l’uso corretto dei quantificatori.
• Esercizio per il riconoscimento di frasi vere o false.
• Lettura e scrittura dei numeri entro il 1000.
• Esercizi di scomposizione dei numeri naturali.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni di una grandezza.
• Esercizio per l’individuazione della frazione complementare.
• Esercizio di trasformazione di frazioni decimali in numeri decimali.
• Lettura e scrittura di numeri decimali.
• Esercizio di confronto dei numeri decimali con l’uso corretto dei simboli >, <, =.
• Esercizio di ordinamento dei numeri decimali.
• Esercizio per eseguire addizioni e sottrazioni in colonna.
• Esercizio per eseguire moltiplicazioni e divisioni in colonna.
• Risoluzione di problemi con le quattro operazioni.
• Esercizi per il riconoscimento di retta, semiretta e segmento.
• Esercizio di classificazione di angoli.
• Esercizio di classificazione dei triangoli.
• Esercizio di classificazione dei quadrilateri.
• Esercizi sulle unità di misura di lunghezza, peso e capacità.
• Esercizio per eseguire le equivalenze.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Mitici Greci!
Unità di lavoro traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
T1
T1
T1 T10

numeri
• Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti di 3° ordine), ed esprimere la quantità in numeri seguendo il criterio posizionale.
• Indicare con le potenze il valore di ogni cifra di un numero scritto in basi diverse.
• Indicare con le potenze il valore di ogni cifra in un numero scritto in basi dieci.
• Scomporre, sotto forma di polinomio con le potenze, un numero scritto in basi diverse.
• Scomporre, sotto forma di polinomio con le potenze, un numero scritto in base dieci.
• Leggere e scrivere i numeri naturali oltre il milione.
T1
T1
T1 T10
• Confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il milione.
• Leggere e scrivere i numeri romani, confrontando il sistema di scrittura posizionale con quello additivo.
• Confrontare le operazioni di addizione e sottrazione.
T1
T1
T1
T1
T7 T8
T7 T8
T8
• Conoscere il comportamento dello zero nell’addizione e nella sottrazione.
• Riconoscere e applicare le proprietà dell’addizione per semplificare il calcolo.
• Riconoscere e applicare la proprietà della sottrazione per semplificare il calcolo.
• Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri naturali.
• Individuare i dati essenziali, sottintesi, mancanti per la risoluzione di un problema.
• Riconoscere le domande implicite, “nascoste”, nel testo di un problema.
• Risolvere problemi con una o più operazioni.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
• Esercizi di raggruppamento.
• Il valore di una potenza.
• Numeri espressi in forma di potenza di 10.
• Esercizi di scomposizione dei numeri.
• Le potenze e la scrittura polinomiale dei numeri naturali.
• Lettura della storia di Sessa Ebu Daher, l’inventore del gioco degli scacchi per accennare al valore dei numeri grandi e consolidare il concetto delle potenze del 10 per scrivere i numeri.
• Lettura e scrittura dei numeri oltre il milione.
• Approssimazione per eccesso e per difetto.
• Esercizi di confronto e ordinamento dei numeri.
• Esercizi di scrittura nel sistema di numerazione romano.
• Esercizi con l’uso di tabelle e operatori per eseguire addizioni e sottrazioni in riga.
• Analisi del comportamento dello zero.
• Ricerca dell’elemento neutro.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esercizi per eseguire addizioni e sottrazioni in colonna.
• Analisi di situazioni problematiche e individuazione di dati essenziali, sottintesi, mancanti.
• Ricerca e selezione di dati nel testo di un problema per pianificare una soluzione.
• Risoluzione di problemi con le quattro operazioni.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
spAzio e figure
T3 T4
T2
T3 T4
T3
T3
• Consolidare il concetto di retta, semiretta, segmento.
• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di incidenza, perpendicolarità, parallelismo.
• Classificare gli angoli in base all’ampiezza.
• Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
• Consolidare il concetto di poligono.
• Riconoscere e rappresentare i poligoni convessi e concavi.
• Individuare vertici,lati e angoli di un poligono.
• Definizione e riproduzione di retta, semiretta, segmento.
• Definizione e disegno di rette incidenti, parallele e perpendicolari.
• Individuazione delle caratteristiche dei vari angoli.
• Utilizzo di strumenti specifici per misurare gli angoli (uso del goniometro).
• Definizione di poligono.
• Definizione di poligono convesso e concavo.
• Esercizi per il riconoscimento di poligoni convessi e concavi.
• Definizione degli elementi di un poligono. relAzioni, dAti e previsioni
• Comprendere il significato dei connettivi logici “e”, “non”, “e/o”, “o”.
T7
T7
T5 T7
• Usare correttamente il linguaggio degli insiemi nell’operazione di unione di insiemi disgiunti e non disgiunti.
• Comprendere il significato logico di “se... allora” e di “se e solo se”.
• Classificare in base a tre attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.
• Il significato di “e”, “non” in enunciati.
• L’uso di “e/o”, “o” nel senso di aut.
• Gli insiemi disgiunti, inclusi, congiunti.
• Implicazione semplice e tabella della verità.
• Doppia implicazione e tabella della verità.
• Le classificazioni.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Competenza matematica (A) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
• Confrontare le operazioni di moltiplicazione e divisione.
• Esercizi con l’uso di tabelle e operatori per eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga.
T1
T1
T1
• Conoscere il comportamento dello zero e dell’uno nella moltiplicazione.
• Conoscere il comportamento dello zero nella divisione.
• Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione.
• Applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione.
• Applicare la proprietà invariantiva della divisione.
• Estendere la conoscenza dei numeri all’insieme dei numeri relativi.
T1
T10
T1
T1
T1
T1
T1 T9
T1
T1
T5
T8
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre con i numeri naturali.
• Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una e di due cifre con i numeri naturali.
• Eseguire in colonna divisioni con il divisore di tre cifre con i numeri naturali.
• Prevedere il risultato di un’operazione eseguendo un calcolo approssimato.
• Calcolare multipli e divisori di un numero.
• Riconoscere alcuni criteri di divisibilità.
• Ricercare i numeri primi utilizzando il crivello di Eratostene.
• Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
• Analisi del comportamento dello zero.
• Ricerca dell’elemento neutro e annullante.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Osservazione dei numeri relativi.
• Costruzione della retta dei numeri relativi.
• Rilevazione di temperature.
• Calcolo con i numeri relativi.
• Uso dei numeri relativi nella realtà.
• Riconoscimento dell’uso dei numeri negativi in situazioni d’esperienza.
• Esercizi per eseguire in riga moltiplicazioni e divisioni per 10, per 100, per 1000.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna.
• Esercizi per eseguire divisioni in colonna.
• Esercizi per eseguire divisioni in colonna.
• Esecuzione di un calcolo approssimato per prevedere il risultato.
• Ricerca di multipli e divisori di un numero.
• Ricerca di multipli in comune.
• Criteri di divisibilità.
• Esercizi per la ricerca dei numeri primi (crivello di Eratostene).
• Risoluzione di problemi sulla compravendita.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Competenza
Competenza matematica (A) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
spAzio e figure
• Classificare i triangoli rispetto ai lati.
• Classificare i triangoli rispetto agli angoli.
T3
T3
T3 T4
T3 T4
T4
T3
T3
T3 T8
T5
T5
T5 T6 T7
• Classificare i quadrilateri convessi.
• Consolidare i concetti di base, altezza e diagonale nei triangoli e nei quadrilateri.
• Classificare e denominare i poligoni con più di quattro lati.
• Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni.
• Consolidare i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria.
• Calcolare il perimetro dei triangoli e dei quadrilateri.
• Risolvere problemi geometrici (perimetro).
• Esercizi di classificazione dei triangoli.
• Definizione di triangolo equilatero, isoscele e scaleno.
• Definizione di triangolo rettangolo, acutangolo, ottusangolo.
• Esercizi di classificazione dei quadrilateri per l’individuazione delle caratteristiche dei trapezi e dei parallelogrammi.
• Definizione di base, altezza e diagonale.
• Uso del righello per disegnare altezze e diagonali dei triangoli e dei quadrilateri.
• Costruzione di poligoni con più di quattro lati.
• Uso della carta quadrettata, riga, squadra, e compasso.
• Esercizi di ritaglio.
• Il gioco del “Tangram”.
• Esercizi di calcolo per la misurazione del perimetro.
• Risoluzione di problemi per il calcolo del perimetro. relAzioni, dAti e previsioni
• Individuare i criteri di una classificazione rappresentata mediante diagrammi e tabelle.
• Stabilire relazioni d’ordine e di equivalenza riconoscendo le proprietà simmetrica, transitiva e riflessiva.
• Intuire regolarità e costruire progressioni aritmetiche.
• Esercizi di logica.
• Rappresentazioni grafiche di relazioni tra insiemi.
• La successione di Fibonacci.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
numeri
• Rappresentare e denominare frazioni di figure.
• Rappresentazioni grafiche di unità frazionarie.
T1 T10
• Individuare l’intero conoscendo il valore dell’unità frazionaria.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni come parti di figure geometriche.
• Lettura e scrittura di frazioni.
T1 T10
T10
T1 T10
T1 T10
• Individuare la frazione complementare di una frazione data.
• Riconoscere e denominare frazioni proprie, improprie, apparenti.
• Riconoscere frazioni equivalenti.
• Confrontare e ordinare frazioni.
• Calcolare frazioni di quantità numeriche.
T1 T10
• Calcolare l’intero della parte frazionaria.
• Riconoscere le frazioni decimali.
T1 T10
• Scrivere le frazioni decimali sotto forma di numeri decimali e viceversa.
• Attività grafiche ed esercizi per l’individuazione della frazione complementare.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni proprie, improprie, apparenti.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni equivalenti.
• Esercizi di confronto e di ordinamento di frazioni con l’uso corretto dei simboli >, <.
• Rappresentazioni di frazioni sulla linea dei numeri.
• Esercizi per calcolare la frazione di quantità numeriche.
• Esercizi per calcolare l’intero della parte frazionaria con l’algoritmo.
• Lettura e scrittura delle frazioni decimali.
• Addizioni tra frazioni decimali.
• Rappresentazione di numeri decimali sulla linea dei numeri.
T1 T10
T1 T10
• Scomporre e comporre i numeri decimali.
• Confrontare e ordinare numeri decimali.
T1 T10
T1 T8 T10
• Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione.
• Esercizi per trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.
• Esercizi di scomposizione e composizione.
• Esercizi con le equivalenze.
• Esercizi di confronto dei numeri decimali con l’uso corretto dei simboli >, <, =.
• Esercizi di ordinamento dei numeri decimali.
• Risoluzione di problemi con le frazioni.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Competenza matematica (A) C3
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
spAzio e figure
T2
T3
• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
• Conoscere le caratteristiche fondamentali del cerchio.
• Classificare poligoni in regolari e non.
T3
T3
T2 T3
T2 T3
T1 T6
T1 T6
T1 T8
T6 T8
T1 T8
• Acquisire il concetto di apotema.
• Riconoscere le trasformazioni isometriche.
• Individuare gli assi di simmetria nei poligoni.
• Rappresentazione grafica della posizione di un punto sul piano.
• Esercitazioni pratiche e grafiche per individuare gli elementi del cerchio.
• Uso del compasso per disegnare la circonferenza.
• Spiegazione e applicazione della regola per calcolare la lunghezza della circonferenza.
• Costruzione di poligoni con più di quattro lati, equilateri ed equiangoli.
• Definizione di poligono equilatero, equiangolo e regolare.
• Esercizi per il riconoscimento di poligoni equilateri, equiangoli e regolari.
• Sviluppo del concetto di apotema.
• Esercitazioni pratiche e grafiche di traslazioni, rotazioni e simmetrie.
• Rappresentazione grafica degli assi di simmetria nei triangoli, nei parallelogrammi, nei trapezi e nei poligoni regolari.
relAzioni, dAti e previsioni
• Conoscere e utilizzare le principali unità del Sistema Internazionale di misura.
• Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità), espressa con una data unità, a un’altra a essa equivalente.
• Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità anche con le equivalenze.
• Conoscere e operare con le misure di tempo.
• Risolvere problemi con le misure di tempo.
• Risolvere problemi su peso lordo, peso netto e tara.
• Esercizi sul Sistema Internazionale di misura.
• Esercizi per il calcolo di equivalenze.
• Risoluzione di problemi con le principali unità di misura.
• Esercizi con le misure di tempo.
• Risoluzioni di problemi.
• Risoluzioni di problemi.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
MATEMATICA Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Unità di lavoro
Competenza chiave
Alla scoperta delle tradizioni

Competenza matematica (A) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
relAzioni, dAti e previsioni
T5
T5
• Rappresentare e leggere dati rilevati con vari tipi di grafici.
• Rappresentare e leggere sul diagramma cartesiano l’andamento di un semplice fenomeno.
Unità di lavoro
• Rappresentazioni grafiche e lettura di dati con l’istogramma, l’ideogramma e l’areogramma.
• Rappresentazione e lettura dell’andamento di un fenomeno sul diagramma cartesiano.
MATEMATICA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza chiave
Competenza matematica (A) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1 T10
• Riconoscere e utilizzare la frazione come percentuale.
T1 T10
T1
T1
T1 T10
• Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali.
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali.
• Eseguire in colonna divisioni con i numeri decimali.
T1 T10
• Trasformare una frazione non decimale in un numero decimale.
• Calcolo della percentuale.
• Calcolo dello sconto e dell’interesse.
• Dalla frazione non decimale alla frazione decimale equivalente e percentuale corrispondente.
• Esercizi per eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali in riga e in colonna.
• Esercizi per eseguire in riga moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna (fattori con non più di due cifre dopo la virgola).
• Esercizi per eseguire:
– divisioni in colonna con il divisore e il dividendo decimali; – divisioni da continuare fino alla fine.
• Divisioni per trasformare una frazione non decimale in un numero decimale.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1 T10
• Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di operazioni.
T8 T9
T3
T3
• Costruire ragionamenti formulando ipotesi, descrivere il procedimento seguito per la risoluzione di un problema e confrontarsi con il punto di vista degli altri.
• Risoluzione di espressioni aritmetiche.
• Risoluzioni di problemi, indovinelli e quiz.
spAzio e figure
• Calcolare l’area dei principali poligoni.
• Calcolare l’area dei poligoni regolari.
• Calcolare l’area del cerchio.
T3
T3 T4
T3
T3
T3
• Riconoscere figure piane simili.
• Riprodurre in scala una figura assegnata.
• Classificare e denominare le principali figure solide.
• Saper costruire e sviluppare sul piano il cubo e il parallelepipedo.
• Calcolare l’area del cubo e del parallelepipedo.
• Acquisire il concetto di volume.
• Calcolare il volume del cubo.
• Spiegazione e applicazione di formule per calcolare l’area del rettangolo, del quadrato, del rombo, del romboide, del trapezio e del triangolo.
• Spiegazione e applicazione di formule per calcolare l’area dei poligoni regolari.
• Confronto dell’area del cerchio con quella di un quadrato inscritto.
• Confronto dell’area del cerchio con quella di un quadrato circoscritto.
• Spiegazione e applicazione della formula per calcolare l’area del cerchio.
• Le similitudini: ingrandimenti e rimpicciolimenti.
• Riproduzione in scala su fogli quadrettati.
• Esercitazioni pratiche e grafiche per individuare le caratteristiche delle principali figure solide.
• Lo sviluppo dei solidi.
• Spiegazione e applicazione delle formule per calcolare la superficie di alcune figure solide.
• Esercitazioni pratiche per sviluppare il concetto di volume.
• Spiegazione e applicazione della formula per calcolare il volume del cubo.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Competenza matematica (A) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività relAzioni, dAti e previsioni
T8 T10
T5 T8
T8 T11
T8 T10
T3
T3 T8
T5
T3
T5
T6 T9
• Risolvere problemi che implicano anche il calcolo di percentuali.
• Risolvere problemi mediante diagrammi ed espressioni.
• Costruire, dato un algoritmo risolutivo, il testo di un problema.
• Conoscere il rapporto dell’euro con altre monete.
• Conoscere le misure di superficie.
• Risolvere problemi geometrici (area).
• Intuire il rapporto esistente tra spazio, tempo e velocità.
• Conoscere le misure di volume.
• Individuare moda, media, mediana.
• Rappresentare, elencare e numerare tutti i possibili casi in semplici situazioni combinatorie e calcolarne le probabilità.
• Risoluzioni di problemi con la percentuale.
• Dal problema al diagramma e all’espressione.
• Dall’algoritmo risolutivo al problema.
• Risoluzione di problemi che prevedono cambi di monete: euro-dollaro.
• Esercizi sulle misure di superficie.
• Risoluzione di problemi sulle aree.
• Esercitazioni pratiche per l’intuizione del rapporto tra spazio, tempo e velocità.
• Applicazione di formule che legano le tre grandezze.
• Esercizi sulle misure di volume.
• Calcolo di moda, media e mediana usando, se opportuno, la calcolatrice.
• Eventi certi, possibili, impossibili.
• Calcolo combinatorio.
• Calcolo delle probabilità.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Unità di lavoro
chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
T2
T2 T4
T2 T4
T5
T5
• Esplorare i fenomeni naturali con metodo scientifico.
• Conoscere e servirsi di unità di misura convenzionali.
• Sperimentare e schematizzare passaggi di stato della materia.
• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale.
• Riconoscere le relazioni tra le componenti di un ecosistema.
Unità di lavoro
• Osservazione di fenomeni e applicazione del metodo scientifico-sperimentale.
• Le unità di misura convenzionali.
• Osservazione e misurazione di fenomeni e oggetti.
• I passaggi di stato di aggregazione della materia.
• Esperimenti e schematizzazioni dei passaggi di stato.
• Classificazione di illustrazioni in “viventi” e non “viventi”.
• Costruzione di un album murale sui viventi.
• Individuazione della componente biotica e della componente abiotica di un ecosistema.
• Osservazione di immagini e completamento di testi sui rapporti tra le specie.
SCIENZE Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza chiave
Mitici Greci!
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
• Individuare il concetto di forza.
T4
• Individuazione del concetto di forza attraverso l’osservazione degli effetti prodotti su un corpo.
• Descrizione grafica di una forza.
• Esperimenti sui concetti di attrito e di inerzia. osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Sperimentare la composizione di un osso.
T6
T6
T5
T6
• Sperimentare la contrazione dei muscoli.
• Esperimento sulla funzione della componente inorganica delle ossa: i sali minerali e la rigidità.
• Esperimento sulla funzione della componente organica delle ossa: l’osseina e l’elasticità.
• Esperimento sulla contrazione dei muscoli. l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Conoscere la struttura della cellula.
• Osservazione e descrizione della struttura di una cellula eucariote.
• Completamento di illustrazioni e di testi sulla struttura della cellula.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
SCIENZE Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità

Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’AmBiente
T5 T6
T5 T6
• Conoscere le fasi della vita della cellula.
• Conoscere i diversi tipi di tessuto cellulare.
• Conoscere la struttura di un organismo.
T5 T6
T5 T6
T6
• Conoscere l’apparato locomotore.
• Conoscere l’apparato scheletrico.
T6
T6
• Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato scheletrico.
• Conoscere l’apparato muscolare.
• Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato muscolare.
• Domande a risposta aperta sul ciclo vitale della cellula.
• Descrizione dei quattro principali tipi di tessuto cellulare: epiteliale, muscolare, connettivo e nervoso.
• Completamento di un testo cloze sulla struttura di un organismo.
• Completamento di una tabella sulle funzioni vitali dell’uomo.
• Osservazione e descrizione di illustrazioni dei diversi apparati del corpo umano.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sulla funzione dell’apparato locomotore.
• Osservazione e completamento di un’illustrazione dello scheletro umano.
• Completamento di un testo cloze sui tessuti dello scheletro.
• Osservazione e classificazione delle ossa in ossa lunghe, corte e piatte.
• Individuazione delle tre parti dello scheletro umano e colorazione di uno scheletro.
• Osservazione, individuazione e descrizione delle ossa del capo, del tronco e degli arti.
• Questionario vero/falso sulle articolazioni fisse, semimobili e mobili.
• Osservazione e descrizione delle principali deformazioni della colonna vertebrale.
• Distinzione tra lussazione e distorsione e tra artrosi e artrite.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione sull’apparato muscolare dell’uomo.
• Descrizione dei tre tipi di tessuto muscolare.
• Osservazione e individuazione dei diversi tipi di muscoli in relazione al movimento che consentono.
• Osservazione e sperimentazione del funzionamento dei muscoli antagonisti.
• Lettura e completamento di un questionario sulla struttura del muscolo scheletrico.
• Descrizione delle modalità di produzione dell’energia necessaria alla contrazione del muscolo.
• Individuazione dei muscoli maggiormente impegnati in diverse attività sportive.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
• Costruire il concetto di energia.
T1 T3
T2 T6
T2 T6
T2 T6
• Lettura e completamento di un testo sul concetto di energia.
• Abbinamento di definizioni a descrizioni dei diversi tipi di energia.
• Osservazione e completamento di didascalie di illustrazioni di diverse forme di energia. osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Individuare gli alimenti contenenti i grassi.
• Sperimentare la funzione della saliva nella digestione.
• Sperimentare i danni prodotti dal fumo ai polmoni.
• Esperimento sulla presenza di grassi negli alimenti.
• Esperimento sulla funzione della saliva nella digestione: la scomposizione dell’amido.
• Esperimento sui danni prodotti dal fumo ai polmoni.
l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Comprendere la funzione della nutrizione.
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
• Conoscere i nutrienti.
• Conoscere la struttura e la funzione dei carboidrati.
• Conoscere la struttura e la funzione dei grassi.
• Conoscere la struttura e la funzione delle proteine.
• Conoscere la struttura e la funzione delle vitamine.
• Conoscere la struttura e la funzione dei sali minerali.
• Conoscere la funzione dell’acqua.
• Lettura e completamento di un testo sulla funzione della nutrizione.
• Classificazione degli alimenti in base alla loro origine, animale o vegetale.
• Classificazione dei nutrienti.
• Completamento di abbinamenti tra alimenti e nutrienti.
• Classificazione dei carboidrati.
• Individuazione degli alimenti in cui sono presenti gli zuccheri semplici e gli zuccheri complessi.
• Lettura e completamento di un testo sulla classificazione dei grassi.
• Questionario vero/falso sulla struttura e le funzioni della proteine.
• Individuazione di alimenti ricchi di proteine.
• Lettura di una tabella sulle principali vitamine, la loro azione sull’organismo, gli effetti della loro carenza e le fonti alimentari più ricche di ciascuna vitamina.
• Lettura di una tabella e completamento di un testo sulla funzione dei sali minerali.
• Individuazione dei principali sali minerali in alimenti.
• Lettura e completamento di un testo sulla funzione dell’acqua e completamento di una bilancia illustrativa del concetto di equilibrio idrico.
• Classificazione di cibi in relazione alla loro percentuale di acqua.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Acquisire il concetto di fabbisogno energetico.
• Lettura e completamento di un testo sul concetto di fabbisogno energetico.
T6
• Conoscere l’apparato digerente.
T6
T6
T6
T6
• Conoscere le ghiandole annesse all’apparato digerente.
• Conoscere la struttura, lo sviluppo e la funzione dei denti.
• Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato digerente.
• Conoscere l’apparato respiratorio.
T6
T6
• Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato respiratorio.
• Individuazione delle chilocalorie dei nutrienti.
• Osservazione e descrizione di una piramide alimentare.
• Osservazione e completamento con didascalie di un’illustrazione dell’apparato digerente.
• Lettura e completamento di un testo sulle funzioni e gli organi dell’apparato digerente.
• Completamento di un quiz e di un’illustrazione sull’apparato digerente.
• Lettura e completamento di testi sulla struttura e la funzione del fegato e del pancreas.
• Lettura di un testo e completamento di illustrazioni sulla struttura dei denti.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione dell’arcata dentaria.
• Ricerca di informazioni su alcune malattie dell’apparato digerente.
• Questionario vero/falso sulle carie dentali.
• Osservazione e completamento con didascalie di un’illustrazione dell’apparato respiratorio.
• Osservazione, descrizione e completamento di illustrazioni degli organi dell’apparato digerente.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta sulla struttura e la funzione della trachea, dei bronchi, dei bronchioli, degli alveoli polmonari e dei polmoni.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di un testo sui movimenti respiratori.
• Completamento di un quiz sull’apparato respiratorio.
• Osservazione di illustrazioni di comportamenti corretti/scorretti per una buona respirazione.
• Completamento di frasi sulle caratteristiche e la funzione del singhiozzo e dello sbadiglio.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
• Costruire il concetto di suono.
T4
• Osservazione di illustrazioni e completamento di un testo sul suono e sui materiali conduttori e fonoassorbenti.
• Lettura e completamento di un testo sui caratteri del suono.
• Osservazione di un’illustrazione sui decibel prodotti da suoni diversi e domande a risposta aperta.
• Abbinamento di illustrazioni e didascalie dei principali fenomeni sonori.
osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Sperimentare suoni.
T2
T4
T2 T6
• Sperimentare i battiti del cuore.
• Esperimento sulla capacità di produrre un suono con vibrazioni di oggetti.
• Esperimento sulla capacità dell’energia prodotta da un suono di muovere oggetti.
• Esperimento sulla variazione dei battiti del cuore prima e dopo un’attività fisica.
l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Conoscere l’apparato circolatorio.
• Osservazione e completamento con didascalie di un’illustrazione dell’apparato circolatorio.
• Completamento di frasi sulle funzioni del sistema circolatorio: trasporto, difesa e termoregolazione.
• Completamento di frasi sulle differenze tra arterie e vene.
• Osservazione e descrizione di illustrazioni del sistema arterioso e del sistema venoso, lettura di testi, domande a risposta aperta e completamento di un questionario vero/falso.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione del cuore, lettura e completamento di un testo sulla struttura e la funzione del cuore.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione del ciclo cardiaco e riordino di sequenze.
• Osservazione e descrizione di un’illustrazione sulla grande e sulla piccola circolazione e completamento di frasi.
• Completamento di un questionario sull’apparato circolatorio con autovalutazione.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Unità di lavoro

Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Conoscere la struttura e la funzione del sangue.
T6
T6
T6
T6
• Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato circolatorio.
• Conoscere la struttura e la funzione del sistema linfatico.
• Conoscere l’apparato escretore.
• Conoscere la struttura e la funzione della pelle.
T6
T6
T6
• Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute della pelle.
• Conoscere la struttura e la funzione del sistema immunitario.
• Abbinamento di frasi e definizioni delle parti del sangue: il plasma, i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine.
• Lettura di un testo e completamento di una tabella sui gruppi sanguigni.
• Lettura di descrizioni sulle principali malattie del sistema circolatorio.
• Completamento di una tabella sui comportamenti di prevenzione delle malattie circolatorie.
• Osservazione e completamento con didascalie di un’illustrazione del sistema linfatico.
• Lettura e completamento di testi e domande sulla struttura e sulla funzione del sistema linfatico.
• Osservazione e completamento con didascalie di un’illustrazione dell’apparato escretore.
• Lettura e completamento di un testo sulle funzioni e la struttura dell’apparato escretore.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sulla struttura della pelle.
• Osservazione di illustrazioni, lettura e completamento di testi sulla struttura e la funzione degli annessi cutanei.
• Lettura e completamento di un testo sui danni alla pelle prodotti dal sole.
• Completamento di una tabella sui comportamenti di prevenzione delle malattie della pelle provocate dal sole.
• Lettura e completamento di un testo sulla funzione di difesa della pelle e delle mucose delle vie aeree.
• Osservazione di un’illustrazione e lettura di un testo con domande a risposta aperta sul sistema immunitario.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p.
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
T1
T2 T4
T2 T4
T2 T6
• Costruire il concetto di luce.
• Osservazione di illustrazioni e lettura e completamento di un testo e di didascalie sulla luce naturale e sulla luce artificiale.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di testi sui fenomeni luminosi. osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Sperimentare la luce.
• Sperimentare illusioni ottiche.
• Sperimentare la sensibilità del corpo umano.
• Esperimento sulla produzione di luce bianca: il “disco di Newton”.
• Completamento di un testo sulla dispersione di luce prodotta da un prisma.
• Osservazione e completamento di frasi su alcune illusioni ottiche.
• Esperimento sulla diversa sensibilità delle parti del corpo umano.
l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Conoscere l’apparato riproduttore.
T6
T6
T6
T6
• Conoscere le caratteristiche della pubertà.
• Conoscere la fecondazione.
• Conoscere le fasi della gravidanza.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di testi sulle caratteristiche del gamete maschile (spermatozoo) e femminile (ovulo).
• Completamento di didascalie di illustrazioni dell’apparato riproduttore maschile e dell’apparato riproduttore femminile.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sul ciclo ovarico.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di frasi sulla pubertà nel maschio e nella femmina.
• Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sulla fecondazione.
• Completamento di un questionario vero/falso sullo sviluppo da zigote a embrione.
• Osservazione di un’immagine di un feto nell’utero e abbinamento di didascalie e descrizioni alle diverse strutture: placenta, cordone ombelicale, liquido amniotico e sacco amniotico.
• Osservazione di un’illustrazione di un embrione e di un feto durante la gravidanza e abbinamento di didascalie e descrizioni delle diverse fasi della gravidanza.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Verso la scuola secondaria

Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’AmBiente
• Conoscere le fasi del parto.
• Conoscere la struttura e la funzione degli organi di senso.
T6
T6
• Conoscere la struttura e la funzione del sistema nervoso.
• Lettura e completamento di testi sulle fasi del parto: il travaglio, l’espulsione e il secondamento.
• Osservazione di un’illustrazione, lettura e completamento di testi e frasi sui gemelli monozigoti ed eterozigoti.
• Lettura e completamento di testi e frasi sui recettori sensoriali.
• Osservazione di un’illustrazione, lettura e completamento di testi e individuazioni di frasi vere sull’occhio e il senso della vista.
• Osservazione di un’illustrazione, lettura e completamento di testi e frasi sull’orecchio e il senso dell’udito.
• Osservazione di un’illustrazione, lettura e completamento di testi e frasi sul naso e il senso dell’olfatto.
• Osservazione di un’illustrazione, lettura e completamento di testi e di un questionario vero/ falso sulla lingua e il senso dell’udito.
• Completamento di testi e frasi sulla pelle e sul tatto e osservazione e descrizione di un’illustrazione dell’omuncolo sensoriale.
• Lettura e completamento di testi e frasi sul sistema nervoso e osservazione di un’illustrazione.
• Osservazione di un’illustrazione e descrizione di un neurone e completamento di testi e frasi.
• Colorazione di un’illustrazione del sistema nervoso centrale e lettura e completamento di frasi.
• Osservazione di un’illustrazione dell’encefalo e completamento di didascalie.
• Osservazione di un’illustrazione del cervello e completamento di testi e frasi.
• Osservazione di un’illustrazione del midollo spinale, completamento di testi e questionario vero/falso.
• Colorazione di un’illustrazione del sistema nervoso periferico e lettura di un testo con domande a risposta aperta.
• Lettura e completamento di un testo sul sistema nervoso autonomo e completamento di una tabella sulle azioni del sistema ortosimpatico e del sistema parasimpatico.
• Conoscere la struttura e la funzione del sistema endocrino.
• Osservazione di un’illustrazione e lettura e completamento di testi e frasi sul sistema endocrino.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenza chiave
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività T2
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Il canto degli Italiani (Inno di Mameli).
• L’orchestra e le sue varie sezioni.
• La disposizione degli strumenti nell’orchestra.
Competenza chiave
MUSICA Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Viaggio in Italia
Unità di lavoro traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
• Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Musica popolare e danza: aspetti storici e spunti operativi.
• Gli strumenti ad arco.
MUSICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
T2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
T3 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Unità di lavoro
Competenza chiave

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione.
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
• Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Musica popolare e teatro: aspetti storici e spunti operativi (l’opera e il cabaret).
• Gli strumenti a fiato (i legni e gli ottoni).
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
T5
T7
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Musica popolare e danza: aspetti storici e spunti operativi.
• Gli strumenti a percussione.
T4 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
T5 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
T6 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
T7 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività esprimersi e comunicAre
• Elaborare creativamente produzioni personali e collettive.
• Realizzazione collettiva di composizioni astratte con motivi geometrici.
T1
T1
T1
T1
T2
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
• Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate.
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
• Rappresentazione con il disegno delle caratteristiche del protagonista di un libro e di un paesaggio da brivido.
• Realizzazione di manufatti: la calamita decorativa.
• Il ritratto: – osservazione e trasformazione del Ritratto della principessa de Broglie di J.A. Ingres.
• Produzione di calligrammi con l’applicazione WordArt. osservAre e leggere le immAgini
• Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato.
• Abbigliamento, mitologia nell’antica Grecia: – osservazione e descrizione di costumi. – associazione di un’immagine al corrispondente contorno.
comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
T2
T4
T2
T3
T2
T4
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte. • Lettura di opere d’autore, la Nascita di Venere di S. Botticelli, i Bronzi di Riace: – osservazione guidata, descrizione, espressione del giudizio personale.
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Il Partenone: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione.
• Il teatro greco di Taormina: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione.
ARTE E IMMAGINE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
esprimersi e comunicAre
T1
T1
T1
T3
T1
• Elaborare creativamente produzioni personali e collettive.
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
• Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate.
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
• Realizzazione della copertina di un libro, completamento di immagini.
• Realizzazione di decori natalizi con materiali di recupero.
• La natura morta: – osservazione e trasformazione di una natura morta di G. Morandi.
• Produzione di calligrammi natalizi e scritte con l’applicazione WordArt.
osservAre e leggere le immAgini
T2
• Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato.
• Osservazione guidata e descrizione dell’interno di una biblioteca.
• Giochi percettivi.
comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
T2
T2 T3
T2 T4
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Lettura di opere d’autore, Il bibliotecario di G. Arcimboldo: – osservazione guidata, descrizione, soluzione di un questionario a scelta multipla, espressione del giudizio personale.
• Il padiglione d’oro di Kyoto: – stile, elementi caratteristici e funzione.
• La necropoli etrusca di Tarquinia: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione.
T2 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
T3 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
T4 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
esprimersi e comunicAre
• Elaborare creativamente produzioni personali.
T1
T1
T1
T2
T1
T2
T4
T2
T2
T2
T4
T2
T3
T2
T4
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
• Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate.
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
• Rappresentazione con il disegno delle caratteristiche del protagonista di un libro; completamento di immagini relative al Carnevale.
• Realizzazione di manufatti con materiali di vario tipo: decorazioni pasquali.
• Osservazione e trasformazione del dipinto Il bacio di F. Hayez.
• Produzione di testi con caratteri diversi.
osservAre e leggere le immAgini
• Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato.
• Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva.
• Conoscere il linguaggio dei fumetti.
• Osservazione guidata e descrizione di un teatro italiano.
• Giochi percettivi.
• Lettura, interpretazione e realizzazione di onomatopee.
comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Lettura di opere d’autore, Amore e Psiche di Canova: – osservazione guidata, descrizione, espressione del giudizio personale.
• La Statua della Libertà: – stile, elementi caratteristici e funzione.
• Le ville palladiane: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione.
ARTE E IMMAGINE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività esprimersi e comunicAre
T1
T1
T1
T2
T1
• Elaborare creativamente produzioni personali.
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.
• Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate.
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
• Rappresentazione con il disegno di personaggi e ambienti di una storia letta.
• Realizzazione di un biglietto d’auguri.
• Il paesaggio: – osservazione e trasformazione di una piazza d’Italia di De Chirico.
• Produzione di testi con caratteri diversi.
osservAre e leggere le immAgini
T2
T2
T2
T2 T4
T2 T3
T2 T4
• Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato.
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva.
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, individuando il loro significato espressivo.
• Osservazione guidata e descrizione dell’Aula di Montecitorio.
• Osservazione di immagini per rilevarne particolari intrusi e/o dettagli: – esercizi di memoria visiva.
• Le inquadrature. comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Lettura di opere d’autore, Apollo e Dafne di G.L. Bernini: – osservazione guidata, descrizione, espressione del giudizio personale.
• La moschea blu: – stile, elementi caratteristici e funzione.
• Il Colosseo: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione.
T2 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
T3 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
T4 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

EDUCAZIONE FISICA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
T1
T1
T2
T3
T4
T6
T7
• Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva.
• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé e agli altri.
• Esercizi con schemi motori combinati tra loro.
• Gioco: l’ombra del mio compagno.
• Esercizi di movimento. il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Sperimentare la comunicazione con il corpo ed esprimersi attraverso esso.
• Esercizi per creare un laboratorio “ideale” dedicato al linguaggio del corpo. il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Partecipare a vari giochi organizzati anche in forma di gara.
• Giochi: la patata bollente; mini-staffetta; la pila di scatole; il gioco della dama e degli scacchi.
• Olimpiadi e paraolimpiadi: un’esperienza da provare. sAlute e Benessere, prevenzione e sicurezzA
• Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza in palestra.
• Ideazione e compilazione del decalogo: “Regole di comportamento per un corretto uso della palestra”.
EDUCAZIONE FISICA Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T1
T1 T4
T2
T3 T7
T6 T7
Contenuti e attività
il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
• Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea.
• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione agli oggetti e/o agli attrezzi.
• Esercizi di combinazione motoria.
• Esercizi di movimento con oggetti e/o attrezzi.
il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Usare il corpo e il viso per esprimere azioni e stati d’animo.
• Giochi di espressività.
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Rispettare le regole in una competizione sportiva.
• Giochi: i dieci passaggi; il calcio-seduti.
• Le regole e le sanzioni in un gioco sportivo.
sAlute e Benessere, prevenzione e sicurezzA
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni.
• Regole per la prevenzione di infortuni.
EDUCAZIONE FISICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
T2 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
T3 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
EDUCAZIONE FISICA Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
T1 T4
T2
T3
T6
• Riconoscere e valutare traiettorie e distanze.
• Esercizi con la palla per la valutazione di traiettorie e distanze.
il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee attraverso varie forme di danza.
• Hully-gully: sequenza di alcuni passi base.
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare.
• Giochi tradizionali e popolari.
sAlute e Benessere, prevenzione e sicurezzA
• Acquisire consapevolezza della funzione fisiologica cardio-respiratoria.
• I benefici dell’attività motoria sull’apparato cardiovascolare e respiratorio.
EDUCAZIONE FISICA Periodo: APRILE-MAGGIO
Unità di lavoro
Competenza chiave
Verso la scuola secondaria
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare C5 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T1 T4
T1 T2
T3 T7
T7
Contenuti e attività
il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
• Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali di azioni motorie.
• La sincronizzazione dei movimenti.
il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Trovare e mantenere l’equilibrio.
• Esercizi per sperimentare l’equilibrio.
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Partecipare a giochi sportivi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta e manifestando senso di responsabilità.
• Partecipazione a partite di pallavolo e palla tamburello.
sAlute e Benessere, prevenzione e sicurezzA
• Conoscere le regole di comportamento da tenere durante le manifestazioni sportive.
• Ricerca su riviste e giornali di documenti e testimonianze circa episodi di comportamenti sleali e scorretti in campo agonistico.
T4 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
T5 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
T6 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
T7 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Unità di lavoro

TECNOLOGIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
Competenza digitale C4 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività vedere e osservAre
T1 T3
T1 T3
T3 T5
T3 T5
T3 T5
• Conoscere e utilizzare le leve.
• Rappresentare macchine semplici con il disegno.
• Osservazione, descrizione e individuazione delle leve di primo, di secondo e di terzo genere.
• Osservazione, descrizione e individuazione di altre macchine semplici: la carrucola e il piano inclinato. prevedere e immAginAre
• Organizzare una gita usando internet.
• Ricerca di informazioni per un viaggio ad Atene. intervenire e trAsformAre
• Realizzare una maschera greca con il cartoncino.
• Cercare e selezionare in internet un programma di utilità.
Unità di lavoro
TECNOLOGIA
• Realizzazione di una maschera del teatro greco con il cartoncino.
• Ricerca in internet di un gioco per lo studio della geografia.
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
Competenza digitale C4 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
Contenuti e attività vedere e osservAre
T3
T3
T3
T4
T3 T5
T3
• Descrivere la funzione dei principali apparecchi elettrodomestici ed elettronici.
• Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un frigorifero.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: il legno.
• Completamento di frasi sulla funzione dei principali apparecchi elettrodomestici ed elettronici.
• Osservazione, descrizione ed individuazione delle diverse parti del frigorifero.
• Osservazione delle fasi di lavorazione del legno.
• Osservazione dei componenti di una sedia. prevedere e immAginAre
• Prevedere le conseguenze di comportamenti personali: il risparmio energetico.
• Pianificare la fabbricazione di un oggetto di legno.
• Abbinamento di didascalie a un’etichetta energetica di un frigorifero.
• Individuazione degli strumenti e dei materiali per la realizzazione di una stella natalizia di legno. intervenire e trAsformAre
• Utilizzare la corretta procedura per la preparazione del pane.
• Completamento di un diagramma e di un testo sulle fasi della panificazione.
TECNOLOGIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
T2 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
T3 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)

Competenza digitale C4 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
vedere e osservAre
T3
T2
T4
T3 T6
T3
• Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di una lavatrice.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: la carta.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: le fibre tessili.
• Osservazione di un’illustrazione, descrizione e individuazione delle diverse parti della lavatrice.
• Riordino di sequenze e abbinamento a illustrazioni delle fasi della produzione della carta.
• Completamento di didascalie e di frasi sulle fibre naturali ed esperimento sulla resistenza di tessuti. prevedere e immAginAre
• Pianificare la produzione di un oggetto di stoffa.
• Realizzazione di abiti in miniatura in tessuti diversi. intervenire e trAsformAre
• Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una maschera di cartapesta.
Unità di lavoro
Competenza chiave
TECNOLOGIA
• Osservazione e descrizione di strumenti e materiali per realizzare una maschera per il Carnevale.
Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 94)
Competenza digitale C4 (p. 95)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
Contenuti e attività vedere e osservAre
T3 T5
T3 T5
T6
T2
T3
T3
T3
• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.
• Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di: – un televisore; – un telefono; – una calcolatrice.
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: le ceramiche.
• Rappresentazione di una libreria con le regole del disegno tecnico.
• Osservazione e descrizione della struttura di: – un televisore; – un telefono multifunzione; – i principali tasti della calcolatrice.
• Riordino delle fasi di lavorazione dell’argilla ed esperimento sulle proprietà delle ceramiche. prevedere e immAginAre
• Pianificare la fabbricazione del “Disco di Newton”. • Disegno e realizzazione del “Disco di Newton”.
• Pianificare la fabbricazione di un telefono.
• Progettazione e realizzazione di un telefono rudimentale. intervenire e trAsformAre
• Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una mattonella di argilla.
• Osservazione e descrizione delle fasi per realizzare una mattonella di argilla per la festa della mamma.
T4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
T5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
T6 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio comportamento utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
T7 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
EDUCAZIONE CIVICA

Periodo: PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Nodo concettuale Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
coS tituzione e diritti
• Riconoscere i valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.
• Identificare pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi per contrastarli.
• Lettura dell’art. 1 della Costituzione e comprensione dei concetti di Stato e di Repubblica democratica.
• Riflessione sul principio della separazione dei poteri dello Stato.
• Riordino di sequenze e completamento di didascalie sulla storia della Costituzione della Repubblica italiana.
• Conoscenza della struttura e dei valori fondamentali della Costituzione italiana.
• Lettura e domande sul discorso I have a dream di M.L. King; riflessione sulla segregazione razziale.
• Lettura di una poesia e riflessione sull’importanza di identificare e superare i pregiudizi razzistici.
• Conoscere le principali istituzioni della Repubblica italiana.
• Conoscere l’inno nazionale italiano.
• Conoscere l’organizzazione amministrativa della Regione, della Provincia e del Comune.
• Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza territoriale.
• Riconoscere il ruolo della cooperazione e della solidarietà come strategia per migliorare le relazioni interpersonali e sociali.
• Accettare e accogliere le diversità, impiegandole come risorse per compiti o progetti comuni.
• Individuare i servizi offerti dal territorio e comprenderne la funzione.
• Comprendere la funzione e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana.
• Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale.
• Letture, completamento di testi e domande sulle principali istituzioni della Repubblica italiana.
• Lettura e spiegazione dell’Inno nazionale italiano.
• Letture, completamento di testi e domande sull’organizzazione di Regione, Provincia, Comune.
• Colorazione di bandiere e stemmi dell’Unione europea, dell’Italia, della Regione, della Provincia e del Comune.
• Lettura di una poesia di Bertolt Brecht e della fiaba dei fratelli Grimm Il vecchio nonno e il nipotino e riflessione sull’importanza della solidarietà.
• Lettura di una poesia, colorazione della bandiera della pace e conversazione sul valore della pace.
• Lettura di una favola e riflessione sull’importanza della diversità nella cooperazione.
• Lettura del testo autobiografico di Rosanna Benzi e riflessione sulla disabilità.
• Lettura di una poesia e conversazione sui servizi offerti dal territorio e sulla loro funzione.
• Schema di una lettera da indirizzare al Sindaco.
• Lettura di un brano del libro di Gherardo Colombo Le regole raccontate ai bambini e riflessione sul valore delle regole.
• Lettura di filastrocche e di un racconto e riflessione sul bullismo.
• Osservazione e descrizione dei principali segnali stradali.
• Individuazione delle principali regole di educazione stradale per il pedone e il ciclista.
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
Contesto e obiettivi
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.
Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione.
Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali.
In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica.
I principali scopi del quadro di riferimento sono:
a) individuare e definire le competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale;
b) fornire uno strumento di riferimento europeo al servizio dei decisori politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale didattico, degli specialisti dell’orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pubblici per l’impiego e dei discenti stessi;
c) prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle competenze in una prospettiva di apprendimento permanente.
Competenze chiave
Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

C1 Competenza alfabetica funzionale
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
C2 Competenza multilinguistica (1)
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese (2).
C3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
A.
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
B.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.
(1) Mentre il Consiglio d’Europa utilizza il termine «plurilinguismo» per fare riferimento alle molteplici competenze linguistiche delle persone, i documenti ufficiali dell’Unione europea utilizzano il termine «multilinguismo» per descrivere sia le competenze individuali che le situazioni sociali. Ciò è dovuto, in parte, alla difficoltà di distinguere tra «plurilingue» e «multilingue» nelle lingue diverse dall’inglese e dal francese.
(2) È compresa anche l’acquisizione delle lingue classiche come il greco antico e il latino. Le lingue classiche sono all’origine di molte lingue moderne e possono pertanto facilitare l’apprendimento delle lingue in generale.
C4 Competenza digitale

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
C5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
C6 Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
C7 Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
C8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.
Per Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a ciascuna competenza si rimanda ai contenuti della Pen drive allegata alla Guida dov’è riportato l’intero documento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1 - Gli scacchi
2 - I miti
Italiano: Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni. Matematica: Leggere e scrivere i numeri naturali oltre il milione.
Educazione fisica: Partecipare a vari giochi organizzati anche in forma di gara.
Italiano: Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: il mito.
Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto: le sequenze.
Storia: Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Greci.
Arte e immagine: Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
3 - Alessandro Magno
4 - Il teatro greco
5 - Le Olimpiadi
6 - La moda greca
7 - I Bronzi di Riace
Italiano: Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
Storia: Conoscere la nascita e le principali vicende storiche delle civiltà dei Macedoni.
Italiano: Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
Storia: Conoscere la funzione e la struttura del teatro presso i Greci.
Arte e immagine: Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche. Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
Educazione fisica: Sperimentare la comunicazione con il corpo ed esprimersi attraverso esso.
Italiano: Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su argomenti di studio.
Storia: Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Greci.
Educazione fisica: Partecipare a vari giochi organizzati anche in forma di gara.
Storia: Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Greci. Arte e immagine: Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato.
Storia: Produrre informazioni dai Bronzi di Riace. Arte e immagine: Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
* Le competenze chiave sono elencate alle pagine 94-95.
competenze chiave *

1 - Il primo soccorso
Italiano: Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi.
Educazione fisica: Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni.
2 - Regole di comportamento
3 - La biblioteca
4 - Le origini dell’Italia
Italiano: Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo. Scrivere testi regolativi: le regole di comportamento in un museo.
Educazione fisica: Rispettare le regole in una competizione sportiva.
Italiano: Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo. Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione.
Arte e immagine: Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato.
Storia: Conoscere e analizzare la funzione e la struttura delle necropoli etrusche.
Arte e immagine: Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
5 - Il comune di appartenenza
Italiano: Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze.
Geografia: Localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia.
* Le competenze chiave sono elencate alle pagine 94-95.

1 - Le origini di Roma
Italiano: Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni. Acquisire il piacere di leggere.
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
Storia: Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’abbigliamento.
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età monarchica.
Conoscere l’origine mitologica della civiltà dei Romani. Conoscere la nascita della civiltà dei Romani. Geografia: Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Lazio.
Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Lazio.
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
Tecnologia: Pianificare la fabbricazione di un oggetto di tessuto.
2 - Il teatro
3 - Il suono
Italiano: Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto. Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti.
Arte e immagine: Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato.
Tecnologia: Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una maschera di cartapesta.
Italiano: Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale: le figure di suono.
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
Scienze: Costruire il concetto di suono.
Sperimentare suoni.
Musica: Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
Arte e immagine: Conoscere il linguaggio dei fumetti.
Educazione fisica: Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee attraverso varie forme di danza.
4 - Regole per stare bene
Scienze: Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato circolatorio.
Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute della pelle.
Educazione fisica: Acquisire consapevolezza della funzione fisiologica cardio-respiratoria.
5 - Viaggio nei sentimenti
Italiano: Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente.
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione: il mito.
Leggere testi letterari narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore.
Arte e immagine: Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate.
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
Educazione fisica: Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare.
* Le competenze chiave sono elencate alle pagine 94-95.
competenze chiave *

1 - L’Impero romano
Italiano: Acquisire il piacere di leggere. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Storia: Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età imperiale. Conoscere la funzione e la struttura del circo e delle terme presso i Romani.
Geografia: Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Campania. Arte e immagine: Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva.
2 - Colosseo
3 - Star bene
4 - I sensi
5 - Il ritmo
Italiano: Leggere testi narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore.
Storia: Conoscere la funzione e la struttura dell’anfiteatro presso i Romani.
Arte e immagine: Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
Italiano: Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti.
Scienze: Conoscere le caratteristiche della pubertà.
Educazione fisica: Conoscere le regole di comportamento da tenere durante le manifestazioni sportive.
Italiano: Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
Scienze: Conoscere la struttura e le funzioni degli organi di senso.
Musica: Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
Educazione fisica: Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali di azioni motorie.
* Le competenze chiave sono elencate alle pagine 94-95.

Le Indicazioni metodologiche predisposte per ogni disciplina sono accompagnate dal relativo elenco dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria” così come riportati nelle nuove Indicazioni nazionali. Ciascun traguardo è contrassegnato dalla lettera T seguita da un numero progressivo a cui farà riferimento, singolarmente o insieme con altri, ogni obiettivo di apprendimento di ciascuna disciplina.
L’ultimo anno della scuola primaria è cruciale nel percorso formativo degli allievi che stanno vivendo la delicata transizione dall’infanzia all’adolescenza, tra le esperienze vissute nella scuola di base e le discipline della scuola secondaria. Nel predisporre e orientare l’azione didattica non si può non tener conto degli impegni che gli alunni dovranno affrontare nei prossimi anni. Conoscenze e abilità, che sono componenti essenziali delle competenze, devono essere acquisite in maniera corretta, stabile; i contenuti devono essere compresi a un livello di profondità adeguato all’età degli alunni. Al termine del percorso, ciascun allievo dovrà dimostrarsi in grado di affrontare un compito assegnatogli utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, sulla base delle sue personali risorse. Il percorso delineato si basa sui concreti bisogni linguistici degli alunni, parte dai fatti linguistici e approda all’approfondimento, alla puntualizzazione delle conoscenze, privilegiando l’attività ludica. In tale prospettiva la didattica laboratoriale si dimostra particolarmente indicata, poiché prevede che ogni alunno sia protagonista del processo di apprendimento, superando così l’atteggiamento di passività e di estraneità tipico della tradizionale lezione frontale. Al docente compete sempre il ruolo centrale di animatore di situazioni di apprendimento, di guida dell’azione didattica.
Le proposte relative all’ascolto e al parlato sono trasversali a tutte le discipline, infatti vengono prospettati nuclei tematici che si collegano a ognuna di esse. È necessario creare un clima favorevole alla comunicazione, in cui ognuno abbia l’opportunità di esprimersi e imparare a saper ascoltare, poiché questo è il metodo più semplice e diretto per acquisire e fornire informazioni e notizie. La partecipazione agli scambi comunicativi in classe può essere sollecitata dall’insegnante con domande stimolanti, con un tono di voce coinvolgente, promuovendo il confronto e la discussione di ipotesi, e garantendo a tutti la possibilità di contribuire all’individuazione della risposta esatta. Le situazioni comunicative create in classe devono mettere gli allievi in condizione di fare esperienza del parlare per chiedere, convincere, riferire, descrivere, spiegare. Sperimentando tali scambi verbali, essi imparano a osservare le regole della conversazione collettiva.
Saper leggere significa compiere contemporaneamente più operazioni mentali; percepire i segni grafici e il loro significato, cogliere l’organizzazione delle varie informazioni e collegarle alle conoscenze già possedute. L’azione didattica deve necessariamente mirare allo sviluppo di tutte queste abilità, attraverso esercitazioni costanti e di graduale difficoltà, con testi continui e non continui. L’allievo deve acquisire l’abilità di leggere e comprendere una vasta gamma di testi: – quelli in prosa o in poesia, definiti “continui” in quanto formati da frasi organizzate in capoversi, paragrafi e capitoli;

– grafici, tabelle, mappe, definiti “non continui” perché comprendono elementi non verbali. Le tipologie testuali sono diverse perché diverse sono le esigenze che devono soddisfare: – articoli di giornale, avvisi, locandine e manifesti consentono di acquisire informazioni; – ricette, istruzioni e regolamenti mettono nelle condizioni di fare o usare qualcosa;
– libri scolastici, enciclopedie, manuali e vocabolari permettono di apprendere nozioni; – racconti, fumetti, fiabe, favole, miti, leggende e poesie hanno lo scopo di divertire, intrattenere;
– testi argomentativi, articoli d’opinione hanno lo scopo di sostenere un’idea e convincere il lettore della sua validità.
Ora che gli alunni sono cresciuti e si preparano ad affrontare la scuola secondaria, approfondiamo la conoscenza del testo argomentativo: esso si prefigge l’obiettivo di esporre un’opinione e persuadere il lettore della sua validità portando prove, offrendo esempi e producendo ragionamenti logici. In effetti, quella di argomentare è un’operazione che svolgiamo quotidianamente, ogni qualvolta discutiamo con gli altri, esprimendo e sostenendo il nostro punto di vista sui temi più vari. Compito della scuola primaria è stimolare negli alunni la riflessione sulla struttura e lo scopo del testo argomentativo, fornire gli strumenti per la sua comprensione, chiarirne la funzione.
Le esercitazioni proposte si possono classificare in tre grandi gruppi:
1. attività che mirano all’affinamento della tecnica della lettura, inerenti alla rapidità, alla correttezza, sia nella modalità silenziosa che a voce alta;
2. attività che mirano alla comprensione del contenuto, alla capacità di cogliere le relazioni logiche e i nessi linguistici del testo, alla capacità di anticipare le parole e i contenuti che si stanno per leggere;
3. attività che mirano all’ampliamento del bagaglio di conoscenze, relativamente all’arricchimento del vocabolario, alla capacità di effettuare collegamenti e rielaborare le informazioni.
Le proposte riguardanti la scrittura si sviluppano parallelamente a quelle di lettura in un percorso così articolato:
– ascolto e/o lettura di un testo;
– discussione guidata per la focalizzazione degli aspetti fondamentali del testo;
– racconto orale di vissuti, espressione e confronto di opinioni e punti di vista inerenti all’argomento trattato;
– elaborazione e/o rielaborazione di testi di diversa tipologia, con il supporto di mappe, schemi e tabelle;
– revisione del testo.
Nel proporre le diverse attività di scrittura, evidenziamone sempre l’aspetto pratico: la scuola è il laboratorio in cui gli allievi sperimentano le tecniche che utilizzeranno nella vita di tutti i giorni. Nella quotidianità, infatti, la scrittura è un potente mezzo per il conseguimento di una pluralità di scopi:
– stabilire rapporti con gli altri;
– esprimere emozioni e stati d’animo;
– rappresentare la realtà;
– immaginare mondi fantastici.
Quest’anno, alle tradizionali esercitazioni di produzione di testi descrittivi, narrativi, regolativi e informativoespositivi, aggiungiamo quelli argomentativi, in cui l’alunno deve esprimere la propria opinione, sostenerla con opportune motivazioni e convincere il lettore che sia quella giusta.
Uno spazio adeguato deve essere dato alle attività di rielaborazione di testi: le operazioni di riassunto e parafrasi sono frequentemente richieste, sia in ambito scolastico che nella vita di ogni giorno.
Allenandosi a riassumere e a parafrasare, gli allievi acquisiscono l’abitudine a modificare parole, a riferire e/o riscrivere informazioni in modi diversi, rafforzando così la propria abilità di espressione.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
La promozione della competenza lessicale, relativamente all’ampiezza e alla padronanza nell’uso del proprio vocabolario, è da considerarsi trasversale a tutte le discipline, deve permeare tutto l’insegnamento. Per questo motivo le esercitazioni per l’arricchimento lessicale non sono limitate alla specifica sezione, ma costanti e frequenti sono i richiami nelle varie parti della Guida. Attraverso un continuo allenamento, gli allievi sono in grado di ricostruire il significato di vocaboli in un determinato contesto, di cogliere le relazioni di significato tra di essi e di riutilizzarli in nuove situazioni. In conclusione acquisiranno la capacità di destreggiarsi con successo nella lingua, di esprimere efficacemente il proprio pensiero scegliendo le forme più idonee per comunicare, in base alle diverse situazioni e agli interlocutori. Oltre al ripasso dei concetti già studiati negli anni precedenti, sarà approfondito in ogni bimestre lo studio delle singole categorie lessicali, proponendo continue esercitazioni. Nelle attività proposte le norme grammaticali sono in stretto rapporto con la realtà concreta della lingua e sono presentate sempre in forma ludica, tenendo conto delle conoscenze pregresse degli allievi. L’apprendimento mnemonico e ripetitivo di norme non migliora automaticamente la capacità individuale di esprimersi oralmente e per iscritto. Eppure il rispetto delle norme linguistiche rende possibile la corretta comunicazione con gli altri. Perciò, un valido progetto didattico non può prescindere dalla stretta relazione tra norma teorica e concreta realtà linguistica, in una dimensione ludica. Inoltre, all’insegnante spetta il compito di aiutare, stimolare e indirizzare quegli alunni che dovessero dimostrare difficoltà nella risoluzione di alcuni esercizi più complessi, sviluppando atteggiamenti di delusione e sfiducia in se stessi. Per concludere, è necessario sottolineare che l’acquisizione delle regole della lingua è lenta e graduale e che la pratica della lettura incide in maniera decisiva su tale processo: il bambino che legge spesso e con piacere acquisisce maggiore familiarità con la lingua scritta e più velocemente ne scoprirà e comprenderà le regole.
ITALIANO: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Nel percorso suggerito nelle proposte metodologiche di Storia nella Guida Unica di classe quinta, gli alunni conosceranno molte interessanti civiltà, dagli affascinanti Greci ai raffinati Etruschi fino agli avvincenti Romani; attenzione è prestata anche ai vari popoli che abitarono la penisola italica prima dell’avvento della potenza romana.
In classe quinta lo studio della Storia consentirà agli alunni di costruire degli efficaci quadri di civiltà, di conoscere i fatti storici fondamentali e di integrare le nuove informazioni con quelle già acquisite, cogliendo sempre la relazione tra causa ed effetto, domandandosi il perché degli eventi e individuandone le conseguenze. È importante l’utilizzo sia di linee del tempo, per consentire un’adeguata collocazione cronologica degli eventi studiati, sia di carte geo-storiche, per collocare nello spazio le civiltà studiate e per favorire negli alunni la capacità di cogliere l’indissolubile legame tra l’uomo e l’ambiente in cui vive.
Sarà fondamentale, ove possibile, anche l’individuazione sul territorio di tracce dei popoli studiati e l’analisi delle fonti, sia materiali sia scritte: anche attraverso l’utilizzo di internet, gli alunni potranno abituarsi a ricercare immagini di reperti, siti archeologici dei popoli presentati e testi storici da utilizzare per ricavarne informazioni e conoscenze.
Durante quest’anno scolastico, in relazione anche alle proposte di Educazione civica, nelle quali è presentato l’assetto organizzativo della Repubblica italiana, è importante dare centralità allo studio delle istituzioni politiche e sociali dei popoli: un utile spunto per confronti con la realtà contemporanea.
STORIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Durante quest’anno scolastico il percorso delle proposte metodologiche di Geografia consentirà agli alunni di conoscere meglio il territorio dell’Italia e di compiere un interessante viaggio nel suggestivo patrimonio naturale e nel ricchissimo patrimonio culturale del nostro Paese.
Lo studio della Geografia è uno strumento culturale fondamentale perché, partendo dall’osservazione e dalla lettura del territorio, sostiene l’alunno nella comprensione della realtà e nell’esercizio della cittadinanza

attiva: grazie allo studio delle venti regioni italiane, inoltre, ciascun alunno comprenderà di far parte di una comunità territoriale organizzata, in cui gli elementi naturali sono collegati in un rapporto di connessione e di interdipendenza con gli elementi antropici.
Molti i mediatori didattici che si possono utilizzare nello studio della Geografia: dalle carte geografiche alle fotografie o immagini dal satellite, fino alle tecnologie più avanzate, come Google Earth che permette una visualizzazione reale dei luoghi geografici oggetto di studio.
È fondamentale che i nostri alunni, nella descrizione dei luoghi, utilizzino in modo appropriato il linguaggio della geo-graficità. Centrale il ruolo dell’attività laboratoriale, che favorisce la progettazione condivisa e partecipata di qualsiasi ricerca: con l’ausilio degli Approfondimenti, uno per ciascuna regione, gli alunni potranno realizzare atlanti murali, presentazioni o ipertesti con PowerPoint, con cui elaboreranno in maniera efficace le loro conoscenze geografiche.
GEOGRAFIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
La psicologia dell’apprendimento nel corso di questi ultimi decenni ha fatto registrare in ambito matematico notevoli trasformazioni circa il modo di intendere la matematica e, quindi, di insegnarla e apprenderla. Le innovazioni prodotte in campo metodologico-didattico sono state bene evidenziate nelle ultime Indicazioni nazionali che sottolineano il valore della didattica laboratoriale, dell’apprendimento per scoperta, della problematizzazione della realtà e della ricerca.
L’alunno stimolato dalla guida dell’insegnante e dalle discussioni con i compagni di classe imparerà a porsi domande significative, ad affrontare con fiducia la risoluzione di problemi, a tradurre i problemi in rappresentazioni matematiche adatte, a controllarne la risolvibilità e a trovare le soluzioni più adeguate. La disciplina è sviluppata nelle consuete tre sezioni: Numeri, Spazio e figure, e Relazioni, dati e previsioni.
Numeri
Con riferimento a questa sezione, cuore dell’intero lavoro di insegnamento-apprendimento della matematica, l’insegnante, nel corso della classe quinta, procede al consolidamento della tecnica delle quattro operazioni

con i numeri naturali; approfondisce la conoscenza delle frazioni, dei numeri decimali e delle percentuali; guida gli alunni a operare con i numeri decimali e con i numeri interi negativi, dando ampio spazio alle esercitazioni collettive e individuali tratte da contesti concreti e vicini alla loro realtà.
Con riferimento a questa sezione, le attività saranno volte all’acquisizione, da parte degli alunni, delle capacità di riconoscimento e di rappresentazione di forme del piano e dello spazio; di denominazione e classificazione di figure geometriche; di riproduzione di figure mediante l’utilizzo di strumenti per il disegno geometrico; di riproduzione in scala; di calcolo del perimetro e dell’area. L’insegnante condurrà gli alunni a comprendere che fare geometria significa schematizzare la realtà, anche quando essa varia e cambia; introdurrà quindi lo studio delle traslazioni, delle rotazioni, delle simmetrie o ribaltamenti, degli ingrandimenti e dei rimpicciolimenti.
Relazioni, dati e previsioni
Gli obiettivi di apprendimento relativi a questa sezione fanno riferimento a conoscenze, abilità e competenze che sono trasversali a tutte le discipline e che, in particolare, riguardano la logica: stabilire nessi, collegamenti, relazioni tra grandezze, quantità, cose, fatti e fenomeni. Viene data grande importanza, inoltre, al concetto di misura. L’insegnante potrà utilizzarlo come parte tra la realtà e il mondo dei numeri, proponendo una serie di attività con evidenti risvolti pratici.
MATEMATICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Il percorso delle proposte metodologiche di Scienze suggerito per quest’anno scolastico susciterà un vivace interesse degli alunni, che saranno impegnati per lo più a conoscere e comprendere la struttura e il funzionamento del loro corpo. È importante procedere partendo sempre dal pensiero spontaneo degli alunni e dalle loro domande, che sicuramente saranno molteplici: si attiverà così un apprendimento caratterizzato da concetti significativi che consentiranno all’alunno di capire e assimilare quello che studia. Fondamentale è abituare gli alunni a collocare le proprie conoscenze in un quadro unitario, stimolando in loro la capacità di organizzare quanto apprendono: proprio lo studio del corpo umano, unico pur nei suoi diversi apparati e sistemi, sarà l’occasione per consentire a ogni allievo di superare la frammentarietà dei diversi contenuti e di riconoscere un’unitarietà della conoscenza. Essenziale è l’attività laboratoriale attraverso cui si rafforzerà nei ragazzi la fiducia nelle proprie possibilità e si stimoleranno fondamentali abilità sociali, come la disponibilità a dare e ricevere aiuto, la capacità di riconoscere il punto di vista altrui e d’imparare dai propri e altrui errori.
I dettagliati Approfondimenti contenuti nella pen drive e le molteplici illustrazioni presenti nelle schede, con il supporto anche di immagini e filmati da ricercare in internet, potranno essere utilizzati per realizzare efficaci cartelloni o presentazioni digitali sugli argomenti studiati.
SCIENZE: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

“L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze”. Questa considerazione, con cui le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo esordiscono in riferimento all’insegnamento della musica nella scuola primaria, chiarisce in modo inequivocabile il percorso raccomandato per l’acquisizione delle competenze attese al termine di questo segmento scolastico. Tale percorso si articola in due momenti: la produzione e la fruizione. Relativamente alla prima fase, abbiamo privilegiato l’avvicinamento a canti e tradizioni musicali di alcune regioni del nostro Paese. Sarà un modo per approfondire, in una dimensione interdisciplinare, la conoscenza di aspetti riguardanti la lingua, la storia, la geografia e, in generale, la cultura dei luoghi di provenienza dei brani. È chiaro che tale attività presuppone e implica anche il momento della fruizione. Raccomandiamo, infatti, nel momento preparatorio (fase preparatoria), l’ascolto di più versioni dello stesso brano, tali da suggerire un’esecuzione che tenga conto delle diverse inflessioni della voce e dei diversi modi di sentire e interpretare il testo soprattutto in relazione al ritmo, alla melodia e all’armonia, sollecitando in particolare la riflessione sulle diverse cellule ritmiche adottate (tempi binari, ternari, quaternari).
Per quanto riguarda, infine, la conoscenza degli aspetti tecnici e strutturali del discorso musicale, verrà ripreso e approfondito il discorso sul “colore” o timbro strumentale già affrontato e in parte svolto nella Guida Unica di classe quarta. Il presente lavoro, perciò, parte proprio da questa base, per ampliare, poi, gli ascolti dei principali strumenti presenti in un’orchestra sinfonica, fornendo anche occasione di conoscere meglio particolari storici e tecnici, come la nascita e lo sviluppo dell’orchestra moderna, la disposizione dei vari strumenti nell’orchestra e le diverse sezioni che ne fanno parte. Si raccomanda vivamente di far precedere tutte le varie considerazioni riguardanti i timbri strumentali dagli ascolti esemplificativi che si possono effettuare sul sito della casa editrice.
MUSICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
T2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
T3 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
T4 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
T5 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
T6 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
T7 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Le proposte di Arte e immagine per la classe quinta si collocano su una linea di continuità con quelle degli anni precedenti e si articolano in una serie di attività legate a esperienze diverse:
l’esplorazione di forme, oggetti, immagini, per sviluppare la memoria e la percezione visiva; – la manipolazione di materiali diversi, per sviluppare la manualità;
– il modellamento di materiali plastici e l’utilizzo di nuove tecniche, per esprimersi in modo personale; – la realizzazione di opere collettive, per lo sviluppo delle capacità collaborative;
– l’esplorazione e la conoscenza dei beni del patrimonio artistico di varie epoche e culture, per affinare il gusto estetico.
Attraverso la didattica laboratoriale si realizza un ambiente di apprendimento creativo e cooperativo, in cui c’è opportunità di sviluppo per le attitudini dei singoli e insieme di crescita per il gruppo. L’operatività stimola a ricercare modalità e strategie compositive non convenzionali, a sviluppare la capacità di progettazione, a cooperare in vista di un prodotto finale, in cui ognuno è responsabile sia del proprio contributo che dell’insieme degli interventi.
In un’ottica interdisciplinare, numerosi sono gli agganci all’Italiano (descrizioni e fumetti), alla Matematica (elementi geometrici), alla Storia (civiltà greca, etrusca e romana), alla Tecnologia (stili grafici con il computer).
Costantemente è sollecitata la conoscenza dei beni artistici e culturali per apprezzare e rispettare opere appartenenti a diverse epoche e culture che sono patrimonio dell’umanità. L’approccio all’opera d’arte avviene sempre in forma ludica, in modo da essere a portata di bambino: essa va smontata e rimontata, osservata, colorata, rielaborata, trasformata. Sviluppando la sensibilità estetica si creano le basi per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale
ARTE E IMMAGINE: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
T2 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
T3 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
T4 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Nel richiamare e ribadire il valore educativo di questa disciplina e la sua importanza per lo sviluppo della personalità dell’alunno così come della sua dignità pedagogico-didattica, nonostante si connoti come disciplina fondata prevalentemente su un codice linguistico di tipo non verbale, è utile sottolineare ciò che di essa sostengono le Indicazioni del 2012 : “Nel primo ciclo l’Educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché il continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere.”
A tale affermazione e alle sue successive esplicitazioni la Guida si ispira e si uniforma specie per quanto riguarda la prescrittività dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che gli alunni devono raggiungere al termine della scuola primaria e che vengono declinati con puntuale riferimento allo sviluppo di conoscenze e abilità relative ai quattro indicatori in cui si snoda l’itinerario curricolare proposto nelle Indicazioni. Le attività didattiche che verranno, pertanto, presentate in classe quinta si organizzeranno proprio intorno ai suddetti quattro indicatori.
–
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, le funzioni senso-percettive necessarie per conoscere e padroneggiare sia la dimensione spazio-temporale della realtà che gli schemi motori di base mediante i quali mantenere il controllo del corpo e organizzarne i movimenti.
– Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva, il possesso sicuro di un alfabeto corporeo idoneo e capace di emettere e ricevere messaggi unitamente all’acquisizione di comportamenti migliorativi sul piano espressivo ed estetico.
– Il gioco, lo sport, le regole e il fair play, l’apprendimento di comportamenti sociali e relazionali quanto più possibili funzionali sia alla capacità di partecipare ad attività di gioco-sport o sportive condividendo regole e procedure, sia al rispetto di valori e principi connessi con la pratica motoria individuale, di gruppo o a squadre.
– Salute e benessere, prevenzione e sicurezza, l’assunzione e l’osservanza di stili di vita improntati al benessere, alla salute e alla sicurezza.
La presente proposta per la quinta classe si configura, perciò, come itinerario finalizzato allo sviluppo di competenze plurime che consentano all’alunno di scoprirsi padrone e protagonista della propria corporeità ma, soprattutto, del valore sociale, morale ed etico dell’esperienza motoria.
EDUCAZIONE FISICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
T2 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
T3 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
T4 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
T5 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
T6 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
T7 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Durante quest’anno scolastico invitiamo l’alunno a guardarsi intorno, individuare oggetti di uso comune (dal frigorifero allo smartphone), che l’uomo ha progettato per risolvere o gestire problemi o per migliorare la propria vita, e a descriverne la struttura e il funzionamento. Sollecitiamo, inoltre, nell’alunno una metodologia operativa centrata sulla progettazione per la realizzazione di semplici prodotti originali, dalla mattonella di argilla al modello di tunica, alla maschera di cartapesta: egli deve imparare a individuare e gestire le molteplici variabili, dalle risorse materiali agli aspetti organizzativi, che concorrono nel processo di realizzazione di un prodotto.
TECNOLOGIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
T2 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
T3 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
T4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
T5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
T6 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio comportamento utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
T7 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
L’insegnamento dell’Educazione civica è stato introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92. La scelta è ispirata al principio secondo il quale l’insegnamento di questa disciplina «contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri». Secondo quanto previsto dalla Legge e dalle relative Linee guida 2020, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, l’insegnamento dell’Educazione civica deve essere sviluppato «intorno a tre nodi concettuali [...] ai quali possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche individuate»:
1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà.
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
3. Cittadinanza digitale.
Da un punto di vista metodologico-didattico gli insegnamenti relativi all’Educazione civica non potranno essere isolati, ma saranno di carattere trasversale e interdisciplinare, anche se dotati di una ben definita programmazione autonoma.
Particolare attenzione si è voluta dedicare, in questa sede, allo studio della Costituzione e alla riflessione sul tema della diversità, cui si ispira anche il titolo del percorso “Diversi e insieme!”.


Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T1 , T2 , T3 , T6 e T8 (v. pag. 102).
Ormai i bambini frequentano già da quattro anni la scuola e hanno acquisito moltissime conoscenze di cui non sempre hanno consapevolezza. Possiamo spiegare loro che dedicheremo questo primo periodo dell’anno scolastico alla ripetizione “delle cose che già sanno e che già sanno fare”, i “prerequisiti”. Questa fase è fondamentale per passare da attività più semplici ad altre più complesse. Infatti gli esercizi di allenamento sono utili sia per acquisire che per consolidare le abilità.
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni T1 T2
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente T1 T2
Come nel precedente anno scolastico, evidenziamo l’importanza di ricordare le informazioni ascoltate, in modo da farle proprie. Alleniamo questa abilità di base con un gioco già noto alla classe: leggiamo a voce alta un testo interessante, successivamente distribuiamo il testo bucato da completare con i termini corretti da scegliere tra le opzioni proposte. Prima di leggere, avvertiamo gli alunni che è necessario prestare molta attenzione e che dovranno memorizzare le parole ascoltate per svolgere correttamente il gioco. Evidenziamo con tono enfatico le parole utili a completare il testo nella scheda. Converrà leggere il brano più volte per abituare nuovamente gli alunni alla concentrazione. Essi dovranno compiere uno sforzo per ricordare, infatti le opzioni fornite risulteranno tutte adeguate, sia a livello logico sia morfologico. Nella stessa scheda sono suggerite alcune domande per stimolare la discussione sul tema delle vacanze, in modo che gli alunni possano esprimere le loro preferenze e raccontare le esperienze vissute.
Antologia pag. 134 Atmosfera di settembre • 135 Brani da ascoltare
Scheda 1 Vacanze in campagna
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione T3
Gli alunni devono riprendere l’abitudine a leggere i testi in maniera attiva, sforzandosi di riconoscere i legami logici, di individuare la funzione delle parole e di comprenderne il significato. È consigliabile sottoporre all’attenzione della classe un testo che non sia troppo complesso, ad

esempio una breve fiaba. Proponiamo attività note alla classe: il completamento di un cloze o testo bucato con le parole di una lista data e la soluzione di un questionario concernente principalmente l’uso e la funzione delle diverse categorie lessicali. Inoltre, cogliamo l’occasione per ripetere l’uso dei tempi verbali, chiedendo agli alunni se riescono a stabilire quando si è svolta la storia raccontata. Ricordiamo che ricaviamo questa informazione dalla flessione dei verbi. È evidente che la nostra storia si svolge nel passato, trasportiamola nel presente, come se stesse svolgendosi in questo momento: in che modo dobbiamo trasformare i verbi?
Facciamo leggere a voce alta le due versioni del brano in modo che risultino evidenti le differenze.
Nell’Approfondimento sono indicate le soluzioni degli esercizi proposti.
Scheda 2 La fiaba sbadata
Approfondimento 1 La fiaba sbadata
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche dei principali generi di narrazione T3
Sarà utile ricapitolare anche i principali generi narrativi studiati nei precedenti anni. Presentiamo piccoli ma significativi brani di diverso genere. Verificheremo la capacità degli alunni di farsi un’idea del contenuto del testo: leggendo le poche righe a disposizione essi dovranno dimostrare di saper prevedere, sia pure a grandi linee, il resto della storia.
Prima di avviare l’attività, stimoliamo la classe con domande mirate, in modo da far emergere le principali caratteristiche di ogni genere:
◆ la favola è una storia fantastica che ha per protagonisti animali con i vizi e virtù degli uomini e ha sempre una morale;
◆ la fiaba è una storia fantastica che ha per protagonisti persone dotate di poteri magici;
◆ la cronaca è il racconto di fatti realmente accaduti;
◆ la lettera personale è l’esposizione, da un punto di vista personale, di fatti realmente accaduti;
◆ la leggenda è un una storia che dà una spiegazione fantasiosa di un fenomeno naturale;
◆ la storia di paura è il racconto di fatti misteriosi, inspiegabili, che suscitano la curiosità del lettore;
◆ il mito è una narrazione fantastica che ha per protagonisti divinità ed eroi che compiono imprese epiche;
◆ il diario è una narrazione particolarmente libera, scritta per se stessi.
Abbiniamo a questa attività un gioco che la renda maggiormente piacevole: dopo aver scritto accanto a ogni brano il corrispondente genere, gli alunni dovranno considerare le lettere indicate tra parentesi che, lette di seguito, formeranno una parola. Naturalmente è necessario che il primo esercizio sia stato svolto correttamente.
Le associazioni corrette sono: 1 / c; 2 / d; 3 / a; 4/ f; 5 / e; 6 / h; 7 / g; 8 / b.
La parola misteriosa è FANTASIA.
Scheda 1 Indovino il genere

• Produrre testi sostanzialmente corretti, legati a scopi concreti T1 T6
Relativamente alla scrittura, converrà verificare quelle capacità che costituiscono le basi necessarie per i successivi apprendimenti: descrivere e raccontare. Su queste due abilità se ne innestano altre più complesse: esporre, argomentare, relazionare, rielaborare, scrivere regole e testi creativi.
Chiediamo alla classe qual è lo scopo di un testo descrittivo e quali regole dobbiamo seguire per raggiungere lo scopo che abbiamo fissato.
Ricordiamo che il testo descrittivo serve a dare informazioni su una persona, un animale, un oggetto o un ambiente. La descrizione, per essere efficace, deve seguire un criterio, altrimenti risulterà confusa e chi legge il testo non riceverà alcuna informazione. Se lo riteniamo opportuno, chiediamo a ciascun alunno di portare a scuola una foto o una cartolina di un luogo visitato durante le vacanze. Organizziamo una discussione in cui ognuno presenti brevemente la località visitata, prendiamo la parola per primi. Di seguito si forniscono alcuni suggerimenti sulle domande da porre. È consigliabile ridurne il numero nella discussione, poiché i tempi di ascolto si allungherebbero eccessivamente, specialmente nel caso di una classe numerosa.
Qual è il nome della località che hai visitato?
È molto lontana dal luogo in cui vivi?
Quale mezzo di trasporto hai usato per arrivarci?
Che cosa ritrae in particolare la foto che hai portato?
Ci sono persone? Chi sono?
Che cosa si vede al centro?
Che cosa si vede in primo piano?
Che cosa si vede in secondo piano?
E sullo sfondo?
Che cosa si vede ai lati della foto?
Che cosa si vede in alto? E in basso?
Quali colori spiccano nella foto?
Quali ricordi suscita in te la foto?
Ti è piaciuta la località che hai visitato?
Perché?
Le domande così formulate saranno una guida nella composizione del testo scritto, fornendo suggerimenti sull’uso della punteggiatura. In alternativa, possiamo far descrivere delle immagini che avremo scelto e distribuito alla classe.
Scheda 3 La foto delle vacanze
Al rientro dalla pausa estiva, i bambini hanno tante esperienze da comunicare. Invitiamoli a raccontare ai compagni come hanno trascorso il giorno più bello delle vacanze. Ricordiamo che una narrazione deve necessariamente contenere alcune informazioni essenziali:
◆ i protagonisti della vicenda;
◆ il luogo e il tempo in cui si è svolta;
◆ lo svolgimento dei fatti;
◆ la conclusione della vicenda.
Facciamo precedere la fase della produzione scritta dal racconto orale. L’insegnante può invitare ogni alunno a raccontare brevemente una propria esperienza: ciò richiede un tempo abbastanza lungo, ma viene data a ognuno la possibilità di esprimersi. Se invece non c’è sufficiente tempo a disposizione, possiamo sollecitare alcuni alunni a formulare

qualche esempio. Coinvolgiamo il resto della classe chiedendo di esprimere un parere sulla correttezza e completezza degli esempi forniti.
Scheda 4 Il giorno più bello delle mie vacanze
• Riconoscere le fondamentali convenzioni di scrittura e le principali parti del discorso T8
Nel predisporre le prove di ingresso, teniamo conto del fatto che sicuramente molti alunni, durante la pausa estiva, hanno dimenticato alcune delle regole di grammatica esplicita studiate nel precedente anno scolastico. Esse saranno riprese e approfondite in classe quinta. Per il momento, facciamo un rapido ripasso proponendo dei giochi. Gli alunni si divertiranno e prenderanno anche coscienza degli argomenti che hanno scordato e che quindi devono essere riesaminati. Assicuriamoci inoltre che i giochi non risultino troppo difficili, ma neanche troppo semplici: l’eccessiva facilità non suscita l’interesse dei ragazzini che ormai si sentono grandi. Prendiamo nota delle difficoltà maggiormente incontrate dagli alunni così da predisporre gli interventi più opportuni.
Per esempio, si può distribuire alla classe la scheda “Alla ricerca delle parole corrette”, in cui è richiesto agli alunni di individuare, in una serie di tre parole, l’unica scritta correttamente per poi formare una frase con le lettere indicate nella colonna accanto.
Come si può notare, devono essere risolti due giochi: il secondo costituisce la verifica del primo, infatti la sua riuscita dipende dalla corretta esecuzione del primo. La scheda consente di ripassare velocemente le principali difficoltà: digrammi, trigrammi, raddoppiamenti di consonante, accenti.
Nell’Approfondimento sono presenti le soluzioni dei giochi.
Scheda 2 Alla ricerca delle parole corrette
Approfondimento 2 Alla ricerca delle parole corrette
Prima di risolvere il gioco proposto nella scheda “Alla ricerca… della grammatica” leggiamo insieme le consegne e rinfreschiamo la memoria:
◆ le esclamazioni servono a esprimere con enfasi sensazioni e stati d’animo;
◆ il punto esclamativo si usa per esprimere un sentimento di gioia, stupore ecc.;
◆ il verbo essere è un verbo speciale perché può avere tanti significati e funzioni;
◆ gli aggettivi qualificativi esprimono una qualità del nome a cui si riferiscono;
◆ le preposizioni sono parole vuote, che da sole non hanno alcun significato; si usano per collegare due elementi della frase e possono essere semplici o articolate;
◆ il modo infinito è la forma base del verbo, esprime solo l’azione, non dà informazioni sulla persona;
◆ i nomi indicano persone, animali, cose, idee, fatti e possono variare nel genere (maschile o femminile) e nel numero (singolare o plurale);

◆ gli aggettivi numerali cardinali danno informazioni precise sulla quantità del nome a cui si riferiscono.
Man mano che ripetiamo questi concetti invitiamo gli alunni a fare degli esempi. In questo modo potremo notare quali sono gli alunni che intervengono spesso e quelli che invece rimangono in silenzio. Per questi ultimi presumibilmente sarà necessario un aiuto.
Riportiamo la soluzione del gioco. La frase nascosta è: (F) EVVIVA - (B) ! - (D) SONO - (G) FELICE - (C) DI - (A) ESSERE - (E) IN - (I) CLASSE - (H) QUINTA
Scheda 5 Alla ricerca… della grammatica

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T2 , T3 , T5 , T7 , T8 e T9 (v. pag. 103).
• Conoscere le fonti della Storia T2 T5
Nelle prime settimane di scuola presentiamo ai nostri alunni contenuti già proposti durante lo scorso anno scolastico, fondamentali per un sicuro approccio metodologico allo studio della Storia: le fonti storiche; il lavoro dello storico e degli scienziati che lo aiutano; la datazione. Ricordiamo che la parola greca historía, che significa “ricerca”, deriva da un’altra parola greca, ístor, che significa “colui che ha visto”, perciò la storia è ricerca di ciò che è stato visto, di ciò che è reale, di fatti umani realmente accaduti e documentabili. Collegandoci a quanto affermato, sottolineiamo l’importanza dei documenti per la ricostruzione e la narrazione di un fatto storico, perciò riproponiamo ai nostri alunni la classificazione delle fonti storiche.
Le fonti della storia
Utensili, armi, resti di edifici, arredi, monete, tracce di cibo sono fonti materiali.
Dipinti, graffiti, sculture, mosaici, mappe, fotografie, filmati sono fonti iconografiche.
Testimonianze verbali dirette e racconti, leggende, canti tramandati a voce sono fonti orali.
Tutti i tipi di testo scritto (iscrizioni su pietre o altro materiale, atti di nascita o di compravendita, preghiere, diari, lettere, libri) sono fonti scritte.
Presentiamo alla classe una scheda in cui sono raffigurate tre illustrazioni: alcuni geroglifici egizi (fonte scritta), lo Stendardo di Ur (fonte iconografica della civiltà mesopotamica) e la Corazza di bronzo di Dendra (fonte materiale della civiltà micenea) e invitiamo gli alunni a completare una semplice carta d’identità delle fonti.
Scheda 3 Tante fonti!
• Ricavare e produrre informazioni da fonti di diverso tipo T2
Proponiamo ai nostri alunni di comportarsi come uno storico, producendo informazioni attraverso l’analisi di fonti di diverso tipo. Riproponiamo alla classe il seguente schema, esemplificativo delle fasi in cui si articola il metodo storico. Lo storico: ricerca, analizza e interpreta le fonti; ricostruisce i fatti; colloca i fatti nel tempo e nello spazio; individua i collegamenti dei fatti con altri precedenti, contemporanei e successivi; espone i fatti analizzati.

Successivamente invitiamo gli alunni a osservare illustrazioni di fonti delle civiltà studiate durante lo scorso anno scolastico, per trarre informazioni utili a descriverle.
LABORATORIO Costruiamo un album storico
Invitiamo gli alunni a portare in classe immagini di fonti delle civiltà studiate durante lo scorso anno scolastico (dalla Stele di Hammurabi, al Papiro di Hunefer, alle Piramidi di Gizah, ad affreschi con illustrazioni di imbarcazioni fenicie ecc.).
Successivamente costruiamo un album murale in cui, accanto a ciascuna immagine, gli alunni scriveranno didascalie con le informazioni ricavate utilizzando le fonti.
Scheda 6 Come uno storico
• Esporre conoscenze utilizzando il linguaggio specifico della Storia T8
Proponiamo ai nostri alunni di esporre il ruolo svolto dagli specialisti delle “scienze ausiliarie” della Storia (l’antropologo, l’archeologo, l’economista, il geografo, il geologo, il paleografo e il paleontologo), utilizzando correttamente i termini specifici della disciplina.
Scheda 4 Chi è?
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico T3
Per collocare i fatti nel tempo, lo storico deve datarli, disponendoli in ordine cronologico, al fine di interpretarli e leggerli sia in prospettiva diacronica, cioè nella loro successione temporale, sia in prospettiva sincronica, cioè in relazione a fatti contemporanei.
Per gli uomini è stato necessario creare un sistema di datazione, individuando un momento di partenza nella misurazione del tempo, denominato anno 0.
L’anno 0 per i popoli occidentali
Per i popoli occidentali l’anno 0 coincide con l’anno di nascita di Gesù Cristo. Nel 527 d.C. un monaco, Dionigi il Piccolo, sostenne che la nascita di Gesù Cristo fosse un evento fondamentale per la religione cristiana e propose che gli anni venissero contati da quel momento, piuttosto che dalla fondazione di Roma o dall’inizio del regno di Diocleziano, come si usava in quel tempo. Dionigi calcolò che Gesù fosse nato nell’anno 753 Ab Urbe Condita, cioè dalla fondazione di Roma. Questo metodo non fu immediatamente accolto, neanche dalla Chiesa cattolica che iniziò a impiegarlo solo verso la fine del X secolo d.C.
L’abbreviazione a.C. (avanti Cristo) indica tutti gli anni precedenti alla nascita di Cristo, mentre d.C. (dopo Cristo) indica gli anni dopo la nascita di Cristo.
Gli anni a.C. si contano all’indietro e maggiore è il numero che esprime la data, più antico è l’anno. Gli anni d.C., invece, si contano progressivamente e maggiore è il numero che esprime la data, più recente è l’anno.
Facciamo esercitare i nostri alunni a collocare in ordine cronologico diverse date, anche costruendo e utilizzando una linea del tempo.
Scheda 5 Sulla linea del tempo

• Usare una carta geo-storica T7
Per consentire agli alunni di orientarsi su una carta geo-storica, proponiamo di individuare i luoghi nei quali si sono sviluppate le civiltà studiate durante lo scorso anno scolastico. Invitiamoli a riflettere sulla connessione tra l’ambiente geografico in cui una popolazione si insedia e le attività economiche prevalenti: se lungo i fiumi si sono sviluppate civiltà la cui economia era fondata prevalentemente sull’agricoltura irrigua, lungo le coste si sono insediate popolazioni dedite primariamente al commercio marittimo e che hanno attivato significativi processi di colonizzazione.
Scheda 7 Dove si sono sviluppate le civiltà?
• Conoscere la struttura di un quadro storico di civiltà T5 T9
Proponiamo ai nostri alunni, anche all’inizio della quinta classe, come abbiamo suggerito già in quarta, la struttura di un quadro di civiltà.
Il termine civiltà deriva dal latino civitas, città, e indica l’insieme degli aspetti della vita di un popolo in un determinato periodo storico.
Per conoscere un popolo è fondamentale costruire un quadro storico della civiltà, presentandone le caratteristiche peculiari attraverso i principali indicatori tematici.
Indicatore tematico di civiltà Contenuto
Tempo e luogo
Organizzazione politica e sociale
Cultura e scienza
Credenze e religione
Attività economiche
Vita quotidiana
Collocazione spazio-temporale di una civiltà, con particolare attenzione alla conformazione fisica dell’ambiente e alla contemporanea esistenza di altre civiltà, nonché alle vicende storiche significative.
Conoscenza delle caratteristiche dell’organizzazione del governo e della società.
Conoscenze, invenzioni e scoperte di una civiltà.
Conoscenza di ciò in cui credono le civiltà: le divinità e i riti.
Attività che le persone esercitano per vivere, con particolare rilevanza da attribuire ai mestieri tipici.
Cibi, passatempi, case, vestiti, con attenzione ai compiti svolti dalle donne e dai bambini.
Attraverso l’utilizzo degli indicatori tematici di ciascuna civiltà, gli alunni potranno conoscere in modo sistematico le caratteristiche di un popolo e memorizzarle più facilmente.
Scheda 6 Il quadro storico di civiltà
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate T9
Completiamo le attività di verifica delle conoscenze dei nostri alunni, invitandoli a confrontare alcuni aspetti caratterizzanti i diversi popoli delle civiltà studiate.
Utilizziamo immagini di costruzioni o altre fonti materiali per ripercorrere brevemente e in modo suggestivo le principali caratteristiche delle civiltà fluviali:

◆ la ziggurat di Ur e la Stele con il codice di Hammurabi per la civiltà mesopotamica;
◆ le piramidi di Gizah e la maschera funeraria del faraone Tutankhamon per la civiltà egizia;
◆ l’immagine dall’alto dell’antica città indiana di Mohenjo-Daro;
◆ uno scorcio della muraglia cinese.
Stimoliamo gli alunni a ricordare le principali caratteristiche delle civiltà che si svilupparono lungo le coste del Mar Mediterraneo attraverso l’associazione di parole:
◆ porpora, vetro di Sidone, cedro, Cartagine e Biblo per la civiltà fenicia;
◆ Canaan, Filistei, Torah, Abramo, Giordano, Gerusalemme, Menorah, Esodo e profeta per la civiltà ebraica;
◆ Cnosso, ascia bipenne, labirinto, Minosse e tauromachia per la civiltà cretese;
◆ Porta dei Leoni, acropoli, Troia e Peloponneso per la civiltà micenea.
Proponiamo, poi, alla classe di osservare e descrivere immagini rappresentative delle civiltà:
◆ i Murex trunculus, molluschi di piccole conchiglie da cui si estraeva la porpora, sostanza con cui si tingevano i tessuti e che rese famosi i Fenici in tutto il mondo;
◆ la Menorah, un grande candelabro a sette bracci, che ricorda quello che fu fatto costruire da Mosè secondo precise indicazioni ricevute da Yahweh (contenute nel libro dell’Esodo); la funzione della Menorah era quella di ardere perennemente nel Tempio di Gerusalemme dove era custodita l’Arca dell’Alleanza, ed è ancora oggi un simbolo della religione ebraica perché, secondo i più, simbolo dei sette giorni della creazione;
◆ l’ascia bipenne, spesso raffigurata anche negli affreschi dei sontuosi palazzi dell’isola di Creta, simbolo del potere del re di Cnosso, nel cui palazzo sono state ritrovate asce in oro, in rame, in argento, oltre molte incisioni che le raffigurano. Dall’ascia bipenne o lábrys deriva il nome “Labirinto” attribuito proprio al Palazzo del re di Cnosso;
◆ la “Maschera di Agamennone”, una maschera funeraria rinvenuta nel 1876 dal famoso Heinrich Schliemann, un appassionato studioso dei testi attribuiti al poeta greco Omero. Quando Schliemann la rinvenne inviò al re di Grecia Giorgio I un telegramma in cui scrisse: “Ho visto il volto di Agamennone”. In verità, si scoprirà più tardi che la maschera era appartenuta a un re morto circa 300 anni prima del periodo in cui pare fosse vissuto Agamennone.
Schede 8 Un viaggio tra le civiltà fluviali • 9 Sulle coste del Mar Mediterraneo

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T2 , T3 , T4 , T5 e T7 (v. pag. 104).
• Conoscere e utilizzare il metodo di lavoro del geografo T2 T7
Durante le prime settimane di scuola è importante potenziare negli alunni sia l’acquisizione di un adeguato lessico disciplinare sia la consapevolezza che il geografo, come lo storico, utilizza un metodo di lavoro caratterizzato dal succedersi di diverse fasi.
La Geografia
La parola “geografia” è formata dalle parole greche ge¯o-, derivante da gê = Terra, e -graphía, derivante dal verbo gráphein = tracciare dei segni, descrivere.
La Geografia è una scienza che si occupa di rappresentare graficamente dei luoghi e descriverli e di cogliere le relazioni tra gli aspetti fisici e naturali di un ambiente e quelli antropici, introdotti dall’uomo.
Per svolgere il suo lavoro, il geografo segue un metodo caratterizzato dalle seguenti fasi:
◆ osservazione diretta o attraverso fotografie del luogo da studiare;
◆ documentazione del luogo da studiare;
◆ raccolta e analisi dei dati sul luogo;
◆ descrizione del luogo attraverso parole e immagini.
Inizialmente il geografo osserva un luogo, direttamente o attraverso fotografie, individuandone gli elementi fisici (la conformazione del territorio), gli elementi naturali (flora e fauna) e gli elementi antropici (insediamenti e attività dell’uomo).
Proponiamo ai nostri alunni di osservare un luogo conosciuto direttamente o attraverso immagini e filmati, invitandoli a riconoscerne gli elementi fisici, naturali e antropici.
Con l’aiuto di immagini facilmente reperibili anche in internet, riproponiamo la differenza, già esposta nella Guida Unica di classe quarta, tra:
◆ la fotografia panoramica, scattata a distanza ravvicinata, che consente di vedere in maniera più dettagliata le caratteristiche fisiche e antropiche di un ambiente;
◆ la fotografia aerea, realizzata da un aereo che sorvola un territorio scattando molte fotografie successivamente assemblate, che mostra uno spazio più vasto di quello ripreso da una foto panoramica;
◆ la fotografia satellitare, scattata dai satelliti artificiali orbitanti intorno alla Terra, che è in grado di riprendere territori vastissimi, anche i due emisferi terrestri; le immagini ottenute dai satelliti sono poi elaborate dal computer per ottenere carte geografiche molto precise.
Scheda 10 Come un geografo
• Conoscere e utilizzare gli strumenti di lavoro del geografo T2
Ricordiamo ai nostri alunni alcune definizioni concernenti i diversi tipi di rappresentazione dello spazio, già presentate nei precedenti anni scolastici.
A seconda della scala di riduzione si distinguono:

◆ la pianta e la mappa con scala di riduzione fino a 1:10.000;
◆ la carta topografica con scala di riduzione da 1:10.000 a 1:100.000.
◆ la carta corografica con scala di riduzione da 1:100.000 a 1:1.000.000.
◆ la carta geografica con scala di riduzione superiore a 1:1.000.000.
◆ il planisfero, che rappresenta tutta la Terra su una superficie piana, con scala di riduzione superiore a 1:30.000.000.
Un’altra importante classificazione è collegata al contenuto della carta geografica:
◆ la carta fisica rappresenta gli aspetti fisici del territorio, cioè i rilievi, i mari, i fiumi, i laghi ecc.;
◆ la carta politica rappresenta i confini dello Stato (confini politici) o di regioni, province e comuni (confini amministrativi) e la distribuzione e l’entità dei centri abitati;
◆ la carta fisico-politica rappresenta insieme gli aspetti fisici e politici e i centri abitati;
◆ le carte tematiche descrivono un particolare aspetto del territorio rappresentato (carte economiche, carte etniche, carte geofisiche, carte linguistiche, carte naturalistiche, carte nautiche o carte storiche).
Scheda 7 Tante carte per il geografo
• Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali T2
Dopo aver ripresentato diverse carte fisiche, politiche e tematiche, ricordiamo ai nostri alunni che per convenzione tutte le carte geografiche sono orientate con il nord (N) in alto, il sud (S) in basso, l’est (E) a destra e l’ovest (O) a sinistra.
Invitiamoli a leggerle secondo l’orientamento dei punti cardinali, con riferimento anche a quelli intermedi, cioè il nord-est (NE), il sud-est (SE), il sud-ovest (SO) e il nord-ovest (NO).
Scheda 8 Orientarsi in Italia
• Riconoscere e analizzare i principali caratteri fisici di un territorio T4
Presentiamo agli alunni immagini di mari, fiumi, laghi, isole, monti, colline e pianure.
Per ciascuna domandiamo: Quale elemento fisico è raffigurato?
In seguito alle risposte degli alunni chiediamo: Che cos’è un lago? Che cos’è un fiume? Che cos’è un monte? ecc.
Possiamo completare la proposta con un’attività laboratoriale.
LABORATORIO Costruiamo un vocabolario geografico illustrato
Invitiamo gli alunni a portare in classe immagini di paesaggi geografici o a disegnarne di particolareggiati. Successivamente, utilizzando cartelloni colorati o anche della carta da sottoparati, costruiamo un vocabolario murale illustrato in cui, accanto a ciascuna immagine, gli alunni scrivono i principali elementi fisici con una breve didascalia descrittiva.
Tale album potrà essere realizzato anche in formato digitale e utilizzato efficacemente con la lavagna multimediale, se la scuola ne è dotata.
Schede 11 Immagini geografiche d’acqua • 12 Immagini geografiche di terra

• Conoscere gli elementi caratteristici dei principali paesaggi geografici T5
Ricordiamo ai nostri alunni che il paesaggio è la forma che assume l’ambiente che ci circonda e riproponiamo le parole caratterizzanti il paesaggio marino, il paesaggio fluviale e il paesaggio montano, già presentate nella Guida Unica di classe quarta, che andranno ad arricchire il nostro vocabolario geografico illustrato.
Parole del paesaggio marino
Ansa Grande curva formata dal fiume.
Arcipelago Gruppo di isole vicine tra loro.
Baia Piccola rientranza della costa.
Costa alta Luogo di incontro tra il mare e la terra montuosa o collinare.
Costa bassa Luogo di incontro tra il mare e la terra pianeggiante.
Falesia Costa con pareti rocciose che scendono a picco sul mare.
Faraglioni Scogli aguzzi sporgenti dal mare.
Fiordo Rientranza alta e stretta che penetra nella costa anche per molti chilometri.
Fiume Corso d’acqua perenne.
Foce Punto in cui il fiume sbocca nel mare.
Golfo Grande rientranza della costa.
Isola Terra circondata dal mare da ogni lato.
Laguna Bacino d’acqua sulla costa comunicante attraverso delle bocche con il mare, da cui è separato da strisce di terra.
Lido Lunga striscia di sabbia che delimita la costa.
Penisola Parte di terra circondata dal mare da tre lati.
Promontorio Tratto di terra montuosa che si protende nel mare.
Spiaggia Tratto di costa sabbiosa.
Stretto Spazio di mare, limitato da due coste, che separa due tratti di mare.
Parole del paesaggio fluviale
Affluente Corso d’acqua secondario che sbocca in un corso principale.
Ansa Grande curva formata dal fiume.
Cascata Salto che fa un corso d’acqua quando incontra un dislivello.
Emissario Fiume che esce da un lago.
Fiume Corso d’acqua perenne.
Foce a delta Punto in cui il fiume sbocca nel mare dividendosi in tanti rami.
Foce a estuario Punto in cui il fiume sbocca nel mare allargandosi a imbuto.
Ghiacciaio Vasta distesa di ghiacci parzialmente perenni.
Immissario Fiume che porta le sue acque in un lago.
Lago Massa d’acqua in una cavità naturale della superficie terrestre.
Lingua Parte del ghiacciaio che tende a scorrere verso il basso.
Palude Area di terreno ricoperta di acqua stagnante.
Ruscello Breve e sottile corso d’acqua.
Sorgente Punto in cui nasce il fiume.
Torrente Corso d’acqua breve e impetuoso, con andamento stagionale.
Parole del paesaggio montano

Catena Successione di montagne, più o meno allineate.
Crinale Profilo di una montagna o di una catena che unisce i due versanti o le vette.
Ghiacciaio Vasta distesa di ghiacci parzialmente perenni.
Massiccio Insieme di montagne compatte e raggruppate, l’una a ridosso dell’altra.
Parete Versante particolarmente ripido.
Piede Parte più bassa di una montagna.
Valico o passo Avvallamento tra cime di una montagna che permette di passare da un versante all’altro.
Valle Spazio compreso tra i versanti di due montagne.
Versante Fianco di un rilievo, identificabile con il punto cardinale verso cui è rivolto.
Vetta o cima Parte più alta di una montagna.
Successivamente invitiamo gli alunni a disegnare un paesaggio marino, un paesaggio fluviale e un paesaggio montano e a collegare a ciascun paesaggio le parole della Geografia che servono per descriverlo.
• Ricavare informazioni geografiche da tabelle e grafici T3
Alcune informazioni geografiche, come ad esempio il numero degli abitanti o delle montagne di un territorio, il numero di lavoratori impiegati nei diversi settori produttivi di una regione ecc., sono quantificabili ed esprimibili con numeri: sono dati statistici e possono essere rappresentati con tabelle o grafici.
Tabelle e grafici
Le tabelle ordinano i dati e permettono una rapida comparazione. I grafici rappresentano i dati statistici con un disegno e sono di diverso tipo:
– l’areogramma (o grafico a torta) raffigura i dati come parti di un tutto;
il cartogramma utilizza la carte geografica e indica con simboli, colori o disegni l’intensità di un fenomeno nel territorio raffigurato; – il diagramma mostra l’andamento di un fenomeno nel tempo e rappresenta i dati in una linea che si costruisce all’interno di assi cartesiane; sull’asse orizzontale (asse delle ascisse) si indicano i dati relativi al tempo, mentre sull’asse verticale (asse delle ordinate) quelli relativi al valore del fenomeno; – l’istogramma o diagramma a barre raffigura i dati con colonne di diversa altezza; – l’ideogramma mostra i dati con disegni o simboli e ad ogni disegno o simbolo corrisponde una data quantità di dati.
Presentiamo ai nostri alunni tabelle e grafici e invitiamoli a leggere i dati statistici rappresentati per ricavarne informazioni geografiche, nonché a completare un areogramma quadrato.
Schede 13 Rilievi d’Italia in areogrammi • 10 Grafici d’Italia

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T1 , T2 , T3 , T7 , T8 e T10 (v. pag. 105).
Il mese di settembre è dedicato, come di consueto, all’accertamento dei livelli di partenza della classe. Il percorso di verifica prevede lo svolgimento di alcune prove, su alcuni obiettivi fondamentali presentati in classe quarta, volte a verificare il livello di apprendimento in ordine alle conoscenze, alle abilità e alle competenze necessarie per affrontare la classe quinta. I risultati delle suddette prove ci forniscono elementi di conoscenza degli alunni, necessari per impostare adeguatamente l’attività di programmazione.
Attraverso la registrazione dei risultati potremo valutare il possesso o meno delle conoscenze, e con gli alunni che non le possiedono, o le possiedono solo in parte iniziare subito un lavoro di recupero individualizzato o di gruppo, prevedendo esercitazioni con sussidi didattici strutturati e la compilazione di schede relative all’obiettivo da raggiungere.
• Usare i quantificatori logici T7
• Attribuire valore di verità a enunciati logici T7
È sempre utile e importante verificare la capacità dell’alunno di usare i quantificatori logici in modo preciso e corretto e attribuire valore di verità a enunciati. L’uso dei quantificatori permette all’alunno di sviluppare e potenziare importanti capacità intellettive. I quantificatori, impiegati nel linguaggio comune, sono uno strumento indispensabile per la matematica. Ricordiamo il significato dei singoli quantificatori:
◆ “tutti” significa nessuno escluso;
◆ “alcuni” significa una parte di tutti, ma non determina quanti siano esattamente;
◆ “ognuno”, “ogni”, “ciascuno” sono termini che si riferiscono a tutti gli elementi, presi però uno per volta e non nel loro insieme;
◆ “nessuno” esclude tutti gli elementi che stiamo considerando;
◆ “almeno uno” implica che fra gli elementi considerati ve ne sia almeno uno che presenta quelle determinate caratteristiche; ciò significa che possono essere anche più di uno. Per l’attribuzione del valore di verità a enunciati, gli alunni, nella scheda proposta, dovranno individuare tra varie frasi quelle che possono essere considerate enunciati logici e poi assegnare il valore di verità a ognuno di essi. Ricordiamo che sono enunciati logici le frasi alle quali si può assegnare con sicurezza un valore di verità (vero o falso). Se le frasi risultano ambigue, per cui non possiamo affermare se siano vere o false, non sono da considerarsi enunciati.
Scheda 14 Quantificatori ed enunciati logici
• Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci fino alle centinaia di migliaia, indicando il valore di ogni cifra T1
In ambito aritmetico, l’abilità aritmetica da verificare è quella che si riferisce alla lettura e scrittura dei numeri naturali fino alle centinaia di migliaia, abilità nella quale gli alunni

devono dimostrare la più completa padronanza e sicurezza. Si propongono alcuni esercizi che prevedono la lettura e la scrittura del numero in cifre e in lettere e la scomposizione dei numeri, anche con l’attribuzione del valore di ogni cifra. Ciò per offrire agli alunni un ulteriore stimolo ai fini della comprensione della struttura del numero.
Scheda 15 Numeri grandi
• Rappresentare, leggere e scrivere la frazione di una grandezza T1 T10
• Individuare la frazione complementare di una frazione data T1 T10
Il concetto di frazione è stato introdotto in classe terza collegandolo a esperienze di tipo concreto come la divisone di oggetti a metà, in quarti ecc. In classe quarta l’argomento è stato approfondito e formalizzato mediante attività che hanno chiamato in causa capacità di ragionamento e di riflessione. In classe quinta, i modelli matematici e i ragionamenti deduttivi possono diventare sempre più oggetto su cui operare direttamente, anche tralasciando progressivamente l’esperienza concreta e ricorrendo alla sua rappresentazione mentale. Pertanto, per evitare una noiosa ripetizione del lavoro già svolto, ma nel contempo garantire a ciascun allievo la comprensione dei concetti base, si consiglia di verificare il grado di assimilazione attraverso la seguente scheda e valutare se ripetere collettivamente e che cosa riprendere con attività di recupero in piccolo gruppo.
Scheda 16 Le frazioni
• Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa T1 T10
• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri decimali T1 T10
La scheda presenta esercizi volti a verificare se i bambini hanno compreso la regola per trasformare le frazioni decimali in numeri decimali e viceversa, senza però utilizzare automatismi. Riprendiamo l’argomento nel suo aspetto logico e strutturale e proponiamo un ripasso dei numeri con la virgola. Gli alunni incontrano difficoltà nel lavorare con i numeri con la virgola e dimostrano a volte per essi un’avversione. Forse alla base di ciò c’è un’insicurezza derivante dalla scarsa gradualità con la quale gli allievi vengono messi a contatto con i numeri decimali, certo non facili, sui quali si basa l’intera costruzione dei numeri razionali. Insistiamo affinché gli alunni superino le proprie incertezze.
Scheda 17 Frazioni e numeri decimali
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali e decimali T1 T10
Questo obiettivo da verificare consente di fare il punto sul livello di abilità nel calcolo scritto. Giunti al quinto anno della scuola primaria, gli alunni eseguono con sicurezza le quattro operazioni e conoscono i loro algoritmi di calcolo. Sarà nostra cura accertarci della perfetta padronanza del meccanismo delle quattro operazioni e proporre attività di consolidamento

se dovessero sorgere problemi di incolonnamento. Invitiamo ciascun bambino a eseguire alla lavagna un’addizione e una sottrazione in colonna sia con i numeri naturali che con i decimali per verificarne l’avvenuta acquisizione. Per mettere bene in evidenza il valore posizionale di ciascuna cifra facciamo eseguire le operazioni in tabella; poi procediamo senza la tabella, consentendo di usarla solo a quegli alunni che ancora si mostrano deboli nell’attività di incolonnamento dei numeri.
L’esito dei risultati potrà essere verificato o mediante correzione individuale con l’esecuzione delle corrispondenti prove oppure mediante correzione collettiva previa scrittura alla lavagna dell’operazione eseguita da noi o da un alunno.
Scheda 18 Addizioni e sottrazioni
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali e decimali T1 T10
Anche questo obiettivo come quello precedente consente di fare il punto sul livello di abilità nel calcolo scritto. Per affrontare la verifica dell’esecuzione delle moltiplicazioni in colonna, sarà opportuno ripeterle gradualmente secondo un ordine crescente di difficoltà. Si inizia con il proporre l’esecuzione di moltiplicazioni con il moltiplicatore di due cifre e si giunge a proporre le moltiplicazioni con i numeri decimali. I bambini dovranno rispettare, nell’incolonnare i numeri, il valore posizionale delle cifre.
Anche per affrontare la verifica dell’esecuzione delle divisioni in colonna sarà opportuno ripeterle gradualmente secondo un ordine crescente di difficoltà (divisioni con il divisore di due cifre, con il dividendo decimale e infine con il divisore decimale).
Le esecuzioni delle operazioni in colonna saranno riprese e consolidate nel corso della quinta classe, per cui se qualche alunno dovesse trovare qualche difficoltà, sarà nostra cura rassicurarlo e proporre di tanto in tanto esercitazioni collettive e individuali fin quando tutti gli alunni avranno acquisito dimestichezza e sicurezza con i vari procedimenti.
Scheda 19 Moltiplicazioni e divisioni
• Risolvere problemi con due domande e due operazioni T8
Riprendiamo un’altra importante attività del precedente anno scolastico: risolvere problemi. Per risolvere un problema matematico si deve iniziare con il comprendere il testo verbale e le difficoltà sostanzialmente sono due: decodificare un testo scritto e conoscere l’uso delle quattro operazioni. Attraverso una prima buona lettura è già possibile individuare i dati, la domanda e intuire la strategia risolutiva.
In quinta classe sembrerebbe ormai possibile dare per scontato che gli alunni siano in grado di leggere senza difficoltà, scorrevolmente e con espressività, ma, interrogati su quanto hanno letto, non di rado dimostrano una comprensione superficiale e lacunosa delle informazioni. È, pertanto, consigliabile procedere inizialmente con la lettura guidata, rivolgendo agli alunni opportune domande al fine di stimolare in essi l’analisi e la comprensione del testo e, dopo aver accertato che tutti l’abbiano compreso, chiedere che cosa “vuole sapere” il

problema con la prima domanda e, nel caso di problema con più domande, che cosa con la seconda e così via.
Successivamente gli alunni saranno chiamati a elencare i dati che sono presenti nel testo del problema e a individuare, tra questi, solo quelli necessari. Li condurremo a riflettere sui dati, a fare ragionamenti per individuare ed eseguire le corrette operazioni e a formulare le risposte da fornire a ogni domanda.
Anche per questo obiettivo si consiglia di proporre molti problemi da risolvere collettivamente prima di passare a quelli da risolvere individualmente.
Può certamente risultare utile il ricorso alla seguente scheda di lavoro sulla cui falsariga, se necessario, l’insegnante potrà crearne altre simili.
Scheda 20 Problemi
• Distinguere retta, semiretta e segmento T2
• Classificare gli angoli T3
Con riferimento ad analoghe attività svolte in classe quarta, l’insegnante propone agli alunni una scheda contenente linee rette, semirette e segmenti e li invita, con l’aiuto di pastelli o pennarelli a distinguerli.
Per quanto riguarda la classificazione degli angoli li invita a classificarli in retto, piatto, giro, acuto, ottuso. Le attività legate a questo obiettivo possono essere svolte sulla scheda, sul quaderno o alla lavagna, individualmente, in coppia e in piccolo gruppo. Non ci limiteremo alla mera correzione di eventuali errori, ma ne cureremo l’analisi per comprendere quali ragionamenti hanno motivato le scelte degli alunni.
Scheda 21 Retta, semiretta, segmento e angoli
• Classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli T3
• Classificare i quadrilateri convessi T3
La scheda verifica le abilità di classificare:
◆ i triangoli, rispetto ai lati, come equilatero, isoscele e scaleno;
◆ i triangoli, rispetto agli angoli, come rettangolo, acutangolo, ottusangolo;
◆ i quadrilateri, come trapezi (rettangolo, isoscele, scaleno) e parallelogrammi (quadrato, rettangolo, romboide o parallelogramma, rombo).
Potrebbe accadere che gli alunni non abbiano acquisito sicurezza nella conoscenza e nella classificazione dei triangoli e dei quadrilateri. In tal caso facciamo in modo che gli allievi si possano esercitare attraverso numerose attività.
Scheda 22 Triangoli e quadrilateri
• Conoscere le unità di misura del sistema metrico decimale T1 T3
Riprendiamo un’altra importante attività del precedente anno scolastico: la conoscenza delle unità di misura del sistema metrico decimale. Proponiamo una scheda nella quale gli

alunni devono completare le tabelle delle misure di lunghezza, peso e capacità e ripetiamo con i bambini il procedimento che si utilizza per effettuare le equivalenze. Se i bambini sono ancora incerti nelle equivalenze, facciamoli ragionare sui rapporti tra le misure e sul procedimento da seguire per velocizzare il passaggio da un’unità all’altra. Per trasformare un valore relativo a una determinata unità di misura in un altro relativo a un’altra unità di misura, si possono verificare due casi:
◆ se si passa da un multiplo a un sottomultiplo, si moltiplica per 10, per 100, per 1 000, a seconda dei posti che separano l’unità di partenza da quella di arrivo. Facciamo un esempio alla lavagna: 45 m = 4 500 cm
◆ se si passa da un sottomultiplo a un multiplo, si divide per 10, per 100, per 1 000, contando anche in questo caso il numero dei posti.
Altri esercizi da proporre sono i seguenti:
◆ esercizi di confronto tra coppie di misure per stabilire qual è la più piccola/la più grande, oppure di quanto, una misura rispetto a un’altra, è più piccola o più grande;
◆ esercizi di scomposizione.
◆ domande stimolo come le seguenti: Quanti decimetri ci sono in un metro? Quanti ettogrammi ci sono in un chilogrammo? Quanti litri ci sono in un ettolitro?
Scheda 23 Unità di misura

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T2 , T3 , T4 , T5 e T7 (v. pag. 106).
• Esplorare i fenomeni naturali con metodo scientifico T2 T4
Ricordiamo agli alunni che i fenomeni naturali sono gli eventi che accadono in natura e che sono osservabili con i sensi o con strumenti adeguati. Sono gli scienziati a studiare i fenomeni naturali con il metodo scientifico-sperimentale, introdotto nella pratica scientifica dall’illustre Galileo Galilei.
Il metodo scientifico-sperimentale
Il metodo scientifico-sperimentale si basa sul susseguirsi di alcune fasi: osservazione di un fenomeno; individuazione di un problema e formulazione di una domanda; elaborazione di un’ipotesi per spiegare il fenomeno stesso; progettazione di un esperimento per verificare l’esattezza dell’ipotesi; realizzazione dell’esperimento, che può avere esito positivo o negativo; se l’esperimento ha esito positivo, cioè conferma l’ipotesi teorizzata si giunge alla formulazione della legge scientifica; se l’esperimento ha esito negativo, si dovrà formulare una nuova ipotesi.
Proponiamo ai nostri alunni di osservare alcuni fenomeni naturali, frequenti nella vita quotidiana, e di spiegarli con approccio scientifico. Presentiamo anche un’attività laboratoriale volta a dimostrare che l’aria ha un peso e sollecitiamo gli alunni a schematizzare l’esperimento secondo le fasi del metodo scientifico-sperimentale.
Scheda 24 Come uno scienziato
• Conoscere e servirsi di strumenti per unità di misura convenzionali T2 T4
Come già evidenziato nella Guida Unica di classe quarta, ricordiamo agli alunni che il metodo scientifico serve a trovare una spiegazione dei soli fenomeni naturali per i quali si valutano proprietà misurabili quantitativamente, come la lunghezza, il peso, la temperatura ecc.
Le unità di misura convenzionali
Ai diversi tipi di fenomeni naturali corrispondono diverse grandezze fisiche e diversi strumenti per misurarle operando un confronto con le unità campione, cioè le unità di misura convenzionali, fissate nel 1961, quando è nato il SI - International System of Units (Sistema internazionale di unità di misura): la lunghezza si misura con il metro (m), la massa con il chilogrammo (kg), l’intervallo di tempo con il secondo (s), l’intensità di corrente con l’ampere (A), la temperatura con il kelvin (K), spesso sostituito con il grado centigrado o grado Celsius (°C), la quantità di sostanza con la mole (mol).
Coinvolgiamo i nostri alunni in divertenti esercitazioni invitandoli a misurare diversi fenomeni registrando i risultati in tabelle.
Scheda 11 Tante misure!
• Sperimentare e schematizzare passaggi di stato della materia
Tutto ciò che ci circonda, ogni corpo, è formato da materia. La materia, che può essere visibile a occhio nudo o richiedere il microscopio per essere esplorata, si presenta in tre

stati fisici di aggregazione, distinti a seconda della forza che tiene unite le particelle, atomi o molecole, che la compongono: stato solido, stato liquido e stato gassoso.
Il calore, la forma di energia che aumenta il movimento delle particelle della materia, determina dei passaggi di stato della materia: al variare del calore le stesse sostanze cambiano il loro stato di aggregazione, passando da uno stato all’altro.
Ricordiamo ai nostri alunni che i passaggi di stato della materia avvengono col modificarsi della temperatura, cioè col variare della quantità di calore posseduta dal corpo.
LABORATORIO Sperimentiamo i passaggi di stato aumentando la temperatura
Se ne abbiamo la possibilità conduciamo i nostri alunni nel laboratorio scientifico oppure realizziamo questi esperimenti in aula. Abbastanza facili sono le attività per sperimentare i tre passaggi di stato che avvengono aumentando la temperatura:
la sublimazione, cioè il passaggio dallo stato solido allo stato gassoso, può sperimentarsi lasciando evaporare delle palline di naftalina collocate in un piattino di plastica ed esposte per alcuni giorni al sole o collocate su un termosifone acceso; – la fusione, cioè il passaggio dallo stato solido allo stato liquido, può sperimentarsi semplicemente lasciando sciogliere un cubetto di acqua ghiacciata; – la vaporizzazione, cioè il passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso, può sperimentarsi facilmente versando un po’ d’acqua in un piattino collocato sul davanzale della finestra e lasciandola evaporare naturalmente.
Al termine delle attività laboratoriali, proponiamo agli alunni una scheda che li aiuti ad acquisire la capacità di rappresentare conoscenze con schematizzazioni.
Scheda 25 Sperimento… i passaggi di stato!
• Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale T5
Dopo aver ricordato la differenza tra materia organica (composta di sostanze organiche, cioè sostanze che sono esseri viventi o derivano da essi, come la farina, l’olio, il latte) e materia inorganica (composta di sostanze inorganiche, che sono tutte le altre sostanze che si trovano in natura), riproponiamo la fondamentale classificazione tra viventi (che nascono, si nutrono, crescono, si riproducono e muoiono) e non viventi, e l’ulteriore classificazione degli esseri viventi in animali e vegetali.
Le classificazioni dei viventi
Gli scienziati classificano i viventi tra: organismi unicellulari (che sono formati da una sola cellula) e organismi pluricellulari (che sono formati da più cellule); organismi procarioti (nelle cui cellule non si osserva il nucleo) e organismi eucarioti (nelle cui cellule c’è il nucleo); organismi autotrofi (che sono capaci di produrre da soli il proprio nutrimento) e organismi eterotrofi (che si nutrono di altri esseri viventi).
Sulla base di questi ulteriori criteri sono stati individuati ben cinque regni: gli organismi unicellulari procarioti, come alcuni tipi di alghe e i batteri, formano il regno delle monere; gli organismi unicellulari eucarioti, come le amebe e i parameci, formano il regno dei protisti; gli organismi pluricellulari eucarioti privi di clorofilla, perciò eterotrofi, che si nutrono per assorbimento, formano il regno dei funghi, a cui a appartengono anche lieviti e muffe; gli organismi pluricellulari eucarioti provvisti di clorofilla, perciò autotrofi, formano il regno

delle piante; gli organismi pluricellulari eucarioti eterotrofi che si nutrono per ingestione di altri organismi formano il regno degli animali.
LABORATORIO Costruiamo un album fotografico dei viventi
Proponiamo agli alunni di costruire un album fotografico murale sui viventi.
Dividiamo la classe in cinque gruppi a ognuno dei quali assegniamo il compito di ricercare immagini o realizzare illustrazioni di uno dei regni dei viventi. Distribuiamo a ogni gruppo un cartoncino di colore diverso nel quale gli alunni ritaglieranno dei riquadri che faranno da cornice alle immagini scelte. Suggeriamo l’aggiunta di didascalie con il nome e le caratteristiche, a corredo delle immagini.
Incollando i cartoncini uno accanto all’altro, realizziamo un efficace album murale dei viventi.
Schede 26 Cinque regni per i viventi 12 Viventi o non viventi?
• Riconoscere le relazioni tra le componenti di un ecosistema T5
È prioritario che gli alunni comprendano che i viventi coesistono in ambienti in cui la vita di ogni organismo è in relazione con le altre forme di vita, perciò anche quest’anno scolastico presentiamo il concetto di ecosistema. Un ecosistema è costituito dalla comunità biologica, cioè l’insieme degli esseri viventi che popolano un ambiente, e dal biotopo, cioè l’ambiente con le sue caratteristiche fisiche e chimiche, ma anche dall’insieme delle relazioni tra gli esseri viventi (come tra predatore e preda).
Coinvolgiamo la classe in una simpatica attività, distribuendo fotografie di diversi ecosistemi e invitando gli alunni a ritagliare tutti i viventi: ciò che rimane è la componente abiotica dell’ecosistema, cioè la parte senza vita di un ecosistema, costituita dai fattori fisici e chimici di un ambiente, come l’aria, la luce, la temperatura, l’umidità, il suolo. La componente biotica, cioè la parte vivente di un ecosistema, è costituita da tutti gli organismi vegetali e animali che vi abitano. Successivamente sollecitiamo gli alunni a riflettere sui diversi rapporti che possono riscontrarsi tra le specie in un ecosistema.
I rapporti tra le specie in un ecosistema
Nel mutualismo c’è una simbiosi tra le specie, necessaria per la sopravvivenza di entrambe. Nella protocooperazione tra le specie c’è una forma di collaborazione vantaggiosa, ma non essenziale per la loro sopravvivenza. Nel commensalismo si riscontra una relazione vantaggiosa per una specie che non procura né danno né beneficio ad un’altra. Nella competizione due o più organismi, che vivono in un ambiente in cui non ci sono risorse sufficienti, si contendono il nutrimento, la luce, il riparo, l’acqua ecc. Nella predazione una specie si nutre dell’altra: il predatore si nutre della preda. Nel parassitismo un organismo, il parassita, vive a spese di un altro organismo, l’ospite, e lo indebolisce, generalmente senza ucciderlo perché dal suo rimanere in vita dipende anche la sopravvivenza del parassita.
Per rendere più divertente lo svolgimento di quest’obiettivo coinvolgiamo gli alunni in una rappresentazione teatrale in cui essi, recitando nei ruoli di cooperazione o di conflitto, colgano efficacemente le caratteristiche dei diversi tipi di rapporti tra le specie in un ecosistema.
Schede 27 Nemici nell’ecosistena 13 I viventi nell’ecosistema • 14 Amici nell’ecosistema
Antologia
Letture pagg. 134-135
Schede operative Italiano
Schede da 1 a 5 pagg. 136-142
Storia
Schede da 6 a 9 pagg. 143-146
Geografia
Schede da 10 a 13 pagg. 147-150
Matematica
Schede da 14 a 23 ............................................................................................... pagg. 151-160
Scienze
Schede da 24 a 27 pagg. 161-164
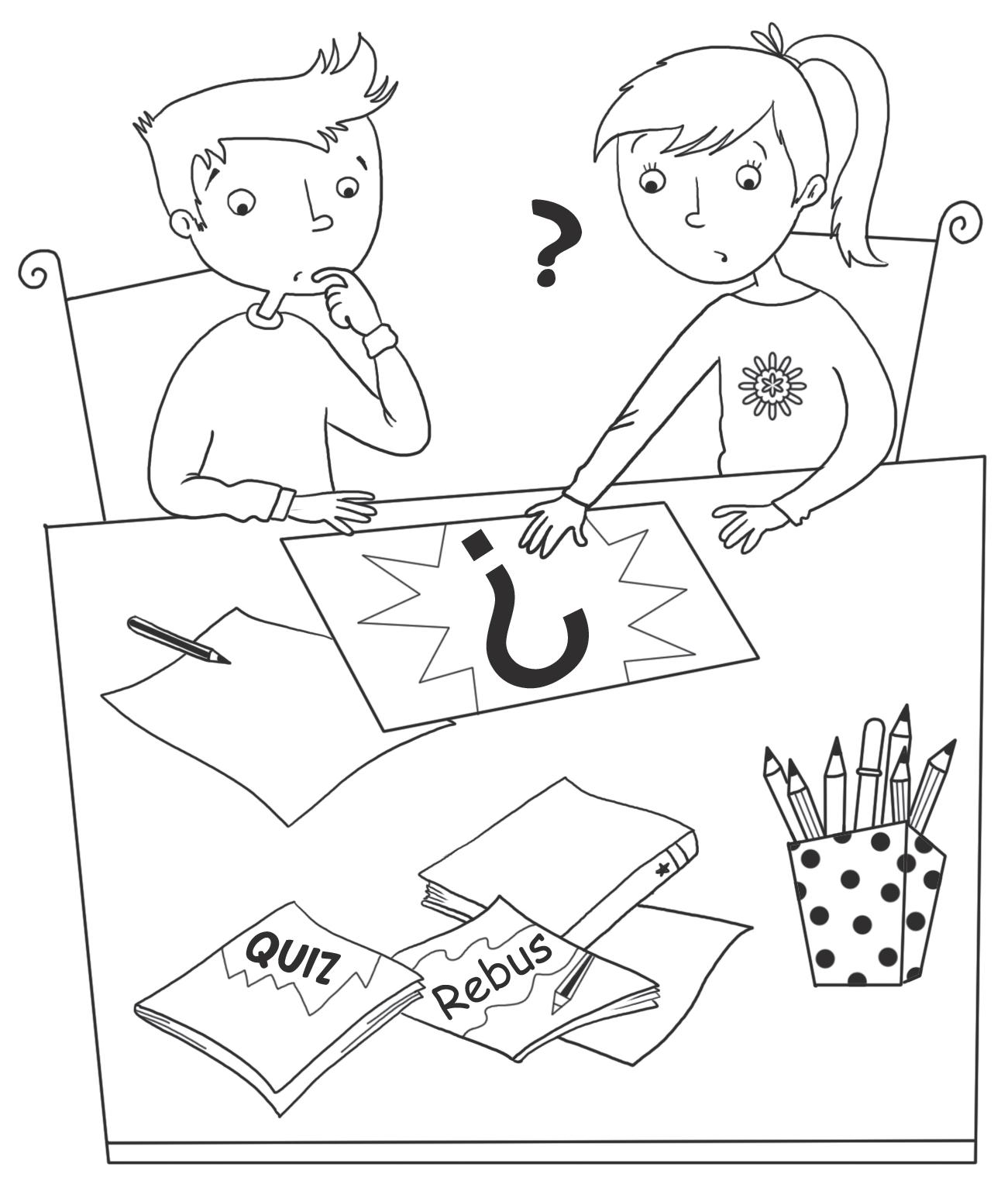
Settembre


Chiaro cielo di settembre illuminato e paziente sugli alberi frondosi sulle tegole rosse fresca erba su cui volano farfalle come i pensieri d’amore nei tuoi occhi giorno che scorri senza nostalgie canoro giorno di settembre che ti specchi nel mio calmo cuore.
A. Bertolucci, La capanna indiana, Garzanti
Come agosto finisce
Come agosto finisce la mattina, dopo una notte di pioggia si sente (il cielo è più profondo) che l’autunno Sta per venire, ci si guarda intorno, e non si sa che fare, tutto è fresco, rinnovato da uno smalto malinconico di perplessità. Sappiamo che c’è tempo, ma che pure, l’anno dovrà morire, ed il bel cielo, il verde verniciato delle piante, l’incudine che suona di lontano, lento cuore del giorno, tutto parla d’una partenza prossima, un addio.
A. Bertolucci, La capanna indiana, Garzanti
La casa delle farfalle
Settembre andava per la valle tirandosi dietro gli ori suoi lento come al giogo i buoi, e noi abitavamo felici la casa che tu dici delle farfalle.
Le farfalle errano senza fine leggiadre candide cenerine gialle cerulee verdine: vestite di seta e mussoline, così fragili, così fine. Trepidavano in fola ai vetri, sfioravano tende e pareti: di semplici e cheti giri di danza empievano l’estatica stanza: finché sazie del moto perenne si posavano: ed erano gemme.
A.S. Novaro, www.poesie.reportonline.it
Laura e Massimo sono due fratelli gemelli. Abitano a Londra con mamma e papà.
Quando sono in vacanza si divertono a vivere mille avventure e a visitare città e paesi nuovi. Quest’estate, però, la passeranno in una casa di campagna, in un paesino, Stonecross. Laura e massimo non sono per niente contenti.

Scheda n° 1
In campagna… che noia! La casa, poi, è proprio in mezzo a un campo.
– Che cosa ci facciamo noi in mezzo a un campo? – chiede Laura.
– Chissà perché andiamo proprio lì… – aggiunge Massimo.

Una ragione c’è: papà e mamma desiderano una vacanza tranquilla. Papà è molto stanco e ha solo voglia di riposare e alla mamma piace l’idea di poter passeggiare nel verde e dipingere con tranquillità.
– Stonecross è una bellissima località della campagna inglese, piena di cultura, tradizioni, mistero! – interviene la mamma.
È arrivato il giorno della partenza. Dopo due ore di viaggio in auto la famiglia arriva a Stonecross. La casa è davvero in mezzo a un campo. Intorno, oltre il campo, altre villette, fiori, prati, pecore e mucche, verdi colline.
Il paesino non è niente di che. Nella piazzetta ci sono l’ufficio postale, il panettiere, il droghiere, il giornalaio e qualche altro negozietto.
Il giorno dopo la famiglia sale in auto per andare a vedere Stonehenge: in una grande vallata, enormi pietre sono disposte in circolo, intorno c’è uno steccato. Molti turisti scattano fotografie. Non ci si può avvicinare troppo: le pietre non possono assolutamente essere toccate, sono un monumento unico al mondo.
– Prendiamo un’audioguida – suggerisce la mamma.
– Ascoltiamo la storia di Stonehenge. È un posto veramente eccezionale!
Adatt. da Vacanze a Stonecross, Theorema libri


Antologia pag 135

– Che cosa ci facciamo noi in mezzo a un campo? – chiede Laura. – Chissà perché andiamo proprio lì… – aggiunge Massimo. Una ragione c’è: papà e mamma desiderano una vacanza (tranquilla - sfrenata - misteriosa). Papà è molto stanco e ha solo voglia di riposare e alla mamma piace l’idea di poter passeggiare nel verde e (nuotare - lavorare - dipingere) con tranquillità.
– Stonecross è una bellissima località della campagna inglese, piena di cultura, tradizioni, mistero! – interviene la mamma.
È arrivato il giorno della partenza. Dopo due ore di viaggio in auto la famiglia arriva a Stonecross. La casa è davvero in mezzo a un campo. Intorno, oltre il campo, altre villette, fiori, prati, (delfini e balene - pecore e mucche - tigri e leoni), verdi colline.
Il paesino non è niente di che. Nella (villetta - piazzetta - stradina) ci sono l’ufficio postale, il panettiere, il droghiere, il giornalaio e qualche altro negozietto.
Obiettivi:

Il giorno dopo la famiglia sale in auto per andare a vedere Stonehenge: in una grande vallata, enormi (pietre - statue - fontane) sono disposte in circolo, intorno c’è uno steccato. Molti (guardiani - giocatori - turisti) scattano fotografie. Non ci si può avvicinare troppo: le pietre non possono assolutamente essere toccate, sono un (museo - monumento - parco) unico al mondo.
– Prendiamo (un ascensore - un’audioguida - un altoparlante) – suggerisce la mamma.
– Ascoltiamo la storia di Stonehenge. È un posto veramente (eccezionale - noioso - stretto)!
Adatt. da Vacanze a Stonecross, Theorema libri
2 Rispondi alle domande.
a. Dove preferisci trascorrere le vacanze? .....................................................................................................................................................................
b. Che cosa ti piace fare in vacanza? Preferisci una vacanza tranquilla o avventurosa? Perché?
c. Ti piace la campagna? Perché?
d. Quest’estate hai visitato un luogo interessante per la sua cultura e le sue tradizioni? Quale?
e. Che cos’è un’audioguida? L’hai mai utilizzata? In quale occasione?
f. Ricerca informazioni su Stonehenge.

1 Inserisci nel testo le parole mancanti che trovi nel finale della fiaba.
C’era una fiaba sbadata che si perdeva le parole. Così, quando doveva raccontarsi, saltava le parole perdute e nessuno la capiva.
La sua storia, infatti, la raccontava così:
Una volta un che si stancava a volare, si posò su un ............................... che sporgeva sull’autostrada e fermò un ............................................... che passava.
– Dove potrei un aeroplanino? – chiese.
– Che pretese assurde – rispose il signore severamente.
– La natura ti ha per volare, perciò le ali e .
L’uccellino lo guardò divertito.
– E lei – disse – la non l’ha creato per ?
– Cosa ............................................... dire? – rispose l’uomo.
– Non ti ............................................... .
Riavviò il , premette il sull’acceleratore e si allontanò sulla sua .
Un’altra fiaba, assai gentile, ritrovate le parole perdute dalla collega, le raccolse e gliele restituì. Ma siccome le aveva messe in un sacchettino, gliele restituì alla rinfusa. Erano queste: auto • camminare • capisco • comprare • creato • motore • natura • piede • ramo • signore • usa • vola • vuoi • uccellino
La fiaba sbadata sta ancora cercando di rimetterle al loro posto. Come voi, sicuramente.
Da M. Argilli, Storie del tic-tac, Editori Riuniti
Obiettivo: Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.

2 Segna con le ✗ le risposte giuste.
a. Nel testo puoi sostituire la parola “sbadata” con: sbagliata distratta fantastica sbalordita
c. “Premette” è una voce del verbo: prendere promettere premettere premere
e. La parola “motore” è un: nome aggettivo pronome verbo
g. La parola “autostrada” è un nome: collettivo derivato alterato composto
b. Nel testo puoi sostituire l’espressione “alla rinfusa” con: senza ordine con forza che fa le fusa rinchiuse
d. “Raccolse” e “ restituì” sono verbi al tempo: passato prossimo imperfetto passato remoto trapassato prossimo
f. Le parole “severamente” e “sicuramente” sono: nomi aggettivi verbi avverbi
h. La parola “assurde” è un: nome aggettivo pronome verbo
3 Completa il testo con i verbi al tempo presente.
C’ ........... una fiaba sbadata che si per.................. le parole. Così, quando d.................. raccontarsi, salt........... le parole perdute e nessuno la cap...................... .
Un’altra fiaba, assai gentile, ritrovate le parole perdute dalla collega, le racc e gliele restitu . Ma siccome le messe in un sacchettino, gliele restitu alla rinfusa.
Obiettivo: Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.

Segui le indicazioni per descrivere la foto che hai scattato durante le vacanze. Nello spazio sottostante incolla un lembo della foto o disegna un particolare di una località che hai visitato.
Qual è il nome del luogo che hai visitato?
Chi, che cosa ritrae la tua la tua foto?
Che cosa si vede in primo piano?
E al centro?
Che cosa si vede in secondo piano?
E sullo sfondo?
Che cosa si vede ai lati della foto?
Che cosa si vede in alto?
E in basso?
Quali colori spiccano nella foto?
Quali ricordi suscita in te la foto?
Ti è piaciuta la località che hai visitato? Perché?
Durante le vacanze sono stato
La mia foto ritrae
In primo piano
Obiettivo: Produrre testi sostanzialmente corretti, legati a scopi concreti.

Segui le indicazioni per raccontare come hai trascorso il giorno più bello delle tue vacanze.
Inizio Quando? Dove? Chi?
Sviluppo
Che cosa è successo?
Finale Come si è conclusa la giornata?
Giudizio
Che cosa hai provato?
Perché ti è piaciuta la giornata?
Obiettivo: Produrre testi sostanzialmente corretti, legati a scopi concreti.

• Classe quinta ©
Segui le istruzioni per scoprire la frase nascosta nello schema.
A IMPARO LETTURA SCRITTO CANTANTE HANNO ESSERE ANNO È
B : ! . ; ? … “ ,
C DELLA AGLI NELLE SULLO DI ALLA NEL DAL
D ENTRÒ SCRIVI SONO SUONA SALIAMO CORRETE EBBERO DIREI
E IL LO LA I GLI LE IN L’
F IL SCHEMA ESTIVA EGLI TORNA CON SEMPRE EVVIVA
G SCUOLA VACANZE INSEGNANTI FELICE CLASSE COMPAGNI FELICITÀ FESTA
H TRE QUINTA CINQUE CINQUECENTO UNO QUINDICI DUE CINQUANTA
I CLASSE ITALIA MITO LEGGENDE ATTORI TIGRI MONDO ANDREA
Nella riga F evidenzia l’esclamazione.
Nella riga B evidenzia il punto esclamativo.
Nella riga D evidenzia la voce del verbo essere.
Nella riga G evidenzia l’aggettivo qualificativo.
Nella riga C evidenzia la preposizione semplice.
Nella riga A evidenzia il verbo al modo infinito.
Nella riga E evidenzia la preposizione.

Nella riga I evidenzia il nome comune, femminile, singolare.
Nella riga H cancella gli aggettivi numerali cardinali.
Scrivi qui la frase nascosta.
Obiettivo: Riconoscere le fondamentali convenzioni di scrittura e le principali parti del discorso.

1 Numera da 1 a 5 le fasi in cui si articola il metodo storico.
Racconto dei fatti analizzati.
Ricerca, analisi e interpretazione delle fonti.
Collocazione dei fatti nel tempo e nello spazio.
Individuazione di collegamenti tra fatti.
Ricostruzione di fatti.
2 Analizza le seguenti fonti e scrivi tutte le informazioni che ne ricavi.

Fonte: tavoletta sumerica in argilla.
È scritta in caratteri . I caratteri sono incisi su una tavoletta di .................................. .
Informazioni:
I Sumeri conoscevano la e scrivevano in caratteri ................................................. su ............. di .

3 Rispondi.
Fonte: maschera fenicia in pasta di vetro.
È realizzata in ................................................. . Raffigura .
Informazioni:
I Fenici lavoravano il ed erano raffinati che realizzavano preziosi manufatti.
Che cosa significa produrre informazioni da una fonte storica?

1 Osserva la carta geo-storica e inserisci nel luogo giusto i numeri corrispondenti alle civiltà.
1 Civiltà mesopotamica 2 Civiltà egizia 3 Civiltà indiana
4 Civiltà fenicia 5 Civiltà ebraica 6 Civiltà cretese 7 Civiltà micenea

2 Rispondi.
Quali civiltà si sono sviluppate soprattutto lungo i corsi dei fiumi?
Quali attività economiche furono favorite dall’insediamento delle popolazioni lungo le rive dei fiumi?
Quali civiltà si sono sviluppate lungo le coste del Mar Mediterraneo?
Quali attività economiche furono favorite dall’insediamento delle popolazioni lungo le coste?
Obiettivo: Usare una carta geo-storica.

1 Scrivi accanto a ogni civiltà il nome del fiume o dei fiumi sulle cui sponde si sviluppa.
Civiltà mesopotamica:
Civiltà egizia:
Civiltà indiana:
Civiltà cinese:
2 A quali civiltà appartengono le seguenti immagini? Scrivi nel quadratino il numero della civiltà corrispondente.
1 Civiltà mesopotamica 2 Civiltà egizia 3 Civiltà indiana 4 Civiltà cinese
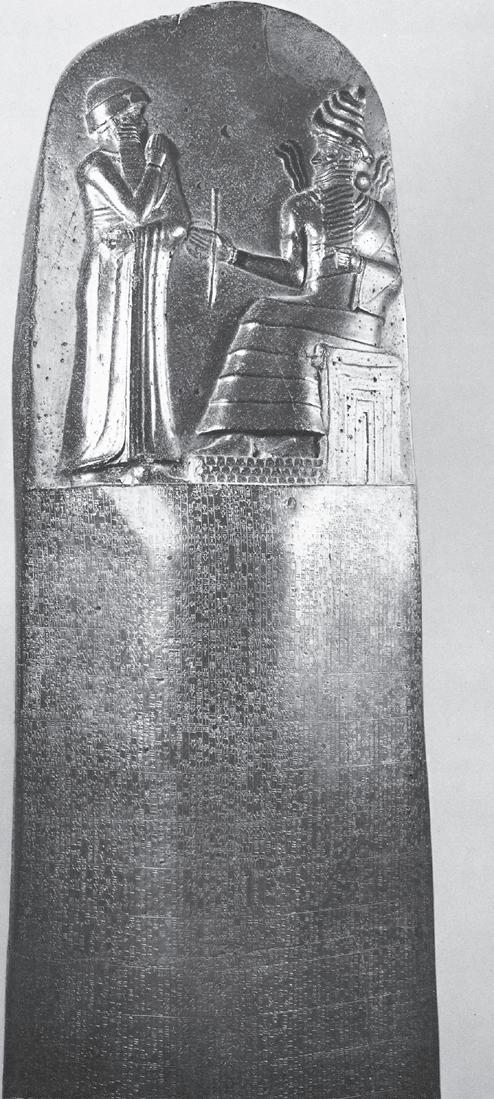






1 Colora i riquadri seguendo le indicazioni: in rosso i riquadri con le parole della civiltà fenicia; in giallo i riquadri con le parole della civiltà ebraica; in azzurro i riquadri con le parole della civiltà cretese; in verde i riquadri con le parole della civiltà micenea.
Porpora Canaan Porta dei Leoni Filistei Acropoli Cnosso Ascia bipenne Torah Vetro di Sidone Abramo Labirinto Troia
Giordano Cedro Gerusalemme Minotauro Menorah Esodo
Peloponneso Minosse Tauromachia Profeta Cartagine Biblo
2 Osserva le immagini e completa le descrizioni.
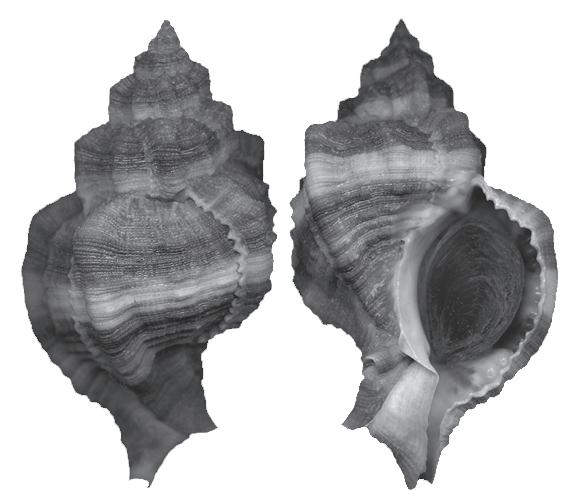

È un Murex trunculus, da cui si estraeva la , che ha reso famosa la civiltà .
È la , un grande candelabro a sette bracci, simbolo religioso della civiltà .

È un’ , presente anche in affreschi dei lussuosi palazzi, ed è caratteristica della civiltà .
È la famosa , incisa su una lamina d’oro, simbolo della civiltà .
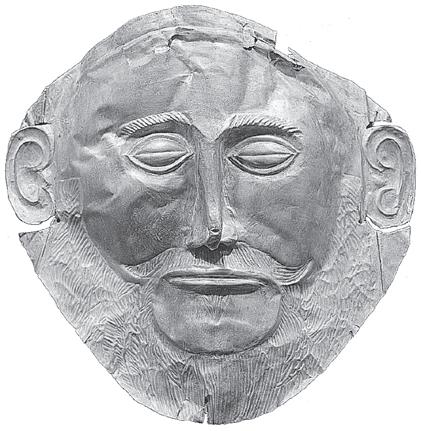
Obiettivo: Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate.

1 Completa la definizione di Geografia, inserendo al posto giusto le parole elencate nel riquadro.
antropici • fisici • graficamente • luoghi • relazioni
La Geografia è una scienza che si occupa di rappresentare dei , di descriverli e di cogliere le tra gli aspetti e naturali di un ambiente e quelli , introdotti dall’uomo.
2 Segna con una ✗ il tipo di elemento geografico raffigurato.
È un elemento fisico.
È un elemento naturale.
È un elemento antropico.
È un elemento fisico.
È un elemento naturale.
È un elemento antropico.
È un elemento fisico.
È un elemento naturale.
È un elemento antropico.
È un elemento fisico.
È un elemento naturale.
È un elemento antropico.
È un elemento fisico.
È un elemento naturale.
È un elemento antropico.
È un elemento fisico.
È un elemento naturale.
È un elemento antropico.
3 Numera da 1 a 4 le fasi in cui si articola il metodo di lavoro del geografo.
Raccolta e analisi dei dati sul luogo.
Documentazione del luogo da studiare.
Descrizione del luogo attraverso parole e immagini.
Osservazione diretta o attraverso fotografie del luogo da studiare.
Obiettivo: Conoscere e utilizzare il metodo di lavoro del geografo.

1 Completa le descrizioni delle immagini geografiche.


È un .................... .
Il è un d’acqua perenne, che nasce in un punto denominato e sbocca nel mare con una che può essere a o a .
È un
Il è una massa d’ , di solito ...................., raccolta in una cavità del terreno. Riceve le sue acque da un fiume .............................. , dallo scioglimento di un , dalle precipitazioni o da ......................... sotterranee.

2 Rispondi.
Che cos’è l’idrografia?
È un .................... .
Il .................... è un’immensa distesa di acqua che circonda i continenti e le isole di tutto il mondo. È alimentato soprattutto dai , che vi riversano anche i minerali assorbiti dalle rocce e dai terreni in cui scorrono.
Obiettivo Riconoscere e analizzare i principali caratteri fisici di un territorio.

....................................................
1 Rispondi.
Che cos’è l’orografia? .............................................................................................................................
Che cos’è l’altitudine? ............................................................................................................................
2 Completa le descrizioni delle immagini geografiche.

È una .
La è un rilievo naturale con un’ ........................... compresa tra i 300 e i metri.

È una ...................................................... .
La è un’ampia distesa di leggermente ondulato e in lieve pendenza che non supera i metri di altitudine. È una .

La è un rilievo naturale, costituito di terra e , di altezza variabile a partire da almeno metri di .
Obiettivo: Riconoscere e analizzare i principali caratteri fisici di un territorio.

1 In ogni grafico è rappresentata la regione con la maggior percentuale di superficie occupata rispettivamente da montagne, colline e pianure. Osserva i grafici e rispondi.
Quale tipo di grafico è utilizzato per rappresentare i dati?
In quale regione c’è la maggior percentuale di pianure? E di colline?
di montagne?
In che percentuale le pianure italiane sono presenti in Lombardia?
2 Riporta i dati dell’areogramma a torta nell’areogramma quadrato, che è diviso in 100 quadratini uguali. Colora in marrone i quadratini corrispondenti alle montagne, in giallo quelli corrispondenti alle colline e in verde quelli corrispondenti alle pianure.

1 Osserva le figure e completa gli enunciati utilizzando una di queste parole: “tutti”, “alcuni”, “nessuno”, “almeno uno”, in modo che le frasi diventino vere.
sono poligoni. hanno 4 angoli retti.
ha 5 lati.
è un triangolo.
2 Individua, tra le seguenti frasi, quelle che possono essere considerate enunciati logici e colora di verde il quadratino corrispondente. Infine assegna il valore di verità a ogni enunciato.
Napoli si trova in Sicilia.
V F
16 non è multiplo di 3. V F
Mi piace mangiare la frutta. V F
L’angolo retto misura 90°. V F
In Australia vivono i canguri. V F
Avrò studiato bene l’argomento? V F
Marzo ha 30 giorni. V F
3 Rappresenta un insieme di numeri per il quale risultino veri tutti i seguenti enunciati.
Tutti sono numeri minori di 28. Nessuno è pari.
Alcuni sono multipli di 3. Almeno uno ha la cifra 2 al posto delle decine.

1 Scrivi in cifre i seguenti numeri. tremilaottocentododici duecentonovemila cinquecentomilaventiquattro diecimiladodici centoduemilanovanta
2 Scrivi in lettere i seguenti numeri sottolineando con la penna rossa il gruppo di lettere “mila” in ogni numero.
7 305
2 010 13 900
500 050
800 400
571 270 ......................................................................................................................................
3 Scomponi i seguenti numeri.
246 581
305 107 819 365
4 Indica il valore della cifra 5 in ciascuno dei seguenti numeri. 5 870 ............................................... 576 870 ...............................................
352 890 3 561
5 Scrivi il valore della cifra sottolineata e completa.
234 567 la cifra 4 vale = 4 unità
667 310
128 536 ......................................................................................................................................
Obiettivo: Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci fino alle centinaia di migliaia, indicando il valore di ogni cifra.

1 Rappresenta le seguenti frazioni.
2 Indica le parti colorate di ogni figura con una frazione e poi scrivila a lettere.
3 Scrivi la frazione che rappresenta la parte colorata e completa con la frazione complementare.
4 Scrivi accanto a ogni frazione la sua complementare.

1 Trasforma le frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.
2 Leggi il numero in lettere e scrivilo in cifre. ventisette decimi 5 cinquanta millesimi 5 sei centesimi 5 trecentoundici centesimi 5
3 Scrivi in lettere i seguenti numeri decimali.
4 Confronta i seguenti numeri decimali inserendo i segni ., , oppure 5 . 1,5 2
5 Ordina i seguenti numeri dal minore al maggiore.

Esegui

Esegui

Risolvi i problemi.
1. La biblioteca del mio paese comprende una bella collana di 150 romanzi per ragazzi. Attualmente ne mancano 28 perché sono in rilegatura. Quanti ne restano? Se ogni volume ha un prezzo di € 7,50, quanto vale l’intera collana?
2. Nei mesi di luglio e agosto Andrea ha eseguito tutti i compiti per le vacanze. Esclusa una decina di giorni di festa, ogni giorno ha completato lo stesso numero di pagine del suo libro che in totale ne ha 156. Quante pagine ha completato al giorno?
Obiettivo: Risolvere problemi con due domande e due operazioni.

1 Ripassa con il rosso le rette, con il verde le semirette, con il giallo i segmenti.
2 Segna con una ✗ l’opzione corretta. a
retta semiretta segmento
retta semiretta segmento
retta semiretta segmento
rette parallele rette perpendicolari
rette parallele rette perpendicolari
3 Osserva gli angoli e specifica se sono acuti, retti, ottusi, piatti o giri.

1 Osserva i triangoli e classificali seguendo le indicazioni delle tabelle.
Triangoli
Equilateri Isosceli
Scaleni Triangoli Rettangoli Acutangoli Ottusangoli
2 Colora di giallo i trapezi, di verde i parallelogrammi e scrivi il nome accanto a ciascun quadrilatero.

1 Completa le seguenti tabelle.
Lunghezza
2 Scrivi il valore delle cifre sottolineate.
3 Scomponi indicando il valore di ogni cifra.
4 Esegui le equivalenze.

1 Numera da 1 a 6 le fasi in cui si articola il metodo scientifico-sperimentale.
Progettazione di un esperimento per verificare l’esattezza dell’ipotesi.
Osservazione di un fenomeno.
Realizzazione dell’esperimento che può avere esito positivo o negativo.
Individuazione di un problema e formulazione di una domanda.
Formulazione della legge scientifica se l’esperimento ha esito positivo.
Elaborazione di un’ipotesi per spiegare il fenomeno stesso.
2 Leggi il testo e cancella la parola sbagliata in ogni coppia.
Osservazione di un fenomeno
Il palloncino gonfio è più leggero/pesante del palloncino sgonfio.
Formulazione di una domanda
Perché il palloncino gonfio/sgonfio è più pesante?
Elaborazione di un’ipotesi per spiegare il fenomeno stesso
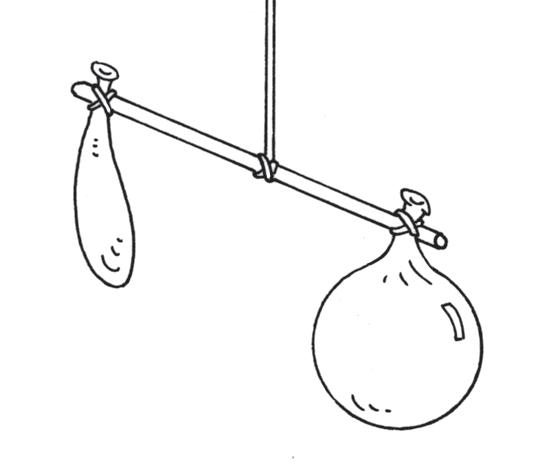
Il palloncino sgonfio è più leggero/pesante perché contiene/non contiene aria e l’aria ha/non ha peso.
Progettazione di un esperimento per verificare l’esattezza dell’ipotesi
Progetta un esperimento con dei palloncini per verificare l’esattezza/inesattezza dell’ipotesi.
Realizzazione dell’esperimento per verificare l’esattezza dell’ipotesi
Gonfia due palloncini in modo che abbiano la stessa grandezza e legali con un filo alle estremità di una cannuccia.
La tua bilancia è in disequilibrio/equilibrio perché i due palloncini pesano in modo diverso/uguale. Fai scoppiare il palloncino di sinistra e osserva. Si verifica la situazione illustrata nell’immagine in alto: il palloncino gonfio è più leggero/ pesante del palloncino sgonfio poiché contiene/non contiene l’aria.
Formulazione della legge scientifica
L’aria ha/non ha un peso.

Obiettivo: Esplorare i fenomeni naturali con metodo scientifico.

1 Osserva le illustrazioni e segna con una ✗ il passaggio di stato che si è verificato.






Solidificazione. Vaporizzazione. Sublimazione. Fusione. Condensazione. Vaporizzazione. Fusione. Brinamento. Sublimazione. Condensazione. Solidificazione. Vaporizzazione.
2 Completa la schematizzazione dei passaggi di stato.
stato solido stato gassoso calore sublimazione + =
stato solido calore fusione + =
stato liquido calore vaporizzazione + =
stato liquido calore solidificazione – =
stato gassoso calore condensazione – =
stato gassoso calore brinamento – =
3 Rispondi.
Che cosa determina i passaggi di stato della materia?
La variazione della quantità di luce che colpisce la materia.
La variazione della quantità di calore posseduta dalla materia.
La variazione della quantità di molecole che formano la materia.
Obiettivo: Sperimentare e schematizzare passaggi di stato della materia.

1 Per ogni definizione colora il completamento giusto.
Gli organismi unicellulari sono: formati da una sola cellula. formati da più cellule.
Gli organismi pluricellulari sono: formati da una sola cellula. formati da più cellule.
Gli organismi procarioti hanno le cellule in cui: il nucleo non è ben delimitato. c’è il nucleo.
Gli organismi eucarioti hanno le cellule in cui: il nucleo non è ben delimitato. c’è il nucleo.
Gli organismi autotrofi: producono da soli il proprio nutrimento. si nutrono di altri esseri viventi.
Gli organismi eterotrofi: producono da soli il proprio nutrimento. si nutrono di altri esseri viventi.
2 Collega ogni regno alla sua descrizione.
Organismi unicellulari procarioti, come i batteri e alcuni tipi di alghe.



Organismi pluricellulari eucarioti provvisti di clorofilla, perciò autotrofi.


Monere Piante Animali Funghi Protisti
Organismi unicellulari eucarioti, come le amebe e i parameci.
Organismi pluricellulari eucarioti privi di clorofilla, perciò eterotrofi, che si nutrono per assorbimento.
Organismi pluricellulari eucarioti eterotrofi che si nutrono per ingestione.
Obiettivo: Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale.

1 Leggi e completa il testo, inserendo al posto giusto le parole elencate nel riquadro.
ambiente • competizione • ospite • parassita • predazione • parassitismo • risorse • sopravvivenza
Nella una specie si nutre dell’altra.
Nella due o più organismi, che vivono in un in cui non ci sono sufficienti, si contendono il nutrimento, la luce, il riparo, l’acqua ecc.
Nel un organismo, il parassita, vive a spese di un altro organismo, l’ lo indebolisce, generalmente senza ucciderlo, perché dalla sua dipende anche quella del .
2 Leggi e completa i riquadri.

Il ghepardo sta inseguendo la gazzella. Il ghepardo è un animale

La sanguisuga è un anellide che si attacca al corpo di altri animali e si nutre del loro sangue. È un animale .
Obiettivo: Riconoscere le relazioni tra le componenti di un ecosistema.