Guida didattica per la scuola primaria
Matematica Italiano
Stor
Geografia
Scienze
Tecnologia
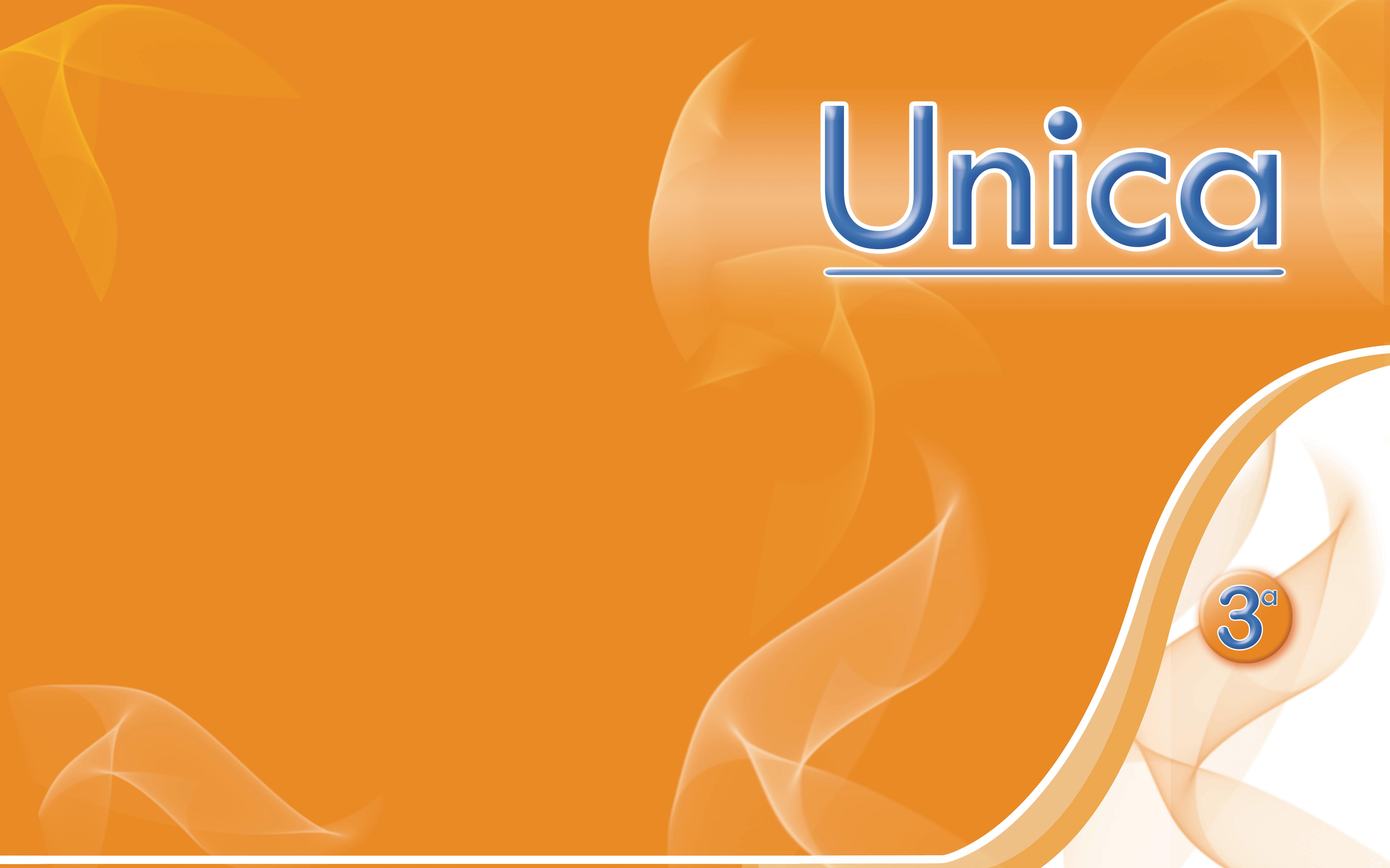
Educazione
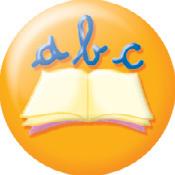


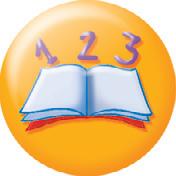

















N o m e
C o g n o m e
S c u o l a
L . M i s a s i • D. M o l i n o • E . Po n t i c e l l i
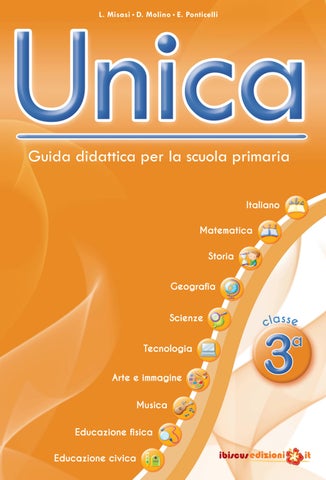
Matematica Italiano
Stor
Geografia
Scienze
Tecnologia
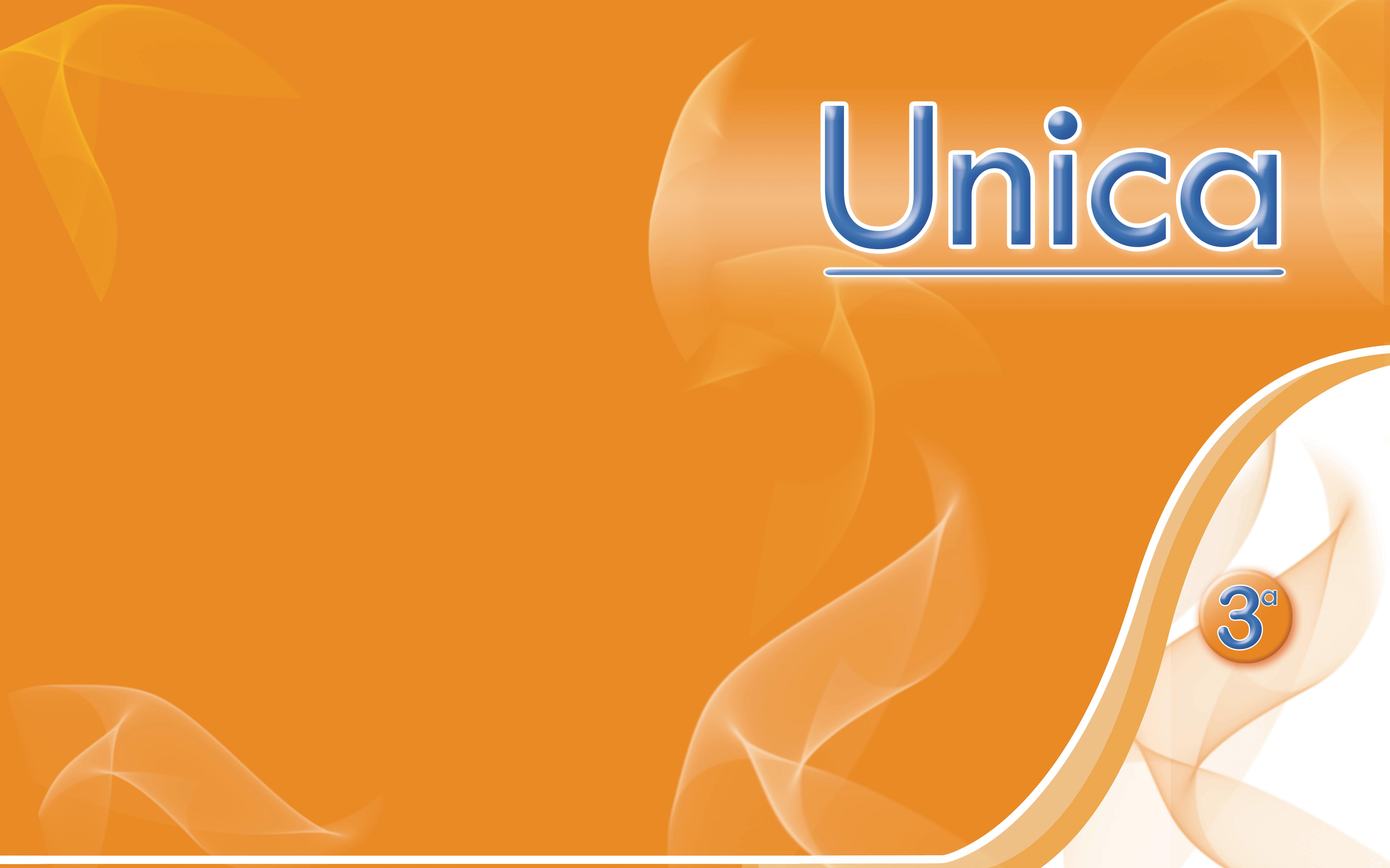
Educazione
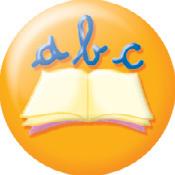


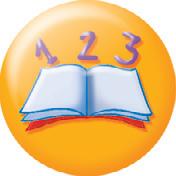

















N o m e
C o g n o m e
S c u o l a
L . M i s a s i • D. M o l i n o • E . Po n t i c e l l i
G u i d a d i d a t t i c a p e r l a s c u o l a p r i m a r i a
A n n o s c o l a s t i c o

lo sviluppo delle
SETTEMBRE
Pronti per la terza
Proposte metodologiche
99
Raccontare esperienze vissute e storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie........ 099
Esprimere opinioni, sentimenti e stati d’animo.......................... 100
Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.......................................................... 100
Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali................................................................................ 101
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le loro relazioni.......................................................................... 101
Produrre testi per esprimere sentimenti, stati d’animo, opinioni........................................................................................................................ 102
Produrre testi per raccontare vissuti e storie.................................. 102
Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura
Le schede contrassegnate dal simbolo sono state elaborate sulla base della metodologia INVALSI
Riconoscere una storia come successione di fatti...................... 104
Usare in maniera appropriata gli indicatori temporali............ 105
Riconoscere e utilizzare le fonti della storia...................................... 106
Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi nel tempo e nello spazio................................................................ 106 Geografia ...................................................................................................................... 109
Classificare un paesaggio................................................................................
diversi tipi di carte....................................................................
Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali
Leggere e interpretare semplici rappresentazioni cartografiche............................................................................................................ 109 Matematica ................................................................................................................ 111
Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi.......................... 112
Stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco di coppie ordinate e tabelle..........................................................................
e comporre i numeri entro il 100................................
addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio della decina
problemi con l’addizione e con la
le linee in aperte/chiuse, semplici/non semplici
Individuare le regioni che si formano con più confini
n 12 • Riconosco i mesi 135
n 13 • Vacanze a confronto 136 Geografia
n 14 • Costruisco la mappa del tesoro 137
n 15 • Creo un disegno 138 Matematica
n 16 • Insiemi e sottoinsiemi 139
n 17 • Le relazioni tra gli insiemi 140
n 18 • I numeri 141
n 19 • Conto 142
n 20 • Confronto 143
n 21 • Compongo, scompongo, addiziono e sottraggo 144
n 22 • Moltiplico e divido 145
n 23 • Descrivo e risolvo (1) 146
n 24 • Descrivo e risolvo (2) 147
n 25 • Classifico le linee 148
n 26 • Confini e regioni 149 Scienze
n 27 • La ciclicità 150
n. 28 • Esseri viventi e non viventi ............................................................ 151
n. 29 • Conosco gli animali ............................................................................ 152
OTTOBRE • NOVEMBRE
Sperimento, imparo, comunico
Proposte metodologiche Italiano 154
• Ascolto e parlato 157
Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 157
Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 157
Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento e istruzioni per svolgere attività ................ 158
• Lettura .......................................................................................................................... 158
Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura 158
Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni 159
Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 159
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni temporali 160
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e relazioni logiche 161
Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 161
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche 161
Leggere comprendere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: la favola 162
Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni 162
Leggere testi informativi in vista di scopi pratici: l’avviso 162
Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche formali: le rime baciate e alternate 163 • Scrittura 164
Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane: gli ambienti 164
Produrre testi per raccontare vissuti e storie, che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione 164
Produrre testi per raccontare vissuti e storie, che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione: il discorso diretto e indiretto 165
Produrre testi per raccontare vissuti e storie, che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione: la favola 165
Produrre testi regolativi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione: il regolamento 166
Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi
con situazioni quotidiane: l’avviso 166
Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi
con situazioni quotidiane: la relazione 167
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: la filastrocca
Sperimentare tecniche di riduzione del testo ................................ 168
• Acquisizione ed espansion
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
basil
r
del lingu
ggio musicale all’interno di brani
di vario genere e provenienza 171
Arte e immagine 173
• Osservare e leggere le immagini 173
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 173
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 173
Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 173
• Esprimersi e comunicare 174
Elaborare creativamente produzioni personali 174
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 174
Educazione fisica 175
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 176
Usare in modo corretto e consapevole gli arti superiori e inferiori 176
Riconoscere la parte destra e sinistra sugli altri e sugli
oggetti 179
Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo riferimenti diversi da sé (altri e oggetti) ........................................................................ 180
Cogliere la relatività dell’orientamento .............................................. 181
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva .................................................................................................................... 182
Riconoscere i messaggi non verbali espressi mediante il corpo 182 Eseguire giochi mimici 183
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 184
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per affinare la coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 184
Storia 185
• Organizzazione delle informazioni 185
Rappresentare graficamente e verbalmente un fatto vissuto, definendone la durata temporale 185
• Uso delle fonti 186
Individuare tracce e usarle come fonti di tipo diverso per ricavare conoscenze sul passato personale e familiare 186
• Strumenti concettuali 187
Definire la durata temporale di fatti e periodi 187
• Produzione scritta e orale 188
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti 188
Geografia 189
• Orientamento 189
Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante ...................................... 189
Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi utilizzando le proprie carte mentali ........................................................ 190
• Regione e sistema territoriale .................................................................... 191
Comprendere che il terrirorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 191
• Linguaggio della geo-graficità 192
Rappresentare in prospettiva verticale ambienti noti 192
• Paesaggio 192
Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta 192
Matematica 193
• Relazioni, dati e previsioni 195
Comprendere e usare correttamente “ e ” , “ non ” in enunciati 195
Usare i connettivi “ se allora” 196 Individuare l’insieme complementare 196
Usare correttamente “ e ” , “ non ” nelle operazioni di complemento 197
Stabilire e rappresentare relazioni con frecce, elenco di coppie ordinate, tabelle e reticolati 197
Individuare la relazione inversa rispetto alla relazione data 198
• Numeri 198
Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti di 3° ordine) ed esprimere la quantità in numeri, seguendo il criterio posizionale 198
Trasformare in base dieci numeri scritti in basi diverse 202
Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci entro il 999 ................................................................................................................ 205
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 999 .......... 206
Confrontare e ordinare i numeri entro il 999 utilizzando i simboli >, <, = .......................................................................................................................... 206
Scomporre i numeri in centinaia, decine e unità ........................ 207
Comporre numeri espressi in centinaia, decine e unità 207
Conoscere il significato dello 0 nell’addizione 208
Conoscere i termini dell’addizione 209
Conoscere e applicare la proprietà commutativa e la proprietà associativa dell’addizione 209
Eseguire addizioni in colonna con due cambi 210
Conoscere i termini della sottrazione 211
Conoscere il significato dello 0 nella sottrazione 212
Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della sottrazione 212
Eseguire sottrazioni in colonna con due cambi 213
Individuare stati e operatori additivi e inversi 215
Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione 216
Eseguire le prove dell’addizione e della sottrazione 217
Comprendere una situazione problematica attraverso l’analisi e la comprensione del testo 217
Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema 218
Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato dell’addizione 218
Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato della sottrazione (come mancanza, resto e differenza) ...................................................................... 218
• Spazio e figure ..........................................................................................................
Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o un oggetto prendendo come riferimento se stesso
nella realtà figure geometriche solide
Conoscere le caratteristiche dei solidi 221
Riconoscere linee aperte/chiuse, semplici/non semplici 222 Riconoscere linee curve, spezzate, miste 223 Riconoscere linee rette, semirette
n 31 • Il libro perfetto
n 32 • Il castello misterioso
n 33 • Confetti senza confini!
n 34 • Il Mangiasogni
n. 35 • L’aspirapolvere pepato ....................................................................
n 36 • Giufà e la statua
n 37 • In biblioteca
n 38 • Il topo che mangiava i gatti
n 39 • La battaglia navale
n 40 • Corsi di nuoto
n. 41 • Filastrocca della pioggia ..................................................................
n 42 • Sogno
n 43 • L’aula prima e dopo
n 44 • Io racconto
n 45 • Pronto soccorso
n 46 • Discorso diretto 264
n. 47
• Discorso diretto e indiretto ..........................................................
n 48 • Invento una favola
n 49 • Gioco con i compagni
n 50 • Che scienziati!
n 51 • Nomi in rima
n 52 • I funghi di Marcovaldo
n. 53
• So usare la c e la g ..................................................................................
n 54 • So usare gli, gl, li
n 55 • So usare cu, qu, cqu
n 56
• So usare gn e ni
n 57
• So usare sci, sce, scie
n. 58 • So usare le doppie in... autunno ..................................................
n 59 • So usare l’apostrofo
n 60
• So usare l’accento
n 61
• So dividere in sillabe
n 62
• So usare e, è
n 63
• So usare h 282
n. 64 • Metto in ordine... alfabetico .......................................................... 283
n 65
• So usare il dizionario 284
n 66 • So usare la punteggiatura (1) 285 Musica
n 67 • Le note musicali (1) 286
n 68 • Le note musicali (2) 287
Arte e immagine
n 69 • Domenica pomeriggio 288
n. 70 • Paesaggi da favola (1) ........................................................................ 289
n 71 • È autunno! 290
Educazione fisica
n. 72 • Arti superiori e arti inferiori .......................................................... 291
n 73 • Arti superiori e inferiori destri e sinistri 292
n 74 • Sinistra o destra 293
n 75 • Qual è la destra e qual è la sinistra? 294
n 76 • L’orientamento 295
n 77 • Messaggi non verbali 296
Storia
n 78 • Indico il tempo
n. 79 • Ordino il tempo (1)............................................................................
n 80 • Tutto ha una storia (1) 299
n 81 • Tutto ha una storia (2) 300
n 82 • La mia storia nella storia 301
n 83 • Chi è? 302
n 84 • L’archeologo 303
n 85 • Lo storico 304
n 86 • Lo storico sono io 305
n 87 • Le fonti della storia 306
n 88 • Anni e anni 307
n 89 • La storia e i suoi studiosi 308
Geografia
n. 90 • Il percorso di esodo dall’aula ........................................................ 309
n. 91 • Gli ambienti della scuola ................................................................ 310
n 92 • Da casa a scuola
n 93 • Cerca la casa
n 95 • Il geografo e la geografia
n 96 • Il geografo sono io
n 97 • Prova tu
Matematica
n
sottoinsieme
“Il
n 105 • Raggruppa in basi diverse (1)
n 106 • Raggruppa in basi diverse (2)
n 107 • Basi diverse con il B A M (1)
n 108 • Da basi diverse a base dieci (1)
n 109 • Da basi diverse a base dieci (2)
n 110 • Dal B A M al numero
n 111 • Raggruppa per dieci
n 112 • Rappresenta sull’abaco
n 113 • Si conta
n 114 • L’ordine giusto
n 115 • Precede e segue
118 • Scomporre in h, da, u ....................................................................
119 • Il centinaio e la decina
120 • Componiamo i numeri
121 • Lo zero nell’addizione
122 • I termini dell’addizione
n 123 • Le proprietà dell’addizione
n 124 • Addizioni in colonna con due cambi (1)
n 125 • Addizioni in colonna con due cambi (2)
n 126 • I termini della sottrazione
n 127 • Lo zero nella sottrazione
proprietà invariantiva
n 129 • Sottrazioni in colonna con due cambi (1)
n. 130 • Sottrazioni in colonna con due cambi (2) ....................
n. 131 • Cerca lo stato o l’operatore ........................................................
n 134 • Calcoli (1) 353
n 135 • Calcoli (2) 354
n 136 • Addizioni e sottrazioni con la prova 355
n. 137 • Analizzo il testo dei problemi (1).......................................... 356
n 138 • Gioco con i problemi (1) 357
n 139 • Gioco con i problemi (2) 358
n 140 • Tanti problemi per capire l’addizione (1) 359
n. 141 • Tanti problemi per capire l’addizione (2)...................... 360
n 142 • Tanti problemi per capire la sottrazione (1) 361
n 143 • Tanti problemi per capire la sottrazione (2) 362
n 144 • Destra e sinistra 363
n 145 • I solidi nella realtà 364
n 146 • I solidi 365
n 147 • Le caratteristiche dei solidi (1) 366
n 148 • Le caratteristiche dei solidi (2) 367
n 149 • Le caratteristiche dei solidi (3) 368
n 150 • Linee semplici/non semplici 369
n 151 • Linee curve, spezzate, miste 370
n 152 • Rette, semirette, segmenti 371
Scienze
n 153 • Il metodo scientifico 372
n 154 • Chi è?
n 155 • Il botanico e lo zoologo 374
n 156 • Il chimico, l’astronomo e il geologo 375
n 157 • Il compasso e il telescopio 376
n 158 • Sperimentiamo (1) 377
n 159 • Sperimentiamo (2)
n 160 • Fenomeno chimico o fisico? (1) 379
n 161 • Fenomeno chimico o fisico? (2) 380
n 162 • Materia organica e inorganica 381
n. 163 • I tre stati della materia .................................................................... 382
n 164 • La materia 383
n 165 • L’aria e lo spazio 384
n 166 • L’aria e il peso 385
n. 167 • L’inquinamento dell’aria ............................................................ 386
Tecnologia
n. 168 • Mi guardo intorno .......................................................................... 387
n 169 • La storia del petrolio 388
n 170 • La comunicazione (1) 389
n 171 • La comunicazione (2) 390
• Lettura 396
Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura ............................................................................................................ 396
Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali: i dati uditivi 397
Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 397
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni temporali
DIcEMBRE • GENNaIO Momenti mitici
Proposte metodologiche Italiano 392
• Ascolto e parlato .................................................................................................. 395 Ascoltare, comprendere e fornire informazioni 395
Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 395
Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 396
Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato 396
398
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche 398
Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 398
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche
Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: il mito ........................................................................
Leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi: la lettera personale
Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze
Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni
Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche: le onomatopee ..................................................................
399
399
399
400
400
400
401
Produrre testi descrittivi connessi con situazioni quotidiane e/o fantasiose: personaggi reali e fantastici 401
Produrre testi per esprimere emozioni: la lettera personale
401
Produrre testi per raccontare storie che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione 402
Produrre testi per raccontare storie fantastiche: il mito ........ 402
Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane: le istruzioni 403
Produrre testi espositivi per relazionare su argomenti di studio: la ricerca
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: la filastrocca
403
403
Sperimentare tecniche di riduzione del testo 403
• Acquisizione ed esposizione del lessico ricettivo e produttivo 404
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sugli usi della lingua 404
Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: i nomi
404
Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: gli articoli 404
Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: gli aggettivi qualificativi
405
Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: le preposizioni 405
Musica 406
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 406
Arte e immagine 407
• Osservare e leggere le immagini 407
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 407
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 407
Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 407
• Esprimersi e comunicare 408
Elaborare creativamente produzioni personali 408
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 408
Educazione fisica 409
• Il corpo e a sua relazione con lo spazio e il tempo 410
Migliorare il controllo di movimento delle mani nell’uso di oggetti e di attrezzi 410
Prendere coscienza della posizione corretta della colonna vertebrale e del tronco ...................................................................................... 412
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità/successione, prima/dopo, lento/veloce) 413
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre/saltare, afferrare/lanciare 414
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 415
Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il movimento 415
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 416
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per la valutazione della distanza 416
Eseguire giochi presportivi 416
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 417
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 417
Storia 418
• Uso delle fonti 418
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato 418
• Organizzazione delle informazioni 420
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 420
• Produzione scritta e orale 421
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti ............................................................................................ 421
Geografia .................................................................................................................... 423
• Orientamento ........................................................................................................ 423
Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante ...................................... 423
• Linguaggio della geo-graficità 424
Leggere e interpretare carte geografiche 424
• Paesaggio 425
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano l’ambiente 425
Matematica 426
• Relazioni, dati e previsioni 428
Rappresentare l’intersezione di due insiemi 428
Usare correttamente “ e ” , “ non ” nelle operazioni di intersezione 429
Classificare in base a due attributi dati usando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 430
Individuare i criteri adottati in una classificazione rappresentata mediante i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 432
• Numeri 435
Effettuare cambi tra centinaia, decine e unità 435
Conoscere a memoria le tabelline 435
Conoscere il significato dello 0 nella moltiplicazione 436 Eseguire moltiplicazioni in riga 437
Eseguire moltiplicazioni per 10, per 100 con i numeri naturali 438
Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione
Applicare la proprietà distributiva del prodotto rispetto
Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una cifra 443
Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di due cifre 444
Conoscere i termini della moltiplicazione 446
Eseguire la prova della moltiplicazione 446
Distinguere il concetto di divisione come partizione da quello di divisione come contenenza 446
Eseguire divisioni in riga senza e con il resto 447
Individuare, attraverso la tabella della divisione, proprietà e caratteristiche specifiche della divisione 448
Eseguire divisioni per 10, per 100 con i numeri naturali 449
Conoscere i termini della divisione 452
Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza cambio, con e senza resto 452
Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra con il cambio, con e senza resto 453
Individuare stati moltiplicativi e inversi 455
Eseguire la prova della divisione 457
Individuare la domanda adatta a una situazione problematica 458
Formulare la domanda adatta al testo di un problema 458
458
Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato della moltiplicazione ................ 459
Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato della divisione (come contenenza e partizione) .............................................................. 459
• Spazio e figure 459
Rappresentare percorsi su reticolati individuando la direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso 459
Riconoscere l’angolo come cambio di direzione
e conoscere gli elementi costitutivi dell’angolo 461
Classificare gli angoli in base all’ampiezza 462
Riconoscere e denominare rette incidenti, parallele e perpendicolari 463
Scienze 464
• Esplorare e descrivere oggetti e materiali 464
Descrivere la struttura della cellula 464
Descrivere la struttura della Terra 465
Descrivere il Sistema Solare 467
• Osservare e sperimentare sul campo 468
Avere familiarità con la periodicità dei fenomeni celesti 468
Tecnologia 469
• Vedere e osservare 469
Rappresentare un oggetto osservato con il disegno 469
• Prevedere e immaginare 469
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 469
• Intervenire e trasformare 470
Utilizzare il programma PowerPoint 470
Antologia
È inverno ........................................................................................................................ 472
È Natale ............................................................................................................................ 474
Il Natale dei Folletti ................................................................................................ 476
Lo schiaccianoci 478
Le onomatopee 479
Il topo dei fumetti 480
Filastrocche delle discipline 482
Schede operative Italiano
n 172 • Il Natale dei Folletti 483
n 173 • Lo schiaccianoci 484
n 174 • L’automobile a trombetta 485
n 175 • Inverno a Boscodirovo 486
n 176 • Storia di un uovo 488
n 177 • Il ballo della neve 490
n 178 • Atalanta e le mele d’oro 492
n 179 • Zilla 494
n 180 • Ade e Persefone 495
n 181 • La lettera 496
n 182 • Il fossile Ciro 498
n 183 • Messaggi invisibili 500
n 184 • Notte fumetto 501
n 185 • Tabella della descrizione 502
n 186 • Scrivo una lettera 503
n 187 • Racconto a fumetti 504
n. 188 • Invento un mito .................................................................................. 505
n. 189 • La pasta di sale ...................................................................................... 506
n. 190 • Dinosauri .................................................................................................. 507
n. 191 • Cielo a pecorelle ................................................................................ 508
n. 192 • Perla d’argento...................................................................................... 509
n 193 • L’uomo di neve 510
n 194 • Nomi in inverno 512
n 195 • Nomi propri e comuni 513
n 196 • Nomi maschili e femminili 514
n 197 • Nomi singolari e plurali 515
n 198 • Nomi concreti e astratti 516
n 199 • Nomi collettivi 517
n 200 • Nomi primitivi e derivati 518
n 201 • Nomi alterati 519
n 202 • Nomi composti 520
n 203 • Analisi dei nomi (1) 521
n 204 • Gli articoli determinativi e indeterminativi 522
n 205 • Gli aggettivi qualificativi 523
n 206 • Aggettivi sinonimi 524
n 207 • Aggettivi contrari 525
n 208 • Le preposizioni semplici
n 217 • Mito o racconto storico? 535
n 218 • Luonnotar
n 219 • Il dio Tzakol
n 220 • Panku
n 221 • Il Big Bang 539
n 222 • La Terra si forma 540
n 223 • Pangea e Panthalassa 541
n 224 • Verifico le mie conoscenze 542
n 225 • La vita sulla Terra 543
n 226 • Conosco il significato 544
n 227 • I dinosauri (1) 545
n 228 • I dinosauri (2) 546
n 229 • Un sito archeologico 547
n 230 • I fossili 548
n 231 • La storia della Terra (1) 549
n 232 • La storia della Terra (2) 550
n 233 • Verifico le mie conoscenze (1) 551
n 234 • Verifico le mie conoscenze (2) 552 Geografia
n 235 • Occhio alle indicazioni 553
n 236 • A ognuno la sua casa 554
n 237 • Vieni a casa mia! 555
n. 238 • I punti cardinali (1) .......................................................................... 556
n. 239 • I punti cardinali (2) .......................................................................... 557
n. 240 • L’orientamento spaziale della mia aula ............................ 558
n. 241 • So orientarmi ........................................................................................ 559
n. 242 • La Stella Polare .................................................................................... 560
n 243 • La rosa dei venti 561
n 244 • Orientarsi 562
n 245 • L’Italia politica 563
n 246 • L’Italia fisica 564
n 247 • Le cartine dell’Italia 565
n 248 • I simboli e i colori della geografia 566 Matematica
n 249 • L’intersezione 567
n 250 • “ e ” , “ non ” 568
n 251 • Classifico con i diagrammi di Venn 569
n 252 • Classifico con i diagrammi di Carroll 570
n 253 • Classifico con i diagrammi ad albero 571
n 254 • Rappresentazioni diverse 572
n 255 • I cambi 573
n 256 • Impariamo le tabelline!!! 574
n 257 • Lo zero nella moltiplicazione 575
n 258 • Moltiplicazioni con gli schieramenti (1) 576
n 259 • Addizioni e moltiplicazioni 577
n 260 • Moltiplicazioni per 10 578
n 261 • Le proprietà della moltiplicazione: commutativa e associativa 579
n 262 • La proprietà distributiva della moltiplicazione 580
n. 263 • Moltiplicazioni in colonna con moltiplicatore a una cifra ................................................................................................ 581
n. 264
• Moltiplicazioni in colonna con moltiplicatore a due cifre ................................................................................................ 582
n. 265 • Termini e prova della moltiplicazione .............................. 583
n 266
• Partizione o contenenza? 584
n 267
• Divisioni in riga (1) 585
n 268 • Divisioni in riga (2) 586
n 269 • Divisioni in riga (3) 587
n 270 • La tabella della divisione 588
n 271
• Divisioni per 10 589
n 272
• I termini della divisione 590
n 273
• Divisioni in colonna (1) 591
n 274
• Divisioni in colonna (2) 592
n 275 • Divisioni in colonna (3) 593
n 276
• Moltiplicazioni e divisioni 594
n 277 • Alla scoperta di ciò che manca 595
n 278 • Moltiplicazione e divisione: operazioni inverse 596
n 279 • La prova della divisione 597
n 280 • Problemi incompleti (1) 598
n 281 • Problemi incompleti (3) 599
n 282 • Problemi senza domanda 600
n 283 • Problemi monelli (1) 601
n 284 • Tanti problemi per capire la moltiplicazione (1) 602
n 285 • Tanti problemi per capire la divisione (1) 603
n 286 • Direzione e verso (1) 604
n 287 • Percorsi su reticolati (1) 605
n 288 • Percorsi su reticolati (2) 606
n. 289 • Angolo come cambio di direzione ...................................... 607
n. 290 • Gli angoli .................................................................................................. 608
n. 291 • Angoli acuti e angoli ottusi.......................................................... 609
n. 292 • Angolo retto, piatto e giro ............................................................ 610
n. 293 • Rette incidenti, parallele e perpendicolari ...................... 611 Scienze
n 294 • La cellula 612
n 295 • Le prime cellule 613
n 296 • La nostra Terra 614
n 297 • C’è Terra e terra 615
n 298 • Il terreno (1) 616
n 299 • Il terreno (2) 617
n 300 • Esperimento sul terreno 618
n 301 • L’inquinamento del terreno 619
n 302 • Salviamo il terreno 620
n 303 • Il vulcano 621
n 304 • L’eruzione vulcanica 622
n 305 • Il Sistema Solare 623
n 306 • Il Sole 624
n 307 • I pianeti rocciosi 625
n 308 • I pianeti gassosi 626
n 309 • Il movimento della Terra (1) 627
n 310 • Il movimento della Terra (2) 628
n 311 • La Luna 629
fEBBraIO • MaRzO Ambientiamoci
Proposte metodologiche
• Ascolto e parlato .................................................................................................. 635
Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 635
Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento 635
Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato 635
Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 635
• Lettura 636
Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui
si parla e individuando le informazioni principali: i dati sensoriali 636
Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 637
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche 637
Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 638
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche 638
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: il narratore 638
Leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi: il diario 639
Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: la fiaba .......................................................... 639
Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni .............................................................................................. 640
Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze .................................................................................. 640
Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche: versi e strofe 640
• Scrittura 641
Produrre testi descrittivi connessi con situazioni
quotidiane: i dati sensoriali 641
Produrre testi per raccontare vissuti e storie 641
Produrre testi per esprimere emozioni: il diario 642
Produrre testi per raccontare storie fantastiche: la fiaba 642
Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane: le istruzioni 642
Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane 643
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: la filastrocca 643
Sperimentare tecniche di riduzione del testo 643
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 643
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 643
Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: i verbi 643
Musica 645
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza ........................................................................................ 645
Arte e immagine.................................................................................................... 647
• Osservare e leggere le immagini .............................................................. 647
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 647
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 647
Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 647
• Esprimersi e comunicare 648
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 648
Elaborare creativamente produzioni personali 648
Educazione fisica 650
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 651
Riconoscere e denominare le varie posture del corpo 651
Rappresentare graficamente le varie posture del corpo 651
Controllare e gestire le condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo 652
Sperimentare la propria assenza di movimento (rilassamento) 653
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 654
Eseguire semplici sequenze di movimento e semplici coreografie individuali e collettive 654
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 654
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per sperimentare e giocare con l’equilibrio................................................ 654
Eseguire esercizi con attrezzi in un contesto fantastico .......... 655
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza .................................. 656
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria 656
Storia 657
• Organizzazione delle informazioni 657
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 657
• Uso delle fonti 658
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato 658
• Strumenti concettuali 661
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia 661
Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi 661
• Produzione scritta e orale 662
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti 662
Geografia 663
• Orientamento 663
Utilizzare la bussola per muoversi consapevolmente nello spazio circostante 663
• Paesaggio 664
Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio...................................................... 664
• Regione e sistema territoriale .................................................................... 667
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane ............................................................ 667
Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione 667
• Linguaggio della geo-graficità 668
Leggere e interpretare carte geografiche 668
Matematica 669
• Numeri 671
Leggere, scrivere e rappresentare il migliaio 671
Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità 672
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 100, per 1000 con i numeri naturali 673
Calcolare il doppio, il triplo, la metà e la terza parte 673
Riconoscere multipli e divisori di un numero dato 673
Discriminare interi frazionati e non 674
Riconoscere interi frazionati e quantificarne le parti 675
Riconoscere e denominare unità frazionarie 676
Individuare i termini di una frazione 676
Individuare la frazione che rappresenta parti di una figura geometrica data 677
Individuare in una figura geometrica la parte corrispondente a una frazione data 677
Leggere e scrivere una frazione data 677
Confrontare e ordinare frazioni, utilizzando i simboli >, <, = 677
Acquisire il concetto di frazione complementare ...................... 679
Scrivere il testo di un problema sulla base di elementi dati.. 679
Risolvere problemi con due domande e due operazioni .... 680
• Spazio e figure ........................................................................................................ 680
Riconoscere le figure geometriche piane attraverso lo sviluppo dei solidi 680
Distinguere i poligoni dai non poligoni 680
Conoscere definizione e terminologia dei poligoni 682
Realizzare su carta quadrettata figure ottenute in seguito a traslazioni 683
Costruire figure simmetriche rispetto a un asse interno o esterno alla figura 684
Costruire figure simmetriche rispetto a un asse di simmetria orizzontale, verticale e obliquo 685
Tracciare assi di simmetria 686
• Relazioni, dati e previsioni 686
Risolvere semplici problemi di logica 686
Scienze 688
• Osservare e sperimentare sul campo 688
Comprendere il concetto di ecosistema e la sua struttura 688
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 689
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 690
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi viventi 690
Tecnologia .................................................................................................................. 692
• Vedere e osservare .............................................................................................. 692
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni e testi................................................................................................................................ 692
• Prevedere e immaginare ................................................................................ 694
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 694
• Intervenire e trasformare 694
Acquisire fotografie sul computer 694
Antologia
Ricorrenze ...................................................................................................................... 696
Filastrocche e poesie di primavera .............................................................. 697
La corona di rugiada .............................................................................................. 698
Filastrocche delle discipline ............................................................................ 700
Fiabe in rima 701
Schede operative Italiano
n 312 • La corona di rugiada 702
n 313 • La mimosa 703
n 314 • Prometeo 704
n 315 • La nascita dell’ulivo 706
n 316 • L’erba magica 708
n 317 • Cappuccetto Tosto 710
n 318 • Il Dito Magico 712
n 319 • Che sfortuna! 713
n 320 • Il macinino magico 714
n 321 • La principessa sul pisello 716
n 322 • Giochiamo al teatro 718
n 323 • L’uovo di Pasqua 719
n 324 • La Repubblica tutela il paesaggio 720
n 325 • Il pranzo ideale 721
n 326 • Il mio potere magico 722
n 327 • Caro diario 723
n 328 • L’inventafiabe 724
n 329 • Il teatrino 726
n. 330 • La mia scuola ........................................................................................ 727
n. 331 • Filastrocca dei giochi ...................................................................... 728
n. 332 • La matita innamorata .................................................................... 729
n. 333 • I verbi .......................................................................................................... 730
n 334 • Le persone del verbo 731
n 335 • Le coniugazioni 732
n 336 • I tempi dei verbi (1) 733
n 337 • I tempi dei verbi (2) 734
n 338 • Il tempo presente 735
n 339 • Il tempo imperfetto 736
n 340 • Il tempo passato remoto 737
n 341 • Il tempo futuro semplice 738
n 342 • Cambia il tempo verbale! (2) 739
n 343 • Cambio di persona 740
n 344 • Il verbo essere 741
n 345 • Il verbo avere 742
n 346 • L’analisi dei verbi (1) 743
Arte e immagine
n 347 • Ambienti fiabeschi (1) 744
n 348 • Gli iris 745
n 349 • L’ulivo 746
n 350 • Cornici simmetriche 747
Educazione fisica
n. 351 • Indovina che posizione è ............................................................
n. 352 • La respirazione ....................................................................................
n. 353 • Verifico le mie conoscenze ........................................................
n. 354 • L’evoluzione ..........................................................................................
n 355 • I primi mammiferi (1) 752
n 356 • I primi mammiferi (2) 753
n 357 • Le prime scimmie
n 358 • Gli ominidi
n 359 • Lucy
n 360 • Le differenze 757
n 361 • L’Homo habilis 758
n 362 • L’Homo habilis e l’Homo erectus
n 363 • La scoperta del fuoco (1)
n 364 • L’uomo di Neanderthal 761
n 365 • Il quadro evolutivo 762
n 366 • La Preistoria e il Paleolitico 763
n 367 • Le abitazioni dell’uomo (1) 764
Geografia
n 368 • La bussola 765
n 369 • I paesaggi geografici 766
n 370 • Le parole della montagna 767
n 371 • La montagna 768
n 372 • Montagne: nascita e trasformazione 769
n 373 • Una montagna particolare 770
n 374 • La flora in montagna 771
n 375 • La fauna in montagna 772
n 376 • Vivere in montagna 773
n 377 • Le parole della collina 774
n. 378 • La collina ..................................................................................................775
n. 379 • La flora in collina ................................................................................776
n. 380 • La fauna in collina ..............................................................................777
n. 381 • Le parole della pianura ..................................................................778
n 382 • La pianura 779
n 383 • La flora e la fauna in pianura 780
n 384 • Vero o falso? 781
n 385 • L’uomo e l’ambiente 782
n 386 • Io abito a 783
n 387 • Completa la cartina 784 Matematica
n 388 • Il migliaio (1) 785
n 389 • Il migliaio (2) 786
n 390 • Rappresenta sull’abaco il migliaio 787
n 391 • Più di 1000 788
n 392 • Scomponi in k, h, da, u 789
n 393 • Scopri il numero 790
n 394 • Moltiplicare e dividere per 100 791
n 395 • Moltiplicare e dividere per 1000 792
n 396 • Il doppio e il triplo 793
n 397 • La metà e la terza parte 794
n 398 • I multipli 795
n 399 • I divisori 796
n 400 • Le frazioni (1) 797
n 401 • Le frazioni (2) 798
n 402 • Parti frazionarie 799
n. 403 • Unità frazionarie ................................................................................ 800
n. 404 • I termini di una frazione ................................................................ 801
n. 405 • Occhio alla frazione.......................................................................... 802
n. 406 • Frazioni a... colori ................................................................................ 803
n. 407 • Leggere e scrivere le frazioni ...................................................... 804
n 408 • Confronto tra frazioni (1) 805
n 409 • Confronto tra frazioni (2) 806
n 410 • Ordiniamo le frazioni 807
n 411 • Le frazioni complementari (1) 808
n 412 • Inventaproblemi (1) 809
n 413 • Problemi plus (1) 810
n 414 • Lo sviluppo dei solidi 811
n 415 • Poligoni e non poligoni (1) 812
n 416 • Figure concave e convesse (1) 813
n 417 • I poligoni 814
n 418 • La traslazione (1) 815
n 419 • Quale traslazione? 816
n 420 • La simmetria (1) 817
n 421 • La simmetria (2) 818
n 422 • Figure simmetriche 819
n 423 • Assi di simmetria 820
n 424 • Assi di simmetria nei poligoni 821
n 425 • Logica mente (1) 822
Scienze
n 426 • L’ecosistema 823
n 427 • A ognuno il suo 824
n 428 • Il panda 825
n 429 • L’ecosistema bosco 826
n. 430 • Gli abitanti del bosco ...................................................................... 827
n. 431 • L’ecosistema stagno ........................................................................ 828
n. 432 • Gli abitanti dello stagno ................................................................ 829
n. 433 • L’ecosistema mare ............................................................................ 830
n. 434 • Gli abitanti del mare ........................................................................ 831
n 435 • La piramide alimentare 832
n 436 • La catena alimentare 833
n 437 • Verifico le mie conoscenze 834
Tecnologia
n 438 • L’uomo e l’ambiente (1) 835
n 439 • La centrale idroelettrica 836
n 440 • Le industrie 837
n 441 • L’inquinamento 838
aPRIlE • MaGGIO
Tiriamoci in... ballo
Proposte metodologiche Italiano 840
• Ascolto e parlato 843
Ascoltare, comprendere e fornire informazioni 843
Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 843
Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 843
Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento 843
Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato 844
• Lettura .......................................................................................................................... 844
Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura .................................................................................................................... 844
Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali ...................... 845
Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 845
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche 847
Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 848
Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche 848
Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: la leggenda 848
Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze 849
Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni 849
Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche: l’allitterazione 849
• Scrittura 850
Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti: i paesaggi 850
Produrre testi per raccontare vissuti personali 850
Produrre testi per raccontare storie fantastiche: la leggenda 850
Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane .............................................................................. 851
Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane .............................................................................. 851
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo .. 851
Sperimentare tecniche di riduzione del testo ................................ 852
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 852
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 852
Riconoscere gli elementi essenziali della frase e riflettere
sulla loro funzione 852
Musica 854
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere provenienza 854
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione al riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi 854
Arte e immagine 856
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 856
Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore ........................................ 856
• Esprimersi e comunicare................................................................................ 857
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 857
Elaborare creativamente produzioni personali 857
• Osservare e leggere le immagini 857
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 857
Educazione fisica 858
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 858
Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili e cinestetiche) 858
Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del corpo 859
Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo e con piccoli attrezzi 860
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 861
Migliorare le abilità relative alla comunicazione gestuale 861
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 861
Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un gioco di squadra 861
Sviluppare la capacità di prendere inziative e di elaborare soluzioni di problemi attraverso il gioco di squadra 862
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 862
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria 862
Storia 863
• Organizzazione delle informazioni 863
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate .......................................................................... 863
• Uso delle fonti ........................................................................................................ 864
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato 864
• Strumenti concettuali 868
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia 868
Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi 869
• Produzione scritta e orale 870
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti 870
Geografia 871
• Paesaggio 871
Individuare gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano vari tipi di paesaggio 871
• Regione e sistema territoriale 875
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 875
Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione 875
• Linguaggio della geo-graficità 876
Leggere e interpretare carte geografiche 876
Matematica 877
• Numeri 878
Costruire sequenze numeriche, dato l’operatore ........................ 878
Scoprire l’operatore di una sequenza data ........................................ 879
Riconoscere le frazioni decimali, trasformandole nel corrispondente numero decimale (entro i decimi) .................. 879
Rappresentare graficamente i numeri decimali entro i decimi 880
Confrontare e ordinare i numeri decimali (entro i decimi), utilizzando i simboli >, <, = 881
Risolvere problemi con una domanda e due operazioni 881
Individuare il diagra
Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale per la soluzione di problemi 885
• Spazio e figure 886
Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli 886
Comprendere il concetto di perimetro 888
Individuare gli ingrandimenti e i rimpicciolimenti di una figura data 888
• Relazioni, dati e previsioni 890
Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e trovare un campione adeguato per misurarle 890
Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale per la lunghezza 892
Conoscere i sottomultipli del metro 892
Conoscere i multipli del metro 894
Passare da una misura espressa in una data unità a un ’altra a essa equivalente 895
Calcolare il perimetro di alcuni poligoni ............................................ 896
Intuire la possibilità del verificarsi o meno di un evento ........ 897
Rappresentare con istogrammi i dati rilevati in semplici
indagini statistiche ................................................................................................ 899
Leggere istogrammi individuando la moda .................................... 901
Conoscere e usare misure convenzionali di valore: l’euro 902
Scienze 904
• Osservare e sperimentare sul campo 904
Osservare e descrivere le piante 904
Osservare e descrivere gli animali 906
• Esplorare e descrivere oggetti e materiali 908
Eseguire trasformazioni in laboratorio 908
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 908
Acquisire le regole per una corretta alimentazione 908
Tecnologia 911
• Vedere e osservare 911
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni
e testi 911
• Intervenire e trasformare 913
Realizzare un prodotto digitale con il programma
PowerPoint 913
Antologia
Un punto artistico 916
Filastrocche sull’alimentazione 917
Filastrocche sugli animali 918
Filastrocche delle discipline 919
L’estate 920
Schede operative Italiano
n 442
• Un punto artistico 921
n 443
• Il sole e l’acqua 922
n 444 • Laika 924
n 445
• Cuccioli nella bufera 926
n. 446
• Vendesi mamma nuova .............................................................. 928
n. 447
• Zorba e la gabbianella .................................................................... 930
n. 448
• Il pescatore di perle .......................................................................... 932
n. 449
• Strumenti musicali ............................................................................ 934
n. 450
• Balliamo! .................................................................................................. 936
n 451
• Le parole adatte 937
n 452
• Pastasciutta 938
n 453
• Il villaggio dell’età della pietra 940
n 454
• Ecco la mia mamma 941
n 455 • Scrivo una leggenda! 942
n 456 • Regole in cucina 943
n 457 • Che parco! 944
n 458 • Poesia in pizza! 945
n 459 • I colori della pelle 946
n 460
n 461
• Quante frasi! 948
• L’ordine delle parole nella frase 949
n 462 • I sintagmi (1) 950
n 463
n 464
n 465
n 466
• Sintagmi in ordine (1) 951
• La frase minima 952
• Soggetto e predicato (1) 953
• Soggetto e predicato (2) 954
n 467 • Il soggetto 955
n 468 • Il soggetto sottinteso 956
n 469 • Il predicato verbale 957
n 470 • Il predicato nominale 958
n 471 • Le espansioni (1) 959
Musica
n 472 • Il tamburo e la chitarra 960
Arte e immagine
n. 473 • Le inquadrature .................................................................................. 961
n. 474 • Opere d’arte............................................................................................ 962
n. 475 • Donne al pozzo .................................................................................. 963
n. 476 • Un punto e basta? .............................................................................. 964
Educazione fisica
n 477 • Ritmo e movimento 965
n 478 • Dirigere un gioco di squadra 966
Storia
n 479 • Ordiniamo le fasi dell’evoluzione 967
n 480 • L’arte nella preistoria 968
n 481 • La religione degli uomini primitivi 969
n 482 • Le glaciazioni 970
n 483 • L’uomo cacciatore e pescatore 971
n 484 • L’uomo agricoltore 972
n 485 • L’uomo allevatore 973
n 486 • La prima grande invenzione 974
n 487 • L’aratro 975
n 488 • La tessitura 976
n 489 • Vero o falso? 977
n 490 • I metalli 978
n 491 • Verifico le mie conoscenze (1) 979
n 492 • Le palafitte 980
n 493 • L’alimentazione nella preistoria 981
n 494 • Gli indios 982
n 495 • Ötzi, un primitivo italiano 983 Geografia
n. 496 • Le parole del fiume .......................................................................... 984
n. 497 • La flora del fiume ................................................................................ 985
n. 498 • La fauna del fiume ............................................................................ 986
n. 499 • Le parole del lago .............................................................................. 987
n. 500 • Il lago (1) .................................................................................................. 988
n 501 • La flora del lago 989
n 502 • La fauna del lago 990
n 503 • Vivere sul lago 991
n 504 • Le parole del mare 992
n 505 • Il mare 993
n 506 • La flora del mare 994
n 507 • La fauna del mare 995
n 508 • Vivere al mare 996
n 509 • La città 997
n 510 • Completa la cartina fisica 998
n 511 • Completa la cartina politica 999
Matematica
n 512 • Le sequenze a colori 1000
n 513 • Le sequenze (2) 1001
n 514 • Scopri il numero 1002
n 515 • Scopri l’operatore 1003
n 516 • Le frazioni decimali 1004
n 517 • Coloriamo le frazioni decimali 1005
n 518 • Decimali: frazioni e numeri 1006
n 519 • Frazioni decimali e numeri decimali 1007
n 520 • I numeri decimali 1008
n 521• I numeri decimali sulla retta numerica 1009
n 522 • Rappresentiamo i numeri decimali (1) 1010
n. 523 • Rappresentiamo i numeri decimali (2) ........................ 1011
n. 524 • Confrontiamo i numeri decimali ...................................... 1012
n. 525 • Ordiniamo i numeri decimali .............................................. 1013
n. 526 • Problemi plus plus (1) ................................................................ 1014
n. 527 • Diagrammi di flusso (1) ............................................................ 1015
n 528 • Dal problema al diagramma (2) 1016
n 529 • Occhio ai prezzi (2) 1017
n 530 • Classifichiamo i poligoni 1018
n. 531
• Triangoli o quadrilateri (1).................................................... 1019
n. 532
• Classificare i triangoli.................................................................... 1020
n. 533
• I quadrilateri........................................................................................ 1021
n. 534
n. 535
n. 536
n. 537
n. 538
n. 539
n. 540
n. 541
n. 542
n. 543
n. 544
n. 545
n. 546
n. 547
n. 548
n. 549
n. 550
n. 551
n. 552
n. 553
n. 554
n. 555
• Il contorno (1).................................................................................. 1022
• Ingrandimenti e rimpicciolimenti...................................... 1023
• Contiamo o misuriamo?.......................................................... 1024
• Le misurazioni.................................................................................. 1025
• Misure non convenzionali...................................................... 1026
• Il metro.................................................................................................... 1027
• Più o meno di un metro?.......................................................... 1028
• I sottomultipli del metro (1).................................................. 1029
• I sottomultipli del metro (2).................................................. 1030
• I sottomultipli del metro (3).................................................. 1031
• I multipli del metro........................................................................ 1032
• Tante misure di lunghezza...................................................... 1033
• Equivalenze con le misure di lunghezza........................ 1034
• Il contorno delle figure................................................................ 1035
• Calcola il perimetro (1)............................................................ 1036
• Calcola il perimetro (3)............................................................ 1037
• Poligoni isoperimetrici................................................................ 1038
• Logiquiz (2)........................................................................................ 1039
• A colpo d’occhio (2).................................................................... 1040
• Analizzo e interpreto (1).......................................................... 1041
• Imparo a usare l’euro (2).......................................................... 1042
• Imparo a usare l’euro (3).......................................................... 1043
Scienze
n. 556
n. 557
n. 558
n. 559
n. 560
n. 561
n. 562
n. 563
n. 564
• Le piante................................................................................................ 1044
• La fotosintesi clorofilliana........................................................ 1045
• Il fiore........................................................................................................ 1046
• Ogni pianta al suo posto............................................................ 1047
• Conosco gli animali (1)............................................................ 1048
• Ogni animale al suo posto........................................................ 1049
• Le api: una società perfetta...................................................... 1050
• La piramide alimentare.............................................................. 1051
• Quando si mangia?........................................................................ 1052
Tecnologia
n. 565
• La tecnologia e l’inquinamento.......................................... 1053
ANNUALE
Piccoli cittadini crescono
Proposte metodologiche
Educazione civica ............................................................................................ 1056
Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé 1057
Conoscere e rispettare alcune fondamentali regole di convivenza........................................................................................................ 1057
Individuare un problema ambientale e proporre soluzioni 1058
Conoscere e ricercare comportamenti ecologici.................... 1059
Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada.................................................... 1060
Conoscere e applicare le principali norme di igiene e profilassi delle malattie..............................................................................1064
Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione........................................................................................................ 1068
Antologia Un fratellino diverso............................................................................................ 1072
Scuola a colori ........................................................................................................ 1074
Schede operative
n. 566 • Collaboriamo!.................................................................................. 1075
n. 567 • Roba da grandi.................................................................................. 1076
n. 568 • Vivere insieme.................................................................................. 1077
n. 569 • Bambini fragilissimi...................................................................... 1078
n. 570 • I comportamenti corretti (1) .............................................. 1079
n. 571 • I segnali stradali................................................................................ 1080
n. 572 • I segnali stradali verticali............................................................ 1081
n. 573 • A caccia di cattivi comportamenti (1)............................ 1082
n. 574 • Il test della salute.............................................................................. 1083
n. 575 • Prevenzione ........................................................................................ 1084
n. 576 • Le funzioni dell’alimentazione.............................................. 1085 n. 577 • Le calorie................................................................................................ 1086 n. 578 • Gli errori nutrizionali (1)..........................................................
Matematica
n. 25 • Le relazioni (2)........................................................................................30
n. 26 • Basi diverse con il B.A.M. (2)......................................................31
n. 27 • Simboli e numeri..................................................................................32
n. 28 • Le numerazioni......................................................................................33
n. 29 • Maggiore o minore di... ....................................................................34
n. 30 • Il centinaio, la decina e l’unità......................................................35
n. 31
• Commutare e associare..................................................................36
n. 32 • Calcoli veloci............................................................................................37
n. 33 • Analizzo il testo dei problemi (2)............................................38
n. 34 • Gioco con i problemi (3)..............................................................39
n. 35 • Tanti problemi per capire l’addizione (3)........................40
n. 36 • Tanti problemi per capire la sottrazione (3)..................41 Scienze
n. 37 • Definisco esattamente......................................................................42
n. 38 • Cambiamenti di stato........................................................................ 43
DIcEMBRE • GENNaIO Italiano
n. 39 • Il tempo libero..........................................................................................46
n. 40 • La signorina Dolcemiele................................................................47
n. 41 • Analisi dei nomi (2)............................................................................48
n. 42 • I sinonimi.................................................................................................... 49
n. 43 • Gli omonimi..............................................................................................50
n. 44 • I contrari......................................................................................................51
Arte e immagine
n. 45 • Emozioni a fumetti.............................................................................. 052
n. 46 • I simboli dei fumetti............................................................................ 053
n. 47
• Nuvolette.................................................................................................... 054
n. 48 • Stelle a colori............................................................................................ 055
n. 49 • Disegno il sole.......................................................................................... 056 Educazione fisica
n. 50 • Posizione corretta o scorretta?.................................................... 057 Storia
n. 51 • Che cosa conosco del mito?........................................................ 058
n. 52 • La deriva dei continenti.................................................................... 059
n. 53 • Il tirannosauro.......................................................................................... 060
n. 54 • Lo stegosauro.......................................................................................... 061
n. 55 • Lo pterosauro.......................................................................................... 062
n. 56 • Il plesiosauro............................................................................................ 063
n. 57 • L’iguanodonte........................................................................................ 064 Geografia
n. 58 • L’orientamento spaziale della mia cucina.......................... 065
n. 59 • Mi oriento guardando le carte.................................................... 066
n. 60 • Riconosco altri simboli?.................................................................. 067
Matematica
n. 61 • “e”, “non” nelle operazioni di intersezione........................ 068
n. 62 • Le tabelline................................................................................................ 069
n. 63 • Moltiplicazioni con gli schieramenti (2)............................ 070
n. 64 • Le moltiplicazioni in riga................................................................ 071
n. 65 • Problemi incompleti (2)................................................................ 072
n. 66 • Problemi incompleti (4)................................................................ 073
n. 67 • Problemi monelli (2)........................................................................ 074
n. 68 • Tanti problemi per capire la moltiplicazione (2) 075
n. 69 • Tanti problemi per capire la divisione (2) 076
n. 70 • Il piano cartesiano 077
n. 71 • Direzione e verso (2) 078
n. 72 • Angoli retti, acuti, ottusi 079
n. 73 • Rette incidenti, parallele e perpendicolari.......................... 080
n. 74 • Scopriamo tante rette........................................................................ 081 Scienze
n. 75 • Le prime forme di vita........................................................................ 082
n. 76 • Produrre l’humus.................................................................................. 083
n. 77 • Un amico del terreno: il lombrico.......................................... 084
fEBBraIO • MaRzO
Italiano
n. 78 • Teatro a scuola........................................................................................ 086
n. 79 • Il libro di storie........................................................................................ 088
n. 80 • Se mi arrabbio... 089
n. 81 • Pezzi di... fiabe.......................................................................................... 090
n. 82 • Verbi sinonimi........................................................................................ 091
n. 83 • Verbi contrari.......................................................................................... 092
n. 84 • Il tempo passato prossimo............................................................ 093
n. 85 • Cambia il tempo... verbale! (1).................................................. 094
n. 86 • Il tempo giusto........................................................................................ 095
n. 87 • L’analisi dei verbi (2).......................................................................... 096 Arte e immagine
n. 88 • Ambienti... fiabeschi (2).................................................................. 097
n. 89 • Costumi teatrali...................................................................................... 098
n. 90 • Verdi................................................................................................................ 099
n. 91 • La colomba della pace......................................................................100
n. 92 • Fantasia di figure....................................................................................101
Educazione fisica
n. 93 • Le posture....................................................................................................102
n. 94 • Il rilassamento..........................................................................................103
Storia
n. 95 • L’evoluzione degli esseri viventi................................................104
n. 96 • L’amigdala..................................................................................................105
n. 97 • La scoperta del fuoco (2)..............................................................106
n. 98 • L’Homo sapiens....................................................................................107
n. 99 • La sepoltura dei morti........................................................................108
n. 100 • L’Homo sapiens sapiens..............................................................109
n. 101 • I primi gruppi........................................................................................110
n. 102 • Le abitazioni dell’uomo (2)......................................................111
Geografia
n. 103 • La montagna: verifico le mie conoscenze......................112
n. 104 • La collina: verifico le mie conoscenze..............................113
n. 105 • La pianura: verifico le mie conoscenze............................114
Matematica
n. 106 • Simboli e numeri................................................................................115
n. 107 • Giochiamo con il migliaio e il centinaio..........................116
n. 108 • Scrivere in frazione............................................................................117
n. 109 • Confronto tra frazioni (3)..........................................................118
n. 110 • Le frazioni complementari (2)..............................................119
n. 111 • Inventaproblemi (2)......................................................................120
n. 112 • Inventaproblemi (3)......................................................................121
n. 113 • Problemi plus (2)..............................................................................122
n. 114 • Poligoni e non poligoni (2)......................................................123
n. 115 • Figure concave e convesse (2)................................................
n. 116 • La traslazione (2)..............................................................................
n. 117 • Logica... mente (2)............................................................................
Scienze
n. 118 • Il bosco: verifico le mie conoscenze....................................
n. 119 • Lo stagno: verifico le mie conoscenze..............................
n. 120 • Il mare: verifico le mie conoscenze......................................
Tecnologia
n. 121 • L’uomo e l’ambiente (2)..............................................................
n. 122 • Test... rumoroso..................................................................................
n. 123 • Il picchio e la canna ........................................................................
n. 124 • L’ispettore pappario ........................................................................
n. 125 • La signorina Spezzindue
n. 126 • Paesaggio notturno..........................................................................
n. 127 • Sono goloso di…..............................................................................
n. 128 • Il pollice del principino..................................................................
n. 129 • I sintagmi (2)........................................................................................
n. 130 • Sintagmi in ordine (2)
n. 131 • Le espansioni (2)..............................................................................
Musica
n. 132 • Approfondiamo alcuni brani....................................................
Arte e immagine
n. 133 • Paesaggi fantastici (1)....................................................................
n. 134 • Paesaggi fantastici (2).................................................................... 148
n. 135 • Ambienti e personaggi (1)........................................................ 149
n. 136 • Ambienti e personaggi (2)........................................................ 150
n. 137 • I blu 151 Educazione fisica
n. 138 • Faccio l’insegnante di ginnastica 152 Storia
n. 139 • La ceramica............................................................................................ 153
n. 140 • L’età dei metalli.................................................................................... 154
n. 141 • Verifico le mie conoscenze (2).............................................. 155
n. 142 • Verifico le mie conoscenze (3).............................................. 156
n. 143 • Vita di villaggio.................................................................................... 157
n. 144 • Immagino... 158 Geografia
n. 145 • Il fiume........................................................................................................ 159
n. 146 • Vivere sul fiume.................................................................................. 160
n. 147 • Il lago (2).................................................................................................. 161
n. 148 • L’uomo e l’ambiente...................................................................... 162
n. 149 • La regione in cui vivo...................................................................... 163
n. 150 • Completa la cartina.......................................................................... 164 Matematica
n. 151 • Le sequenze (1).................................................................................. 165
n. 152 • Scopri l’operatore (2) 166
n. 153 • Dalle frazioni decimali ai numeri decimali.................... 167
n. 154 • Problemi plus plus (2).................................................................. 168
n. 155 • Diagrammi di flusso (2).............................................................. 169
n. 156 • Diagrammi di flusso (3).............................................................. 170
n. 157 • Dal problema al diagramma (1)............................................ 171
n. 158 • Dal problema al diagramma (3)............................................ 172
n. 159 • Occhio ai prezzi (1)........................................................................ 173
n. 160 • Triangoli o quadrilateri (2)........................................................ 174
n. 161 • Il contorno (2)....................................................................................
n. 162 • Le misure di lunghezza non convenzionali..................
n. 163 • Confrontiamo le misure..............................................................
n. 164 • Calcola il perimetro (2)................................................................
n. 165
Educazione



Per una più semplice consultazione si riporta schematicamente la struttura della Guida Unica
Premessa Si presenta all’insegnante il progetto della Guida Unica.
La progettazione curricolare prevede per il mese di settembre attività di accoglienza e una suddivisione bimestrale per i restanti mesi.
Programmazione
Ciascun bimestre viene considerato come Unità di lavoro e nello schema programmatico vengono riportati per ciascuna disciplina le competenze chiave europee , i traguardi per lo sviluppo delle competenze secondo le Indicazioni nazionali, gli obiettivi di apprendimento, le relative attività e le proposte di raccordi interdisciplinari .
Indicazioni metodologiche e traguardi per lo sviluppo delle competenze
Proposte metodologiche
Sezioni di antologia e schede di lavoro
Ogni disciplina è introdotta da una breve premessa metodologica e dallo schema dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
Per ciascun bimestre, per ogni disciplina, sono riportati: obiettivi di apprendimento con relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze , attività e contenuti.
Le proposte antologiche sono suddivise per bimestri. Le schede sono ordinate per bimestre e per discipline.




La Guida Unica è stata impostata e redatta secondo le ultime Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, ponendo l’accento, in questa sua nuova edizione, sulla definizione degli obiettivi di apprendimento e sui traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave alla cui realizzazione, valutazione e certificazione è chiamata la scuola.
La Guida Unica rappresenta un prezioso strumento e offre un contributo operativo e metodologico-didattico di spessore, grazie alla concretezza e all’operatività della sua impostazione.
Questo strumento didattico si caratterizza per:
Æ la linearità programmatico-progettuale;
Æ l’essenzialità delle proposte educative;
Æ la chiarezza dell’impostazione metodologico-didattica.
Triplice caratterizzazione che trae origine da profonde motivazioni psico-pedagogiche, socio-culturali e di politica scolastica e che si sostanzia e si distingue sia per la concretezza e per l’operatività con cui si propone sia per la capacità di semplificare le innovazioni rendendo concreti e operativi i percorsi.
Nella convinzione che una guida didattica debba sempre coniugare sapere , saper fare e saper far fare (elementi inseparabili per una corretta funzione docente), la Guida Unica offre un grande numero di piste di lavoro e di proposte didattiche, attraverso una serie di schede logicamente ed epistemologicamente coerenti con l’impianto programmatorio e tra loro connesse da un sotteso filo inter e pluridisciplinare .
Il progetto si sviluppa all’insegna di una dimensione concreta e operativa che intende privilegiare l’esperienza, la scoperta, l’attività pratica e l’apprendimento attivo del bambino in un clima di collaborazione e cooperazione. L’alunno dev’essere reso sempre più autonomo e sicuro nella conquista consapevole delle peculiarità disciplinari. Dev’essere aiutato a far emergere e a finalizzare meglio curiosità, interessi e capacità riflessivo-rielaborative in grado di indirizzarlo verso l’autoapprendimento. Il percorso di apprendimento deve essere costruito a partire dai suoi bisogni formativi ed essere strutturato come percorso di costruzione delle competenze. I saperi di ciascuna disciplina offrono, infatti, il materiale su cui permettere agli alunni di costruire modalità di apprendimento, di riflessione e di risoluzione di problemi reali in contesti nuovi e differenti da quelli in cui sono stati acquisiti.
La trattazione di ogni disciplina è concettualmente suddivisa in due parti:
Æ la prima è dedicata allo sviluppo degli aspetti programmatici e metodologico-didattici, con riferimento agli indirizzi teorico-culturali, agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. In essa sono chiariti i principi pedagogici e culturali di riferimento, le strategie metodologiche e didattiche adottate e, infine, le ragioni di fondo che sono alla base delle scelte contenutistiche e dei suggerimenti operativi;
Æ la seconda, più ricca, è dedicata all’operatività. In essa, infatti, sono contenute le proposte didattiche sotto forma di schede operative, fotocopiabili o stampabili da CD, predisposte per ogni obiettivo indicato nella programmazione curricolare.




Il terzo volume della Guida Unica persegue lo scopo di consolidare e arricchire conoscenze, abilità e competenze, già avviate e sviluppate nel corso della prima e della seconda classe, nell’ambito della letto-scrittura, della matematica e di un primo approccio verso le “specificità” disciplinari; contemporaneamente accompagna docenti e alunni lungo un percorso che sostituisca la globale intuizione delle “specificità” disciplinari con l’apprendimento dei loro singoli tratti distintivi e delle loro singole modalità di approccio al reale.
L’offerta didattica del volume è ampliata e completata da schede supplementari reperibili sul supporto elettronico; infine, anche per la classe terza, la Guida Unica continuerà a proporre, per l’Italiano e per la Matematica, apposite schede di lavoro, con prove strutturate, e concepite secondo il sistema INVALSI al quale, come è noto, è stato conferito l’incarico pluriennale di studiare e realizzare un processo valutativo del sistema scolastico italiano nello sforzo di stimolarlo ad allinearsi alla media delle performance degli altri sistemi scolastici europei.




ITALIANO Periodo: SETTEMBRE
• Raccontare esperienze vissute e storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie.
• Esprimere opinioni, sentimenti e stati d’animo.
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.
• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
• Produrre testi per esprimere sentimenti, stati d’animo, opinioni.
• Produrre testi per raccontare vissuti e storie.
• Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura.
• Riflettere sulla frase.
• Le vacanze e il ritorno a scuola. Ricordi e cambiamenti: – conversazioni guidate; – questionari; – esposizione di sensazioni e stati d’animo.
• Le favole e le regole di comportamento: – ascolto di favole lette dall’insegnante; – ordinamento di immagini in sequenza; – racconto di storie con il supporto di immagini.
• Lettura autonoma di semplici testi: – associazione di immagini a frasi;
– completamento di semplici cloze;
– soluzione di questionari a scelta multipla.
• Le vacanze e il ritorno a scuola:
– discussioni guidate;
– rappresentazione con il disegno; – elaborazione di didascalie esplicative di immagini in sequenza;
– racconto di esperienze personali in ordine cronologico.
• Le principali difficoltà ortografiche: digrammi, trigrammi, gruppi di lettere, raddoppiamenti di consonante.
• L’ordine delle parole nella frase.
– Giochi linguistici.
– Soluzione di cruciverba.
– Riordino di parole all’interno di frasi.
T5
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
Ascolto e parlato T1
• Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti.
T2
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.
• Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento e istruzioni per svolgere attività.




• Le caratteristiche del paesaggio autunnale:
– lettura e/o ascolto di filastrocche sull’autunno; – osservazione dal vero e/o di immagini; – descrizione orale; – uso degli indicatori spaziali.
• La crescita personale, i cambiamenti, il futuro, le attività scolastiche ed extrascolastiche: – ascolto e/o lettura di filastrocche;
– ascolto e racconto di esperienze individuali e/o collettive;
– uso degli indicatori temporali;
– esposizione di sentimenti e opinioni personali.
• Le caratteristiche delle favole: – ascolto di favole lette dall’insegnante; – ordinamento di immagini in sequenza; – racconto di storie con il supporto di immagini; – uso degli indicatori temporali.
• Le regole nel laboratorio scientifico e in biblioteca:
– discussioni guidate; – elaborazione di regolamenti condivisi dal gruppo.
• Gli esperimenti scientifici con l’aria, i giochi: – ascolto e racconto delle fasi.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura.
T3
T3 T4
• Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
• Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
T10
• Leggere testi narrativi e cogliere la struttura.
• Il piacere della lettura: – allestimento della biblioteca di classe; – discussioni guidate sulle preferenze di lettura; – il regolamento della biblioteca; – visita guidata a una biblioteca del territorio; – esposizione di sentimenti e opinioni personali.
• Le descrizioni di ambienti: – uso corretto degli indicatori spaziali; – individuazione di percorsi.
• Lettura attiva del testo narrativo: – completamento di cloze con lista di parole da inserire; – soluzione di questionari a risposta aperta.
• Le relazioni temporali: – l’ordine cronologico; – riordino di sequenze.
• Le relazioni logiche: – il rapporto causa/effetto; – soluzione di questionari con risposta a scelta multipla.
• Inizio, sviluppo e conclusione della storia: – suddivisione di storie in tre fasi; – soluzione di questionari a scelta multipla.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






T3
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali.
• Leggere, comprendere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica.
• Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici.
• Leggere testi informativi in vista di scopi pratici.
• Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche formali.
• Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.




• Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi: – completamento di frasi con informazioni relative al personaggio ricavate dalla lettura del testo.
• La favola: –i personaggi e il messaggio; –soluzione di questionari a risposta aper ta.
• Le istruzioni per un gioco: –lettura guidata di istruzioni per l’individuazione della struttura: i materiali, il procedimento; –soluzione di questionari a risposta aperta.
• Gli avvisi: –individuazione delle informazioni utili; –le caratteristiche dell’avviso.
• Le rime baciate e le rime alternate: –lettura e analisi del contenuto di filastrocche; –ripetizione e memorizzazione; –giochi per l’individuazione delle rime; –giochi di parole con le rime; –strutturazione di schemi di rime.
• Descrizione di ambienti: – osservazione e descrizione guidata, orale/scritta di ambienti noti; –uso degli indicatori spaziali; –l’ordine temporale della descrizione.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Produrre testi per raccontare vissuti e storie che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
T6
T8
T6
T6
T9
• Produrre testi regolativi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
• Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Le esperienze personali e/o collettive; la favola:
– racconto orale di vissuti personali;
– individuazione di inizio, sviluppo e conclusione di un fatto;
– esposizione di sentimenti e stati d’animo in relazione al fatto;
– elaborazione del testo con uno schema guida;
– elaborazione di didascalie esplicative di immagini in sequenza;
– produzione guidata di cronache di esperienze individuali e/o collettive, con il supporto di immagini;
– produzione guidata di favole;
– uso degli indicatori temporali;
– uso del discorso diretto e indiretto.
• Il regolamento di un gioco:
– produzione guidata di testi regolativi con il supporto di immagini.
• L’avviso e la relazione:
– produzione guidata di testi espositivi con modello guida;
– la relazione di un esperimento scientifico.
• La filastrocca:
– costruzione di rimari;
– manipolazione di testi usando le rime; –costruzione di filastrocche rispettando una determinata struttura.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
Scrittura
B




• Sperimentare tecniche di riduzione del testo. • Le tecniche per avviare al riassunto: – elaborazione di didascalie relative a immagini in sequenza;
– individuazione delle sequenze del racconto; – individuazione delle informazioni essenziali; – completamento di schemi guida.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
• Riconoscere e utilizzare le fondamentali convenzioni di scrittura. A B
• Le principali difficoltà ortografiche: raddoppiamenti di consonante, digrammi, trigrammi e gruppi di lettere, accento, apostrofo, divisione in sillabe delle parole, ordine alfabetico.
• L’uso corretto dei principali segni di punteggiatura.
– Giochi linguistici.
– Ascolto, lettura, copia, scrittura sotto dettatura, memorizzazione di filastrocche contenenti parole che presentano difficoltà ortografiche.
– Completamento di testi.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Ascoltare, comprendere e fornire informazioni.
T1
• Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti.
T2
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
T1
T4
T2
• Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato.
Lettura
• Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura.
• Le caratteristiche di persone reali e personaggi fantastici: – osservazione dal vero e/o attraverso immagini e letture; – ascolto di testi letti dall’insegnante; –descrizione orale con il supporto di schemi e tabelle.
• Il Natale, le attività scolastiche e il tempo libero nel periodo invernale: – ascolto e/o lettura di filastrocche; – ascolto e racconto di esperienze individuali e/o collettive; – uso degli indicatori temporali; – esposizione di sentimenti e opinioni personali.
• Storie sull’inverno e il Natale: – ascolto della lettura dell’insegnante; – individuazione dei personaggi delle storie e delle loro caratteristiche; – individuazione di affermazioni vere/false inerenti alla storia.
• La preistoria: – esposizione orale di argomenti con il supporto di schemi, grafici, mappe.
• Il piacere della lettura: –ascolto di libri letti a puntate dall’insegnante; –giochi linguistici.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.
• Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni temporali.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche.
• Leggere testi narrativi e cogliere la struttura.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali.
• Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica.




• I dati uditivi nelle descrizioni: –individuazione dei dati sensoriali nelle descrizioni; –completamento di tabelle.
• Lettura attiva di racconti sull’inverno: –completamento di cloze con lista di parole da inserire; –soluzione di questionari a risposta aperta.
• L’ordine cronologico del testo narrativo: –riordino di sequenze; –completamento di un diagramma di flusso.
• Lettura attiva del testo narrativo: –individuazione di parole intruse in un testo; –giochi linguistici.
• Inizio, sviluppo e conclusione della storia: –suddivisione di storie in tre fasi; –ordinamento delle fasi; –soluzione di questionari con risposta a scelta multipla.
• Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi: –individuazione ed evidenziazione delle caratteristiche di personaggi; –completamento di frasi con informazioni relative al personaggio ricavate dalla lettura del testo.
• Il mito: i personaggi e lo scopo. –Soluzione di questionari con risposta a scelta multipla.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
Lettura
T3
• Leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi.
• Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze.
• Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici.
T6
• Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche.
Scrittura
• Produrre testi descrittivi connessi con situazioni quotidiane e/o fantasiose.
• Produrre testi per esprimere emozioni.
• Produrre testi per raccontare storie che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
• La lettera personale: caratteristiche e struttura.
• Il testo scientifico: –individuazione delle informazioni utili; –soluzione di questionari con risposte a scelta multipla.
• Le istruzioni per un’attività: –lettura guidata di istruzioni per l’individuazione della struttura: i materiali, il procedimento; –individuazione di frasi superflue.
• Le onomatopee: –lettura e analisi del contenuto di filastrocche; –ripetizione e memorizzazione; –giochi per l’individuazione delle onomatopee.
• La descrizione di personaggi reali e fantastici: –completamento della tabella della descrizione.
• La lettera personale: –elaborazione di una lettera con il supporto di un modello guida.
• I fumetti: –osservazione di fumetti; –racconto orale; –produzione del testo narrativo; –uso del discorso diretto e indiretto.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
T6
T6
T4
T6
T6
T9
• Produrre testi per raccontare storie fantastiche.
• Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
• Produrre testi espositivi per relazionare su argomenti di studio.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Il mito: –produzione guidata di miti.
T6
• Sperimentare tecniche di riduzione del testo.
• Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole. A B




• Le istruzioni per realizzare manufatti: –produzione guidata di testi regolativi con il supporto di immagini.
• La ricerca disciplinare: –produzione guidata di testi espositivi con modello guida.
• La filastrocca: –costruzione di rimari; –manipolazione di testi usando le rime; –costruzione di filastrocche rispettando una determinata struttura.
• Le tecniche per avviare al riassunto: –individuazione delle sequenze del racconto; –individuazione delle informazioni essenziali; –completamento di schemi guida.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
• I nomi, gli articoli, gli aggettivi qualificativi, le preposizioni:
– lettura di filastrocche;
– classificazione; – associazione; – trasformazione; – completamento di frasi; – individuazione di elementi intrusi; – soluzione di indovinelli; – giochi linguistici.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
Ascolto e parlato
T2
• Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti.
• Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento.
T1
T3
• Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato.
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.
Lettura
• Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.
• Le caratteristiche del paesaggio primaverile: – lettura e/o ascolto di filastrocche sulle ricorrenze del periodo.
• I giochi creativi, le attività scolastiche ed extrascolastiche: – ascolto e racconto di esperienze individuali e/o collettive.
• Comportamenti collaborativi finalizzati alla realizzazione di un progetto comune: – allestimento di una breve recita; – discussioni guidate; – elaborazione di regolamenti condivisi dal gruppo.
• La scuola: – chiarezza e completezza delle informazioni su ambienti conosciuti.
• La fiaba: – ascolto della lettura dell’insegnante; – individuazione dei personaggi delle storie e delle loro caratteristiche.
• I dati sensoriali nelle descrizioni: – individuazione dei dati sensoriali nelle descrizioni; – completamento di tabelle.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.



Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
T3 T10
T3
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche.
• Leggere testi narrativi e cogliere la struttura.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali.
• Leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi.
• Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica.
• Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici.







• Lettura attiva del testo narrativo: – completamento di cloze senza lista di parole da inserire; –individuazione di affermazioni corrette/errate inerenti al testo; – soluzione di questionari a risposta aperta.
• Lettura attiva del testo narrativo: – ricostruzione logica di storie.
• Inizio, sviluppo e conclusione della fiaba: – suddivisione di fiabe in tre fasi; –soluzione di questionari a risposta aperta.
• Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi: –individuazione di affermazioni corrette/errate; – individuazione del ritratto del personaggio.
• Le caratteristiche del narratore: –individuazione di affermazioni vere/false; – trasformazioni di testi.
• Il diario personale: scopo, struttura, narratore, caratteristiche. –Soluzione di questionari a risposta aperta.
• La fiaba: personaggi e struttura. –Soluzione di questionari a risposta aperta e a scelta multipla.
• Le istruzioni per svolgere un’attività: – individuazione di frasi superflue.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
T3
T4
• Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze.
• Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche.
T6
T1
• Produrre testi descrittivi connessi con situazioni quotidiane.
• La struttura del testo informativo: – individuazione degli argomenti trattati.
• La struttura del testo poetico: versi e strofe. – Lettura e analisi del contenuto di filastrocche.
– Ripetizione e memorizzazione. – Individuazione di versi e strofe.
• I dati sensoriali: – produzione di testi descrittivi con modello guida.
• Produrre testi per raccontare vissuti e storie. • Esperienze personali e situazioni fantasiose: – racconto orale; – elaborazione di testi con il supporto di schemi-guida.
• Produrre testi per esprimere emozioni.
• Produrre testi per raccontare storie fantastiche.
• Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
• Il diario: – racconto orale di vissuti; – esposizione di sentimenti e stati d’animo in relazione al fatto; – elaborazione di pagine di diario.
• La fiaba: – produzione guidata; – completamenti di fiabe.
• Istruzioni per realizzare manufatti: – produzione guidata di testi regolativi con il supporto di immagini.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
T6
T6
T8
T6
• Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.




• Le informazioni sulla scuola: – produzione di testi espositivi con modello guida.
• La filastrocca: – costruzione di rimari; – manipolazione di testi usando le rime; – costruzione di filastrocche rispettando una determinata struttura.
• Sperimentare tecniche di riduzione del testo. • Le tecniche per avviare al riassunto: – la sottolineatura del testo.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
• Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole. A B
• I verbi: – classificazione; – completamenti; – confronti; – sostituzioni; – trasformazione di tempi verbali di frasi e verbi; – analisi grammaticale del verbo.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
T2
T2
T1
T2
Ascolto e parlato
• Ascoltare, comprendere e fornire informazioni. • Soggettività e oggettività nelle descrizioni di animali: – lettura e/o ascolto di filastrocche; – osservazione dal vero e/o di immagini; – descrizione orale.
• Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti.
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.
• Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento.
• Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato.
Lettura
• Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura.
• Le principali ricorrenze del periodo, le attività scolastiche ed extrascolastiche: – ascolto e racconto di esperienze individuali e/o collettive.
• Il racconto realistico: – ascolto della lettura dell’insegnante; – individuazione dei personaggi e delle loro caratteristiche; – ordinamento delle sequenze.
• La tutela della salute: –discussioni guidate, test sull’alimentazione, l’inquinamento acustico.
• Le istruzioni per eseguire danze.
• Gli strumenti musicali: – esposizione orale con supporto di schemi e mappe.
• La leggenda: – ascolto della lettura dell’insegnante; – soluzione di cruciverba.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.
• Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche.
• Leggere testi narrativi e cogliere la struttura.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali.
• Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica.
• Descrizioni oggettive e soggettive:




– completamento di mappe; –soluzione di questionari a risposta aperta.
• Lettura attiva del testo narrativo:
– completamento di cloze senza lista di parole da inserire; –soluzione di questionari a risposta aperta.
• Lettura attiva del testo narrativo: – individuazione di frasi intruse in un testo;
– completamento di testi;
– soluzione di questionari con risposta aperta e a scelta multipla.
• Inizio, sviluppo e conclusione del testo narrativo:
– suddivisione di storie in tre fasi;
– individuazione dell’inizio coerente con le successive fasi;
– soluzione di questionari a scelta multipla.
• Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi:
– individuazione delle caratteristiche;
– completamento della tabella della descrizione.
• La leggenda: scopo, struttura, personaggi, caratteristiche.
– Individuazione del finale coerente con le altre fasi.
– Soluzione di questionari con risposta a scelta multipla.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
T3
T4
T3
T3
T8
• Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze.
• Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici.
• Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche.
Scrittura
• La struttura del testo informativo: – individuazione delle informazioni; – completamento di tabelle e mappe.
• Le istruzioni per svolgere un’attività: – esecuzione di danze.
• L’allitterazione: – lettura e analisi del contenuto di filastrocche; – ripetizione e memorizzazione; – individuazione di allitterazioni.
• Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti. • I paesaggi: – osservazione di immagini; – produzione di testi descrittivi con modello guida; – uso degli indicatori spaziali.
• Produrre testi per raccontare vissuti personali.
T6
• Produrre testi per raccontare storie fantastiche.
• Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
• Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
• I vissuti personali: – produzione di testi con il supporto di modelli guida.
• La leggenda: – produzione guidata.
• La ricetta.
• Le regole di comportamento in cucina: – produzione guidata di testi regolativi con il supporto di immagini.
• Le informazioni sui parchi: – produzione di testi espositivi con modello guida.
ITALIANO –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.






Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
T6
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Sperimentare tecniche di riduzione del testo.
T8
• L’allitterazione:




– costruzione di catene di parole allitteranti;
– elaborazione di testi poetici in gruppo.
• Le tecniche per avviare al riassunto:
– la sottolineatura del testo;
– la divisione in sequenze;
– la soluzione di un questionario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
• Riconoscere gli elementi essenziali della frase e riflettere sulla loro funzione. A B
• Il ruolo e i rapporti delle parole nella frase: i sintagmi, la frase minima, le espansioni, il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale.
– Ordinamenti di parole e sintagmi.
– Completamenti di frasi, tabelle, schemi.
– Individuazione di intrusi.
– Associazioni.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




MUSICA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
T6
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Ascolto di brani di musica per distinguere l’armonia e la melodia.
• Le note musicali.
MUSICA Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
T2
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
• Il coro.
• Esecuzione di cori natalizi.
T1
T2
T3
MUSICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.



MUSICA Periodo: FEBBRAIO-MARZO







Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• La nascita della musica.
• Esecuzione di canti popolari.
MUSICA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione al riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi.
• Riconoscimento nell’ascolto di brani musicali degli strumenti.
• La storia di due strumenti musicali: il tamburo e la chitarra.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.




Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
Esprimersi e comunicare
• Elaborare creativamente produzioni personali.
T1
T1
T2
T3
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
• Dalla geometria alla fantasia: – realizzazione di composizioni astratte con linee spezzate e curve.
• Realizzazione di addobbi autunnali e di un segnalibro con vari materiali e tecniche.
Osservare e leggere le immagini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva.
• Personaggi e ambienti delle favole: – completamenti di immagini.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
• Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore.
• Lettura guidata di quadri d’autore.
Unità di lavoro Momenti mitici
Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8 ARTE E IMMAGINE Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Esprimersi e comunicare
• Elaborare creativamente produzioni personali.
T1
T1
T1
T2
T3
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
• Dalla geometria alla fantasia: – realizzazione di composizioni astratte con rette geometriche.
• A Natale ne facciamo di tutti i colori: – rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali quali il sole, gli alberi di Natale, le stelle.
• Realizzazione di addobbi natalizi con la pasta di sale.
Osservare e leggere le immagini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva.
• Il linguaggio dei fumetti: – simboli, onomatopee, nuvolette; – storie a fumetti.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
• Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore.
• Lettura guidata di quadri d’autore.
ARTE E IMMAGINE –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).






T1
T1
T2
T3




Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
Esprimersi e comunicare
• Elaborare creativamente produzioni personali.
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
• Dalla geometria alla fantasia. Realizzazione di: – composizioni astratte con figure geometriche; – cornici e disegni simmetrici.
• Creazione di costumi di personaggi.
• Realizzazione di un teatrino con il cartone.
• Rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali: i fiori di pesco.
Osservare e leggere le immagini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva.
• Personaggi e ambienti delle fiabe: – completamenti di immagini.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
• Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore.
• Lettura guidata di quadri d’autore.
Unità di lavoro Tiriamoci in… ballo
Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (p. 77) C8
Esprimersi e comunicare
• Elaborare creativamente produzioni personali.
T1
T1
• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
T3
• Dalla geometria alla fantasia: – realizzazione di: composizioni astratte con elementi geometrici (il punto).
• Rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali: il mare.
Osservare e leggere le immagini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva.
• Personaggi e ambienti del presente, del passato e del futuro: – completamento di immagini.
• Le inquadrature: figura intera, primo piano, dettaglio.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
• Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore.
• Lettura guidata di quadri d’autore.
• Individuazione di elementi pittorici, architettonici e scultorei.
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.




EDUCAZIONE FISICA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro
Sperimento, imparo,
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• Usare in modo corretto e consapevole gli arti superiori e inferiori.
T4
• Riconoscere la parte destra e sinistra sugli altri e sugli oggetti.
T4
• Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo riferimenti diversi da sé (altri e oggetti).
• Cogliere la relatività dell’orientamento.
• I movimenti degli arti superiori e degli arti inferiori:
– esercizi con la palla;
– esercizi di deambulazione;
– esercizi di coordinazione dinamica generale;
– giochi con la palla.
• Esercizi e giochi motori:
– l’impronta colorata del corpo;
–le impronte colorate delle mani e dei piedi;
– esercizi a coppie;
– gioco della mano destra o sinistra.
• Il corpo e la relazione spazio/tempo:
– spostamenti e orientamenti nello spazio (palestra, classe);
– percorsi con oggetti;
– gioco dei cigni.
• L’orientamento:
– riconoscimento degli orientamenti spaziali su di sé e sugli altri;
– relazione tra gli orientamenti spaziali del proprio corpo con il mondo esterno.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il corpo.
T2
T3
T4
• Eseguire giochi mimici.
• I messaggi non verbali:
– comunicare mediante smorfie, gesti e sguardi per esprimere emozioni, sentimenti e stati d’animo.
• Giochi senso-percettivi per stimolare la capacità di osservazione e la capacità di imitazione.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play
• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per affinare la coordinazione oculomanuale e oculo-podalica.
• Giochi per il consolidamento percettivo visivo e l’affinamento della coordinazione occhio-mano, occhio-piede.
EDUCAZIONE FISICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. T1 T2 T3






Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• Migliorare il controllo del movimento delle mani nell’uso di oggetti e di attrezzi.
T3
T4
T1
T1
T1 T4
T2
• Prendere coscienza della posizione corretta della colonna vertebrale e del tronco.
• Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità/successione, prima/dopo, lento/veloce).
• Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre/saltare, afferrare/lanciare.
T3
T4
T3
T5




Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
• Giochi per migliorare le capacità coordinative riferite alla destrezza manuale. Giochi con: – palloni da pallavolo; – cerchi; – palline da tennistavolo; – origami; – piegature con fogli colorati e/o giornali.
• Esercizi per la sensibilizzazione della posizione corretta della colonna vertebrale.
• Giochi per riconoscere le coordinate spaziali e temporali: – gioco dei gruppi in ascolto; – gioco del veloce/lento; – gioco del metronomo.
• Percorsi misti con corde o piccoli ostacoli: – gioco del lancia e afferra.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il movimento.
• Giochi di imitazione e di espressione.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play
• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per la valutazione della distanza.
• Eseguire giochi presportivi.
• Giochi a squadre: – la palla nel cerchio; – gioco dei birilli; – pronti oplà.
• Gioco di squadra presportivo.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
• Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
• Sviluppo dell’attitudine all’ordine e del rispetto degli attrezzi e degli spazi: – discussioni guidate al fine di evitare azioni e comportamenti pericolosi.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. T4
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.




di
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• Riconoscere e denominare le varie posture del corpo.
T1
T1
T1
T1
T2
• Rappresentare graficamente le varie posture del corpo.
• Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
• Sperimentare la propria assenza di movimento (rilassamento).
• Le posture del corpo: – esercizi di descrizione di varie posture; – esercizi sulle corrette posture in piedi, in ginocchio, seduti, supini, proni e “a quattro zampe”.
• Rappresentazioni con il disegno di varie posture.
• Esercizi per il controllo dell’equilibrio: – esercizi sull’asse di equilibrio.
• Esercizi di rilassamento.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• Eseguire semplici sequenze di movimento e semplici coreografie individuali e collettive.
T4
T3 T4
T6
• Brevi coreografie e drammatizzazioni.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play
• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per sperimentare e giocare con l’equilibrio.
• Eseguire giochi con attrezzi in un contesto fantastico.
• Giochi motori: – le belle statuine; – uno, due, tre… stella!
• Esercizi motori con l’uso di: – cerchi, nastri, clavette e funicelle.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
• Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere“ legate all’attività ludico-motoria.
• Attività di rilassamento e di respirazione guidata.
EDUCAZIONE FISICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.






Unità di lavoro Tiriamoci in… ballo
Competenza chiave
T1
T1
T1 T2
T2
T3
T3
T6




Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili e cinestetiche).
• Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del corpo.
• Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo e con piccoli attrezzi.
• Attività ludica per l’individuazione di natura e provenienza di stimoli vari.
• Attività ludiche sulla consapevolezza del ritmo.
• Riproduzioni di semplici strutture ritmiche.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• Migliorare le abilità relative alla comunicazione gestuale.
• La danza per migliorare il rapporto tra musica e movimento nella comunicazione gestuale.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play
• Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un gioco di squadra.
• Sviluppare la capacità di prendere iniziative e di elaborare soluzioni di problemi attraverso il gioco di squadra.
• Giochi liberi a piccoli gruppi, a squadre, con e senza regole.
• Gioco per lo sviluppo delle abilità sociali.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
• Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere“ legate all’attività ludico-motoria.
• Esperienze di benessere legate al libero gioco.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.




Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
T8
T5
T1 T2
• Riconoscere una storia come successione di fatti.
• Usare in maniera appropriata gli indicatori temporali.
• Riconoscere e utilizzare le fonti della storia.
• Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi nel tempo e nello spazio.
• Produzione della cronaca delle vacanze.
• Attività su contemporaneità e durata di fatti.
• Uso dell’orologio.
• Attività sui cicli temporali: settimana, mese, stagione, anno.
• Ricerca dei documenti per raccontare un proprio vissuto (le vacanze).
• Raccolta di testimonianze relative al passato dei propri nonni.
• Rappresentazione grafica di oggetti propri e del tempo dei nonni.
STORIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Organizzazione delle informazioni
T3
T2
• Rappresentare graficamente e verbalmente un fatto vissuto, definendone la durata temporale.
• L’ordine cronologico.
• Collocazione del “tempo delle vacanze” sulla linea del tempo.
Uso delle fonti
• Individuare tracce e usarle come fonti di tipo diverso per ricavare conoscenze sul passato personale e familiare.
• Ricerca di documenti delle vacanze: foto, cartoline, souvenir…
• Gli specialisti che ricostruiscono la Storia: archeologo, antropologo, geologo, paleontologo, storico.
• Le fonti della storia: orali, scritte, iconografiche, materiali.
STORIA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.






Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico




Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Strumenti concettuali
• Definire la durata temporale di fatti e periodi.
T5
T8
• Conoscenza delle principali forme di misurazione del tempo: ora, giorno, anno, decennio, secolo, millennio, era.
Produzione scritta e orale
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti.
• Rappresentazione del lavoro degli studiosi del passato.
Unità di lavoro Momenti mitici
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Organizzazione delle informazioni
T5
• Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
T2 T5
• Conoscenza dei grandi periodi storici in cui il tempo è diviso: Preistoria e Storia.
• Conoscenza dell’evoluzione degli esseri viventi (le ere geologiche).
Uso delle fonti
• Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato.
• Conoscenza dei miti e delle leggende sulla nascita della Terra.
• Conoscenza del racconto storico della nascita della Terra.
Produzione scritta e orale
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti.
• Rappresentazione grafica dell’evoluzione degli esseri viventi.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.




Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Organizzazione delle informazioni
T5
• Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
T5
T4
T6 T8
• Conoscenza delle tappe principali del processo evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente e al soddisfacimento dei bisogni.
• Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato.
• Conoscenza delle scoperte e dei cambiamenti che hanno favorito lo sviluppo dell’uomo:
– Australopiteco (Lucy);
– Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens;
– gli strumenti, la scoperta del fuoco, la caccia e la pesca.
Strumenti concettuali
• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia.
• Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi.
• I primi gruppi sociali.
• L’evoluzione delle abitazioni dalla caverna alla casa.
Produzione scritta e orale
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti.
• Il racconto dell’evoluzione.
STORIA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.






T5
T6
T2
T4
T6
T6 T9
T6 T9
T6 T8




Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Organizzazione delle informazioni
• Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
• Conoscenza delle tappe principali del processo evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente e al soddisfacimento dei bisogni.
• Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato.
• Conoscenza delle scoperte e dei cambiamenti che hanno favorito lo sviluppo dell’uomo: – l’agricoltura; – l’allevamento; – la scoperta dei metalli; – la ruota.
Strumenti concettuali
• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia.
• Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi.
• L’organizzazione dei villaggi primitivi.
• L’alimentazione nella Preistoria.
Produzione scritta e orale
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti.
• Il racconto dell’evoluzione.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.




Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
• Classificare un paesaggio.
T5
T2
T2
T2
• Conoscere diversi tipi di carte.
• Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali.
• Leggere e interpretare semplici rappresentazioni cartografiche.
• Analisi e riconoscimento degli elementi caratteristici delle diverse tipologie di paesaggi.
• Distinzione tra mappe, piante e carte geografiche.
• Costruzione di una mappa.
• Realizzazione di un disegno con l’uso di indicatori spaziali.
• Interpretazione dei simboli presenti nel percorso di esodo.
• Esecuzione e riproduzione grafica di percorsi.
GEOGRAFIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
T1
T1
T5
T6
• Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante.
• Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi utilizzando le proprie carte mentali.
• Utilizzazione di punti di riferimento per orientarsi all’interno della scuola.
• Osservazione e descrizione dell’ambiente circostante.
• Raffigurazione dell’ambiente osservato.
• Sperimentazione di una prima analisi geografica del territorio.
Regione e sistema territoriale
• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
• Il lavoro del geografo.
• Conoscenza delle parole della geografia.
• Gli specialisti che aiutano il geografo: cartografo, geologo, meteorologo, storico.
• Osservazione e descrizione di uno spazio.
GEOGRAFIA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artisticoletterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).






GEOGRAFIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Linguaggio della geo-graficità
T2
T1
T5
• Rappresentare in prospettiva verticale ambienti noti.
Paesaggio
• Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.




Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
• La costruzione della pianta dell’aula.
• La costruzione della pianta della casa.
• Riconoscimento nei differenti ambienti naturali di elementi essenziali con l’uso di una terminologia appropriata.
GEOGRAFIA Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Unità di lavoro Momenti mitici
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
T5
T6
T1
T2
T7 Programmazione
• Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante.
• Conoscenza dei punti cardinali.
Linguaggio della geo-graficità
• Leggere e interpretare carte geografiche.
Paesaggio
• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente.
• La carta geografica: fisica e politica.
• Simboli e colori nelle carte geografiche.
• Il pianeta Terra: i cambiamenti e i mutamenti dalla sua origine a oggi.
• Osservazione di immagini.
• Realizzazione di cartelloni murali.
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.




Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
Orientamento
T1
T5
T7
• Utilizzare la bussola per muoversi consapevolmente nello spazio circostante.
Paesaggio
• Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio.
T5
T7
T1
T5
T7
T2
• Uno strumento per orientarsi: – la bussola.
• Osservazione e confronto di paesaggi geografici per individuarne le principali caratteristiche fisiche e antropiche: – la montagna; – la collina; – la pianura.
Regione e sistema territoriale
• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
• Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione.
• Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente: – l’uomo e la montagna; – l’uomo e la collina; – l’uomo e la pianura;
• Osservazione e descrizione dell’ambiente di residenza.
Linguaggio della geo-graficità
• Leggere e interpretare carte geografiche. • La carta geografica: – i colori dei rilievi.
GEOGRAFIA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.). T1 T2
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artisticoletterarie).






Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5 GEOGRAFIA Periodo: APRILE-MAGGIO
Paesaggio
• Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio.
T5
T7
T5
T6
T7
T1
T5
T7
T2
• Osservazione e confronto di paesaggi geografici per individuarne le principali caratteristiche fisiche e antropiche: – il fiume; – il lago; – il mare.
Regione e sistema territoriale
• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
• Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione.
• La città.
• Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente: – la città.
• Osservazione sulla carta geografica e descrizione della regione di residenza.
Linguaggio della geo-graficità
• Leggere e interpretare carte geografiche.
• La carta geografica: – i colori dei paesaggi acquatici.




Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.




MATEMATICA Periodo: SETTEMBRE
Unità di lavoro Pronti per la terza
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
T1 T6
T1 T6
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
• Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi.
• Stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco di coppie ordinate e tabelle.
• Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali entro il 100.
• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100.
• Confrontare e ordinare i numeri naturali, entro il 100, utilizzando i simboli >, <, =.
• Scomporre e comporre i numeri entro il 100.
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio della decina.
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga.
• Risolvere semplici problemi con l’addizione e con la sottrazione.
• Classificare le linee in aperte/chiuse, semplici/non semplici.
• Individuare le regioni che si formano con più confini semplici.
• Esercizi di rappresentazioni d’insiemi e sottoinsiemi.
• Relazioni tra insiemi.
• Lettura e scrittura dei numeri entro il 100.
• Ordinamento dei numeri entro il 100.
• Riconoscimento del precedente e del seguente di un numero dato utilizzando i simboli >, <, =.
• Esercizi di scomposizione e composizione di numeri entro il 100 in decine e unità.
• Esecuzione di addizioni e sottrazioni.
• Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni.
• Risoluzione di problemi con addizione e sottrazione.
• Rappresentazioni di linee aperte/chiuse, semplici/non semplici.
• Esercizi per l’individuazione di regioni.
MATEMATICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.







Unità di lavoro
Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
T10
T1
T1
T1
T1
T1
• Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti di 3° ordine) ed esprimere la quantità in numeri, seguendo il criterio posizionale.
• Trasformare in base dieci numeri scritti in basi diverse.
• Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci entro il 999.
• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 999.
• Confrontare e ordinare i numeri entro il 999 utilizzando i simboli >, <, =.
• Scomporre i numeri in centinaia, decine e unità.
• Comporre numeri espressi in centinaia, decine e unità.
• Conoscere il significato dello 0 nell’addizione.
• Conoscere i termini dell’addizione.
• Conoscere e applicare la proprietà commutativa e la proprietà associativa dell’addizione.




• Raggruppamenti con materiali strutturati.
• Rappresentazioni con il disegno, con il B.A.M. e con l’abaco.
• Rappresentazioni con l’abaco, lettura e scrittura di numeri entro il 999.
• Esercizi di numerazione progressiva e regressiva entro il 999.
• Esercizi di confronto dei numeri naturali entro il 999 con l’uso corretto dei simboli >, <, =.
• Esercizi di scomposizione e composizione di numeri entro il 999.
• Esercizi in tabella e calcoli orali.
• Esercizi per il corretto uso dei termini dell’addizione.
• Esercizi per il calcolo mentale e scritto.
• Eseguire addizioni in colonna con due cambi. • Esercizi per eseguire addizioni in colonna.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.




Programmazione
MATEMATICA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T7
T8
T8
T8
T8
• Conoscere i termini della sottrazione.
• Conoscere il significato dello 0 nella sottrazione.
• Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della sottrazione.
• Eseguire sottrazioni in colonna con due cambi.
• Individuare stati e operatori additivi e inversi.
• Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione.
• Eseguire le prove dell’addizione e della sottrazione.
• Comprendere una situazione problematica attraverso l’analisi e la comprensione del testo.
• Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema.
• Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato dell’addizione.
• Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato della sottrazione (come mancanza, resto e differenza).
• Esercizi per il corretto uso dei termini della sottrazione.
• Esercizi in tabella e calcoli orali.
• Esercizi per il calcolo mentale e scritto.
• Esercizi per eseguire sottrazioni in colonna.
• Esercizi per l’individuazione di operatori additivi e inversi.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esercizi per eseguire le prove dell’addizione e della sottrazione.
• Elaborazione di situazioni problematiche.
• Esercizi di schematizzazione dei dati essenziali di un problema.
• Risoluzione di problemi con addizione.
• Risoluzione di problemi con sottrazione.
MATEMATICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.







Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3 MATEMATICA Periodo:
Spazio e figure
T2
T2
T3
T3
T2
T2
T2
T7
T7
T1
• Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o un oggetto prendendo come riferimento se stesso.
• Riconoscere nella realtà figure geometriche solide.
• Conoscere le caratteristiche dei solidi.
• Riconoscere linee aperte/chiuse, semplici/non semplici.
• Riconoscere linee curve, spezzate, miste.
• Riconoscere linee rette, semirette e segmenti.
• Comprendere e usare correttamente “e”, “non” in enunciati.
• Usare i connettivi “se… allora”.
• Individuare l’insieme complementare.




• Riconoscimento della destra e della sinistra.
• Costruzione con cartoncino dei seguenti solidi: cubo, sfera, piramide, cilindro, parallelepipedo, cono.
• Indicazione corretta delle seguenti caratteristiche dei solidi: facce, spigoli, vertici e tridimensionalità (lunghezza, larghezza e altezza).
• Rappresentazioni con il disegno di linee aperte/chiuse, semplici/non semplici.
• Rappresentazioni con il disegno di linee curve, spezzate e miste.
• Rappresentazioni con il disegno di rette, semirette e segmenti.
Relazioni, dati e previsioni
• Esercizi di logica per l’uso di connettivi logici in enunciati.
• Esercizi di logica per l’uso consapevole di “se… allora”.
• Ricerca del complementare con disegni e operazioni.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.




Programmazione
MATEMATICA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
Relazioni, dati e previsioni
T7
T5 T7
T5 T7
• Usare correttamente “e”, “non” nelle operazioni di complemento.
• Stabilire e rappresentare relazioni con frecce, elenco di coppie ordinate, tabelle e reticolati.
• Individuare la relazione inversa rispetto alla relazione data.
MATEMATICA
• Esercizi per l’uso corretto di “e”, “non” in enunciati nelle operazioni di complemento.
• Esercizi per stabilire relazioni tra insiemi con: frecce, elenco di coppie ordinate e reticolati.
• Esercizi per stabilire la relazione inversa.
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Unità di lavoro Momenti mitici
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
T1
T1
T1
T1
• Effettuare cambi tra centinaia, decine e unità.
• Conoscere a memoria le tabelline.
• Conoscere il significato dello 0 nella moltiplicazione.
• Eseguire moltiplicazioni in riga.
• Eseguire moltiplicazioni per 10, per 100 con i numeri naturali.
• Esercizi di cambio con l’abaco.
• Costruzione delle tabelline in sequenza.
• Calcoli orali.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in riga.
MATEMATICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.







Unità di
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3 MATEMATICA Periodo:
Numeri
T1
T1
T1
T1
• Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione.
• Applicare la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una cifra.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di due cifre.
• Conoscere i termini della moltiplicazione.
• Eseguire la prova della moltiplicazione.
• Distinguere il concetto di divisione come partizione da quello di divisione come contenenza.
• Eseguire divisioni in riga senza e con il resto.
• Individuare, attraverso la tabella della divisione, proprietà e caratteristiche specifiche della divisione.
• Eseguire divisioni per 10, per 100 con i numeri naturali.
• Conoscere i termini della divisione.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.




• Esercizi per il calcolo mentale e scritto.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna.
• Esercizi per il corretto uso dei termini della moltiplicazione.
• Esercizi per eseguire la prova della moltiplicazione.
• Sperimentazione di situazioni concrete di partizione e contenenza.
• Esercizi per eseguire divisioni in riga aventi come quoziente solo numeri interi.
• Costruzione della tabella della divisione.
• Esercizi per eseguire divisioni in riga.
• Esercizi per il corretto uso dei termini della divisione.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.




Programmazione
MATEMATICA Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Unità di lavoro Momenti mitici
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
Numeri
• Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza cambio, con e senza resto.
• Esercizi per eseguire divisioni in colonna.
T1
T1
T1
T7
T8
T7
T8
T7 T8
T8
T8
• Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra con il cambio, con e senza resto.
• Individuare stati moltiplicativi e inversi.
• Chiudere enunciati aperti sulle quattro operazioni.
• Eseguire la prova della divisione.
• Individuare la domanda adatta a una situazione problematica.
• Formulare la domanda adatta al testo di un problema.
• Individuare nel testo di un problema i dati mancanti, superflui, nascosti.
• Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato della moltiplicazione.
• Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato della divisione (come contenenza e partizione).
• Esercizi per l’individuazione di operatori additivi e inversi, moltiplicativi e inversi.
• Esercizi per eseguire la prova della divisione.
• Individuazione di domande congruenti con il testo.
• Formulazione di domande coerenti con il testo.
• Risoluzione di problemi contenenti vari dati.
• Risoluzione di problemi con la moltiplicazione.
• Risoluzione di problemi con la divisione.
MATEMATICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.







Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
Spazio e figure
T2
T3
T3 T4
T2 T3
T5 T7
T5 T7
T5 T7
T5 T7
• Rappresentare percorsi su reticolati individuando la direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso.
• Riconoscere l’angolo come cambio di direzione e conoscere gli elementi costitutivi dell’angolo.
• Percorsi in palestra.
• Rappresentazioni grafiche su reticolati.
• Giochi in palestra.
• Definizione di angolo.




• Classificare gli angoli in base all’ampiezza. • Rappresentazioni grafiche di vari tipi di angoli: retto, acuto, ottuso, piatto e giro.
• Riconoscere e denominare rette incidenti, parallele e perpendicolari.
• Rappresentazioni grafiche di rette incidenti, parallele e perpendicolari.
Relazioni, dati e previsioni
• Rappresentare l’intersezione di due insiemi.
• Usare correttamente “e”, “non” nelle operazioni di intersezione.
• Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.
• Individuare i criteri adottati in una classificazione rappresentata mediante i diagrammi di Venn, di Carrolle ad albero.
• Esercizi di esperienze concrete.
• Esercizi con rappresentazioni grafiche.
• Esercizi per la classificazione.
• Esercizi di logica.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.




Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
• Leggere, scrivere e rappresentare il migliaio.
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1 T10
• Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità.
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 100, per 1000 con i numeri naturali.
• Calcolare il doppio, il triplo, la metà e la terza parte.
• Riconoscere multipli e divisori di un numero dato.
• Discriminare interi frazionati e non.
• Riconoscere interi frazionati e quantificarne le parti.
• Riconoscere e denominare unità frazionarie.
• Individuare i termini di una frazione.
• Individuare la frazione che rappresenta parti di una figura geometrica data.
• Individuare in una figura geometrica la parte corrispondente a una frazione data.
• Leggere e scrivere una frazione data.
• Confrontare e ordinare frazioni, utilizzando i simboli >, <, =.
MATEMATICA
• Rappresentazione con l’abaco, lettura e scrittura del numero 1000.
• Esercizi di scomposizione e composizione.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga.
• Schede operative.
• Schede operative.
• Attività manipolative e grafiche individuali e di gruppo.
• Attività grafiche.
• Attività manipolative e grafiche di gruppo.
• Esercizi per il corretto uso dei termini di una frazione.
• Attività grafiche ed esplicative.
• Esercizi di relazioni.
• Dettato, scrittura e lettura di frazioni.
• Esercizi di confronto e ordinamento di frazioni con numeratore uguale e denominatore differente.
–Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.







Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
T1
T10
T7
T8
T8
T2
T2
T3
T2
T4
T2
T4
T2
T4
T7
T8
• Acquisire il concetto di frazione complementare.
• Scrivere il testo di un problema sulla base di elementi dati.
• Risolvere problemi con due domande e due operazioni.
• Esercizi di completamento di un intero.
• Elaborazione di testi problematici.
• Risoluzione di problemi.
Spazio e figure
• Riconoscere le figure geometriche piane attraverso lo sviluppo dei solidi.
• Distinguere i poligoni dai non poligoni.
• Conoscere definizione e terminologia dei poligoni.
• Realizzare su carta quadrettata figure ottenute in seguito a traslazioni.
• Costruire figure simmetriche rispetto a un asse interno o esterno alla figura.
• Costruire figure simmetriche rispetto a un asse di simmetria orizzontale, verticale e obliquo.
• Tracciare assi di simmetria.




• Disegno e colorazione delle figure geometriche piane ricavate dallo sviluppo dei solidi.
• Confronti tra poligoni e non poligoni.
• Individuazione dei poligoni attraverso relative rappresentazioni.
• Individuazione di lati, vertici e angoli.
• Definizione di poligono.
• Attività concrete e grafiche.
• Costruzioni concrete e grafiche di figure simmetriche.
• Disegni ed esercizi di piegature.
Relazioni, dati e previsioni
• Risolvere semplici problemi di logica.
• Risoluzione di problemi di logica.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.




Programmazione didattica
Unica • Guida didattica © ibiscusedizioni.it
MATEMATICA Periodo: APRILE-MAGGIO
Unità di lavoro Tiriamoci in… ballo
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
Numeri
• Costruire sequenze numeriche, dato l’operatore.
• Esercizi di calcolo mentale e scritto.
T1
T1
T10
T1
T10
T1 T10
T8
T8
T8
T3
T3
T3
• Scoprire l’operatore di una sequenza data.
• Riconoscere le frazioni decimali, trasformandole nel corrispondente numero decimale (entro i decimi).
• Rappresentare graficamente i numeri decimali entro i decimi.
• Confrontare e ordinare i numeri decimali (entro i decimi), utilizzando i simboli >, <, =.
• Risolvere problemi con una domanda e due operazioni.
• Individuare il diagramma adatto per risolvere un problema.
• Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale per la soluzione di problemi.
• Costruzione di una linea di numeri divisa in decimi.
• Rappresentazione grafica dei numeri decimali.
• Esercizi di confronto dei numeri decimali.
• Risoluzione di problemi più complessi.
• Costruzione di un diagramma di flusso.
• Risoluzione di semplici problemi di compravendita.
Spazio e figure
• Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli.
• Comprendere il concetto di perimetro.
• Individuare gli ingrandimenti e i rimpicciolimenti di una figura data.
• Classificazione dei triangoli.
• Classificazione dei quadrilateri.
• Esercizi di ritaglio, di confronto e di ripasso del confine dei poligoni.
• Semplici esercizi di rimpicciolimento.
MATEMATICA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.







Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3 MATEMATICA Periodo:
Relazioni, dati e previsioni
T4
T4
T4
T1 T4
T1 T4
T3 T4
T7
T5
T5
T1 T8
• Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e trovare un campione adeguato per misurarle.
• Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale per la lunghezza.
• Conoscere i sottomultipli del metro.
• Conoscere i multipli del metro.
• Passare da una misura espressa in una data unità a un’altra a essa equivalente.
• Calcolare il perimetro di alcuni poligoni.
• Intuire la possibilità del verificarsi o meno di un evento.
• Rappresentare con istogrammi i dati rilevati in semplici indagini statistiche.
• Leggere istogrammi individuando la moda.
• Conoscere e usare misure convenzionali di valore: l’euro.
• Esercizi di confronto di oggetti.
• Misurazioni con campioni arbitrari.
• Registrazioni in tabella.
• Misurazioni di grandezze con il metro.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.




• Misurazioni di grandezze con il decimetro, centimetro e millimetro.
• Uso del righello.
• Costruzione del decametro con fettucce lunghe un metro ciascuna.
• Esercizi di equivalenze con le misure di lunghezza.
• Esercizi di calcolo per la misurazione del perimetro.
• Attività ludiche finalizzate all’individua-zione di possibile/impossibile.
• Costruzione di istogrammi.
• Lettura di istogrammi e individuazione della relativa moda.
• Gioco di cambi di banconote e monete.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.




Unità di lavoro Pronti per la terza
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76) C3
T3
T3 T5
T3 T5
• Distinguere i cicli temporali.
• Individuare le caratteristiche di esseri viventi e non viventi.
• Classificare gli animali.
• Distinzione di cicli temporali.
• Distinzione delle caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.
• Distinzione delle caratteristiche degli animali per la loro classificazione.
SCIENZE Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76) C3
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
• Imparare ad apprendere attraverso il metodo scientifico.
T2
T2
T3
T3
T2
• Descrivere semplici fenomeni chimici e fisici.
• Applicazione del metodo scientifico.
• Conoscenza del lavoro dello scienziato e di diversi specialisti delle Scienze.
• Conoscenza di qualche notizia relativa alla vita e agli esperimenti di Galileo Galilei.
• I fenomeni chimici e i fenomeni fisici.
• Classificare la materia in organica e inorganica. • La materia organica e inorganica.
• Individuare e descrivere gli stati di aggregazione della materia.
• I tre stati di aggregazione della materia.
Osservare e sperimentare sul campo
• Osservare e interpretare le caratteristiche dell’aria. • Sperimentazioni sull’aria.
SCIENZE –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.






SCIENZE Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
T5
T6
T1
T3
T1
T3
T2
T3




Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76) C3
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
• Descrivere la struttura della cellula.
• Descrivere la struttura della Terra.
• Descrivere il Sistema Solare.
• La struttura della cellula:
– la membrana cellulare, il citoplasma e il nucleo;
• La prima forma di vita sulla Terra.
• La conformazione della Terra: – la crosta, il mantello e il nucleo.
• Le caratteristiche del terreno.
• Il Sistema Solare:
– il Sole; – i pianeti rocciosi e gassosi; – i satelliti.
Osservare e sperimentare sul campo
• Avere familiarità con la periodicità dei fenomeni celesti.
• La periodicità: notte/giorno, il “percorso del Sole”, le stagioni e le fasi lunari.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.




SCIENZE Periodo: FEBBRAIO-MARZO
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76) C3
Osservare e sperimentare sul campo
T5
T6
T5 T6
• Comprendere il concetto di ecosistema e la sua struttura.
• Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale.
T5
• L’habitat, la comunità ecologica, il biotipo, l’ecosistema.
• Gli ecosistemi naturali: – l’ecosistema bosco; – l’ecosistema stagno; – l’ecosistema mare.
L’uomo, i viventi e l’ambiente
• Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi viventi.
• La piramide alimentare.
• La catena alimentare.
SCIENZE –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.



SCIENZE Periodo: APRILE-MAGGIO
Unità di lavoro Tiriamoci in… ballo







Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76) C3
Osservare e sperimentare sul campo
• Osservare e descrivere le piante.
T5
T5
T2
T6
• Osservare e descrivere gli animali.
• Le piante: – le parti della pianta; – la foglia e la fotosintesi clorofilliana; – il fiore, il seme e la germinazione.
• Gli animali: – vertebrati e invertebrati; – erbivori, carnivori e onnivori; – ovipari, ovovivipari e vivipari.
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
• Eseguire trasformazioni in laboratorio.
• Preparazione della marmellata.
L’uomo, i viventi e l’ambiente
• Acquisire le regole per una corretta alimentazione.
• La corretta alimentazione: la prima colazione.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.




TECNOLOGIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro Sperimento, imparo, comunico
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76)
Competenza digitale (p. 77) C4
Vedere e osservare
T1
T3 T5
T2 T6
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di materiali comuni.
• Osservazione di materiali naturali e artificiali.
• La storia di un materiale organico: il petrolio.
Prevedere e immaginare
• Orientarsi tra diversi mezzi di comunicazione. • I mezzi di comunicazione: dai segnali di fumo al computer.
Intervenire e trasformare
• Realizzare un oggetto in cartoncino.
• La storia dell’energia eolica.
• Costruzione di una rudimentale pala eolica.
TECNOLOGIA
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Unità di lavoro Momenti mitici
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76)
Competenza digitale (p. 77)
Vedere e osservare
T3
T6
T6
T5 T6
• Rappresentare un oggetto osservato con il disegno.
• Osservazione e rappresentazione con il disegno degli strumenti per esplorare il cielo: il binocolo, il cannocchiale e il telescopio.
Prevedere e immaginare
• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto.
• Costruzione di un cartoncino augurale per il Natale.
Intervenire e trasformare
• Utilizzare il programma PowerPoint.
• Il programma PowerPoint e le possibili funzioni.
TECNOLOGIA –Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1
T2
T3
T4
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.






T1
T6
T6




Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76)
Competenza digitale (p. 77)
Vedere e osservare
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni e testi.
• Le attività umane che influiscono sull’ambiente.
• Completamento di disegni e testi.
Prevedere e immaginare
• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto.
• Progettazione e realizzazione di un portapenne.
Intervenire e trasformare
• Acquisire fotografie sul computer.
T3
• Uso della macchina fotografica digitale, acquisizione delle immagini e loro utilizzo.
• Il programma PowerPoint e le possibili funzioni.
Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76)
T1
T6
T3
Competenza digitale (p. 77) C3 C4
Vedere e osservare
• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni e testi.
• Le attività umane che influiscono sull’ambiente.
• Completamento di disegni e testi.
Intervenire e trasformare
• Realizzare un prodotto digitale con il programma PowerPoint.
• Creazione di un prodotto digitale (testo + immagini) con il programma PowerPoint.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. T5
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio comportamento utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.




Competenza chiave Competenza in materia di cittadinanza (p. 77) C6
• Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé.
• Conoscere e rispettare alcune fondamentali regole di convivenza.
• Individuare un problema ambientale e proporre soluzioni.
• Conoscere e ricercare comportamenti ecologici.
• Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada.
• Conoscere e applicare le principali norme di igiene e profilassi delle malattie.
• Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione.
• Esperienze ludiche, di gioco di squadra, di lavoro di gruppo, di assunzione di incarichi finalizzate allo sviluppo delle abilità sociali.
• Le regole di convivenza nel gruppo classe, in famiglia, nel gioco, per strada.
• Comportamenti corretti verso piante e animali.
• Conoscenza di abitudini di culture diverse.
• Comportamenti ispirati alla tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà.
• Sviluppo dell’attitudine all’ordine e al rispetto degli attrezzi e degli spazi mediante discussioni guidate al fine di evitare azioni e comportamenti pericolosi.
• Osservazione, descrizione, discussione e formulazione di ipotesi di soluzione di problematiche ambientali.
• Elaborazione di un regolamento per la tutela dell’ambiente.
• Conoscenza e rispetto dei principali segnali stradali.
• Regole di comportamento come utente di servizi pubblici.
• Corrette abitudini per la cura della propria persona.
• Riflessioni su esperienze personali e discussioni per individuare comportamenti che favoriscano la prevenzione, la salute e il benessere.
• Corrette abitudini per una sana alimentazione.




RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
Contesto e obiettivi
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione.
Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica.
I principali scopi del quadro di riferimento sono:
a)individuare e definire le competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale;
b)fornire uno strumento di riferimento europeo al servizio dei decisori politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale didattico, degli specialisti dell’orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pubblici per l’impiego e dei discenti stessi;
c) prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle competenze in una prospettiva di apprendimento permanente.
Competenze chiave
Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
d)la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; e)per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.




Competenza alfabetica funzionale
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.
Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
Competenza multilinguistica (1)
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese (2).
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
A.
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
B.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.
(1) Mentre il Consiglio d’Europa utilizza il termine «plurilinguismo» per fare riferimento alle molteplici competenze linguistiche delle persone, i documenti ufficiali dell’Unione europea utilizzano il termine «multilinguismo» per descrivere sia le competenze individuali che le situazioni sociali. Ciò è dovuto, in parte, alla difficoltà di distinguere tra «plurilingue» e «multilingue» nelle lingue diverse dall’inglese e dal francese. (2) È compresa anche l’acquisizione delle lingue classiche come il greco antico e il latino. Le lingue classiche sono all’origine di molte lingue moderne e possono pertanto facilitare l’apprendimento delle lingue in generale.
Competenza digitale




La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.
Per Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a ciascuna competenza si rimanda al CD-Rom allegato alla Guida dov'è riportato l'intero documento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




1 - Spostarsi e orientarsi nello spazio
Italiano: Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
Geografia: Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante.
Matematica: Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o un oggetto prendendo come riferimento se stesso.
Educazione fisica: Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo riferimenti diversi da sé (altri e oggetti).
2 - Messaggi verbali e non
Italiano: Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti.
Tecnologia: Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione.
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
Educazione fisica: Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il corpo.
3 - Metodo della ricerca
Italiano: Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.
Storia: Individuare tracce e usarle come fonti di tipo diverso per ricavare conoscenze sul passato personale e familiare.
Geografia: Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi utilizzando le proprie carte mentali.
Scienze: Imparare ad apprendere attraverso il metodo scientifico.
Matematica: Comprendere una situazione problematica attraverso l’analisi e la comprensione del testo.
1 - I miti
Italiano: Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica. Storia: Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato.
Scienze: Descrivere la struttura della Terra.
2 - Il testo del problema
Italiano: Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche.
Matematica: Individuare nel testo di un problema i dati mancanti, superflui, nascosti.
3 - I percorsi
Matematica: Rappresentare percorsi su reticolati individuando la direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso.
Geografia: Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante.
4 - L’orientamento
Geografia: Leggere e interpretare carte geografiche.
Educazione fisica: Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità/successione, prima/dopo, lento/veloce).
Matematica: Riconoscere l’angolo come cambio di direzione e conoscere gli elementi costitutivi dell’angolo.
5 - Le piegature
Italiano: Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici.
Tecnologia: Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto.
Arte e immagine: Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti.
Educazione fisica: Migliorare il controllo di movimento delle mani nell’uso di oggetti e di attrezzi.
*Le competenze chiave sono elencate alle pagine 76-77.
C1
C3
C5
1 - Le simmetrie
Italiano: Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti.
Matematica: Costruire figure simmetriche rispetto a un asse interno o esterno alla figura.
Costruire figure simmetriche rispetto a un asse di simmetria orizzontale, verticale e obliquo.
Tracciare assi di simmetria.
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
2 - Il testo del problema
Italiano: Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche.
Matematica: Scrivere il testo di un problema sulla base di elementi dati.
Risolvere semplici problemi di logica.
3 - L’ambiente
Italiano: Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche.
Geografia: Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio.
Scienze: Comprendere il concetto di ecosistema e la sua struttura.
1 - L’alimentazione
Italiano: Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche.
Scienze: Acquisire le regole per una corretta alimentazione.
Storia: Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia.
2 - Le situazioni problematiche nella vita quotidiana
Italiano: Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche.
Matematica: Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale per la soluzione di problemi. Conoscere e usare misure convenzionali di valore: l’euro.
Storia: Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi.
Educazione fisica: Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un gioco di squadra. Sviluppare la capacità di prendere iniziative e di elaborare soluzioni di problemi attraverso il gioco di squadra.
3 - Il ritmo e la danza
Italiano: Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici.
Educazione fisica: Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del corpo.
Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo e con piccoli attrezzi.
Matematica: Costruire sequenze numeriche, dato l’operatore. Scoprire l’operatore di una sequenza data.
*Le competenze chiave sono elencate alle pagine 76-77.








Le Indicazioni metodologiche predisposte per ogni disciplina sono accompagnate dal relativo elenco dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria” così come riportati nelle nuove Indicazioni nazionali.
Ciascun traguardo è contrassegnato dalla lettera . T
Giunti in classe terza, i bambini hanno acquisito le abilità linguistiche di base, che devono essere perfezionate e potenziate attraverso un percorso ricco di momenti ludici, per sostenere costantemente la motivazione all’apprendimento.
Le proposte che si riferiscono alle abilità di base sono presentate separatamente, ma si integrano con continui richiami. Gli argomenti di ogni bimestre sono trattati in una prospettiva interdisciplinare.
Ascolto e parlato
È compito dell’insegnante creare un clima favorevole alla comunicazione, in cui il bambino abbia l’opportunità di esprimersi e impari a saper ascoltare: è il metodo più semplice e diretto per acquisire informazioni e notizie. Una parte della giornata scolastica sarà dedicata alla conversazione.
In questa fase l’insegnante:
svolge il delicato ruolo di moderatore stimolando ogni alunno a intervenire nello scambio verbale in modo adeguato rispetto alle diverse situazioni comunicative e nell’osservanza delle regole della conversazione collettiva;
promuove l’acquisizione di strategie per l’ascolto, come la ricerca della posizione più adatta;
guida gli alunni a mantenere l’attenzione per periodi di tempo sempre più lunghi;
stimola ciascun alunno a interagire in modo attivo e creativo con i compagni superando il classico schema della lezione frontale;
crea situazioni comunicative in cui il bambino faccia esperienza del parlare per chiedere, convincere, riferire, descrivere e spiegare.
Per ogni bimestre sono proposti dei nuclei tematici che si collegano anche alle altre discipline e sono introdotti dall’ascolto e/o lettura di brani, per accendere la curiosità degli alunni verso un determinato argomento.
Il percorso che proponiamo è il seguente:
con domande stimolo l’insegnante focalizza l’attenzione degli alunni sugli aspetti fondamentali del brano ascoltato e/o letto;
Indicazioni metodologiche
Traguardi per lo sviluppo delle competenze




l’insegnante incoraggia gli alunni a riferire vissuti e opinioni personali relativi all’argomento trattato e nella discussione fa confrontare i diversi punti di vista;
gli alunni leggono autonomamente brani relativi al tema affrontato e ne riferiscono il contenuto con l’aiuto di mappe, schemi e tabelle;
con il supporto di immagini e/o di modelli guida gli alunni elaborano testi di diverso tipo.
Lettura
È fondamentale che i bambini vivano l’esperienza del leggere in modo significativo e coinvolgente e che considerino i libri come oggetti di piacere.
Molteplici sono le strategie per il raggiungimento di tali obiettivi:
l’ascolto della lettura dell’insegnante;
l’animazione della lettura;
l’allestimento della biblioteca di classe;
la costruzione di giochi a partire da libri;
l’allestimento di una mostra con prodotti realizzati dagli alunni;
le visite guidate in libreria;
l’incontro con autori di libri per bambini.
L’azione didattica deve mirare a formare “un buon lettore” che sappia:
leggere ad alta voce, rispettando le pause e usando la giusta intonazione;
capire il contenuto di un testo;
comprendere lo scopo per cui è stato scritto, cioè narrare, descrivere, informare o regolare.
Proponiamo un percorso che si sviluppi attraverso la lettura di semplici testi per giungere all’analisi testuale di brani più lunghi e complessi, sia a livello lessicale che contenutistico.
Si consiglieranno numerose esercitazioni allo scopo di:
migliorare l’abilità tecnica della lettura silenziosa e a voce alta;
riconoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura;
guidare gli alunni alla scoperta delle strategie per la comprensione del testo;
intraprendere l’analisi dei principali generi di narrazione breve, sia fantastica (favola, fiaba, mito, leggenda) che realistica (lettera, diario, racconto realistico);
avviare al riconoscimento delle sequenze narrative.
Le letture proposte sono accompagnate da domande a risposta aperta, a scelta multipla e del tipo vero/falso, che hanno la funzione di:
abituare alla riflessione personale e al confronto con i compagni;
avviare all’argomentazione;
stimolare alla comprensione, alla ricerca lessicale e alla produzione guidata e/o autonoma.




Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Scrittura
Le proposte riguardanti la scrittura si sviluppano parallelamente a quelle di lettura: gli alunni sono stimolati a produrre elaborati di vario tipo, solo dopo aver letto e analizzato i diversi generi testuali.
In classe terza gli alunni hanno acquisito la tecnica della scrittura, pur se con notevoli differenze. Per consentire anche a quelli meno abili di acquisire idonee competenze, presentiamo esercitazioni con un livello crescente di difficoltà.
Le attività di scrittura devono avere un riscontro pratico: la scuola deve essere il laboratorio in cui gli alunni sperimentano le tecniche che utilizzeranno nella vita di tutti i giorni.
È opportuno guidarli gradualmente ad analizzare e a produrre diversi tipi di testo, a seconda dello scopo che intendono conseguire nella realtà quotidiana:
stabilire rapporti con gli altri;
esprimere emozioni e stati d’animo;
rappresentare la realtà;
immaginare mondi fantastici.
Saranno proposte esercitazioni per elaborare:
testi descrittivi, soggettivi e/o oggettivi, che presentano le caratteristiche di persone, animali, ambienti, paesaggi;
testi narrativi, che hanno lo scopo di conservare la memoria e/o informare di un fatto reale o immaginario;
testi regolativi, che suggeriscono comportamenti e procedure da seguire;
testi espositivi, che trasmettono notizie, illustrano argomenti o espongono attività svolte, delle quali si presentano strumenti, metodi e tempi.
Allo stesso tempo gli alunni saranno stimolati a esprimere per iscritto:
sentimenti, emozioni e stati d’animo personali;
opinioni, giudizi, commenti su esperienze individuali e/o collettive.
Per il riassunto sarà opportuno chiarire che:
riassumere significa ridurre, sintetizzare, rielaborare in forma più breve un testo senza fargli perdere il senso originario;
le tecniche per riassumere variano a seconda del tipo di testo;
nel riassunto di un testo narrativo non possono mancare alcune informazioni essenziali, cioè il fatto, il tempo, il luogo, i personaggi, lo sviluppo dei fatti, la conclusione.
Elaborare una sintesi è un’attività molto complessa, perciò gli alunni saranno avviati a questa pratica sperimentando molteplici tecniche di riduzione del solo testo narrativo:
il supporto di domande guida e/o di immagini;
la divisione del brano in fasi e sequenze;
la sottolineatura del testo.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua




Le attività di riflessione sugli usi della lingua si riferiscono all’ortografia, alla morfologia e alla sintassi, che saranno proposte in forma di gioco, scoperta, manipolazione delle parole attraverso cruciverba illustrati, giochi di parole, rime, filastrocche, scioglilingua, fumetti.
Le schede relative a ogni bimestre sono presentate secondo un ordine progressivo, ma l’insegnante può decidere le modalità e i tempi più opportuni per proporle ai propri alunni, nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento.
Le proposte operative si articolano in tre fasi principali: l’osservazione, il riconoscimento della regola e l’esercitazione.
L’acquisizione del lessico e delle regole della lingua italiana è lenta e graduale e la pratica della lettura incide in maniera decisiva su tale processo: il bambino che legge spesso e con piacere acquisisce maggiore familiarità con la lingua scritta e più velocemente ne scoprirà e comprenderà le regole.
ITALIANO: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.




Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’educazione musicale ha come obiettivo primario la formazione delle abilità musicali attraverso il potenziamento della pratica corale-strumentale e motoria, privilegiando un percorso trasversale con le diverse proposte didattiche.
Nelle indicazioni nazionali per il curriculo della scuola del primo ciclo d’istruzione si legge:
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.
L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due dimensioni:
a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme;
b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato.
Da tale lettura si deduce che la finalità prioritaria dell’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola primaria è il saper costruire occasioni per utilizzare la musica come momento di comunicazione, anche attraverso situazioni ludiche che prevedano l’uso di strumentari didattici e di apparecchiature multimediali.
Le proposte didattiche mireranno perciò a sviluppare:
la pratica vocale e corale;
la pratica ritmica con l’uso di semplici strumenti a percussione;
il movimento corporeo e la drammatizzazione in musica;
la conoscenza degli strumenti musicali più popolari.
MUSICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.




Nel delineare il percorso di Arte e immagine si deve tener conto delle esperienze pregresse dei bambini e dell’influenza che hanno i linguaggi delle immagini sui processi cognitivi e affettivi e sui modelli di comportamento in generale. Le attività proposte mirano al conseguimento di competenze trasversali comunicative di espressione, osservazione e comprensione, come previsto dalle Indicazioni ministeriali. Principalmente i bambini devono acquisire la consapevolezza che per comunicare, oltre alle parole, si possono usare le immagini, le forme e i colori.
Attraverso la didattica laboratoriale, i bambini svilupperanno una sensibilità artistica e la capacità di esprimersi e comunicare usando le tecniche proprie del linguaggio visuale.
La dimensione operativa contribuisce, inoltre, allo sviluppo delle capacità collaborative: i bambini sperimentano l’efficacia della cooperazione nella realizzazione di un progetto condiviso. Il percorso proposto prevede una molteplicità di esperienze:
l’esplorazione di forme, oggetti, immagini presenti nell’ambiente circostante;
la manipolazione di materiali diversi;
il modellaggio di materiali plastici;
l’utilizzo di colori, strumenti, materiali e tecniche in modo non convenzionale.
Poesie, racconti fantastici e/o realistici, musica, ricorrenze tradizionali saranno lo stimolo per lo svolgimento delle attività e offriranno occasioni per rielaborazioni personali.
Contemporaneamente gli alunni saranno sollecitati ad analizzare immagini e opere d’arte per riconoscerne le principali funzioni. Il rafforzamento della preparazione culturale e civica costituirà un vantaggio per la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.
In un’ottica interdisciplinare numerosi sono gli agganci alle varie discipline. I fumetti, le descrizioni di ambienti e paesaggi sono argomenti presenti sia nelle Proposte di Italiano che in quelle di Arte e immagine e sono trattati da diversi punti di vista, che finiscono con l’integrarsi a vicenda.
Elementi geometrici e simmetrie sono approfonditi in Matematica e, contemporaneamente, costituiscono la base di composizioni libere, non stereotipate in Arte e immagine.
ARTE E IMMAGINE: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.




Indicazioni metodologiche
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
La disciplina “Educazione fisica” contribuisce, insieme alle altre discipline, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea. Gli alunni dovranno imparare a “stare bene con se stessi”, a prendersi cura della propria persona e del proprio benessere.
Attraverso i giochi di movimento gli alunni potranno esplorare lo spazio, conoscere il proprio corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo efficace.
La partecipazione alle attività motorie dovrà essere un momento di grande gioia e dovrà essere finalizzata all’accettazione della presenza “dell’altro” e al desiderio di rendersi disponibile a momenti di interazione con i propri compagni.
È opportuno creare, nell’ambiente dove si svolge l’attività motoria, un clima sereno e caloroso e il rapporto tra gli allievi e l’insegnante deve entrare nella dimensione dell’ “empatia”, cioè dell’affiatamento e della disponibilità reciproci.
L’esercizio-gioco che privilegia l’esecuzione in gruppo è la soluzione ottimale da proporre ai bambini che saranno liberi di scegliersi un compagno di gioco.
Si consigliano anche momenti di attività a coppie.
La palestra dovrà diventare un luogo in cui i bambini sentono di potersi muovere liberamente e potrà essere decorata con cartelloni murali, creati dagli allievi, che illustrino momenti salienti della loro attività motoria.
La mancanza della palestra non può costituire un alibi per non fare attività. È ideale uno spazio all’aperto nella stagione consentita, anche se attrezzato con materiale di fortuna (scatole di cartone, mattoncini, rami d’albero ecc.).
Tutte le attività o esercizi proposti non dovranno essere eseguiti in ordine determinato e ogni insegnante potrà scegliere quegli esercizi, giochi o attività che ritiene più adatti ai bisogni e alle esigenze dei propri alunni.
Come già sottolineato nei precedenti volumi, l’insegnamento della storia e della geografia nelle prime due classi è stato finalizzato all’acquisizione, da parte degli alunni, della capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio.
Questo terzo anno rappresenterà una tappa importante perché, con metodologie didattiche meno ludiche e più strutturate, gli alunni impareranno a:
ricavare informazioni da testi diversi;
“leggere” documenti;
organizzare le informazioni secondo criteri dati;
inserire un singolo evento in un periodo storico più ampio;
trovare collegamenti tra eventi contemporanei;
ordinare eventi in ordine cronologico;
distinguere elementi naturali e antropici;
orientarsi;
comprendere il significato di sviluppo sostenibile.




L’obiettivo principale sarà far acquisire agli alunni gli strumenti operativi e intellettuali indispensabili per cogliere i nessi antropologici, fisici, economici e socio-politici che strutturano la realtà. Quando gli alunni saranno in grado di leggerla secondo questa chiave, e non solo su un piano meramente descrittivo, comprenderanno la realtà e daranno un personale contributo agli interventi su di essa.
EdUCAzIONE fISICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
L’insegnamento della Storia concorre a sviluppare il pensiero nei bambini di scuola primaria attraverso:
la costruzione delle strutture temporali di base per l’organizzazione e l’analisi delle informazioni sul passato;
la comprensione del passato come un aspetto della realtà mediante procedure conoscitive definite;
l’acquisizione dell’ abilità di ricavare informazioni dalle fonti
Ogni curricolo di Storia deve consentire all’alunno di appropriarsi di basilari strumenti cognitivi e operativi:




la capacità di organizzare piccole quantità di informazioni sul passato;
la capacità di operare con gli strumenti elementari della cronologia;
la capacità di leggere per acquisire informazioni dalle fonti;
la comprensione delle misure e dei termini cronologici convenzionali della Storia;
la comprensione della necessità dell’uso delle fonti e dell’elaborazione delle informazioni per costruire conoscenze del passato;
la consapevolezza che dietro ogni conoscenza storica c’é un’attività di ricerca.
È indispensabile motivare gli alunni alla conoscenza del passato e allo studio della Storia.
Nella metodologia l’insegnante darà importanza:
all’organizzazione temporale;
al ruolo dello storico;
alla documentazione;
alla distinzione tra informazioni certe, probabili, ipotetiche.
Gli alunni percepiranno, così, che la conoscenza storica è opera del lavoro storiografico.
STORIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.




Nei primi due anni gli alunni hanno imparato, attraverso l’approccio senso-percettivo, a osservare, analizzare e conoscere ogni elemento dell’ambiente circostante.
In classe terza l’insegnamento della Geografia si arricchisce di contenuti ed è compito dell’insegnante renderlo piacevole, evitando che possa essere considerato quasi esclusivamente mnemonico.
A torto, da più parti, si ritiene che la conoscenza da acquisire attraverso l’insegnamento della Geografia riguardi essenzialmente:
la localizzazione dei luoghi e il loro nome (cartografia e toponomastica);
i caratteri quantitativi e qualitativi dei luoghi e dei loro abitanti (descrizione e memorizzazione dei medesimi).
In realtà chiunque possegga un atlante, oppure un computer, può ottenere tutte le informazioni in proposito, anche solo facendo un paio di clic in Internet.
Non è questo, però, lo scopo dell’insegnamento della Geografia.
Più che imporre lo studio e la memorizzazione di tutte le informazioni, è fondamentale che l’insegnante favorisca l’uso degli strumenti per giungere a comprendere il mondo nelle sue diversità naturalistiche e antropiche. In tal modo la Geografia aiuterà gli alunni anche a capire le loro responsabilità e i loro diritti rispetto al mondo che li circonda.
La Geografia non è mai soltanto racconto di viaggio: se non dà spiegazioni, non è Geografia.
GEOGRAfIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.




Traguardi per lo sviluppo delle competenze
In classe terza i bambini devono consolidare conoscenze, abilità e competenze già acquisite nelle classi precedenti e devono arricchirle attraverso un progressivo passaggio, più formalizzato e maturo, dall’attività senso-percettiva e manipolatoria a quella più formale e astratta.
L’insegnante dovrà proporre iniziative didattiche che, pur trattando nuovi obiettivi, contengano il richiamo costante agli apprendimenti precedenti.
Il gioco, la curiosità, l’esplorazione, la scoperta, la concretezza delle proposte dovranno continuare a essere i principi metodologici fondamentali cui ispirarsi.
L’alunno di classe terza, pur essendo pronto a guardare la realtà in modo più problematico e a “operare” su di essa per comprenderne leggi e meccanismi, continua a essere legato al dato concreto e a essere ingannato da sensi e percezioni.
Il suo ragionamento è ancora vincolato al “qui” e “ora”, ma l’alunno è pronto per imparare a utilizzare schemi concettuali e operativi propri dello scienziato.
Queste caratteristiche di approccio al reale dovranno continuare ad esistere, ma in una nuova dimensione, in cui la rappresentazione, l’immaginazione e la previsione di “ciò che potrebbe accadere se…” incomincino a essere i nuovi modi (più idonei, più utili, più efficaci) per guardare e conoscere la realtà.
La maturazione di questi nuovi stili cognitivi presuppone sempre più attente e precise capacità di osservazione e individuazione delle situazioni problematiche, nonché il conseguimento di meccanismi e automatismi, come espressione di conquiste concettuali certe e ben acquisite. Il gioco con i numeri, con le forme, con i problemi, con le misure e con i se dovrà prefigurarsi come un’avvincente avventura e una coinvolgente sfida, in cui il dubbio, la prova del vero e la riflessione critica prima si affiancano e poi si distinguono dalla fantasia, dall’affabulazione e dall’incanto, che sono le modalità con cui inizialmente i bambini percepiscono, conoscono e si confrontano con la realtà e con gli altri.
Sarà cura dell’insegnante, a tale scopo, predisporre un adeguato ambiente di apprendimento, mirato a stimolare in ogni singolo alunno il piacere della scoperta, la soddisfazione delle proprie padronanze conoscitive e la voglia di proseguire per incrementare le capacità di apprendimento.
In questa fascia di età lo sviluppo delle capacità concettuali deve obbligatoriamente passare attraverso esperienze prima di tipo percettivo, manipolatorio e operativo e solo in un secondo momento di tipo astratto, perciò l’insegnante, per un corretto processo d’insegnamento/apprendimento, imposterà ogni iniziativa didattica nel rispetto di quattro aspetti fondamentali:
osservazione;
operatività sul piano concreto, ludico e cooperativo;
riflessione;
verifica.




La metodologia e la didattica dell’insegnamento della matematica, così come dell’insegnamento di tutte le discipline di natura scientifica, sono fondate su questi quattro peculiari aspetti, che saranno resi concreti dall’insegnante, tenendo costantemente operanti alcuni principi fondamentali: l’interesse, la curiosità, la collaborazione e il lavoro individuale. Il rispetto di tali principi è necessario affinché ogni alunno acquisisca un “modus operandi” di tipo scientifico, che lo abitui a guardare e affrontare il mondo con occhi critici e consapevoli.
Si elencano qui di seguito, desunti dalle Indicazioni Nazionali 2012, i principali obiettivi che andranno perseguiti nel corso del nuovo anno scolastico e su cui costruire le competenze matematiche dell’allievo.
Numeri
Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali in notazione decimale entro il migliaio.
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 1000 e per salti di due, tre...
Confrontare e ordinare i numeri entro il 1000 utilizzando i simboli >, <, =.
Comporre e scomporre i numeri in migliaia, centinaia, decine e unità.
Eseguire mentalmente semplici calcoli con i numeri naturali.
Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali.
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino al 10.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali (entro i decimi).
Spazio e figure
Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o un oggetto prendendo come riferimento se stesso.
Rappresentare percorsi su reticolati individuando la direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali.
Relazioni, dati e previsioni
Classificare numeri, figure, oggetti in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.
Individuare i criteri adottati in una classificazione rappresentata mediante i diagrammi di Venn, di Carroll, ad albero.
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie e l’unità di misura convenzionale per la lunghezza.




Traguardi per lo sviluppo delle competenze
MATEMATICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Nei primi due anni di scuola primaria lo studio delle Scienze si è essenzialmente connotato come interdisciplinare.
In classe terza si sistematizzano le conoscenze che saranno acquisite sempre attraverso l’applicazione del “metodo scientifico”.
Per il duplice aspetto formativo e culturale della didattica delle Scienze e della Tecnologia, l’insegnante ricorrerà, fin dai primi giorni di lezione, a una corretta metodologia induttivo-sperimentale e a un approccio interdisciplinare ai problemi.
Le scienze sperimentali (fisica, chimica, scienze della natura), con il loro aspetto empirico e teorico, sono particolarmente idonee a stimolare lo sviluppo dei processi cognitivi nel bambino.




Quando l’alunno si trova nello stadio del pensiero concreto, l’insegnamento scientifico, opportunamente condotto, stimola le capacità di manipolare, osservare, descrivere, registrare, confrontare. Il bambino, crescendo, si abitua a collegare le osservazioni fatte, a stabilire relazioni di causa ed effetto, a formulare ipotesi, a programmare verifiche, a trarre le prime deduzioni, a raggiungere gradualmente lo stadio del pensiero formale.
È necessario sfatare l’opinione, abbastanza diffusa, che i bambini debbano limitarsi a fare delle osservazioni sul mondo della natura, per acquisire un certo “habitus” scientifico.
Si ritiene, invece, che le nozioni che essi apprendono debbano essere inquadrate in un sistema rigoroso e coerente: le osservazioni dei bambini non devono rimanere frammentarie e incongruenti, ma essere finalizzate all’acquisizione di concetti tra loro collegati, secondo un percorso programmato dall’insegnante.
Nella scuola primaria è necessario saper commisurare le proposte didattiche allo sviluppo cognitivo del bambino: è noto che, per quasi tutto il periodo della scuola primaria, è in grado di eseguire solo operazioni basate su entità concrete.
La metodologia delle Scienze e della Tecnologia è prevalentemente sperimentale: le proposte sono strutturate in modo che l’alunno, partendo dalla manipolazione diretta degli oggetti, sia il protagonista della sperimentazione.
Attraverso l’osservazione e la descrizione delle proprietà degli oggetti, il bambino è avviato a una corretta metodologia dell’indagine.
Ciò consente di:
effettuare classificazioni e seriazioni;
introdurre l’idea che, attraverso lo studio delle proprietà caratteristiche di una sostanza, è possibile individuarla anche quando essa è “confusa” con altre;
correlare le proprietà di un oggetto e il suo uso;
comprendere che le proprietà di un oggetto possono cambiare a causa di “interazioni”.
Anche una forma d’insegnamento che contempli un’attività sperimentale in laboratorio si rivela soddisfacente.
Molte attività proposte prevedono che gli alunni lavorino in gruppi, così da acquisire la capacità di collaborare e la consapevolezza che in ogni ricerca scientifica è di grande importanza la fase di confronto e di discussione dei risultati.




SCIENzE: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.
TECNOLOGIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio comportamento utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.




Il parallelismo evolutivo nel bambino, dalla sua nascita fin verso i 13/14 anni, tra la sfera dell’intelligenza e quella etico-sociale è una caratteristica che è stata studiata e ampiamente dimostrata da eminenti personalità, da Jean Piaget in poi. Il decentramento cognitivo conduce il soggetto a relazionarsi con la realtà, svincolandosi progressivamente dal dato senso-percettivo e della concretezza esperienziale fino ad arrivare a operare su di essa in termini immaginativi e astratti; quello etico-sociale e affettivo consente al bambino di passare dalla fase della anomia a quella della interiorizzazione delle regole (prima perché imposte e successivamente perché comprese e condivise) e non vi può essere decentramento cognitivo se non accompagnato da decentramento etico-sociale e affettivo. Si tratta di due processi che, benché autonomi e distinti, sono tra loro strettamente connessi e complementari. L’uno non esiste senza l’altro. Queste ricerche scientifiche sono alla base della necessità e dell’urgenza di inserire nella sfera educativa, scolastica e curricolare anche l’aspetto etico-sociale e affettivo della personalità del soggetto per un suo sviluppo armonico e integrale. Oggi, altre valide ragioni culturali danno il giusto peso a quest’aspetto dell’educazione, da quelle politico-sociali a quelle morali e religiose, da quelle familiari a quelle mondiali, da quelle legate ai processi di democratizzazione dei popoli a quelle che ineriscono la consapevolezza civile e democratica dell’esistere di ogni singolo uomo fino ad arrivare alla consapevolezza di sé e all’identità personale in relazione ai singoli altri, al gruppo e alla comunità.
La scuola italiana, sia pure con finalità, motivazioni e impostazioni metodologico-didattiche diverse, ha sempre cercato di curare e attribuire giusta importanza allo sviluppo etico-sociale del soggetto. Nel fare proprie le motivazioni scientifiche e culturali, che ne sono alla base, tende a dare oggi dignità di disciplina a questo importante aspetto della vita umana.
Questa disciplina ha, tuttavia, una caratteristica interdisciplinare e trasversale rispetto a tutte le altre che connotano l’attività didattica soprattutto nella scuola primaria: è uno dei principali collanti che conferiscono unitarietà ai processi di insegnamento-apprendimento.
La finalità ultima è aiutare il soggetto nel lungo e impegnativo cammino verso la conquista di quei principi di vita e di condotta che sono alla base del concetto di “cittadinanza attiva”: ogni uomo, nel rispetto delle regole e delle norme che governano la vita civile della società, arriva alla consapevolezza di sé e della propria dignità in un vasto tessuto di rapporti umani, regolati da un sistema di diritti cui fa da contrappeso uno speculare sistema di doveri.
Questo cammino, che inizia già in ambito familiare, deve essere, nella scuola, progressivamente sorretto e supportato, in modo sistematico e intenzionale, da una precisa progettazione opportunamente declinata in obiettivi, attività e contenuti e opportunamente condotta con un’impostazione metodologica e didattica attiva, concreta, ludica ed esperienziale generata sempre dal vissuto diretto o indiretto del bambino.

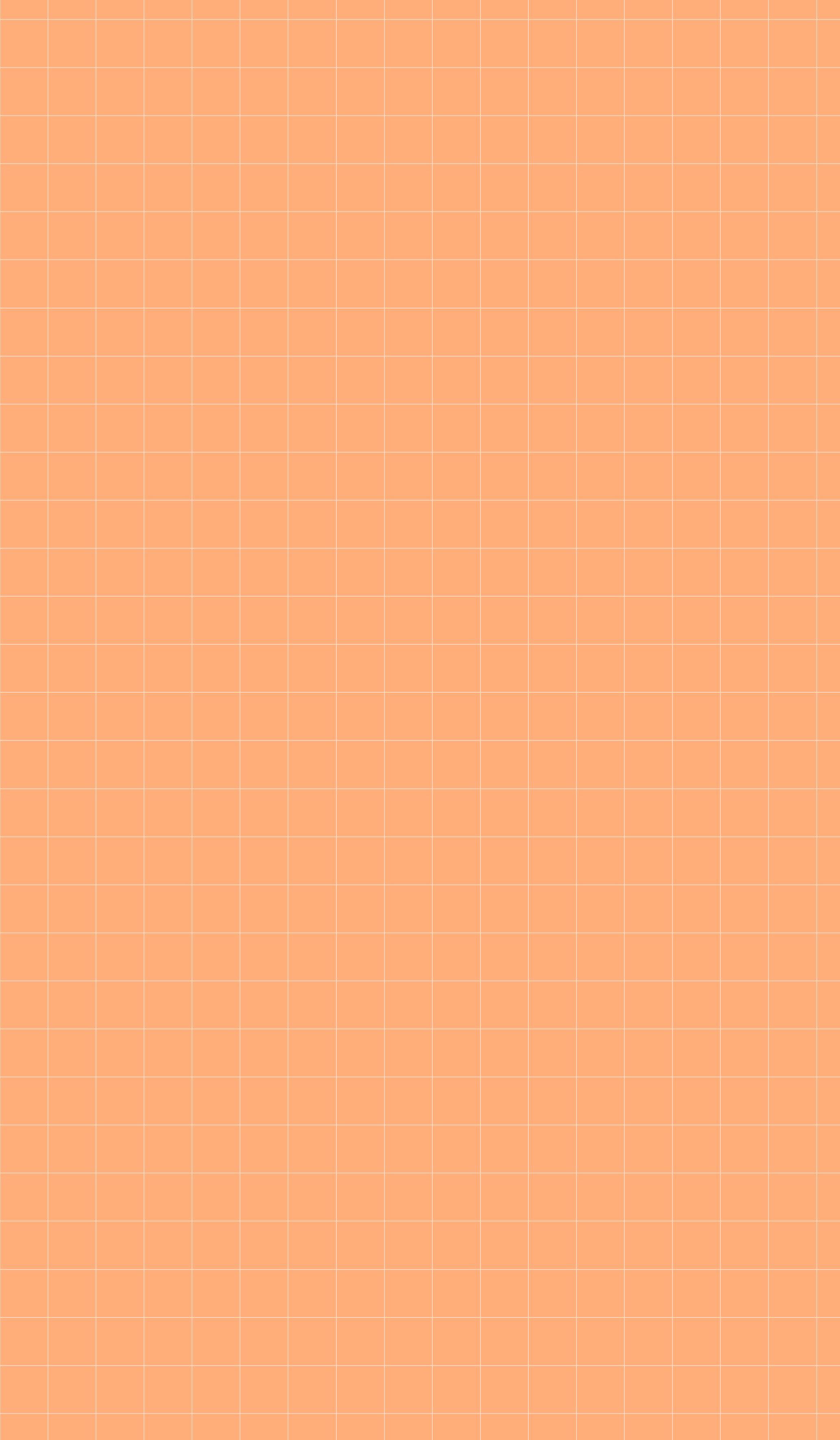
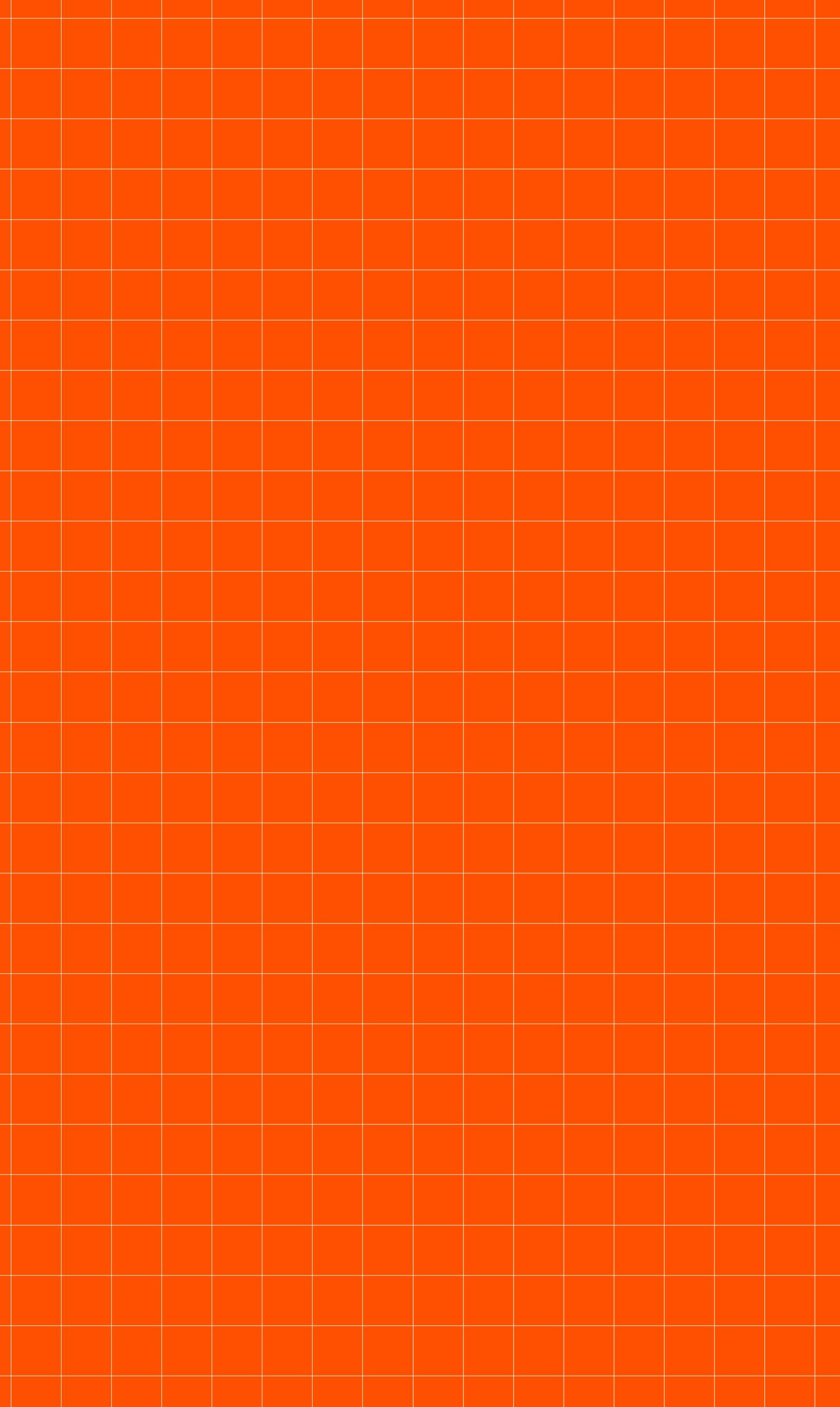


Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: , , e (v. pag. 83).
Competenza chiave Competenza alfabetica funzionale (p. 76) C1
• Raccontare esperienze vissute e storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie.
• Esprimere opinioni, sentimenti e stati d’animo.
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.
• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
• Produrre testi per esprimere sentimenti, stati d’animo, opinioni.
• Produrre testi per raccontare vissuti e storie.
• Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura.
• Riflettere sulla frase.
T8
• Le vacanze e il ritorno a scuola. Ricordi e cambiamenti: – conversazioni guidate; – questionari; – esposizione di sensazioni e stati d’animo.
• Le favole e le regole di comportamento: – ascolto di favole lette dall’insegnante; – ordinamento di immagini in sequenza; – racconto di storie con il supporto di immagini.
• Lettura autonoma di semplici testi: – associazione di immagini a frasi; – completamento di semplici cloze; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• Le vacanze e il ritorno a scuola: – discussioni guidate; – rappresentazione con il disegno; – elaborazione di didascalie esplicative di immagini in sequenza; – racconto di esperienze personali in ordine cronologico.
• Le principali difficoltà ortografiche: digrammi, trigrammi, gruppi di lettere, raddoppiamenti di consonante.
• L’ordine delle parole nella frase.
– Giochi linguistici.
– Soluzione di cruciverba.
– Riordino di parole all’interno di frasi.
Italiano



Anche in classe terza, l’argomento vacanze costituirà una preziosa occasione da cui trarre numerosi spunti operativi; è forte infatti il desiderio dei bambini, al rientro a scuola, di raccontare e condividere con il gruppo classe le proprie esperienze. In tal modo renderemo serena e piacevole questa fase iniziale di accoglienza che per qualche bambino, soprattutto se nuovo della classe, potrebbe essere fonte di ansia e preoccupazione.
È importante che tutti, anche i più timidi e quelli che non sono andati in vacanza, abbiano la possibilità di riferire liberamente le proprie esperienze.
L’instaurazione di un clima sereno nella classe, imperniato sul dialogo, l’ascolto e la collaborazione, unito alla conoscenza delle caratteristiche, dei bisogni e delle potenzialità degli alunni, sono le condizioni necessarie per una corretta impostazione dell’azione didatttica.
Le attività previste per il mese di settembre avranno lo scopo di:
verificare l’acquisizione da parte dei bambini degli obiettivi minimi strumentali della classe seconda;
riprendere il discorso iniziato lo scorso anno e interrotto dalla pausa estiva;
preparare quelle condizioni che permetteranno agli alunni di procedere gradualmente nell’acquisizione di altri concetti e abilità.
• Raccontare esperienze vissute e storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie
È consigliabile riprendere in classe terza i piccoli “riti” cui gli alunni sono ormai abituati: creiamo ogni mattina un clima accogliente, facendo disporre i bambini in cerchio, in una posizione comoda, e iniziamo le attività con un gesto concordato.
Questa prima fase dell’anno scolastico, in cui insegnanti e alunni si salutano, parlano e ascoltano, è un momento utile per osservare i comportamenti dei bambini e valutare la loro capacità di mantenere l’attenzione sul messaggio orale, rispettare il turno nella conversazione, fornire le informazioni richieste, esporre il contenuto di una storia, riferire propri vissuti ed esprimere idee personali.
Inizialmente parliamo delle vacanze: i bambini generalmente sono impazienti di raccontare i momenti di svago e le esperienze vissute in famiglia.
Offriamo loro una serie di spunti di conversazione:
i cambiamenti avvenuti nella composizione della classe (arrivo o trasferimento di compagni) e nell’aspetto fisico (l’altezza, i capelli, l’abbronzatura);
le informazioni sulle località in cui sono stati;
le esperienze che hanno vissuto;
le persone con cui hanno condiviso le vacanze;
i mezzi di trasporto utilizzati;
i motivi per cui la vacanza è stata piacevole/sgradevole;
gli stati d’animo al rientro a scuola;
i propositi per il nuovo anno.
per la terza



Introduciamo i vari argomenti leggendo, o facendo leggere, divertenti filastrocche sulla scuola.
Antologia pagg. 114-115 È settembre! Siamo pronti per la terza
• Esprimere opinioni, sentimenti e stati d’animo
Invitiamo gli alunni a completare un semplice questionario e allestiamo un cartellone con i materiali che hanno portato dalle vacanze: fotografie, cartoline, disegni, ricordi ecc.
Scheda CD n. 1 Pronti per la terza… via!
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile
Una particolare attenzione dedichiamo, anche quest’anno, all’ascolto della lettura dell’insegnante.
Varie sono le strategie per catturare l’attenzione dei bambini:
accompagnare la lettura con gesti;
usare un tono enfatico della voce;
coinvolgere gli alunni con sguardi, per creare attesa o anticipare ciò che sta per accadere.
Leggiamo una storia accattivante, “Il lupo e i sette capretti”, poi formuliamo domande per accertarci che tutti ne abbiano compreso il contenuto:
Di chi parla la storia?
Dove si svolge?
Che cosa succede prima?
Che cosa succede dopo?
Come si conclude?
A questo punto gli alunni possono numerare le vignette per ordinare le varie sequenze della storia.
1. La capra Berta lascia i suoi sette caprettini soli in casa perché deve andare al mercato. Prima però raccomanda ai figli di fare attenzione al lupo e di non aprire a nessuno.
2. Per due volte il lupo bussa alla porta e fa finta di essere la capra Berta, ma i caprettini lo riconoscono e non gli aprono la porta.
3. La terza volta che il lupo chiede di entrare in casa, i caprettini lo scambiano per la loro mamma e aprono la porta. Appena vedono il lupo, scappano terrorizzati.
4. I caprettini corrono a nascondersi, ma il lupo li trova e li divora. Soltanto il caprettino più piccolo, che si era infilato nella cassa dell’orologio, riesce a salvarsi.
5. La mamma torna a casa e scopre che cosa è successo, va a cercare il lupo e lo trova addormentato sotto un albero. Apre la pancia del lupo, tira fuori i caprettini, li sostituisce con dei sassi e ricuce tutto.
6. Quando il lupo si sveglia, sente una gran sete e va alla fontana in cerca di acqua, ma appena si sporge per bere, il peso della sua pancia gli fa perdere l’equilibrio. Così il lupo cade nell’acqua e annega.



La favola offre diversi spunti di riflessione, che servono a introdurre argomenti che svilupperemo nel corso dell’anno.
Tradizionalmente il lupo è presentato come un animale malvagio, perché può attaccare gli animali allevati dall’uomo: per questo motivo, è stato preda dei cacciatori e la specie è stata a rischio di estinzione per cui oggi il lupo vive protetto nei parchi nazionali.
Conosci altre favole che hanno il lupo per protagonista? Tu hai paura del lupo?
I genitori si preoccupano per i figli e fanno sempre tante raccomandazioni.
Quali raccomandazioni ti fanno i tuoi genitori? In quali occasioni? Ascolti i tuoi genitori?
Invitiamo gli alunni a esprimere un giudizio personale sulla storia ascoltata.
Antologia pagg. 112-113 Il lupo e i sette capretti
Scheda n. 1 Il lupo e i sette capretti
• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali
Per verificare la capacità di leggere e comprendere testi, proponiamo attività organizzate secondo la struttura dei test oggettivi dell’INVALSI. Al fine di evitare negli alunni l’insorgenza di stati di ansia e di tensione, cerchiamo di sdrammatizzare presentando in forma ludica testi semplici e divertenti e spiegando in modo chiaro che cosa è richiesto.
Suggeriamo la lettura del breve testo descrittivo “Le sette nane”, da cui gli alunni devono ricavare semplici informazioni e individuare i personaggi, associandoli alla corrispondente immagine.
Scheda n. 2 Le sette nane
Invitiamo gli alunni a completare un semplice cloze, o testo bucato, scegliendo le parole da una lista posta in fondo al testo.
Scheda n. 3 Il lupo
• Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le loro relazioni Leggiamo, o chiediamo agli alunni di leggere, la storia “La lucertola Gonzilla”, per rispondere a un questionario con quattro alternative di risposta, di cui solo una è esatta.
1. Gonzilla è una grossa lucertola.
2. Gonzilla è grossa e prepotente.
3. Gonzilla vuole il sole tutto per sé.
4. Malibù è una gazza.
5. Le lucertole vanno dalla maga Malibù per chiedere aiuto contro Gonzilla.
6. La maga prende una lente.
7. Malibù con la lente concentra i raggi di sole sulla testa della lucertola.
8. Alla fine Gonzilla corre a chiamare le altre lucertole.



9. L’acacia è un albero.
10. La gazza non ha la caratteristica di essere lenta.
11. I fatti raccontati si svolgono di giorno.
12. Il racconto vuol far capire che non dobbiamo essere egoisti.
Scheda n. 4 La lucertola Gonzilla
• Produrre testi per esprimere sentimenti, stati d’animo, opinioni
Prima di impegnare gli alunni nella scrittura, stimoliamoli a raccontare esperienze ed esprimere emozioni in relazione al tema delle vacanze. Nel corso dell’anno i bambini recupereranno e consolideranno abilità più complesse, per il momento proponiamo attività semplici, con numerose immagini da colorare e da completare con didascalie: evidenziamo che la scrittura è un potente mezzo per conservare la memoria di eventi e comunicare con gli altri.
Confrontiamo ciò che è possibile fare in vacanza con le attività che si svolgono a scuola.
In vacanza possiamo: trascorrere più tempo con la famiglia, dormire fino a tardi, vedere posti nuovi, conoscere nuovi amici ecc.
A scuola possiamo: stare con i compagni, imparare cose nuove ecc.
Scheda n. 5 In vacanza e a scuola
• Produrre testi per raccontare vissuti e storie
Dopo averne discusso, invitiamo gli alunni a scrivere un breve testo, “Presento la mia classe”, con il supporto di domande guida:
Da quanti bambini è formata la classe? Quante femmine, quanti maschi?
C’è qualche bambino nuovo? Come si chiama?
Quanti insegnanti lavorano con la classe? Come si chiamano? Quali attività svolgono?
Scheda n. 6 Presento la mia classe
Per ricordare il corretto uso dei connettivi temporali, facciamo raccontare un’esperienza collettiva, ad esempio il primo giorno di scuola, con il supporto delle immagini.
Prima siamo entrati nella nuova aula.
Poi ci siamo salutati.
In seguito abbiamo raccontato come abbiamo trascorso le vacanze.
Infine siamo tornati a casa.
Scheda n. 7 Benvenuti in terza!
• Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura
• Riflettere sulla frase
Rendiamo gradevole il rientro a scuola organizzando attività in forma di gioco: i bambini si divertiranno e contemporaneamente consolideranno gli apprendimenti.
Schede n. 8 Cruciverba • CD n. 2 Doppie in… vacanza • CD n. 3 Frasi in pezzi



L’insegnante ricaverà dati importanti per stabilire quali abilità e conoscenze hanno bisogno di essere recuperate dopo la pausa estiva. Proponiamo cruciverba di riepilogo delle principali difficoltà ortografiche, giochi di parole associati a immagini, ricche e accattivanti da colorare, e riordino di frasi.



Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: , , , e (v. pag. 88). T1 T2 T4 T8 T5
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
T8
T5
T1 T2
T1 T2
T4
• Riconoscere una storia come successione di fatti.
• Usare in maniera appropriata gli indicatori temporali.
• Riconoscere e utilizzare le fonti della storia.
• Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi nel tempo e nello spazio.
• Produzione della cronaca delle vacanze.
• Attività su contemporaneità e durata di fatti.
• Uso dell’orologio.
• Attività sui cicli temporali: settimana, mese, stagione, anno.
• Ricerca dei documenti per raccontare un proprio vissuto (le vacanze).
• Raccolta di testimonianze relative al passato dei propri nonni.
• Rappresentazione grafica di oggetti propri e del tempo dei nonni.
• Riconoscere una storia come successione di fatti
I primi giorni di scuola sono molto importanti per valutare quali nozioni, apprese durante l’anno scolastico precedente, gli alunni hanno memorizzato.
Le vacanze appena trascorse sono l’argomento principale per le prime attività.
Invitiamo gli alunni a raccontare la cronaca delle esperienze vissute, come successione di fatti nel tempo: episodi buffi, avventurosi o particolarmente piacevoli, nuovi amici conosciuti e luoghi visitati.
La produzione, esclusivamente orale, è eventualmente arricchita con disegni.
Proponiamo la lettura di un diario di viaggio e invitiamo i bambini a descrivere le loro vacanze, utilizzando la stessa tecnica narrativa adoperata dall’autore del seguente testo:
Una giornata a Capri
Appena sbarcati, con la navetta raggiungiamo il capolinea ad Anacapri quindi a piedi scendiamo in Piazza Vittoria e dopo una pizza napoletana possiamo iniziare la nostra visita di Anacapri.
Ecco cosa abbiamo visitato:
Villa San Michele
Fu fatta costruire dal medico e scrittore svedese Axel Munthe, con un bellissimo giardino botanico e la vista a strapiombo su Marina Grande. Qui sono conservati reperti archeologici recuperati da Munthe a Capri e



Anacapri: frammenti di sarcofagi, busti, pavimenti romani, marmi e colonne. Nel giardino c’è una tomba greca, mentre una sfinge in granito domina dal belvedere tutta l’isola di Capri. Nel suo libro “La Storia di San Michele” Munthe racconta del suo arrivo a Capri nel 1885 e della progressiva costruzione della villa; il complesso è articolato su più livelli; lo studio è al primo piano e la loggia attraversa pergole e colonne per giungere a un belvedere circolare che affaccia sul Golfo di Napoli.
La casa rossa
Di colore rosso pompeiano, situata in Via Orlandi, è una delle costruzioni più singolari dell’isola. Fu fatta costruire tra il 1876 e il 1899 accanto a un’antica torre quattrocentesca da un eccentrico colonnello americano il quale la arricchì con reperti archeologici trovati nelle varie località dell’Isola; dal 1990 è stata destinata dal Comune di Anacapri a spazio espositivo e attualmente ospita una mostra di pittura di artisti capresi dell’otto e novecento.
La Chiesa di san Michele Arcangelo
Bellissimo esempio di architettura barocca, la cui vera attrazione è il pavimento in maioliche colorate che rappresenta la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre ad opera di un angelo con la spada infuocata.
Le viuzze dell’isola sono strette con i negozi di ricordi capresi.
Nel pomeriggio scendiamo alla Grotta Azzurra per una visita d’obbligo all’attrazione principale dell’isola.
Gli esperti barcaioli prelevano i turisti e sulle loro barchette a remi si infilano nel cunicolo che si apre nella grotta trainando una catena murata all’ingresso e facendo stendere tutti sul fondo della barca dal momento che l’entrata della grotta è alta soltanto un metro. Una volta dentro si apre uno spettacolo mozzafiato: il cosiddetto Duomo Azzurro si mostra in tutto il suo splendore, con il suo indimenticabile colore: i giochi di luce creano riflessi turchesi e la grotta rifrange il colore del mare creando uno spettacolo luminoso che accende di luce blu tutta l’ampia volta della grotta.
Molte sono le cose che abbiamo dovuto tralasciare per mancanza di tempo: Villa Damecuta, il sentiero dei Fortini, la Certosa di San Giacomo… ma poco male, abbiamo la scusa per ritornare!
(dal sito www.cisonostato.it)
• Usare in maniera appropriata gli indicatori temporali
Attraverso il racconto delle vacanze, l’insegnante, oltre a verificare la capacità degli alunni di produrre oralmente la cronaca di un evento, valuta l’uso appropriato di alcuni indicatori temporali (prima, dopo, adesso, mentre ecc.), di fondamentale importanza nello studio di causa ed effetto dei fatti e della loro evoluzione temporale.
Il concetto di tempo, almeno intuitivamente ed empiricamente, dovrebbe essere stato suf ficien temen te interiorizzato nei due anni precedenti, attraverso attività scrupolosamente centrate sull’esperienza concreta.
Proponiamo esercitazioni sui concetti di successione temporale, contemporaneità e durata. In seguito ripresentiamo l’orologio ed esercizi per la lettura delle ore e dei minuti nel quadrante.
Schede n. 9 La mia giornata • n. 10 Il tempo e le ore



Verifichiamo in maniera divertente la conoscenza in successione dei giorni della settimana, dei mesi dell’anno e delle quattro stagioni, proponendo le seguenti filastrocche:
Lunedì andò da Martedì per vedere se Mercoledì avesse saputo da Giovedì se fosse vero che Venerdì avesse detto a Sabato che Domenica era festa.
www.filastrocche.it
Nel gennaio freddo e gelo.
A febbraio di nebbia il velo.
Marzo pazzo, agitatore.
Dolce è aprile col suo tepore.
Maggio, sbocciano le rose.
Giugno, messi rigogliose.
Luglio invita in riva al mare.
Arde agosto e fa sudare.
Nel settembre la poesia!
Vino a ottobre ed allegria!
Vien novembre, umido e tetro.
Poi dicembre ha tutti dietro.
Ecco i dodici fratelli, metà brutti, metà belli.
www.filastrocche.it
Le stagioni
Prima viene Primavera con i fiori sulla pianta, poi Estate calda e chiara quando la cicala canta, poi Autunno bruno e quieto con castagne e foglie rosse, poi Inverno infreddolito con starnuti, gelo e tosse.
R. Piumini, Poesie Piccole, Mondadori
Schede n. 11 I giorni della settimana e i mesi dell’anno • n. 12 Riconosco i mesi
• Riconoscere e utilizzare le fonti della storia
L’insegnante utilizza i documenti, che testimoniano le vacanze appena trascorse (foto, souvenir e cartoline), come supporto alla cronaca del vissuto degli alunni, conservandoli per le successive esercitazioni.
• Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi nel tempo e nello spazio
Gli alunni paragonano le proprie vacanze e quelle vissute dai loro nonni, quando erano bambini. Leggiamo il seguente racconto, in linea con l’argomento vacanze, e poi proponiamo di illustrarlo in sequenze, che verranno sistemate su di un cartellone con brevi didascalie di commento.
Il sogno della signora Eufemia De-Tappetti è diventato una realtà. Policarpo è riuscito a farsi subaffittare, da un suo collega, una casa di campagna nelle vicinanze di Frascati. Nei tre giorni precedenti alla partenza per la villeggiatura Policarpo non ha fatto che ripetere a tutto il vicinato:
–Ah, non ne posso piú; sarà meglio che ce ne andiamo subito al nostro villino.
–Un villino?
Pronti per la terza



–Oh, una cosa da niente: una palazzina di due piani, con un po’ di giardino. Venite pure a trovarmi... quando volete… ma è così lontano... c’è due ore di cammino, a piedi... con questo sole... e poi, una strada impossibile... il governo non pensa mai alle strade... ma venite pure, mi farete tanto piacere. La palazzina, tutt’insieme! È una casuccia rustica, molto vituperata dalle intemperie. Una porta sbocconcellata, munita di un semplice saliscendi, mette in una specie di stalla, che sarebbe la sala da pranzo, per la ragione che c’è la cucina fatta unicamente per abbrustolire le focacce dei tempi d’Isacco e di Giacobbe. Una magnifica scala di legno, tarlata a dovere, e abbellita di spaventose ragnatele, porta al secondo piano della palazzina, che si compone di una cameraccia schifosa, divisa in due da un tramezzo d’assi sconnesse, abitacolo sacro alle pulci, che professano un verace attaccamento ai membri della famiglia De-Tappetti. Il giardino consiste in un pezzetto di terreno incolto, pieno d’erbacce, di sterpi, tra cui cresce rigoglioso il papavero, l’ortica abbonda, e i cespugli di corbezzoli si aggraziano dei loro bottoni di corallo. Il terreno è cinto da una staccionata cadente, in un angolo si vede una cisterna in cui, secondo la leggenda che corre in paese, i gatti defunti avrebbero trovato l’estrema dimora fin dalla piú remota antichità.
Policarpo, per godere una mesata intiera tale delizia, ha promesso di pagare 22 lire dicendo:
–Il sacrificio è grave, ma la salute prima di tutto…
La partenza per la campagna è un vero avvenimento per la famiglia De-Tappetti, e per l’intero vicinato chesia detto a sua lode - non ci aveva mai creduto.
Le lenzuola dentro a un secchio - i fazzoletti e i calzoncini di Agenore stiacciati nella cazzerola - le calze e le mutande del genitore, pigiate bene dentro la pignatta - altri indumenti rassettati con garbo dentro parecchi utensili di cucina; il tutto caricato sul gobbone della serva, l’infelice Rosa, che viene spedita alla stazione due ore prima della partenza del convoglio.
La signora Eufemia s’è messa due abiti, quello per casa, e quello per fuori, uno sull’altro, a scanso di maggiori impicci. Policarpo ha le tasche piene d’ogni sorta di roba, dai pettini ai cucchiai, dalla scatolina del lucido per le scarpe, al macinino per il caffè. Il piccolo Agenore è ovattato di stracci per la cucina, di cartaccia per accendere il fuoco, ha una padella sullo stomaco e un soffietto sulla schiena, del quale dice talvolta di sentire il soffio, la qual cosa non è sufficientemente appurata dalla storia.
Tutti e tre hanno le mani impacciate da fagotti, in cui si celano i misteri della famiglia, dalle scarpe vecchie, alla conserva di pomidoro. I De-Tappetti salgono sopra un omnibus, e arrivano alla stazione un’ora prima della partenza del treno…
Finalmente la famiglia è in viaggio. Agenore non lascia un minuto il finestrino, e tempesta il babbo di domande imbarazzanti.
Finalmente si scende a Frascati.
La giornata è afosa; il sole scotta, la strada è faticosa, la polvere acceca, il caldo è soffocante; Agenore ha fuori un palmo di lingua; la signora Eufemia va in acqua dal sudore; l’infelice Rosa fa salire gli ultimi rantoli d’una serva oppressa al trono dell’eterno. Policarpo s’asciuga la fronte, con un grembiulino di Agenore, e dice con voce tronca e affaticata:
–Qui almeno... si respira un po’ d’aria... un po’ d’aria sana... fa piacere... in verità... che bella frescura!
–A me pare –soggiunge Rosa –che ci si crepi di caldo.



–Tu non calcoli il peso delle parole, disgraziata! –grida Policarpo –Tu calunni la villeggiatura, tu vorresti insinuare nel cuore inesperto del mio tenero figlio un sospetto: il sospetto che Policarpo DeTappetti sacrifichi 22 lire d’affitto per fargli soffrire in piena campagna il caldo insopportabile delle grandi città.
–Scusami tanto, ma io provo un caldo simile a quello di Roma. Policarpo, con un sorriso di profonda commiserazione:
–È naturale: tu ignori che cosa sia un termometro, il tuo caldo non è che un frutto della tua ignoranza!
La famiglia De-Tappetti entra in possesso della palazzina.
–Papà! quanto è brutta! –esclama il piccolo Agenore.
–Dio mio! –mormora la signora Eufemia –mi pare una spelonca da ladri.
–Voi vi fermate alle apparenze –brontola Policarpo –voi non cercate che l’opera dell’uomo, innalzate invece le vostre menti a contemplare la bellezza della natura.
La catapecchia, del resto, sarebbe comodissima, se non mancasse di tutto, specialmente di mobilio. Rosa accende il fuoco, e la palazzina si riempie di fumo. I De-Tappetti sono costretti a fare un cenino all’aperto, con cinque uova al tegame, e un po’ di prosciutto. All’ora delle galline vanno a letto. Rosa dorme in cucina sopra un pagliericcio e Agenore nella stanza superiore, sopra sei sedie, rese soffici da una quantità di stracci e di giornali vecchi.
Indi Policarpo si sveste e sale a letto: un letto alto quanto l’arco di Tito, con durezza analoga, e travertino.
Poco dopo è quasi colto da vertigini, e prima di chiudere gli occhi, formula questa preghiera: –Signore! Fate che domattina io riesca a ridiscendere sulla superficie della terra.
Adatt. da Gandolin, La famiglia De-Tappetti, Treves Milano 1912
Scheda n. 13 Vacanze a confronto
Una breve intervista ai nonni sarà lo spunto di conversazione per capire come siano cambiati mezzi di trasporto, modalità, mete, vissuti, oggetti ecc.
Concludiamo l’esercitazione realizzando un cartellone murale “Al tempo dei nonni e oggi”.



Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: e (v. pag. 89). T2 T5
Competenza chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (p. 77) C5
T5
T2
T2
T2
• Classificare un paesaggio.
• Conoscere diversi tipi di carte.
• Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali.
• Leggere e interpretare semplici rappresentazioni cartografiche.
• Classificare un paesaggio
• Analisi e riconoscimento degli elementi caratteristici delle diverse tipologie di paesaggi.
• Distinzione tra mappe, piante e carte geografiche.
• Costruzione di una mappa.
• Realizzazione di un disegno con l’uso di indicatori spaziali.
• Interpretazione dei simboli presenti nel percorso di esodo.
• Esecuzione e riproduzione grafica di percorsi.
L’argomento vacanze aiuta a distinguere e a spiegare i caratteri salienti e le diversità delle varie tipologie di paesaggio: marino, montuoso, cittadino, campestre.
L’osservazione e la descrizione particolareggiata del materiale portato a scuola (fotografie, cartoline, depliant ecc.) stimolano gli alunni a riconoscere e distinguere, nei paesaggi proposti, gli elementi naturali e quelli che rivelano l’intervento umano.
Al termine della conversazione operiamo una classificazione su di un cartellone.
• Conoscere diversi tipi di carte
Ricordando le nozioni apprese nei due anni precedenti, l’insegnante invita i bambini a scrivere sul quaderno la definizione di diversi tipi di carta: mappa; pianta; carta geografica.
Dopo la costruzione della mappa proposta nella scheda allegata, l’insegnante mostra agli alunni la carta geografica dell’Italia, evidenziando le differenze tra la carta fisica e quella politica.
Scheda n. 14 Costruisco la mappa del tesoro
• Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali
Verifichiamo se i bambini conoscono gli indicatori spaziali (destra, sinistra, centro, davanti, dietro, dentro, fuori ecc.), proponendo la realizzazione di un disegno.
Scheda n. 15 Creo un disegno
• Leggere e interpretare semplici rappresentazioni cartografiche
L’insegnante attira l’attenzione dei bambini su una mappa presente nell’aula: il percorso di esodo. Gli alunni leggono la mappa, interpretandone i simboli, poi eseguono il percorso, individualmente e con la classe. In tal modo svolgiamo un esercizio di geografia e un’esercitazione pratica di sicurezza. Terminiamo l’attività invitando i bambini a disegnare il proprio percorso casa-scuola.



Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: , e (v. pag. 92). T1 T2 T6
Competenza chiave Competenza matematica (A) (p. 76) C3
T1 T6
T1 T6
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
• Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi.
• Stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco di coppie ordinate e tabelle.
• Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali entro il 100.
• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100.
• Confrontare e ordinare i numeri naturali, entro il 100, utilizzando i simboli >, <, =.
• Esercizi di rappresentazioni d’insiemi e sottoinsiemi.
• Relazioni tra insiemi.
• Lettura e scrittura dei numeri entro il 100.
• Ordinamento dei numeri entro il 100.
• Riconoscimento del precedente e del seguente di un numero dato utilizzando i simboli >, <, =.
• Scomporre e comporre i numeri entro il 100. • Esercizi di scomposizione e composizione di numeri entro il 100 in decine e unità.
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio della decina.
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga.
• Risolvere semplici problemi con l’addizione e con la sottrazione.
• Classificare le linee in aperte/chiuse, semplici/non semplici.
• Individuare le regioni che si formano con più confini semplici.
• Esecuzione di addizioni e sottrazioni.
• Esecuzione di moltiplicazioni e divisioni.
• Risoluzione di problemi con addizione e sottrazione.
• Rappresentazioni di linee aperte/chiuse, semplici/non semplici.
• Esercizi per l’individuazione di regioni.
All’inizio dell’anno scolastico l’insegnante, prima di progettare e articolare gli interventi educativi, verifica il livello di apprendimento di ogni alunno e procede all’accertamento dei prerequisiti.
I primi obiettivi proposti presentano il duplice scopo di: - valutare la solidità degli apprendimenti acquisiti nelle classi precedenti; - predisporre gli alunni a procedere gradualmente nella comprensione dei concetti matematici, nell’articolazione del pensiero e nell’arricchimento della comunicazione. Riproponiamo attività volte a consolidare le abilità indispensabili per una più approfondita riflessione sulla struttura del numero e sulle operazioni logiche e aritmetiche.
Le abilità di base per gli alunni della classe terza sono:
una completa padronanza della lettura e della scrittura dei numeri entro il 100;
una buona sicurezza nell’esecuzione delle quattro operazioni aritmetiche;



una prima capacità di approccio, anche se solo intuitiva, alle situazioni problematiche.
• Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi
Per verificare il concetto di insieme , incuriosiamo i bambini tirando fuori dalla borsa un sacchetto colorato, contenente piccoli oggetti di vario tipo: tappi, anelli, palline colorate, pezzi di costruzione lego, tessere di puzzle e così via.
Sicuramente un primo alunno chiederà qual è il contenuto del sacchetto posto sulla cattedra; poi si assoceranno anche gli altri, fino al coinvolgimento dell’intera classe.
A questo punto invitiamo gli alunni a indovinare il contenuto del sacchetto, permettendo a ciascuno di loro di manipolarlo.
I bambini sulla base dell’affinamento delle singole capacità percettivo-sensoriali formulano ipotesi diverse che faremo verificare facendo aprire il sacchetto e riscontrando insieme quali e quanti tra loro si sono maggiormente avvicinati alla corretta individuazione degli oggetti.
Dopo questa prima fase almeno un alunno chiederà perché sono stati portati questi oggetti e a che cosa servono. L’insegnante risponderà che vuole proporre divertenti e attraenti giochi ed esorterà gli alunni a “raggruppare insieme”, secondo una caratteristica comune, i vari oggetti e a dare una definizione precisa degli insiemi che si formano.
Si ricorda che per “insieme” s’intende un gruppo, una collezione, una categoria di persone, animali o cose che hanno in comune almeno una caratteristica, ossia una qualità o un aspetto particolare, che permetta di individuarli e distinguerli.
Ogni tipo di materiale occasionale può essere utilizzato a tale scopo, tuttavia è bene servirsi anche di materiale strutturato come i blocchi logici proposti dal Dienes, costituiti da 48 pezzi, che si distinguono per 4 attributi o variabili:
colore: 16 blu, 16 rossi, 16 gialli;
forma: 12 quadrati, 12 rettangoli, 12 triangoli, 12 cerchi;
grandezza: 24 grandi e 24 piccoli;
spessore: 24 spessi e 24 sottili.
Ogni blocco è differente da ogni altro per il valore di almeno una variabile.
Per consolidare la familiarizzazione con i blocchi l’insegnante dispone che tutti gli alunni, singolarmente, disegnino sul quaderno insiemi secondo una definizione/caratteristica data.
La definizione corretta della caratteristica distintiva di un insieme è necessaria per stabilire quali elementi appartengono a un insieme e quali non vi appartengono.
La proprietà caratteristica, definita in modo chiaro e preciso, consente di inserire nell’insieme gli elementi giusti senza utilizzare espressioni generiche, imprecise o derivanti da opinioni, tendenze o preferenze personali.



Per esempio, “l’insieme dei balli più divertenti” non può essere accettata come definizione della proprietà di un insieme perché non tutti i balli sono piacevoli allo stesso modo per tutti.
Per consentire ai nostri alunni una corretta acquisizione del concetto di sottoinsieme e della relazione di inclusione a esso collegata, riprendiamo il gioco del sacchetto.
Invitiamo gli alunni a formare un insieme di tappi di colori diversi e a racchiudere con una cordicella o un elastico tutti i tappi dello stesso colore.
Successivamente chiediamo:
Nell’insieme dei tappi colorati puoi formare l’insieme dei tappi rossi?
Questo secondo insieme si trova all’interno del primo?
Se si trova all’interno di un altro insieme, come si chiama?
Nell’insieme dei tappi colorati puoi costruire un altro sottoinsieme? Quale?
Si raccomanda all’inizio dell’anno scolastico di svolgere frequenti e diversificate attività connesse con l’acquisizione del concetto di insieme perché propedeutiche e basilari per la successiva operatività aritmetica.
Scheda n. 16 Insiemi e sottoinsiemi
• Stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco di coppie ordinate e tabelle
Per la verifica di questo obiettivo proponiamo una scheda che stabilisce una relazione tra due insiemi rappresentata con frecce, con un elenco di coppie ordinate e con una tabella a doppia entrata, in cui le coppie sono indicate con un segno convenzionale (crocetta) posto nella casella di incrocio.
Scheda n. 17 Le relazioni tra gli insiemi
• Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali entro il 100
In ambito aritmetico la prima abilità di base da verificare è la lettura e la scrittura dei numeri entro il 100. L’insegnante propone una serie di attività sulla “linea dei numeri”, opportunamente preparata in precedenza, e invita gli alunni allo svolgimento di esercizi guidati, sia in forma orale sia per iscritto.
Scheda n. 18 I numeri
• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100
• Confrontare e ordinare i numeri naturali, entro il 100, utilizzando i simboli >, <, =
Per verificare l’abilità di enumerazione si considera la linea dei numeri fino a 100, già precedentemente proposta, e si chiede a ogni alunno la lettura ad alta voce di tutti i numeri da 1 a 100, in senso progressivo e regressivo. La capacità di contare in modo sicuro e corretto non è scontata neanche nei bambini di classe terza, per cui va continuamente rinforzata.
La linea dei numeri si configura come la rappresentazione dei numeri reali attraverso una retta orientata, su cui i bambini possono muoversi per eseguire i calcoli, utilizzando i consueti algoritmi operativi. Ricordiamo che il movimento ha un andamento progressivo nel caso dell’addizione
Pronti per la terza



(avanzare/andare avanti sulla linea dei numeri) e regressivo nel caso della sottrazione (retrocedere/andare dietro).
Introduciamo altre esercitazioni di questo tipo: disegniamo alla lavagna diversi tratti di linea numerati e chiediamo ai bambini di contare materialmente, spostandosi da un punto all’altro della retta, secondo le consegne date.
Contestualmente presentiamo esercizi di confronto tra numeri naturali per consolidare anche la comprensione e l’uso dei simboli >, <, =.
Schede n. 19 Conto • n. 20 Confronto
• Scomporre e comporre i numeri entro il 100
La scomposizione e la composizione dei numeri offrono agli alunni un’ulteriore opportunità per comprendere la struttura numerica e favoriscono l’abilità nel calcolo mentale e scritto.
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio della decina
Per la verifica di questo obiettivo i bambini eseguono, in una scheda, addizioni e sottrazioni in colonna, con e senza riporto.
Scheda n. 21 Compongo, scompongo, addiziono e sottraggo
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga
L’insegnante invita i bambini a eseguire, in una scheda, moltiplicazioni e divisioni in riga.
Scheda n. 22 Moltiplico e divido
• Risolvere semplici problemi con l’addizione e con la sottrazione
Proponiamo alla classe alcune situazioni problematiche rappresentate con immagini e invitiamo gli alunni a descriverle verbalmente e a tradurle numericamente, per abituarli ad avere dimestichezza con i problemi e a elaborare ipotesi di soluzione.
Schede n. 23-24 Descrivo e risolvo
• Classificare le linee in aperte/chiuse, semplici/non semplici
Presentiamo una scheda contenente linee chiuse, aperte, semplici e non semplici, e invitiamo gli alunni, con utilizzo di pastelli o pennarelli, a raggrupparle in insiemi con le stesse caratteristiche.
Scheda n. 25 Classifico le linee
• Individuare le regioni che si formano con più confini semplici
L’insegnante espone i concetti di confine e di regione, già affrontati nei due precedenti anni scolastici e, in una scheda, chiede ai bambini di ripassare con il colore rosso i confini, colorare di giallo le regioni interne ai confini e di azzurro la regione esterna a tutti i confini e individuare il numero delle regioni e dei confini.
Scheda n. 26 Confini e regioni



Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: e (v. pag. 94). T3 T5
Competenza chiave Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) (p. 76) C3
T3
T3 T5
T3 T5
• Distinguere i cicli temporali.
• Individuare le caratteristiche di esseri viventi e non viventi.
• Classificare gli animali.
• Distinzione di cicli temporali.
• Distinzione delle caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.
• Distinzione delle caratteristiche degli animali per la loro classificazione.
Prima di verificare gli apprendimenti relativi alle Scienze acquisiti nel biennio precedente, occorre fare un’importante premessa particolarmente valida per l’ambito scientifico-tecnologico.
In terza classe gli alunni saranno istruiti progressivamente, mediante molteplici occasioni di indagini e ricerche, a utilizzare il “metodo scientifico”, che prevede l’osservazione come primo passo per giungere alla formulazione di ipotesi, da sottoporre al vaglio della sperimentazione.
L’insegnante utilizzerà ogni occasione per stimolarli a osservare in maniera critica le cose, i fatti e i fenomeni della realtà.
Guardando il mondo con gli occhi indagatori dello scienziato, gli alunni non si accontenteranno di accettarlo per come lo percepiscono, o per la spiegazione che ne danno gli altri, ma ambiranno a conoscerlo attraverso provate e dimostrate spiegazioni ai mille perché, suggeriti dall’osservazione della realtà.
• Distinguere i cicli temporali
T3
Collegandoci alle esercitazioni di Storia sui cicli temporali, presentiamo agli alunni le caratteristiche della ciclicità in natura, riferendoci alle piante (alberi, foglie, fiori, frutti) e agli animali.
Scheda n. 27 La ciclicità
• Individuare le caratteristiche di esseri viventi e non viventi
Proponiamo l’osservazione di ambienti naturali e operiamo con i nostri alunni una classificazione tra esseri viventi e non viventi.
Scheda n. 28 Esseri viventi e non viventi
• Classificare gli animali
Invitiamo gli allievi a classificare gli animali distinguendoli in base ad alcune caratteristiche (hanno quattro o due zampe, sono senza zampe ecc.).
Schedan. 29 Conosco gli animali
Antologia
Letture
Schede operative
Italiano
Schede da 1 a 8
Storia
Schede da 9 a 13
Geografia
Schede da 14 a 15
Matematica
Schede da 16 a 26
Scienze
Schede da 27 a 29





C’era una volta una capra di nome Berta che aveva 7 caprettini: Ben, Bet, Miò, Miù, Ron, Rut, l’ultimo si chiamava Piccolo.

Scheda n° 1
Un giorno mamma capra disse ai suoi piccoli che doveva andare al mercato.
–Mi raccomando, non aprite la porta a nessuno – disse. – Il lupo è molto astuto, sapete?
A volte si traveste per non farsi riconoscere.
Rimasti soli in casa, i capretti decisero di giocare a “Lupo contro tutti”.
Bet corse sotto il tavolo... Ben si nascose sotto la poltrona... Miò s’infilò nella stufa... Miù dietro una tenda... Rut sotto il lavandino... Ron in un armadio...
Ma in quel momento qualcuno bussò alla porta.
–Aprite, sono la mamma – disse una voce grossa e rauca. –
Ho portato un bel regalo a tutti voi!
–Tu non sei la nostra mamma – disse Miù. – La mamma ha la voce dolce come un bicchiere di latte e miele. Tu, invece , hai la voce grossa e rauca. Sei il lupo, vattene!
–Brutti mocciosi – si disse il lupo –vogliono la voce dolce, eh e va bene, gliela do io la voce dolce...
Andò nel negozio di un pasticciere e chiese se aveva torte dolci.
– Ho quello che fa per lei! – disse il pasticciere, andando a prendere una torta alla pasta di mandorle, farcita di miele e croccantini e ricoperta di glassa zuccherina! Il lupo afferrò la torta e se la cacciò in gola. Poi scappò come un matto verso la casa dei caprettini.
Toc, toc, toc! Il lupo bussò per la seconda volta alla porta della casa dei capretti e con la sua nuova voce dolce disse: –Aprite, sono la mamma. Ho portato un bel regalo a tutti voi!
–Tu non sei la nostra mamma! – disse Rut –



La mamma ha le zampe bianche come la neve. Tu invece hai le zampe nere come il carbone. Sei il lupo, vattene!
Per la seconda volta il lupo si allontanò furibondo. Così andò da un mugnaio e chiese un sacco di farina. Il lupo lo aprì e ci infilò dentro le zampe, le imbiancò per bene e poi corse via.
Quella mattina, per la terza volta, il lupo bussò alla porta della casa dei capretti. Toc, toc, toc!
–Aprite, sono la mamma dalla voce dolce come il miele e dalle zampe bianche come la neve.
–È la nostra mamma! – esclamarono in coro i sette capretti, correndo a togliere il catenaccio alla porta. La porta si spalancò. I capretti alzarono gli occhi e... si trovarono di fronte il lupo.
–Il lupo! Il lupo! – urlarono i capretti pieni di paura – Corriamo a nasconderci!
E Bet corse sotto il tavolo, Ben sotto la poltrona, Miò nella stufa, Miù dietro la tenda, Ron nell’armadio, Rut sotto il lavandino e Piccolo nella cassa dell’orologio, che era il suo nascondiglio speciale.
–È inutile che corriate! – disse il lupo – Tanto vi prendo tutti. Il lupo guardò sotto il tavolo, sotto la poltrona, nella stufa, dietro la tenda, dentro l’armadio, sotto il lavandino e... a uno a uno, tutti i capretti finirono nella sua pancia. Tutti tranne Piccolo.
–Be’, per oggi ho mangiato a sufficienza. Farò a meno del settimo capretto. Poi uscì e andò a sdraiarsi sotto un albero.
Poco dopo mamma capra tornò e Piccolo le raccontò tutto quello che era successo. –Quel furfante! – disse mamma capra. –Poi prese un paio di forbici, una spoletta di filo con l’ago e andò a cercare il lupo. La capra prese le grosse forbici e, adagio adagio, iniziò a tagliare la pancia del lupo. Uno a uno i sette capretti saltarono fuori. Berta riempì di sassi il ventre del lupo, quindi lo ricucì in fretta.
Quando il lupo si svegliò sentì una gran sete, arrivò alla fontana e si sporse per bere. Ma il peso del pancione gli fece perder l’equilibrio e così cadde nell’acqua, dove annegò. Da quel giorno i capretti vissero felici e sereni con la loro mamma, senza più pericolo di lupi malvagi. Ma non persero mai l’abitudine di giocare a “Lupo contro tutti”.
Adatt. da T. Merani, Il lupo e i sette capretti, Einaudi
Pronti per la terza



È settembre! Siamo pronti per la terza
Buongiorno alla scuola
Che deserto la scuola, tutta l’estate!
Chiuse le porte, le finestre sprangate, l’aule parevan morte.
Ma una mattina la vecchia bidella si attacca alla campanella
E “ den! den! den! ” la scuola si ridesta.
Ora parla la lavagna È finita, è finita la lunga dormita…
Mi sento così fresca e riposata che con queste due zampe di legno vorrei farmi una passeggiata.
Dite, ho la faccia pulita?
Per favore, signor cancellino, vorreste cancellarmi per benino?
Il cancellino
Ecco fatto, madama. Sentite la campana come chiama. Preparatevi a sopportare i soliti scarabocchi dei soliti marmocchi.
I gessetti
Ella è piena d’invidia, già si sa: tutto quello che noi scriveremo lei lo cancellerà.
La cattedra (severamente)
Suvvia, non cominciamo a litigare.
Il maestro sta per arrivare: toglietemi la polvere con lo straccio, sennò che figura ci faccio?
Silenzio! Arriva il primo scolaretto.
Guardatelo: contento, vispo come un soffio di vento… la voglia d’imparare e di far bene gli brilla negli occhi scuri.
Facciamogli i nostri auguri, salutiamolo come si conviene.
Tutta l’aula
Buongiorno, benvenuto!
Lo scolaro
Di dove verrà mai questo saluto?
Qui non vedo nessuno…
Me lo devo essere sognato, sono ancora un pochino addormentato. Però posso rispondere lo stesso.
Sulla lavagna scriverò col gesso (non c’è nessuno intorno?)
“Cara scuola, buongiorno!”.
Adatt. da G. Rodari, Buongiorno alla scuola , Editori Riuniti
Che cos'è la geografia?
La geografia
è dove stanno gli amici, le strade per le bici, i posti felici.
Che cos'è la storia?
La storia sono i giochi di ieri, i ricordi leggeri lasciati sui sentieri.
Che cos'è la grammatica?
La grammatica
è fare filastrocche, far festa con le bocche senza sentirsi sciocchi.
Che cos'è l'aritmetica?
L'aritmetica
siamo io più te più tutti i belli insieme ai brutti, le radici più le foglie più i frutti.
R. Piumini, B. Tognolini, Rimelandia , Mondadori
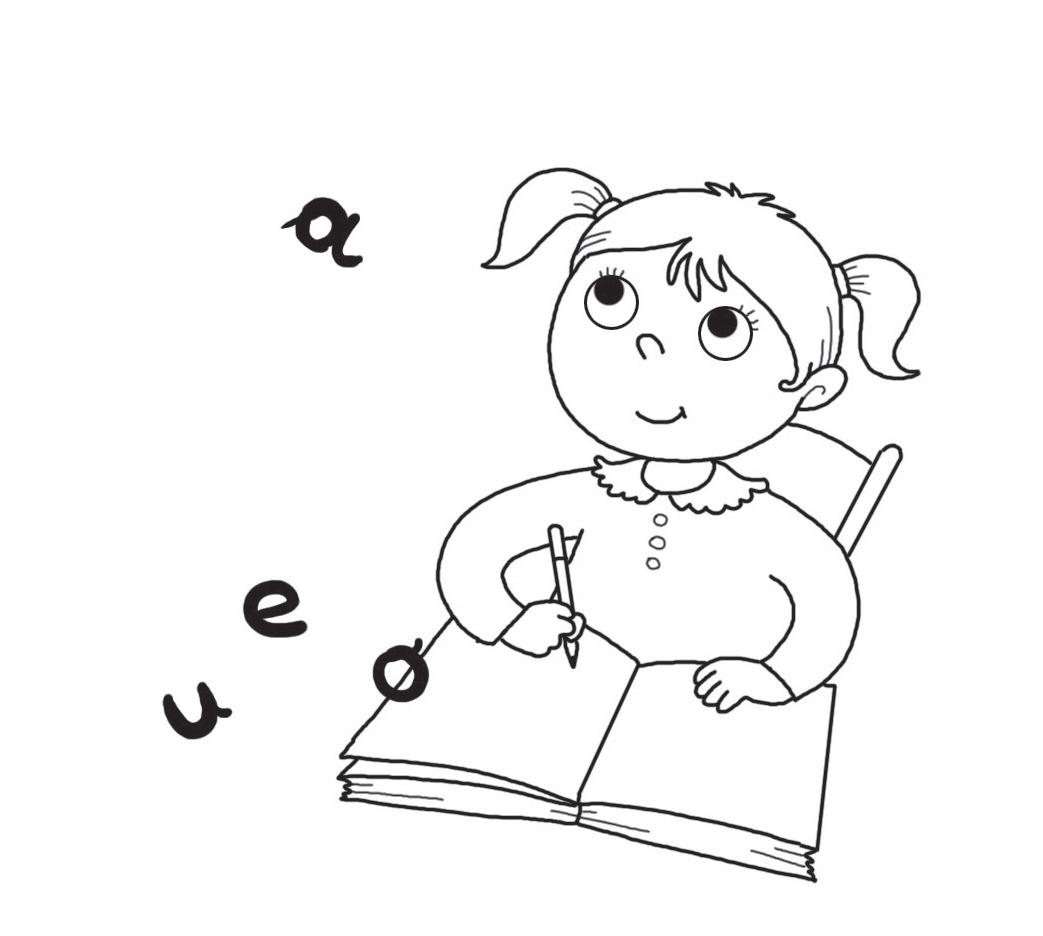
Vado a scuola, vedo amici, gioco, parlo, imparo, rido, più si è, più si è felici: degli amici io mi fido.
La maestra ha bei capelli, è un’amica un po’ più grande: lei ci insegna i ritornelli, lei risponde alle domande.
Vado a scuola e vedo cose, le disegno con colori, sento storie misteriose, e alla fine torno fuori.
Ore del giorno



R. Piumini, B. Tognolini, Rimelandia , Mondadori
Mezza mattina, le ore operose, buone per fare tantissime cose.
È mezzogiorno, bussa la fame, chiede una cassa di pane e salame.
Il pomeriggio di giochi e di sonno passa con passo lento di sonno.
Scende la sera sulla giornata: sembrava lunga, ma è quasi passata.
L’ora di cena arriva tra poco, sotto le pentole brucia il fuoco.
Viene la notte e spegne ogni cosa: anche il mio gioco tra poco riposa.
R. Piumini, B. Tognolini, Rimelandia , Mondadori



Antologia pag. 116
Dopo aver ascoltato la lettura dell’insegnante, riordina la storia numerando da 1 a 6 i fatti principali.
La capra Berta lascia i suoi sette caprettini soli in casa perché deve andare al mercato. Prima però raccomanda ai figli di fare attenzione al lupo e di non aprire a nessuno.

La terza volta che il lupo chiede di entrare in casa, i caprettini lo scambiano per la loro mamma e aprono la porta. Appena vedono il lupo, scappano terrorizzati.

La mamma torna a casa e scopre che cosa è successo, va a cercare il lupo e lo trova addormentato sotto un albero. Apre la pancia del lupo, tira fuori i caprettini, li sostituisce con dei sassi e ricuce tutto.


Quando il lupo si sveglia, sente una gran sete e va alla fontana in cerca di acqua, ma appena si sporge per bere, il peso della sua pancia gli fa perdere l’equilibrio. Così il lupo cade nell’acqua e annega.
Per due volte il lupo bussa alla porta e fa finta di essere la capra Berta, ma i caprettini lo riconoscono e non gli aprono la porta.
I caprettini corrono a nascondersi, ma il lupo li trova e li divora. Soltanto il caprettino più piccolo, che si era infilato nella cassa dell’orologio, riesce a salvarsi.
Adatt. da T. Merani, Il lupo e i sette capretti , Einaudi




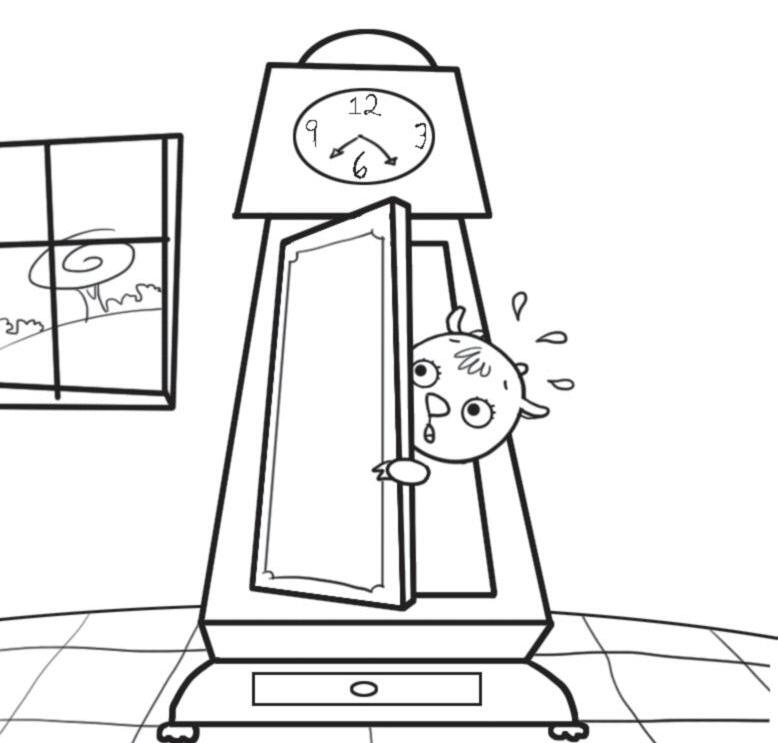



Leggi il testo e osserva le immagini. Colora nel modo giusto i vestiti delle sette nane e scrivi i loro nomi.
Le sette nane avevano ciascuna il nome di un colore: Bianca, Rosa, Azzurra, Nerina, Violetta, Rossella e Smeraldina. Bianca non si arrabbiava mai ed era una gran lavoratrice: si divertiva molto a cucinare, ed era capace di tener tutto sempre perfettamente in ordine. Rosa era molto istruita: la sua grande passione era leggere e studiare, e sapeva sempre quasi tutto. Azzurra costruiva aquiloni colorati che erano i più belli, leggeri e resistenti del mondo, ed era bravissima a farli volare in alto, sopra il vento, fino in cielo. Nerina era una pacifica pigrona e sapeva cento ninne nanne: il suo sogno era andare a letto presto e stare a poltrire a letto fino a mezzogiorno. Violetta era dolce e timidissima, scriveva in segreto poesie e aveva inventato più di mille e una fiaba. Rossella era una grande ballerina: valzer, tango, mazurca e cancan... Andava matta per le fiere, le feste, i luna-park e per tutti i tipi di divertimento. Smeraldina era una mattacchiona, sempre pronta a fare qualche scherzo divertente… e poi rideva a crepapelle e le sue grasse risate facevano venir voglia di ridere a tutti.
L. Cella, Sette per sette , Einaudi

Obiettivo: Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.



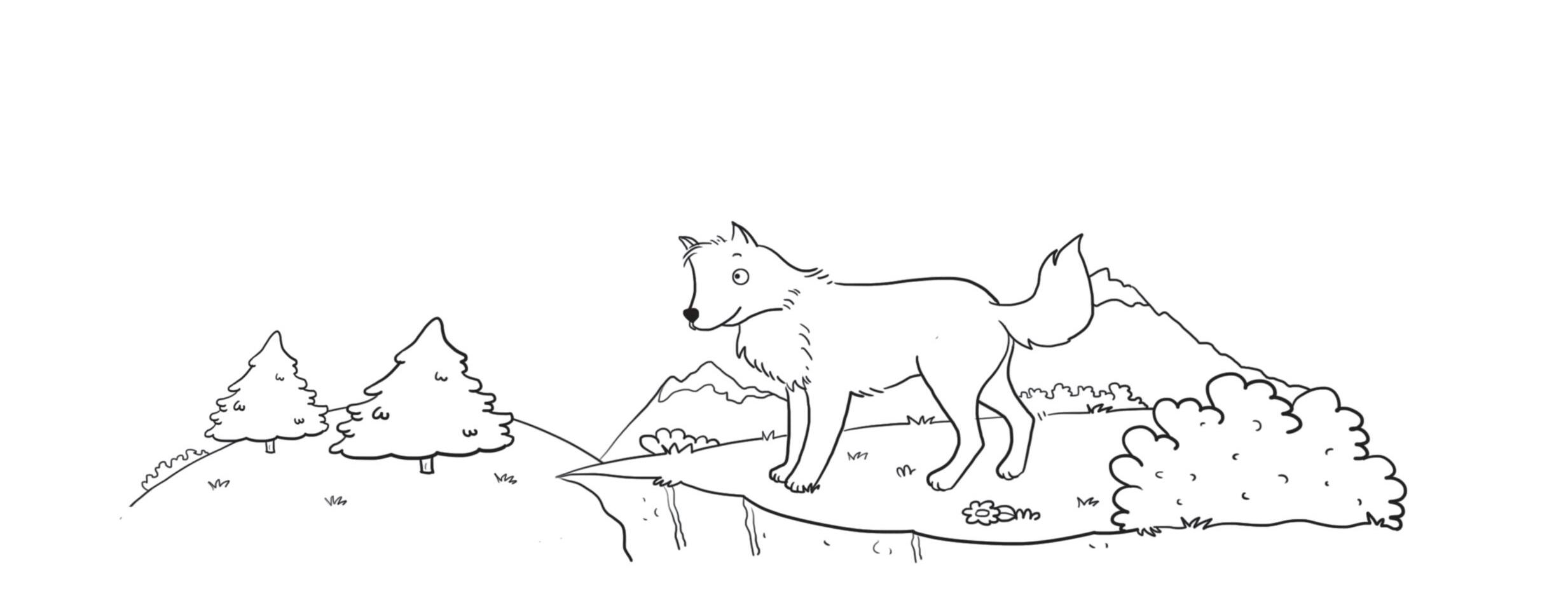
Inserisci nel testo le parole mancanti che trovi elencate in basso.
Ricordi la fiaba di Cappuccetto Rosso e quella dei Tre ?
In queste storie c’era il personaggio del lupo cattivo che voleva mangiare tutti. Ma il lupo è davvero un animale malvagio?
Nella realtà il lupo è un animale che si nutre soprattutto di cervi, caprioli e ........................................................ Preferisce abitare in alta ......................................................., ma a volte si adatta a vivere in collina, vicino ai centri abitati e ogni tanto attacca gli animali delle .
Per questo motivo gli uomini gli hanno sempre dato la , mettendo anche a rischio di la sua specie.
Oggi in Italia il lupo vive protetto nei dell’Appennino proprio per evitare che scompaia del tutto.
T. Merani, Il lupo e i sette capretti , Einaudi parchi nazionali montagna fattorie porcellini selvatico caccia estinzione cinghiali



Leggi la storia e rispondi al questionario. Metti una crocetta nel quadratino corrispondente alla risposta giusta.
C’era, nel paese delle lucertole, una lucertola più grossa delle altre, molto prepotente. Quando vedeva una lucertola al sole, la grande lucertola, che si chiamava Gonzilla, le andava davanti e diceva:
– Non rubarmi il sole, tu!
– Ma io non te lo rubo, Gonzilla! Di sole ce n’è per tutte!
– Storie! – Gonzilla gridava – Il sole che prendi tu, non lo prendo io! Vattene subito, o ti mordo la coda!
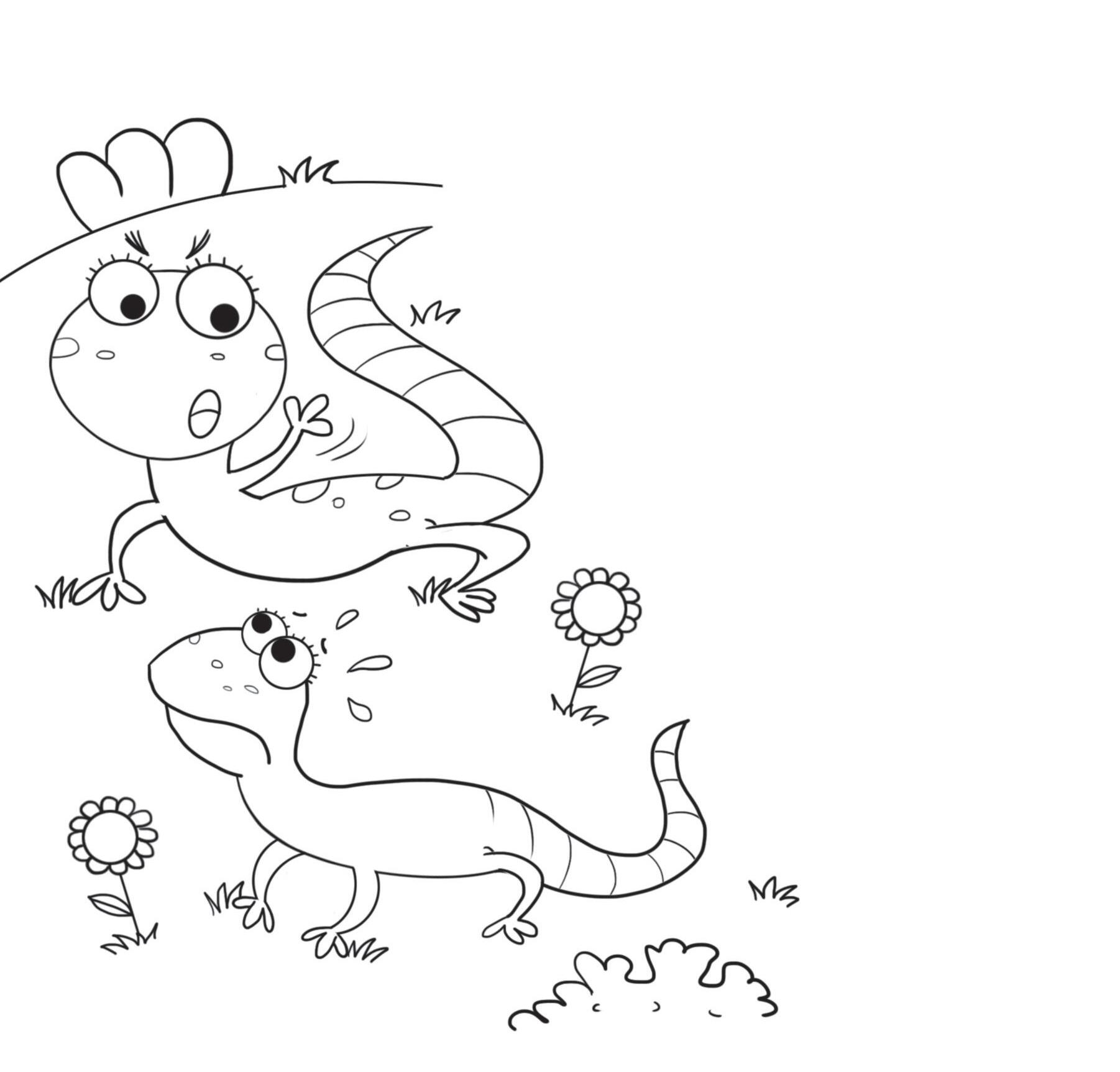
Più in là c’era un’altra lucertola al sole. Gonzilla le correva davanti:
– Questo sole è per me, ladruncola!
– Ma di sole ce n’è per tutte!
– Sciocchezza! Il sole che prendi tu, non lo prendo io! – e la scacciava.
Così faceva giorno dopo giorno. La vita delle lucertole diventava difficile. Allora decisero di andare dalla maga Malibù, una gazza vecchia e saggia che viveva su un’acacia. Malibù ascoltò quello che le lucertole avevano da dire, e rispose: – Domani, a mezzogiorno, nascondetevi tutte e lasciate fare a me.



Il giorno dopo, Malibù volò su un ramo vicino a dove Gonzilla stava prendendosi il sole. Non c’era nessun altra lucertola nelle vicinanze. La gazza si levò da sotto le piume una lente, la prese nel becco e concentrò un raggio di sole proprio sulla testa di Gonzilla, che stava beata a occhi chiusi.
– Ahia! – disse dopo un poco la lucertola e aprì gli occhi. Da sopra la testa le usciva un filo di fumo.
– Che succede, cara? – disse Malibù, dopo aver posato la lente sul ramo.
– Succede che mi sono bruciata qui sopra!
– È stata la luce del sole! – disse Malibù.
– Il sole, come il sole? Il sole non mi ha mai scottato in questo modo! – disse Gonzilla.
– Già... ma adesso, vedi, le altre lucertole non ci sono più – disse la gazza. –Prima la luce andava su tutte: ora che sei sola, la luce cade tutta su di te, e ti scotta!
– Davvero? – disse Gonzilla, e subito cominciò a correre di qual e di là, gridando:
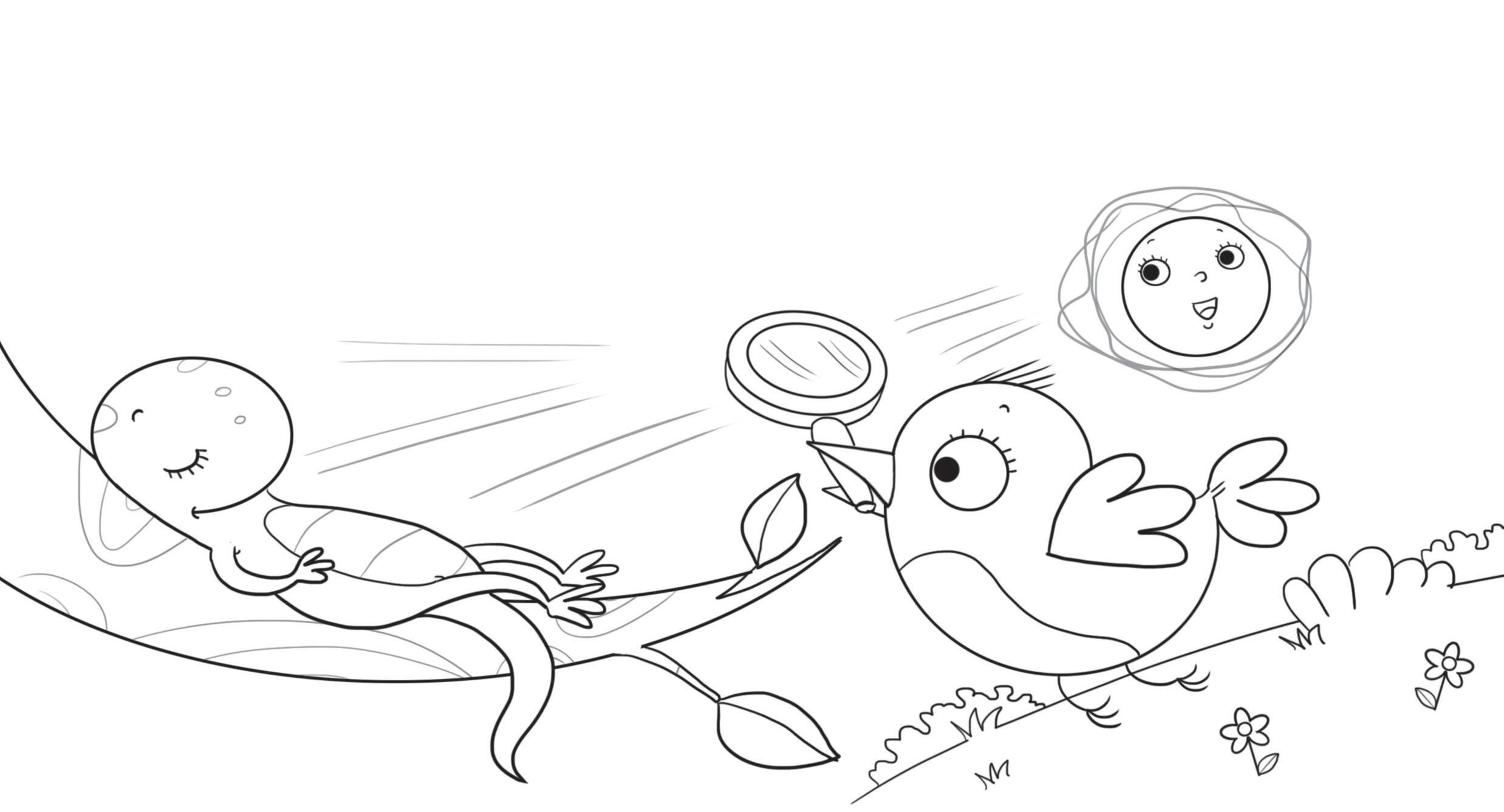
– Sorelle, tornate, presto!
Fu così che Gonzilla smise di disturbare le altre lucertole, e non si scottò più.
R. Piumini, F. Altan, Mi leggi una storia? Einaudi


1.Gonzilla è:
☐ una furba gazza.
☐ una piccola lucertola.
☐ una grossa gazza.
☐ una grossa lucertola.
3. Che cosa fa Gonzilla?
☐ Vuole abbronzarsi.
☐ Vuole il sole tutto per sé.
☐ Vuole aiutare le altre lucertole.
☐ Non vuole stare al sole.

2. Come è Gonzilla?
☐ Grossa e gentile.
☐ Grossa e prepotente.
☐ Piccola e prepotente.
☐ Piccola e gentile.
4. Chi è Malibù?
☐ Una gazza.
☐ Una lucertola.
☐ Un’acacia.
☐ Un pirata.
5. Perché le lucertole vanno dalla maga Malibù?
☐ Per aiutare Gonzilla.
☐ Per curare Gonzilla.
☐ Per cuocere Gonzilla.
☐ Per chiedere aiuto contro Gonzilla.
6. Che cosa prende la maga?
☐ Un ramo.
☐ Il sole.
☐ Una lente.
☐ Una coda.
7. Quale sistema usa Malibù per far scottare Gonzilla?
☐ Accende un fuoco vicino alla lucertola.
☐ Con la lente concentra i raggi di sole sulla testa della lucertola.
☐ Costringe la lucertola a stare al sole.
☐ Fa addormentare la lucertola al sole.
Obiettivo:

0 8. Che cosa fa alla fine Gonzilla?
☐ Corre a chiamare le altre lucertole.
☐ Si brucia la coda.
☐ Corre all’ombra.
☐ Litiga con la gazza.
0 9. Che cosa è un’acacia?
☐ Una strega.
☐ Un uccello.
☐ Un insetto.
☐ Un albero.
10. Indica quale caratteristica non ha la gazza:
☐ vecchia.
☐ saggia.
☐ furba.
☐ lenta.
11. Quando si svolgono i fatti raccontati?
☐ Di notte.
☐ In un giorno di pioggia.
☐ Di giorno.
☐ Durante una nevicata.


12. Che cosa vuol farti capire il racconto? Scegli la risposta che ti sembra più giusta.
☐ Non dobbiamo essere egoisti.
☐ Non dobbiamo stare per molto tempo al sole.
☐ Le lucertole rubano la luce del sole.
☐ Le lucertole odiano il sole.



Osserva le immagini e scrivi le frasi. In vacanza puoi

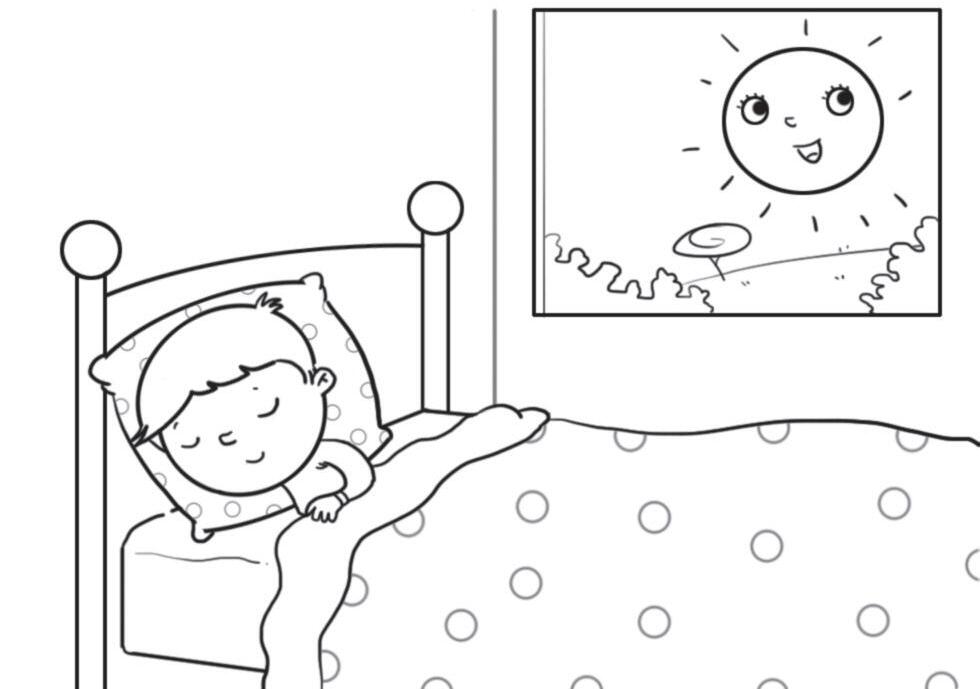
A scuola puoi
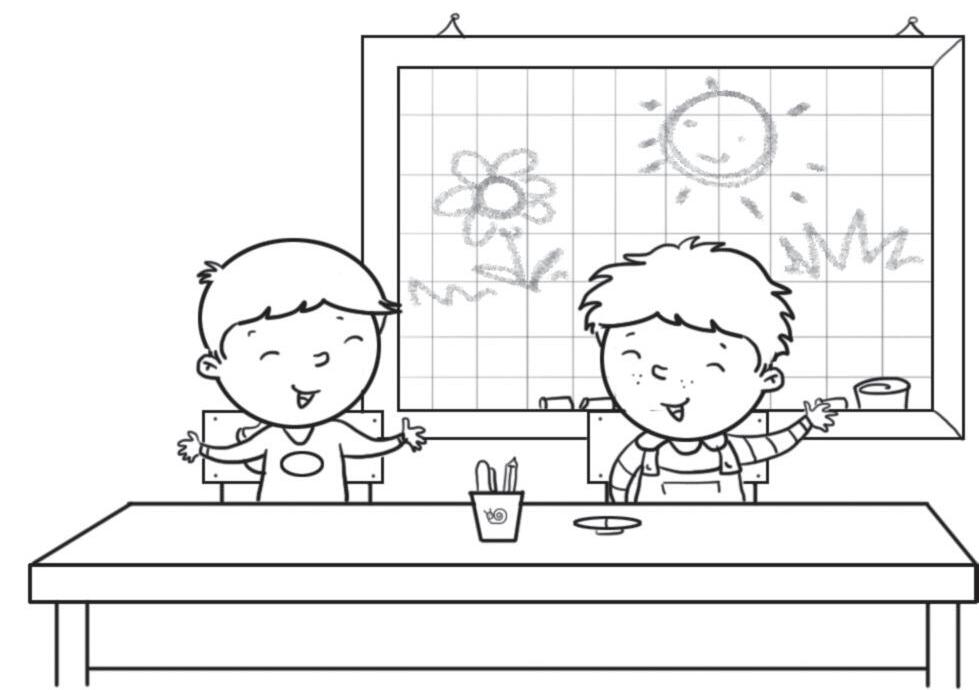

Obiettivo: Produrre testi per esprimere sentimenti, stati d’animo, opinioni.

Rispondi .



Da quanti bambini è formata la tua classe? ............................................................
Quante femmine, quanti maschi? ......................................................................................
C’è qualche bambino nuovo?
Come si chiama? .
Quanti insegnanti lavorano con la classe?
Come si chiamano? .
Quali attività svolgono? .



Osserva le immagini e racconta il primo giorno di scuola.
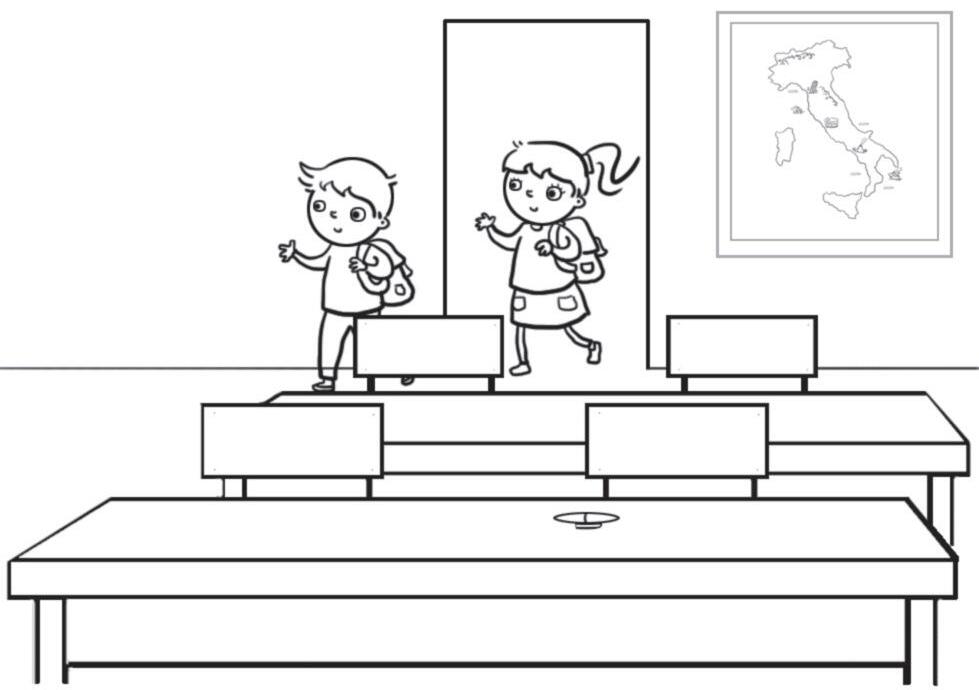
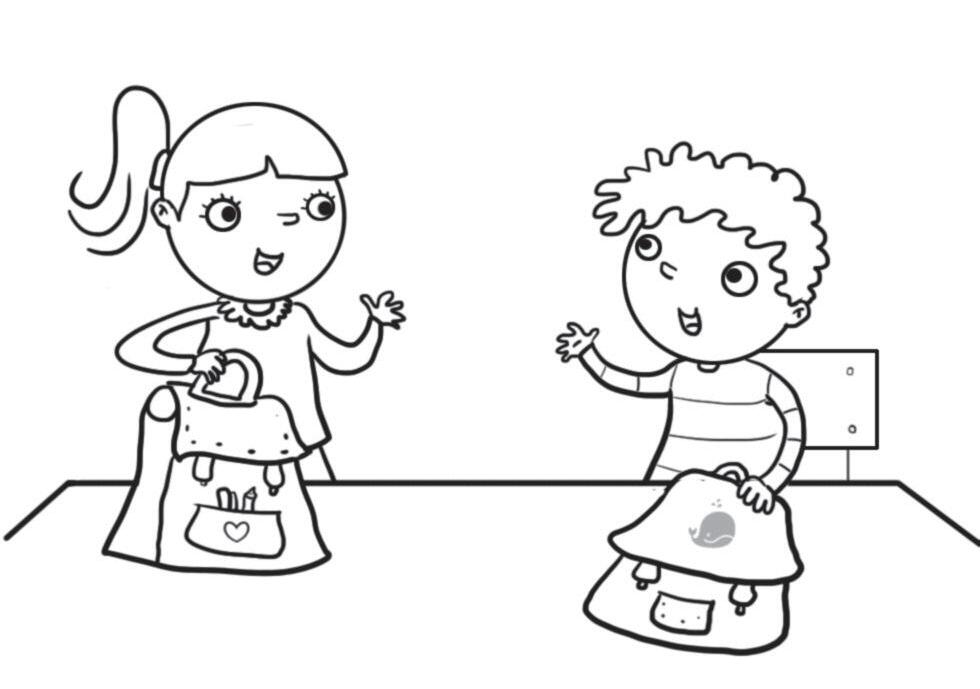
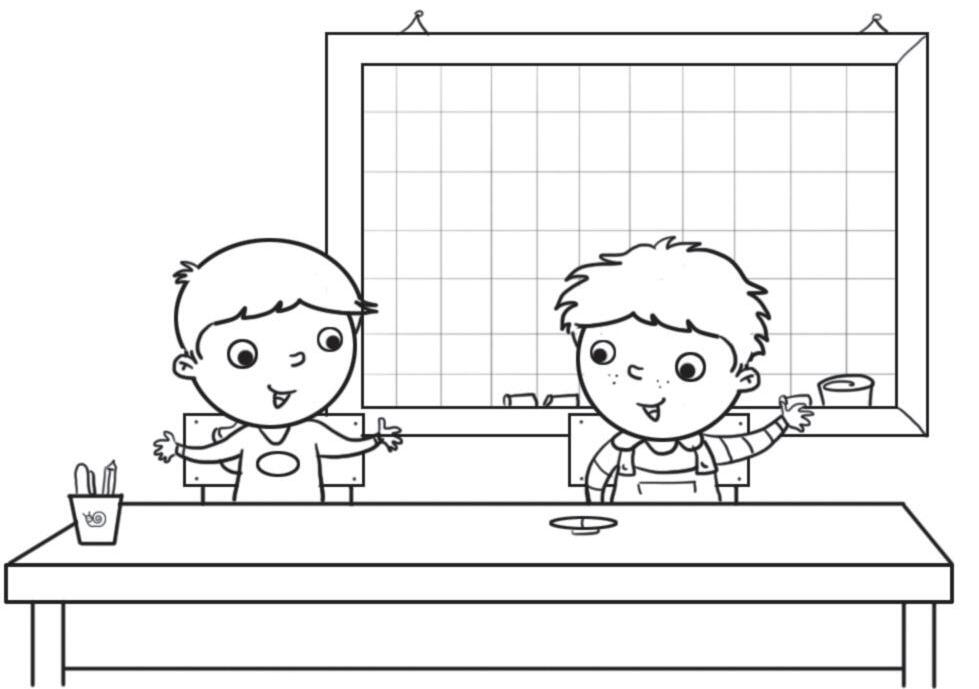

Obiettivo: Produrrre testi per raccontare vissuti e storie.


0 1. Dirige il traffico.
0 2. Si infila nella serratura.
0 3. È il figlio del re.
0 4. Vegetali che crescono in fondo al mare.
0 5. È simile al maiale.
0 6. Addolcisce il caffè.
0 7. Figli uguali.
Le parole piacevoli sono

Leggi le definizioni e completa il cruciverba. Attento, le parole che dovrai inserire contengono i gruppi ci, ce, gi, ge, chi, che, ghi, ghe, gn, sc, cu, qu, cqu, gli. Nella colonna evidenziata leggerai due parole… piacevoli.
0 8. La indossi in piscina per non bagnarti i capelli.
0 9. Ha in petto una stella.
10. È il predatore del mare.
11. È un uccello bianco molto elegante.
12. Può essere limpida, fresca, bollente, minerale.
13. La usi per aprire la porta. Italiano


Storia

Completa .
Al mattino io mentre la mia mamma e il mio papà .
A scuola io sono mentre i miei compagni .....................................................................................................................................
A pranzo io mangio con mentre il papà .
Al pomeriggio io la televisione mentre mio fratello .
Alla sera io mentre i miei genitori ............................................................................................................................................................
Disegna un momento della tua giornata .
Obiettivo:

Completa .


Il mio sonno dura .
Il mio pranzo dura . A scuola rimango per . Per la merenda impiego . Guardo
Completa .



Completa .
Se oggi è lunedì, domani sarà ................................................................................................, ieri era .
Se oggi è mercoledì, domani sarà , ieri era .
Se oggi è venerdì, domani sarà , ieri era .
Se oggi è domenica, domani sarà , ieri era ...............................................................................................................................................................
Se oggi è martedì, domani sarà ........................................................................................, ieri era .
Se oggi è giovedì, domani sarà , ieri era .
Se oggi è sabato, domani sarà , ieri era .
Riordina i mesi dell’anno: dicembre, ottobre, gennaio, marzo, aprile, giugno, maggio, agosto, luglio, settembre, febbraio, novembre. 1 2 3 4

Completa .


I mesi dell’anno sono: .
I mesi di 30 giorni sono:
I mesi di 31 giorni sono: ................................................................................................................
Il mese di 28 giorni è: .
Segna con una X le affermazioni V (vero) o F (falso).
La settimana è formata da 7 giorni.
La settimana è formata da 6 giorni.
In un anno ci sono 10 mesi.
In un anno ci sono 12 mesi.
Il mese di marzo ha 30 giorni.
Il mese di agosto è di 31 giorni.
Le stagioni sono 4.
Il mese di gennaio è il secondo dell’anno.
Il lunedì viene dopo la domenica.
Prima del mese di dicembre c’è novembre.
Il mese di febbraio conta 31 giorni.
Il giorno è di 24 ore.
Il giorno è di 12 ore.



Dopo aver ascoltato il racconto delle vacanze della famiglia De-Tappetti, rispondi alle domande seguenti.
Che cosa significa la parola villeggiatura?
Anche oggi si usa andare in villeggiatura?
Come si recano al loro villino i De-Tappetti?
Quali mezzi si usano oggi per andare in vacanza?
Quali sono le differenze tra la vacanza descritta nel brano e quella dei nostri giorni?



Il pirata Barbaverde detta al suo fidato Nicolino le istruzioni per ritrovare il tesoro. Aiutalo a disegnare la mappa .
Dall’approdo nell’isola fare 10 passi verso destra, proseguire in avanti per 2 passi, si arriverà vicino a 3 alberi. Da quello centrale fare 6 passi a sinistra e 2 passi in avanti: dietro a un cespuglio troverai il tesoro…




Disegna seguendo le istruzioni.
Al centro disegna un albero, alla tua sinistra una panchina, alla tua destra un bambino che gioca, tra il bambino e l’albero disegna un cespuglio, davanti all’albero una vasca e dentro di essa tanti pesciolini rossi, sulla panchina un cane, poi colora il tutto.
Obiettivo: Conoscere e

Forma un insieme A e un sottoinsieme B.



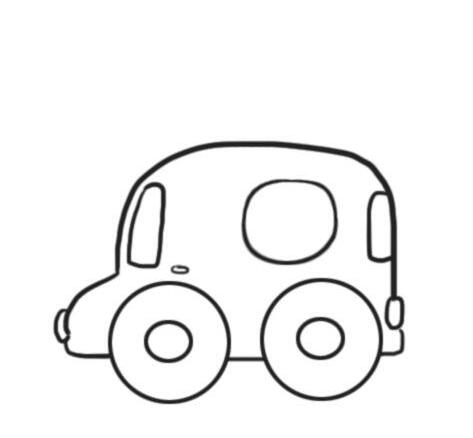
Scrivi l’elenco degli elementi dell’ insieme A e descrivine le caratteristiche.
A = insieme dei
Scrivi l’elenco degli elementi del sottoinsieme B e descrivine le caratteristiche.
B = sottoinsieme dei



Osserva le relazioni tra l’insieme A e l’insieme B , poi rappresenta le relazioni nelle tabelle.
• Carlo, Marco, Luca e Andrea giocano:
A B
Carlo
Marco
gioca a
Luca Andrea Calcio Basket Scherma Tennis
Tabella semplice
gioca a
Insieme A Insieme B
Carlo Calcio
Marco Basket
Tabella a doppia entrata
gioca a
Calcio Basket Scherma Tennis
Carlo X
Marco X

Scrivi il numero in cifre e a lettere. X 1 unità
1 unità


3 da 2 u 32 trentadue da u ......................................................................... da u
E ora fai il contrario.
7 da 1 u 71 settantuno da u



Scrivi i numeri da 27 a 54.
Scrivi i numeri da 98 a 70.
Ordina i numeri dal minore al maggiore. 97 - 17 - 77 - 57 - 67 - 87 - 47 - 27 - 37 - 7
Ordina i numeri dal maggiore al minore. 10 - 30 - 50 - 20 -
Completa le linee dei numeri.

Tra ogni coppia di numeri inserisci quello mancante.





Componi e scrivi a lettere il numero ottenuto.
8 da e 1 u
3 da e 7 u
5 da e 5 u
6 da e 7 u
4 da e 4 u
Scomponi come nell’esempio.
Esegui sul quaderno le seguenti operazioni in colonna e scomponi il risultato.

Esegui in riga .




NOME ....................................................................

Descrivi a parole e con i numeri.
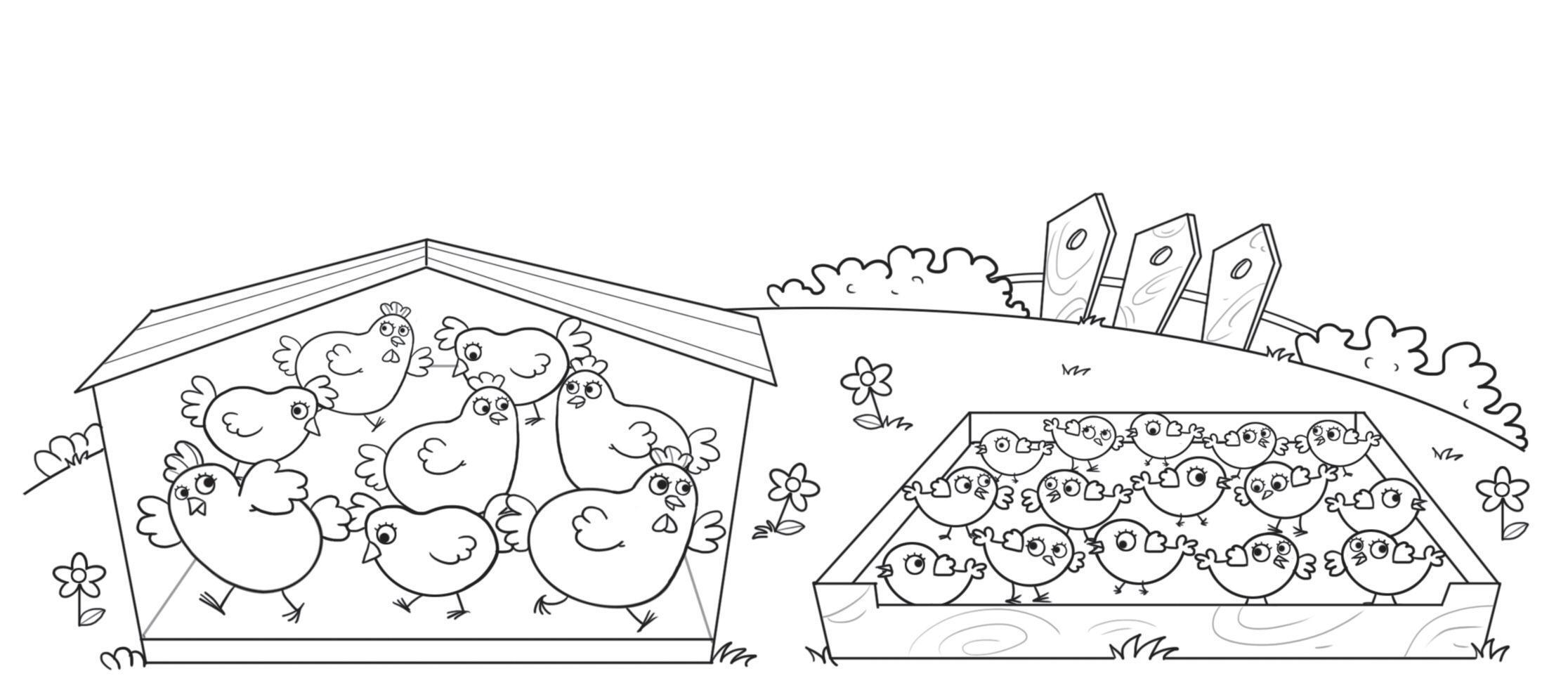
Nel cortile ci sono: una con galline; una con che cercano il . In tutto si vedono animali.
Galline +
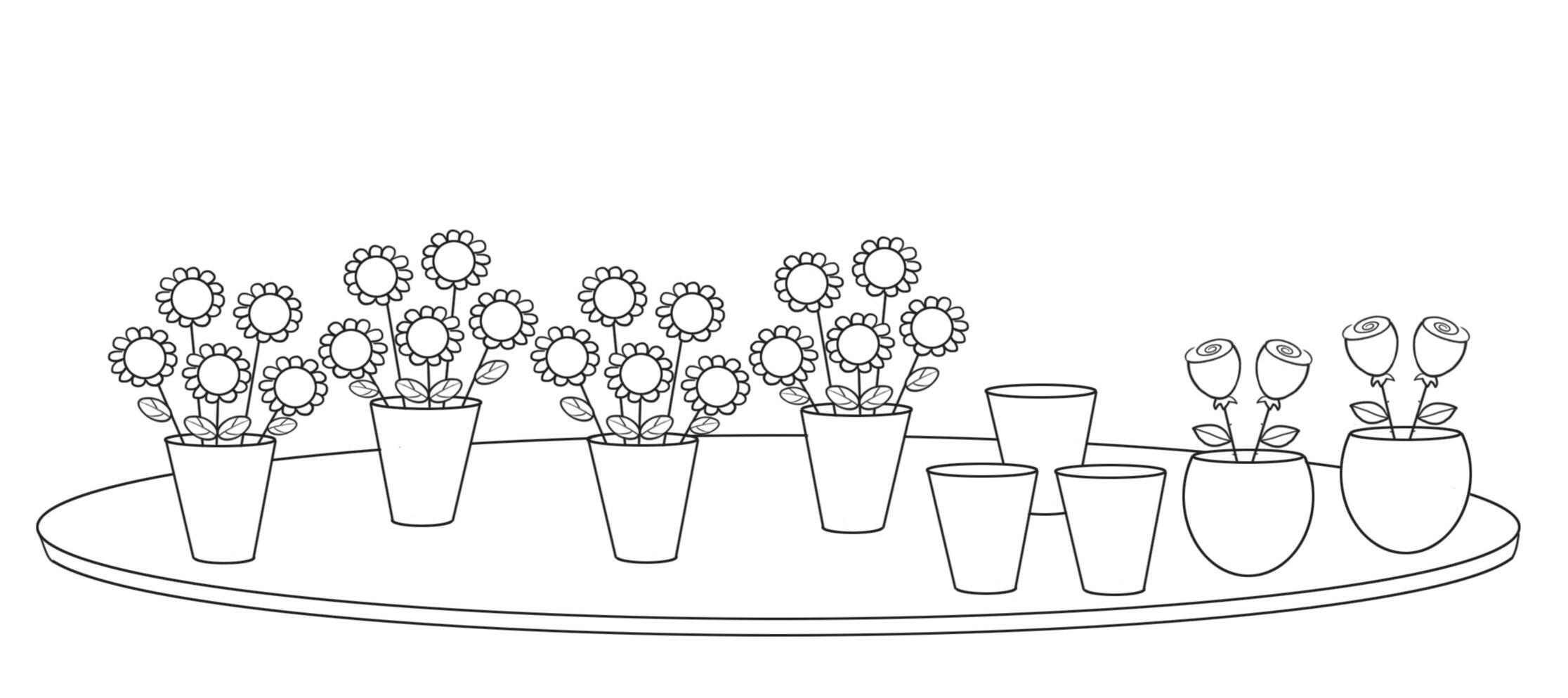
Pulcini =
Animali
Sul tavolo ci sono
Obiettivo: Risolvere semplici problemi con l’addizione e con la sottrazione.



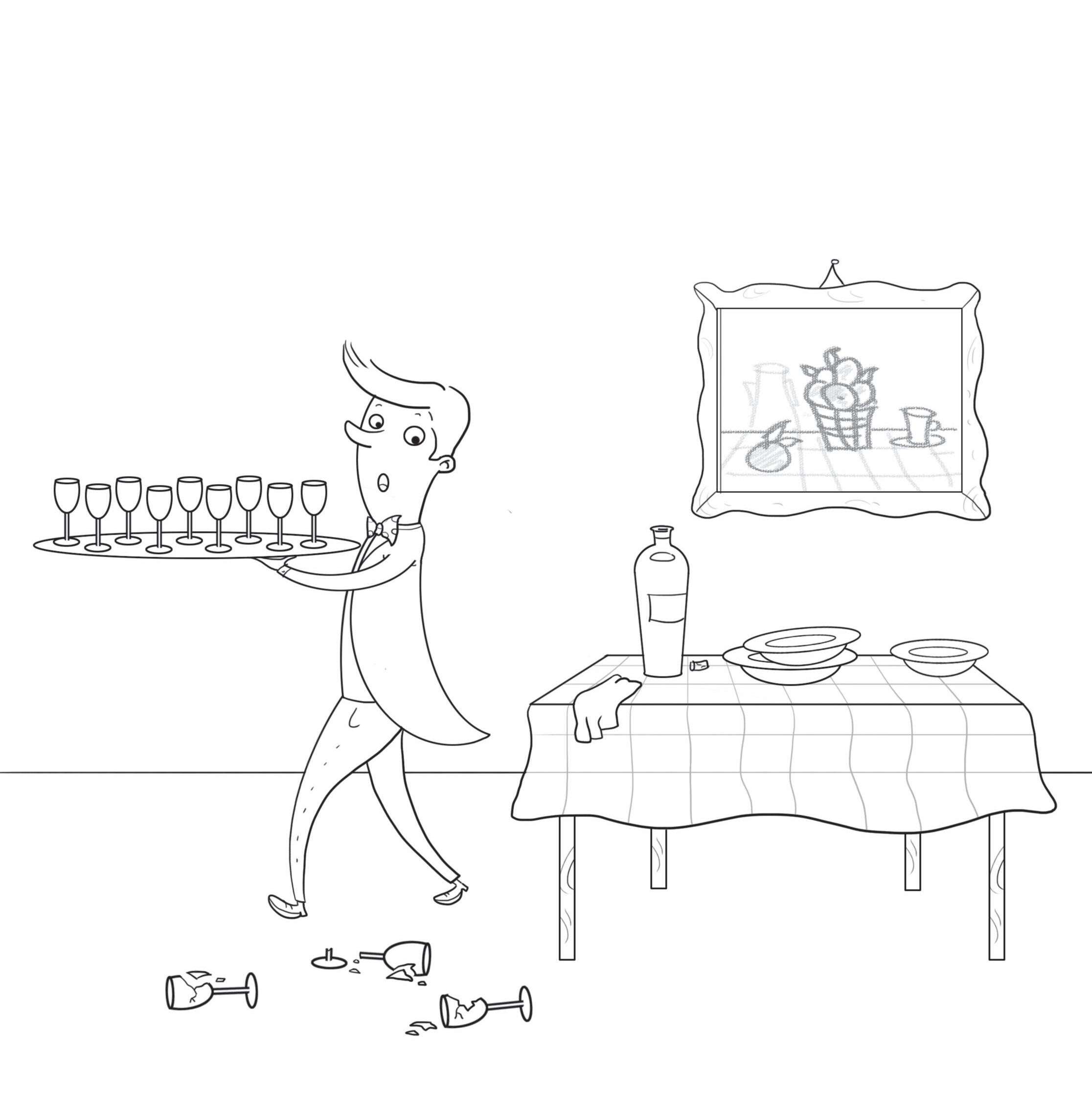

Descrivi a parole e con i numeri. NOME ....................................................................
Un cameriere stava a tavola bicchieri. Gli sono a terra bicchieri che si sono . Quanti sono sul vassoio?
Tutti i biccheri –
Bicchieri rotti =
Bicchieri interi
Obiettivo: Risolvere



Forma i seguenti insiemi:
A insieme di linee aperte semplici;
B insieme di linee chiuse semplici;
C insieme di linee aperte non semplici;
D insieme di linee chiuse non semplici.
Obiettivo: Classificare le linee in aperte/chiuse, semplici/non semplici.

Ricalca con il rosso i confini ; colora di giallo le regioniinterne ai confini; colora di azzuro la regioneesterna a tutti i confini.
Rispondi .


Quante sono le regioni? . Quanti sono i confini? .



.
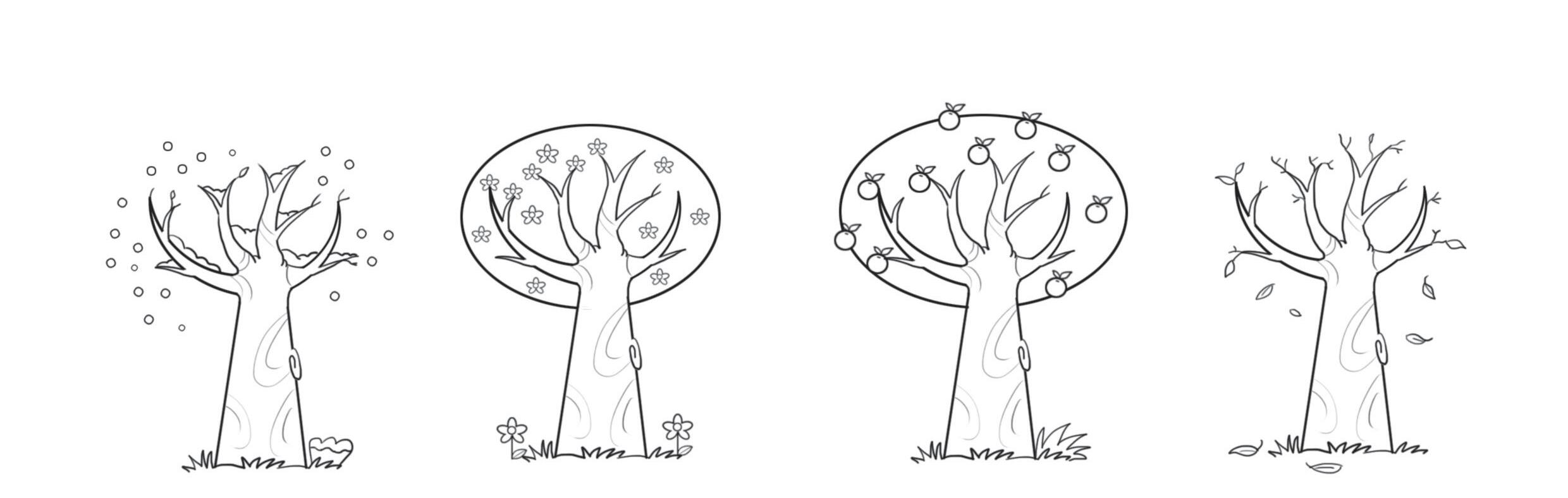
È il ciclo delle .

È il ciclo delle

È il ciclo degli ...........................................................................................................
Obiettivo: Distinguere i cicli temporali.

Completa la tabella .
Esseri viventi
Completa il testo .
Esseri non viventi


Gli esseri nascono, , si riproducono e .
Gli esseri non viventi non , non
, .................... si riproducono e .................... muoiono.



Segna con una X le affermazioni V (vero) o F (falso).
I quadrupedi hanno quattro zampe.
Tutti gli animali che volano hanno due zampe.
Il serpente non ha le zampe.
Il cane ha lo scheletro.
La mosca ha lo scheletro.
L’ape non vola.
Il gatto depone le uova.
Il pesce ha due zampe.
Il pesce vive in acqua.
Il cane respira.
L’orso cammina su due zampe.
L’oca vola.
La zanzara punge.
Il leone vive nel lago.
Lo struzzo è un mammifero.
La zebra ha il manto a pallini.
Il coccodrillo vive nel mare.
Obiettivo: