Guida didattica per la scuola primaria

Italiano
Matematica
Geografia
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Educazione civica
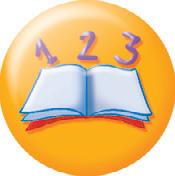

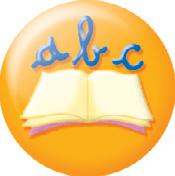



















ibiscus it edizioni

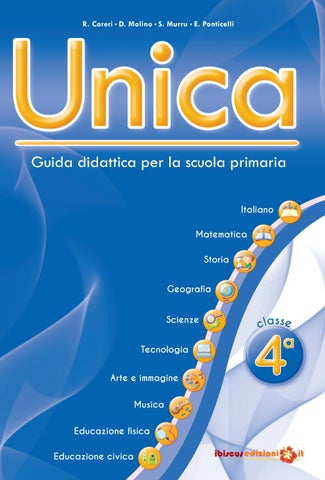

Italiano
Matematica
Geografia
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Educazione fisica
Educazione civica
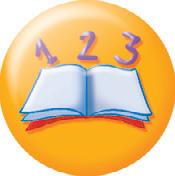

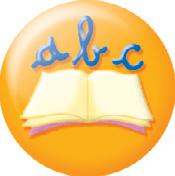



















ibiscus it edizioni


Indicazioni metodologiche Traguardi per lo sviluppo delle competenze
SETTEMBRE
Benvenuti in quarta
Proposte metodologiche
Italiano
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 112
Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 113
Scrivere testi descrittivi chiari e coerenti 114
Scrivere testi chiari e coerenti per raccontare vissuti e storie 115
Scrivere testi espositivi 115
Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche 115
Riflettere sulle parole: riconoscere le principali parti del discorso 116
Osservare, esplorare, descrivere e leggere fumetti 116
Storia
Conoscere le fonti della Storia 117
Conoscere il lavoro dello storico 117
Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie
della Storia 118
Conoscere le parole della Storia 118
Conoscere e confrontare sistemi di datazione 119
Conoscere la storia dell’evoluzione dell’uomo 120
Geografia
Conoscere il lavoro del geografo 121
Conoscere e confrontare gli strumenti del geografo 121
Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie
della Geografia 122
Leggere ed eseguire riduzioni in scala 122
Conoscere e descrivere diversi tipi di carte 123
Interpretare e realizzare legende di carte
Leggere e rappresentare dati statistici
Matematica
Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero
Leggere e scrivere i numeri naturali in base 10 entro il 1000
124
124
125
127
Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità 127
Ordinare e confrontare i numeri naturali entro il 1000 utilizzando i simboli >, <, =
Eseguire le quattro operazioni in riga
127
128
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con due cambi 128
Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una e di due cifre 129
Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra
senza e con il cambio, con e senza resto 129
Risolvere situazioni problematiche con l’uso delle quattro operazioni 129
Riconoscere e rappresentare linee rette, semirette e segmenti
Classificare e rappresentare gli angoli in
denominare e rappresentare figure
16 Dal diagramma di Carroll al diagramma ad albero
e scrivere i numeri entro il
n. 19 Dal B.A.M. all’abaco 157
n. 20 Numeri in tabella e sull’abaco 158
n. 21 So ordinare e confrontare i numeri 159
n. 22 Operazioni in riga 160
n. 23 Proviamo a eseguire addizioni e sottrazioni in colonna 161
n. 24 Ripassiamo un po’ le tabelline 162
n. 25 Ripetiamo le divisioni in colonna 163
n. 26 Quale operazione? (1) 164
n. 27 Mettiamoci alla prova con rette, semirette, segmenti e angoli 165
n. 28 Le figure geometriche 166
Scienze
n. 29 Tante scienze naturali 167
n. 30 Osservo io… 168
n. 31 Osservo e rispondo 169
n. 32 Gli strumenti per misurare 170
Comunicativa… mente
Proposte metodologiche Italiano
• Ascolto e parlato 172
Ascoltare e comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi orali 172
Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione 172
Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 173
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 173
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 174
Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 175
• Lettura 175
Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità 175
Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi descrittivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche 176
Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche: il diario 176
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 177
Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi narrativi, individuando gli elementi principali: tempo, luogo e personaggi 178
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: la favola 179
Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto 179
Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni per realizzare un manufatto 180
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 181
Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore: gli schemi delle rime 182
• Scrittura 183
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 183
Scrivere testi per esprimere emozioni: il diario 183
Scrivere testi per raccontare storie: discorso diretto e indiretto 184
Scrivere testi per raccontare storie fantastiche partendo da immagini 185
Scrivere testi per raccontare storie fantastiche: la favola 186
Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: la ricetta di cucina 186
Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio 187
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: lo slogan 188
Sperimentare tecniche per riassumere testi 189
Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato: la trasformazione del testo teatrale in testo narrativo 190
Sperimentare tecniche per parafrasare testi: la parafrasi del testo poetico 190
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 192
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 192
Utilizzare adeguatamente il dizionario 192
Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura 193
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: gli iperonimi 193
Riconoscere e rispettare le funzioni sintattiche ed espressive dei principali segni interpuntivi 193
Riconoscere e utilizzare adeguatamente le tecniche del discorso diretto e indiretto 194
Storia
• Uso delle fonti 196
Ricavare informazioni dallo Stendardo di Ur 196
Ricavare informazioni dalla Stele di Hammurabi 196
Ricavare informazioni dalla Stele di Naram-Sin 196
• Organizzazione delle informazioni 197
Comprendere le cause e gli effetti della rivoluzione agricola 197
Comprendere le cause e gli effetti della rivoluzione urbana 197
• Comprendere la struttura di un quadro storico di civiltà 197
Collocare nel tempo e nello spazio le antiche civiltà 198
Comprendere l’importanza del fiume per lo sviluppo delle antiche civiltà 198
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà mesopotamica 198
Collocare sulla linea del tempo i diversi popoli dell’antica Mesopotamia 199
• Strumenti concettuali 199
Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Sumeri 199
Conoscere le principali opere idrauliche realizzate dai Sumeri 200
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Sumeri 200
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Sumeri 200
Conoscere e analizzare la religione dei Sumeri 200
Conoscere le principali divinità dei Sumeri 201
Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Sumeri 201
Conoscere le principali attività economiche dei Sumeri 201
Conoscere le principali invenzioni dei Sumeri 201
Conoscere il sistema di scrittura dei Sumeri 201
Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Sumeri 202
Conoscere la civiltà degli Accadi 202
Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Babilonesi 202
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica e sociale dei Babilonesi 202
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Babilonesi 203
Conoscere le principali opere architettoniche dei Babilonesi 203
Conoscere il Codice di Hammurabi 203
Conoscere la civiltà degli Hittiti 203
Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Assiri 204
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica e sociale degli Assiri 204
• Produzione scritta e orale 204
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà mesopotamica del passato con quella attuale 204
Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 204
Geografia
• Orientamento 205
Conoscere il Sistema Solare 205
Conoscere il pianeta Terra 205
Orientarsi sul mappamondo utilizzando i punti cardinali 205
Orientarsi attraverso le coordinate geografiche 206
Conoscere cause ed effetti del moto di rotazione della Terra 207
Conoscere cause ed effetti del moto di rivoluzione della Terra 207
• Linguaggio della geo-graficità 208
Leggere e interpretare il planisfero 208
Localizzare la posizione di luoghi sul planisfero 208
Leggere e interpretare planisferi tematici 208
Leggere e interpretare areogrammi e istogrammi 208
• Paesaggio 209
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi mondiali 209
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi europei 209
• Regione e sistema territoriale 209
Conoscere il concetto di clima, i suoi elementi e i suoi fattori 209
Conoscere e descrivere le fasce climatiche mondiali 210
Conoscere e descrivere le aree climatiche europee 210
Conoscere e descrivere le regioni climatiche italiane 210
Matematica
• Relazioni, dati e previsioni 211
Usare correttamente i quantificatori: tutti, alcuni, ognuno, nessuno, almeno uno 211
Attribuire valore di verità a enunciati logici 211
Stabilire il valore di verità della proposizione composta dalla “o” intesa come “disgiunzione inclusiva” 212
Classificare in base a tre attributi dati organizzando i diagrammi di Venn, Carroll e ad albero 214
• Numeri 217
Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci oltre il 1000 217
Scomporre e comporre i numeri in unità, decine e centinaia semplici e in unità, decine e centinaia di migliaia 218
Confrontare e ordinare i numeri in base dieci oltre il 1000 218
Conoscere i numeri romani 219
Effettuare cambi tra migliaia, centinaia, decine e unità 219
Riconoscere e applicare le proprietà dell’addizione e della sottrazione per semplificare il calcolo 220
Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione 222
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali 223
Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione 226
Applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione 227
Eseguire calcoli mentali di moltiplicazione 228
Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 229
Individuare i multipli di un numero 231
Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre 231
Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema 234
Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato delle quattro operazioni 235
Risolvere problemi con due domande e due operazioni 235
• Spazio e figure
Utilizzare il piano cartesiano per individuare punti dati
Rafforzare i concetti di linea retta, semiretta e segmento
Conoscere la definizione di angolo
Misurare e disegnare gli angoli
Classificare gli angoli in base all’ampiezza
Riconoscere angoli concavi e convessi
Rafforzare i concetti di incidenza, perpendicolarità e parallelismo
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni
Individuare le proprietà della materia
Osservare gli stati di aggregazione della materia
Individuare il concetto di calore
Conoscere i modi di trasmissione del calore
Conoscere la dilatazione termica della materia
Osservare i passaggi di stato della materia
Individuare le proprietà dell’aria
Individuare le proprietà dell’acqua
• Osservare e sperimentare sul campo
Osservare e classificare la materia in organica e inorganica
Osservare e sperimentare fenomeni collegati al calore e alla temperatura
Osservare e sperimentare passaggi di stato della materia
Osservare e sperimentare fenomeni collegati all’aria
Osservare e sperimentare fenomeni collegati all’acqua
• L’uomo, i viventi e l’ambiente
Comprendere l’importanza dell’aria nella vita dell’uomo
Comprendere l’importanza dell’acqua nella vita dell’uomo
Musica
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali
Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti
Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini
236
236
237
237
238
238
238
240
241
241
242
242
242
243
243
244
244
245
245
245
245
245
245
246
246
246
247
249
249
249
249
• Osservare e leggere le immagini 250
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 250
Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 250
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 251
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 251
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 251
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 253
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: lanciare e afferrare 253
Percepire la frequenza cardiaca 255
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 255
Esprimersi e comunicare con il corpo 255
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 256
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della pallavolo 256
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 257
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 257
Tecnologia
• Vedere e osservare 258
Riconoscere le caratteristiche e le funzioni degli strumenti di misurazione degli elementi del clima 258
Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di Word 258
• Prevedere e immaginare 259
Pianificare la fabbricazione di un anemometro 259
Pianificare la fabbricazione di un pluviometro 259
• Intervenire e trasformare 259
Realizzare una tabella in cartoncino 259
Antologia
Bentornato autunno! 262
Pubbli, pubbli, pubblicità 265
Rime per tutti i gusti 266
Brani da ascoltare 267
Schede operative
Italiano
n. 33 Ascolto perché… 268
n. 34 La mia opinione sulla pubblicità 269
n. 35 Il gelato 270
n. 36 Diario di bordo 272
n. 37 Primitivi! 274
n. 38 Teatro in classe (1) 276
n. 39 Fossili… freschi 278
n. 40 La pubblicità 280
n. 41 Nocciola 282
n. 42 Un gattino da adottare 284
n. 43 Diario di classe 285
n. 44 Le parole dei personaggi (1) 286
n. 45 Il torrone con le nocciole 287
n. 46 Una classe speciale!
n. 47 Invento slogan
n. 48 Trasformo… la nocciola
n. 49 Il dizionario (1)
n. 50 Il dizionario (2)
n. 51 L’ordine alfabetico
n. 52 Ripeto i suoni c – g
n. 53 Ripeto cu, qu, cqu
n. 54 Ripeto h
n. 55 Ripeto le doppie… in un antico villaggio
n. 56 Ripeto gli, gl, li
n. 57 Ripeto gn e ni
n. 58 Ripeto sci, sce e scie
n. 59 Ripeto le sillabe
n. 60 Ripeto l’accento
n. 61 Ripeto e - è
n. 62 Ripeto l’apostrofo 304
n. 63 Mini riassunti 305
n. 64 Il punto fermo e la virgola
n. 65 I due punti
n. 66 Ripeto la punteggiatura 308
n. 67 Discorso diretto e indiretto (1) 309
Storia
n. 68 Lo Stendardo di Ur
n. 69 La Stele di Hammurabi
n. 70 la Stele di Naram-Sin
n. 71 Il quadro di civiltà 313
n. 72 Le civiltà fluviali nello spazio 314
n. 73 Le opere idrauliche dei Sumeri 315
n. 74 La società sumera 316
n. 75 La “Torre Tempio” di Ur 317
n. 76 I Sumeri: esperti agricoltori
n. 77 I Sumeri: celebri inventori 319
n. 78 La storia della tavoletta d’argilla
n. 79 La scrittura cuneiforme
n. 80 A casa dei Sumeri
n. 81 La maestosità di Babilonia 323
n. 82 L’esercito assiro
n. 83 Gioca con la Mesopotamia
Geografia
n. 84 Il sistema solare 326
n. 85 Pianeti in tabella
n. 86 Il pianeta Terra
n. 87 I paralleli e i meridiani
329
n. 88 Il reticolato geografico 330
n. 89 Il moto di rotazione della Terra 331
n. 90 I fusi orari 332
n. 91 Il moto di rivoluzione della Terra 333
n. 92 Le stagioni 334
n. 93 Alla lettura del planisfero 335
n. 94 Quale continente è più esteso? 336
n. 95 Clima e temperatura 337
n. 96 Gli elementi del clima 338
n. 97 Il clima nel mondo 339
n. 98 Il clima in Italia 340
Matematica
n. 99 I quantificatori
341
n. 100 Gli enunciati logici 342
n. 101 La tabella della verità 343
n. 102 Classificazioni più difficili 344
n. 103 Classifico con il diagramma di Carroll 345
n. 104 Leggo e scrivo i numeri grandi 346
n. 105 Gioco con i simboli e con le cifre 347
n. 106 Ogni cifra ha il suo valore 348
n. 107 Scomposizioni particolari
n. 108 Metto in ordine i numeri grandi
349
350
n. 109 Confronto i numeri grandi 351
n. 110 Gioco con i numeri
352
n. 111 Quiz sui numeri 353
n. 112 I numeri romani (1) 354
n. 113 I numeri romani (2) 355
n. 114 Leggiamo i numeri romani 356
n. 115 I cambi 357
n. 116 L’addizione e le sue proprietà (1)
n. 117 L’addizione e le sue proprietà (2)
n. 118 L’addizione e le sue proprietà (3)
n. 119 La sottrazione e le sue proprietà
n. 120 Calcolo a mente
n. 121 Calcolo velocemente (1)
n. 122 Calcolo velocemente (2)
n. 123 Addizioni in colonna
n. 124 Sottrazioni in colonna
n. 125 La moltiplicazione e le sue proprietà (1)
n. 126 La moltiplicazione e le sue proprietà (2)
n. 127 La moltiplicazione per 10, per 100, per 1000 (1)
n. 128 I multipli
n. 129 Multipli di 2 e di 4
n. 130 Scopriamo i multipli in comune (1)
n. 131 I multipli di...
n. 132 Moltiplicazioni in colonna
n. 133 Problemi ingannevoli (1)
n. 134 Pronta… mente (1)
n. 135 Pronta… mente (2)
n. 136 Le coppie giuste (1)
n. 137 A caccia di punti!
n. 138 Ripasso le linee
n. 139 L’angolo
n. 140 Definizione di angolo
n. 141 Misuro e disegno gli angoli
n. 142 Il goniometro
n. 143 Uso il goniometro
n. 144 Misuro e confronto gli angoli
n. 145 Classifico gli angoli
n. 146 Angoli diversi
n. 147 Angoli concavi e angoli convessi
n. 148 Rette incidenti, perpendicolari e parallele 390
Scienze
n. 149 La materia e le sue proprietà 391
n. 150 La materia sulla Terra e sulla Luna 392
n. 151 Come si trasmette il calore? 393
n. 152 La dilatazione termica 394
n. 153 Che passaggio di stato è? 395
n. 154 Galleggia? 396
n. 155 Organica o inorganica? 397
n. 156 Conduttori o isolanti? 398
n. 157 Chi è più caldo? 399
n. 158 Sperimenta… la dilatazione termica! 400
n. 159 Sperimenta… l’evaporazione! 401
n. 160 Sperimenta… il peso dell’aria! 402
n. 161 Sperimenta… l’acqua nel freezer! 403
n. 162 L’inquinamento atmosferico 404
n. 163 L’acqua nelle nostre case 405
Musica
n. 164 L’intensità dei suoni 406
n. 165 La frase musicale 407
Arte e immagine
n. 166 Coloro la poesia: la pioggia 408
n. 167 Lo studio televisivo 409
Educazione fisica
n. 168 Lancio e afferro 410
n. 169 Mimo e imito 411
n. 170 Fair play 412
Tecnologia
n. 171 Come misuriamo 413
n. 172 Costruisci un pluviometro 414
In giro per le… civiltà
Proposte metodologiche
Italiano
• Ascolto e parlato
416
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 416
Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti
416
416
Formulare domande e fornire risposte precise e pertinenti durante e dopo l’ascolto 417
Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 417
Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 417
• Lettura
417
Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità 417
Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi: la descrizione a scopo informativo 418
Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche: la lettera personale 418
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 419
Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi narrativi, individuando gli elementi principali: tempo, luogo, personaggi e loro caratteristiche 419
Leggere e individuare le sequenze in testi narrativi 420
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: la fiaba 421
Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni per inviare una e-mail 422
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo: la lettera formale 422
Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore: versi e strofe 424
• Scrittura 425
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti: i paesaggi 425
Scrivere testi per esprimere emozioni: la lettera personale 425
Scrivere testi per raccontare vissuti 425
Scrivere testi per raccontare storie 426
Scrivere testi per raccontare storie fantastiche: la fiaba 427
Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: le istruzioni per realizzare un manufatto 428
Scrivere lettere adeguando le forme espressive ai destinatari e alle situazioni: la lettera formale 429
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo
430
Sperimentare tecniche per riassumere testi 430
Sperimentare tecniche per parafrasare testi 430
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 431
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 431
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 431
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: sinonimi, omonimi e contrari 432
Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 433
Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 434
Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 435
Storia
• Uso delle fonti 438
Ricavare informazioni dall’Inno al Nilo 438
Ricavare informazioni dalla Paletta di Narmer 438
Ricavare informazioni dal Papiro di Hunefer 438
Ricavare informazioni da immagini del tesoro del faraone Tutankhamon 439
Ricavare informazioni dalla Stele di Rosetta 439
• Organizzazione delle informazioni 439
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà egizia 440
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà indiana 440
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà cinese 440
• Strumenti concettuali 440
Conoscere la nascita della civiltà degli Egizi 440
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Egizi 441
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Egizi 441
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Egizi 442
Conoscere e analizzare la religione degli Egizi 442
Conoscere le principali divinità degli Egizi 443
Conoscere le principali attività economiche degli Egizi 443
Conoscere il sistema di scrittura degli Egizi 443
Conoscere aspetti della vita quotidiana degli Egizi 444
Conoscere la civiltà indiana 444
Conoscere la civiltà cinese 444
• Produzione scritta e orale 445
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà egizia del passato con quella attuale 445
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà indiana del passato con quella attuale 445
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà cinese del passato con quella attuale 445
Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà fluviali 445
Geografia
• Orientamento 446
Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia utilizzando i punti cardinali 446
Leggere immagini satellitari dell’Italia 446
• Linguaggio della geo-graficità 446
Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi idrografici 446
Sapere leggere e rappresentare le profondità dei mari italiani 446
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali mari 447
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali fiumi 447
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali laghi 447
Realizzare carte geografiche evidenziando elementi idrografici 448
Leggere e interpretare aerogrammi e istogrammi sul sistema idrografico italiano 448
• Paesaggio 448
Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio marino 448
Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio fluviale 449
Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio
lacustre 450
Conoscere le caratteristiche fisiche dell’Italia 450
Conoscere e descrivere i paesaggi marini dell’Italia 451
Conoscere e descrivere i paesaggi fluviali dell’Italia 452
Conoscere e descrivere i paesaggi lacustri dell’Italia 453
• Regione e sistema territoriale 453
Conoscere le principali attività umane collegate al mare 453
Conoscere le principali attività umane collegate al fiume 453
Conoscere le principali attività umane collegate al lago 453
Matematica
• Relazioni, dati e previsioni
454
Stabilire relazioni di equivalenza in un insieme 454
Stabilire relazioni d’ordine tra due o più elementi 454
Rappresentare e leggere istogrammi e ideogrammi 455 Individuare la moda 458 • Numeri 458
Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della divisione 458
Eseguire calcoli mentali di divisione 459
Eseguire divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 460
Individuare i divisori di un numero 460
Riconoscere i numeri primi entro i primi cento numeri naturali 461
Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una cifra 463
Eseguire in colonna divisioni con il divisore di due cifre 463
Eseguire le prove delle quattro operazioni 465
Comprendere il concetto di frazione 465
Individuare l’unità frazionaria di un intero 467
Individuare la frazione complementare di una frazione data 467
Individuare i dati mancanti, i dati superflui e quelli nascosti per la risoluzione di un problema 468
Risolvere problemi con una domanda nascosta 468
Risolvere problemi con una domanda e due operazioni 470
• Spazio e figure 471
Distinguere poligoni e non poligoni 471
Individuare vertici, lati e angoli di un poligono 472
Riconoscere i poligoni convessi e concavi 472
Riconoscere un poligono equilatero, equiangolo e regolare 473
Individuare il numero delle diagonali di un poligono 473
Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli 474
Classificare i triangoli rispetto ai lati 474
Classificare i triangoli rispetto agli angoli 474
Individuare la base e l’altezza di un triangolo 476
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni 478
Individuare le proprietà di diversi tipi di terreno 478
• Osservare e sperimentare sul campo 478
Conoscere l’origine del suolo 478
Conoscere la struttura e la composizione del suolo 478
Osservare la vita nel suolo 479
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 479
Classificare i viventi e i non viventi 479
Conoscere il ciclo vitale 480
Elaborare i primi elementi di classificazione dei viventi 480
Osservare e descrivere le parti della pianta 481
Elaborare i primi elementi di classificazione delle piante 482
Descrivere la struttura e la funzione della radice 482
Descrivere la struttura e la funzione del fusto 483
Descrivere la struttura e la funzione della foglia 483
Descrivere la struttura e la funzione del fiore 484
Descrivere la struttura e la funzione del frutto 485
Musica
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 487
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 487
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare 489
Elaborare creativamente produzioni personali 489
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 489
Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 489
• Osservare e leggere le immagini 490
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 490
Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 491
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 491
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 491
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 491
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 492
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 493
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: strisciare e rotolare 493
Prendere coscienza dei diversi gradi di tono muscolare e rilassamento 493
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 494
Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione 494
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 496
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della palla tamburello 496
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 496
Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute 496
Tecnologia
• Vedere e osservare 497
Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei satelliti artificiali 497
Riconoscere le funzioni principali di SmartArt 497
• Prevedere e immaginare 498
Pianificare la costruzione di un istogramma con Word 498
• Intervenire e trasformare 498
Realizzare interventi di decorazione del corredo scolastico 498
Antologia
Bentornato inverno! 500
Natale in… poesia 503
La poesia nelle discipline 505
Brani da ascoltare
507
Arte e Storia 509
Schede operative
Italiano
n. 173 La maledizione di Tutankhamon 510
n. 174 Domanda e risposta 511
n. 175 La tavola di Natale 512
n. 176 il re scorpione (1) 514
n. 177 Il Faraone e l’oboe (1) 516
n. 178 Inviare una e-mail 518
n. 179 La lettera formale 520
n. 180 Vilasdrogga del ravvreddore 522
n. 181 Descrivo il Nilo 524
n. 182 Una strana conversazione 525
n. 183 Invento una fiaba 526
n. 184 Il portacandele 528
n. 185 Scrivo una lettera formale 529
n. 186 La filastrocca malata 530
n. 187 il Faraone e l’oboe (2) 531
n. 188 Le regole per mangiare sano (1) 532
n. 189 I nomi 533
n. 190 Il genere dei nomi (1) 534
n. 191 Il numero dei nomi (1) 535
n. 192 Gli articoli (1) 536
n. 193 Gli aggettivi qualificativi (1) 537
n. 194 I gradi dell’aggettivo qualificativo (1) 538
n. 195 Il superlativo assoluto e relativo 539
n. 196 Gli aggettivi possessivi 540
n. 197 Gli aggettivi dimostrativi 541
n. 198 Gli aggettivi indefiniti 542
n. 199 Gli aggettivi numerali 543
n. 200 Gli aggettivi interrogativi ed esclamativi (1) 544
n. 201 Analisi degli aggettivi (1) 545
Storia
n. 202 Il “Libro dei morti” di Hunefer 546
n. 203 Il tesoro di Tutankhamon 547
n. 204 Le stagioni “agricole” 548
n. 205 Il Re con le due corone 549
n. 206 Ramses II il condottiero 550
n. 207 Il faraone e i simboli del suo potere 551
n. 208 Chi è? 552
n. 209 Gli animali sacri 553
n. 210 Da Gizah… alla Valle dei Re 554
n. 211 Le divinità egizie 555
n. 212 L’economia degli Egizi 556
n. 213 Adesso scrivo io… 557
n. 214 Il papiro: dalla pianta al rotolo 558
n. 215 A scuola con gli Egizi 559
n. 216 Cerco le parole 560
Geografia
n. 217 Dove si trova? 561
n. 218 Mari, fiumi e laghi d’Italia 562
n. 219 I mari d’Italia 563
n. 220 I fiumi d’Italia 564
n. 221 I laghi d’Italia 565
n. 222 I fiumi in grafico 566
n. 223 I laghi in grafico 567
n. 224 Il paesaggio marino 568
n. 225 Il paesaggio fluviale 569
n. 226 Il paesaggio lacustre 570
n. 227 Un mare, tanti mari 571
n. 228 Il bacino idrografico del Po 572
n. 229 Il mare e il turismo balneare 573
n. 230 Il fiume e l’uomo 574
n. 231 Il lago e l’uomo 575
Matematica
n. 232 Le relazioni (1) 576
n. 233 Gli istogrammi 577
n. 234 Gli ideogrammi 578
n. 235 La moda (1) 579
n. 236 So individuare la moda (1) 580
n. 237 La divisione e la sua proprietà 581
n. 238 Divido a mente 582
n. 239 Le divisioni per 10, 100, 1000 583
n. 240 I divisori 584
n. 241 Scopriamo i divisori di… 585
n. 242 I numeri primi 586
n. 243 Il crivello di Eratostene 587
n. 244 Divisioni facili 588
n. 245 Divisioni difficili 589
n. 246 Mi metto alla prova 590
n. 247 Interi frazionati e non 591
n. 248 Sono parti uguali? 592
n. 249 Conto le parti colorate 593
n. 250 Unità frazionarie (1) 594
n. 251 Completo l’intero 595
n. 252 Dati sotto osservazione (1) 596
n. 253 Dati sotto osservazione (2) 597
n. 254 La domanda giusta (1) 598
n. 255 Sono veloce e riflessivo (1) 599
n. 256 Sono veloce e riflessivo (2) 600
n. 257 Poligoni e non poligoni 601
n. 258 Gli elementi di un poligono 602
n. 259 Vertici, lati e angoli 603
n. 260 Poligoni convessi e concavi (1) 604
n. 261 Poligoni equilateri 605
n. 262 Poligoni equiangoli 606
n. 263 Poligoni regolari 607
n. 264 Le diagonali di un poligono 608
n. 265 Classifico i poligoni 609
n. 266 I triangoli rispetto ai lati 610
n. 267 I triangoli rispetto agli angoli (1) 611
n. 268 I triangoli rispetto agli angoli (2) 612
n. 269 Basi e altezze dei triangoli (1) 613
n. 270 Basi e altezze dei triangoli (2) 614
n. 271 Basi e altezze dei triangoli (3) 615
Scienze
n. 272 Come nasce il suolo? 616
n. 273 Il suolo è vivo 617
n. 274 I cinque regni 618
n. 275 Tante radici 619
n. 276 Il fusto: la sua struttura 620
n. 277 Tanti fusti 621
n. 278 La foglia: la sua struttura 622
n. 279 Tante foglie 623
n. 280 Il fiore: la sua struttura 624
n. 281 Il fiore e la sua riproduzione 625
n. 282 L’impollinazione 626
n. 283 La fecondazione 627
n. 284 Il frutto: la sua struttura 628
n. 285 La disseminazione 629
n. 286 La germinazione 630
Musica
n. 287 I timbri strumentali 631
n. 288 L’armonia e il colore della musica 632
Arte e immagine
n. 289 Parole mascherate da... Egizi 633
n. 290 L’inverno 634
Educazione fisica
n. 291 Mi muovo come più mi piace! 635
n. 292 Mi rilasso un po’ 636
n. 293 Le ombre cinesi 637
n. 294 Gioco a… 638
Tecnologia
n. 295 Satelliti artificiali 639
n. 296 Costruisci un istogramma 640
La natura tra realtà e fantasia
Proposte metodologiche
Italiano
• Ascolto e parlato 642
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 642
Individuare e usare il canale adeguato alla comunicazione 642
Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 642
• Lettura 643
Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi: la descrizione fantastica 643
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 643
Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze di testi narrativi 644
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: la leggenda 644
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca 645
Leggere testi dialogati, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto 645
Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni 645
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuandone le caratteristiche e lo scopo 646
Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore: le figure di significato 646
• Scrittura 647
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 647
Scrivere testi per raccontare storie fantastiche: la leggenda 648
Scrivere la cronaca di un evento accaduto per informare 648
Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività 649
Scrivere testi informativo-espositivi: la relazione 649
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 650
Sperimentare tecniche per riassumere testi 650
Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato 651
Sperimentare tecniche per parafrasare testi 651
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 652
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 652
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: il linguaggio figurato 652
Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 652
Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 653
Storia
• Uso delle fonti 655
Ricavare informazioni dalla Stele di Nora 655
Ricavare informazioni da versetti del Libro dell’Esodo 655
Ricavare informazioni da simboli della religione ebraica 655
• Organizzazione delle informazioni 656
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà fenicia 656
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà ebraica 656
• Strumenti concettuali 656
Conoscere la nascita della civiltà dei Fenici 656
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Fenici 657
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Fenici 657
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Fenici 657
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Fenici 658
Conoscere le principali attività economiche dei Fenici 658
Conoscere le principali invenzioni dei Fenici 659
Conoscere la nascita della civiltà degli Ebrei 659
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Ebrei 660
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Ebrei 660
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Ebrei 661
Conoscere e analizzare la religione degli Ebrei 661
Conoscere le principali attività economiche degli Ebrei 662
• Produzione scritta e orale 662
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà fenicia del passato con quella attuale 662
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà ebraica del passato con quella attuale 662
Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 662
Geografia
• Orientamento 663
Orientarsi sulla carta geografica dell’Italia utilizzando i punti cardinali 663
Osservare elementi orografici in immagini satellitari dell’Italia 663
• Linguaggio della geo-graficità 663
Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi orografici 663
Saper leggere e rappresentare le altitudini dei rilievi italiani 663
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali montagne 664
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali vulcani 664
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali colline 665
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali pianure 665
Realizzare carte geografiche evidenziando elementi orografici 665
Leggere e costruire areogrammi, istogrammi e tabelle sul sistema orografico italiano 665
• Paesaggio 666
Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio montano 666
Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio collinare 666
Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio pianeggiante 667
Conoscere e descrivere i paesaggi montuosi dell’Italia 668
Conoscere e descrivere i paesaggi collinari dell’Italia 669
Conoscere e descrivere i paesaggi pianeggianti
dell’Italia 669
• Regione e sistema territoriale 670
Conoscere le principali attività umane collegate alla montagna 670
Conoscere le principali attività umane collegate alla collina 670
Conoscere le principali attività umane collegate alla pianura 670
Matematica
• Numeri 671
Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti 671
Confrontare e ordinare unità frazionarie 672
Confrontare e ordinare frazioni 673
Riconoscere frazioni equivalenti 674
Calcolare la frazione di un numero 675
Riconoscere le frazioni decimali 676
Trasformare frazioni decimali in numeri decimali 677
Leggere e scrivere i numeri decimali indicando il valore di ogni cifra 680
Scomporre i numeri decimali in decimi, centesimi, millesimi 680
Comporre numeri espressi in decimi, centesimi, millesimi 681
Confrontare e ordinare i numeri decimali 681
Risolvere problemi con più domande esplicite o implicite 682
Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione 682
Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità 683
Risolvere problemi geometrici 683
• Spazio e figure 684
Classificare i quadrilateri 684
Individuare le caratteristiche dei trapezi 685
Individuare le caratteristiche dei parallelogrammi 686
Acquisire i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria 687
Calcolare il perimetro dei triangoli 690
Calcolare il perimetro dei quadrilateri 690
• Relazioni, dati e previsioni 690
Rappresentare e leggere l’areogramma 690
Conoscere le unità di misura convenzionali di lunghezza, peso e capacità 693
Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità a un’altra ad essa equivalente con i numeri interi 699
Leggere, calcolare e interpretare la media aritmetica 701
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni 702
Osservare trasformazioni chimiche 702
• Osservare e sperimentare sul campo 702
Osservare le caratteristiche degli animali 702
Osservare gli invertebrati e i vertebrati 702
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 703
Osservare gli ambienti di vita degli invertebrati 703
Osservare gli ambienti di vita dei vertebrati 703
Elaborare i primi elementi di classificazione degli invertebrati 704
Descrivere le caratteristiche morfologiche degli invertebrati 704
Elaborare i primi elementi di classificazione dei vertebrati 704
Descrivere le caratteristiche morfologiche dei pesci 705
Descrivere le caratteristiche morfologiche degli anfibi 705
Descrivere le caratteristiche morfologiche dei rettili 706
Descrivere le caratteristiche morfologiche degli uccelli 707
Descrivere le caratteristiche morfologiche dei mammiferi 707
Descrivere e interpretare le funzioni vitali degli animali 709
Descrivere e interpretare le principali funzioni vitali degli invertebrati 709
Descrivere gli organi e le modalità della respirazione dei vertebrati 709
Descrivere gli organi e le modalità della nutrizione dei vertebrati 710
Descrivere gli organi e le modalità della circolazione e dell’escrezione dei vertebrati 710
Descrivere gli organi e le modalità del movimento dei vertebrati 710
Descrivere gli organi e le modalità della riproduzione dei vertebrati 711
Musica
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/ strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 712
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 712
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare 714
Elaborare creativamente produzioni personali 714
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 714
Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 715
• Osservare e leggere le immagini 715
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 715
Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 715
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 716
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 716
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 716
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 717
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: camminare e correre 717
Utilizzare le capacità condizionali 717
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 718
Muovere il corpo a ritmo di musica e differenziare gli spostamenti del gruppo nello spazio 718
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 719
Risolvere problemi di pratica sportiva mediante l’accoglimento di correzioni e suggerimenti 719
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 720
Assumere comportamenti salutistici 720
Tecnologia
• Vedere e osservare 721
Riconoscere le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC 721
Riconoscere le funzioni principali di WordArt 721
• Prevedere e immaginare 721
Pianificare la costruzione di una bussola 721
Pianificare la costruzione di un areogramma con Word 722
• Intervenire e trasformare 722
Realizzare un biglietto in cartoncino 722
Antologia
Ciao inverno 724
Bentornata primavera! 725
La pace in… poesia 729
Animali in… poesia 730
Poesia in… natura 732
Schede operative Italiano
n. 297 Ascolto… gli animali 734
n. 298 Comunicare con… 735
n. 299 Animali a Stranalandia (1) 736
n. 300 L’ascensore vulcanico 738
n. 301 L’Arca di Noè (1) 740
n. 302 Una cronaca giurassica (1) 742
n. 303 Metafore! 744
n. 304 Un divertente travestimento 746
n. 305 L’Osservatorio Vesuviano (1) 748
n. 306 Similitudini e metafore 750
n. 307 Invento e descrivo 752
n. 308 Scrivo una cronaca 753
n. 309 Travestimenti 754
n. 310 Scrivo una relazione 755
n. 311 Quasi… poeta 756
n. 312 L’Osservatorio Vesuviano (3) 757
n. 313 Trasformo… gli occhiali 758
n. 314 Le espressioni figurate (1) 759
n. 315 I pronomi personali (1) 760
n. 316 Quanti pronomi! 761
n. 317 I pronomi relativi 762
n. 318 I verbi 763
n. 319 Il verbo essere 764
n. 320 Il verbo avere 765
n. 321 Il modo indicativo (1) 766
n. 322 Il modo congiuntivo 768
n. 323 Il modo condizionale 769
n. 324 Il modo imperativo 770
n. 325 Il modo infinito 771
n. 326 Il modo participio 772
n. 327 Il modo gerundio 773
Storia
n. 328 La Stele di Nora 774
n. 329 Simboli ebraici 775
n. 330 Dalla madrepatria alle colonie 776
n. 331 Dal re ai “suffeti” 777
n. 332 La società fenicia 778
n. 333 I Fenici: artigiani del lusso 779
n. 334 La porpora: simbolo dei re 780
n. 335 La nave dei Fenici 781
n. 336 La civiltà degli Ebrei 782
n. 337 La storia degli Ebrei 783
n. 338 I patriarchi 784
n. 339 Dai patriarchi ai re 785
n. 340 La religione ebraica
n. 341 Tante parole per i Fenici
786
787
n. 342 Tante parole per gli Ebrei 788
Geografia
n. 343 Montagne, colline e pianure d’Italia
n. 344 Le montagne d’Italia
789
790
n. 345 I vulcani d’Italia 791
n. 346 Le colline d’Italia 792
n. 347 Le pianure d’Italia 793
n. 348 I monti più alti d’Italia in istogrammi 794
n. 349 Nasce una montagna 795
n. 350 Il paesaggio montano 796
n. 351 Una montagna speciale: il vulcano 797
n. 352 Nasce una collina 798
n. 353 Nasce una pianura 799
n. 354 Tante immagini per le Alpi 800
n. 355 Tante immagini per gli Appennini 801
n. 356 Tante immagini per le colline 802
n. 357 Una grande pianura 803
Matematica
n. 358 Che frazione è? (1) 804
n. 359 Che frazione è? (2) 805
n. 360 Che frazione è? (3) 806
n. 361 Confronto le unità frazionarie (1) 807
n. 362 Confronto le unità frazionarie (2) 808
n. 363 Confronto le frazioni 809
n. 364 Confronto e ordino le frazioni (2) 810
n. 365 Frazioni equivalenti 811
n. 366 La frazione di un numero (1) 812
n. 367 La frazione di un numero (3) 813
n. 368 Le frazioni decimali (1) 814
n. 369 Le frazioni decimali (2) 815
n. 370 Le frazioni decimali (3) 816
n. 371 Leggo le frazioni decimali 817
n. 372 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (1) 818
n. 373 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (2) 819
n. 374 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (3) 820
n. 375 Scomporre i numeri decimali 821
n. 376 Comporre i numeri decimali 822
n. 377 Confronto i numeri decimali (1) 823
n. 378 Le misure di lunghezza (1) 824
n. 379 Le misure di peso (1) 825
n. 380 Le misure di capacità (1) 826
n. 381 Le equivalenze (1) 827
n. 382 Problemi con più domande (1) 828
n. 383 Problemi con le frazioni (1) 829
n. 384 Problemi… in lungo e largo (1) 830
n. 385 Pesi massimi, medi e piuma (1) 831
n. 386 Verso, travaso, svuoto (1) 832
n. 387 I quadrilateri 833
n. 388 I trapezi (1) 834
n. 389 I parallelogrammi 835
n. 390 Saranno congruenti? 836
n. 391 Figure congruenti ed equivalenti 837
n. 392 Figure isoperimetriche 838
n. 393 Il perimetro del triangolo (1) 839
n. 394 Il perimetro del quadrato e del rettangolo 840
n. 395 Il perimetro del rombo e del parallelogramma 841
n. 396 Il perimetro del trapezio 842
n. 397 L’areogramma 843
n. 398 Problemi e perimetri (1) 844
n. 399 So calcolare la media (1) 845
Scienze
n. 400 Classifica gli animali 846
n. 401 Classifica gli invertebrati 847
n. 402 Gli insetti 848
n. 403 Tanti invertebrati: i molluschi 849
n. 404 Classifica i vertebrati 850
n. 405 Osserva un pesce 851
n. 406 Osserva un anfibio 852
n. 407 Osserva i rettili 853
n. 408 Osserva un uccello 854
n. 409 Osserva i mammiferi 855
n. 410 Tanti arti e tanti denti 856
n. 411 Le funzioni vitali degli animali 857
n. 412 La respirazione dei vertebrati 858
n. 413 La nutrizione dei vertebrati 859
n. 414 La riproduzione dei vertebrati 860
Musica
n. 415 La durata dei suoni 861
n. 416 Ritmo e accenti 862
Arte e immagine
n. 417 Vulcani artistici (1) 863
n. 418 La Primavera 864
Educazione fisica
n. 419 Camminare e correre 865
n. 420 A ognuno il suo movimento 866
Tecnologia
n. 421 Senza mouse… 867
n. 422 Costruisci una bussola 868
APRILE • MAGGIO Girovagando
Proposte metodologiche
Italiano
• Ascolto e parlato 870
Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 870
Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per l’esecuzione di attività 870
Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti 870
Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per l’esecuzione di attività 870
Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 871
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 871
Usare un linguaggio adeguato al contesto e al destinatario 871
• Lettura 872
Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 872
Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi 872
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: il mito 873
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica: la narrazione di paura 873
Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca 875
Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni 876
Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 876
Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa
dell’autore: le figure di suono 876
• Scrittura 877
Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 877
Scrivere testi per raccontare vissuti 878
Scrivere testi per raccontare storie 879
Scrivere la cronaca di un fatto per informare 879
Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: le regole di comportamento in acqua 879
Scrivere testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze 880
Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 880
Sperimentare tecniche per riassumere testi 882
Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato 882
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 883
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 883
Riconoscere preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 883
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 884
Storia
• Uso delle fonti 886
Ricavare informazioni dal Disco di Festo 886
Ricavare informazioni da immagini di oggetti della civiltà cretese 886
Ricavare informazioni da immagini di oggetti della civiltà micenea 886
Ricavare informazioni da immagini di opere architettoniche della civiltà micenea 887
• Organizzazione delle informazioni 887
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà cretese 887
Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà micenea 887
• Strumenti concettuali e conoscenze 887
Conoscere la nascita della civiltà dei Cretesi 887
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Cretesi 888
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Cretesi 889
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Cretesi 889
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Cretesi 889
Conoscere le principali attività economiche dei Cretesi 890
Conoscere la nascita della civiltà dei Micenei 890
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Micenei 891
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Micenei 891
Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Micenei 892
Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Micenei 892
Conoscere le principali attività economiche dei Micenei 892
• Produzione scritta e orale 893
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà cretese del passato con quella attuale 893
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà micenea del passato con quella attuale 893
Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 893
Geografia
• Orientamento 894
Orientarsi su una carta tematica dell’Italia utilizzando i punti cardinali 894
Osservare elementi antropici in immagini di paesaggi 894
• Linguaggio della geo-graficità 894
Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi antropici 894
Realizzare carte geografiche evidenziando elementi antropici 895
Analizzare i concetti di economia e di regione economica 895
Leggere e costruire areogrammi, ideogrammi e tabelle sull’economia europea 895
Leggere e costruire areogrammi, istogrammi, ideogrammi e tabelle sull’economia italiana 895
Analizzare i concetti di popolo e di popolazione 896
Analizzare le caratteristiche della popolazione europea 896
Analizzare le caratteristiche della popolazione italiana 896
• Paesaggio 896
Conoscere gli elementi di paesaggi umanizzati 896
Conoscere gli elementi di paesaggi culturali 897
Conoscere il patrimonio culturale dell’Italia 897
• Regione e sistema territoriale 897
Conoscere e descrivere i settori produttivi 897
Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia in Europa 898
Conoscere e descrivere i settori produttivi
dell’economia in Italia 898
Conoscere e descrivere il settore primario in Italia 899
Conoscere le modalità di tutela dei prodotti agricoli di qualità 900
Conoscere e descrivere il settore secondario in Italia 900
Conoscere e descrivere il settore terziario in Italia 901
Matematica
• Numeri 902
Effettuare cambi tra unità, decimi, centesimi e millesimi 902
Eseguire in riga, su tabelle e con gli operatori, semplici calcoli di addizione e sottrazione con i numeri decimali 902
Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali 903
Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000 903
Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali 906
Eseguire in colonna divisioni con il dividendo decimale 908
Eseguire in colonna divisioni con il divisore decimale 908
Eseguire in colonna divisioni con il dividendo e il divisore decimali 909
Risolvere situazioni problematiche relative a peso lordo, peso netto e tara 910
Risolvere problemi di costo unitario e costo totale 911
Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita 911
Risolvere problemi sulle aree 914
• Spazio e figure 914
Rappresentare sul piano cartesiano figure ottenute per traslazione, per rotazione, per ribaltamento 914
Individuare gli assi di simmetria nei poligoni 916
Conoscere la differenza tra perimetro e area 916
Calcolare l’area del quadrato, del rettangolo e del triangolo 917
• Relazioni, dati e previsioni 918
Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità a un’altra ad essa equivalente con i numeri decimali 918
Conoscere le misure di superficie 918
Conoscere e utilizzare le misure di tempo 921
Leggere, calcolare e interpretare la percentuale 923
Quantificare la probabilità del verificarsi di un evento mediante una frazione 924
Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, la selezione 927
Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, l’iterazione 927
Scienze
• Oggetti, materiali e trasformazioni 928
Interpretare fenomeni osservati 928
• Osservare e sperimentare sul campo 928
Conoscere il concetto di ecosistema 928
Individuare le componenti di un ecosistema 929
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 929
Riconoscere la relazione tra componente abiotica ed ecosistema 929
Riconoscere le strategie di adattamento di piante e di animali 930
Riconoscere la relazione tra componente biotica ed ecosistema 930
Individuare i rapporti tra le specie in un ecosistema 931
Descrivere le catene alimentari 931
Descrivere le reti alimentari 932
Descrivere le piramidi alimentari 932
Descrivere i comportamenti animali 932
Descrivere il linguaggio degli animali 933
Descrivere le attività della vita sociale degli animali 933
Musica
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 936
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 936
Arte e immagine
• Esprimersi e comunicare 938
Elaborare creativamente composizioni 938
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 938
• Osservare e leggere le immagini 939
Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 939
Conoscere il linguaggio dei fumetti 939
Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 939
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 940
Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 940
Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 940
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 941
Educazione fisica
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 942
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre e saltare 942
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 942
Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione 942
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 943
Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare (applicare regole) 943
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 944
Assumere stili di vita salutistici 944
Tecnologia
• Vedere e osservare 945
Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei pannelli solari 945
Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di PowerPoint 945
• Prevedere e immaginare 946
Organizzare una gita utilizzando internet per reperire informazioni 946
• Intervenire e trasformare 946
Utilizzare presentazioni con PowerPoint 946
Antologia
Aspettando l’estate! 948
Nonsense per tutti i gusti 951
Poesie per la mamma 953
La poesia nell’ambiente 954
Brani da ascoltare 954
Schede operative
Italiano
n. 423 Ulisse e Polifemo 956
n. 424 Il pinguino vagabondo 958
n. 425 Tanti modi per parlare 959
n. 426 Teseo (1) 960
n. 427 La guerra di Troia (1) 962
n. 428 La torre del terrore (1) 964
n. 429 L’articolo di giornale 966
n. 430 Corda o spazzolino? 968
n. 431 Il Piedibus (1) 970
n. 432 I suoni della poesia 972
n. 433 Al mostro! 974
n. 434 Sono un giornalista! 975
n. 435 Una storia da brivido! 976
n. 436 Regole in acqua 978
n. 437 Vivo a… 979
n. 438 Imito una poesia 980
n. 439 Il Piedibus (2) 981
n. 440 Dalla poesia al dialogo 982
n. 441 Le preposizioni semplici e articolate 983
n. 442 Gli avverbi 984
n. 443 Le congiunzioni 985
n. 444 Le esclamazioni 986
n. 445 La frase semplice 987
n. 446 Il soggetto 988
n. 447 Il predicato verbale 989
n. 448 Il predicato nominale 990
Storia
n. 449 Il Disco di Festo 991
n. 450 Simboli cretesi 992
n. 451 Corazze, maschere e pugnali 993
n. 452 Porte e tombe ciclopiche 994
n. 453 La civiltà dei Cretesi 995
n. 454 I palazzi minoici 996
n. 455 I culti cretesi 997
n. 456 Il toro a Creta 998
n. 457 La civiltà dei Micenei 999
n. 458 La colonizzazione micenea 1000
n. 459 La guerra di Troia 1001
n. 460 Chi comanda tra gli Achei? 1002
n. 461 La città-fortezza 1003
n. 462 L’economia dei Micenei 1004
n. 463 I Cretesi in cruciverba 1005
n. 464 I Micenei in crucipuzzle 1006
Geografia
n. 465 La densità demografica in Italia 1007
n. 466 Carte umanizzate 1008
n. 467 Economia d’Italia in grafici 1009
n. 468 Una popolazione multietnica 1010
n. 469 Opere d’Italia 1011
n. 470 I settori produttivi 1012
n. 471 Le industrie e i prodotti 1013
n. 472 Dalla materia prima al prodotto finito 1014
n. 473 Il settore terziario 1015
n. 474 L’agricoltura in Europa 1016
n. 475 L’agricoltura in Italia 1017
n. 476 L’allevamento in Italia 1018
n. 477 DOP d’Italia 1019
n. 478 L’industria in Italia 1020
n. 479 I distretti dell’industria italiana 1021
n. 480 Il turismo in Italia 1022
Matematica
n. 481 Cambi difficili 1023
n. 482 Calcoli mentali con i numeri decimali 1024
n. 483 Tabelle con i numeri decimali 1025
n. 484 Addizioni con i numeri decimali (1) 1026
n. 485 Addizioni con i numeri decimali (2) 1027
n. 486 Sottrazioni con i numeri decimali (1) 1028
n. 487 Sottrazioni con i numeri decimali (2) 1029
n. 488 Moltiplico i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (1) 1030
n. 489 Moltiplico i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (2) 1031
n. 490 Divido i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (1) 1032
n. 491 Divido i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (2) 1033
n. 492 Divido con il dividendo decimale 1034
n. 493 Divido con il divisore decimale 1035
n. 494 Divido con il dividendo e il divisore decimali 1036
n. 495 Equivalenze… particolari 1037
n. 496 Ok, il peso è giusto (1) 1038
n. 497 Quanto costa? (1) 1039
n. 498 Affari d’oro! (1) 1040
n. 499 La traslazione 1041
n. 500 La rotazione 1042
n. 501 La simmetria 1043
n. 502 Assi di simmetria (2) 1044
n. 503 La superficie 1045
n. 504 Perimetro e area 1046
n. 505 Le unità di misura di superficie (1) 1047
n. 506 Le unità di misura di superficie (2) 1048
n. 507 Scrivo le misure di superficie 1049
n. 508 L’area del quadrato 1050
n. 509 L’area del rettangolo 1051
n. 510 L’area del triangolo 1052
n. 511 Superfici e aree (1) 1053
n. 512 Le misure del tempo 1054
n. 513 Calcolo il tempo 1055
n. 514 So calcolare la percentuale (1) 1056
n. 515 Calcolo la probabilità 1057
n. 516 Algoritmi sequenziali 1058
n. 517 Diagrammi di flusso (1) 1059
Scienze
n. 518 Abiotica o biotica? 1060
n. 519 L’adattamento di piante e di animali 1061
n. 520 Habitat e popolazione 1062
n. 521 Predatori e prede 1063
n. 522 Tante catene 1064
n. 523 Tanti livelli 1065
n. 524 Le reti alimentari 1066
n. 525 La piramide dei pesi 1067
n. 526 La piramide dei numeri 1068
n. 527 Come apprendono gli animali? 1069
n. 528 La comunicazione animale 1070
n. 529 La difesa del territorio 1071
n. 530 Il corteggiamento 1072
n. 531 La cura dei piccoli 1073
n. 532 Società aperte e chiuse 1074
Musica
n. 533 Le battute 1075
n. 534 Lo Schiaccianoci 1076
Arte e immagine
n. 535 Il fumetto 1077
n. 536 La reggia di Caserta 1078
Educazione fisica
n. 537 Gli schemi motori di base 1079
n. 538 A che gioco giochiamo? 1080
Tecnologia
n. 539 Pannelli solari 1081
n. 540 Costruisci un ipertesto 1082
Uniti e insieme!
Proposte metodologiche
Educazione civica
• Dignità umana 1084
Conoscere la storia della Costituzione italiana 1084
Riflettere sulla pari dignità sociale sancita nell’articolo 3 della Costituzione italiana 1085
Riflettere sul principio di eguaglianza sancito nell’articolo 3 della Costituzione italiana 1086
• Identità e appartenenza 1089
Individuare i segni distintivi della propria identità 1089
Conoscere i segni costituzionali dell’Unità d’Italia 1090
Riconoscere comportamenti idonei per la propria salute e il proprio benessere 1091
• Alterità e relazione 1091
Riconoscere i ruoli e le funzioni nella famiglia 1091
Riconoscere i ruoli e le funzioni nella scuola 1092
• Partecipazione 1093
Elaborare un regolamento di classe 1093
Riconoscere e attuare comportamenti di rispetto dell’ambiente 1093
Schede operative
Educazione civica
n. 541 Tutti egualmente degni 1094
n. 542 In classe 1095
n. 543 Donne coraggiose 1096
n. 544 Sei tu! 1097
n. 545 L’emblema della Repubblica 1098
n. 546 Un decalogo per i tuoi denti 1099
n. 547 Tutti insieme! 1100
n. 548 Diritti e bambini 1101
n. 549 Natura, rimani! 1102
n. 550 Fai compostaggio 1103
approfondimenti
(In questa sezione sono presenti anche le soluzioni relative alle schede operative di Italiano)
29 Il Sistema
34 Le aree climatiche europee
n. 35 Le regioni climatiche italiane
Matematica
n. 36 Gli enunciati logici
n. 37 I numeri oltre il 1000 in base dieci
n. 38 Numeri romani
n. 39 Calcoli mentali di addizione e sottrazione
n. 40 I dati essenziali per risolvere un problema
n. 41 Problemi con una domanda e un’operazione
n. 42 Retta, semiretta e segmento
n. 43 Definizione di angolo
n. 44 Rette incidenti, perpendicolari e parallele
Scienze
n. 45 Gli stati di aggregazione della materia
n. 46 I modi di trasmissione del calore
n. 47 L’aria
n. 48 L’acqua
Educazione fisica
n. 49 La frequenza cardiaca
n. 50 Esprimersi e comunicare con il corpo
n. 51 Esercizi e giochi
n. 52 Una sana e corretta alimentazione
Tecnologia
n. 53 Gli strumenti di misurazione del clima
Italiano
n. 54 Le regole del mangiare sano
n. 55 Il re scorpione
56 La lettera formale
57 Riflessione sui nomi
58 Riflessione sugli articoli
59 Riflessione sugli aggettivi
n. 60 La Paletta di Narmer
65 L’Antica Cina
n. 66 Le vicende storiche degli Egizi
67 L’organizzazione politica degli Egizi
68 La società egizia
69 La religione degli Egizi
70 Le divinità degli Egizi
71 Le attività economiche degli Egizi
72 La scrittura degli Egizi
73 La vita quotidiana degli Egizi
74 La civiltà indiana
75 La civiltà cinese
n. 76 Il paesaggio marino
n. 77 Il paesaggio fluviale
n. 78 Il paesaggio lacustre
n. 79 Mari, coste, isole e arcipelaghi dell’Italia
n. 80 I fiumi dell’Italia
81 I laghi dell’Italia
82 L’uomo e il mare
83 L’uomo e il fiume
Matematica
n. 84 La moda
n. 85 Divisioni in colonna con una cifra
n. 86 Le prove delle quattro operazioni
Scienze
n. 87 L’origine del suolo
n. 88 La struttura e la composizione del suolo
n. 89 La classificazione dei viventi
n. 90 La classificazione delle piante
n. 91 La struttura e la funzione del fusto
n. 92 La struttura e la funzione della foglia
n. 93 Impollinazione e fecondazione
n. 94 La struttura e la funzione del frutto
Educazione fisica
n. 95 La pallatamburello
Tecnologia
n. 96 I satelliti artificiali
3° BIMESTRE
n. 97 L’arca di Noè
n. 98 L’Osservatorio vesuviano
n. 99 Cronaca giurassica
n. 100 Trasformo gli occhiali
n. 101 Riflessione sui pronomi 155
n. 102 I pronomi relativi 158
n. 103 Riflessione sui verbi 159
Storia
n. 104 I simboli della religione ebraica 162
n. 105 La Fenicia 163
n. 106 Le vicende storiche dei Fenici 164
n. 107 Le divinità dei Fenici 165
n. 108 La porpora 166
n. 109 Le principali invenzioni dei Fenici 167
n. 110 Le vicende storiche degli Ebrei 169
n. 111 La società ebraica 172
n. 112 La religione degli Ebrei 173
n. 113 Il Libano 175
n. 114 Israele 176
Geografia
n. 115 Il paesaggio montano 177
n. 116 Il paesaggio collinare 181
n. 117 Il paesaggio pianeggiante 183
n. 118 Le Alpi 185
n. 119 Gli Appennini 186
n. 120 Le colline dell’Italia 187
n. 121 Le pianure dell’Italia 188
n. 122 L’uomo e la montagna 189
n. 123 L’uomo e la collina 190
n. 124 L’uomo e la pianura 191
Matematica
n. 125 La media aritmetica 192
Scienze
n. 126 Gli invertebrati 195
n. 127 Pesci cartilaginei e pesci ossei 198
n. 128 Da girino ad anfibio adulto 199
n. 129 Gli uccelli 200
n. 130 Le funzioni vitali degli invertebrati 201
n. 131 Organi e modalità di respirazione dei vertebrati 202
n. 132 La nutrizione dei vertebrati 203
n. 133 La circolazione e l’escrezione dei vertebrati 204
n. 134 Il movimento dei vertebrati 205
n. 135 La riproduzione dei vertebrati 206
Educazione fisica
n. 136 Le danze 208
n. 137 Osservazione e valutazione della postura 209
Italiano
n. 138 La guerra di Troia
n. 139 Le preposizioni semplici e articolate
n. 140 Le congiunzioni 213
n. 141 Il predicato verbale
Storia
n. 142 Il Disco di Festo
n. 143 Simboli cretesi
n. 144 Corazze, maschere e pugnali 217
n. 145 La Porta dei Leoni e il Tesoro di Atreo 218
n. 146 Creta 219
n. 147 Il Peloponneso 220
n. 148 Le vicende storiche dei Cretesi 221
n. 149 La società cretese 223
n. 150 La religione dei Cretesi 224
n. 151 Le vicende storiche dei Micenei 225
n. 152 La società micenea 228
n. 153 La religione dei Micenei 229
n. 154 Creta oggi 231
n. 155 Il Peloponneso oggi
Geografia
n. 156 La popolazione europea 233
n. 157 La popolazione italiana
n. 158 I settori produttivi
n. 159 La classificazione delle industrie
n. 160 L’economia europea
n. 161 Il settore primario in Italia 240
n. 162 I marchi d’eccellenza 242
n. 163 L’industria italiana, le regioni e i distretti industriali 243
n. 164 Il settore terziario in Italia 245
Matematica
n. 165 Costo unitario e costo totale 247
n. 166 Assi di simmetria nei poligoni 249
n. 167 L’algoritmo 1 251
n. 168 L’algoritmo 2 255
Scienze
n. 169 I rapporti tra le specie dei viventi 257
n. 170 Le catene alimentari e i livelli trofici
n. 171 Le piramidi alimentari
n. 172 Comportamenti innati e appresi
n. 173 l linguaggio degli animali 262
Musica
n. 174 Lo “Schiaccianoci”
SETTEMBRE
Italiano
n. 1 Divento grande
n. 2 Quarta elementare (2)
n. 3 Si parte!
n. 4 Viva i fumetti!
Storia
n. 5 Un formidabile team!
n. 6 Le parole della Storia
n. 7 L’anno zero nella tua vita
n. 8 Tanti anni zero!
n. 9 L’evoluzione dell’uomo
Geografia
n. 10 Tante foto per il geografo
n. 11 Riduco in scala
n. 12 Leggo una carta geografica
n. 13 Tante carte tematiche
n. 14 Carte e legenda
Matematica
n. 15 Quale operazione? (2)
Scienze
n. 16 Le scienze naturali
n. 17 Lo scienziato e il suo metodo
n. 18 Sperimento io…
n. 19 Gli strumenti per osservare
n. 20 Gli attrezzi nel laboratorio
OTTOBRE • NOVEMBRE
Italiano
n. 21 Il leone e l’aquila
n. 22 Canzonetta d’amore per il vento 289
n. 23 Ascolta e ricorda
n. 24 Mi piace
n. 25 La quarta A
n. 26 Il negozio delle furbizie
n. 27 Teatro in classe (2) 296
n. 28 Le parole dei personagi (2) 297
n. 29 Un fantastico manifesto 298
n. 30 Invento una favola 299
n. 31 Scherzi della pubblicità 300
n. 32 Teatro in classe (3) 301
n. 33 Discorso diretto e indiretto (2) 302 Storia
n. 34 La rivoluzione agricola 303
n. 35 La piramide sociale 304
n. 36 Le civiltà fluviali nel tempo 305
n. 37 Perché il fiume è importante? 306
n. 38 La Mesopotamia 307
n. 39 In Mesopotamia… quanti popoli! 308
n. 40 I Sumeri 309
n. 41 Il re e il sommo sacerdote 310
n. 42 Dei e demoni 311
n. 43 Le divinità dei Sumeri 312
n. 44 I Sumeri: abili artigiani e mercanti
n. 45 I Sumeri: eccellenti ingegneri idraulici
n. 46 La scuola delle tavolette
n. 47 A casa dei Sumeri
n. 48 Gli Accadi
n. 49 I Babilonesi
n. 50 La società babilonese
n. 51 La grande ziggurat di Babilonia
n. 52 Il codice di Hammurabi
n. 53 Gli Hittiti
n. 54 Gli Assiri
n. 55 Il re Assurbanipal
n. 56 La Mesopotamia oggi
n. 57 Una civiltà in un… quadro
Geografia
n. 58 In giro attorno al Sole!
n. 59 I poli, l’equatore e gli emisferi
n. 60 Le coordinate geografiche
n. 61 Equinozi e solstizi
n. 62 Il planisfero
n. 63 Storia del planisfero
n. 64 Alla ricerca nel planisfero
n. 65 La fame nel mondo
n. 66 La popolazione nel mondo
n. 67 La biosfera
n. 68 I biomi terrestri
n. 69 L’Europa politica
n. 70 I biomi europei
n. 71 I fattori del clima
n. 72 Il clima in Europa
Matematica
n. 73 Disgiunzioni vere o false? (1)
n. 74 Disgiunzioni vere o false? (2) 343
n. 75 Un simpatico strumento per classificare
n. 76 Rappresento i numeri grandi 345
n. 77 Numerare senza sbagliare 346
n. 78 Giochiamo con i numeri romani 347
n. 79 Moltiplico a mente 348
n. 80 Le moltiplicazioni per 10, per 100, per 1000 (2) 349
n. 81 Scopriamo i multipli in comune (2) 350
n. 82 Gioco con i multipli 351
n. 83 Problemi ingannevoli (2) 352
n. 84 Pronta… mente (3) 353
n. 85 Pronta… mente (4) 354
n. 86 Pronta… mente (5) 355
n. 87 Le coppie giuste (2) 356
n. 88 Le coppie giuste (3) 357
n. 89 Le coppie giuste (4) 358
n. 90 So disegnare le linee 359
n. 91 Misuro i segmenti 360 Scienze
n. 92 La materia: tante forme!
n. 93 L’atomo e la molecola 362
n. 94 La materia e gli stati di aggregazione 363
n. 95 Che cos’è il calore?
n. 96 Calore o temperatura?
n. 97 I passaggi di stato
365
366
n. 98 Che cos’è l’aria? 367
n. 99 Quanto ossigeno c’è nell’aria? 368
n. 100 Le proprietà dell’aria 369
n. 101 L’idrosfera
370
n. 102 Tante acque 371
n. 103 Le proprietà dell’acqua 372
n. 104 Sperimenta… con le mani!
n. 105 Sperimenta… la sublimazione!
n. 106 Sperimenta… l’esistenza dell’aria!
n. 107 Sperimenta… l’elasticità dell’aria!
n. 108 Sperimenta… i vasi comunicanti!
373
374
375
376
377
n. 109 Sperimenta… i movimenti dell’acqua! 378
n. 110 A che cosa serve l’aria?
379
n. 111 A che cosa serve l’acqua? 380
Musica
n. 112 L’altezza dei suoni
n. 113 La melodia
Arte e immagine
n. 114 Fantasia di parallele
n. 115 Fantasia di perpendicolari
n. 116 Una quarta speciale 385
n. 117 Troppo tardi! 386
n.118 Il villaggio neolitico
n. 119 La Ziggurat 388
n. 120 I giardini pensili
n. 121 Benvenuti a Babilonia! 390
n. 122 La Torre di Pisa 391
Educazione fisica
n. 123 Mi batte forte il cuore
n. 124 Suono il ritmo del mio cuore 393
n. 125 Mi esprimo e comunico con il corpo 394
n. 126 Il mio modo di comunicare 395
n. 127 Quando gioco… 396
n. 128 Le mie abitudini alimentari sono… 397
n. 129 Alimentazione e benessere 398
Tecnologia
n. 130 Il termometro 399
n. 131 Il barometro 400
n. 132 Conosci l’interfaccia di Word
n. 133 Costruisci un anemometro 402
n. 134 Costruisci una tabella con Word 403
DICEMBRE • GENNAIO
Italiano
n. 135 Il Taj Mahal
n. 136 Le regole del mangiar sano (2)
n. 137 Gara di lettura
n. 138 La lettera personale 408
n. 139 Il Re Scorpione (2) 410
n. 140 La danza di Natale 411
n. 141 L’acqua della vita (1) 413
n. 142 Descrivo il lago 415
n. 143 Scrivo una lettera personale 416
n. 144 Scrivo una e-mail 417
n. 145 Io racconto 418
n. 146 L’acqua della vita (2) 419
n. 147 Radici e desinenze 420
n. 148 Prefissi e suffissi 421
n. 149 Le parti del discorso 422
n. 150 Le parti variabili e invariabili del discorso 423
n. 151 I sinonimi 424
n. 152 Gli omonimi 425
n. 153 I contrari 426
n. 154 Nomi propri e comuni 427
n. 155 Nomi concreti e astratti 428
n. 156 I nomi collettivi 429
n. 157 Il genere dei nomi (2) 430
n. 158 Il numero dei nomi (2) 431
n. 159 I nomi primitivi e derivati 432
n. 160 Nomi alterati 433
n. 161 Nomi composti 434
n. 162 Analisi dei nomi (1) 435
n. 163 Analisi dei nomi (2) 436
n. 164 Gli articoli (2) 437
n. 165 Analisi degli articoli 438
n. 166 Gli aggettivi qualificativi (2) 439
n. 167 I gradi dell’aggettivo qualificativo (2) 440
n. 168 Gli aggettivi interrogativi ed esclamativi (2) 441
n. 169 Analisi degli aggettivi (2) 442
Storia
n. 170 L’inno al Nilo 443
n. 171 La Paletta di Narmer 444
n. 172 La Stele di Rosetta 445
n. 173 Il Nilo 446
n. 174 Tanta vita lungo il Nilo 447
n. 175 La valle dell’Indo 448
n. 176 Tra Fiume Giallo e Fiume Azzurro 449
n. 177 Dai primi villaggi ai due regni 450
n. 178 Dallo splendore alla decadenza 451
n. 179 Il faraone: re-dio 452
n. 180 La piramide sociale in Egitto 453
n. 181 La dura condizione dei contadini 454
n. 182 L’esercito e le armi 455
n. 183 La vita nell’aldilà 456
n. 184 La mummificazione 457
n. 185 Dalla mastaba alla piramide 458
n. 186 Il mito di Osiride 459
n. 187 Tante imbarcazioni lungo il Nilo 460
n. 188 La scrittura degli Egizi 461
n. 189 A tavola con gli Egizi 462
n. 190 Gli Egizi: eleganti e profumati 463
n. 191 La civiltà dell’Indo 464
n. 192 Dalle dinastie all’impero 465
n. 193 La civiltà cinese 466
n. 194 L’Egitto oggi 467
n. 195 Nelle terre dell’antica civiltà indiana 468
n. 196 La Cina oggi 469
n. 197 Civiltà fluviali a confronto 470 Geografia
n. 198 Orientarsi con i punti cardinali 471
n. 199 Orientarsi con i punti intermedi 472
n. 200 Dal satellite: colori e luci d’Italia 473
n. 201 L’Italia dal satellite 474
n. 202 La profondità dei mari italiani 475
n. 203 Il cartografo sei tu 476
n. 204 Carta muta delle acque d’Italia 477
n. 205 Il mare: onde, correnti e maree 478
n. 206 Tante parole per il mare 479
n. 207 Il lungo viaggio del fiume 480
n. 208 Tante parole per il fiume 481
n. 209 Tante origini per il lago
482
n. 210 L’Italia fisica 483
n. 211 L’Italia fisica: i rilievi 484
n. 212 L’Italia fisica: le acque 485
n. 213 I mari italiani
486
n. 214 Le coste italiane 487
n. 215 Isole e arcipelaghi italiani 488
n. 216 I golfi italiani 489
n. 217 I fiumi italiani
490
n. 218 I fiumi alpini 491
n. 219 I fiumi appenninici 492
n. 220 I laghi italiani 493
n. 221 I laghi prealpini 494
n. 222 I laghi peninsulari e insulari 495
n. 223 Il mare e la pesca 496
Matematica
n. 224 Le relazioni (2) 497
n. 225 I grafici 498
n. 226 La moda (2)
n. 227 So individuare la moda (2)
n. 228 Cerca l’errore
n. 229 Divisioni particolari
n. 230 Multipli e divisori
n. 231 Criteri di divisibilità
n. 232 Divisioni ancora più difficili
499
500
501
502
503
504
505
n. 233 Coloro le frazioni 506
n. 234 Leggo le frazioni 507
n. 235 Unità frazionarie (2) 508
n. 236 Coppie di frazioni complementari 509
n. 237 Dati sotto osservazione (3) 510
n. 238 Dati sotto osservazione (4) 511
n. 239 La domanda giusta (2) 512
n. 240 Sono veloce e riflessivo (3) 513
n. 241 Poligoni convessi e concavi (2) 514
n. 242 Gioco con le diagonali 515
n. 243 I triangoli rispetto agli angoli (3) 516
Scienze
n. 244 È permeabile? 517
n. 245 Com’è fatto il suolo? 518
n. 246 Da che cosa è composto il suolo? 519
n. 247 Un suolo… tanti terreni! 520
n. 248 Il ciclo della materia 521
n. 249 Viventi e non viventi 522
n. 250 il ciclo vitale 523
n. 251 Gli esseri viventi e il ciclo vitale 524
n. 252 Dalla specie al regno 525
n. 253 Panthera leo… chi è? 526
n. 254 Classifica 527
n. 255 A che classe appartiene? 528
n. 256 Le parti della pianta 529
n. 257 Classifica le piante 530
n. 258 Riconosci le piante 531
n. 259 La radice: struttura e funzione 532
n. 260 Il fusto: la sua funzione 533
n. 261 Erbe, arbusti o alberi? 534
n. 262 Fusti epigei e fusti ipogei 535
n. 263 Una foglia al microscopio 536
n. 264 La foglia: la sua funzione 537
n. 265 La fotosintesi clorofilliana 538
n. 266 Curiosando tra le foglie 539
n. 267 Il fiore: la sua funzione 540
n. 268 Tanti frutti 541
n. 269 Il frutto: la sua funzione 542
Musica
n. 270 Lo riconosci? 543
Arte e immagine
n. 271 Fantasia di triangoli 544
n. 272 Il fiore portacandele 545
n. 273 Cartelloni delle parti del discorso 546
n. 274 Coloro la poesia: l’arancia 555
n. 275 Passeggiata sul Nilo 556
n. 276 Costumi dell’antico Egitto 557
n. 277 Un castello fiabesco 558
n. 278 Il Taj Mahal 559
n. 279 Il Ponte di Rialto 560
Educazione fisica
n. 280 Esercizio fisico e salute 561
Tecnologia
n. 281 In orbita adesso 562
n. 282 Piramidi in SmartArt 563
n. 283 Un ciclo in SmartArt 564
n. 284 Costruisco etichette 565
FEBBRAIO • MARZO
Italiano
n. 285 Animali a Stranalandia (2) 567
n. 286 La leggenda dell’orso 569
n. 287 L’Osservatorio vesuviano (2) 571
n. 288 Invento una leggenda 572
n. 289 L’arca di Noè (2) 573
n. 290 Una cronaca giurassica (2) 574
n. 291 Espressioni figurate (2) 575
n. 292 I pronomi personali (2) 576
n. 293 Analisi dei pronomi (1) 579
n. 294 Analisi dei pronomi (2) 580
n. 295 Le coniugazioni 581
n. 296 Verbi sinonimi 582
n. 297 Il modo indicativo (2) 583
n. 298 L’analisi dei verbi (1) 585
n. 299 Analisi dei verbi (2) 586
Storia
n. 300 I comandamenti di Yahweh 587
n. 301 La Fenicia 588
n. 302 La Palestina 589
n. 303 La civiltà dei Fenici 590
n. 304 Un popolo di navigatori e mercanti 591
n. 305 Cartagine: da colonia a città-stato 592
n. 306 Le divinità dei Fenici 593
n. 307 I Fenici: mercanti nel mare 594
n. 308 I Fenici: navigatori del dì e della notte 595
n. 309 L’alfabeto fenicio 596
n. 310 Un popolo in viaggio 597
n. 311 Il regno d’Israele 598
n. 312 Dalla decadenza alla diaspora 599
n. 313 La società ebraica 600
n. 314 Le feste ebraiche 601
n. 315 Il cibo e la religione 602
n. 316 L’economia degli Ebrei 603
n. 317 Il Libano oggi 604
n. 318 Israele oggi 605
Geografia
n. 319 Orientarsi sulla carta fisica d’Italia 606
n. 320 I venti e i punti cardinali 607
n. 321 Le rose dei venti 608
n. 322 I rilievi dal satellite 609
n. 323 L’altitudine e l’altimetria 610
n. 324 Adesso disegna tu 611
n. 325 Carta muta dei rilievi d’Italia 612
n. 326 I rilievi d’Italia in tabelle e grafici 613
n. 327 Tante parole per la montagna 614
n. 328 L’erosione della montagna 615
n. 329 Calanchi, frane e smottamenti 616
n. 330 Le risorgive 617
n. 331 Conosci le Alpi e gli Appennini 618
n. 332 Le Alpi 619
n. 333 Gli Appennini 620
n. 334 Un paese di colline 621
n. 335 L’origine delle pianure italiane 622
n. 336 Tante immagini per la pianura 623
n. 337 La montagna e l’uomo 624
n. 338 La collina e l’uomo 625
n. 339 I tesori della collina: la vite e l’olivo 626
n. 340 La pianura e l’uomo 627
Matematica
n. 341 Frazioni proprie, improprie, apparenti 628
n. 342 Distinguo le frazioni 629
n. 343 Frazioni sulla retta dei numeri 630
n. 344 Confronto e ordino le frazioni (1) 631
n. 345 Magicamente equivalenti! 632
n. 346 Gioco con le frazioni equivalenti 633
n. 347 La frazione di un numero (2) 634
n. 348 Calcolo di frazioni (1) 635
n. 349 Calcolo di frazioni (2) 636
n. 350 Calcolo di frazioni (3) 637
n. 351 Quanto manca per formare l’unità? 638
n. 352 Decimi sulla retta dei numeri 639
n. 353 Centesimi sulla retta dei numeri 640
n. 354 Decimi, centesimi e millesimi 641
n. 355 Leggo e scrivo i numeri decimali 642
n. 356 Quanto vale? 643
n. 357 Confronto i numeri decimali (2) 644
n. 358 Ordino i numeri decimali 645
n. 359 Numeri decimali sulla linea 646
n. 360 Le misure di lunghezza (2) 647
n. 361 Le misure di peso (2) 648
n. 362 Le misure di capacità (2) 649
n. 363 Le equivalenze (2) 650
n. 364 Le equivalenze (3) 651
n. 365 Problemi con più domande (2) 652
n. 366 Problemi con le frazioni (2) 653
n. 367 Problemi… in lungo e in largo (2) 654
n. 368 Pesi massimi, medi e piuma (2) 655
n. 369 I trapezi (2) 656
n. 370 Che parallelogramma è? (1) 657
n. 371 Che parallelogramma è? (2) 658
n. 372 Le caratteristiche dei parallelogrammi 659
n. 373 Congruenza, isoperimetria, equiestensione 660
n. 374 Il perimetro del triangolo (2) 661
n. 375 Problemi e perimetri (2) 662
n. 376 So calcolare la media (2) 663
n. 377 So calcolare la media (3) 664
n. 378 So calcolare la media (4) 665
n. 379 So calcolare la media (5) 666 Scienze
n. 380 L’uovo di gomma 667
n. 381 Conosci gli animali 668
n. 382 Animali e piante: cellule diverse 669
n. 383 Il mondo degli invertebrati 670
n. 384 Il mondo dei vertebrati 671
n. 385 Tanti invertebrati: le spugne del mare 672
n. 386 Tanti invertebrati: i celenterati 673
n. 387 Tanti invertebrati: i vermi 674
n. 388 Tanti invertebrati: gli artropodi 675
n. 389 Tanti invertebrati: stelle e ricci 676
n. 390 Anfibi diversi 677
n. 391 Tanti uccelli diversi 678
n. 392 Tanti mammiferi diversi 679
n. 393 Le funzioni vitali degli invertebrati 680
n. 394 Vertebrati: circolazione e escrezione 681
n. 395 Il movimento dei vertebrati 682
n. 396 Uccelli che… non volano! 683
n. 397 Ovipari, ovovivipari e vivipari 684
n. 398 Come nascono i piccoli? 685
Musica
n. 399 La durata dei rumori 686
n. 400 Ritmo e nomi 687
Arte e immagine
n. 401 Vulcani artistici (2) 688
n. 402 Fantasia di quadrilateri 689
n. 403 Coloro la poesia: gli occhiali 690
n. 404 Il Carnevale di Venezia 691
n. 405 Trova gli animali 692
n. 406 La nave fenicia 693
n. 407 La Fontana di Trevi 694
Educazione fisica
n. 408 La velocità 695
n. 409 Danza e ritmo 696
n. 410 Osservo la mia postura 697
Tecnologia
n. 411 Maschere in WordArt 698
n. 412 Costruisci un areogramma 699
n. 413 Disegna con Paint
Italiano
n. 414 Dedalo e Icaro
n. 415 La torre del terrore (2)
n. 416 Poesia a fumetti
n. 417 Tabella della descrizione 707
n. 418 Che paura! 708
n. 419 Teseo (2) 709
n. 420 La guerra di Troia (2) 710
n. 421 I sintagmi 711
n. 422 La frase minima 712
n. 423 Soggetto e predicato 713
n. 424 Il complemento oggetto 714
n. 425 I complementi indiretti (1) 715
n. 426 I complementi indiretti (2) 716
Storia
n. 427 L’isola di Creta 717
n. 428 Il Peloponneso 718
n. 429 La civiltà dei palazzi
n. 430 Il re cretese
n. 431 Teseo e il Minotauro
n. 432 La società cretese 722
n. 433 La Dea Madre 723
n. 434 L’economia dei Cretesi 724
n. 435 I commerci cretesi 725
n. 436 Le navi cretesi 726
n. 437 Un’origine mitica 727
n. 438 Una guerra mitica 728
n. 439 Un declino misterioso 729
n. 440 La società micenea 730
n. 441 La religione micenea 731
n. 442 Le tombe micenee 732
n. 443 Creta oggi 733
n. 444 Il Peloponneso oggi 734
Geografia
n. 445 Paesaggi umanizzati 735
n. 446 Aeroporti d’Italia 736
n. 447 L’economia 737
n. 448 Economia d’Europa in grafici 738
n. 449 Popolo e popolazione 739
n. 450 L’Europa: giovani e anziani 740
n. 451 Le religioni in Europa 741
n. 452 La popolazione in Italia 742
n. 453 Paesaggi umanizzati d’Italia 743
n. 454 Paesaggi culturali d’Italia
744
n. 455 Il settore primario 745
n. 456 Il settore secondario 746
n. 457 L’industria in Europa 747
n. 458 La terziarizzazione dell’Europa 748
n. 459 I settori produttivi in Italia 749
n. 460 Estensivo, intensivo o biologico?
n. 461 La pesca in Italia
n. 462 Simboli di qualità
n. 463 La geografia dell’industria italiana
n. 464 L’artigianato in Italia
n. 465 Il settore terziario in Italia
n. 466 Il commercio in Italia
750
751
752
753
754
755
756
n. 467 Il terziario avanzato in Italia 757
Matematica
n. 468 Calcoli veloci con i numeri decimali 758
n. 469 Moltiplicazioni con i numeri decimali 759
n. 470 Ok, il peso è giusto (2) 760
n. 471 Ok, il peso è giusto (3) 761
n. 472 Quanto costa? (2) 762
n. 473 Affari d’oro! (2) 763
n. 474 Trasla, ruota, ribalta 764
n. 475 Assi di simmetria (1) 765
n. 476 Superfici e aree (2) 766
n. 477 Misuro il tempo 767
n. 478 So calcolare la percentuale (2) 768
n. 479 So calcolare la percentuale (3) 769
n. 480 So calcolare la percentuale (4) 770
n. 481 So calcolare la percentuale (5) 771
n. 482 Diagrammi di flusso (2) 772
Scienze
n. 483 Luce e acqua per i fagioli 773
n. 484 Dall’ecosistema alla biosfera 774
n. 485 L’ecosistema e i fattori abiotici 775
n. 486 I rapporti tra le specie 776
n. 487 Piante e animali parassiti
n. 488 Relazioni vantaggiose 778
n. 489 La catena alimentare 779
n. 490 I comportamenti degli animali
Arte e immagine
n. 491 Vasi greci 781
n. 492 Il labirinto 782
Verifica e valutazione
1° QUADRIMESTRE
n. 1 Verica di Italiano (1) 812
n. 2 Verifica Italiano (2) 816
n. 3 Verifica di Italiano (3) 818
n. 4 Verifica di Storia 819
n. 5 Verifica di Geografia 822
n. 6 Verifica di Matematica 825
n. 7 Verifica di Scienze 830
n. 493 La bottega del vasaio
n. 494 Il palazzo reale di Cnosso
n. 495 Dedalo e Icaro in… arte
n. 496 La Porta dei Leoni di Micene 786
Educazione fisica
n. 497 Gioco all’aperto 787
Tecnologia
n. 498 Conosci l’interfaccia di PowerPoint 788
n. 499 Temi in PowerPoint 789
n. 500 Animazioni in PowerPoint 790
Annuale
Educazione civica
n. 501 Un test sulla Costituzione italiana 792
n. 502 Maschi e femmine 793
n. 503 Maschi e femmine in classe 794
n. 504 Il nome: insieme per sempre 795
n. 505 Simboli d’Italia: la bandiera 796
n. 506 Indagine sui denti 797
n. 507 Conosci un dente 798
n. 508 La carie: un nemico evitabile! 799
n. 509 Presenta la tua famiglia 801
n. 510 La mia mamma 802
n. 511 Diritti e doveri a scuola 803
n. 512 Collaboriamo 804
n. 513 Il regolamento di classe
n. 514 Differenzia
805
806
2° QUADRIMESTRE
n. 8 Verifica di Italiano (1) 833
n. 9 Verifica di Italiano (2) 836
n. 10 Verifica di Italiano (3) 838
n. 11 Verifica di Storia 839
n. 12 Verifica di Geografia 842
n. 13 Verifica di Matematica 845
n. 14 Verifica di Scienze 849

La Guida Unica è stata impostata e redatta secondo le ultime Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, ponendo l’accento, in questa sua nuova edizione, sulla definizione degli obiettivi di apprendimento e sui traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave alla cui realizzazione, valutazione e certificazione è chiamata la scuola.
La Guida Unica rappresenta un prezioso strumento e offre un contributo operativo e metodologicodidattico di spessore, grazie alla concretezza e all’operatività della sua impostazione. Nella convinzione che una guida didattica debba sempre coniugare sapere, saper fare e saper far fare (elementi inseparabili per una corretta funzione docente), la Guida Unica offre un grande numero di piste di lavoro e di proposte didattiche, attraverso una serie di schede logicamente ed epistemologicamente coerenti con l’impianto programmatico e tra loro connesse da un sotteso filo inter e pluridisciplinare. Il progetto si sviluppa all’insegna di una dimensione concreta e operativa che intende privilegiare l’esperienza, la scoperta, l’attività pratica e l’apprendimento attivo del bambino in un clima di collaborazione e cooperazione. L’alunno dev’essere reso sempre più autonomo e sicuro nella conquista consapevole delle peculiarità disciplinari. Dev’essere aiutato a far emergere e a finalizzare meglio curiosità, interessi e capacità riflessivo-rielaborative in grado di indirizzarlo verso l’autoapprendimento. Il percorso di apprendimento deve essere costruito a partire dai suoi bisogni formativi ed essere strutturato come percorso di costruzione delle competenze. I saperi di ciascuna disciplina offrono, infatti, il materiale su cui permettere agli alunni di costruire modalità di apprendimento, di riflessione e di risoluzione di problemi reali in contesti nuovi e differenti da quelli in cui sono stati acquisiti.
Il quarto volume della Guida Unica si pone in linea di continuità con quelli precedenti. Tutte le discipline di studio in questo volume vengono impostate su:
◆ un solido impianto programmatico e curricolare;
◆ una ragionata selezione di contenuti e attività capaci di stimolare e mantenere vivo il piacere dell’esplorazione e della scoperta;
◆ un percorso cognitivo che dal fare conduca l’alunno in modo progressivo e graduale a concettualizzazioni formalizzate e generative;
◆ un processo di costruzione del sapere centrato sulla sua unitarietà mediante un approccio interdisciplinare;
◆ una strategia metodologica e didattica che privilegi la sperimentazione, la ricerca-azione e la didattica laboratoriale.
Le attività di apprendimento di tutte le discipline prevedono, accanto a un’educazione intellettiva in tutti i suoi aspetti (da quello linguistico-espressivo a quello percettivo-motorio; da quello logico-matematico a quello storico-geografico e scientifico), anche lo sviluppo di un percorso di educazione ai valori nell’ambito di un consapevole esercizio di una nuova cittadinanza attiva in un’ottica interculturale e multietnica. Si tratta di un percorso trasversale che mira ad assicurare al nostro progetto la promozione di un’educazione integrale della personalità dell’alunno

attraverso la conquista dell’autonomia, l’assunzione di responsabilità, la cultura dell’impegno personale e della solidarietà, lo sviluppo dell’identità e il rispetto della legalità, dell’ambiente e delle istituzioni.
Il quarto volume della Guida Unica mantiene la stessa struttura degli altri volumi ma prevede per ciascuna disciplina, accanto a più impegnative proposte metodologiche, un potenziamento sia delle piste di lavoro sia dei suggerimenti operativi riservati ai docenti e un notevole arricchimento sia in termini quantitativi sia qualitativi delle schede di lavoro riservate agli alunni. Questi ampliamenti, approfondimenti e miglioramenti troveranno spazio, previ opportuni richiami, anche nel supporto elettronico allegato al volume.
Al termine di ogni quadrimestre, con riferimento agli obiettivi di apprendimento programmati, per ciascuna disciplina viene fornito un agile strumento di verifica/valutazione (presente nella Pen Drive) corredato di proposte operative (quiz, questionari, brevi esercizi ecc.) che mirano a misurare i livelli di apprendimento di conoscenze, abilità e competenze raggiunti dagli alunni.
Anche nel quarto volume della Guida Unica si propongono per l’Italiano e per la Matematica schede operative ideate e strutturate secondo il sistema INVALSI, terreno consolidato di verifica e di miglioramento della nostra scuola.
Consapevoli dell’oneroso compito affidato agli insegnanti, ma anche supportati dall’apprezzamento e dall’attenzione che sono stati generosamente attribuiti al nostro lavoro, l’impegno di autori, redattori ed editore è stato indirizzato verso il miglioramento e l’arricchimento del nostro progetto editoriale con lo scopo di fornire a docenti e alunni un fedele, utile e aggiornato strumento di lavoro.

Competenza chiave
eriodo: SETTEMBRE
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
T1
T3
T6
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente.
• Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.
T6
T8
T10
T3
• Il passaggio dall’infanzia alla fanciullezza: – questionari conoscitivi.
• Le vacanze, il rientro a scuola: – soluzione di questionari a risposta aperta e a scelta multipla; – individuazione di affermazioni vere/false.
• Scrivere testi descrittivi chiari e coerenti. • I paesaggi: – osservazione di immagini; – produzione di testi descrittivi con un modello guida; – uso degli indicatori spaziali.
• Scrivere testi chiari e coerenti per raccontare vissuti e storie.
• Scrivere testi espositivi.
• Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche.
• Riflettere sulle parole: riconoscere le principali parti del discorso.
• I vissuti personali: – produzione di testi con il supporto di modelli guida.
• Individuazione di errori ortografici.
• Esercitazioni sulla punteggiatura.
• Classificazione delle principali parti del discorso.
• Osservare, esplorare, descrivere e leggere fumetti. • Completamento di fumetti.
Unità di lavoro
ITALIANO
Competenza chiave
traguardi competenze
T2 T3
T2
T1 T2
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e pArlAto
• Ascoltare e comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi orali.
• Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione.
• Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività.
Contenuti e attività
• Lo scopo della comunicazione in situazioni concrete: – lettura di fumetti.
• Ascolto della lettura dell’insegnante: – completamento di testi.
• Le istruzioni: – esposizione orale delle fasi di realizzazione di una ricetta e/o un manufatto.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
Ascolto e pArlAto
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente.
T1
T5
T1
T6
T4 T10
• Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato.
• Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato.
T3 T9
T3
T9
T3
T9
T3 T10
T3
T10
T3
T1
T3
T9
• Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità.
• Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi descrittivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche.
• Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche.
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi narrativi, individuando gli elementi principali.
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
• Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto.
Contenuti e attività
• Le attività preferite: la pubblicità. – Test di gradimento; – le opinioni personali; – discussioni guidate; – espressione di stati d’animo e opinioni.
• Le esperienze personali e/o collettive: – racconto orale di vissuti personali; – lettura di immagini.
• Riassunto orale di racconti di vario genere con il supporto di schemi.
• Esposizione di argomenti con il supporto di schemi.
• Giochi a tempo, individuali e/o a squadra per affinare l’abilità tecnica della lettura.
La descrizione a scopo persuasivo: – confronto di descrizioni; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• Il diario personale: scopo, struttura, narratore, caratteristiche.
• Lettura attiva di un testo narrativo: – ricostruzione logica di una storia.
Il racconto realistico della vita della classe: – tempo e luogo della vicenda; – ruoli e caratteristiche dei personaggi; – soluzione di questionari a scelta multipla.
La favola: personaggi, messaggio e scopo. – Soluzione di questionari a risposta aperta. – Completamento di frasi.
La vita della classe: – lettura espressiva a più voci; – drammatizzazione; – soluzione di questionari a scelta multipla; – trasformazione in testo narrativo.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
T3
T3
• Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore.
T3 T8
T6
T1
T6
T6
T8
• Le istruzioni per la realizzazione di un manufatto: il fossile.
– Lettura guidata di istruzioni per l’individuazione della struttura: i materiali, il procedimento; – individuazione di frasi intruse.
• Il messaggio pubblicitario: caratteristiche e scopi.
• Struttura del testo informativo-espositivo.
• I blocchi di informazioni.
• Gli schemi delle rime: rime baciate e alternate. – Lettura e analisi del contenuto di filastrocche; – ripetizione e memorizzazione; – giochi per l’individuazione delle rime; – giochi di parole con le rime; – strutturazione di schemi di rime; – parafrasi.
scritturA
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
• La descrizione di un animale a scopo persuasivo: – produzione del testo con modelli guida.
• Scrivere testi per esprimere emozioni. • Il diario di bordo della classe: – racconto orale di esperienze collettive; – produzione guidata di pagine di diario.
• Scrivere testi per raccontare storie. • Le tecniche del discorso diretto e indiretto nel racconto di situazioni concrete con il supporto di immagini:
– completamento di dialoghi; – trasformazione di dialoghi.
T6
T8
• Scrivere testi per raccontare storie fantastiche.
• Immagini e fantasia: – osservazione e descrizione di immagini pubblicitarie; – invenzione di storie a partire da immagini stimolo; – produzione guidata di testi.
• La favola: – caratteristiche dei personaggi; – sviluppo e finale della vicenda; – morale; – produzione guidata del testo; – uso del discorso diretto e indiretto.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività scritturA
T6
T3
T4
T6
T3
T6
T3
T6
T6 T8
T6
T8
• Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività.
• Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio.
T7
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• La ricetta di cucina: – produzione guidata di testi regolativi con il supporto di immagini.
• Presentazione della classe: – produzione guidata di testi espositivi con modello guida.
• La ricerca: la torre di Pisa. – Consultazione delle fonti; – confronto di informazioni; – elaborazione di un testo collettivo.
• Lo slogan: – analisi di slogan; – individuazione delle rime; – produzione guidata di slogan.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi. • Le tecniche per avviare al riassunto del testo narrativo: – esercizi di riduzione di frasi; – individuazione delle informazioni essenziali; – completamento di schemi guida.
• Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato.
• La trasformazione del testo teatrale in testo narrativo: – trasformazione del discorso diretto in indiretto.
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi. • La parafrasi del testo poetico: – trasformazione del testo poetico in testo informativo-espositivo.
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
• Utilizzare adeguatamente il dizionario. A
• Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura. B
T2
T8
• Osservazione e consultazione del dizionario: – l’ordine alfabetico delle parole.
• Le principali difficoltà ortografiche: raddoppiamenti di consonante, digrammi, trigrammi e gruppi di lettere, accento, apostrofo, divisione in sillabe delle parole, ordine alfabetico. – Esercizi di completamento, riordinamento, trascrizione, individuazione, correzione, classificazione, produzione, inserimento; – ascolto, lettura, copia, scrittura sotto dettatura, memorizzazione di filastrocche contenenti parole che presentano difficoltà ortografiche; – giochi linguistici; – completamento di testi.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
T8
T8
T5 T6
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole. A
• Riconoscere e rispettare le funzioni sintattiche ed espressive dei principali segni interpuntivi. B
• Riconoscere e utilizzare adeguatamente le tecniche del discorso diretto e indiretto. B
ITALIANO
Unità di lavoro
Competenza chiave
• Gli iperonimi: – sostituzioni lessicali.
• La funzione dei principali segni di punteggiatura: – esercizi di inserimento.
• Le tecniche per riportare le parole dei personaggi: – completamenti e trasformazioni con il supporto di immagini.
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
T2
T2
T2
T1
T1
T6
T4 T7
Ascolto e pArlAto
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
• Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività.
• Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti.
• Formulare domande e fornire risposte precise e pertinenti durante e dopo l’ascolto.
• Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato.
• Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato.
• Ascolto della lettura dell’insegnante: – completamento di cloze senza lista di parole.
• Le istruzioni per svolgere attività (inviare una mail) e realizzare un manufatto (il portacandele).
• La corretta alimentazione: – ascolto di testi in rima; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• Esperienze concrete di conversazione per: – chiedere/ricevere informazioni; – completamento di fumetti.
• Le attività scolastiche nel periodo natalizio, i malanni invernali, le figuracce.
• Riassunto orale di racconti di vario genere con il supporto di schemi.
• Esposizione di argomenti con il supporto di schemi.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento

Contenuti e attività
T3
T3
T3
T3
T7
T3
• Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità.
• Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi.
• Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche.
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi narrativi, individuando gli elementi principali.
• Leggere e individuare le sequenze in testi narrativi.
• Giochi a tempo, individuali e/o a squadra per affinare l’abilità tecnica della lettura.
• La descrizione a scopo informativo: – associazione di testo e immagine; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• La lettera personale: caratteristiche e struttura.
• Racconti sull’antico Egitto: – completamento di cloze con liste di parole contenenti termini superflui; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• Il racconto realistico: – individuazione di tempo, luogo, personaggi, caratteristiche dei personaggi; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• Racconti sull’antico Egitto: – associazione di sequenze e titoli; – elaborazione del riassunto con modello guida.
T3
T6
T3
T3
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
• Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore.
• La fiaba: – individuazione di ruoli e funzioni dei personaggi; – soluzione di questionari a scelta multipla; – elaborazione del riassunto con modello guida.
• Le istruzioni per inviare una e-mail: – completamento di immagini; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• La lettera formale: – completamento di immagini; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• La struttura del testo poetico: versi e strofe. – Lettura e analisi del contenuto e del linguaggio della filastrocca; – individuazione di versi e strofe; – riordino di strofe; – parafrasi.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività scritturA
T6
T10
T6
T3
T6
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
• Scrivere testi per esprimere emozioni.
• La descrizione di un paesaggio a scopo informativo: – osservazione diretta e descrizione di immagini; – il corretto uso degli indicatori spaziali.
• La lettera personale, tradizionale e/o in formato elettronico: – completamento di modelli guida.
• Scrivere testi per raccontare vissuti. • I vissuti personali in relazione al Natale e ai malanni del periodo: – lettura di racconti e filastrocche; – racconto orale di esperienze individuali e/o collettive; – individuazione di inizio, sviluppo e conclusione di un fatto; – esposizione di sentimenti e stati d’animo in relazione al fatto; – elaborazione di testi narrativi con il supporto di un modello guida.
• Scrivere testi per raccontare storie.
T6
T6
T6
T6
T6
T8
T6
T6 T8
• Scrivere testi per raccontare storie fantastiche.
• La tecnica del discorso diretto: – completamento di dialoghi.
• La fiaba a rovescio: – produzione guidata di fiabe non convenzionali.
• Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività.
• Scrivere lettere adeguando le forme espressive ai destinatari e alle situazioni.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Le fasi per la realizzazione di un manufatto: – elaborazione del testo con il supporto di immagini.
• La lettera formale: – elaborazione di una lettera, tradizionale e/o in formato elettronico, con modello guida.
• La filastrocca con le rime baciate: – produzione guidata di filastrocche utilizzando schemi di poesie.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi. • Riassunto del testo narrativo secondo le sequenze
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi. • Trasformazione di un testo in rima in un testo regolativo.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
T8
T8
• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. B
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole. A
• Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. A B
T6
T8
• Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. B
T6
T8
• Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. A B
• Radici, desinenze, prefissi, suffissi: – completamenti, trasformazioni, classificazioni di parole.
• Sinonimi, omonimi e contrari: – giochi linguistici, sostituzioni, trasformazioni, individuazione di elementi intrusi.
• I nomi: significato, forme e struttura. Esercizi di:
– manipolazione; – individuazione;
– inserimento; – correzione;
– sostituzione;
– trasformazione;
– riscrittura;
– produzione; – arricchimento lessicale;
– giochi linguistici.
• Gli articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. Esercizi di:
– manipolazione;
– individuazione;
– inserimento;
– correzione;
– sostituzione;
– trasformazione;
– riscrittura;
– produzione;
– arricchimento lessicale;
– giochi linguistici.
– Forma, genere, numero, funzione, concordanza con il nome degli aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi. I gradi dell’aggettivo. Esercizi di: – manipolazione;
– individuazione; – inserimento;
– correzione; – sostituzione; – trasformazione; – riscrittura; – produzione; – arricchimento lessicale; – giochi linguistici.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Ascolto e pArlAto
T2
T9
T4
T3 T4
T3
T3
T10
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
• Individuare e usare il canale adeguato alla comunicazione.
• Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato.
• Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi.
• Ascolto di un testo in rima: – memorizzazione degli elementi e dell’ordine in cui sono presentati.
• I canali della comunicazione: – associazione di frasi a immagini.
• Esposizione di argomenti con il supporto di schemi.
• Descrizioni di animali fantastici: – individuazione di informazioni; – soluzione di questionari a scelta multipla.
T3
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi.
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca.
T3
T1 T3
• Leggere testi dialogati, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto.
• Il racconto d’avventura: – completamento di cloze; – soluzione di questionari a scelta multipla.
• Lettura di un brano della Bibbia: – riordino di sequenze; – elaborazione del riassunto con modello guida.
• La leggenda: scopo, struttura, elementi. – Individuazione del finale giusto; – soluzione di un questionario a risposta aperta; – individuazione di affermazioni vere/false inerenti al testo.
• La cronaca di un fantasioso avvenimento sportivo: – soluzione di un questionario a scelta multipla.
• I dialoghi dei personaggi: – lettura espressiva a più voci; – soluzione di un questionario a scelta multipla.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
T3
T8
• Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
T3
T4
T3
T6
T6
T6
T6
T6
• Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore.
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
• Scrivere testi per raccontare storie fantastiche.
• Le istruzioni per svolgere un’attività: il travestimento di Carnevale.
– Soluzione di questionari a scelta multipla; – individuazione di forme verbali; – trasformazione della persona del verbo.
• Le caratteristiche del testo informativo: i vulcani.
– Organizzazione delle informazioni; – individuazione di parole chiave; – il linguaggio; – completamento di mappe; – elaborazione del riassunto con modello guida.
• Le figure di significato: – individuazione e confronto di similitudini e metafore; – parafrasi.
• La descrizione di personaggi fantastici: – invenzione di personaggi fantastici; – completamento della tabella della descrizione.
• La leggenda: – produzione guidata.
• Scrivere la cronaca di un fatto per informare. • La cronaca: – produzione guidata.
• Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività.
• I travestimenti di Carnevale: – elaborazione di testi in forma di elenco.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività scritturA
T6
T6 T8
T4 T6
T6
T6
• Scrivere testi informativo-espositivi.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi.
• Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato.
• Sperimentare tecniche per parafrasare testi.
• La relazione: – produzione guidata.
• Similitudini e metafore: – costruzione di testi poetici utilizzando parole, schemi, tecniche dei poeti.
• Il riassunto del testo narrativo con le sequenze.
• Il riassunto del testo informativo con la mappa.
• Trasformazione del tempo di un testo narrativo: – completamento di testi.
• Trasformazione del testo poetico in un testo descrittivo.
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
T8
T9
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole. A
• Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. A B
T6
T7
T8
• Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. A B
T8
• Il significato letterale e il significato figurato delle parole: – associazione di frasi a immagini.
• I pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi, esclamativi. Esercizi di: – individuazione; – inserimento; – trasformazione; – riscrittura; – arricchimento lessicale; – analisi grammaticale.
• Struttura del verbo: persona, numero, modi e tempi, coniugazioni. Esercizi di: – individuazione; – inserimento; – completamento; – sostituzione; – trasformazione; – analisi grammaticale.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Competenza chiave
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
Ascolto e pArlAto
• Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
• Ascolto di un brano dall’Odissea o di un articolo di cronaca:
T3
T3
T1
T3
T3 T5
T1 T10
T9
• Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per l’esecuzione di attività.
• Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti.
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente.
• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato.
• Usare un linguaggio adeguato al contesto e al destinatario.
T3 T6
T3 T6
• Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
• Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi.
– completamento di cloze senza lista di parole da inserire;
– individuazione di fatti intrusi.
• Le istruzioni per usare uno strumento.
• Il rispetto degli animali e dell’ambiente.
• Le regole di comportamento in acqua.
• Dibattiti a partire da fatti di cronaca.
• Le storie di paura: – espressione di stati d’animo e di opinioni personali sul genere horror.
• Racconto orale di fatti di cronaca, vissuti personali, con il supporto di domande guida.
• Le situazioni comunicative, il destinatario della comunicazione: – completamento di fumetti.
letturA
• Lettura di miti greci: – individuazione dell’inizio giusto tra varie opzioni; – ordinamento di sequenze; – soluzione di un questionario a risposta aperta; – elaborazione del riassunto con modello guida.
• Lettura di miti greci:
– riordino delle sequenze; – soluzione di questionari a risposta aperta; – elaborazione del riassunto con modello guida.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Competenza chiave
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
T3
• Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca.
T3
T3
T3
T4
T6
T3 T6
T8
• Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
• Il mito:
– individuazione degli elementi caratteristici del genere;
– soluzione di questionari a risposta aperta e a scelta multipla.
• La narrazione di paura:
– individuazione degli elementi caratteristici del genere;
– soluzione di questionari a risposta aperta/a scelta multipla.
• Lettura di un articolo di cronaca:
– individuazione degli elementi caratteristici del genere;
– soluzione di questionari a risposta aperta/a scelta multipla.
• Le istruzioni per il corretto utilizzo di uno strumento:
– individuazione di informazioni;
– associazione di frasi e immagini.
• Il rispetto dell’ambiente: il piedibus.
– Lettura di testi informativi; – individuazione dei blocchi di informazioni; – soluzione di questionari a risposta aperta; – elaborazione del riassunto con modello guida.
T6
T6
• Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore.
• Le figure di suono: – individuazione di allitterazioni e onomatopee; – trasformazioni di poesie in dialoghi.
• Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti.
• Scrivere testi per raccontare vissuti.
• Invenzione e descrizione di personaggi mostruosi con il supporto di una tabella.
• Esperienza paurosa.
ITALIANO – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Competenza chiave
Competenza alfabetica funzionale C1 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6 T9
• Scrivere testi per raccontare storie.
• Scrivere la cronaca di un fatto per informare
• Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività.
• Scrivere testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze.
• Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo.
• Sperimentare tecniche per riassumere testi.
• Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato.

• Il racconto del brivido: – elaborazione del testo con il supporto di un modello guida.
• La cronaca: – elaborazione del testo con il supporto di un modello guida.
• Le regole di comportamento in acqua: – elaborazione del testo con il supporto di immagini.
• Le informazioni sul luogo di residenza: – raccolta di informazioni; – la carta d’identità del luogo di residenza.
• Le tecniche dell’allitterazione e dell’onomatopea: – completamento/costruzione di testi poetici per gruppi, su imitazione.
• Le tecniche per riassumere il testo narrativo e informativo: – elaborazione del riassunto con il supporto di schemi e modelli guida.
• Trasformazione di testi poetici in dialoghi: – la tecnica del discorso diretto.
A Acquisizione ed espAnsione del lessico ricettivo e produttivo B elementi di grAmmAticA esplicitA e riflessione sugli usi dellA linguA
T8
T8
T10
• Riconoscere preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. A B
• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. A B
• Le parti invariabili del discorso. Esercizi di: – trasformazione, sostituzione, completamento, individuazione dell’opzione giusta, associazione di frasi a immagini.
• I sintagmi, il soggetto, il predicato verbale e nominale, i complementi:
– completamento di fumetti, composizione/ scomposizione di frasi, completamenti, trasformazioni, inserimenti, individuazione dell’opzione giusta.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Competenza
eriodo: SETTEMBRE
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
• Conoscere le fonti della Storia.
T2
T5
T2 T5
T2
T5
T2 T5
T3
• Conoscere il lavoro dello storico.
• Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie della Storia.
• Conoscere le parole della Storia.
• Conoscere e confrontare sistemi di datazione.
• L’etimologia della parola “Storia”.
• Classificazione delle diverse tipologie di fonti storiche: materiali, iconografiche, orali e scritte.
• Lettura di una fonte iconografica.
• L’attività dello storico e le fasi del metodo storico.
• Gli specialisti delle scienze ausiliarie della Storia: l’antropologo, l’archeologo, il geologo, il geografo, l’economista, il numismatico, il paleografo e il paleontologo.
• Attività di analisi di parole della Storia.
• La funzione dell’anno zero nella datazione di eventi storici.
• Confronto di sistemi di datazione diversi.
• Esercitazioni sulla linea del tempo.
T9
• Conoscere la storia dell’evoluzione dell’uomo.
• L’evoluzione e le conquiste dell’uomo: dall’Australopiteco all’Homo sapiens sapiens.
• Rappresentazione delle attività e degli strumenti creati dall’uomo nei diversi periodi della Preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico.
STORIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro
Competenza chiave
Comunicativa… mente
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
uso delle fonti
• Ricavare informazioni dallo Stendardo di Ur.
T2 T9
T2 T9
T2 T9
T5 T9
T5 T9
• Ricavare informazioni dalla Stele di Hammurabi.
• Ricavare informazioni dalla Stele di Naram-Sin.
• Osservazione e descrizione dello Stendardo di Ur: le classi sociali, le facciate della pace e della guerra.
• Osservazione della Stele di Hammurabi: il re e il dio Shamash.
• Osservazione e descrizione della Stele di NaramSin: la divinizzazione del re accade.
orgAnizzAzione delle informAzioni
• Comprendere le cause e gli effetti della rivoluzione agricola.
• Comprendere le cause e gli effetti della rivoluzione urbana.
• La rivoluzione agricola: i villaggi stanziali, l’incremento demografico e la diversificazione del lavoro.
• La differenza tra villaggi e città.
• Completamento di una piramide sociale.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
STORIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, capacità imparare imparare (p. )

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività orgAnizzAzione delle informAzioni
T5
T3 T5
T5
T7
T3 T9
• Comprendere la struttura di un quadro storico di civiltà.
• Collocare nel tempo e nello spazio le antiche civiltà.
• Comprendere l’importanza del fiume per lo sviluppo delle antiche civiltà.
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà mesopotamica.
• Collocare sulla linea del tempo i diversi popoli dell’antica Mesopotamia.
• Il quadro storico e gli indicatori tematici di civiltà.
• Esercitazioni per l’esatta collocazione nel tempo e nello spazio delle civiltà dei fiumi.
• Completamento di testi con abbinamento di causa ed effetto.
• Osservazione e descrizione della carta geo-storica della “terra tra i fiumi” Tigri ed Eufrate: una posizione centrale per i commerci.
• Collocazione di eventi in ordine cronologico.
strumenti concettuAli
• Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Sumeri.
• Lettura e completamento di enunciati sulla civiltà sumera.
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
• Conoscere le principali opere idrauliche realizzate dai Sumeri.
• Conoscere ed analizzare l’organizzazione politica dei Sumeri.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Sumeri.
• Conoscere e analizzare la religione dei Sumeri.
• Conoscere le principali divinità dei Sumeri.
• Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Sumeri.
• Conoscere le principali attività economiche dei Sumeri.
• La terra di Sumer e le “teste nere”; le prime città-stato; le principali vicende storiche.
• Domande a risposta aperta e completamento di illustrazioni sulle opere idrauliche dei Sumeri.
• Riflessione sugli effetti del passaggio dall’agricoltura secca all’agricoltura irrigua.
• La fondazione delle città-stato; dall’ en (sacerdotesignore) al lugal (grande uomo) o all’ensi (governatore).
• Completamento di testi.
• La piramide sociale dei Sumeri.
• Questionari vero/falso.
• La religione politeista e antropomorfa, le credenze in demoni e spiriti maligni e la concezione dell’aldilà.
• Le sette divinità principali dei Sumeri.
• Le divinità secondarie.
• Realizzazione di illustrazioni.
• La funzione religiosa ed economica della ziggurat.
• Individuazione in illustrazioni dei diversi ambienti della ziggurat.
• Le attività economiche dei Sumeri: l’agricoltura, l’allevamento, il commercio e l’artigianato.
• Completamento di testi, enunciati e illustrazioni; questionari vero/falso.
• Conoscere le principali invenzioni dei Sumeri. • Osservazione e illustrazione delle principali invenzioni dei Sumeri: la ruota, i mattoni, i chiodi, l’aratro.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Comunicativa… mente
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
strumenti concettuAli
• Conoscere il sistema di scrittura dei Sumeri.
T5 T9
• Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Sumeri.
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5 T9
T5
T9
T5
T9
T5 T9
• Conoscere la civiltà degli Accadi.
• Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Babilonesi.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica e sociale dei Babilonesi.
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Babilonesi.
• Conoscere le principali opere architettoniche dei Babilonesi.
• Conoscere il Codice di Hammurabi.
• Conoscere la civiltà degli Hittiti.
• Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Assiri.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica e sociale degli Assiri.
• La cretula e i contrassegni.
• L’evoluzione del sistema di scrittura: il pittogramma, l’ideogramma e il fonogramma.
• La scrittura cuneiforme.
• Collocazione di sequenze in ordine cronologico.
• L’edubba, la casa delle tavolette.
• L’alimentazione, l’abbigliamento e le abitazioni dei Sumeri.
• Lettura e completamento di testi.
• Realizzazione di illustrazioni, enunciati e illustrazioni.
• Sargon I e il primo impero della storia.
• Naram-Sin e la divinizzazione del re.
• Osservazione di cartine geografiche e completamento di testi.
• Il primo e il secondo regno di Babilonia.
• Hammurabi e Nabucodonosor.
• Completamento di testi, enunciati e illustrazioni.
• Le classi sociali nella società babilonese: liberi, semiliberi e schiavi.
• Riflessioni e conversazioni collettive.
• Marduk divinità nazionale e la grande ziggurat di Babilonia.
• Lettura di testi e completamento di illustrazioni.
• Osservazione e descrizione delle grandi opere architettoniche dei Babilonesi: la ziggurat di Marduk, la porta di Ishtar, i giardini pensili.
• Realizzazione e colorazione di illustrazioni.
• Il codice di Hammurabi e la legge del taglione.
• Lettura di norme e conversazioni di gruppo.
• Gli Hittiti: le armi di ferro e i carri da guerra; il re e il pankus; l’avanzata cultura giuridica, i “mille dei”.
• Lettura e completamento di testi sulla civiltà hittita.
• Riflessione sull’impero assiro e la crudeltà del suo dominio.
• Il re Assurbanipal e la biblioteca di Ninive.
• Il ruolo dell’esercito assiro.
• Osservazione e illustrazione di bassorilievi e incisioni.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
STORIA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro
Competenza chiave
mente
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività produzione scrittA e orAle
T5 T9
T5 T9
Unità
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà mesopotamica del passato con quella attuale.
• Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate.
Competenza chiave
• L’Iraq oggi: Bagdad, il petrolio e le guerre.
• Lettura, completamento di testi e questionari vero/falso.
• Tabella sul quadro di civiltà.
• Completamento di un cruciverba storico sulle civiltà mesopotamiche.
In giro per… le civiltà
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività uso delle fonti
T2 T9
T2
T9
T2
T9
T2 T9
T2 T9
T5 T7
• Ricavare informazioni dall’Inno al Nilo.
• Ricavare informazioni dalla Paletta di Narmer.
• Lettura dell’Inno al Nilo: i benefici delle periodiche inondazioni del fiume.
• Il dio Hapi e il dio Seth.
• Osservazione e descrizione delle due facce della Paletta di Narmer: le rappresentazioni del re e l’unificazione dei due regni.
• Ricavare informazioni dal Papiro di Hunefer. • Osservazione, descrizione e illustrazione del “libro dei morti” dello scriba Hunefer: il momento della pesatura del cuore.
• Ricavare informazioni da immagini del tesoro del faraone Tutankhamon.
• Lettura della storia del ritrovamento della tomba del faraone Tutankhamon.
• Osservazione, descrizione e illustrazione del faraone e del suo tesoro.
• Ricavare informazioni dalla Stele di Rosetta. • Completamento di testi sulla Stele di Rosetta: l’interpretazione dei geroglifici e i “cartigli”.
orgAnizzAzione delle informAzioni
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà egizia.
• Osservazione e descrizione della carta geostorica: dalle sorgenti al delta del Nilo.
• Il calendario “agricolo”.
• Descrizione della flora e della fauna lungo la valle del Nilo.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orgAnizzAzione delle informAzioni
T7
T7
T5
T9
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà indiana.
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà cinese.
• Osservazione e descrizione della carta geostorica del territorio dei fiumi Indo e Gange.
• L’importanza dei monsoni.
• Osservazione e descrizione della carta geo-storica del territorio del Fiume Giallo e del Fiume Azzurro.
• Il fertile löss e le barriere naturali.
strumenti concettuAli
• Conoscere la nascita della civiltà degli Egizi.
• Dai primi villaggi nelle oasi del Nilo ai regni del Basso Egitto e dell’Alto Egitto.
• Completamento di testi.
T5
T9
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Egizi.
• L’unificazione dei regni del Basso e dell’Alto Egitto: il re Narmer.
• L’Antico Regno, il Medio Regno, il Nuovo Regno e la Decadenza.
• Il faraone Ramses II, l’abile condottiero.
• Letture, osservazione di immagini e completamento di testi.
T5
T9
T5
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Egizi.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Egizi.
• Conoscere e analizzare la religione degli Egizi.
T5
T9
T9
• Conoscere le principali divinità degli Egizi.
• Il faraone e la monarchia teocratica.
• Individuazione in un’immagine di Tutankhamon dei simboli del potere del faraone e spiegazione del loro significato.
• La piramide sociale degli Egizi.
• Osservazione di affreschi sulla dura condizione dei contadini.
• Osservazione e descrizione di illustrazioni di soldati e di armi dell’esercito egizio.
• Letture e domande a risposta aperta sulla credenza degli Egizi nell’aldilà e sulla mummificazione dei defunti.
• Gli animali sacri e le divinità.
• Osservazione di immagini e descrizione delle diverse tombe: mustabe, piramidi a gradoni, piramidi a pareti lisce e sepolture nella roccia.
• Descrizione della valle di Gizah e della Valle dei Re.
• Osservazione e descrizione di illustrazioni delle principali divinità egizie.
• Narrazione del mito di Osiride e illustrazione di una sequenza.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
• Conoscere le principali attività economiche degli Egizi.
• I principali prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato.
T9
• Conoscere il sistema di scrittura degli Egizi.
T3
T9
• Conoscere aspetti della vita quotidiana degli Egizi.
T9
• Conoscere la civiltà indiana.
T9
• Conoscere la civiltà cinese.
T9
T5
T9
T5
T9
T5
T9
T5
T9
• Completamento di un testo sulla navigazione lungo il Nilo.
• La scrittura geroglifica, ieratica e demotica.
• Osservazione delle fasi di lavorazione del papiro e collocazione di sequenze in ordine cronologico.
• Realizzazione di un cartellone murale con nomi scritti con i geroglifici.
• Completamento di testi e questionari vero/falso sull’“Ot seba”, la scuola egizia.
• Completamento di illustrazioni con il cibo dei ricchi e il cibo dei poveri.
• Osservazione e descrizione dell’abbigliamento di uomini, donne e bambini.
• Osservazione di immagini dei resti archeologici di Mohenjo-Daro e Harappa: la loro organizzazione urbanistica.
• I principali indicatori tematici della civiltà indiana.
• Letture sulle vicende della civiltà cinese e individuazione dei principali eventi dalle dinastie Xia, Shang e Zhou all’impero.
• I principali indicatori tematici della civiltà cinese. produzione scrittA e orAle
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà egizia del passato con quella attuale.
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà indiana del passato con quella attuale.
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà cinese del passato con quella attuale.
• Elaborare oralmente e per iscritto quadri storici delle civiltà fluviali.
• L’Egitto oggi: l’agricoltura e il turismo.
• L’apertura del Canale di Suez.
• Lettura e completamento di testi.
• Il Pakistan e l’India oggi.
• Lettura e completamento di testi con la scelta in una coppia della parola giusta.
• La Cina: l’agricoltura e lo sviluppo industriale e commerciale.
• Lettura e questionari vero/falso.
• Completamento di un crucipuzzle sulla civiltà egizia.
• Confronto tra gli indicatori tematici delle civiltà fluviali.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività uso delle fonti
T2 T9
T2 T5
T9
T2 T5 T9
T7
• Ricavare informazioni dalla Stele di Nora.
• Ricavare informazioni da versetti del Libro dell’Esodo.
• Ricavare informazioni da simboli della religione ebraica.
• Osservazione della Stele di Nora.
• I caratteri dell’alfabeto fenicio.
• Lettura e riflessione su alcuni precetti della Torah: i comandamenti di Yahweh.
• Osservazione e descrizione della Menorah, della Torah, del Muro del Pianto e della Stella di David.
orgAnizzAzione delle informAzioni
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà fenicia.
T7
T5
T9
T5
T9
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà ebraica.
• Osservazione e descrizione della carta geostorica della Fenicia, tra i Monti del Libano e il Mar Mediterraneo.
• Completamento di un testo cloze e collegamento di causa/effetto tra frasi.
• Osservazione e descrizione di una carta geostorica della Palestina, tra l’Egitto e la Fenicia.
• Completamento di un testo cloze e questionario vero/falso.
strumenti concettuAli
• Conoscere la nascita della civiltà dei Fenici.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Fenici.
T9
T9
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Fenici.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Fenici.
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Fenici.
• Dal nomadismo alle città-stato sulle coste orientali del Mar Mediterraneo.
• Lettura e domande a risposta aperta.
• Il monopolio del commercio marittimo.
• L’influenza delle altre civiltà.
• La colonizzazione e l’importanza di Cartagine.
• La perdita dell’indipendenza.
• Letture e completamento di testi, domande a scelta multipla.
• Lettura e completamento di un testo sul re, l’assemblea dell’aristocrazia mercantile e i “suffeti”.
• Completamento della piramide sociale fenicia.
• La pirateria e il commercio degli schiavi.
• Osservazione e descrizione di sculture e bassorilievi raffiguranti le principali divinità dei Fenici.
• I sacrifici umani.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
• Conoscere le principali attività economiche dei Fenici.
T3
T5
T9
• I commerci marittimi: importazioni ed esportazioni.
• L’eccellente artigianato: il vetro e gli oggetti in materiali preziosi.
• Letture, domande a risposta aperta e questionari vero/falso.
• Collocazione in ordine cronologico di sequenze sulle fasi di lavorazione della porpora.
• Conoscere le principali invenzioni dei Fenici. • La scrittura consonantica.
• La navigazione diurna e notturna.
T5
T9
T5
T9
T3
T5
T9
T5
T9
T5
T9
• Conoscere la nascita della civiltà degli Ebrei.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Ebrei.
• Le navi fenicie: le navi da guerra e le navi mercantili.
• Osservazione e completamento di testi e di illustrazioni.
• Le tribù nomadi da Ur alla Terra di Canaan.
• Il “patto di alleanza” tra Yahweh e il popolo ebraico.
• Lettura e completamento di un testo.
• Il periodo nomade, il periodo sedentario e il periodo della crisi.
• Letture, domande a risposta aperta e completamento di testi.
• Realizzazione di una linea del tempo murale con illustrazioni e didascalie dei principali eventi della storia ebraica.
T5
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Ebrei.
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Ebrei.
• Conoscere e analizzare la religione degli Ebrei.
• I patriarchi, i giudici e il consiglio degli anziani, il re e l’unzione regale.
• Completamento di frasi e di testi.
• Da una società senza differenze di classe alla diseguaglianza economica e sociale.
• L’organizzazione della famiglia.
• Lettura di testi, domande a risposta aperta e questionari vero/falso.
• Completamento di testi e di questionari a risposta multipla sul monoteismo e il culto di Yahweh.
• Descrizione e illustrazione delle feste religiose: Shavu’òth, Pèsach, Sukkòth
• L’osservanza dello shabbat e l’alimentazione con il cibo kashèr.
• Il ruolo dei profeti.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
T9
T5
T9
T5
T9
T5 T9
• Conoscere le principali attività economiche degli Ebrei.
• Completamento di un testo sull’economia degli Ebrei: la pastorizia, l’agricoltura e l’artigianato. produzione scrittA e orAle
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà fenicia del passato con quella attuale.
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà ebraica del passato con quella attuale.
• Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate.
Unità di lavoro
Competenza chiave
• Il Libano oggi: la centralità dei servizi bancari.
• I conflitti interni ed esterni.
• Lettura e completamento di testi.
• Lo Stato di Israele oggi: la nascita nel 1948 e la conflittualità con gli Stati vicini.
• L’innovazione tecnologica.
• Lettura e completamento di testi.
• Giochi e cruciverba sulle civiltà studiate.
STORIA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
uso delle fonti
• Ricavare informazioni dal Disco di Festo.
T2
T9
T2
T9
T2
T9
T2
T9
• Ricavare informazioni da immagini di oggetti della civiltà cretese.
• Ricavare informazioni da immagini di oggetti della civiltà micenea.
• Ricavare informazioni da immagini di opere architettoniche della civiltà micenea.
Contenuti e attività
• Osservazione e descrizione del Disco di Festo e i suoi segni impressi con punzoni.
• Le tre forme di scrittura cretese: i pittogrammi, la Lineare A e la Lineare B.
• Osservazione e descrizione dell’ascia bipenne o lábrys, del Rhyton con la testa di toro e della moneta di Cnosso con il labirinto.
• Riproduzione degli oggetti con illustrazioni o sculture.
• Osservazione e descrizione della maschera di Agamennone, della corazza in bronzo di Dendra e della lama di un pugnale di Micene.
• Lettura e completamento di un testo.
• Osservazione e descrizione della Porta dei Leoni di Micene e del Tesoro di Atreo.
• Lettura e completamento di testi e illustrazioni.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività orgAnizzAzione delle informAzioni
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà cretese.
T5
T7
T5
T7
T5
T9
• Leggere una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà micenea.
• Osservazione e descrizione di una carta geo-storica di Creta, al centro del Mediterraneo orientale e crocevia delle rotte commerciali marittime tra Asia, Africa ed Europa.
• Completamento di una cartina con le rotte commerciali cretesi.
• Osservazione e descrizione di una carta geostorica della penisola del Peloponneso, tra Mar Ionio e Mar Egeo.
• Lettura di un testo e domande a risposta aperta. strumenti concettuAli
• Conoscere la nascita della civiltà dei Cretesi.
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Cretesi.
T3
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Cretesi.
T5
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Cretesi.
T2
T5
T9
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Cretesi.
T2
T5
T9
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Gli insediamenti umani nell’epoca neolitica, la civiltà minoica e la talassocrazia cretese.
• Lettura e completamento di testi con parole scelte in una coppia.
• Osservazione e descrizione dei palazzi minoici.
• Questionario vero/falso.
• Le età della storia cretese: l’età dei primi palazzi o “protopalaziale”, l’età dei secondi palazzi o “tardopalaziale”, l’età micenea.
• Collocazione di eventi in ordine cronologico.
• Le novanta città dell’isola di Creta.
• Il re-sacerdote e le sue funzioni.
• Minosse, il leggendario re di Cnosso.
• Il mito di Teseo e del Minotauro.
• Lettura di testi e domande a risposta aperta.
• L’organizzazione sociale cretese e il ruolo della donna.
• L’importanza degli architetti, progettisti dei magnifici palazzi dell’isola.
• Lettura e completamento di testi.
• Osservazione e descrizione di un affresco.
• I culti nelle grotte, all’aperto e nei cortili dei palazzi; il culto degli alberi (dendrolatria), degli animali (zoolatria) e dell’ascia bipenne.
• La tauromachia e la taurocatapsia.
• Il culto della Dea Madre.
• Osservazione di immagini, lettura e completamento di testi.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
• Conoscere le principali attività economiche dei Cretesi.
• L’eccedenza alimentare alla base dello sviluppo commerciale di Creta.
T2
T5
T9
• Conoscere la nascita della civiltà dei Micenei.
T7
T9
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Micenei.
T3
T5
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Micenei.
T5
T9
T5
T9
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Micenei.
• L’agricoltura, l’artigianato e il commercio.
• Osservazione e descrizione di navi cretesi raffigurate in un affresco.
• Lettura e completamento di testi.
• Questionario vero/falso.
• L’insediamento nella penisola greca di tribù nomadi di origine indoeuropea: gli Elleni.
• La distinzione in Eoli, Dori, Ioni e Achei.
• Gli Achei e la fondazione delle prime cittadelle fortificate: Argo, Tirinto, Pilo e Micene, la più importante.
• Lettura e completamento di testi e di carte geografiche.
• Dall’iniziale soggezione a Creta alla conquista di Creta e del Mar Egeo.
• La colonizzazione micenea e la guerra contro la città di Troia.
• Collocazione di eventi in ordine cronologico.
• Lettura e completamento di testi.
• Questionari vero/falso e domande a risposta aperta.
• Le città-fortezza e i ruoli politici: il wánax, il lawagétas, il basiléus, il consiglio degli anziani e l’assemblea del popolo.
• Osservazione e descrizione della città-fortezza di Micene.
• La società micenea: il wánax, i nobili, i sacerdoti, il popolo.
• La mancanza della proprietà privata e l’assenza della schiavitù.
• Lettura e completamento di testi.
STORIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività strumenti concettuAli
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Micenei.
• Le principali divinità dei micenei e il ruolo religioso del wánax
T5
T9
T5
T9
T5
T9
T5 T9
T5 T9
• Conoscere le principali attività economiche dei Micenei.
• Il culto dei morti; le tombe a fossa e le tombe a thòlos.
• Lettura e completamento di testi.
• Osservazione e descrizione di immagini.
• Questionari vero/falso.
• L’agricoltura, la pastorizia, l’allevamento, l’artigianato e il commercio.
• Le rotte commerciali dei Micenei.
• Lettura e completamento di un testo.
produzione scrittA e orAle
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà cretese del passato con quella attuale.
• Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà micenea del passato con quella attuale.
• Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate.
• Creta oggi: una regione della Grecia.
• L’agricoltura e il turismo.
• La longevità dei cretesi.
• Lettura e completamento di testi.
• Il Peloponneso oggi: una regione della Grecia.
• Il Canale di Corinto.
• Lettura e completamento di testi.
• Cruciverba, crucipuzzle e giochi sulle civiltà.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
• Conoscere il lavoro del geografo.
T3
T3
• Conoscere e confrontare gli strumenti del geografo.
• Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie della Geografia.
T3
T2
• Leggere ed eseguire riduzioni in scala.
• Conoscere e descrivere diversi tipi di carte.
• L’etimologia della parola “Geografia”.
• L’attività del geografo e le fasi del suo metodo di lavoro.
• Completamento di testi e diagrammi.
• Le caratteristiche e i vantaggi delle fotografie panoramiche, aeree e satellitari.
• Osservazione e descrizione di fotografie.
• Gli specialisti delle scienze ausiliarie della Geografia: l’antropologo, il biologo, il cartografo, il geologo e il meteorologo.
• Osservazione di illustrazioni e completamento di immagini.
• Lettura ed esecuzione di riduzioni in scala.
• Classificazione delle carte in base alla scala: pianta, mappa, carta topografica, carta corografica, carta geografica e planisfero.
T2
T2
T2
T3
• Interpretare e realizzare legende di carte.
• Leggere e rappresentare dati statistici.
• Classificazione delle carte in base al contenuto: carta fisica, carta politica, carta fisico-politica e carta tematica.
• Esercitazioni con carte di diverso tipo.
• Segni, disegni e colori nelle legende delle carte.
• Lettura e completamento di legende.
• I dati statistici.
• Tabelle e grafici: areogrammi, cartogrammi, diagrammi, ideogrammi, istogrammi.
• Lettura e realizzazione di un ideogramma.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Unità di lavoro
Competenza chiave
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orientAmento
• Conoscere il Sistema Solare.
T3
T4
T2 T3
T4
T2
• Conoscere il pianeta Terra.
• Orientarsi sul mappamondo utilizzando i punti cardinali.
• Orientarsi attraverso le coordinate geografiche.
T1
T2
T1
T2
T3
T1
T2
T3
• Conoscere cause ed effetti del moto di rotazione della Terra.
• Il Big Bang e la Via Lattea.
• Il Sistema solare: i pianeti e i loro moti.
• Lettura di testi e tabelle.
• Completamento di testi, domande a risposta aperta e a risposta multipla.
• Osservazione e descrizione di un mappamondo per individuare oceani e continenti.
• I poli, l’equatore e gli emisferi.
• Osservazione di un mappamondo.
• Lettura e completamento di testo e disegni.
• Paralleli e meridiani, il meridiano di Greenwich, Circoli Polari e Tropici.
• Il reticolato geografico.
• La latitudine e la longitudine.
• Lettura e completamento di testi.
• Costruzione di un rudimentale reticolato.
• Individuazione delle coordinate geografiche di un luogo.
• Il moto di rotazione e l’alternanza del dì e della notte.
• I fusi orari e il calcolo dell’ora nel mondo.
• Lettura e completamento di testi.
• Questionari vero/falso e a risposta multipla.
• Conoscere cause ed effetti del moto di rivoluzione della Terra.
• Il moto di rivoluzione e l’alternanza delle stagioni.
• Equinozi e solstizi.
• Osservazione di illustrazioni e domande a risposta chiusa.
• Lettura di testi e completamento di tabelle.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Competenza chiave
eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
linguAggio dellA geo-grAficità
• Leggere e interpretare il planisfero.
T2
T1 T2
T2
T3
T5
• Localizzare la posizione di luoghi sul planisfero.
• Leggere e interpretare planisferi tematici.
• Leggere e interpretare areogrammi e istogrammi.
• Colorazione di planisferi fisici e politici.
• Osservazione e confronto tra il planisfero di Mercatore, quello di Peters e un planisfero satellitare.
• Completamento di tabelle con l’indicazione delle coordinate geografiche di luoghi stabiliti.
• Localizzazione sul planisfero di luoghi con coordinate geografiche stabilite.
• Lettura e descrizione di un planisfero tematico sulla distribuzione nel mondo delle persone sottonutrite.
• Lettura e interpretazione di areogrammi e istogrammi con dati sul pianeta Terra.
pAesAggio
• Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi mondiali.
• Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi europei.
T5
T6
T3
T2
T3
T3
• La biosfera: atmosfera, litosfera, idrosfera.
• I biomi terrestri: i biomi forestali, i biomi di prateria e i biomi desertici.
• Lettura e completamento di testi e tabelle.
• Lettura e completamento di carte geografiche fisiche e politiche dell’Europa.
• Osservazione di immagini dei diversi biomi che caratterizzano il continente europeo.
• Lettura e realizzazione di disegni. regione e sistemA territoriAle
• Conoscere il concetto di clima, i suoi elementi e i suoi fattori.
• Conoscere e descrivere le fasce climatiche mondiali.
• Conoscere e descrivere le aree climatiche europee.
• Conoscere e descrivere le regioni climatiche italiane.
• Il tempo atmosferico e il clima.
• Gli elementi e i fattori del clima.
• Lettura, completamento di testi e disegni.
• Completamento di un planisfero con l’indicazione delle fasce climatiche mondiali.
• Descrizione delle aree climatiche europee e completamento di un testo con parole e immagini.
• Le regioni climatiche italiane.
• Osservazione, descrizione e colorazione di una carta tematica sul clima in Italia.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare

93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orientAmento
T1 T2
T3
T2 T4
T2
T2 T4
T2 T4
T2 T4
T2 T4
T2 T3
T5
• Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia utilizzando i punti cardinali.
• Leggere immagini satellitari dell’Italia.
• I punti cardinali e i punti intermedi.
• Lettura e completamento di carte geografiche e tabelle.
• L’Italia dal satellite: i colori, le luci e i confini.
• Osservazione e descrizione di immagini satellitari dell’Italia.
linguAggio dellA geo-grAficità
• Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi idrografici.
• Saper leggere e rappresentare le profondità dei mari italiani.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali mari.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali fiumi.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali laghi.
• Realizzare carte geografiche evidenziando elementi idrografici.
• Leggere e interpretare areogrammi e istogrammi sul sistema idrografico italiano.
• Osservazione e interpretazione di una carta idrografica dell’Italia: mari, fiumi e laghi.
• Batimetria e isobate.
• Colorazione e realizzazione di isobate.
• Osservazione di una carta geografica con i mari: la posizione dei mari italiani.
• Osservazione di una carta geografica con i fiumi: la posizione dei fiumi italiani e loro foci.
• Osservazione di una carta geografica con i laghi: la posizione dei laghi italiani.
• Completamento di carte mute con elementi idrografici.
• Lettura, interpretazione e realizzazione di areogrammi e istogrammi con dati sui fiumi e sui laghi italiani.
pAesAggio
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio marino.
T5
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio fluviale.
• Oceani e mari, salinità e temperatura.
• Onde, maree e correnti marine.
• Descrizione del paesaggio marino.
• Osservazione di illustrazioni e domande a risposta aperta.
• Lettura e completamento di tabelle e di disegni.
• Il viaggio del fiume; periodi di piena e di magra; corso superiore, medio e inferiore.
• Descrizione del paesaggio fluviale.
• Osservazione di illustrazioni e domande a risposta aperta.
• Lettura e completamento di testi, di tabelle e di disegni.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

le civiltà
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
pAesAggio
T5
T4
T5
T5
T5
T5
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio lacustre.
• Conoscere le caratteristiche fisiche dell’Italia.
• Conoscere e descrivere i paesaggi marini dell’Italia.
• Conoscere e descrivere i paesaggi fluviali dell’Italia.
• Conoscere e descrivere i paesaggi lacustri dell’Italia.
• Le tante origini del lago.
• Descrizione di paesaggi lacustri.
• Lettura e completamento di testi.
• Descrizione dei rilievi e delle acque d’Italia.
• Osservazione di cartine fisiche.
• Lettura e completamento di testi.
• Realizzazione di una scultura dell’Italia.
• Descrizione dei mari, delle coste, dei golfi, delle isole e degli arcipelaghi italiani.
• Lettura e completamento di carte geografiche, testi e tabelle.
• Descrizione dei fiumi italiani: i fiumi alpini e il bacino del Po e i fiumi appenninici.
• Lettura e completamento di testi e tabelle.
• Descrizione dei laghi italiani: i laghi alpini e prealpini; i laghi peninsulari e insulari.
• Lettura e completamento di testi e disegni.
regione e sistemA territoriAle
T7
T7
T7
• Conoscere le principali attività umane collegate al mare.
• Conoscere le principali attività umane collegate al fiume.
• Conoscere le principali attività umane collegate al lago.
• La navigazione, la pesca, il turismo balneare.
• Lettura e completamento di testi e di crucipuzzle.
• L’irrigazione dei campi e la navigazione.
• Le cave e la produzione di energia.
• Lettura e completamento di illustrazioni.
• L’agricoltura, il turismo lacustre e la navigazione.
• Lettura e completamento di crucipuzzle.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orientAmento
• Orientarsi sulla carta geografica dell’Italia utilizzando i punti cardinali.
T1 T2
T3
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2 T3
• Osservare elementi orografici in immagini satellitari dell’Italia.
• I punti cardinali e i punti intermedi.
• La posizione delle montagne, delle colline e delle pianure.
• I venti e la rosa dei venti.
• Completamento di carte e rose dei venti.
• Individuazione di montagne, colline e pianure italiane in immagini satellitari.
linguAggio dellA geo-grAficità
• Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi orografici.
• Sapere leggere e rappresentare le altitudini dei rilievi italiani.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali montagne.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali vulcani.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali colline.
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali pianure.
• Realizzare carte geografiche evidenziando elementi orografici.
• Leggere e costruire areogrammi, istogrammi e tabelle sul sistema orografico italiano.
• Osservazione e interpretazione di una carta orografica dell’Italia: montagne, colline e pianure.
• Colori e altitudine.
• Altimetria e isoipse.
• Colorazione e realizzazione di isoipse.
• Osservazione di una carta geografica con le catene montuose: la posizione delle montagne.
• Osservazione di una carta geografica con i vulcani: la posizione dei vulcani.
• Osservazione di una carta geografica con le colline: la posizione delle colline.
• Osservazione di una carta geografica con le pianure: la posizione delle pianure.
• Completamento di carte mute con elementi orografici.
• Lettura, interpretazione e realizzazione di areogrammi, istogrammi e tabelle con dati su montagne, colline e pianure.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
pAesAggio
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio montano.
T4
T5
T4
T5
T4 T5
T5
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio collinare.
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio pianeggiante.
• Conoscere e descrivere i paesaggi montuosi dell’Italia.
• L’orogenesi e l’erosione delle montagne.
• Descrizione del paesaggio montano.
• Osservazione e descrizione di una montagna speciale: il vulcano.
• Lettura e completamento di testi.
• Le diverse origini delle colline.
• Calanchi, frane e smottamenti.
• Osservazione di immagini, lettura e completamento di testi.
• Le tante origini delle pianure.
• Le risorgive.
• Lettura e completamento di testi e disegni.
• Descrizione delle Alpi occidentali, centrali e orientali.
• Descrizione degli Appennini settentrionali, centrali e meridionali.
• Lettura e completamento di testi e carte.
• Osservazione e lettura di grafici e immagini.
T5
T5
• Conoscere e descrivere i paesaggi collinari dell’Italia.
• Conoscere e descrivere i paesaggi pianeggianti dell’Italia.
• Descrizione delle colline dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale.
• Lettura e completamento di testi e carte.
• Osservazione e lettura di immagini.
• Descrizione della Pianura Padana.
• Descrizione delle pianure dell’Italia centrale e meridionale.
• Lettura e completamento di testi.
• Osservazione e descrizione di immagini.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Unità di lavoro
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività regione e sistemA territoriAle
T6
T7
T6
T7
T6 T7
• Conoscere le principali attività umane collegate alla montagna.
• Conoscere le principali attività umane collegate alla collina.
• Conoscere le principali attività umane collegate alla pianura.
Unità di lavoro
Competenza chiave
• L’allevamento, l’agricoltura e lo sfruttamento delle acque.
• Lettura e completamento di testi.
• L’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato.
• La coltivazione di vite e ulivo.
• Completamento di testi e tabelle.
• Questionario vero/falso.
• Il paesaggio agricolo, industriale e urbano.
• Lettura e completamento di testi.
• Osservazione di immagini.
GEOGRAFIA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
orientAmento
T1 T2
T1 T7
• Orientarsi su una carta tematica dell’Italia utilizzando i punti cardinali.
• Osservare elementi antropici in immagini di paesaggi.
• La distribuzione della popolazione in Italia.
• Lettura e descrizione di un cartogramma.
• Il paesaggio umanizzato.
• Osservazione di immagini e individuazione di elementi antropici in paesaggi agricoli, industriali e urbani.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
linguAggio dellA geo-grAficità
T2
T7
T2 T7
T7
T3
T7
T3
T7
T7
T3
T7
T7
• Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi antropici.
• Realizzare carte geografiche evidenziando elementi antropici.
• Analizzare i concetti di economia e di regione economica.
• Leggere e costruire areogrammi, ideogrammi e tabelle sull’economia europea.
• Leggere e costruire areogrammi, ideogrammi, istogrammi e tabelle sull’economia italiana.
• Analizzare i concetti di popolo e popolazione.
• Analizzare le caratteristiche della popolazione europea.
• Analizzare le caratteristiche della popolazione italiana.
• Conoscere gli elementi di paesaggi umanizzati.
T6
T6
T6
• Gli elementi antropici nelle carte geografiche.
• Osservazione e interpretazione di carte con elementi antropici.
• Completamento di una carta geografica dell’Italia con elementi antropici.
• L’economia e le regioni economiche.
• Lettura e completamento di tabelle.
• Lettura, interpretazione e realizzazione di areogrammi e ideogrammi sull’economia dell’Unione europea.
• Lettura, interpretazione e realizzazione di areogrammi, ideogrammi, istogrammi e tabelle sull’economia dell’Italia.
• Il popolo, la popolazione e la densità demografica.
• Completamento di un testo.
• Il decremento demografico, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’immigrazione.
• Le principali lingue e religioni europee.
• Lettura e interpretazione di tabelle e areogrammi.
• La struttura della popolazione italiana per sesso ed età.
• L’incremento della popolazione immigrata.
pAesAggio
• I diversi tipi di paesaggio: paesaggio agrario, industriale, turistico e urbano.
• Osservazione e descrizione di immagini di diversi tipi di paesaggi.
• Conoscere gli elementi di paesaggi culturali. • Il paesaggio culturale e i beni culturali territoriali.
• Osservazione e descrizione di immagini di paesaggi culturali.
• Conoscere il patrimonio culturale dell’Italia. • Osservazione e descrizione di immagini di monumenti e opere artistiche dell’Italia.
GEOGRAFIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
Competenza chiave
Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare C5 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività regione e sistemA territoriAle
T3
T7
T3
T7
T3 T7
T6
T7
T3
T6
T7
T3
T7
• Conoscere e descrivere i settori produttivi.
T3
T7
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia in Europa.
• Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia in Italia.
• Conoscere e descrivere il settore primario in Italia.
• Conoscere le modalità di tutela dei prodotti agricoli di qualità.
• Conoscere e descrivere il settore secondario in Italia.
• Conoscere e descrivere il settore terziario in Italia.
• Il settore primario, il settore secondario e il settore terziario.
• Lettura e completamento di testi e tabelle.
• Realizzazione di disegni e istogrammi.
• Il settore primario, il settore secondario e il settore terziario in Europa.
• Lettura e completamento di testi, tabelle e istogrammi.
• Questionario vero/falso.
• La distribuzione dei lavoratori in Italia per settore e per posizione geografica.
• Lettura di tabelle e istogrammi.
• L’agricoltura, l’allevamento, la pesca e le risorse minerarie ed energetiche in Italia.
• Lettura e completamento di testi, cartine e tabelle.
• I marchi DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP e STG.
• L’agricoltura biologica. Gli OGM.
• Completamento di una carte tematica con i prodotti DOP italiani.
• Le principali industrie italiane.
• Le regioni industriali e i distretti industriali.
• L’artigianato artistico italiano.
• Lettura e completamento di testi e carte.
• Il commercio interno ed estero, i trasporti, la pubblica amministrazione, il turismo, i servizi finanziari.
• Il terziario avanzato: lo sviluppo della telefonia mobile, dei personal computer, di internet e dell’e-commerce
• Lettura e completamento di testi e cartine.
• Realizzazione di un’indagine in classe.
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Competenza chiave
Periodo: SETTEMBRE
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi da verificare
T5 T7
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1 T8
T2 T4
T2 T4
T2 T4
• Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.
• Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci entro il 1 000.
• Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità.
• Ordinare e confrontare numeri naturali entro il 1 000 utilizzando i simboli >, <, =
• Eseguire le quattro operazioni in riga.
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con due cambi.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una e di due cifre.
• Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza e con il cambio, con e senza resto.
• Risolvere situazioni problematiche con l’uso delle quattro operazioni.
• Riconoscere e rappresentare linee rette, semirette e segmenti.
• Classificare e rappresentare gli angoli in base all’ampiezza.
• Riconoscere, denominare e rappresentare figure geometriche.
Contenuti e attività
• Esercizi per la classificazione con l’uso di diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.
• Lettura e scrittura dei numeri entro il 1 000.
• Scomposizione e composizione di numeri entro il 1 000 in migliaia, centinaia, decine e unità.
• Ordinamento dei numeri entro il 1 000.
• Riconoscimento del precedente e del seguente di un numero dato, utilizzando i simboli >, <, =.
• Esecuzione delle quattro operazioni in riga.
• Esecuzione di addizioni e sottrazioni.
• Esecuzione di moltiplicazioni in colonna.
• Esecuzione di divisioni in colonna.
• Risoluzione di problemi con le quattro operazioni.
• Rappresentazioni con il disegno di rette, semirette e segmenti.
• Rappresentazioni grafiche di vari tipi di angoli: retto, acuto, ottuso, piatto e giro.
• Disegno e colorazione di figure geometriche.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Comunicativa… mente
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1
T1
T1
T10
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
• Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci oltre il 1 000.
• Scomporre e comporre i numeri in unità, decine e centinaia semplici e in unità, decine e centinaia di migliaia.
• Confrontare e ordinare i numeri in base dieci oltre il 1 000.
• Conoscere i numeri romani.
• Effettuare cambi tra migliaia, centinaia, decine e unità.
• Riconoscere e applicare le proprietà dell’addizione e della sottrazione per semplificare il calcolo.
• Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione.
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali.
• Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione.
• Applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione.
• Eseguire calcoli mentali di moltiplicazione.
• Eseguire moltiplicazioni in riga con i numeri naturali per 10, per 100, per 1 000.
• Rappresentazione con l’abaco, lettura e scrittura dei numeri oltre il 1 000.
• Esercizi di scomposizione e composizione dei numeri.
• Esercizi di confronto dei numeri naturali oltre il 1 000 con l’uso corretto dei simboli >, <, =.
• Esercizi di ordinamento dei numeri naturali.
• Esercizi di scrittura nel sistema di numerazione romano.
• Esercizi di cambio con l’abaco.
• Esercizi per il calcolo mentale e scritto.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esecuzione di addizioni e sottrazioni in colonna.
• Esercizi per il calcolo mentale e scritto.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in riga.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Competenza chiave
eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1
T5
T1
T8
T1
T8
T1 T8
• Individuare i multipli di un numero.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre.
• Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema.
• Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato delle quattro operazioni.
• Risolvere problemi con due domande e due operazioni.
• Osservazione della “Tavola pitagorica” ed esecuzione di esercizi di rappresentazione di una classificazione e di calcolo.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna.
• Individuazione di dati essenziali per la risoluzione di problemi.
• Risoluzione di problemi con le quattro operazioni.
• Risoluzione di problemi con due domande e due operazioni.
spAzio e figure
T2 T5
T3
T2 T3
T4
T3 T4
T2 T3
• Utilizzare il piano cartesiano per individuare punti dati.
• Rafforzare i concetti di linea retta, semiretta e segmento.
• Conoscere la definizione di angolo.
• Misurare e disegnare gli angoli.
• Classificare gli angoli in base all’ampiezza.
• Riconoscere angoli concavi e convessi.
• Rafforzare i concetti di incidenza, perpendicolarità e parallelismo.
• Rappresentazione grafica del piano cartesiano.
• Individuazione di un punto.
• Definizione di retta, semiretta, segmento.
• Definizione di angolo.
• Misura dell’ampiezza degli angoli e rappresentazione grafica di vari angoli.
• Uso del goniometro.
• Classificazioni di angoli.
• Confronto tra angoli.
• Definizione di rette incidenti, perpendicolari e parallele.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
MATEMATICA Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Unità di lavoro
Competenza chiave
Comunicativa… mente
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività relAzioni, dAti e previsioni
T5 T7
T7
T7
T5 T7
• Usare correttamente i quantificatori: tutti, alcuni, ognuno, nessuno, almeno uno
• Attribuire valore di verità a enunciati logici.
• Stabilire il valore di verità della proposizione composta dalla “o” intesa come disgiunzione “inclusiva”.
• Classificare in base a tre attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.
Unità di lavoro
Competenza chiave
• Rappresentazioni grafiche e situazioni problematiche per l’uso corretto dei quantificatori.
• Esercizi per il riconoscimento di frasi vere o false.
• Esercizi di utilizzazione della disgiunzione “o”.
• Esercizi per la classificazione.
In giro per… le civiltà
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1
T1
T1
• Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della divisione.
• Eseguire calcoli mentali di divisione.
• Eseguire divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1 000.
• Esercizi per il calcolo mentale e scritto.
• Esercizi per il calcolo rapido.
• Esercizi per eseguire divisioni in riga.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1
T1
T1
T1
T10
T10
T1
T10
T8
T8
T8
• Individuare i divisori di un numero.
• Riconoscere i numeri primi entro i primi cento numeri naturali.
• Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una cifra.
• Eseguire in colonna divisioni con il divisore di due cifre.
• Eseguire le prove delle quattro operazioni.
• Comprendere il concetto di frazione.
• Individuare l’unità frazionaria di un intero.
• Individuare la frazione complementare di una frazione data.
• Individuare i dati mancanti, i dati superflui e quelli nascosti per la risoluzione di un problema.
• Risolvere problemi con una domanda nascosta.
• Risolvere problemi con una domanda e due operazioni.
• Esercizi per l’individuazione dei divisori di un numero.
• Esercizi per il riconoscimento dei numeri primi (crivello di Eratostene).
• Esercizi per eseguire divisioni in colonna.
• Esercizi per eseguire le prove delle quattro operazioni.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni come parti di figure geometriche.
• Lettura e scrittura di frazioni.
• Rappresentazioni grafiche di unità frazionarie.
• Attività grafiche ed esercizi per l’individuazione della frazione complementare.
• Risoluzione di problemi contenenti vari tipi di dati.
• Risoluzione di problemi con una domanda nascosta.
• Risoluzione di problemi con una domanda e due operazioni.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Competenza chiave

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
spAzio e figure
• Distinguere poligoni e non poligoni.
T3
T3
T3
T2
T3
T2
T3
• Individuare vertici, lati e angoli di un poligono.
• Riconoscere i poligoni convessi e concavi.
• Riconoscere un poligono equilatero, equiangolo e regolare.
• Individuare il numero delle diagonali di un poligono.
• Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli.
• Classificare i triangoli rispetto ai lati.
• Classificare i triangoli rispetto agli angoli.
T3
T4
T5
T5
T5
T5
• Individuare la base e l’altezza di un triangolo.
• Definizione di poligono.
• Definizione degli elementi di un poligono.
• Definizione di poligono convesso e concavo.
• Esercizi per il riconoscimento di poligoni convessi e concavi.
• Definizione di poligono equilatero, equiangolo e regolare.
• Esercizi per il riconoscimento di poligoni equilateri, equiangoli e regolari.
• Definizione di diagonale.
• Rappresentazioni grafiche per l’individuazione delle diagonali di un poligono.
• Esercizi di classificazioni di poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli.
• Costruzione di modelli di poligoni.
• Esercizi di classificazione dei triangoli.
• Definizione di triangolo equilatero, isoscele e scaleno.
• Definizione di triangolo rettangolo, acutangolo, ottusangolo.
• Uso del righello per disegnare altezze di un triangolo.
relAzioni, dAti e previsioni
• Stabilire relazioni di equivalenza in un insieme.
• Stabilire relazioni d’ordine tra due o più elementi.
• Rappresentare e leggere istogrammi e ideogrammi.
• Individuare la moda.
• Rappresentazioni grafiche di relazioni tra insiemi.
• Rappresentazioni grafiche di relazioni tra insiemi.
• Rappresentazioni grafiche di istogrammi e ideogrammi.
• Interpretazione di dati mediante l’uso di metodi statistici.
• Confronto di raccolte di dati mediante la moda.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Competenza chiave
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T10
T10
T1
T10
T1 T10
T10
T1
T10
T10
T10
T10
T7 T8
T1 T8 T10
• Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti.
• Confrontare e ordinare unità frazionarie.
• Confrontare e ordinare frazioni.
• Riconoscere frazioni equivalenti.
• Calcolare la frazione di un numero.
• Riconoscere le frazioni decimali.
• Trasformare frazioni decimali in numeri decimali.
• Leggere e scrivere i numeri decimali indicando il valore di ogni cifra.
• Scomporre i numeri decimali in decimi, centesimi, millesimi.
• Comporre numeri espressi in decimi, centesimi, millesimi.
• Confrontare e ordinare i numeri decimali.
• Risolvere problemi con più domande esplicite o implicite.
• Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni proprie, improprie, apparenti.
• Esercizi di confronto di unità frazionarie con l’uso corretto dei simboli >, <.
• Esercizi di ordinamento di unità frazionarie.
• Esercizi di confronto di frazioni con l’uso corretto dei simboli >, <.
• Esercizi di ordinamento di frazioni.
• Rappresentazioni grafiche di frazioni equivalenti.
• Esercizi per calcolare la frazione di un numero.
• Definizione e riconoscimento di frazioni decimali.
• Esercizi di scrittura di numeri decimali.
• Lettura e scrittura dei numeri decimali.
• Esercizi di scomposizione e composizione dei numeri decimali.
• Esercizi di confronto dei numeri decimali con l’uso corretto dei simboli >, <, =.
• Esercizi di ordinamento dei numeri decimali.
• Risoluzione di problemi.
• Risoluzione di problemi con le frazioni.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
chiave
matematica (A) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività numeri
T1 T8
T3 T8
T3
T3
T3
T3 T4
T1 T3
• Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità.
• Risolvere problemi geometrici.
• Classificare i quadrilateri.
• Risoluzione di problemi con le principali unità di misura.
• Risoluzione di problemi per il calcolo del perimetro.
spAzio e figure
• Esercizi di classificazione dei quadrilateri.
T5
T3 T4
T1
T3
T1 T5
• Individuare le caratteristiche dei trapezi.
• Individuare le caratteristiche dei parallelogrammi.
• Acquisire i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria.
• Calcolare il perimetro dei triangoli.
• Calcolare il perimetro dei quadrilateri.
• Esercizi per l’individuazione delle caratteristiche dei trapezi.
• Esercizi per l’individuazione delle caratteristiche dei parallelogrammi.
• Esercizi di ritaglio.
• Il Gioco del Tangram.
• Uso del geopiano.
• Esercizi di calcolo per la misurazione del perimetro. relAzioni, dAti e previsioni
• Rappresentare e leggere l’areogramma.
• Conoscere le unità di misura convenzionali di lunghezza, peso e capacità.
• Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità a un’altra a essa equivalente con i numeri interi.
• Leggere, calcolare e interpretare la media aritmetica.
• Rappresentazione grafica e lettura di un areogramma.
• Esercizi sulle unità di misura di lunghezza, peso e capacità.
• Esercizi di equivalenze con i numeri interi.
• Calcolo della media aritmetica in una indagine statistica.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
numeri
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1
T10
T1 T10
T1 T10
T1 T10
T1 T8
T1 T8
T1 T8
T1 T3 T8
• Effettuare cambi tra unità, decimi, centesimi e millesimi.
• Eseguire in riga, su tabelle e con gli operatori, semplici calcoli di addizione e sottrazione con i numeri decimali.
• Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali.
• Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, per 100, per 1 000 con i numeri decimali.
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali.
• Eseguire in colonna divisioni con il dividendo decimale.
• Eseguire in colonna divisioni con il divisore decimale.
• Eseguire in colonna divisioni con il dividendo e il divisore decimali.
• Risolvere situazioni problematiche relative a peso lordo, peso netto e tara.
• Risolvere problemi di costo unitario e costo totale.
• Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita.
• Risolvere problemi sulle aree.
• Esercizi di cambio tra unità, decimi, centesimi e millesimi.
• Esercizi con l’uso di tabelle e operatori per eseguire addizioni e sottrazioni in riga con i numeri decimali.
• Esercizi per eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri decimali.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni e divisioni in riga per 10, per 100, per 1 000 con i numeri decimali.
• Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna con i numeri decimali.
• Esercizi per eseguire divisioni in colonna con il divisore decimale.
• Esercizi per eseguire divisioni in colonna con i numeri decimali.
• Risoluzione di problemi con peso lordo, peso netto e tara.
• Risoluzione di problemi con costo unitario e costo totale.
• Risoluzione di problemi sulla compravendita.
• Risoluzione di problemi sulle aree.
MATEMATICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Competenza chiave
Competenza matematica (A) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
spAzio e figure
T4
T4
T4
T4
• Rappresentare sul piano cartesiano figure ottenute per traslazione, per rotazione, per ribaltamento.
• Rappresentazioni grafiche di figure per traslazione, rotazione e simmetria.
• Individuare gli assi di simmetria nei poligoni. • Rappresentazione grafica degli assi di simmetria nel triangolo, nel parallelogramma, nel trapezio e nei poligoni regolari.
• Conoscere la differenza tra perimetro e area. • Esercizi di confronto tra il perimetro e l’area.
• Calcolare l’area del quadrato, del rettangolo e del triangolo.
• Applicazione di formule per calcolare l’area dei principali poligoni.
relAzioni, dAti e previsioni
T1
T10
T3
T1 T8
T1 T10
T1 T10
T5
T5
• Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità a un’altra a essa equivalente con i numeri decimali.
• Conoscere le misure di superficie.
• Conoscere e utilizzare le misure di tempo.
• Leggere, calcolare e interpretare la percentuale.
• Quantificare la probabilità del verificarsi di un evento mediante una frazione.
• Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, la selezione.
• Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, l’iterazione.
• Esercizi di equivalenze con i numeri decimali.
• Esercizi sulle unità di misura di superficie.
• Risoluzioni di problemi con le misure di tempo con calcoli ed equivalenze.
• Calcolo della percentuale in una indagine statistica.
• Calcolo delle probabilità mediante l’uso di frazioni.
• Rappresentazione di algoritmi.
• Rappresentazione di algoritmi.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Competenza chiave
eriodo: SETTEMBRE
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi da verificare Contenuti e attività
• Conoscere le scienze naturali.
T1
T2
T2
T1 T2
• Conoscere il lavoro dello scienziato.
• Conoscere la misura delle grandezze.
• Conoscere e confrontare gli strumenti dello scienziato.
Unità di lavoro
SCIENZE
Competenza chiave
• L’etimologia della parola “Scienza”.
• L’oggetto delle scienze naturali: la natura e i fenomeni naturali.
• Realizzazione di un cartellone con le diverse scienze naturali.
• L’attività dello scienziato e le fasi del metodo scientifico-sperimentale.
• Osservazione e classificazione di oggetti.
• Le unità di misura convenzionali.
• Osservazione e misurazione di fenomeni e oggetti.
• Gli strumenti per osservare e per misurare.
• Gli attrezzi del laboratorio scientifico.
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
• Individuare le proprietà della materia.
T3 T4
T3 T4
T3
T4
T3
T4
T3 T4
T3
T4
• Osservare gli stati di aggregazione della materia.
• Individuare il concetto di calore.
• Conoscere i modi di trasmissione del calore.
• Le proprietà della materia: volume, massa e peso.
• L’atomo e la molecola; gli elementi e i composti.
• Costruzione di atomi e molecole con la plastilina.
• Gli stati di aggregazione della materia: solido, liquido e gassoso.
• L’energia termica.
• La differenza tra calore e temperatura.
• Le unità di misura: kcal e °C.
• Realizzazione di un cartellone in cui siano illustrati i modi di trasmissione del calore: conduzione, convenzione e irraggiamento.
• Classificazione di materiali in conduttori e isolanti.
• Conoscere la dilatazione termica della materia. • La dilatazione termica nei solidi, nei liquidi e nei gas.
• Osservare i passaggi di stato della materia.
• I passaggi di stato della materia: la sublimazione e la fusione dei solidi; la solidificazione e la vaporizzazione dei liquidi; il brinamento e la condensazione dei gas.
• Osservazione di passaggi di stato.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Comunicativa… mente
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
• Individuare le proprietà dell’aria.
T3
T4
• Individuare le proprietà dell’acqua.
T3
T4
T3
T2
T2
T2
T2
T5
T6
T5
T6
• Osservare e classificare la materia in organica e inorganica.
• Osservare e sperimentare fenomeni collegati al calore e alla temperatura.
• Le miscele omogenee e eterogenee.
• La composizione dell’aria: una miscela omogenea di gas.
• Le proprietà dell’aria.
• Realizzazione di esperimenti.
• L’idrosfera.
• Gli stati di aggregazione dell’acqua.
• Distinzione tra acqua salata, dolce, distillata, minerale, piovana e potabile.
• Le proprietà dell’acqua.
• Realizzazione di esperimenti.
osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• La materia organica e inorganica.
• Classificazione di immagini.
• Osservare e sperimentare passaggi di stato della materia.
• Osservare e sperimentare fenomeni collegati all’aria.
• Osservare e sperimentare fenomeni collegati all’acqua.
• Esperimenti su fenomeni collegati al calore e alla temperatura: la percezione sensoriale e il termometro; i conduttori e gli isolanti; la trasmissione del calore e l’equilibrio termico; la dilatazione termica.
• Esperimenti sui passaggi di stato della materia: l’evaporazione e la sublimazione.
• Esperimenti sulle proprietà dell’aria: l’esistenza, il peso, la comprimibilità e l’elasticità dell’aria.
• Esperimenti sulle proprietà dell’acqua: la solidificazione, il principio dei vasi comunicanti e la capillarità.
l’uomo, i viventi e l’Ambiente
• Comprendere l’importanza dell’aria nella vita dell’uomo.
• Comprendere l’importanza dell’acqua nella vita dell’uomo.
• L’importanza dell’ossigeno, dell’anidride carbonica e dell’ozono.
• Gli effetti dell’inquinamento dell’aria: la riduzione dell’ossigeno, le piogge acide, l’effetto serra e l’assottigliamento dello strato di ozono.
• Conversazioni sulle problematiche dell’inquinamento ambientale.
• L’acqua come risorsa e gli sprechi nel consumo.
• Elaborazione di un regolamento per ridurre il consumo quotidiano di acqua.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. SCIENZE Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE

Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
T2
T3
T3
T3 T5
T4 T5
• Individuare le proprietà di diversi tipi di terreno.
• Realizzazione di un esperimento sulla permeabilità di terreni diversi: sabbia, argilla e limo.
osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Conoscere l’origine del suolo.
• Conoscere la struttura e la composizione del suolo.
• Osservare la vita nel suolo.
• Il suolo e la litosfera.
• Associazione di illustrazioni a descrizioni delle fasi di formazione del suolo.
• Gli strati e la composizione del terreno.
• Osservazione degli strati del terreno e di diversi tipi di terreno.
• Osservazione di immagini dal vero o al microscopio di organismi e microrganismi del suolo.
• Il ciclo della materia.
l’uomo, i viventi e l’Ambiente
• Classificare i viventi e i non viventi.
• Conoscere il ciclo vitale.
T6
• Elaborare i primi elementi di classificazione dei viventi.
T5
T5
• Osservare e descrivere le parti della pianta.
• Realizzazione di una classificazione di esseri viventi e non viventi.
• Rappresentazione in cartelloni del ciclo vitale: nascita, nutrizione (organismi autotrofi ed eterotrofi) crescita (movimento e sensibilità agli stimoli), riproduzione (sessuata e asessuata), morte.
• La classificazione: specie, genere, famiglia, ordine, classe, phylum, regno.
• Completamento della carta d’identità di un leone.
• Organismi procarioti ed eucarioti, unicellulari e pluricellulari, autotrofi ed eterotrofi.
• Classificazione di immagini di esseri viventi nei cinque regni: monere, protisti, funghi, piante e animali.
• Le caratteristiche delle piante: organismi eucarioti, pluricellulari e autotrofi.
• Osservazione e individuazione delle parti della pianta: radice, fusto, ramo, foglia, fiore e frutto.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’Ambiente
T5
• Elaborare i primi elementi di classificazione delle piante.
• Descrivere la struttura e la funzione della radice.
T5
• Descrivere la struttura e la funzione del fusto.
T5
• Descrivere la struttura e la funzione della foglia.
T5
• Descrivere la struttura e la funzione del fiore.
T5
T5
• Descrivere la struttura e la funzione del frutto.
• Completamento di una mappa per la classificazione delle piante: alghe, briofite, pteridofite, gimnosperme e angiosperme.
• Illustrazioni di piante.
• Le funzioni della radice e la sua struttura: apice, zona di accrescimento e zona di assorbimento.
• Osservazione, classificazione e illustrazione dei diversi tipi di radice: a fittone, ramificata, fascicolata, tuberiforme e avventizia.
• Le funzioni del fusto e la sua struttura: epidermide, corteccia, cilindro centrale e midollo.
• I fusti epigei e ipogei.
• Osservazione e classificazione dei diversi tipi di fusto: erbaceo, arbustivo e arboreo, succulento.
• Osservazione della struttura della foglia: picciolo, lamina e nervature.
• Classificazione e illustrazione di diversi tipi di foglia a seconda della forma del picciolo, della pagina, del margine e delle nervature.
• Le funzioni della foglia: la fotosintesi, la respirazione e la traspirazione.
• Piante a foglie decidue e piante a foglie persistenti.
• Osservazione della struttura del fiore: il peduncolo, il ricettacolo, il calice, la corolla, gli stami e i pistilli.
• La funzione del fiore: la riproduzione della pianta.
• Illustrazione dell’impollinazione anemofila, entomofila, idrofila e zoofila.
• Illustrazione e descrizione delle fasi della fecondazione.
• Osservazione della struttura del frutto: epicarpo, mesocarpo, endocarpo.
• Distinzione e illustrazione di veri e falsi frutti e di frutti secchi e carnosi.
• La funzione del frutto: la protezione del seme.
• Osservazione e illustrazione dei diversi tipi di disseminazione e delle fasi della germinazione.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
T2
T5
T5
• Osservare trasformazioni chimiche. • Esperimento sulle trasformazioni chimiche: l’uovo di gomma.
osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Osservare le caratteristiche degli animali.
• Osservare gli invertebrati e i vertebrati.
T5
T5
T5
T5
• Osservare gli ambienti di vita degli invertebrati.
• Osservare gli ambienti di vita dei vertebrati.
• Le caratteristiche degli animali: organismi eucarioti, pluricellulari e eterotrofi.
• I vertebrati e l’endoscheletro.
• Gli invertebrati: l’esoscheletro, il dermascheletro e l’assenza di sostegno.
• Osservazione e classificazione di animali in vertebrati e invertebrati.
• Classificazione di invertebrati in terrestri e acquatici.
• Classificazione di vertebrati in terrestri e acquatici.
• Classificazione di vertebrati in eterotermi e omeotermi.
l’uomo, i viventi e l’Ambiente
• Elaborare i primi elementi di classificazione degli invertebrati.
• Descrivere le caratteristiche morfologiche degli invertebrati.
• Elaborare i primi elementi di classificazione dei vertebrati.
• Osservazione e classificazione di poriferi, celenterati, platelminti, nematodi, anellidi, artropodi, molluschi e echinodermi.
• Realizzazione di cartelloni murali o presentazioni in PowerPoint per illustrare le principali caratteristiche morfologiche degli invertebrati.
T5
T5
• Descrivere le caratteristiche morfologiche dei pesci.
• Osservazione e classificazione di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi in base ai diversi tipi di cute: nuda, con squame, con scaglie, con penne e piume, con peli.
• Osservazione e descrizione delle caratteristiche morfologiche dei pesci: il corpo idrodinamico, le scaglie e le pinne.
• Realizzazione con l’argilla di un semplice “museo del mare”.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’Ambiente
• Descrivere le caratteristiche morfologiche degli anfibi.
T5
T5
T5
• Descrivere le caratteristiche morfologiche dei rettili.
T5
• Descrivere le caratteristiche morfologiche degli uccelli.
T5
• Descrivere le caratteristiche morfologiche dei mammiferi.
• Descrivere e interpretare le funzioni vitali degli animali.
• Descrivere e interpretare le principali funzioni vitali degli invertebrati.
T5
• Osservazione e descrizione delle caratteristiche morfologiche degli anfibi: le differenze tra il girino e l’anfibio adulto.
• Classificazione di anfibi in anuri, apodi e urodeli.
• Osservazione e descrizione delle caratteristiche morfologiche dei rettili: le squame e il corpo strisciante.
• Classificazione di rettili in cheloni, loricati e squamati.
• Osservazione e descrizione delle caratteristiche morfologiche degli uccelli: lo scheletro cavo, le ali, le piume, le penne, il becco e le zampe.
• Classificazione di uccelli in anseriformi, falconiformi, galliformi, passeriformi, psittaciformi e strigiformi.
• Osservazione e descrizione delle caratteristiche morfologiche dei mammiferi: le mammelle e l’allattamento dei piccoli; il rivestimento della cute, i diversi tipi di arti e di denti.
• Classificazione di mammiferi nei principali ordini.
• La cellula, il tessuto, l’organo, gli apparati e l’organismo.
• Descrizione delle funzioni vitali degli animali: respirazione, nutrizione, circolazione, escrezione, movimento e riproduzione.
• Descrizione della respirazione: per diffusione, attraverso branchie, polmoni o trachee.
• La riproduzione asessuata e sessuata.
• La fecondazione esterna e interna.
• Completamento di un questionario vero/falso.
• Descrivere gli organi e le modalità della respirazione dei vertebrati.
• Gli organi della respirazione: branchie, cute, polmoni e sacche aeree.
T5
• Descrizione delle modalità di respirazione di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi.
• Osservazione e descrizione di immagini.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’Ambiente
• Descrivere gli organi e le modalità della nutrizione dei vertebrati.
• Gli organi della nutrizione e della digestione: bocca, faringe, stomaco, intestino.
T5
T5
T5
• Descrivere gli organi e le modalità della circolazione e dell’escrezione dei vertebrati.
• Descrizione delle modalità di nutrizione di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi.
• La dentatura dei mammiferi erbivori, carnivori e onnivori.
• Lettura e completamento di testi.
• La circolazione: il sangue, il cuore e i vasi sanguigni.
• La circolazione semplice o doppia, completa o incompleta.
• L’escrezione: reni, uretere, vescica e uretra.
• Questionari a risposta aperta e vero/falso.
T5
• Descrivere gli organi e le modalità del movimento dei vertebrati.
• Descrivere gli organi e le modalità della riproduzione dei vertebrati.
Unità di lavoro
Competenza chiave
• Lo scheletro e i muscoli.
• Descrizione delle modalità di movimento di pesci, anfibi, rettili, uccelli e anfibi.
• Lettura e completamento di testi.
• I gameti e le gonadi maschili e femminili.
• La fecondazione esterna e interna.
• Gli animali ovipari, ovovivipari e vivipari.
• I mammiferi monotremi, marsupiali e placentati.
• Osservazione e completamento di sequenze di illustrazioni.
SCIENZE Periodo: APRILE-MAGGIO
Girovagando
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività oggetti, mAteriAli e trAsformAzioni
T2
T3 T5
T3 T5
• Interpretare fenomeni osservati.
• Esperimento sull’importanza dell’acqua e del calore nella germinazione dei semi. osservAre e sperimentAre sul cAmpo
• Conoscere il concetto di ecosistema. • L’ecosistema: insieme di biotopo e comunità biologica.
• Individuare le componenti di un ecosistema. • Individuazione della componente abiotica e biotica di un ecosistema.
SCIENZE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività l’uomo, i viventi e l’Ambiente
T2
T3
T3
T3
• Riconoscere la relazione tra componente abiotica ed ecosistema.
• La componente abiotica e l’adattamento di piante e animali.
• Riflessione sull’incidenza delle condizioni fisiche (luce e temperatura) e delle condizioni chimiche (aria, suolo e acqua) sull’ecosistema.
• Riconoscere le strategie di adattamento di piante e di animali.
• Riconoscere la relazione tra componente biotica ed ecosistema.
• Individuare i rapporti tra le specie in un ecosistema.
T3
• Descrivere le catene alimentari.
T3
T5
T5
T6
• Descrivere le reti alimentari.
• Descrivere le piramidi alimentari.
• Descrivere i comportamenti animali.
T3
T3
T3
• Descrivere il linguaggio degli animali.
• Descrivere le attività della vita sociale degli animali.
• Osservazione e individuazione delle strategie di adattamento di piante e animali.
• La popolazione e l’habitat.
• La nicchia ecologica.
• Osservazione di ecosistemi e individuazione di popolazioni.
• Riflessione sui rapporti svantaggiosi tra le specie: la competizione, la predazione e il parassitismo.
• Riflessione sui rapporti vantaggiosi tra le specie: il commensalismo, il mutualismo e la protocooperazione.
• Gli anelli fondamentali della catena alimentare: i produttori, i consumatori e i decompositori.
• I livelli trofici delle catene alimentari.
• Completamento di catene alimentari.
• Individuazione di intrecci di catene alimentari.
• La piramide delle biomasse.
• La piramide dell’energia.
• La piramide dei numeri.
• Osservazione e riflessione sulle piramidi alimentari.
• L’etologia e Konrad Lorenz.
• Il comportamento innato e quello appreso.
• Riflessione sull’apprendimento degli animali: l’imprinting, l’apprendimento per assuefazione, per associazione, per prove ed errori, per imitazione e per intuito.
• La comunicazione animale.
• Classificazione di segnali in visivi, acustici, tattili, olfattivi e chimici.
• La difesa del territorio e l’aggressività, la ricerca del partner e il corteggiamento, la cura della prole.
• Osservazione e riflessione sulle attività sociali degli animali.
• Le società chiuse e le società aperte.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T1
T6
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
Contenuti e attività
• L’altezza e l’intensità dei suoni.
• La melodia.
MUSICA
Unità di lavoro
Competenza chiave
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T1
T2
T1
T2
• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Il timbro.
• L’armonia.
Contenuti e attività
MUSICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
T2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
T3 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Competenza chiave
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T3
T5
T1
T2
• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.

Contenuti e attività
• La durata dei suoni.
• Il ritmo.
Unità di lavoro
Competenza chiave
MUSICA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
T1
T2
T1
T2
• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
Contenuti e attività
• Ritmi binari, ternari, quaternari.
• Analisi strutturale di brani tratti dalla suite orchestrale di P.I. Tchaikosky: lo “Schiaccianoci”.
T4 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
T5 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
T6 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
T7 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Comunicativa… mente
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
esprimersi e comunicAre
T1
T1
T1
• Elaborare creativamente produzioni personali.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti.
T2
T2
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
• Dalla geometria alla fantasia: realizzazione di composizioni astratte con linee curve, rette parallele e perpendicolari.
• Realizzazione di manufatti: il diario di bordo, i fossili.
– Manipolazione di materiali di risulta; – sperimentazione e rielaborazione di tecniche diverse.
• Produzione di calligrammi con l’applicazione WordArt.
osservAre e leggere le immAgini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo.
T3
T4
• Giochi percettivi.
• Descrizioni di paesaggi, situazioni e immagini pubblicitarie: – analisi e individuazione delle caratteristiche principali.
comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Testimonianze delle civiltà mesopotamiche: la Ziggurat, i Giardini Pensili, la Porta di Babilonia. – Individuazione del luogo, contesto storico, stile, elementi caratteristici e funzione di una produzione artistica.
• La torre di Pisa: – osservazione e individuazione delle caratteristiche; – ricerca di informazioni; – rielaborazione personale.
ARTE E IMMAGINE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività
esprimersi e comunicAre
T1
T1
T1
• Elaborare creativamente produzioni personali.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti.
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
T2
T2
• Dalla geometria alla fantasia: realizzazione di composizioni astratte con i triangoli.
• Realizzazione di manufatti: il fiore portacandele. – Manipolazione di materiali di risulta; – sperimentazione e rielaborazione di tecniche diverse.
• Produzione di cartelloni e calligrammi con l’applicazione WordArt.
osservAre e leggere le immAgini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo.
• Giochi percettivi.
• Descrizioni di paesaggi e costumi: – analisi e individuazione delle caratteristiche principali. comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
T2
T4
T3
T4
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Lettura di un quadro d’autore, l’Inverno di A. Grimmer: – osservazione guidata; – giochi percettivi; – espressione del giudizio personale; – rielaborazione personale.
• Testimonianze della civiltà indiana: il Tajmahal. – Individuazione del luogo, contesto storico, stile, elementi caratteristici e funzione di una produzione artistica.
• Il Ponte di Rialto a Venezia: – osservazione e individuazione delle caratteristiche; – ricerca di informazioni; – rielaborazione personale.
T2 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
T3 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
T4 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività esprimersi e comunicAre
T1
T1
T1
• Elaborare creativamente produzioni personali.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti.
• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini.
T2
T2
• Dalla geometria alla fantasia: realizzazione di composizioni astratte con quadrilateri.
• Rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali: i vulcani.
• Realizzazione di manufatti con la pasta di mais: – produzione e modellaggio di materiali plasmabili.
• Produzione di cartelloni e calligrammi con l’applicazione WordArt. osservAre e leggere le immAgini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo.
• Giochi percettivi.
• Le immagini a scopo informativo: la nave fenicia. – Analisi e individuazione delle caratteristiche principali. comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
T4
T4
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Lettura di un quadro d’autore La primavera di S. Botticelli: – osservazione guidata; – giochi percettivi; – espressione del giudizio personale; – rielaborazione personale.
• La Fontana di Trevi a Roma: – osservazione e individuazione delle caratteristiche; – ricerca di informazioni; – rielaborazione personale.
ARTE E IMMAGINE – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività esprimersi e comunicAre
T1
T1
T2
T1 T2
T3
• Elaborare creativamente composizioni. • I colori primari e secondari, le gradazioni di colore: – realizzazione di opere di gruppo con i colori.
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti.
• Realizzazione di manufatti: l’erbario, composizioni di fiori secchi: – manipolazione di materiali vari. osservAre e leggere le immAgini
• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
• Conoscere il linguaggio dei fumetti.
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo.
• Giochi percettivi.
• Completamento di vignette con le onomatopee adatte.
• Le immagini a scopo informativo: il Palazzo Reale di Creta: – analisi e individuazione delle caratteristiche principali. comprendere e ApprezzAre le opere d’Arte
• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
T2
T4
T3
T4
• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
• Lettura di un’opera d’autore, Dedalo e Icaro di A. Canova:
– osservazione guidata; – espressione del giudizio personale; – rielaborazione personale.
• Testimonianze della civiltà micenea: la Porta dei Leoni a Micene: – individuazione del luogo, contesto storico, stile, elementi caratteristici e funzione di una produzione artistica.
• La Reggia di Caserta: – osservazione e individuazione delle caratteristiche; – ricerca di informazioni; – rielaborazione personale.
T2 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
T3 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
T4 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Competenza
eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
Competenza materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
T1 T4
T1
T2
T3 T7
T6
• Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: lanciare e afferrare.
• Giochi: la battaglia navale, prendi e colpisci.
• Percepire la frequenza cardiaca. • Misurazione della propria frequenza cardiaca a riposo e dopo un’attività motoria.
il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Esprimersi e comunicare con il corpo.
• L’uso del corpo per raccontare.
• La comunicazione: questionario.
• Le forme del linguaggio.
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della pallavolo.
• Gioco sportivo con la palla.
sAlute e benessere, prevenzione e sicurezzA
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico.
EDUCAZIONE FISICA
Competenza chiave
• Ideazione e compilazione del decalogo: “Una sana e corretta alimentazione per un sano sviluppo del proprio corpo”.
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
T1 T4
T1
T2
T3 T4
T7
T6
• Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: strisciare e rotolare.
• Prendere coscienza dei diversi gradi di tono muscolare e rilassamento.
• Esercizi sullo strisciare e rotolare.
• Esercizi di rilassamento ed esercizio del dondolo.
• Giochi: il burattino, la pietra. il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione.
• Realizzazione del teatro d’ombre con movimenti del corpo, singolarmente e in gruppo.
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della palla tamburello.
• Gioco sportivo con tamburello e palla.
sAlute e benessere, prevenzione e sicurezzA
• Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute.
• I benefici che si possono conseguire praticando attività sportive.
EDUCAZIONE FISICA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
T2 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
T3 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
EDUCAZIONE FISICA
Periodo:
Competenza in materia di consapevolezza espressione (p. ) Competenza chiave

traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
T1
T4
T1
T4
T2
T3 T7
T6
• Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: camminare e correre.
• Utilizzare le capacità condizionali.
• Giochi: – gioco delle torri; – gioco della fiducia; – gioco del corridoio.
• Esercizi sulla velocità di reazione, di esecuzione e sulla frequenza dei movimenti.
• Gare di velocità.
il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Muovere il corpo a ritmo di musica e differenziare gli spostamenti del gruppo nello spazio.
• Esecuzione di una semplice coreografia di gruppo con l’uso di danze: polka, Loot is dood (danza olandese).
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Risolvere problemi di pratica sportiva mediante l’accoglimento di correzioni e suggerimenti.
• Gioco: corsa con palline. sAlute e benessere, prevenzione e sicurezzA
• Assumere comportamenti salutistici.
• Valutazione della postura.
• Conoscenza di atteggiamenti o posizioni da evitare.
EDUCAZIONE FISICA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali C8 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività il corpo e lA suA relAzione con lo spAzio e il tempo
T1 T4
T2
T1
T7
T6
• Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre e saltare.
• Giochi: corsa nei sacchi, percorso a balzi. il linguAggio del corpo come modAlità comunicAtivo-espressivA
• Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione.
• Le danze folcloristiche e popolari: la tarantella.
il gioco, lo sport, le regole e il fAir plAy
• Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare (applicare regole).
• Giochi: – la settimana; – i quattro cantoni; – mosca cieca.
sAlute e benessere, prevenzione e sicurezzA
• Assumere stili di vita salutistici.
• Esperienze di benessere legate al libero gioco.
T4 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
T5 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
T6 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
T7 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

Competenza chiave
eriodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
Comunicativa… mente
scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
Competenza digitale C4 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
vedere e osservAre
T1 T3
T1 T3
T3 T6
T3 T6
T1 T6
• Riconoscere le caratteristiche e le funzioni degli strumenti di misurazione degli elementi del clima.
• Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di Word.
Contenuti e attività
• Le caratteristiche e le funzioni del termometro, del barometro, dell’anemometro, dell’igrometro, del pluviometro.
• Le funzioni dell’interfaccia di Word: la barra del titolo, la barra multifunzione, la barra di stato, la finestra del documento, il cursore e il righello.
prevedere e immAginAre
• Pianificare la fabbricazione di un anemometro. • La costruzione di un anemometro.
• Pianificare la fabbricazione di un pluviometro. • La costruzione di un pluviometro.
intervenire e trAsformAre
• Realizzare una tabella in cartoncino.
Unità di lavoro
TECNOLOGIA
Competenza chiave
traguardi competenze
T1
T1 T3
T1 T6
T1 T6
• La realizzazione di un cartoncino con la costruzione di una tabella in Word.
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
In giro per… le civiltà
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
Competenza digitale C4 (p. 93)
Obiettivi di apprendimento
vedere e osservAre
• Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei satelliti artificiali.
• Riconoscere le funzioni principali di SmartArt.
Contenuti e attività
• Le caratteristiche e le funzioni dei satelliti artificiali.
• Le funzioni della Piramide e del Ciclo di SmartArt.
• Le indicazioni da seguire per inserire una Piramide e un Ciclo di SmartArt in un testo.
prevedere e immAginAre
• Pianificare la costruzione di un istogramma con Word.
• La costruzione di un istogramma con Word.
intervenire e trAsformAre
• Realizzare interventi di decorazione del corredo scolastico.
• La realizzazione di etichette per decorare i quaderni.
TECNOLOGIA – Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
T2 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
T3 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Unità di lavoro
Competenza chiave
Competenza in scienze,

Competenza digitale C4 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
vedere e osservAre
T1
T1
T3 T6
T1 T6
T1 T6
• Riconoscere le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC.
• Riconoscere le funzioni principali dI WordArt.
Contenuti e attività
• Le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC.
• Esercitazioni con i tasti di scelta rapida.
• La realizzazione di nomi di maschere con gli effetti di WordArt.
prevedere e immAginAre
• Pianificare la costruzione di una bussola.
• Pianificare la costruzione di un areogramma con Word.
• La costruzione di una bussola.
• La costruzione di un areogramma con Word.
intervenire e trAsformAre
• Realizzare un biglietto in cartoncino.
Unità di lavoro
Competenza chiave
• La realizzazione di un biglietto pop-up con le forme geometriche di Paint.
TECNOLOGIA Periodo: APRILE-MAGGIO
Competenza in scienze, tecnologie e ingegneria (B) C3 (p. 92)
Competenza digitale C4 (p. 93)
traguardi competenze Obiettivi di apprendimento
vedere e osservAre
T1
T1
T4 T5
T1
• Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei pannelli solari.
• Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di PowerPoint.
Contenuti e attività
• Individuazione delle parti di un impianto con pannello solare termico.
• Individuazione delle parti di un impianto solare fotovoltaico.
• Le funzioni dell’interfaccia di PowerPoint: la barra del titolo, la barra multifunzione, la barra di stato, la finestra del documento.
prevedere e immAginAre
• Organizzare una gita utilizzando internet per reperire informazioni.
• La realizzazione di ricerche in internet.
• Le indicazioni da seguire per creare dei collegamenti ipertestuali.
intervenire e trAsformAre
• Utilizzare presentazioni con PowerPoint.
• Individuazione e scelta dei Temi nella progettazione di una presentazione.
• Individuazione e scelta di Animazioni nella progettazione di una presentazione.
T4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
T5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
T6 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio comportamento utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
T7 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

Periodo: PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività insieme!
Competenza in materia di cittadinanza C6 (p. 93)
dignità umAnA
• Conoscere la storia della Costituzione italiana.
• Riflettere sulla pari dignità sociale sancita nell’articolo 3 della Costituzione italiana.
• Riflettere sul principio di uguaglianza sancito nell’articolo 3 della Costituzione italiana.
• Lettura della storia della Costituzione italiana.
• Conversazioni collettive e questionario sulla Costituzione italiana.
• Conversazioni collettive e questionario sul concetto della pari dignità sociale.
• Lettura di una pagina di diario e domande a risposta aperta e chiusa.
• Conversazioni collettive sul principio di uguaglianza.
• Letture sull’uguaglianza senza distinzione di sesso.
• Titolazione di sequenze per illustrare l’origine della Giornata della Donna.
identità e AppArtenenzA
• Individuare i segni distintivi della propria identità.
• Conoscere i segni costituzionali dell’Unità d’Italia.
• Riconoscere comportamenti idonei per la propria salute e il proprio benessere.
• Lettura di una poesia e riflessioni sull’importanza del nome.
• Completamento di una carta d’identità.
• Lettura di poesie e documenti sulla bandiera italiana.
• Osservazione dell’emblema della Repubblica italiana: i suoi elementi e il loro significato.
• Indagini sulle abitudini di igiene orale della classe.
• Osservazione della struttura di un dente e delle sue parti.
• Lettura e questionario sulla carie.
• Elaborazione di un decalogo per una corretta prevenzione dentale.
Alterità e relAzione
• Riconoscere i ruoli e le funzioni nella famiglia.
• Riconoscere i ruoli e le funzioni nella scuola.
• Lettura di una poesia e riflessione sulla funzione della famiglia.
• Presentazione e descrizione della famiglia con individuazione dei compiti svolti dai genitori.
• Lettura di un brano e conversazione sulle cause più frequenti dei conflitti genitori-figli.
• Lettura del regolamento di istituto e individuazione dei diritti e dei doveri di alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici e dirigente scolastico.
• Lettura dell’articolo 34 della Costituzione italiana e riflessioni sul diritto allo studio.
pArtecipAzione
• Elaborare un regolamento di classe.
• Riconoscere e attuare comportamenti di rispetto dell’ambiente.
• Lettura di una favola sull’importanza della collaborazione.
• Realizzazione di un regolamento con comportamenti obbligatori, vietati e permessi.
• Lettura di una poesia e riflessione sull’importanza della tutela ambientale.
• Esercitazioni per realizzare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.
• Realizzazione di un’esperienza di compostaggio.
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
Contesto e obiettivi
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.
Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione.
Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica.
I principali scopi del quadro di riferimento sono:
a) individuare e definire le competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale; b) fornire uno strumento di riferimento europeo al servizio dei decisori politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale didattico, degli specialisti dell’orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pubblici per l’impiego e dei discenti stessi;
c) prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle competenze in una prospettiva di apprendimento permanente.
Competenze chiave
Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.
C2 Competenza multilinguistica (1)
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese (2).
C3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
A.
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
B.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.
(1) Mentre il Consiglio d’Europa utilizza il termine «plurilinguismo» per fare riferimento alle molteplici competenze linguistiche delle persone, i documenti ufficiali dell’Unione europea utilizzano il termine «multilinguismo» per descrivere sia le competenze individuali che le situazioni sociali. Ciò è dovuto, in parte, alla difficoltà di distinguere tra «plurilingue» e «multilingue» nelle lingue diverse dall’inglese e dal francese.
(2) È compresa anche l’acquisizione delle lingue classiche come il greco antico e il latino. Le lingue classiche sono all’origine di molte lingue moderne e possono pertanto facilitare l’apprendimento delle lingue in generale.
C4 Competenza digitale

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
C5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.
C6 Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
C7 Competenza imprenditoriale
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.
C8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.
Per Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a ciascuna competenza si rimanda alla USB Pen Drive allegata alla Guida dov’è riportato l’intero documento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

1 - Dalla geometria alla fantasia
2 - Tanti modi per comunicare
3 - Misuro e mi oriento
4 - Paesaggi di ieri e di oggi
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
Matematica: Rafforzare i concetti di incidenza, perpendicolarità e parallelismo.
Italiano: Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
Arte e immagine: Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo.
Storia: Conoscere il sistema di scrittura dei Sumeri.
Educazione fisica: Esprimersi e comunicare con il corpo.
Geografia: Localizzare la posizione di luoghi sul planisfero.
Matematica: Utilizzare il piano cartesiano per individuare punti dati.
Italiano: Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi.
Arte e immagine: Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
Storia: Conoscere le principali opere architettoniche dei Babilonesi.
PROPOSTE DI RACCORDI INTERDISCIPLINARI
1 - Civiltà egizia
2 - Civiltà indiana
3 - La salute in… rima
4 - Grafici per tutti i gusti
5 - I triangoli
competenze chiave *
Periodo: DICEMBRE-GENNAIO
Italiano: Leggere e individuare le sequenze in testi narrativi.
Arte e immagine: Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo.
Storia: Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Egizi.
Italiano: Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.
Arte e immagine: Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.
Storia: Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà indiana del passato con quella attuale.
Italiano: Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore.
Educazione fisica: Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute.
Italiano: Organizzare un’esposizione su un argomento in modo completo, chiaro e ordinato.
Matematica: Rappresentare e leggere istogrammi e ideogrammi.
Geografia: Leggere e interpretare areogrammi e istogrammi sul sistema idrografico italiano.
Tecnologia: Pianificare la costruzione di un istogramma con Word.
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
Matematica: Classificare i triangoli rispetto ai lati.
* Le competenze chiave sono elencate alle pagine 92-93.
competenze chiave *
1 - Animali tra fantasia e realtà
2 - Civiltà ebraica
3 - Civiltà fenicia
4 - Gli areogrammi
5 - I vulcani
6 - I quadrilateri

Italiano: Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi.
Scienze: Classificare gli animali.
Italiano: Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi.
Storia: Ricavare informazioni da versetti del libro dell’Esodo.
Arte e immagine: Osservare immagini, analizzarne gli aspetti e coglierne lo scopo.
Storia: Conoscere le principali invenzioni dei Fenici.
Matematica: Rappresentare e leggere l’areogramma.
Geografia: Leggere e costruire areogrammi, istogrammi e tabelle sul sistema orografico italiano.
Tecnologia: Costruire areogrammi.
Italiano: Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
Geografia: Conoscere e descrivere i paesaggi montuosi dell’Italia.
Arte e immagine: Elaborare creativamente produzioni personali.
Matematica: Classificare i quadrilateri.
PROPOSTE DI RACCORDI INTERDISCIPLINARI Periodo: APRILE-MAGGIO
1 - Rispetto l’ambiente
Italiano: Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo.
Arte: Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio artistico e culturale italiano.
Geografia: Conoscere gli elementi di paesaggi culturali.
Scienze: Riconoscere le relazioni tra componente biotica ed ecosistema.
competenze chiave *
2 - Civiltà cretese e micenea
3 - La percentuale
4 - Regole per stare bene
Italiano: Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
Arte e immagine: Sviluppare il gusto per l’opera d’arte.
Storia: Ricavare informazioni da immagini di opere architettoniche della civiltà micenea.
Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Cretesi.
Geografia: Leggere e costruire areogrammi, ideogrammi, istogrammi e tabelle sull’economia italiana.
Matematica: Leggere, calcolare e interpretare la percentuale.
Italiano: Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività.
Educazione fisica: Assumere stili di vita salutistici.
* Le competenze chiave sono elencate alle pagine 92-93.

Le Indicazioni metodologiche predisposte per ogni disciplina sono accompagnate dal relativo elenco dei “Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria” così come riportati nelle nuove Indicazioni nazionali. Ciascun traguardo è contrassegnato dalla lettera T .
L’ultimo biennio della scuola di base è da considerarsi un ponte tra l’infanzia e l’adolescenza, tra le esperienze vissute nella scuola primaria e le discipline della scuola secondaria. In questo periodo vanno consolidate le abilità acquisite nei precedenti anni scolastici, tenendo presenti gli impegni che gli alunni dovranno affrontare nei prossimi anni. In che modo orientare, allora, l’azione didattica? Ci sembra opportuno mirare al raggiungimento di obiettivi sostanziali, all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze basilari. È superfluo e dannoso sottoporre a enormi sforzi i bambini, proponendo contenuti che non sono alla loro portata né destano il loro interesse. Il percorso delineato si basa sui concreti bisogni linguistici degli alunni, parte dai fatti linguistici e approda all’approfondimento, alla puntualizzazione delle conoscenze, privilegiando l’attività ludica. Per esigenze espositive, le proposte che si riferiscono alle abilità di base sono presentate separatamente, ma si integrano con continui richiami.
Compito della scuola è formare buoni ascoltatori, perciò è importante che l’insegnante osservi l’atteggiamento e il comportamento dei bambini per coglierne le reazioni: per tenere desta l’attenzione degli ascoltatori, evitiamo interventi troppo lunghi, vivacizziamo le lezioni usando toni di voce coinvolgenti. Poniamo domande stimolanti, sollecitiamo il confronto e la discussione in classe delle varie ipotesi avanzate, in modo che tutti possano contribuire all’individuazione della risposta esatta.
Creiamo un clima favorevole alla comunicazione, in cui ogni bambino abbia l’opportunità di esprimersi e impari a saper ascoltare: questo è il metodo più semplice e diretto per acquisire informazioni e notizie.
Durante le conversazioni, opportunamente stimolate, l’insegnante:
◆ svolge il delicato ruolo di moderatore stimolando ogni alunno a intervenire nello scambio verbale in modo adeguato rispetto alle diverse situazioni comunicative e nell’osservanza delle regole della conversazione collettiva;
◆ promuove l’acquisizione di strategie per l’ascolto, come la ricerca della posizione più adatta;
◆ guida gli alunni a mantenere l’attenzione per periodi di tempo sempre più lunghi;
◆ stimola ciascun alunno a interagire in modo attivo e creativo con i compagni, superando il classico schema della lezione frontale;

◆ crea situazioni comunicative in cui il bambino faccia esperienza del parlare per chiedere, convincere, riferire, descrivere, spiegare.
Per ogni bimestre sono proposti dei nuclei tematici che si collegano anche alle altre discipline e sono introdotti dall’ascolto e/o lettura di brani, per accendere la curiosità degli alunni verso un determinato argomento.
Il percorso che proponiamo è il seguente:
◆ con domande stimolo l’insegnante focalizza l’attenzione degli alunni sugli aspetti fondamentali del brano ascoltato e/o letto;
◆ l’insegnante incoraggia gli alunni a riferire vissuti e opinioni personali relativi all’argomento trattato e nella discussione fa confrontare i diversi punti di vista;
◆ gli alunni leggono autonomamente brani relativi al tema affrontato e ne riferiscono il contenuto con il supporto di mappe, schemi e tabelle;
◆ con il supporto di immagini e/o di modelli guida elaborano testi di diverso tipo;
◆ approfondiscono autonomamente gli argomenti e pianificano l’esposizione con il supporto di mappe, schemi e tabelle, in modo che essa risulti chiara, comprensibile, efficace.
Il percorso didattico proposto mira essenzialmente a combattere la pessima abitudine della lettura passiva: dobbiamo evitare che i nostri alunni leggano in modo meccanico, rendendo tale azione praticamente improduttiva. Per attirare l’attenzione, scegliamo testi con graduali difficoltà (anche l’eccessiva semplicità del contenuto o delle consegne può risultare controproducente), che presentino elementi spiritosi, sorprendenti, comici. La lettura deve costituire lo stimolo per attivare la riflessione e la discussione su temi adeguati all’età della classe e rilevanti ai fini dello sviluppo della personalità di ogni singolo alunno.
A livello strumentale, l’alunno deve perfezionare le diverse tecniche di lettura: espressiva e silenziosa, individuale e collettiva. Egli deve giungere alla consapevolezza che esistono diversi tipi di testo perché diverse sono le esigenze che la lettura deve soddisfare:
◆ articoli di giornale, avvisi, locandine, manifesti consentono di acquisire informazioni;
◆ ricette, istruzioni, regolamenti per fare o usare qualcosa;
◆ libri scolastici, enciclopedie, manuali, vocabolari per imparare;
◆ racconti, fumetti, fiabe, favole, miti, leggende e poesie per divertirsi, per il puro e semplice gusto di leggere.
Per fissare e assimilare i concetti fondamentali espressi dal testo, risultano utili le varie tecniche per intervenire graficamente su di esso: sottolineature, evidenziazioni, schematizzazioni, tabelle e mappe sono strumenti di straordinaria efficacia.

Correggiamo eventuali scorrette abitudini di lettura, per esempio:
◆ invitiamo i bambini ad appoggiarsi allo schienale della sedia, a non curvare la schiena sul libro;
◆ il libro deve trovarsi a opportuna distanza;
◆ assicuriamoci che l’illuminazione dell’ambiente sia adeguata.
In ogni bimestre sono suggeriti esercizi per migliorare la capacità di lettura:
◆ giochi per lo sviluppo della memoria e della percezione visiva;
◆ giochi per acquisire velocità nella lettura;
◆ giochi che richiedono una partecipazione attiva dell’alunno (parole crociate, individuazione di affermazioni vere/false, completamenti di cloze, eliminazione di parole/frasi incongruenti, ecc.).
Infine tutte le attività di rielaborazione del testo sollecitano la comprensione e l’approfondimento del testo, perciò proponiamo regolarmente l’elaborazione di: riassunti, parafrasi, trasformazioni del discorso da diretto in indiretto e viceversa, trasformazioni di un testo in un’altra tipologia testuale.
Scrittura
Le proposte riguardanti la scrittura si sviluppano parallelamente a quelle di lettura: gli alunni sono stimolati a produrre elaborati di vario tipo dopo aver letto e analizzato i diversi generi testuali.
Le attività di scrittura devono avere un riscontro pratico: la scuola deve essere il laboratorio in cui gli alunni sperimentano le tecniche che utilizzeranno nella vita di tutti i giorni.
È opportuno guidarli gradualmente ad analizzare e a produrre diversi tipi di testo, a seconda dello scopo che intendono conseguire nella realtà quotidiana:
◆ stabilire rapporti con gli altri;
◆ esprimere emozioni e stati d’animo,
◆ rappresentare la realtà;
◆ immaginare mondi fantastici
Saranno proposte esercitazioni per elaborare:
◆ testi descrittivi, soggettivi e/o oggettivi, che presentano le caratteristiche di persone, animali, ambienti, paesaggi;
◆ testi narrativi, che hanno lo scopo di conservare la memoria e/o informare di un fatto reale o immaginario;
◆ testi regolativi, che suggeriscono comportamenti e procedure da seguire;
◆ testi espositivi, che trasmettono notizie, illustrano argomenti o espongono attività svolte, delle quali si presentano strumenti, metodi e tempi.
Allo stesso tempo, gli alunni saranno stimolati a esprimere per iscritto:
◆ sentimenti, emozioni e stati d’animo personali;

◆ opinioni, giudizi, commenti relativi a esperienze individuali e/o collettive.
Nell’ultimo biennio della scuola primaria, i bambini hanno ormai consolidato la strumentalità della scrittura, per cui possiamo introdurre l’uso dei fogli con un unico rigo. Inoltre sarà dato uno spazio maggiore alle attività di rielaborazione dei testi, in modo da preparare adeguatamente gli alunni alla scuola media.
Oltre a sperimentare tecniche diverse per riassumere, essi saranno impegnati anche nell’elaborazione di parafrasi, poiché, sia in ambito scolastico che nella vita di ogni giorno, sono spesso chiamati a svolgere queste due operazioni.
Ma che cosa significa parafrasare un testo? Qual è la differenza tra parafrasi e riassunto?
Le due tecniche hanno indubbiamente delle caratteristiche comuni:
◆ implicano la comprensione profonda del testo;
◆ non modificano in alcun modo il contenuto e il significato del testo originario.
Sul piano operativo, “riassumere” significa “ridurre”, “rielaborare in forma più breve” i concetti espressi da un testo; “parafrasare” significa “riscrivere”, “rielaborare le informazioni” in una forma diversa da quella originaria, usando parole e espressioni della lingua quotidiana.
Nell’ambito scolastico la parafrasi si utilizza per spiegare il contenuto di una poesia con termini più familiari o per esporre con parole proprie il contenuto di un paragrafo letto di storia o geografia, ecc. Allenandosi a parafrasare, gli alunni acquisiscono l’abitudine a modificare parole, a riferire e/o riscrivere informazioni in modi diversi, rafforzando così la propria abilità di espressione.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
È ormai accertato che lo studio mnemonico di astratte norme grammaticali non garantisce un uso corretto della lingua sia scritta che orale. Le strutture fondamentali della lingua vengono acquisite in maniera più immediata sperimentandole in concreto. A ciò si aggiunga che la grammatica non suscita affatto l’interesse degli alunni. Eppure il rispetto delle norme linguistiche rende possibile la corretta comunicazione con gli altri. La padronanza dei meccanismi linguistici consente di esprimere efficacemente il proprio pensiero, accresce la capacità di comunicare della persona.
Perciò un valido progetto didattico non può prescindere dalla stretta relazione tra norma teorica e concreta realtà linguistica, in una dimensione ludica.
Per concludere, è necessario sottolineare che l’acquisizione delle regole della lingua è lenta e graduale e che la pratica della lettura incide in maniera decisiva su tale processo: il bambino che legge spesso e con piacere acquisisce maggiore familiarità con la lingua scritta e più velocemente ne scoprirà e comprenderà le regole.

ITALIANO: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
T2 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
T3 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
T4 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
T5 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
T6 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
T7 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
T8 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
T9 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
T10 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
Durante quest’anno scolastico lo studio della Storia è molto stimolante per i nostri alunni, che saranno condotti gradualmente a conoscere le più antiche civiltà. Pertanto, la programmazione di Storia per la classe quarta si presenta significativamente articolata affinché lo studio di questa disciplina avvenga in modo sistematico e, quindi, in grado di indurre l’alunno a imparare a costruire efficaci quadri di civiltà. Conseguentemente elaboriamo la nostra progettazione curriculare sulla base di alcune indicazioni metodologiche che favoriscano un apprendimento della Storia significativo, e non meccanico, in cui i nostri alunni deliberatamente cerchino di connettere e integrare le nuove informazioni all’interno di una struttura di conoscenze che già posseggono. Fin dalle prime attività proposte si sottolinea l’importanza dell’individuazione e dell’analisi delle fonti: dallo Stendardo di Ur dei Sumeri fino alla corazza di Dendra dei Micenei, passando per i meravigliosi gioielli del faraone Tutankhamon o i raffinati affreschi dei palazzi minoici, presentiamo agli alunni fonti significative delle varie civiltà e stimoliamoli, anche attraverso ricerche in internet, a cercare immagini di reperti e siti archeologici dei popoli che via via essi studieranno sollecitandoli a osservarle e a descriverle, ma, soprattutto, a utilizzarle per ricavarne informazioni e conoscenze.

L’attività di esplorazione, anche se solo sul web, favorirà un approccio sicuramente più dinamico e interattivo con quest’affascinante disciplina. Nello studio della Storia è necessario cogliere sempre la relazione tra causa ed effetto, sollecitando i nostri alunni a domandarsi il perché degli eventi e a individuarne le conseguenze. Importante è l’utilizzo di carte geo-storiche, sia per una corretta collocazione nello spazio del popolo studiato, sia perché è imprescindibile il continuo riferimento alle caratteristiche geografiche dei territori in cui le civiltà si sviluppano. Oltre a favorire un indispensabile approccio interdisciplinare con la Geografia, in relazione agli elementi fisici, naturali e antropici di un ambiente, l’utilizzo delle carte geo-storiche consente una contestualizzazione dei fatti storici che aiuta gli alunni a cogliere anche nella loro realtà quotidiana l’indissolubile collegamento tra l’uomo e l’ambiente in cui vive.
Al termine della presentazione di ciascun popolo sollecitiamo gli alunni, anche attraverso giochi, come i cruciverba o i crucipuzzle, a un riepilogo significativo di quanto appreso, al fine di aiutarli a consolidare un sistema di conoscenze sui quadri di civiltà dei popoli studiati. Utili e opportune, nello studio della Storia, sono le attività di cooperative learning con cui gli alunni lavorano in piccoli gruppi eterogenei per migliorare reciprocamente il loro apprendimento: ciascun gruppo può avere il compito di realizzare cartelloni murali o prodotti digitali (testi in Word, presentazioni in PowerPoint, ipertesti) su un aspetto di una civiltà, utilizzando in modo opportuno i numerosi Approfondimenti presenti nella Pen Drive allegata alla Guida.
I lavori di ricerca, l’attività di elaborazione e la presentazione finale alla classe dei lavori prodotti da ciascun gruppo favoriranno una costruzione attiva, critica e democratica del sapere, nel cui apprendimento ogni alunno ha un ruolo attivo. Fondamentale è che gli alunni comprendano come la conoscenza storica è sempre sottoponibile a revisione. Infatti, il ritrovamento di un nuovo reperto o la scoperta di un sito archeologico avvolto dalla leggenda, come è avvenuto per la mitica città di Troia, possono anche indurre a riscriverne, o a scriverne per la prima volta, la storia.
STORIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
T2 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
T3 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
T4 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
T5 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
T6 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
T7 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
T8 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
T9 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
T10 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Lo studio della Geografia, durante quest’anno scolastico, è finalizzato alla conoscenza degli elementi, soprattutto fisici, che caratterizzano il paesaggio italiano e al consolidamento nell’uso dei riferimenti topologici, i punti cardinali e le coordinate geografiche, che consentono all’alunno una sicura consultazione delle carte geografiche.
È fondamentale attivare nei nostri alunni una buona capacità di osservazione dell’ambiente e molteplici devono essere le occasioni per stimolare, attraverso l’osservazione dal vero o di immagini, la descrizione di luoghi utilizzando in modo appropriato il linguaggio della geo-graficità.
Costante deve essere il ricorso sia alla consultazione di carte geografiche, di immagini fotografiche o satellitari, sia all’utilizzo di mezzi più innovativi, come Google Earth che, con l’ausilio delle sempre più diffuse lavagne multimediali, consente una visualizzazione reale dei luoghi geografici oggetto di studio.
È importante anche che gli alunni comprendano che lo spazio geografico è un sistema territoriale in cui gli elementi naturali sono collegati in un rapporto di interdipendenza con gli elementi antropici. È, pertanto, essenziale non solo che essi comprendano che l’uomo modifica lo spazio per adeguarlo alle proprie esigenze, ma che siano anche stimolati a individuare le tracce del passato presenti nel territorio nazionale.
La ricchezza di paesaggi in cui sono riconoscibili segni del passato della storia italiana è un’occasione imperdibile per educare gli alunni anche alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese.
Diversi sono i Laboratori presenti nelle proposte metodologiche di quest’anno scolastico. L’attività laboratoriale, infatti, attraverso un approccio concreto e attivo al sapere, favorisce negli alunni l’analisi, la problematizzazione e la progettazione condivisa e partecipata di qualsiasi ricerca. La realizzazione di plastici di paesaggi geografici, di atlanti murali corredati da efficaci didascalie, la realizzazione di presentazioni o ipertesti con PowerPoint sicuramente sono efficaci strumenti per costruire adeguate competenze geografiche.
GEOGRAFIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
T2 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
T3 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
T4 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.).
T5 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
T6 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
T7 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Giunti in classe quarta, i bambini hanno acquisito le abilità matematiche di base che devono essere perfezionate, potenziate e arricchite attraverso un percorso in cui si promuove la naturale propensione all’apprendimento inteso come momento spontaneo di ricerca. È importante sviluppare sia il pensiero convergente inteso come capacità di utilizzare e organizzare le proprie conoscenze, di applicare regole ed eseguire istruzioni in modo preciso, sia il pensiero divergente, incoraggiando i bambini a elaborare nuove strategie di risoluzione dei problemi.
Con la guida dell’insegnante i bambini devono acquisire sempre di più il linguaggio specifico della disciplina cercando di correggere le approssimazioni e assimilando invece le forme e le tipiche formule sintetiche della comunicazione logico-matematica (simboli, termini specifici, definizioni, rappresentazioni grafiche).
L’insegnante guida la classe in modo tale che tutti partecipino attivamente alle esperienze didattiche, adottando varie tecniche di gioco, esperienze di tipo manipolativo con materiale strutturato e non, fino alla costruzione di modelli. Tali attività saranno propedeutiche alla graduale e progressiva acquisizione di strumenti logico-matematici più formalizzati come la rappresentazione grafica e simbolica.
Si cercherà di alternare momenti di applicazione individuale a momenti di impegno collettivo per rendere gli argomenti trattati più piacevoli e accendere una sana competizione.
Gli argomenti inclusi in ogni bimestre vengono trattati in una prospettiva di difficoltà crescente e per ciascun bimestre i nuclei tematici, pur essendo proposti separatamente, obbediscono a una logica di integrazione sia disciplinare che metodologia e didattica.
L’insegnante procede a un riesame delle quattro operazioni con i numeri naturali, analizzandone specificità e tecniche di calcolo. Affronta la conoscenza delle frazioni e dei numeri decimali. Comincia l’approccio graduale all’esecuzione delle quattro operazioni con i numeri decimali, per cui deve riservare ampio spazio alle esercitazioni.
La risoluzione di problemi è proposta come modalità di lavoro in ogni ambito sia della ricerca matematica sia come modello di comportamento per la soluzione di problemi pratici. Infatti nel percorso didattico proposto si consigliano numerose esercitazioni su problemi reali.
Spazio e figure
Le proposte riguardanti la geometria rafforzano la conoscenza dei concetti di linee rette, semirette, segmenti e di angolo. Continuano ad affrontare lo studio delle principali figure piane fino al calcolo del perimetro e dell’area, che prevede l’uso di unità di misura specifiche (di lunghezza e di superficie) che i bambini impareranno a utilizzare unitamente alle unità di misura di peso, di capacità e di tempo.

La logica delle proposizioni viene rivista e ampliata con l’introduzione di nuovi connettivi e riprendendo concetti già conosciuti.
In statistica vengono analizzati vari modelli di rappresentazione in modo tale da abituare i bambini a imparare a leggere prontamente grafici di diverso tipo.
Nel campo della probabilità si affinano inoltre le capacità previsionali di un evento e la relativa descrizione numerica, resa possibile dalla conoscenza più approfondita delle frazioni.
MATEMATICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
T2 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
T3 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
T4 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
T5 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
T6 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
T7 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
T8 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
T9 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
T10 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
T11 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Lo studio delle Scienze è sempre particolarmente interessante per gli alunni, che naturalmente sono incuriositi da ciò che accade nella realtà e spesso formulano spontaneamente domandeproblema sui fenomeni che osservano e ne cercano risposte. È importante, quindi, che in tutte le attività suggerite dalle Proposte di Scienze la costruzione delle conoscenze avvenga partendo da esperienze reali, quali l’osservazione dal vero del cielo, di una pianta o di un animale, oppure la realizzazione di semplici esperimenti come quelli proposti nella presente Guida.

Gli alunni devono essere guidati ad interpretare le esperienze reali imparando progressivamente a utilizzare il metodo scientifico-sperimentale, in cui i fenomeni osservati sono spiegati con ipotesi da assoggettare sempre alla verifica degli esperimenti. Attraverso una metodologia attiva, che li veda protagonisti del loro apprendimento, gli alunni strutturano un percorso di conoscenze con cui costruiscono una rete di concetti significativi che, pur nella diversità di contenuti, sono unificati dalla medesima impostazione metodologica. È fondamentale favorire, partendo sempre dall’osservazione, sia l’elaborazione delle prime classificazioni animali e vegetali, cogliendo somiglianze e diversità, sia l’utilizzo di un adeguato linguaggio disciplinare nella descrizione dei fenomeni e degli organismi osservati. Le attività laboratoriali proposte per quest’anno scolastico sono molteplici e svilupperanno anche fondamentali abilità sociali, come la capacità di riconoscere il punto di vista altrui e la capacità di cooperare.
Numerosi e di facile realizzazione sono gli esprimenti suggeriti, che favoriranno un approccio concreto e divertente ai concetti, anche a quelli più astratti. Le varie classificazioni di piante e animali rintracciabili nelle Proposte di Scienze e i dettagliati Approfondimenti contenuti nella Pen Drive, con l’ausilio di immagini e filmati da ricercare in internet, possono essere utilizzati dagli alunni per la realizzazione di efficaci album cartacei o digitali sulle piante o sugli animali studiati che stimoleranno la loro capacità di organizzare le conoscenze apprese, basilare abilità metacognitiva.
SCIENZE: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
T2 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche in conformità a ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
T3 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
T4 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
T5 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
T6 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.
T7 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
T8 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
T9 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

L’insegnamento della musica nella scuola primaria esige, forse più che per le altre discipline, un approccio metodologico attivo e operativo, in grado di suscitare negli alunni interesse e curiosità. In ciò risiedono senso e significato dell’espressione “pratica musicale” a cui sempre più spesso (come sottolineato anche nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012: “l’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze”) la scuola è esortata a riferirsi nel tentativo di avvicinare alla musica gli alunni, anche e soprattutto di scuola primaria, e di favorire attraverso essa la maturazione di conoscenze, abilità e competenze anche in ambito matematico, linguistico-espressivo, socio-affettivo e relazionale. Tuttavia, la specificità della disciplina mette a dura prova anche le migliori intenzioni inducendo spesso scoraggiamenti o, nella migliore delle ipotesi, sterili espedienti didattici. La buona volontà e uno strumento operativo concreto e agile possono, però, fare molto sia per aiutare l’insegnante nella sua attività didattica sia per avvicinare i bambini al linguaggio musicale. Le proposte e le relative schede operative della presente guida mirano a sviluppare negli alunni, rispetto alla musica, una maggiore consapevolezza e una fruizione più critica. Sarà importante, in tal senso, che gli ascolti, la produzione e la riflessione stessa sui fenomeni sonori siano guidati con cura e attenzione. In continuità con la programmazione della Guida Unica della terza classe, si è voluto approfondire il discorso relativo agli elementi strutturali del discorso musicale (melodia, armonia, ritmo) arricchendo ogni argomento con specifiche indicazioni di ascolto. Si è inoltre ritenuto opportuno analizzare con maggiore attenzione le caratteristiche del suono (durata, altezza, intensità e timbro), dedicando a ognuna di esse una specifica attività. Per agevolare il lavoro dei docenti, alla fine delle varie sezioni dedicate alle proposte didattiche, accanto al richiamo alle relative schede operative sono state indicate le risposte corrette e ulteriori informazioni.
MUSICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
T2 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
T3 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
T4 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
T5 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
T6 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
T7 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

La padronanza del linguaggio iconico, insieme a quello corporeo e musicale, contribuisce alla formazione globale e armonica della personalità dell’alunno. Come previsto dalle Indicazioni ministeriali, il percorso di Arte e immagine mira al conseguimento di competenze trasversali comunicative di comprensione e di produzione. Principalmente i bambini devono acquisire la consapevolezza che per comunicare, oltre alle parole, si possono usare le immagini, le forme e i colori. Attraverso la didattica laboratoriale, essi sperimentano la creatività, sviluppano la sensibilità artistica e le capacità di esprimersi e comunicare usando le tecniche proprie del linguaggio visuale. Il percorso proposto suggerisce in ogni bimestre una molteplicità di esperienze:
◆ l’esplorazione di forme, oggetti, immagini, per sviluppare la memoria e la percezione visiva;
◆ la manipolazione di materiali diversi, per sviluppare la manualità fine;
◆ il modellaggio di materiali plastici e l’utilizzo di nuove tecniche, per esprimersi in modo personale;
◆ la realizzazione di opere collettive, per lo sviluppo delle capacità collaborative;
◆ l’esplorazione e la conoscenza dei beni del patrimonio artistico di varie epoche e culture, per affinare il gusto estetico.
A livello cognitivo, i giochi percettivi contribuiscono all’acquisizione delle competenze dell’osservare, analizzare, riflettere, discriminare.
L’operatività stimola gli alunni a ricercare modalità e strategie compositive non convenzionali, a sviluppare la capacità di progettazione, a cooperare in vista di un prodotto finale, in cui ognuno è responsabile sia del proprio contributo che dell’insieme degli interventi.
In quest’ultimo biennio è opportuno sollecitare la conoscenza dei beni artistici e culturali, a partire dal territorio, per apprezzare e rispettare opere appartenenti a diverse epoche e culture che sono patrimonio dell’umanità. L’approccio all’opera d’arte deve avvenire in forma ludica: ai bambini deve essere data la possibilità di osservare, colorare, rielaborare, trasformare la riproduzione dell’opera d’arte. Sviluppando la sensibilità estetica si creano le basi per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale.
In un’ottica interdisciplinare, numerosi sono gli agganci alle varie discipline.
I fumetti, le descrizioni di ambienti e paesaggi sono argomenti presenti sia nelle proposte di Italiano che in quelle di Arte e immagine e vengono trattati da diversi punti di vista che finiscono con l’integrarsi a vicenda. Elementi geometrici sono analizzati in Matematica e contemporaneamente costituiscono la base di composizioni libere, non stereotipate, in Arte e immagine.
Continui e frequenti sono richiami con le proposte di Storia: i bambini avranno la possibilità, giocando, di approfondire la conoscenza di forme artistiche di antiche e lontane civiltà.

ARTE E IMMAGINE: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
T2
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip ecc.)
T3 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
T4 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
L’Educazione fisica, in sinergia con le altre discipline, considera il movimento al pari di altri linguaggi e si inserisce perfettamente nel processo di formazione e maturazione dell’autonomia personale dell’alunno. Essa si allinea in modo incisivo nell’educare al vivere sociale concorrendo allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, promuovendo lo sviluppo dell’alunno sul piano psicomotorio e contribuendo alla formazione di un’immagine di sé completa e positiva. Per stimolare gli alunni a dare il meglio di sé le attività motorie proposte devono essere calibrate per impegno e difficoltà. Esse non devono risultare troppo banali né comportare un grado eccessivo di complessità e devono essere vissute in un clima relazionale positivo. Il gioco rappresenta sempre un’importante strategia didattica per sviluppare le funzioni psicomotorie e rappresenta inoltre un’occasione privilegiata per stimolare la maturazione dell’area sociale della personalità perché implica competenze relazionali, rispetto dell’altro, rispetto delle regole e sviluppo della capacità di iniziativa e di soluzione dei problemi.
L’utilizzo dei giochi competitivi proposti quest’anno ha precise finalità di tipo comportamentale e mira sia alla conoscenza e al rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive sia all’organizzazione democratica del gruppo in cui ognuno può sperimentare diversi ruoli e collaborare con gli altri imparando a controllare emotivamente una vittoria o una sconfitta.
L’insegnante formula chiaramente la consegna di un gioco o di un esercizio sottolineando lo scopo dell’azione, lasciando liberi gli alunni di organizzare la propria motricità e non suggerendo il modo in cui essi possono risolvere piccoli problemi ma spronandoli invece a diversificare ed arricchire le risposte motorie.
È compito dell’insegnante creare un clima favorevole alla comunicazione e alla partecipazione attiva di tutti gli alunni.
In ogni bimestre sono proposti nuclei tematici che si collegano tra loro e anche ad altre discipline.
La mancanza della palestra non può costituire un alibi per non fare attività. È sufficiente uno spazio all’aperto da utilizzare nella stagione consentita, anche se attrezzato con materiale di fortuna.
Traguardi per lo sviluppo

EDUCAZIONE FISICA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
T2 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
T3 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
T4 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
T5 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
T6 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
T7 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
È fondamentale che lo studio della Tecnologia stimoli nell’alunno una metodologia operativa caratterizzata dalla centralità della progettazione mediante la quale l’alunno, di fronte a un problema osservato, progetta un percorso per risolverlo utilizzando le risorse a disposizione. Le Proposte di Tecnologia durante quest’anno scolastico si muovono, perciò, in due direzioni:
◆ da una parte stimolano gli alunni a conoscere e, ove possibile, a riprodurre strumenti che l’uomo ha progettato e realizzato per migliorare le proprie condizioni di vita;
◆ dall’altra favoriscono una rielaborazione delle conoscenze acquisite attraverso un utilizzo consapevole e approfondito del linguaggio informatico.
TECNOLOGIA: Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
T1 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
T2 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
T3 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
T4 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
T5 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
T6 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio comportamento utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
T7 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

Le proposte del percorso di Educazione civica sono organizzate attorno ai tre nuclei concettuali indicati dalle linee guida per l’insegnamento di questa disciplina:
◆ Costituzione;
◆ Sviluppo sostenibile;
◆ Cittadinanza digitale.
Tutti gli obiettivi di apprendimento suggeriti sono funzionali alla promozione negli alunni e nelle alunne di una cittadinanza attiva che essi devono progressivamente imparare a esercitare nelle più disparate circostanze. Fondamentale è promuovere la consapevolezza di appartenere a diverse “formazioni sociali ove si svolge la propria personalità” (art. 2 della Costituzione italiana), dalla famiglia alla scuola, alla società nel suo complesso, allo Stato.
Compito del percorso di Educazione civica è insegnare a scegliere i basilari valori costituzionali come guida delle proprie azioni, improntando la propria partecipazione alla realtà sociale a principi come la pari dignità di tutti gli esseri umani, l’eguaglianza, la libertà nelle sue varie accezioni, il rispetto dell’ambiente ecc.
In ogni azione è importante sollecitare un forte senso della legalità, che aiuti a comprendere che le norme (che riguardino il regolamento di classe o il mondo virtuale o la raccolta differenziata) sono garanzia di uguaglianza e di sviluppo.
In una società multietnica e multiculturale come la nostra, è imprescindibile educare alunni e alunne alla tutela della diversità, aiutandoli a vivere esperienze di collaborazione e di solidarietà in cui il rispetto, l’accettazione e il confronto con l’altro siano preziose occasioni di crescita e di sviluppo collettivo.

U A R T A

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T1 , T3 , T6 , T8 e T10 (v. pag. 100).
Il mese di settembre è dedicato, come di consueto, all’accertamento dei livelli di partenza della classe. Tale attività di documentazione è necessaria all’insegnante per impostare adeguatamente il proprio piano di lavoro.
Il percorso didattico della classe quarta prevede, infatti, il possesso di alcuni fondamentali prerequisiti su cui devono innestarsi gli apprendimenti successivi.
Le prove da somministrare devono essere inerenti alle conoscenze, competenze e abilità più qualificanti del precedente anno scolastico e consentono anche di riprendere il dialogo educativo già iniziato e interrotto dalla pausa estiva.
• Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente T1 Accogliamo gli alunni invitandoli a trattare i seguenti temi, che possono essere introdotti dalla lettura, dal commento e dalla memorizzazione di divertenti filastrocche da scegliere tra quelle presentate nell’Antologia: le vacanze estive, le esperienze vissute con la famiglia, le nuove conoscenze e nuove esperienze, i luoghi visitati, il ritorno a scuola, i cambiamenti dopo l’estate, le problematiche legate alla crescita.
Antologia pag. 136
Facciamo evidenziare i cambiamenti avvenuti nella classe rispetto al precedente anno scolastico, ponendo domande stimolo, come quelle di seguito suggerite.
◆ Da quanti bambini è formata la classe? Quante femmine, quanti maschi?
◆ C’è qualche bambino nuovo? Come si chiama?
◆ Quanti insegnanti lavorano con la classe? Come si chiamano? Quali attività svolgono?
◆ Che cosa è cambiato nell’aula? È la stessa dell’anno scorso? Sono cambiati i banchi?
Soffermiamoci in particolare sui cambiamenti legati alla crescita, dal momento che in questo periodo generalmente si verifica il passaggio dall’infanzia alla fanciullezza. Sono più marcati i cambiamenti nell’aspetto fisico ma soprattutto si modificano pensieri e sentimenti: spesso nei bambini convivono il desiderio e la paura di “diventare grandi”.
Attiviamo, quindi, la riflessione e la discussione su questo tema attraverso la lettura della scheda Quarta elementare 1. I due personaggi del racconto sono alunni di quarta elementare che vivono la crescita in modo molto diverso: Schizzo, che racconta i fatti, vorrebbe rallentare
il processo di crescita, è insicuro, mentre l’amico Joey ritiene che diventare grandi significhi mostrarsi prepotenti, fare i “duri” con i genitori e i “bulli” con i deboli che non possono difendersi. Commentiamo insieme le domande contenute nella scheda Divento grande, chiedendo agli alunni di esprimere i propri sentimenti e le opinioni personali sull’argomento.
Schede 1 Quarta elementare (1) • 1 Divento grande
È opportuno riprendere anche in classe quarta i piccoli “riti” cui gli alunni si sono abituati negli anni precedenti. Perciò creiamo ogni mattina un clima sereno per accogliere i bambini: facciamoli disporre in cerchio in una posizione comoda e, con un gesto concordato, segnaliamo l’inizio delle attività.
In questa prima fase della giornata insegnante e alunni si salutano, cantano, parlano a turno, si ascoltano.
Sfruttiamo l’occasione per osservare i comportamenti assunti da ciascun alunno in modo da valutare la capacità di:
◆ mantenere l’attenzione sul messaggio orale;
◆ rispettare il turno per intervenire nella conversazione;
◆ fornire le informazioni richieste;
◆ riferire vissuti personali;
◆ riferire il contenuto di una semplice storia ascoltata;
◆ esprimere idee personali.

Proponiamo, come ogni anno, il tema delle vacanze: ora che i bambini sono un po’ più grandi, durante le vacanze hanno probabilmente vissuto nuove esperienze che sono ansiosi di raccontare. Offriamo di seguito una serie di spunti di conversazione:
◆ le informazioni sulle località in cui i bambini sono stati;
◆ le esperienze che hanno vissuto;
◆ le persone con cui hanno condiviso le vacanze;
◆ i mezzi di trasporto utilizzati;
◆ i motivi per cui la vacanza è risultata piacevole/sgradevole;
◆ gli stati d’animo al rientro a scuola;
◆ i loro propositi per il nuovo anno.
Confrontiamo ciò che è possibile fare in vacanza con le attività che si svolgono a scuola. In vacanza possiamo: trascorrere più tempo con la famiglia, dormire fino a tardi, vedere posti nuovi, conoscere nuovi amici. A scuola possiamo: stare con i compagni, imparare cose nuove. Se lo riteniamo opportuno, anche quest’anno possiamo allestire un cartellone con i materiali che i bambini avranno portato dalle vacanze: fotografie, cartoline, disegni, ricordi ecc.
• Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale T3
Per verificare la capacità di leggere e comprendere testi, proponiamo attività organizzate secondo la struttura dei test oggettivi dell’INVALSI. Proponiamo la lettura di divertenti testi narrativi, in seguito alla quale i bambini dovranno:
◆ individuare la funzione e lo scopo dei testi;
◆ risolvere questionari con risposte a scelta multipla;
◆ individuare affermazioni vere/false inerenti ai testi.

Nelle schede Quarta elementare 1 e 2 il protagonista è un bambino che frequenta la classe quarta e racconta come si è svolto il primo giorno di scuola. Le domande focalizzano l’attenzione sugli elementi fondamentali della narrazione: personaggi; luogo e tempo della storia; narratore; rapporti di causa-effetto.
Invitiamo gli alunni a leggere attentamente le risposte fornite prima di scegliere l’opzione che ritengono giusta; ricordiamo, infatti, che alcune risposte sono parzialmente corrette e perciò possono trarre in inganno. Forniamo di seguito la soluzione:
1) In una scuola.
3) Schizzo.
5) In prima persona.
7) Ha paura dei ragni.
2) Il primo giorno di scuola.
4) Due alunni di quarta elementare.
6) Si è fatto male a un dito.
8) Degli elefanti.
Schede 1 Quarta elementare (1) • 2 Quarta elementare (2)
Il secondo brano proposto tratta un altro tema gradito ai bambini: l’avventura. Anche in questo caso è opportuno ricordare che è necessario, prima di barrare la casella V (Vero) o quella F (Falso), leggere attentamente le affermazioni inerenti alla storia. Le risposte corrette sono le seguenti: 1F • 2V • 3F • 4V • 5F
Riserviamo un’attenzione particolare al momento della correzione dei questionari. Suggeriamo questa procedura: è necessario che l’insegnante raccolga e corregga le singole prove in modo da rendersi conto della frequenza degli errori; successivamente, è opportuno discutere, confrontare con la classe le risposte fornite, in modo che tutti si rendano conto degli errori commessi.
Scheda 3 Si parte!
• Scrivere testi descrittivi chiari e coerenti T6
Nell’organizzare le attività di questo primo periodo dell’anno scolastico, ricordiamo che esse hanno lo scopo di verificare l’acquisizione degli obiettivi minimi della classe terza e, allo stesso tempo, di riprendere contenuti e tecniche dopo la pausa estiva.
Con un’immagine-stimolo, invitiamo i bambini a produrre un testo descrittivo che abbia per oggetto un paesaggio: avremo così l’occasione di consolidare l’uso dei principali indicatori topologici, esercitando la percezione visiva. Invitiamo gli alunni a osservare attentamente l’immagine e poniamo domande-stimolo: essi dovranno prima descrivere l’immagine oralmente, utilizzando adeguatamente gli indicatori spaziali, e poi elaborare il testo con il supporto di un modello.
Scheda 2 Una casa di campagna
• Scrivere testi chiari e coerenti per raccontare vissuti e storie T6
Facciamo notare come la scrittura sia un potente mezzo per conservare la memoria di eventi e comunicare con gli altri. Quindi prendiamo spunto dalla lettura della scheda Quarta elementare e invitiamo gli alunni a raccontare esperienze di cui sono stati protagonisti. Sfrutteremo l’occasione per ribadire il corretto uso dei connettivi temporali, attraverso conversazioni guidate come quelle di seguito esposte.
Ai bambini capitano spesso piccoli incidenti in cui si procurano ferite o contusioni. Sicuramente sarà successo anche a te. Racconta.
Quando si è svolto il fatto?
Dove ti trovavi?
Chi c’era con te?
Che cosa è successo?
Come ti sei comportato? Hai pianto? Hai strillato?
Chi ti ha aiutato?
Come si è concluso il fatto?
Che cosa hai provato?
Oppure:
Quali sono gli animali/insetti che ti fanno paura?

Come reagisci quando ne vieni a contatto? Piangi? Urli? Scappi? Chiedi aiuto?
Tenti di allontanare l’animale/insetto con qualche strumento?
Dopo aver raccontato a turno le proprie esperienze, gli alunni elaborano il testo con il supporto del modello guida.
Scheda 3 Che dolore!
• Scrivere testi espositivi T6
Dopo aver discusso sui cambiamenti avvenuti durante l’estate, invitiamo gli alunni a scrivere un breve testo con il supporto di domande-guida in cui i bambini possano presentare la nuova classe, sulla falsariga delle seguenti.
◆ Da quanti bambini è formata la classe? Quanti maschi? Quante femmine?
◆ C’è qualche bambino nuovo? Chi si è trasferito?
◆ La classe occupa la stessa aula dell’anno scorso? Dove si trova la nuova aula?
◆ Quanti insegnanti lavorano con la classe? Quali discipline insegnano?
◆ Quali attività svolge la classe?
• Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche T8
Cerchiamo di rendere gradevole il rientro a scuola organizzando attività in forma di gioco:

i bambini si divertiranno e contemporaneamente consolideranno gli apprendimenti. L’insegnante ricaverà dati importanti per stabilire quali abilità e conoscenze abbiano bisogno di essere recuperate dopo la lunga pausa estiva.
Proponiamo cruciverba di riepilogo delle principali difficoltà ortografiche o giochi di parole associati a immagini da colorare, ricche e accattivanti.
Scheda 4 La frase segreta
È sempre utile insistere sul coretto uso della punteggiatura. Presentiamo un breve testo privo dei principali segni di interpunzione e chiediamo agli alunni di completarlo. L’insegnante valuterà se sia opportuna o meno una lettura a voce alta del testo che agevoli lo svolgimento dell’attività da parte dei bambini. Se scegliamo questa modalità operativa, possiamo chiedere ai bambini di ascoltare la lettura dell’insegnante, focalizzando l’attenzione sull’intonazione della voce. Accentuiamo le esclamazioni, il tono interrogativo, le pause lunghe. Il testo potrebbe essere il seguente.
Complimenti! Stai diventando grande. Ma sai riconoscere i pericoli? Fai attenzione e segui questi consigli:
non sporgerti troppo da finestre e balconi; prima di usare gli apparecchi elettrici assicurati che non ci sia acqua; non lanciare oggetti verso i compagni; non fare sgambetti ai compagni; non spingere i compagni; attraversa la strada sulle strisce pedonali; allaccia la cintura di sicurezza in auto.
Scheda 5 La punteggiatura
• Riflettere sulle parole: riconoscere le principali parti del discorso T10
Riprendiamo un’altra importante attività del precedente anno scolastico: il riconoscimento di alcune parti del discorso. Presentiamo un breve testo che tratti un tema inerente al periodo autunnale ed evidenziamo le parole che i bambini dovranno classificare in un’apposita tabella. Inizialmente sarà opportuno ricordare brevemente le caratteristiche di nomi, articoli, aggettivi, verbi e preposizioni.
Scheda 6 È quasi autunno
• Osservare, esplorare, descrivere e leggere fumetti T3
Rendiamo piacevole il ritorno a scuola impegnando i bambini nel completamento di fumetti. Questa tipologia testuale, che utilizza sia il linguaggio scritto che quello iconico, consente di fornire le basi per ulteriori apprendimenti. Simboli, onomatopee, nuvolette e linee potranno essere utilizzati anche in altri ambiti, stimolando i bambini meno motivati.
Scheda 4 Viva i fumetti!

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T2 , T3 , T5 e T9 (v. pag. 101).
• Conoscere le fonti della Storia T2 T5
Nelle prime settimane di scuola ripercorriamo e approfondiamo concetti già presentati durante lo scorso anno scolastico che sono fondamentali per un competente approccio metodologico allo studio della Storia: le fonti storiche, il lavoro dello storico e degli scienziati che lo aiutano, la datazione.
È importante che gli alunni acquisiscano un lessico corretto e preciso, perciò iniziamo le attività di quest’anno domandando: Che cos’è la Storia? Che cosa significa questa parola? Riportiamo alla lavagna le molteplici risposte, poi spieghiamo che la parola Storia deriva dal greco historía, che significa “ricerca” e, per far comprendere ancora di più ai bambini il significato della parola, precisiamo che historía deriva da un’altra parola greca, íst¯or, che significa “colui che ha visto”: la Storia è ricerca di ciò che è stato visto, di ciò che è reale, di ciò che è documentabile. Nell’attività di ricerca e di ricostruzione di fatti storici imprescindibile è il ruolo delle fonti, ovvero le testimonianze sul passato.
Si distinguono diversi tipi di fonti storiche:
Le fonti storiche
◆ le fonti materiali: utensili, armi, resti di edifici, arredi, monete, tracce di cibo;
◆ le fonti iconografiche: dipinti, graffiti, sculture, mosaici, mappe, fotografie, filmati;
◆ le fonti orali: testimonianze verbali dirette e racconti, leggende, canti tramandati a voce;
◆ le fonti scritte: ogni tipo di testo scritto, come iscrizioni su pietre o altro materiale, atti di nascita o di compravendita, preghiere, diari, lettere, libri.
Le prime due tipologie, definite anche “fonti mute” perché non fondate sulla scrittura o sul linguaggio, sono essenziali per ricostruire il periodo denominato Preistoria, in cui l’uomo non ha ancora elaborato forme di scrittura. Solo con l’inizio della Storia, che si fa coincidere con l’invenzione della scrittura, l’uomo lascia testimonianze scritte della propria esistenza.
Proponiamo ai nostri alunni una scheda che li aiuti a distinguere i diversi tipi di fonte e a ricavare informazioni da una fonte iconografica.
Scheda 7 Le fonti storiche
• Conoscere il lavoro dello storico T2 T5
Ripresentiamo ai nostri alunni la figura professionale dello storico che, compiendo ricerche e indagini e ricavando informazioni dalle fonti, ricostruisce fatti del passato e li trasmette attraverso il racconto. Lo storico indaga, ricostruisce e racconta attraverso il metodo storico.
Il metodo storico si articola in varie fasi:
Il metodo storico
◆ ricerca, analisi e interpretazione delle fonti;
◆ ricostruzione di fatti;
◆ collocazione di fatti nel tempo e nello spazio;
◆ individuazione di collegamenti di fatti con altri precedenti, contemporanei e successivi;
◆ esposizione dei fatti analizzati.

comprendere le fasi del metodo storico.
ausiliarie della Storia T2 T5
racconto, lo storico si avvale di specialisti
ausiliare della Storia culture. i reperti e datandoli. reperti.
consumo dei beni.
collaborazione tra i diversi specialisti Storia e, collegandoci alle Proposte di Educazione civica, evidenziamo l’importanza della cooperazione in ogni forma di attività sociale. Invitiamo anche gli alunni a raccontare verbalmente e per iscritto un’esperienza vissuta di collaborazione per la realizzazione di un obiettivo comune.
Scheda 5 Un formidabile team!
• Conoscere le parole della Storia T2 T5
Abituiamo i nostri alunni a ricercare l’etimologia delle parole ricorrenti nello studio della Storia, con particolare attenzione ai diversi elementi che compongono le parole più diffuse.
Le parole della Storia
-logia dal verbo greco légein (dire, parlare), da cui deriva il sostantivo lógos (parola, discorso, studio, trattazione)
geo- dal greco ge¯o, derivante da gê = Terra
-grafia dal greco -graphía, derivante dal verbo greco gráphein = tracciare dei segni, descrivere antropodal greco ánthr¯opos = uomo archeodal greco archâios = antico
-litico dal greco líthos = pietra
-ontologia dal greco ón (ente) e lógos (parola) = che riguarda l’essere neodal greco néos = nuovo
paleodal greco palaiós = antico
Scheda 6 Le parole della Storia
Benvenuti in quarta
• Conoscere e confrontare sistemi di datazione T3
Abbiamo già precisato ai nostri alunni che lo storico colloca i fatti nel tempo, disponendoli in ordine cronologico, cioè mettendoli in relazione con ciò che è accaduto prima e dopo.
Senza datazione gli eventi rimarrebbero confusi e non si potrebbero interpretare e leggere:
◆ né in prospettiva diacronica, cioè nella loro successione temporale;
◆ né in prospettiva sincronica, cioè in confronto con fatti contemporanei.
Domandiamo ai nostri alunni: Come si collocano in ordine cronologico gli eventi? Come si data un fatto? Per gli uomini è stato necessario elaborare un sistema di datazione, individuando un momento di partenza nella misurazione del tempo: questo momento di partenza è l’anno zero.
L’anno zero
Per i popoli occidentali l’anno zero coincide con l’anno di nascita di Gesù Cristo.
Nel 527 d.C. un monaco, Dionigi il Piccolo, sostenne che la nascita di Gesù Cristo fosse un evento fondamentale per la religione cristiana e propose che gli anni venissero contati da quel momento, piuttosto che dalla fondazione di Roma o dall’inizio del regno di Diocleziano, come si usava a quel tempo. Dionigi calcolò che Gesù fosse nato nell’anno 753 Ab Urbe Condita, cioè dalla fondazione di Roma. Questo modo di contare gli anni non fu immediatamente accolto, neanche dalla chiesa cattolica che iniziò ad impiegarlo solo verso la fine del X secolo d.C.
L’anno zero non coincide per tutti i popoli con lo stesso evento storico:

◆ gli Ebrei collocano l’anno zero nel 3760 a.C., anno della creazione del mondo, pertanto l’anno 1 inizia il 6 ottobre 3761 a.C.;
◆ i Giapponesi considerano anno zero il 660 a. C., quando il re Jimmu Tenno fondò l’impero giapponese;
◆ i Cinesi confuciani considerano anno zero il 551 a.C., anno della nascita di Confucio;
◆ i buddisti iniziano a contare gli anni dal 543 a.C., anno della morte di Buddha;
◆ i musulmani considerano anno zero il 622 d.C., anno dell’ègira, ovvero della fuga di Maometto dalla Mecca a Medina, in seguito alla quale acquisì il potere politico, oltre a quello religioso.
Per familiarizzare con il concetto di anno zero, proponiamo un’attività laboratoriale.
LABORATORIO Costruiamo la linea del tempo
Forniamo a ciascun alunno un foglio di quaderno a quadretti grandi sistemato in orizzontale e facciamo disegnare una linea del tempo con la freccia rivolta verso destra; poi, in un punto più vicino alla freccia che è all’origine della linea, ogni alunno segnerà con il pennarello rosso un trattino verticale che indica l’anno zero.
Partendo dal trattino che rappresenta l’anno zero e procedendo verso destra, gli alunni tracciano con il pennarello blu un trattino verticale per ogni quadratino, scrivendo le date: 1 d.C., 2 d.C. ecc.; spieghiamo che l’abbreviazione d.C. (dopo Cristo) indica gli anni successivi alla nascita di Cristo.
Ritornando sul segno che rappresenta l’anno zero e procedendo verso sinistra, gli alunni tracciano con il pennarello verde un trattino verticale per ogni quadratino scrivendo le date: 1 a.C., 2 a.C. ecc.
Precisiamo che la sigla a.C. è l’abbreviazione di “avanti Cristo” e indica tutti gli anni che precedono la nascita di Cristo.
Schede 9 L’anno zero 7 L’anno zero nella tua vita • 8 Tanti anni zero!

• Conoscere la storia dell’evoluzione dell’uomo T9
Dopo che gli alunni si saranno esercitati a muoversi lungo la linea del tempo, ripresentiamo brevemente la storia dell’evoluzione umana dall’ Australopiteco all’Homo sapiens sapiens , magari allestendo un cartellone che ne evidenzi i passaggi.
Da Australopiteco a Homo sapiens sapiens: il lungo cammino dell’uomo
In un periodo compreso tra 5 e 1 milione di anni fa nell’Africa orientale, lungo la Rift Valley (la Valle del Crepaccio), si sviluppano degli ominidi, gli Australopitechi, caratterizzati da postura eretta e andatura bipede: secondo gli studiosi da loro si avvia il processo di evoluzione dell’uomo, detto “ominazione”. Dagli Australopitechi, circa 2,3 milioni di anni fa, deriva il primo esemplare del genere Homo: l’Homo habilis, l’uomo abile a scheggiare la pietra per adattarla alle proprie esigenze e capace di modificare l’ambiente. Successivamente, tra 1,5 milioni e 200 mila anni fa, compare l’Homo erectus, l’uomo che si muove stabilmente in posizione eretta, ricordato per la capacità di accendere e di usare il fuoco e perché dall’Africa si sposta in Europa e in Asia. In seguito si diffonde l’Homo sapiens, di cui una sottospecie, l’Homo sapiens neanderthalensis, si sviluppa in Europa circa 200 mila anni fa e si estingue circa 40 mila anni fa, probabilmente sopraffatto dalla specie a cui appartengono gli uomini che oggi popolano la Terra: l’Homo sapiens sapiens
Ricordiamo ai nostri alunni che il lunghissimo periodo che va dalla comparsa dell’Homo habilis fino all’invenzione della scrittura si chiama Preistoria, cioè “prima della Storia”, ma anche “età della pietra”, perché inizia quando l’uomo impara a lavorare la pietra, con cui fabbrica utensili vantaggiosi per la sua sopravvivenza.
L’età della pietra è suddivisa in tre periodi:
◆ il Paleolitico (dal greco palaiós = antico e líthos = pietra): età della pietra antica, in cui l’uomo caccia animali, raccoglie frutti e bacche, è nomade, si ripara in grotte o costruisce capanne con rami e pelli di animali, usa utensili di pietra e conosce il fuoco, realizza le prime forme d’arte e seppellisce i morti;
◆ il Mesolitico (dal greco mésos = medio e líthos = pietra): età della pietra di mezzo, in cui l’uomo impara ad usare l’arco, pratica molto di più la pesca, costruisce le prime barche e le palafitte, addomestica il cane e inizia ad allevare bovini e ovini;
◆ il Neolitico (dal greco néos = nuovo e líthos = pietra): età della pietra nuova, in cui l’uomo usa pietre levigate, inizia a coltivare la terra e costruisce i primi attrezzi per l’agricoltura (zappa, rastrello, aratro, falce, mortaio e pestello), inventa la ceramica e sviluppa la tecnica della filatura e della tessitura, inizia a lavorare i metalli, passa dal nomadismo alla sedentarietà e si insedia nei primi villaggi.
Organizziamo dei gruppi di lavoro e invitiamo i nostri alunni a illustrare con disegni e didascalie le attività svolte e gli strumenti utilizzati dall’uomo nei tre periodi della Preistoria.
Concludiamo domandando alla classe: Quando termina la Preistoria?
Probabilmente gli alunni ricordano che la Preistoria termina con l’inizio della Storia, momento che si fa coincidere con i primi documenti scritti rinvenuti in Mesopotamia e in Egitto e risalenti alla fine del IV millennio a.C.: con la scrittura, infatti, l’uomo lascia testimonianze più precise della propria vita.
Schede 10 La Preistoria umana 9 L’evoluzione dell’uomo

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T2 e T3 (v. pag. 102).
• Conoscere il lavoro del geografo T3
Nelle prime settimane di scuola ripresentiamo la figura professionale del geografo e analizziamo gli strumenti di cui si serve per la sua attività.
Anche nelle Proposte di Geografia, come in quelle di Storia, rileviamo l’importanza di fare acquisire ai nostri alunni un adeguato lessico disciplinare.
Domandiamo: Che cos’è la Geografia? La parola geografia è formata dalle parole greche ge¯o-, derivante da gê = Terra, e -graphía, che significa descrizione.
Letteralmente, quindi, la Geografia è la descrizione della Terra ed è una scienza antichissima: nei pressi dell’antica Babilonia sono state rinvenute alcune tavolette di argilla, risalenti a circa 7000 anni fa, che rappresentano paesaggi geografici.
La Geografia è una scienza che nel passato si interessava soprattutto della rappresentazione grafica dei luoghi e della loro descrizione, mentre oggi si occupa anche di comprendere le relazioni tra l’uomo e l’ambiente e tra gli aspetti fisici e naturali di un ambiente e quelli antropici, introdotti dall’uomo. Queste attività sono svolte dal geografo.
Domandiamo alla classe: Che cosa fa il geografo? Come organizza il suo lavoro?
Il metodo di lavoro del geografo
Il geografo svolge la sua attività seguendo un metodo di lavoro caratterizzato da alcune fasi:
◆ osservazione diretta o attraverso fotografie del luogo da studiare;
◆ documentazione del luogo da studiare;
◆ raccolta e analisi dei dati sul luogo;
◆ descrizione del luogo attraverso parole e immagini.
Il primo momento è l’osservazione del luogo, che può avvenire direttamente o attraverso fotografie. Che cosa osserva il geografo?
In un ambiente il geografo osserva gli elementi fisici (la conformazione del territorio), gli elementi naturali (flora e fauna) e gli elementi antropici (insediamenti e attività dell’uomo). Presentiamo delle fotografie di ambienti e invitiamo i nostri alunni a evidenziare con colori diversi gli elementi fisici, naturali e antropici.
Scheda 11 Il lavoro del geografo
• Conoscere e confrontare gli strumenti del geografo T3
Come osserva il geografo? Invitiamo i nostri alunni a formulare le loro ipotesi, poi evidenziamo che un luogo può essere osservato direttamente o indirettamente con il sussidio di fotografie.
Le immagini in Geografia
Se nel passato per descrivere un luogo, allo scopo preminente di realizzare una carta geografica, erano necessari l’osservazione diretta o il racconto di viaggiatori, oggi la tecnologia è di fondamentale aiuto per il geografo, che si avvale di molti generi di immagini.

A tal proposito si distinguono:
◆ la fotografia panoramica, scattata a distanza ravvicinata, che consente di vedere in maniera più dettagliata le caratteristiche fisiche e antropiche di un ambiente;
◆ la fotografia aerea, che può mostrare uno spazio più vasto di quello ripreso da una foto panoramica ed è realizzata con un aereo che sorvola un territorio e scatta molte fotografie che sono poi assemblate. Se nell’ambiente sono presenti dei rilievi, la foto è elaborata attraverso il rilevatore fotogrammetrico, che consente di acquisire immagini corrette nelle tre dimensioni geometriche (lunghezza, larghezza e altezza), evitando una visione piatta del territorio;
◆ la fotografia satellitare, che è scattata dai satelliti artificiali orbitanti intorno alla Terra, in grado di riprendere territori vastissimi, anche i due emisferi terrestri; le immagini ottenute dai satelliti sono elaborate dal computer per ottenere carte geografiche molto precise.
Invitiamo i nostri alunni a portare fotografie dei luoghi in cui abitano: distinguiamo le foto panoramiche e aeree e, se ne abbiamo la possibilità, utilizziamo anche programmi di visione satellitare, come Google Earth.
Scheda 10 Tante foto per il geografo
• Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie della Geografia T3
Spieghiamo ai nostri alunni che è necessaria l’interazione del geografo con altri studiosi che analizzano l’ambiente sotto diversi aspetti.
Gli specialisti delle scienze ausiliarie della Geografia
◆ L’antropologo studia i costumi e le tradizioni dei popoli che vivono in un ambiente.
◆ Il biologo studia gli organismi viventi e le condizioni di vita del loro ambiente.
◆ Il cartografo si occupa della stesura di carte, piante e mappe rappresentative di un ambiente.
◆ Il geologo studia la struttura della Terra e i fenomeni naturali come le eruzioni vulcaniche e l’erosione che modificano l’ambiente.
◆ Il meteorologo studia e analizza i fenomeni atmosferici come venti, piogge, nevicate che incidono sulle caratteristiche di un ambiente.
Scheda 12 Gli aiutanti del geografo
• Leggere ed eseguire riduzioni in scala T2
Il territorio osservato deve essere rappresentato attraverso piante, mappe e carte geografiche. Una carta, per essere utile e consultabile, deve essere notevolmente più piccola dell’ambiente da rappresentare, per cui è necessario realizzare una riduzione in scala.
Ridurre in scala significa rimpicciolire proporzionalmente un territorio da rappresentare e la scala è data dal rapporto tra la grandezza reale dell’ambiente e la carta geografica che otteniamo: se stabiliamo un rapporto 1 a 2, significa che la realtà è 2 volte più grande della carta, se stabiliamo un rapporto 1 a 3, la realtà è 3 volte più grande della carta ecc.; precisiamo che il rapporto può scriversi anche 1:2 e si legge 1 a 2.
Utilizzando fogli quadrettati facciamo esercitare i bambini con diverse riduzioni in scala e invitiamoli a realizzare ingrandimenti e riduzioni di semplici disegni.
Scheda 11 Riduco in scala
• Conoscere e descrivere diversi tipi di carte T2
Approfondiamo con i nostri alunni alcune definizioni concernenti i diversi tipi di rappresentazione dello spazio già presentate negli scorsi anni scolastici.
Tante carte
◆ La pianta e la mappa hanno una scala di riduzione fino a 1:10.000.
◆ La carta topografica (dal greco tópos = luogo) ha una scala di riduzione da 1:10.000 a 1:100.000.
◆ La carta corografica (dal greco ch¯orographikós composto di ch¯oros = terreno e graphía = descrizione) ha una scala di riduzione da 1:100.000 a 1:1.000.000.
◆ La carta geografica ha una scala di riduzione superiore a 1:1.000.000.
◆ Il planisfero ha una riduzione superiore a 1:30.000.000 e rappresenta la Terra su una superficie piana.
Osservando la carta geografica dell’Italia sicuramente presente in aula o comunque facilmente reperibile, facciamo notare agli alunni che esistono due tipi di scala:
◆ la scala numerica, in cui la riduzione è rappresentata con numeri e indica di quante volte è stata rimpicciolita la realtà; ad esempio 1:1000 vuol dire che 1 cm sulla carta equivale a 1000 cm nella realtà e il 1000 indica il numero di riduzioni; per cui, più grande è il divisore tanto maggiormente il territorio è stato rimpicciolito;
◆ la scala grafica, in cui la riduzione è rappresentata con un segmento diviso in parti uguali, ciascuna delle quali rappresenta una distanza nella realtà; ad esempio in una scala di questo genere:

0 100 200 300 400 500 m ogni segmento corrisponde a 100 metri.
Un’altra importante classificazione è collegata al contenuto della carta geografica.
La prima distinzione è tra carta fisica, carta politica e carta fisico-politica:
◆ la carta fisica rappresenta gli aspetti fisici del territorio, cioè i rilievi, i mari, i fiumi, i laghi ecc.;
◆ la carta politica rappresenta i confini dello Stato (confini politici) o delle regioni, province e comuni (confini amministrativi) e la distribuzione e l’entità dei centri abitati;
◆ la carta fisico-politica rappresenta insieme gli aspetti fisici e politici e i centri abitati.
Interessanti per i risvolti immediatamente pratici sono, inoltre, le carte tematiche, che descrivono un particolare aspetto del territorio rappresentato.
Le carte tematiche
Tra le carte tematiche sono annoverate:
◆ le carte automobilistiche o stradali, che indicano le strade di regioni più o meno vaste;
◆ le carte archeologiche, che indicano i siti archeologici;
◆ le carte batimetriche, che segnano le curve di profondità (isobate);
◆ le carte economiche, che evidenziano i singoli prodotti economici o le caratteristiche economiche complessive di determinati territori;
◆ le carte geofisiche (ad esempio le carte geologiche, magnetiche, meteorologiche), che rappresentano specifiche caratteristiche della superficie terrestre o l’andamento di fenomeni;
◆ le carte etniche, che rappresentano la distribuzione delle diverse popolazioni sotto l’aspetto nazionale o tribale, la distribuzione di forme religiose, i tipi di abitazione ecc.;

◆ le carte linguistiche, che descrivono la diffusione e la distribuzione delle lingue o l’andamento geografico di fenomeni fonetici, morfologici e lessicali, specialmente nell’uso dialettale;
◆ le carte nautiche, che rappresentano i mari, le coste e le isole e sono necessarie per la navigazione marittima e aerea;
◆ le carte naturalistiche, le quali riproducono la distribuzione di flora e fauna in un dato territorio;
◆ le carte storiche, raffiguranti le condizioni geografiche antiche di determinati paesi, con gli insediamenti umani e le divisioni politiche.
Spesso le carte tematiche utilizzano simboli o disegni corrispondenti a ciò che si vuole rappresentare o impiegano diverse sfumature di colore, come i cartogrammi.
Schede 13 Tante scale 12 Leggo una carta geografica • 13 Tante carte tematiche
• Interpretare e realizzare legende di carte T2
Nella lettura di una carta è fondamentale prestare attenzione alla legenda, un riquadro posto a margine, che contiene un elenco dei simboli, segni o colori utilizzati per indicare la presenza di particolari elementi nello spazio rappresentato. Proponiamo ai nostri alunni di leggere e realizzare legende utilizzando forme, disegni convenzionali e colori appropriati.
Scheda 14 Carte e legende
• Leggere e rappresentare dati statistici T2 T3
Osservando e interpretando un territorio, i geografi formulano alcune domande, ad esempio:
Quanti sono gli abitanti? Quanti sono i lavoratori impiegati nei diversi settori produttivi?
Quanti fiumi attraversano un territorio? Quanta parte del territorio è occupata da montagne? Queste informazioni, quantificabili ed esprimibili con numeri, sono dati statistici e vengono rappresentati con tabelle o grafici.
Tabelle e grafici
Le tabelle ordinano i dati e consentono un confronto veloce.
I grafici mostrano i dati statistici con un disegno e sono di diverso tipo:
◆ l’areogramma, comunemente chiamato grafico a torta, rappresenta i dati come parti di un tutto;
◆ il cartogramma utilizza le carte geografiche per indicare con simboli, colori o disegni l’intensità di un fenomeno in un territorio;
◆ il diagramma si utilizza per mostrare l’andamento di un fenomeno nel tempo e rappresenta i dati in una linea che si costruisce all’interno di assi cartesiane; sull’asse orizzontale (asse delle ascisse) si indicano i dati relativi al tempo, mentre sull’asse verticale (asse delle ordinate) quelli relativi al valore del fenomeno;
◆ l’istogramma o diagramma a barre riporta i dati con colonne di diversa altezza e più la colonna è alta più il valore rappresentato è maggiore;
◆ l’ideogramma riporta i dati con disegni o simboli e ad ogni disegno o simbolo corrisponde una data quantità di dati.
Presentiamo ai nostri alunni tabelle e grafici e invitiamoli a leggere i dati statistici rappresentati, nonché a realizzare un ideogramma.
Scheda 14 Realizzo un ideogramma

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T1 , T2 , T4 , T5 , T7 e T8 (v. pag. 104).
Il ritorno a scuola rappresenta un momento particolare per i bambini perché devono riadattarsi al ritmo del lavoro scolastico dopo la pausa estiva. All’inizio l’insegnante predispone alcune attività non troppo impegnative e incalzanti e dedica questo primo periodo alle prove d’ingresso da somministrare in tempi distesi, per favorire una ripresa serena e far riacquistare gradualmente agli alunni il ritmo di lavoro. Le verifiche d’ingresso servono per rilevare le conoscenze acquisite, le sicurezze raggiunte e le abilità necessarie per affrontare i nuovi apprendimenti e saranno utilizzate anche per registrare sinteticamente le condizioni d’ingresso in termini di bisogni specifici e di risorse. I risultati delle suddette prove forniscono all’insegnante elementi di conoscenza degli alunni, necessari per puntuali adeguamenti della programmazione didattica nella dinamica insegnamento/apprendimento, consentendogli di progettare eventuali strategie didattiche personalizzate che prevedano, a seconda dei casi, interventi di recupero o di approfondimento. Dopo aver registrato i risultati delle prove, l’insegnante può ragionare insieme agli alunni sugli eventuali errori commessi anche per indirizzarli verso un’attività di autovalutazione e dare loro la possibilità di correggersi, contribuendo, così, allo sviluppo del pensiero metacognitivo dell’alunno. Si propone, pertanto, di riprendere quelle attività che permettono di rinforzare le abilità indispensabili per una più approfondita riflessione sulla struttura del numero, sulle operazioni logiche e aritmetiche e sul rapporto tra spazio e figure.
Le abilità di base e le conoscenze da verificare sono, pertanto:
◆ la completa padronanza della lettura e scrittura dei numeri entro il 1000;
◆ la capacità di eseguire a mente le quattro operazioni aritmetiche con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo;
◆ la sicurezza nell’esecuzione delle quattro operazioni aritmetiche con i numeri naturali;
◆ la capacità di approccio alle situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni;
◆ la capacità di riconoscere figure geometriche.
• Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero T5 T7
Verificare la capacità dell’alunno di classificare oggetti ed elementi in modo sempre più preciso e approfondito è uno dei prerequisiti più importanti per la formazione e lo sviluppo dei concetti logici e matematici. Tale capacità, tra l’altro, è indispensabile per ogni disciplina di studio anche se ha come campo di elezione quello logico-matematico e scientifico. Essendo, pertanto, configurabile come nucleo fondamentale del sapere per lo sviluppo dell’intelligenza, ad essa va riservata particolare attenzione sia in fase di verifica che in prospettiva di nuovi apprendimenti.
Ciò detto, l’insegnante, con riferimento a quanto già proposto e svolto in classe terza, sottoporrà agli alunni varie attività che li metteranno di fronte alla necessità di organizzare e

rappresentare dati e oggetti raggruppandoli in base a due caratteristiche date (attributi dati). Proponiamo un esempio nel quale l’alunno deve rappresentare con i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero la classificazione di seguito indicata.
◆ Disegna 1 torta con le fragoline, 1 torta con le candeline, 2 torte senza fragoline e senza candeline e l’insieme intersezione rappresentato da 2 torte con fragoline e candeline.
1. Rappresentiamo con il diagramma di Venn.
Sottoinsieme di torte con fragoline Insieme intersezione
2. Rappresentiamo con il diagramma di Carroll.
A: insieme di torte
3. Rappresentiamo con il diagramma ad albero.
Sottoinsieme di torte con candeline
Illustriamo alla lavagna anche la seguente situazione problematica e chiediamo alla classe di rappresentarla con il diagramma di Carroll: ogni bambino della classe deve scrivere il proprio nome al posto giusto.
Benvenuti in quarta
Alcuni alunni avranno scritto il loro nome e la tabella risulterà così completata:
Hanno gli occhiali Non hanno gli occhiali
Maschi Paolo Giorgio Giacomo
Femmine Giada Silvia
Antonella non ha gli occhiali. Dove scriverà il proprio nome?
A dove l’ha scritto Giada;
B dove l’ha scritto Silvia;
C dove l’ha scritto Giacomo.
Schede 15 Candeline e fragoline: classifichiamo
• 16 Dal diagramma di Carroll al diagramma ad albero
• Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci entro il 1000 T1
In ambito aritmetico, la prima abilità di base da verificare è, senza dubbio, quella che si riferisce alla lettura e scrittura dei numeri entro il 1000, abilità nella quale gli alunni devono dimostrare la più completa padronanza.

Per verificare e consolidare negli alunni tale abilità, proponiamo alcuni esercizi che prevedono la lettura e la scrittura del numero in cifra e in parola con l’uso del materiale
B.A.M. e degli abachi. I bambini saranno invitati singolarmente allo svolgimento di esercizi guidati sia in forma orale che per iscritto, alla lavagna o sul quaderno.
Schede 17 Un ripasso veloce per leggere e scrivere i numeri entro il mille
• 18 Il materiale B.A.M. • 19 Dal B.A.M. all’abaco
• Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità T1
La scomposizione e la composizione dei numeri offrono agli alunni un’ulteriore opportunità per la comprensione della struttura numerica e favoriscono, nello stesso tempo, l’abilità nella pratica del calcolo mentale e scritto. Si invitano i bambini a scomporre oralmente i numeri in migliaia, centinaia, decine e unità, e si passa poi alla registrazione sul quaderno. Gli alunni devono dimostrare una buona conoscenza dei numeri naturali e la capacità di operare con essi lavorando sul valore posizionale delle cifre.
Scheda 20 Numeri in tabella e sull’abaco
• Ordinare e confrontare numeri naturali entro il 1000 utilizzando i simboli >, <, = T1
Per permettere agli alunni di ripetere il sistema di numerazione e per verificare la loro abilità di enumerazione si può ricorrere a un’attività che sarà svolta, sia oralmente che per iscritto e
Benvenuti in quarta

sia collettivamente che individualmente, sulle numerazioni in senso progressivo e regressivo entro il 1000.
Utilizzeremo la retta dei numeri che si configura come rappresentazione dei numeri reali attraverso una retta orientata. Ricordiamo agli alunni che il movimento sulla retta dei numeri ha un andamento progressivo nel caso dell’addizione (andare avanti/avanzare) e regressivo nel caso della sottrazione (retrocedere/tornare indietro). L’insegnante chiede ai bambini di essere molto precisi nella rappresentazione grafica e nello stabilire con esatezza il punto di inizio e il punto di fine della retta dei numeri.
Sappiamo che la capacità di contare in modo sicuro e corretto non è scontata neanche nei bambini di classe quarta per cui va continuamente rinforzata.
Contestualmente, si procederà nel proporre agli alunni opportune esercitazioni di confronto tra i numeri naturali, consolidando in tal modo anche la comprensione e l’uso dei simboli > , < , = .
Scheda 21 So ordinare e confrontare i numeri
• Eseguire le quattro operazioni in riga T1
I bambini, affrontando le verifiche degli obiettivi precedenti sulla scomposizione dei numeri e sull’esecuzione di diverse serie di numerazioni progressive e regressive con somme e sottrazioni, si saranno già esercitati sul calcolo orale.
Essi opereranno finché non avranno acquistato sicurezza e velocità. Un veloce ripasso sulla conoscenza di tutte le possibili coppie dei numeri che servono per formare 10, 50, 100 e 1000 sarà sicuramente un valido aiuto.
Pertanto saranno proposte addizioni e sottrazioni da eseguire oralmente. Inoltre, per ridurre le carenze nel calcolo dei prodotti, sarà opportuno riprendere il ripasso delle tabelline e si faranno eseguire in riga moltiplicazioni con il moltiplicando di due cifre e il moltiplicatore di una cifra e divisioni con il dividendo di due cifre e il divisore di una cifra. Se i bambini eseguiranno l’attività con difficoltà, l’insegnante potrà consentire l’esecuzione in colonna delle operazioni che non riusciranno ad eseguire, presentandola come verifica e controllo dei risultati.
Scheda 22 Operazioni in riga
• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con due cambi T1
Questo obiettivo da verificare consente di fare il punto sul livello di abilità nel calcolo scritto. Se gli alunni trovano difficoltà a svolgere questa attività, l’insegnante può ricorrere ad altri esercizi di consolidamento e se per esempio sorgono problemi di incolonnamento, può riproporre la lettura del valore posizionale delle cifre e la corretta disposizione ordinata dei termini.
Sarà opportuno presentare prima addizioni e sottrazioni senza cambio e poi addizioni e sottrazioni con il cambio, per poi arrivare a quelle con due cambi.
Scheda 23 Proviamo a eseguire addizioni e sottrazioni in colonna
• Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una e di due cifre T1
• Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza e con il cambio, con e senza resto T1
Per affrontare la verifica delle moltiplicazioni in colonna, sarà opportuno ripeterle gradualmente secondo un ordine crescente di difficoltà (senza e con il cambio, con il moltiplicando di due/tre cifre e il moltiplicatore di una/due cifre).
Sarà cura dell’insegnante accertarsi della perfetta padronanza del meccanismo della moltiplicazione da parte dei suoi alunni prima di procedere con le moltiplicazioni più complesse. L’esito dei risultati potrà essere verificato o mediante correzione individuale oppure mediante correzione collettiva previa scrittura alla lavagna dell’operazione eseguita dall’insegnante o da un alunno.
Per affrontare, invece, la verifica dell’esecuzione delle divisioni in colonna, sarà opportuno ripeterle gradualmente secondo un ordine crescente di difficoltà (con il divisore di una cifra senza e con il cambio, con e senza resto).
Poiché questo obiettivo sarà ripreso, consolidato e ampliato nel corso della quarta classe, con l’apprendimento delle divisioni in colonna con due cifre al divisore, l’insegnante dovrà soffermarsi per un tempo più congruo su queste difficoltà affinché l’alunno acquisisca dimestichezza con il procedimento.

A tale scopo, l’insegnante inviterà ogni alunno a ripetere sempre ad alta voce ciascun passaggio del procedimento nell’esecuzione della divisione. Si consiglia all’insegnante di rivedere le proposte metodologiche dell’obiettivo “Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza cambio, con e senza resto” del secondo bimestre della Guida di classe terza.
Schede 24 Ripassiamo un po’ le tabelline • 25 Ripetiamo le divisioni in colonna
• Risolvere situazioni problematiche con l’uso delle quattro operazioni T1 T8
Certamente uno dei modi migliori per verificare sia la perfetta padronanza della tecnica di esecuzione delle quattro operazioni, sia la funzione logica che ciascuna di esse svolge nella rappresentazione e quantificazione di rapporti e relazioni tra oggetti e grandezze, è quello di proporre agli alunni in forma ludica e, possibilmente, facendole scaturire dalla loro concreta esperienza vissuta, delle semplici situazioni problematiche, la cui soluzione richieda una o due operazioni e il cui testo contempli una o due domande.
Approfittando di questa attività di verifica, l’insegnante riproporrà agli alunni lo schema logico di svolgimento per la soluzione dei problemi (si consiglia la rilettura dell’obiettivo “Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema” del primo bimestre della Guida di terza classe).
Nello svolgimento di questa attività di verifica, inizialmente, ogni situazione problematica proposta dovrà essere discussa con l’insegnante da tutti gli alunni, al fine di individuare e condividere la strategia o le strategie di soluzione più efficaci, e di illustrare

oralmente il ragionamento sotteso ad ogni ipotesi di soluzione. Un altro importante scopo di questa attività collettiva iniziale sarà quello di condividere un modello unitario di trasferimento dalla forma orale a quella scritta di ogni situazione problematica e della relativa soluzione.
A questa iniziale attività collettiva (una volta accertato un accettabile livello di apprendimento e consolidamento di tecniche e modelli per la soluzione di problemi con l’uso delle quattro operazioni sia in forma orale che scritta da parte di tutti gli alunni), potrà seguire il lavoro individuale, anche con limiti temporali dati. A tale scopo potrà certamente risultare utile il ricorso alla seguente scheda di lavoro sulla cui falsariga, se necessario, l’insegnante potrà crearne altre simili.
Schede 26 Quale operazione? (1) • 15 Quale operazione? (2)
• Riconoscere e rappresentare linee rette, semirette e segmenti T2 T4
• Classificare e rappresentare gli angoli in base all’ampiezza T2 T4
L’approfondimento delle relazioni spaziali e delle caratteristiche delle figure geometriche, che costituisce uno degli obiettivi prioritari per la classe quarta, presuppone una adeguata conoscenza e capacità di discriminazione relativa sia alle linee che agli angoli.
Con riferimento alle analoghe attività svolte in classe terza, l’insegnante propone agli alunni una scheda contenente linee rette, semirette e segmenti e li invita, con l’utilizzo di pastelli, pennarelli ecc. a distinguerli.
Per quanto riguarda la classificazione degli angoli è preferibile che l’insegnante svolga l’attività di verifica collettivamente e in modo guidato, innanzitutto mostrando agli alunni vari tipi di angoli da lei preparati su appositi cartoncini e invitandoli a ripetere a voce alta il tipo di angolo considerato. Successivamente potrà essere svolta l’attività proposta nella seguente scheda, che prevede la classificazione degli angoli in piatto, giro, retto, ottuso e acuto.
Scheda 27 Mettiamoci alla prova con rette, semirette, segmenti e angoli
• Riconoscere, denominare e rappresentare figure geometriche T2 T4
Durante la classe terza, gli alunni hanno imparato a classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli e, al fine di verificare e consolidare gli apprendimenti relativi a questo obiettivo, l’insegnante rappresenterà le varie figure geometriche e non studiate l’anno precedente su grandi cartoncini che mostrerà uno per volta alla classe, invitando gli alunni a riconoscere e denominare il poligono rappresentato. Se i bambini troveranno difficoltà a ricordare i nomi delle figure geometriche, l’insegnante consegnerà a gruppi di alunni il materiale di lavoro utilizzato, lasciandogli la libertà di classificare le figure rappresentate secondo criteri scelti da loro. Successivamente, inviterà gli alunni a separare i poligoni dai non poligoni e ricorderà loro che: i poligoni sono figure piane che hanno come contorno una linea spezzata chiusa formata da almeno tre segmenti consecutivi.
L’insegnante inviterà gli alunni anche a individuare forme di figure non geometriche presenti nell’aula.
Utilizzando lo stesso materiale (la rappresentazione su cartoncino di poligoni con tre, quattro, cinque o più lati), l’insegnante inviterà gli alunni a individuare, nell’insieme dei poligoni, alcuni sottoinsiemi secondo il numero dei lati.
A questo punto l’insegnante formulerà alcune domande-guida come quelle di seguito elencate.
◆ Come si chiama il sottoinsieme dei poligoni con tre lati?
◆ Come si chiama il sottoinsieme dei poligoni con quattro lati?
◆ Come si chiama il sottoinsieme dei poligoni con cinque lati?
◆ In base a quale criterio hai formato i sottoinsiemi?
L’insegnante condurrà l’attenzione degli alunni sul fatto che i poligoni con tre lati hanno anche tre angoli e tre vertici, i poligoni con quattro lati hanno anche quattro angoli e quattro vertici, e così via.
Il passo successivo sarà quello di ricordare agli alunni che i poligoni con tre lati si chiamano triangoli, quelli con quattro lati si chiamano quadrilateri, quelli con cinque lati si chiamano pentagoni, quelli con sei lati si chiamano esagoni, quelli con sette lati si chiamano ettagoni e quelli con otto si chiamano ottagoni (chiarendo, però, che ne esistono anche altri raramente rintracciabili).

L’insegnante farà disegnare ad ogni alunno sul proprio quaderno quadrettato, e con l’ausilio di righello e squadra, i vari tipi di quadrilateri, e sotto ciascuno di essi farà scrivere la denominazione.
Dopo questa attività, gli alunni saranno pronti ad affrontare il compito assegnato dalla scheda proposta.
Scheda 28 Le figure geometriche

Lo svolgimento degli obiettivi del presente bimestre è funzionale al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: T1 e T2 (v. pag. 105).
• Conoscere le scienze naturali T1
Nelle prime settimane di scuola spieghiamo ai nostri alunni di che cosa si occupano le scienze naturali e sperimentali. La parola Scienza deriva dal latino scie˘ntia, che significa “conoscenza”. Le scienze naturali hanno come oggetto di studio la natura e i fenomeni naturali, cioè gli eventi che accadono in natura e che sono osservabili con i sensi o con strumenti adeguati. Per studiare le Scienze è necessario essere curiosi e guardarsi attorno, osservare e farsi domande per cercare di individuare le cause e gli effetti dei fenomeni naturali.
Stimoliamo gli alunni a comportarsi da scienziati: facciamoli avvicinare a una finestra o, se la scuola ne è dotata, conduciamoli in cortile e invitiamoli ad alzare lo sguardo verso il cielo e a descrivere ciò che osservano, come il sole che sembra spostarsi lentamente, le nuvole che eventualmente lo coprono, il colore del cielo ecc. In natura moltissimi sono i fenomeni naturali osservabili e diverse sono le Scienze che se ne occupano. Invitiamo i bambini a realizzare un cartellone murale simile allo schema proposto, arricchito da brevi didascalie in cui siano sinteticamente spiegati gli oggetti di studio delle diverse discipline scientifiche.
Scienze naturali
Terra Vita Corpi celesti
geologia geografia mineralogia sismologia vulcanologia
Trasformazione delle sostanze
anatomia umana botanica ecologia genetica zoologia chimica astronomia astrofisica cosmologia
Fenomeni in cui agiscono il movimento, le forze e l’energia acustica elettricità fisica nucleare magnetismo ottica termodinamica
Nel percorso di osservazione dei fenomeni naturali sollecitiamo i nostri alunni a utilizzare costantemente tre parole guida: come perché perciò
È importante che i bambini comprendano che l’osservazione scientifica riguarda aspetti della loro vita quotidiana e siano sollecitati a guardare con curiosità il mondo che li circonda e a porsi domande sul come e perché certi fenomeni accadono e sulle loro conseguenze.
Schede 29 Tante scienze naturali 16 Le scienze naturali
• Conoscere il lavoro dello scienziato T2
Le persone che si occupano di studiare i fenomeni naturali sono gli scienziati, che utilizzano nel loro lavoro un metodo rigoroso, cioè una procedura precisa che possa condurli alla
Benvenuti in quarta
formulazione di leggi di carattere generale per spiegare i fenomeni naturali. Evidenziamo ai nostri alunni che la parola metodo deriva dal greco méthodos, che ha il significato di “via che conduce oltre”, “strada da seguire”.
Gli scienziati studiano i fenomeni con il metodo scientifico-sperimentale, introdotto nella pratica scientifica dall’illustre fisico e astronomo Galileo Galilei.
Focalizziamo l’attenzione dei nostri alunni sulla parola “sperimentale” e sicuramente qualche bambino vi assocerà la parola “esperimento”.
Che cos’è l’esperimento?
È il momento fondamentale del metodo scientifico, perché ricrea le condizioni necessarie al verificarsi del fenomeno che si studia e consente la registrazione dei risultati che si ottengono: le scienze naturali sono sperimentali perché si fondano sul metodo sperimentale.
Il metodo scientifico-sperimentale è caratterizzato da alcune fasi che possiamo illustrare con un diagramma di flusso:
Osservazione di un fenomeno
Individuazione del problema
Formulazione di un’ipotesi
Progettazione di un esperimento
Realizzazione dell’esperimento
L’ipotesi è verificata? no
sì
Formulazione della legge scientifica

È importante evidenziare che il metodo scientifico-sperimentale, spiegando i fenomeni naturali e dando valore di verità alle leggi scientifiche, ha determinato il formarsi di conoscenze ed è stato di rilevante stimolo al progresso scientifico e tecnologico.
Domandiamo: Che cos’è il progresso? Riflettiamo insieme agli alunni e in seguito proponiamo di osservare oggetti attorno a loro e classificarli secondo il colore, le qualità o il peso.
Schede 30 Osservo... • 17 Lo scienziato e il suo metodo
• Conoscere la misura delle grandezze T2
Attraverso il metodo scientifico si possono spiegare i fenomeni naturali misurabili: se ne devono, cioè, valutare le proprietà che possono essere misurate quantitativamente, come la lunghezza, il peso, la temperatura ecc.
Solo un fenomeno che è possibile misurare può essere oggetto delle scienze sperimentali. Ai diversi tipi di fenomeni naturali corrispondono diverse grandezze fisiche e diversi strumenti per misurarle operando un confronto con le unità campione, cioè le unità di misura convenzionali.
Benvenuti in quarta

Le unità campione per misurare le grandezze fisiche sono state fissate nel 1961, quando è nato il Sistema Internazionale di unità di misura (SI - International System of Units). Le unità campione del Sistema Internazionale sono state scelte facendo riferimento a grandezze fisiche facilmente valutabili con i nostri sensi. In Italia le unità di misura del SI sono obbligatorie in tutti gli atti pubblici dal 1976 e dal 1990 sono le uniche misure ammesse.
Grandezza
Unità di misura
Simbolo
Lunghezza metro m Massa chilogrammo kg
Intervallo di tempo secondo s
Intensità di corrente elettrica ampere A
Temperatura kelvin K
Quantità di sostanza mole mol
Proponiamo ai nostri alunni divertenti esercitazioni invitandoli, per esempio, a misurare oggetti presenti nell’aula utilizzando unità di misura arbitrarie, come matite, gomme e quaderni. Facilmente i bambini verificano che la misurazione di uno stesso oggetto, effettuata impiegando unità di misura arbitrarie, non produce lo stesso risultato per tutti: è necessario ricorrere a unità di misura convenzionali (in questo caso il metro) per misurare i fenomeni ed ottenere risposte omogenee, precise, confrontabili e verificabili da tutti.
Schede 31 Osservo e rispondo… • 18 Sperimento io…
Nello svolgere la sua attività lo scienziato si serve di molti strumenti per osservare fenomeni non visibili ad occhio nudo o per misurare i fenomeni studiati.
Sollecitiamo gli alunni a comprendere che la nostra vista non è sempre sufficiente per esaminare tutto ciò che ci circonda.
Occorrono strumenti che ingrandiscano sufficientemente ciò che vogliamo osservare: la lente di ingrandimento, il cannocchiale, il binocolo, il microscopio ottico, il microscopio elettronico e il telescopio svolgono proprio questa funzione.
Altri fenomeni, per essere studiati, richiedono la misurazione delle loro proprietà attraverso strumenti differenti: servono la bilancia per misurare il peso, il termometro per quantificare la temperatura, il metro per calcolare la lunghezza, l’orologio per precisare il tempo o i cilindri graduati per accertare il volume.
Successivamente presentiamo agli alunni l’attrezzatura di cui si serve uno scienziato, con particolare riferimento al complesso e affascinante mondo degli oggetti in vetro.
Se la scuola ne è dotata, possiamo condurre la classe nel laboratorio scientifico e fare osservare e denominare gli strumenti presentati oppure possiamo realizzare un cartellone murale che riproduca un laboratorio scientifico con gli attrezzi di uso più comune.
Schede 32 Gli strumenti per misurare • 19 Gli strumenti per osservare • 20 Gli attrezzi nel laboratorio
Antologia
Letture ............................................................................................................................... pagg. 136-137
Schede operative Italiano
Schede da 1 a 6 pagg. 138-144
Storia
Schede da 7 a 10 ................................................................................................... pagg. 145-148
Geografia
Schede da 11 a 14 pagg. 149-152
Matematica
Schede da 15 a 28 pagg. 153-166
Scienze
Schede da 29 a 32 pagg. 167-170
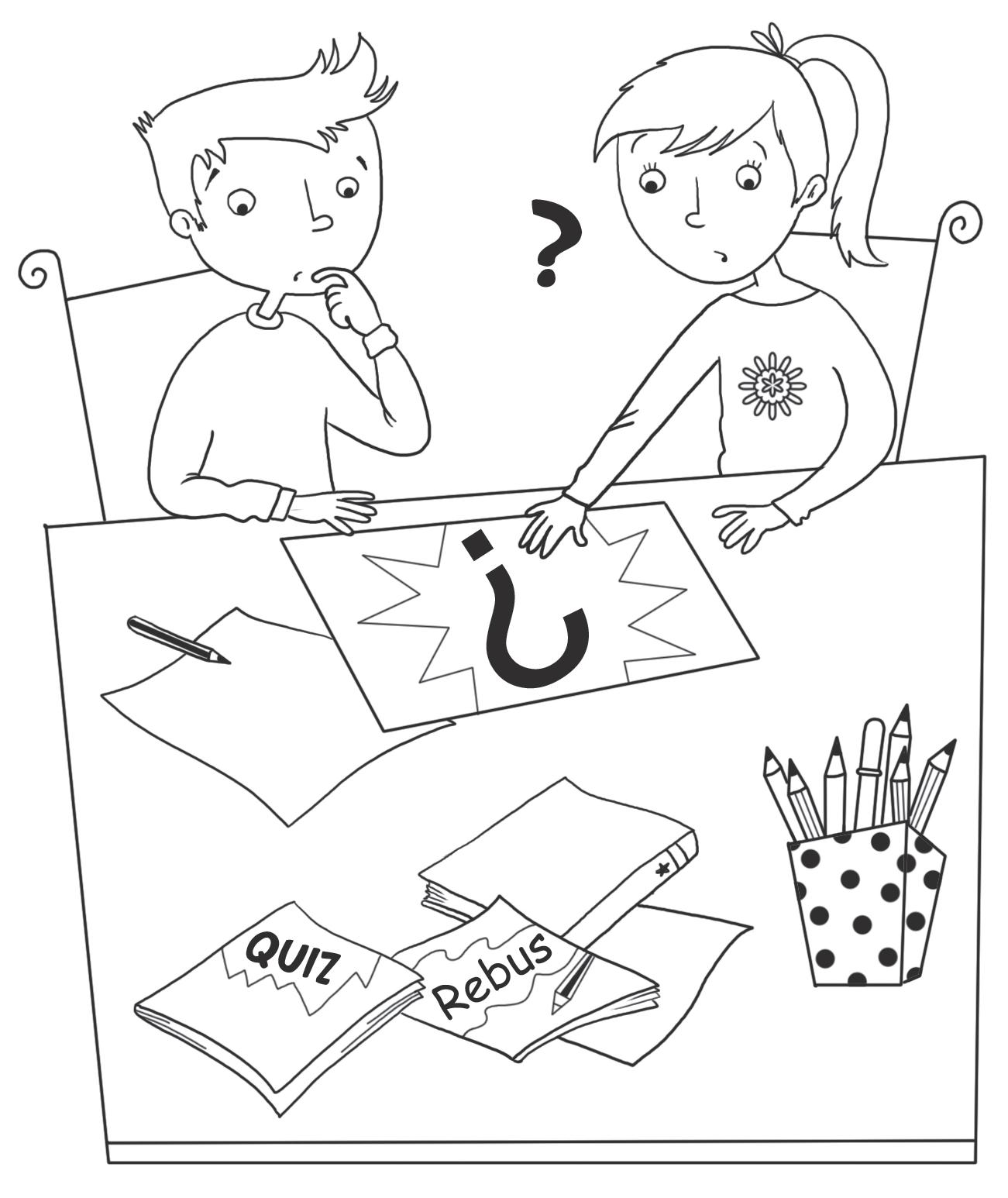

E dopo agosto, con la sua calura, viene settembre, tiepida frescura.
L’estate non è morta, ma si ammala, il giorno un po’ si accorcia, il sole cala.
Le foglie sono verdi, ma più stanche, le belle abbronzature tornano bianche.
Il bosco ronza ancora, ma più quieto, gli uccelli fanno un canto più segreto.
La scuola ricomincia a metà mese, con cose note e con delle sorprese.

Lo zaino è più pesante, tira in basso, quest’anno ti rallenta un poco il passo.
Gli amici e le amiche sono quelli,
ma sono un po’ più alti, un po’ più snelli.
Invece la maestra è sempre uguale: se è una maestra nuova, meno male.
R. Piumini, Mesi in rima, Ed. Messaggero
Arriva l’autunno, il caldo va via.
La foglia cade: ma che nostalgia!
Le vigne ricche son d’uva e nei tini allegramente fermentano i vini.
Poi vien l’inverno freddo e maestoso, di neve bianco, o grigio e piovoso.
La terra protegge i chicchi di grano che, nascosti, germogliano piano.


La primavera è dolce e graziosa e dà tepore al mughetto e alla rosa.
Cantano allegri i vispi uccellini, ridono i fiori nei prati e giardini.
Torna l’estate, ubriaca di sole, col biondo grano e dei frutti il colore; col blu del cielo e l’azzurro del mare, con le vacanze ci invita a cantare.
D. Cologgi, Verde è vita, Ed. Paoline
Benvenuti in quarta
Uno strano sogno
Questa mattina dormivo sognavo ho fatto un sogno mentre sognavo mentre dormivo.
C’era una nave che andava andava sola nel mare velava velava le onde solcava era una nave che andava andava.
Poi quella nave andava per la strada
non era una nave era un pulmino e quel pulmino stradava stradava le strade passava era un pulmino che andava andava.
Poi quel pulmino saliva le scale
non era un pulmino era un bambino scalava scalava le scale saliva.
E quel bambino
là ero io e da quel sogno mi sono svegliato eran le sette mi son preparato andavo a scuola ci sono andato.


Leggi la storia e rispondi alle domande.
In prima mocciosi!
In seconda gatti!
In terza angeli!
In quarta… RATTI!
Era la prima ricreazione del primo giorno di scuola.
– Mi piacerebbe essere ancora in terza – dissi.
– Perché? – chiese Joey.
– Perché così sarei ancora un angelo.
– Io non vorrei… neanche un po’. Ho aspettato anni per diventare un ratto. E adesso lo sono.

Joey si arrampicò fino in cima al quadro svedese gridò a tutta la palestra:
– E ne sono fiero!
Mi arrampicai anch’io. Ma mi scivolò una scarpa
Atterrai sulla mano e il pollice mi si piegò all’indietro.
Dolore! Gridai. Fortissimo. Mi misi a piangere. del quadro mi giunse la voce di Joey:
– I ratti non piangono.
Suonò la campanella: la ricreazione era finita. minuto dopo, mentre leggevamo, un ragno sulle mie ginocchia. Schizzai in piedi sul cominciai a saltellare come un forsennato urlando:
– Un ragno! Toglietemelo di dosso! Aiuto!
Poco dopo, mentre stavamo andando a mensa, sussurrò:
– I ratti non hanno paura dei ragni.
Ci sedemmo insieme in sala mensa, proprio l’anno prima. E tutti e due c’eravamo portati il pranzo da casa. Sentii Joey sghignazzare.
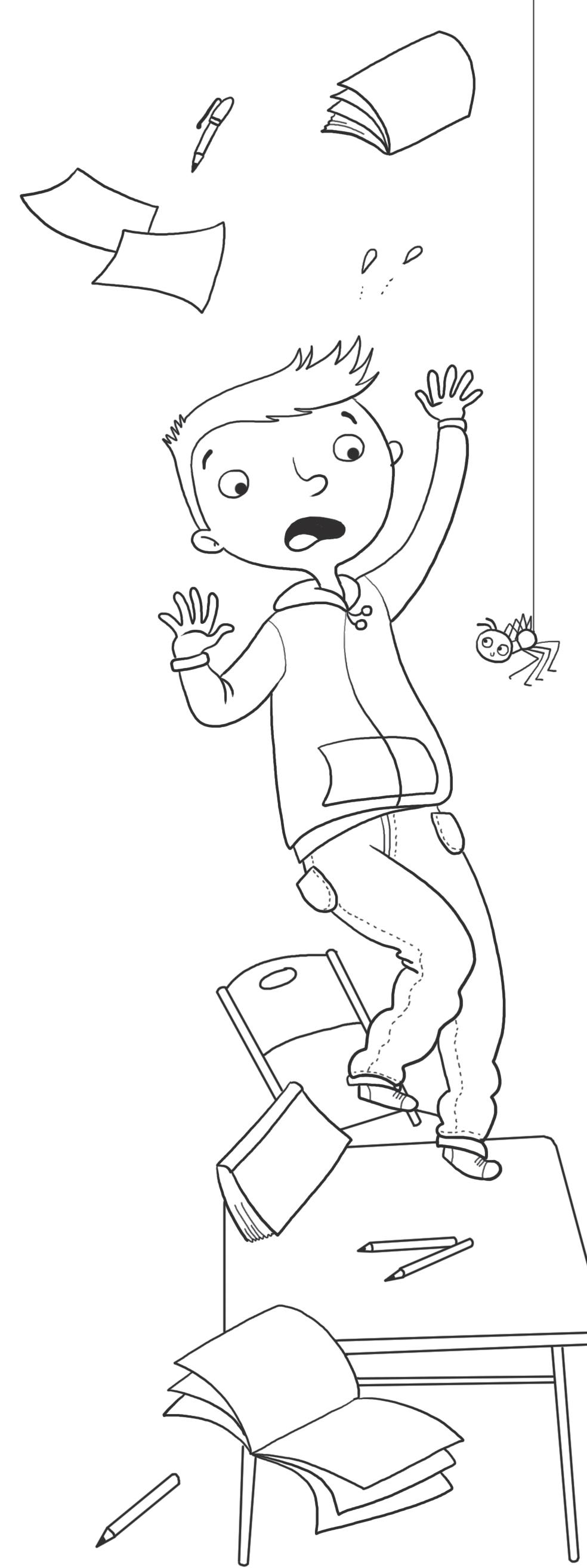
Obiettivi: Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente. Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Scuoteva la testa e ghignava.
– Che c’è di tanto divertente? – gli chiesi.
– Quello. – rispose indicando il mio cestino – Non è lo stesso che avevi l’anno scorso?
– Sì, e allora?
– Guardalo. Cosa c’è disegnato sopra?
– Elefanti che volano. E hanno grandi orecchie e giocano allo yo-yo con la proboscide. Stava per scoppiare a ridere, ma si trattenne.
– Schizzo, ma non capisci? Gli elefanti volanti sul cestino, bello mio. Roba da bambini dell’asilo. Prese il suo sacchetto di carta e me lo sventolò davanti al naso.
– Un ratto si porta il pranzo in uno di questi.
– E a me, che me ne importa?
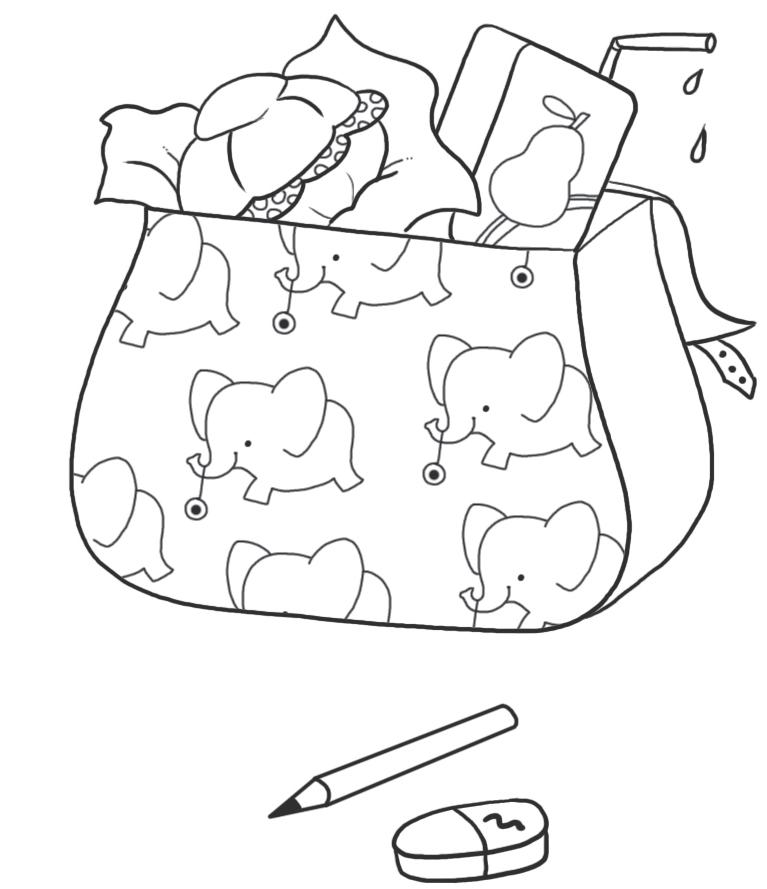
– Invece è importante, amico. Scommetto che quel cestino te l’ha dato tua madre… Ah, le mamme. Vorrebbero farti restare bambino per tutta la vita. Lasciatelo dire, Schizzo, devi darci un taglio e subito. Se permetti a tua madre di continuare così andrai al liceo con un cestino con sopra gli elefanti che volano.
Adatt. da J. Spinelli, Quarta elementare, Einaudi Scuola
1. Anche nella tua scuola c’è l’abitudine di dare soprannomi ai bambini delle varie classi? Quali? Prova anche tu a dare dei soprannomi.
In prima !
In seconda !
In terza !
In quarta ................................................................................................................................................ !
In quinta ................................................................................................................................................ !
2. Che cosa provi adesso che frequenti la classe quarta? Vorresti tornare in classe terza come Schizzo oppure sei fiero di essere arrivato in quarta come Joey?
Obiettivi: Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente. Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il
Osserva l'immagine e descrivila utilizzando gli indicatori spaziali suggeriti. Arricchisci di particolari il testo.


Gustav Klimt, La casa del guardiaboschi, 1912. Collezione privata.
1. Nell'immagine è rappresentata:
2. In primo piano ci sono:
3. Dietro, al centro:
4. In alto:
Obiettivo: Scrivere testi descrittivi chiari e coerenti.
Rispondi alle domande e scrivi il testo.

Inizio
Sviluppo
Quando?
Dove?
Chi?
Finale
Che cosa è successo?
Come ti sei comportato?
Hai pianto?
Hai strillato?
Hai chiesto aiuto?
Giudizio
Come si è concluso il fatto?
Che cosa hai provato?
Perché?
Obiettivo: Scrivere testi chiari e coerenti per raccontare vissuti e storie.
Per ogni coppia di parole, scegli quella scritta correttamente e colora la casella corrispondente. Leggi di seguito le lettere e nelle caselle colorate scopri la frase segreta.
Italia STO
Itaglia SO
Ingegniere STO
Ingegnere DI
Prociutto VA
Prosciutto VE
Città NT
Citta CO
Trè NA
Tre AN
Un’attrice DO
Un attrice DI
Igiene GR
Igene PIC
Esploratore AN
Esplorattore TE
Licquirizia DI
Liquirizia DE

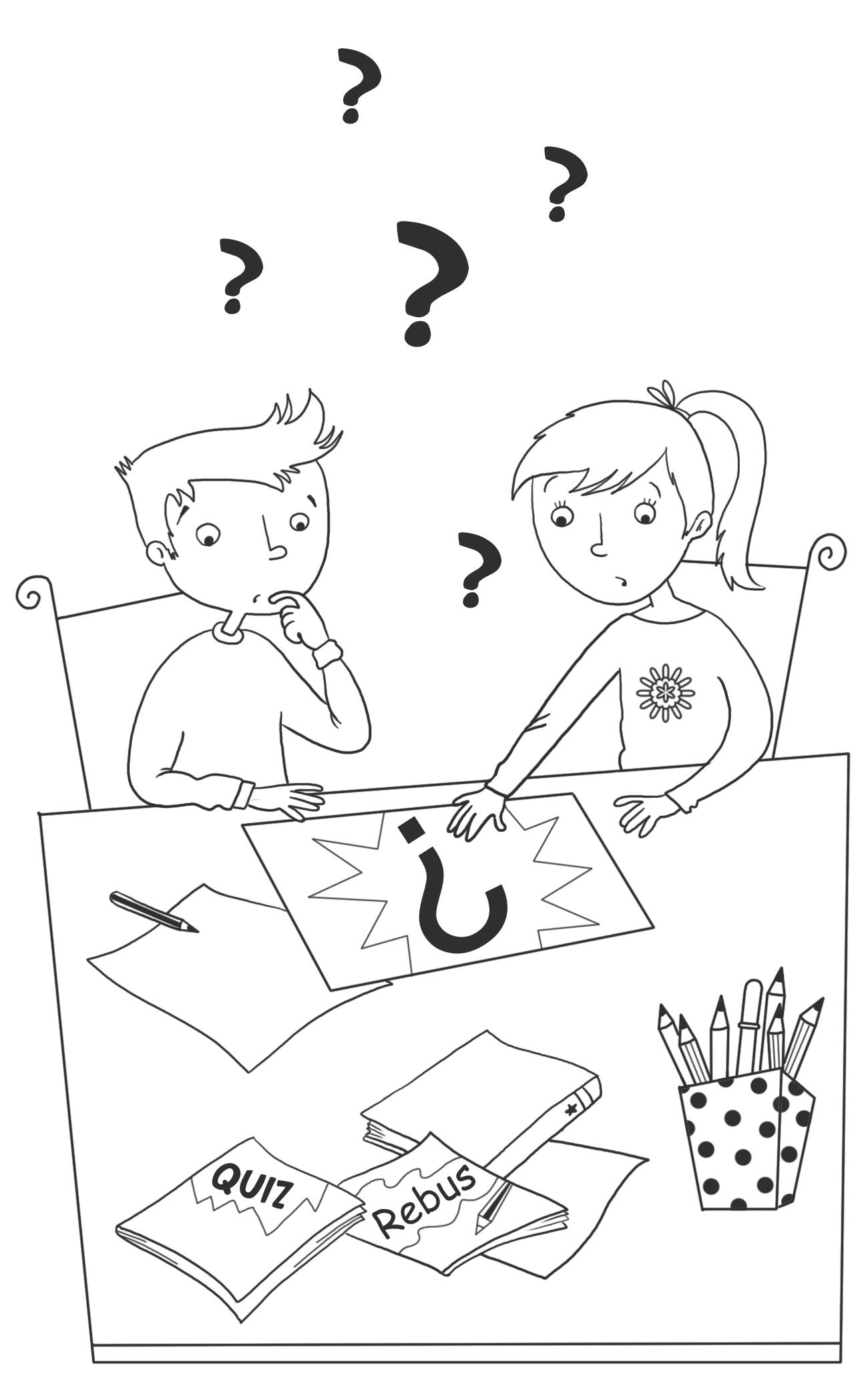
Scrivi qui la frase segreta.
Obiettivo: Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche.

Ascolta la lettura dell’insegnante e riscrivi il testo inserendo la punteggiatura giusta, vai a capo e inserisci le maiuscole dove è necessario. . . : ? ! ; ; ; ; ; ;

complimenti stai diventando grande ma sai riconoscere i pericoli fai attenzione e segui questi consigli non sporgerti troppo da finestre e balconi prima di usare gli apparecchi elettrici assicurati che non ci sia acqua non lanciare oggetti verso i compagni non fare sgambetti ai compagni non spingere i compagni attraversa la strada sulle strisce pedonali allaccia la cintura di sicurezza in auto
Leggi il testo e ricopia le parole sottolineate nella colonna giusta.
Ricomincia la scuola e arriverà anche il momento di occuparsi dell’orto. Si andrà a ispezionare le aiuole per vedere cosa è accaduto: tra le erbe forse si troveranno delle zucche, ormai mature e pronte per essere cucinate; sottoterra da qualche parte ci sono le patate!
E i fiori? Girasoli, zinnie e calendule tutti fioriti! Guarda sotto la paglia, la terra è umida e c’è un gran movimento di lombrichi. Tutto sembra molto vitale e un po’ disordinato. Le aiuole, che sono rimaste incolte dalla fine della scuola, hanno riposato per alcuni mesi e ora si possono seminare.

Ortaggi che si possono seminare in autunno e raccogliere prima dell’inverno: insalate, crescione, ravanelli e spinaci.

Ortaggi che si possono seminare in autunno e raccogliere in primavera e in estate: piselli, carote, peperoni.
M.G. Gambuzzi, D. Conati, G. Crivellente, L’orto didattico, Mela Music
Articoli Nomi Aggettivi Preposizioni Verbi
Obiettivo: Riflettere sulle parole: riconoscere le principali parti del discorso.

1 Abbina con lo stesso colore ciascuna pergamena al riquadro che completa le definizioni dei diversi tipi di fonte.
Le fonti materiali sono…
Le fonti iconografiche sono…
Le fonti orali sono…
Le fonti scritte sono…
…testimonianze verbali dirette, racconti, leggende, canti.
…iscrizioni su pietre o altro materiale, atti di nascita o di compravendita, preghiere, diari, lettere, libri.
…utensili, armi, resti di edifici, arredi, monete, tracce di cibo.
…dipinti, graffiti, sculture, mosaici, mappe, fotografie, filmati.
2 Secondo te, quali fonti si definiscono “mute”? Perché?
3 Osserva con attenzione questo graffito ritrovato in Valcamonica e scrivi tutte le informazioni che riesci a ricavare sulla vita che conduceva chi lo ha realizzato.
Graffito preistorico, Capo di Ponte, Valcamonica. Parco Nazionale delle incisioni rupestri.
Obiettivo: Conoscere le fonti della Storia.
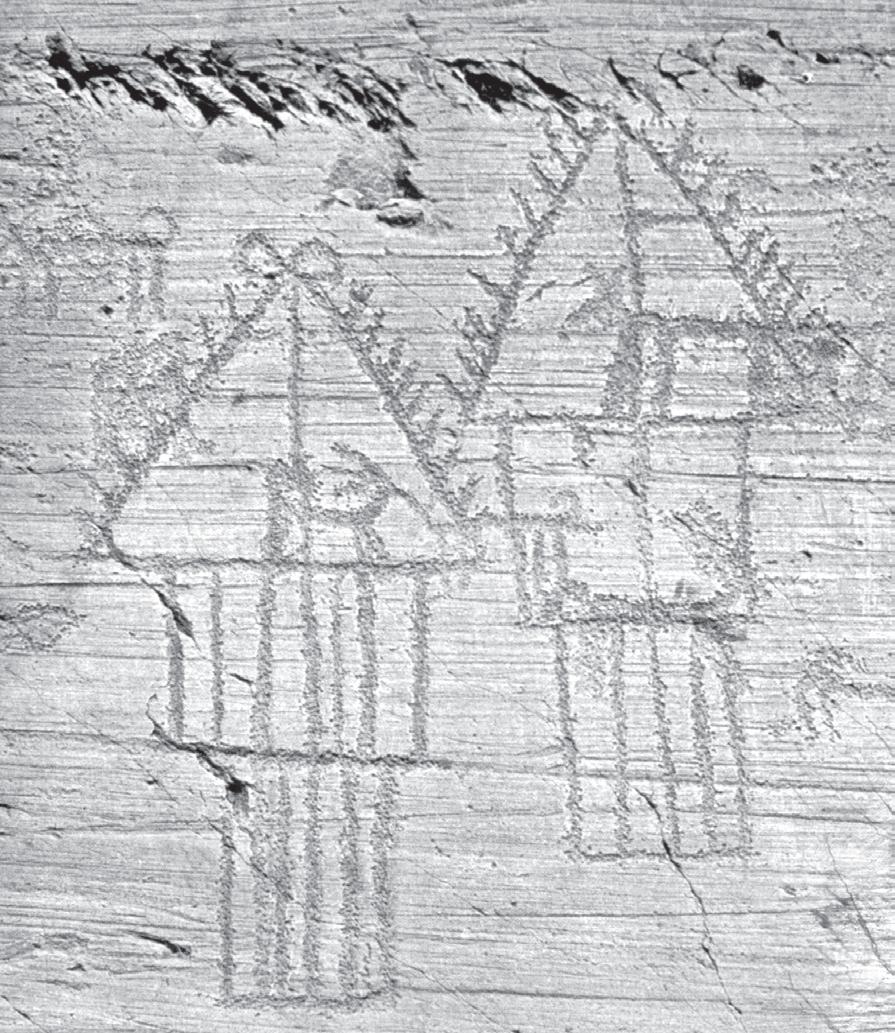
1 Leggi e sottolinea la definizione della parola “storia”.
La parola storia deriva dal greco historía, che significa “ricerca”. La parola historía deriva da un’altra parola greca, ísto¯r , che significa colui che ha visto, perciò la storia è ricerca di ciò che è stato visto, di ciò che è reale, di ciò che è documentabile.
Questa ricerca è il compito professionale dello storico, che opera la sua indagine utilizzando le fonti e seguendo il metodo storico.

2 Riscrivi in ordine nel diagramma le fasi in cui si articola il metodo storico.
Collocazione di fatti nel tempo e nello spazio • Individuazione di collegamenti tra fatti • Racconto dei fatti analizzati • Ricerca, analisi e interpretazione delle fonti • Ricostruzione di fatti
Obiettivo: Conoscere il lavoro dello storico.

1 Leggi e rispondi.
Lo storico deve disporre i fatti in ordine cronologico, sistemarli in relazione a ciò che è accaduto prima e dopo, perciò ha necessità di stabilire un punto di partenza, l’anno 0.
Per i popoli occidentali l’anno 0 coincide con l’anno di nascita di Gesù Cristo. Nel 527 d.C. il monaco Dionigi il Piccolo propose di iniziare a contare gli anni dalla nascita di Gesù Cristo e non dal momento della fondazione di Roma o dall’inizio del regno di Diocleziano, come si usava al suo tempo. Tutti gli anni precedenti la nascita di Cristo sono accompagnati dall’abbreviazione a.C. (avanti Cristo) e tutti gli anni successivi dall’abbreviazione d.C. (dopo Cristo).
Secondo te, sono in numero maggiore gli anni antecedenti la nascita di Cristo o quelli successivi?
2 Completa la linea del tempo.
1 a.C. 1 d.C.
Anno 0
3 Segna con una ✗ le affermazioni vere (V) o false (F).
1. Il 2 a.C. è più lontano nel tempo del 5 a.C. V F
2. Il 3 a.C. è più vicino nel tempo del 3 d.C. V F
3. Il 2000 d.C. è più vicino nel tempo del 1900 d.C. V F
4. Il 50 a.C. è più lontano nel tempo del 700 a.C. V F
4 Riscrivi le seguenti date ordinandole dalla più antica alla più recente.
Obiettivo: Conoscere e confrontare sistemi di datazione.
1 Leggi e completa le didascalie con brevi descrizioni.
Quando compare il primo ominide capace di scheggiare le pietre, l’Homo habilis, inizia la Preistoria umana, un lungo periodo che termina con l’invenzione della scrittura.
La Preistoria è divisa in 2 periodi o età principali:
Paleolitico Neolitico



sapiens sapiens
2 Completa il testo inserendo al posto giusto le parole elencate.
animali • antica • caccia • cuocere • falce • fuoco • illuminare • linguaggio • nomade • nuova • pesca • piante • raccolta • sedentario • zappa
Durante il Paleolitico, l’“Età della pietra ”, l’uomo vive di , di e di . Grazie alla scoperta del inizia a riscaldarsi, a la notte, a i cibi e a tenere lontano le belve feroci. Riunirsi attorno al focolare facilita lo sviluppo della socialità e delle prime forme di ....................................... Nel Paleolitico gli uomini conducono una vita .............................., cioè si spostano continuamente alla ricerca di cibo e al seguito della selvaggina. Durante il Neolitico, l’“Età della pietra .............................. ” l’uomo inizia a diventare , perché comincia a coltivare con nuovi strumenti, come la e la , e ad addomesticare .
Obiettivo: Conoscere la storia dell’evoluzione dell’uomo.

1 Leggi e sottolinea la definizione della parola “geografia”.
Il termine geografia è formato dalle parole greche geo-, derivante da gê = Terra, e -graphía, dal verbo gráphein = tracciare dei segni, descrivere.
La Geografia è una scienza che si occupa di descrivere e di conoscere la Terra. Si interessa della rappresentazione grafica dei luoghi e della loro descrizione e delle relazioni tra gli aspetti fisici e naturali di un ambiente e quelli antropici, cioè introdotti dall’uomo.
2 Completa il diagramma con le seguenti espressioni:
flora e fauna • insediamenti e attività dell’uomo • conformazione del territorio
Il geografo osserva
elementi fisici
elementi naturali
elementi antropici
3 Completa il testo inserendo al posto giusto le parole contenute nel riquadro.
analisi • descrizione • fotografie • luogo • osservazione • parole • raccolta
Il geografo segue un metodo di lavoro caratterizzato da alcune fasi:
• diretta o attraverso del luogo da studiare;
• documentazione del da studiare;
• e dei dati sul luogo;
• ........................................ del luogo attraverso ........................................ e immagini.
Obiettivo: Conoscere il lavoro del geografo.
1 Completa il testo con le parole elencate nel riquadro.
antropologo • biologo • cartografo • geologo • meteorologo
Il geografo collabora con altri studiosi che analizzano l’ambiente.
Il studia e analizza i fenomeni atmosferici, come venti, piogge, nevicate che incidono sulle caratteristiche di un ambiente.
Il studia gli organismi viventi e le condizioni di vita del loro ambiente.
L’ studia i costumi e le tradizioni dei popoli che vivono in un ambiente.
Il studia la struttura della Terra e i fenomeni naturali, come le eruzioni vulcaniche e l’erosione che modificano l’ambiente.

Il si occupa della stesura di carte, piante e mappe rappresentative di un ambiente.

2 Collega ciascuna illustrazione allo specialista a cui si riferisce. Cartografo
Antropologo Meteorologo
Biologo Geologo




Obiettivo: Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie della Geografia.

1 Collega con frecce ciascuna scala con la sua descrizione e con la sua rappresentazione.
La riduzione del territorio è espressa con un segmento diviso in parti uguali e ogni parte rappresenta una distanza reale.
Scala grafica
Scala numerica
La riduzione del territorio è espressa con numeri che indicano di quante volte la realtà è stata rimpicciolita.
2 Osserva la carta, sottolinea in rosso la scala numerica e in giallo la scala grafica, poi rispondi alle domande.
Qual è la scala numerica?
Nella scala grafica a quanto corrisponde 1 cm?
................................................................
3 Scegli due luoghi sulla carta e misura la distanza con il tuo righello.
Che luoghi hai scelto?
1. .........................................................
2. .........................................................
Quanti cm distano sulla carta?
A quanti km nella realtà corrispondono? ............................ 1 : 150000
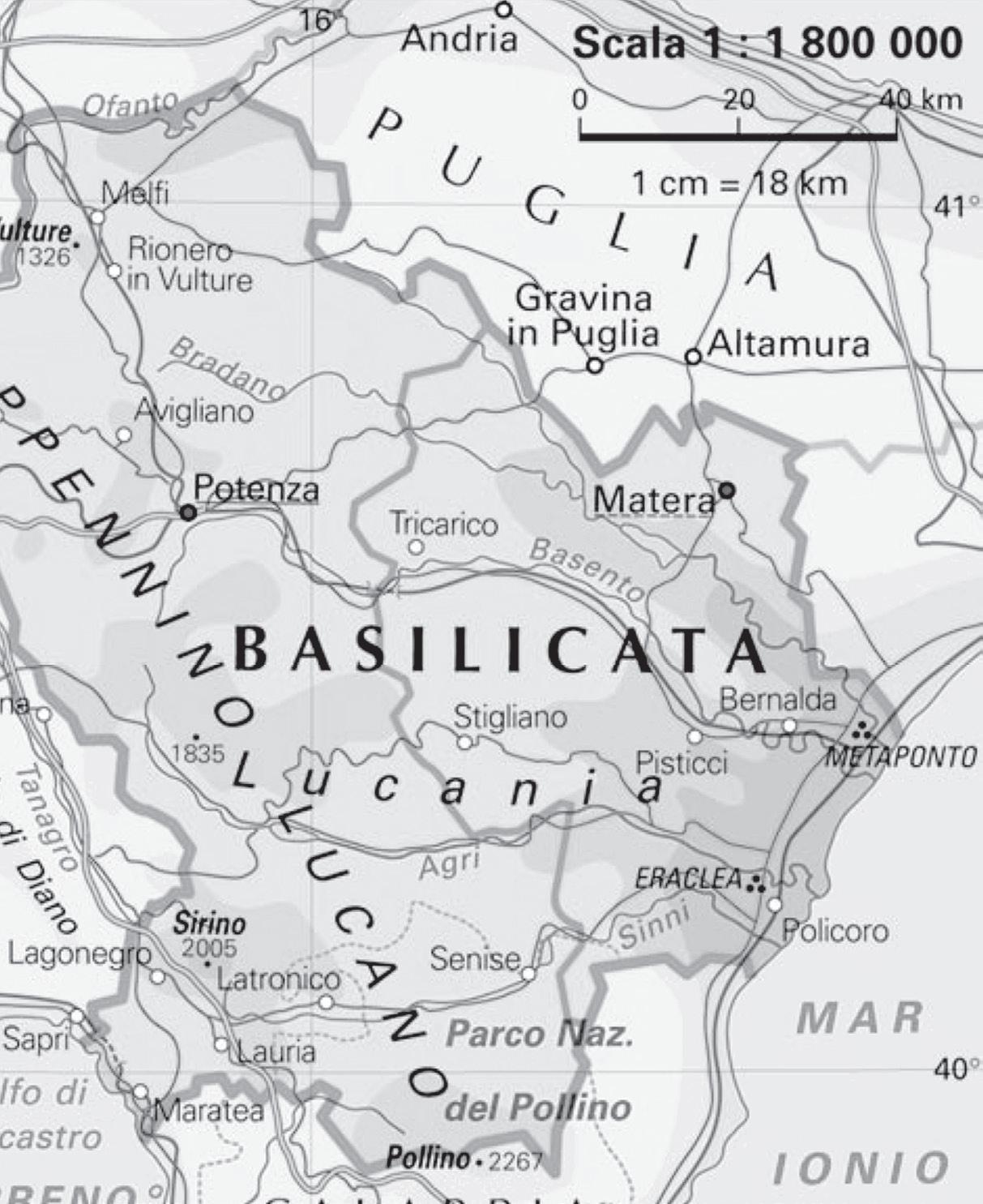
Obiettivo: Conoscere e descrivere diversi tipi di carte.
1 Leggi questo ideogramma e rispondi.














1993 1999 2004


Quali informazioni ci fornisce questo ideogramma?
Che cosa indica ciascuno zaino?
In quale anno c’è il numero minore di alunni stranieri in Italia?
In quale anno c’è il numero maggiore di alunni stranieri in Italia?
2 Leggi questi dati e realizza un ideogramma seguendo la legenda.
Stagione
Alunni stranieri presenti in Italia = 30 000 alunni = 5 giorni di pioggia legenda
Giorni di pioggia a Roma nel 2000
Primavera 25 Estate 10 Autunno 20 Inverno 30
Giorni di pioggia a Roma nel 2000

Obiettivo: Leggere e rappresentare dati statistici.

Osserva i disegni e completa il diagramma di Venn







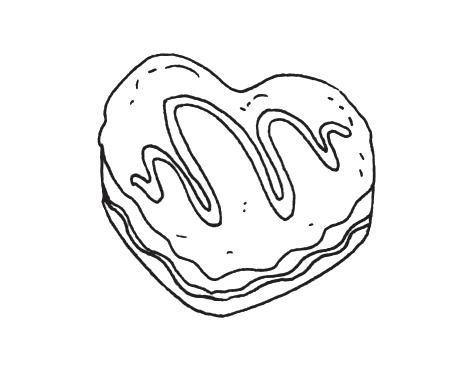
insieme di A
Osserva i disegni e colloca i numeri al posto giusto nei diagrammi che seguono.
a) Diagramma di Carroll.
Gancio Non gancio cornice
non cornice

b) Diagramma ad albero.
Obiettivo: Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero.

1 Completa scrivendo il numero in parola.
Parole 845 976 703 680
2 Leggi e scrivi il numero in cifre.
Parole Cifre cinquecentododici trecentosettantaquattro quattrocentonove duecento
3 Osserva e rispondi.


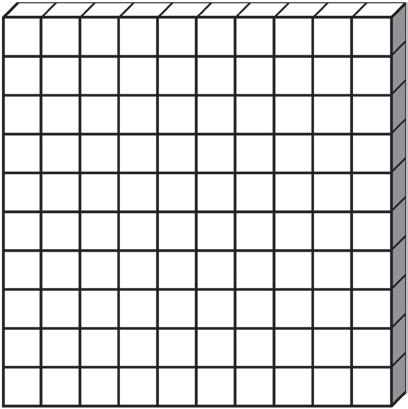
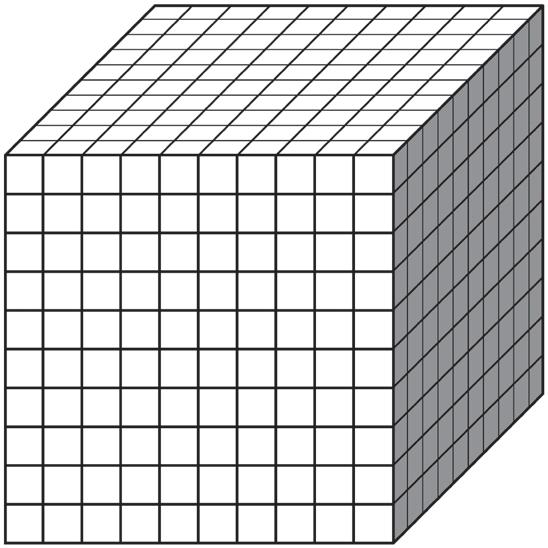
1. Quante unità ti occorrono per formare una decina?
2. Quante decine ti occorrono per formare un centinaio?
3. Quante unità ti occorrono per formare un centinaio? ........................
4. Quante centinaia ti occorrono per formare un migliaio? ........................
5. Quante decine ti occorrono per formare un migliaio?
6. Quante unità ti occorrono per formare un migliaio? unità decina centinaio migliaio
Obiettivo: Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci entro il 1000.
Racchiudi i pezzi uguali del materiale B.A.M. in un insieme, collega ogni insieme alla cifra corrispondente e scrivi il numero in lettere.
Materiale B.A.M. k h da u Numero in lettere

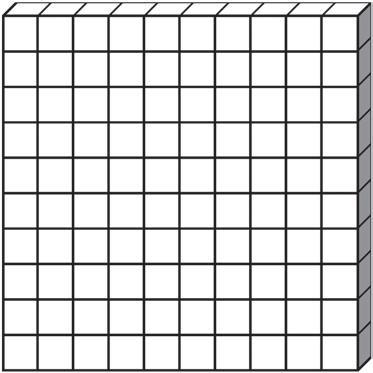






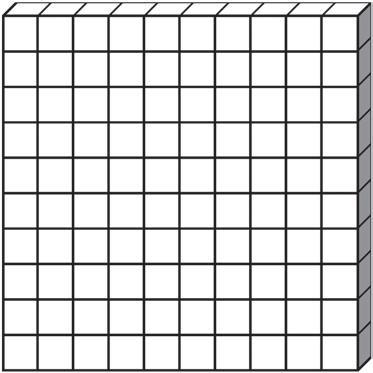










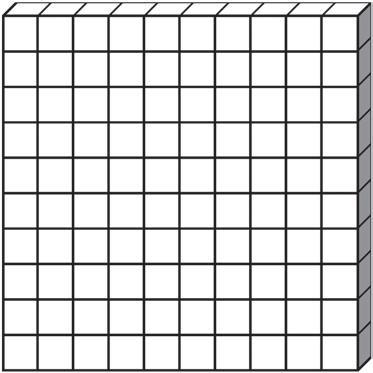








Obiettivo: Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci entro il 1000.

Registra sull’abaco le quantità rappresentate con il materiale B.A.M. e scrivi il numero in cifre. k h da u
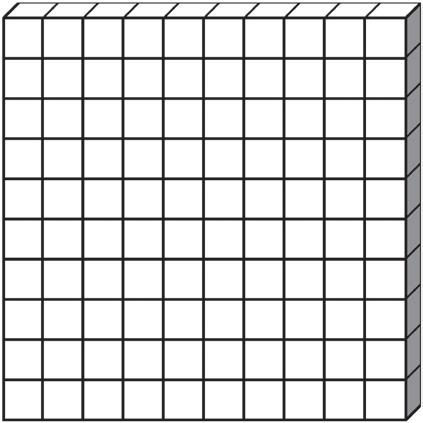
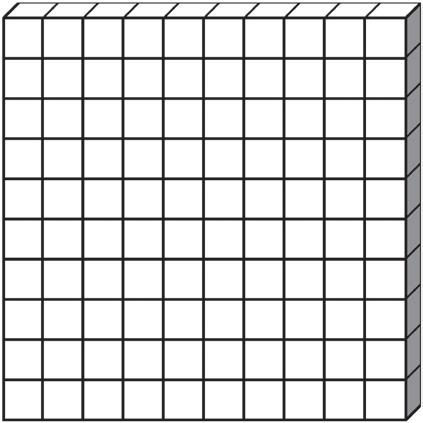

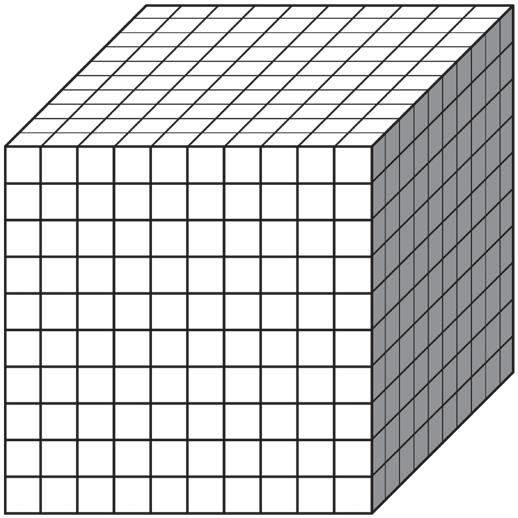
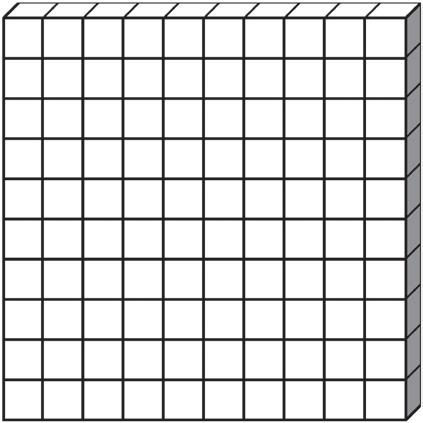








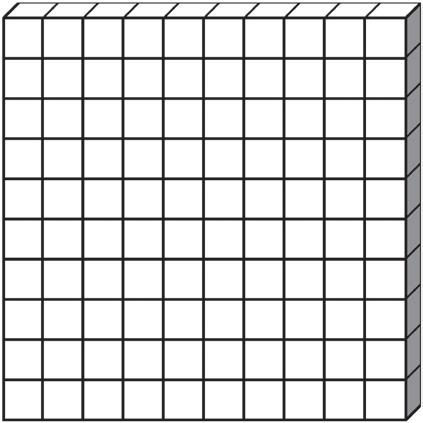
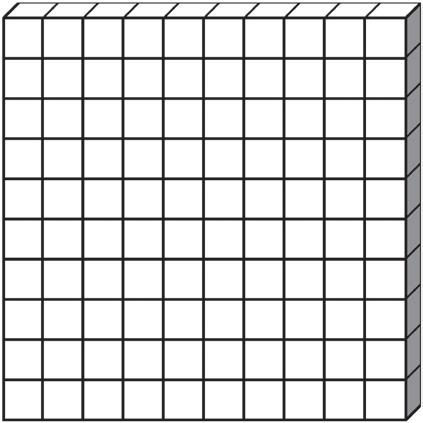








Obiettivo: Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci entro il 1000.
k h da u k h da u k h da u
1 Usa la tabella delle unità, decine, centinaia e migliaia per incolonnare i seguenti numeri, trascrivendo non più di una cifra in ogni colonna.
Migliaia k Centinaia h Decine da Unità u
2 unità 13 unità
124 unità 10 decine e 3 unità
100 decine

2 Leggi e rappresenta il numero sull’abaco, poi scomponilo come nell’esempio.
1 migliaio k h da u seicentosettantaquattro ➝ = = =
ottocentodue
802 ➝ 8 h = 800 0 da = 0 2 u = 2 k h da u 8 0 2
quattrocentoventisette ➝ = = = k h da u
3 Continua l’esercizio sul quaderno con i seguenti numeri. trecentovetisette - duecentoquattro - seicentocinquantaquattro cinquecentoventidue - settecentonavanta - novecentocinque
Obiettivo: Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità.

1 Metti in ordine dal minore al maggiore i seguenti numeri.
2 Completa la tabella.
3 Metti il segno > , < o = tra i due numeri di ciascuna coppia.
4
Esegui le operazioni in riga.

Obiettivo: Eseguire le quattro operazioni in riga.

Esegui sul quaderno le seguenti addizioni e sottrazioni mettendo i numeri in colonna e scrivendo accanto i relativi termini, come negli esempi.
137 + Addendo
85 = Addendo 222 Somma o totale 1 224 – Minuendo 138 = Sottraendo 86 Differenza 11 1 1
137 + 85 =
265 + 178 =
384 + 28 = 499 + 28 = 209 + 82 =
346 + 75 =
325 + 286 =
128 + 98 =
257 + 147 =
395 + 55 =
741 + 179 =
464 + 187 =
428 + 295 =
343 + 77 =
269 + 145 = 196 + 154 =
588 + 85 + 4 =
367 + 147 + 3 =
381 + 122 + 28 =
456 + 75 + 15 =
224 – 138 = 532 – 279 = 511 – 269 = 623 – 147 = 401 – 134 = 311 – 289 = 430 – 182 = 364 – 75 = 305 – 66 = 214 – 168 = 481 – 295 = 523 – 167 = 714 – 345 = 911 – 498 = 926 – 487 = 305 – 138 = 137 – 79 = 144 – 86 = 608 – 499 = 747 – 398 =
Obiettivo: Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con due cambi.
Esegui sul quaderno le moltiplicazioni mettendo i numeri in colonna e scrivendo accanto i relativi termini, come nell’esempio.
124 3 Moltiplicando 2 = Moltiplicatore 248 Prodotto
3 Moltiplicando
= Moltiplicatore 296 + Prodotto parziale
= Prodotto parziale
Prodotto finale Senza il cambio

Obiettivo: Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una e di due cifre.

Senza il cambio
Obiettivo: Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza e con il cambio, con e senza resto.
Leggi attentamente il testo di ogni problema e cerchia con il blu i dati e con il rosso la domanda. Segna con una ✗ l’operazione necessaria e infine risolvi sul quaderno.
Problema n. 1
Nel suo album di 189 figurine Emilio ne ha incollate 97. Quante figurine dovrà ancora incollare?
3 :
Problema n. 2
Agli inquilini del primo palazzo di un parco il postino ha consegnato 13 lettere. A quelli del secondo palazzo ne ha consegnate 28 e a quelli del terzo solo 8. Quante lettere ha consegnato complessivamente il postino?

– 3 :
Problema n. 3
I compagni della quarta A durante le vacanze hanno letto 15 libri in meno di quelli della quarta B che ne hanno letti 62. Quanti libri hanno letto gli alunni della quarta A?
3 :
Problema n. 4
Il letturista ha rilevato che ciascuno dei 22 inquilini di un condominio ha consumato un’eccedenza di acqua del valore di 17 euro. Quanto dovrà pagare complessivamente il condominio per il consumo eccedente?
– 3 :
Problema n. 5
In una camiceria le 378 camicie per la nuova stagione verranno sistemate in 9 espositori. Quante camicie conterrà ogni espositore?
3 :
Obiettivo: Risolvere situazioni problematiche con l’uso delle quattro operazioni.

1 Disegna le seguenti linee nelle posizioni indicate.
retta orizzontale semiretta verticale segmento obliquo retta obliqua
semiretta orizzontale segmento verticale semiretta obliqua
2 Classifica gli angoli in retto, piatto, giro, acuto e ottuso.
Obiettivi: Riconoscere e rappresentare linee rette, semirette e segmenti. Classificare e rappresentare gli angoli in base all’ampiezza.
Completa la tabella e scrivi nell’ultima colonna “triangolo”, “quadrilatero”, “pentagono” o “esagono”.
Poligono
Numero di lati
Numero di angoli
Numero di vertici

Si definisce
Obiettivo: Riconoscere, denominare e rappresentare figure geometriche.

1 Leggi e completa il testo inserendo al posto giusto le parole contenute nel riquadro.
biologia • chimica • fisica • scienze astronomiche • scienze della Terra
Le scienze naturali, che studiano la natura e i tantissimi fenomeni naturali, sono suddivise in alcuni gruppi.
Le studiano i fenomeni riguardanti i corpi celesti.
Le si occupano dei fenomeni che interessano il pianeta Terra e comprendono la geologia, la geografia, la mineralogia, la sismologia e la vulcanologia.
La ...................................................................... analizza i fenomeni che si riferiscono alla vita e si suddivide in molte discipline: l’anatomia umana, la botanica, la zoologia, ecc.
La si occupa dei fenomeni in cui agiscono il movimento, le forze e l’energia e comprende l’acustica, l’ottica, la fisica nucleare, l’elettricità, la meccanica.
La si interessa dei fenomeni che comportano una trasformazione delle sostanze.
2 Collega ciascuna illustrazione con la disciplina che se ne occupa.


Obiettivo: Conoscere le scienze naturali.
Zoologia
Vulcanologia Astronomia

Botanica

Osserva intorno a te gli oggetti raffigurati e completa la tabella dove è possibile.
Oggetto Colore Liscio/ruvido Caldo/freddo Elastico/rigido
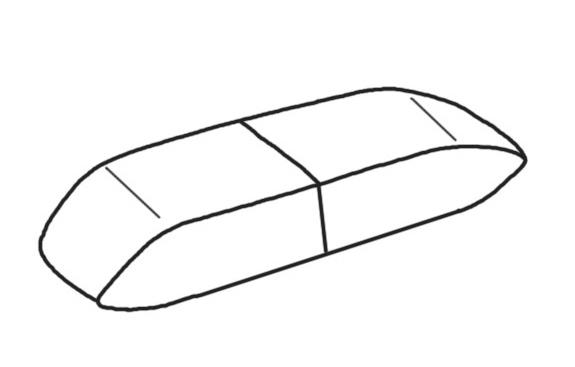
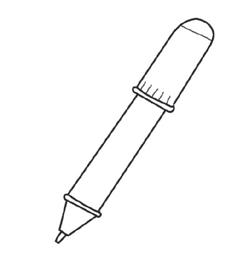
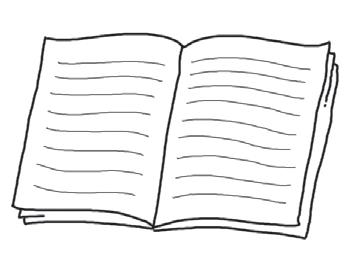
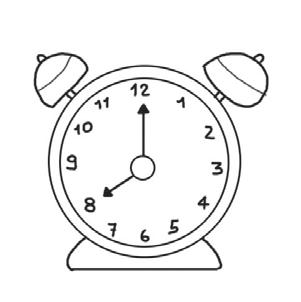
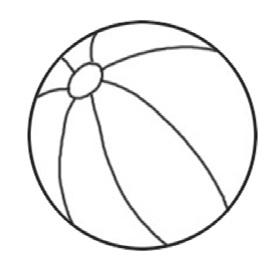
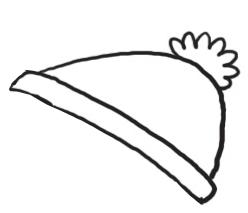




Obiettivo: Conoscere il lavoro dello scienziato.

1 Osserva questa illustrazione, colorala in maniera appropriata e poi rispondi.

1. Che cosa vedi?
2. Di che colore è?
3. Che forma ha?
4. Quanto è lunga?
5. Quanto pesa? ......................................................................................................................................
Hai risposto a tutte le domande?
A quali domande non hai potuto rispondere? La n° e la n° .
Per rispondere a queste domande occorre effettuare una misurazione, utilizzando le unità di misura.
2 Collega ciascuna domanda allo strumento che ti
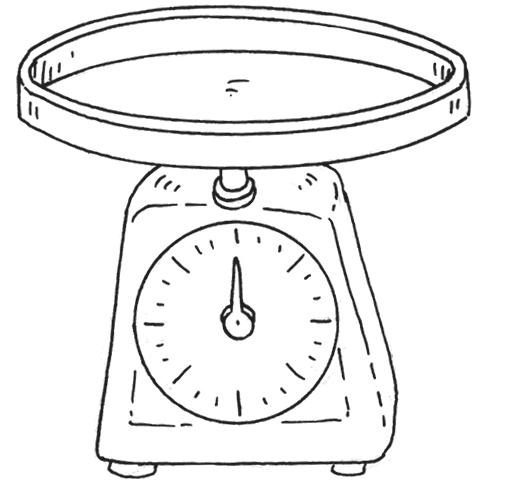
Quanto è lunga?
Quanto pesa?
Obiettivo: Conoscere la misura delle grandezze.

1 Leggi e completa il testo, scegliendo il nome giusto tra quelli elencati nel riquadro.
Alcuni fenomeni, per essere studiati, richiedono la misurazione delle loro proprietà attraverso strumenti differenti.
La misura il peso.
Il quantifica la temperatura.
Il misura la lunghezza.
L’ segna il tempo.
Il accerta il volume.
Bilancia
Cilindro graduato
Metro
Orologio
Termometro
2 Che cosa usi per misurare? Leggi le frasi e collegale con l’illustrazione dello strumento adatto.




Il peso del tuo zaino.
Il volume di una mela.
L’altezza della lavagna.
Il tuo peso.
La durata di un film.
La temperatura del tuo corpo.
La lunghezza del tuo banco.
Il peso della tua merendina.
La durata della verifica di scienze.
Obiettivo: Conoscere e confrontare gli strumenti dello scienziato.


