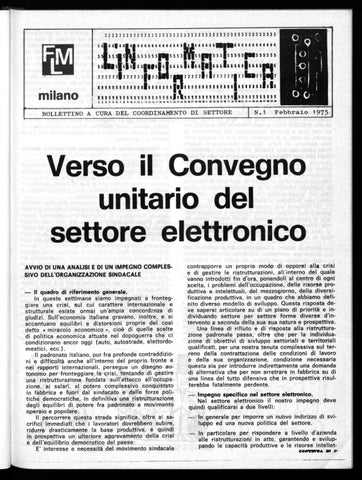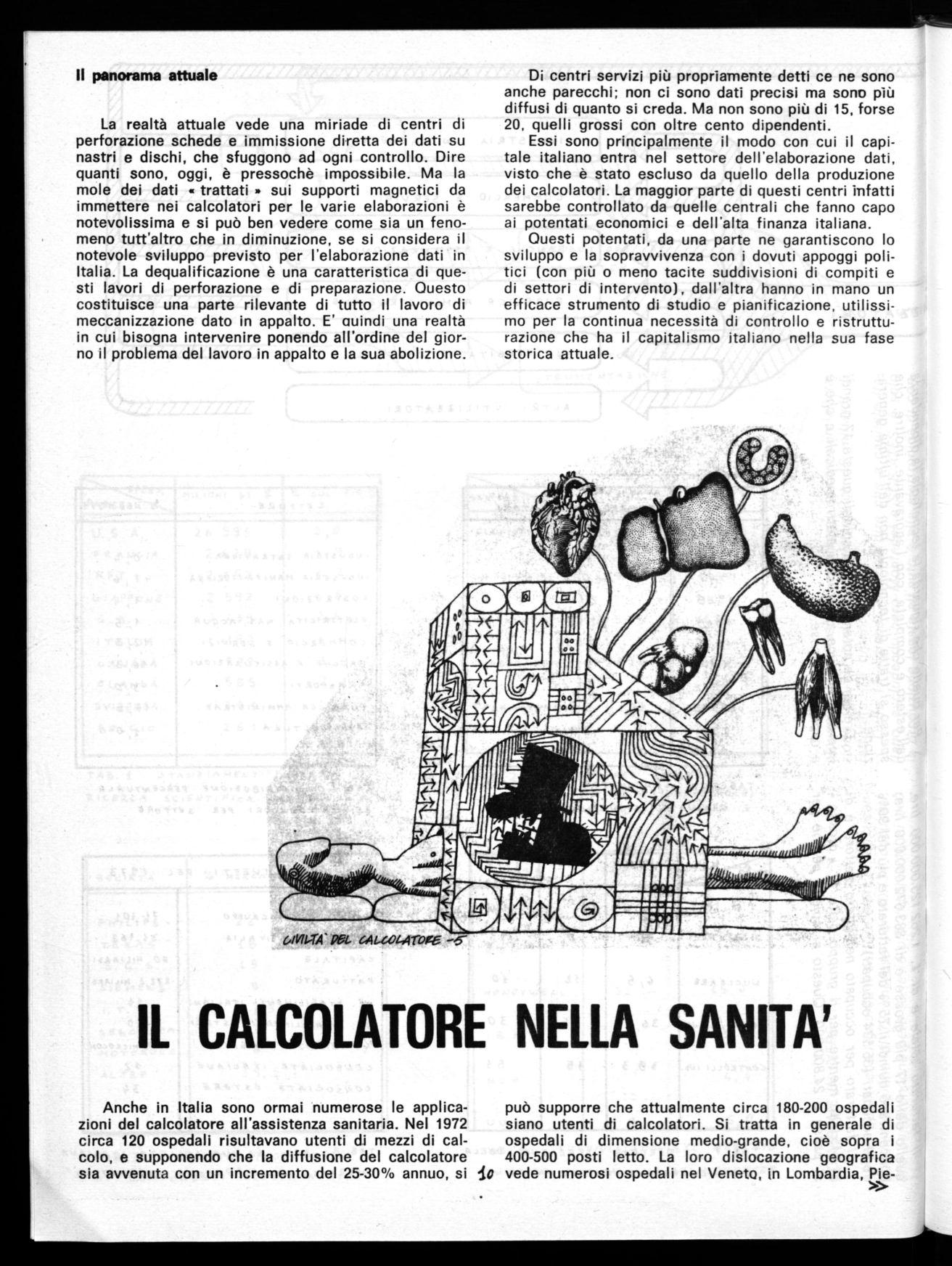
3 minute read
IL CALCOLATORE NELLA UNITA'
from Informatica1
Anche in Italia sono ormai numerose le applicazioni del calcolatore all'assistenza sanitaria. Nel 1972 circa 120 ospedali risultavano utenti di mezzi di calcolo, e supponendo che la diffusione del calcolatore sia avvenuta con un incremento del 25-30% annuo, si può supporre che attualmente circa 180-200 ospedali siano utenti di calcolatori. Si tratta in generale di ospedali di dimensione medio-grande, cioè sopra i 400-500 posti letto. La loro dislocazione geografica .10 vede numerosi ospedali nel Veneto, in Lombardia, Pie- monte ed Emilia, ed i più grossi ospedali nel Mezzogiorno.
Apparentemente, il fatto che un calcolatore sia usato « per la salute » sembrerebbe di per sè un modo « positivo » di utilizzarlo. In realtà occorre guardare un po' più a fondo in questo settore, per cercare di ricavarne alcune indicazioni di massima.
Advertisement
Fino ad ora, come si è detto, nella sanità il calcolatore è entrato esclusivamente attraverso l'ospedale. Questo, essendo nella società attuale, organizzato come una azienda, ha incontrato gli stessi problemi delle aziende produttive: crescita del lavoro burocratico, conseguente aumento del personale impiegatizio e conseguente aumento dei costi. A questi problemi ogni ospedale, in assoluta autonomia e mancanza di coordinamento, ha cercato di far fronte con l'adozione del calcolatore, utilizzandolo prevalentemente per la preparazione delle paghe e stipendi del personale, e per la fatturazione delle rette di degenza, talvolta per la gestione dei magazzini. In questo modo, l'introduzione del calcolatore ha rafforzato il carattere aziendale dell'ospedale, senza per altro consentire, finora, un vero ed efficace controllo di gestione sull'attività e sulla spesa dell'ospedale stesso.
Oltre che per le applicazioni contabili-gestionali, il calcolatore è stato frequentemente usato nella gestione del laboratorio di analisi, in base alla considerazione che lì si trattavano dati numerici, e quindi più facilmente gestibili su calcolatore.
Le case costruttrici di calcolatori guardano alla sanità come ad un mercato molto promettente perchè poco critico, ripetendo in sostanza la strategia commerciale che dieci anni fa le portò, complice la impreparazione degli utenti, ad invadare il mercato delle aziende produttive. In questo settore è impegnata, oltre le consuete IBM, Honeywell ed Univac, anche la FIAT, attraverso la proprietà della SORIN e della SPO e la sua partecipazione alla SAGO.
Si può affermare con certezza che l'introduzione del calcolatore ha apportato sostanziali benefici nel settore dell'assistenza sanitaria? Ha veramente migliorato il modo di offrire al cittadino un servizio sanitario? Allo stato attuale ci sembra problematico affermarlo, per le ragioni che abbiamo detto. L'utilizzazione del calcolatore per fini amministrativo-gestionali può aver consentito — diciamo può perchà la cosa è tutt'altro che dimostrata — qualche aumento dell'efficienza del lavoro burocratico, sen'a che questo si sia tradotto in un vero miglioramento assistenziale: negli ospedali si fa ancora la fila per l'accettazione e per le visite ambulatoriali, si ripetono ancora tutti gli esami di laboratorio e radiografici ad ogni ammissione, si attendono ancora in un letto giornate intere per poter fare una radiografia. Il calcolatore non poteva incidere in una situazione organizzativa che dipende dai rapporti di potere esistenti dentro l'ospedale, dal sovraccarico, dalla carenza degli organici, dall'atteggiamento della componente medica. Credere, o far credere, che questi problemi siano superabili con una soluzione puramente tecnica e non politica, ha rappresentato la mistificazione tecnocratica attraverso la quale il calcolatore è entrato nella sanità.
E' possibile servirsi di questi strumenti per una gestione diversa del problema della salute? La risposta non è immediata, perchè le elaborazioni e le sperimentazioni che si muovono lungo una linea non tecnocratica sono ancora molto scarse. Esse sono dovute prevalentemente ad alcune Regioni (Emilia, Umbria,
Toscana) che si sono correttamente posto, prima ancora del problema « calcolatore o non calcolatore », il problema di quali possano essere i criteri per gestire l'informazione sanitaria, elemento certo non trascurabile di una corretta politica sanitaria. Evitando la tentazione di ricalcare pedissequamente i modelli stranieri (come il celebre Sistema Informativo automatizzato realizzato in Svezia, che trova la sua matrice in una impostazione personale ed atomizzata, cioè non politica, del rapporto cittadino-stato), si cerca di elaborare e sperimentare modi di gestione dell'informazione, o, come si dice, sistemi informativi, che: non privilegino il momento della cura, rappresentato dall'ospedale, ma accentuino il momento della prevenzione, cioè della conservazione dello stato di salute; superino il criterio della dimensione strettamente individuale, privilegiando ad esempio il gruppo omogeneo in fabbrica, il distretto di quartiere o scolastico, rispetto al cittadino considerato isolato dal suo contesto; rinuncino almeno in parte all'oggettivazione carismatica ed autoritaria da parte del medico, recuperando gli elementi soggettivi dell'informazione. Gli esperimenti pilota in questo senso sono quelli di controllo operaio della nocività, per esempio alla Montedison di Castellanza e alle Acciaierie di Terni; che non « esproprino » i soggetti delle loro informazioni, ma gli lascino in ogni momento il controllo su queste informazioni, sull'uso che se ne fa, sulle elaborazioni alle quali si assoggettano.
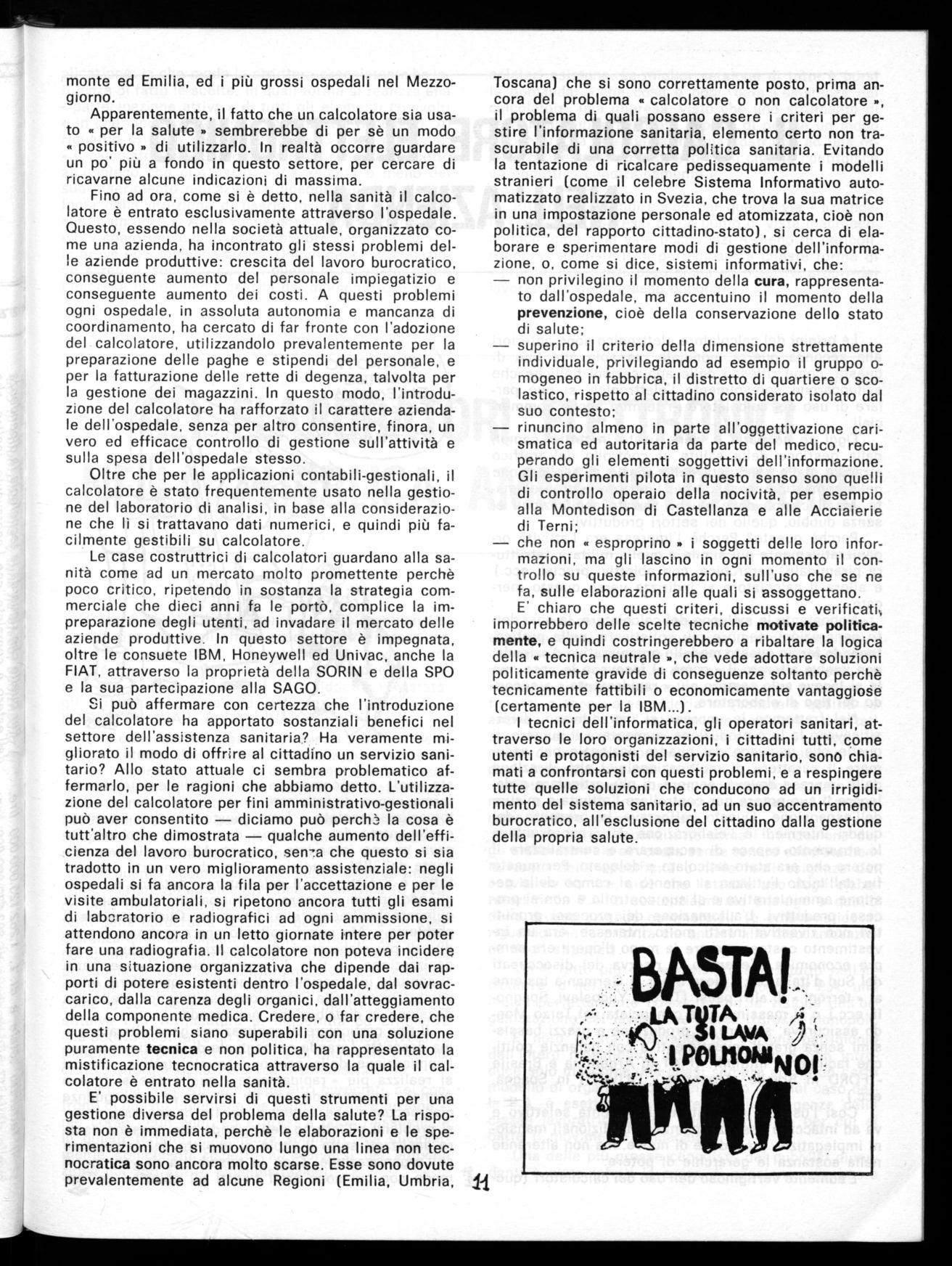
E' chiaro che questi criteri, discussi e verificati, imporrebbero delle scelte tecniche motivate politicamente, e quindi costringerebbero a ribaltare la logica della « tecnica neutrale », che vede adottare soluzioni politicamente gravide di conseguenze soltanto perchè tecnicamente fattibili o economicamente vantaggioSe (certamente per la IBM...).
I tecnici dell'informatica, gli operatori sanitari, attraverso le loro organizzazioni, i cittadini tutti, come utenti e protagonisti del servizio sanitario, sono chiamati a confrontarsi con questi problemi, e a respingere tutte quelle soluzioni che conducono ad un irrigidimento del sistema sanitario, ad un suo accentramento burocratico, all'esclusione del cittadino dalla gestione della propria salute.