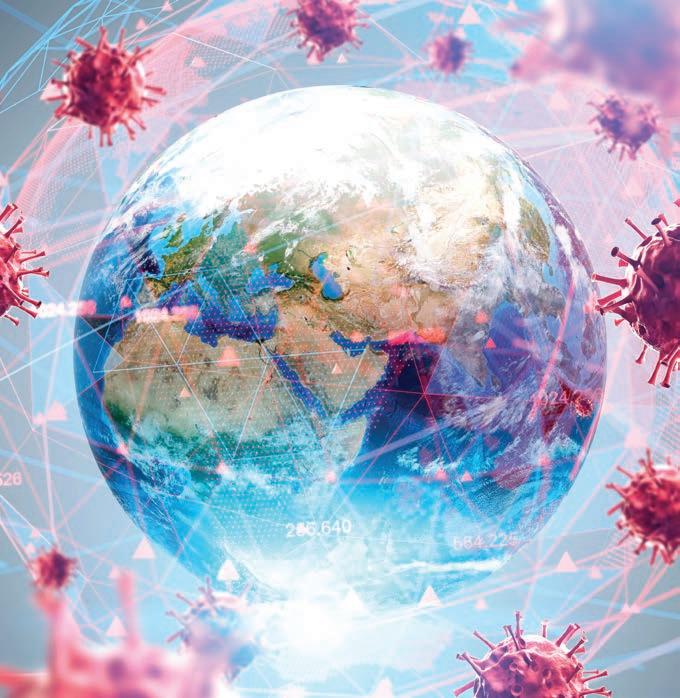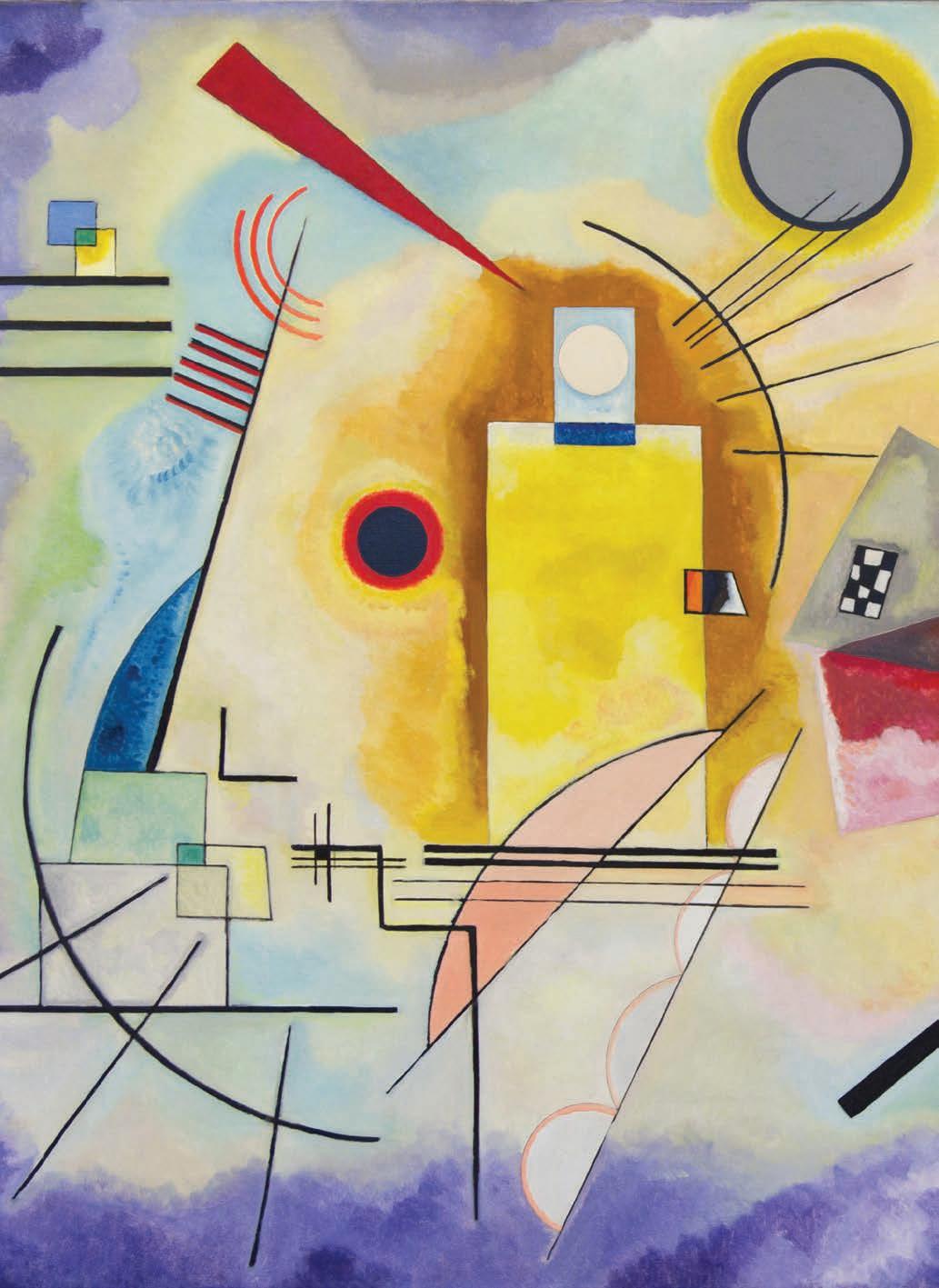5 minute read
La Didattica a Distanza tra istruire e insegnare Pierluigi Fratarcangeli
LA DaD TRA ISTRUIRE E INSEGNARE L’OPINIONE DI UN DOCENTE
di Pierluigi Fratarcangeli
PAROLE CHIAVE: DaD, SCUOLA, RELAZIONE, NUOVE TECNOLOGIE, CORONAVIRUS
Alcune considerazioni sulla DaD in questo periodo di clausura forzata che rivoluziona il nostro modo di fare ed essere scuola e rimodula il ruolo di insegnanti, studenti e genitori. Cosa abbiamo da imparare da questa crisi così dirompente? Cosa ci insegna sulle nuove tecnologie e di cosa è bene riappropriarsi quando sarà tutto finito?
Con l’emergenza COVID-19 alla maggior parte dei docenti è piombata sulla testa la necessità, e non soltanto l’opportunità, di applicare metodi e strumenti della DaD, che sta per “didattica a distanza”. Alcuni erano già avvezzi alle nuove tecnologie, ma molti altri si sono dovuti adeguare alla situazione come hanno potuto, e continuano ad adeguarsi tra difficoltà varie dovute alla mancanza di competenze digitali e di strumenti adatti. Gli stessi distinguo valgono, ovviamente, anche per le scuole (e le famiglie): alcune informatizzate fino ai denti, altre carenti di strutture e mezzi. A ciò si aggiunga la componente alunni, che sono un ulteriore universo variegato, che comprende sia chi è fornito di strumenti e capacità sia chi non possiede né gli uni né le altre. Rispetto a questa situazione inedita, nel momento in cui intendiamo fare considerazioni il più possibile costruttive, dobbiamo tenere conto di alcuni generali principi che guidano qualsiasi valutazione in ogni ambito: anzitutto la necessità di evitare generalizzazioni, che non rendono meriti alle positività e ne danno troppi alle negatività; in secondo luogo la possibilità di fare tesoro di qualsiasi situazione critica si presenti ad una comunità, scolastica
in questo caso, ammettendo che si può sempre imparare qualcosa, anche dalla peggiore delle catastrofi (e per fortuna non è questo il caso); in ultimo l’importanza di agire con intelligenza, con scelte concrete presenti e future, facendo tesoro di ciò che di buono possiamo trarre da errori, inefficienze, incapacità. E dunque da docente, rispetto alla didattica a distanza, mi sento di proporre le seguenti considerazioni, tra le tante che ce ne sarebbero, con tutti i limiti che il mio sguardo parziale può avere sulla questione. Credo sia chiaro che l’emergenza ci abbia trovati piuttosto impreparati, quanto a disponibilità di mezzi e a strutture multimediali. Conosco colleghe e colleghi che fino a poco fa ignoravano la possibilità di condividere file con Drive o persino l’esistenza delle piattaforme digitali. E un po’ lo sapevamo, sebbene facessimo finta del contrario; ci vogliono le emergenze, purtroppo, per mostrarci quanto siamo inadeguati, e se questo vale per il sistema sanitario, vale anche ancora di più per le strutture e le infrastrutture della scuola. Ora si corre per rimediare, ma è bene fare tesoro di questo problema e rendere i futuri interventi ordinari e di sistema. Togliamoci dalla testa, poi, che quello che stiamo praticando in questi giorni sia “smart working”, cioè, tradotto, “lavoro intelligente”. Chi ha detto, difatti, che le attività che svolgiamo dietro ad un monitor rendano il nostro lavoro più
“intelligente” di quello ordinario, che abbiamo svolto per anni “off line”? Chiamiamolo semplicemente “lavoro on line”, dunque, senza attribuire agli strumenti multimediali delle qualità che competono invece soltanto a chi di essi deve sapersene servire. E credo, in aggiunta, che questo abuso terminologico veicoli l’autoreferenzialità con cui le tecno-scienze si arrogano talvolta meriti e poteri che non hanno (o che non hanno ancora), come ad esempio la pretesa di sostituirsi all’intelligenza speculativa, relazionale ed emotiva delle persone. Il lavoro intelligente, allora, è quello che si serve anche degli strumenti tecnologici, ma che non li assolutizza: un insegnante mediocre lo è anche se padroneggia tutti gli strumenti informatici esistenti; per contro, e per assurdo, quello capace potrebbe incantare e motivare i suoi studenti anche con una semplice video chiamata.

E arrivo così alla terza, ed ultima, delle considerazioni: questo periodo di clausura coatta dentro le nostre case, di rivoluzione del nostro modo di fare ed essere scuola, che rimodula il ruolo di insegnanti, studenti e genitori, ci fa notare cose che in un regime ordinario diamo per scontate: anzitutto l’importanza dei riti, della scansione dei tempi e della varietà degli spazi. Il rito di vestirsi e rendersi presentabili, quello dello spostarsi per raggiungere il proprio posto di lavoro, di avere un tempo per le lezioni, uno per i compiti a casa, uno per lo svago, uno per il riposo, contribuiscono a mettere ordine nella nostra vita e in quella della collettività. I riti tengono fuori la follia dalle comunità e quelli specificamente scolastici rischiano di venire meno proprio con la DaD, che confonde tempi, spazi e talvolta ruoli. È questa la ragione per cui pretendo dai miei studenti che durante le video lezioni
siano vestiti decentemente e, in più, consiglio ai ragazzi di pettinarsi come al solito e alle ragazze di truccarsi come facevano ogni mattina. I riti, insomma, ci rendono comunità e questo potere Google e le altre piattaforme proprio non ce l’hanno. Impariamo a valorizzarli di più quando torneremo nelle nostre scuole, seppur sgangherate e spesso inadeguate. E in ultimo, ma non certo in termini di importanza, c’è la relazione, che si dà soltanto con la presenza e la corporeità delle persone, con i loro gesti, le smorfie, gli odori, la camminata e persino il modo di stare seduti. Non esiste né educazione né insegnamento senza la relazione, cioè senza quel legame speciale che aggancia lo studente al suo insegnante, ai suoi compagni e a tutte le presenze significative di una comunità, cominciando proprio dall’interazione tra corpi, tra presenze fisiche che occupano insieme uno spazio e lo vivono. E neppure questo, per fortuna, ce lo può dare una webcam o il migliore dei software su piazza. Insomma, diciamocelo: con la sola DaD possiamo istruire, e certo in questo periodo dobbiamo farlo nel migliore di modi, ma non certo insegnare.
PIERLUIGI FRATARCANGELI

È nato a Frosinone il 4 ottobre del 1980. Laureato in lettere e scienze della formazione primaria è attualmente docente nella scuola secondaria di II grado. Svolge l’attività di formatore rivolta a docenti di lettere di ogni ordine e grado presso enti e ambiti territoriali. Ha collaborato sul piano pedagogico-didattico con Tecnodid. Dal 2013 gestisce il blog di pedagogia e didattica www.guamodiscuola.it. Autore di alcuni versi poetici e di un romanzo.