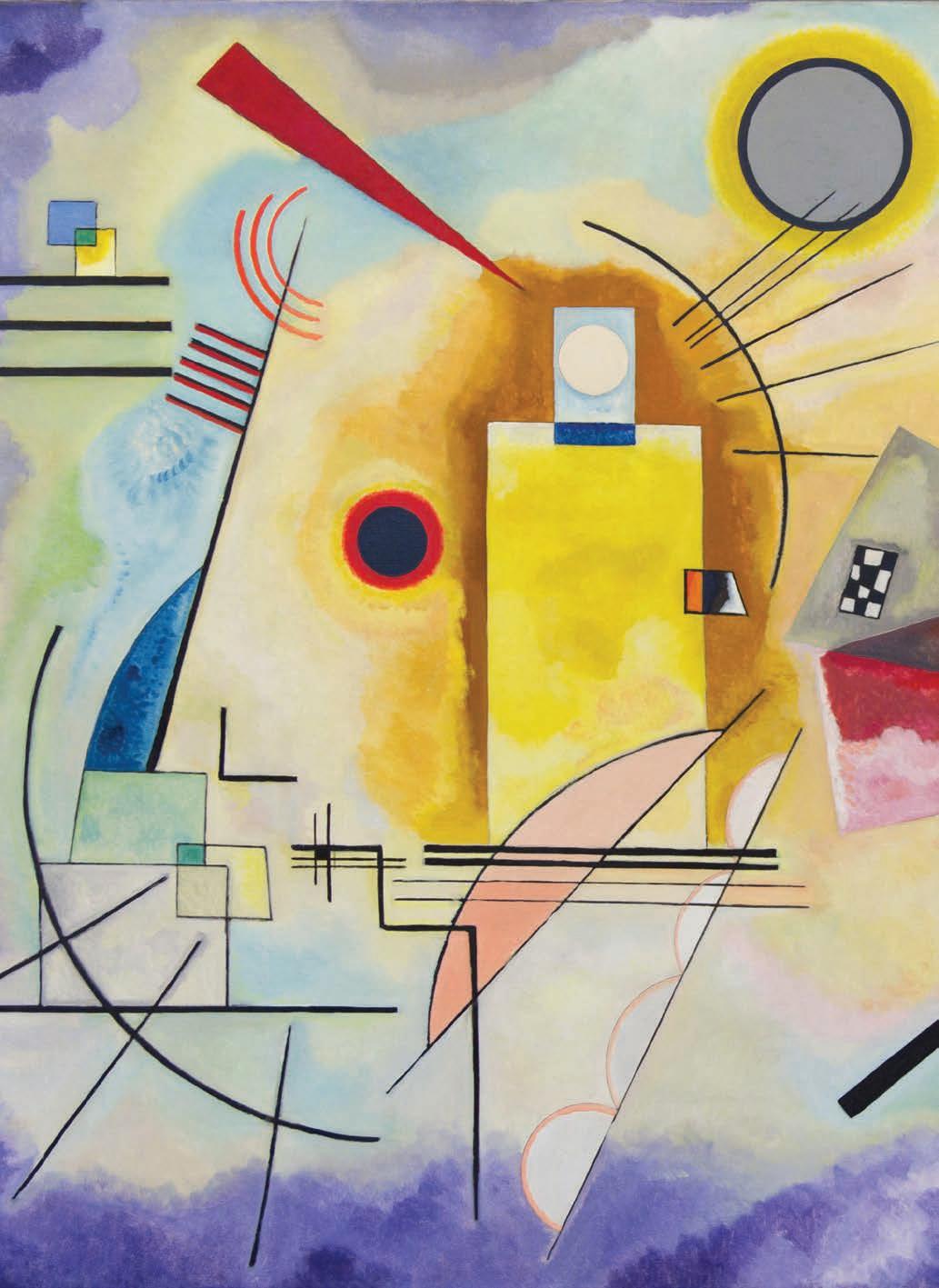11 minute read
APNEE EDUCATIVE
SI FA PRESTO A DIRE DaD
di Francesco Provinciali
PAROLE CHIAVE: PERVASIVITÀ PLANETARIA, FORMAZIONE IN PRESENZA, DIDATTICA A DISTANZA, CONTROLLO SOCIALE, APPROCCIO RELAZIONALE
Viene presentata una fotografia dell’attuale scenario della scuola in quarantena forzata, con tutti i problemi che ne conseguono, per i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie. Ci si trova proiettati in questo scenario inconsueto “tutto da inventare” senza che ce ne sia ancora piena consapevolezza soprattutto riguardo alle “cause” che l’hanno provocato..
Le evidenze più immediate e dolorose della pandemia Covid-19 riguardano ovviamente gli aspetti sanitari, con conseguenze drammatiche, a cominciare dal contagio rapidissimo e diffuso, dal numero altissimo degli infettati da virus, da quello altrettanto devastante dei decessi. Senza contare che proprio nel momento in cui gli scienziati parlano del
raggiungimento di una soglia di “pianoro” a partire dalla quale le conseguenze infauste dovrebbero arrestarsi e gradatamente calare, c’è già chi ipotizza una ricaduta di morbilità oppure – come alcuni autorevoli virologi sul numero del 31 marzo della rivista “Nature”, chi comincia a parlare di una seconda, terribile ondata espansiva del Coronavirus. Viviamo in una fase in cui, non avendo ancora gli strumenti per sconfiggere il male – in primis il vaccino- avvertiamo tutta la precarietà del momento e l’incertezza del futuro: nulla per lungo tempo sarà più come prima. Una grande “tempesta” – per usare l’espressione di Papa Francesco- sta attraversando il pianeta e l’umanità, sconvolgendo le nostre vite, le abi
tudini, bloccando le attività umane, fermando il lavoro e la produzione, alterando i rapporti umani e le relazioni sociali fino a creare una sorta di conteso anaffettivo dove , incrociando una persona anziché salutarla o darle la mano, la si evita girando alla larga. Sembra di rivivere in prima persona le grandi pestilenze del passato, così bene descritte da memorabili pagine di letteratura. Eppure di messaggi autorevoli ne erano stati lanciati dalla scienza e dalle istituzioni. Nel suo libro “Spillover” del 2013 David Quammen aveva anticipato, fin nei minimi dettagli, ciò che sta accadendo ora con il COVID-19: alla pubblicazione del libro gli fu dato del mentecatto. Lo scorso anno a maggio l’OCSE
pubblicò un riassunto di 40 pagine di un Rapporto dell’ONU di ben 1800 pagine sul rischio di estinzione della biodiversità, con una scomparsa di specie viventi sul pianeta fino a 1/8 di quelle esistenti, ipotizzando la sesta estinzione globale della vita sulla terra, la prima per mano dell’’uomo. Una volta superati i 6 miliardi di persone, ammonì il biologo Edward 0. Wilson, l’umanità è prossima all’incompatibilità con l’ambiente. La popolazione è di 7 miliardi e mezzo e cresce di 70 e più milioni l’anno. Fin qui alcuni dati: qualcuno li definisce allarmanti ma il timore è che gli effetti catastrofici della pandemia in atto finisca con il superare le peggiori previsioni. Rapidità del contagio, pervasività planetaria, nessuna esclusione di target o contesti sociali, nessun angolo del pianeta immune dalla pandemia: questi sono i macro-fenomeni più dirompenti. Poi – scendendo a cascata nella nostra quotidianità fatta finora di alternanza di rassicuranti abitudini- ecco il sacrificio del personale medico e sanitario, la reclusione forzata a casa come conseguenza dell’isolamento (prima misura di profilassi), il blocco della attività produttive, la chiusura degli uffici, le restrizioni alla mobilità, le cautele igienico-profilattiche da adottare, il distanziamento sociale, che provoca ricadute emotive e accentua le condizioni di solitudine, isolamento, specie per gli anziani – tra l’altro i più colpiti dal morbo- la paralisi commerciale, la crisi del lavoro, quella finanziaria, il ritiro domiciliare come conditio sine qua non per evitare la diffusione del contagio. Anche la scuola sta pagando un prezzo altissimo: lo tsunami Coronavirus ha comportato la chiusura degli edifici scolastici (dopo gli iniziali tentennamenti) ora anche per il personale dirigente, ATA e docente. Gli alunni sono improvvisamente diventati soprattutto bambini, ragazzi, adolescenti che vivono una sorta di sequestro domestico, necessario ma frustrante. Cesbron li chiamerebbe “cani perduti senza collare”, improvvisamente lasciati soli. Il sistema scolastico sta prendendo le sue contromisure ma anche il periodo dell’anno, in cui è scoppiata l’epidemia, è stato critico e negativamente cruciale: si va avanti con DPCM a tempo e scadenze procrastinate ma è evidente a tutti che l’anno scolastico è praticamente archiviato, le decisioni sono politiche ma resta interrotta una fase di formazione in presenza, che non potrà essere ripresa se non per un ipotetico svolgimento degli esami finali degli terza media e di maturità, sempre che ciò sia compatibile con le indicazioni vincolanti che arriveranno in quel momento dal mondo della scienza e della medicina. Ogni aspetto della vita individuale e sociale è subordinato al prevalente stato di emergenza sanitaria perdurante. Nessuno era preparato al peggio. Nessuno poteva immaginare – se non nel sequel di un film di fantascienza – una situazione così esasperatamente critica e incerta, dagli esiti imprevedibili, almeno sul piano temporale ragionevolmente utile e necessario a trovare un antidoto risolutivo al male. Il problema comune e generale a ogni contesto del vivere sociale – nella gestione delle prassi quotidiane e nelle ipotesi di evoluzione – è data dall’aleatorietà di ogni previsione che acuisce e confonde le ragioni di precarietà e di incertezza. Il mondo della scuola, gli addetti ai lavori stanno vivendo con disagio questo periodo di stand by: come accaduto nell’ambiente sanitario e dell’aiuto sociale anche in ogni istituzione scolastica è partita la corsa ad attrezzarsi, a rendersi disponibili per non far mancare ai ragazzi un aggancio con i docenti, il programma, le attività. Con molti se e molti ma: ci sono dif-
ficoltà oggettive e modi soggettivi e diversi di organizzare questi contatti. Ma non si può dire che gli insegnanti se ne siano stati, nella maggior parte dei casi, con le mani in mano mentre l’apparato amministrativo-gerarchico organizzativo a livello istituzionale – dal Ministero alle singole dirigenze scolastiche – si è mobilitato per atti
vare procedure alternative alle classiche lezioni frontali, alla didattica in presenza, ai libri, ai laboratori, a tutto quel fervore che anima il rapporto fantastico insegnamento/apprendimento, che si basa sulla oggettività delle materie, delle discipline, delle classi riunite nelle aule ma soprattutto fa leva sui rapporti interpersonali- se è vero come è vero quanto affermava Cesare Scurati della scuola: “l’essere un luogo di lavoro e di presenza dove si intrecciano relazioni umane”. Come in tutti gli altri contesti di vita attraversati dal profondo, drammatico disagio dell’epidemia e della sofferenza, anche la scuola ha saputo mantenere vivi in larga e sorprendente misura il pathos del volontariato, il senso del dovere di un compito da portare a termine, il contatto con lo specialissimo mondo dei bambini e dei ragazzi, anche attraverso le loro famiglie. Un po’ enfaticamente il Ministro MIUR
ha definito “comandanti delle navi” i dirigenti scolastici: prima (nella buona scuola) erano sceriffi, si può dire che nella nuova metafora ci sia un significato recondito di “salvezza” e di “abnegazione” piuttosto che di rigido, gerarchico controllo sull’operato del personale. Si sono innescati meccanismi a volte più impostati sul versante organizzativo e con una forte preoccupazione burocratica rispetto ai doveri di certificazione e verifica e ancora di docu
mentazione del lavoro svolto, quasi una sorta di ossequio al doverismo e al cotè del controllo sociale, come a voler sfatare il pregiudizio della scuola come luogo di nullafacenza o di disimpegno. Altre volte, con maggior pregio e probabilmente con maggiore enfasi sull’aspetto del coinvolgimento emozionale e motivazionale, si è privilegiato il contatto umano, il rapporto ad personam, l’andare a cercare in ogni casa, a uno a uno gli alunni di ogni età per conservare quello spirito comunitario e solidaristico che dovrebbe prevalere – anche a conti fatti, alla fin fine – su una parte del programma andato perduto e su alcune materie lasciate a metà. Su questo c’è tempo per recuperare: ma ciò che andava e va privilegiato è soprattutto l’aspetto relazionale ed empatico del rapporto, il contesto scolastico che si avvicina a quello domestico- possibilmente con discrezione e non in modo invasivo- rispettando le intimità familiari, andando incontro alle preoccupazioni dei genitori, tenendo i bambini e i ragazzi impegnati in attività didattiche ma soprattutto facendo capire loro (nella precipua, commisurata all’età e soggettiva ricettività psicologica ed emotiva del fenomeno pandemico in atto) che non sono stati abbandonati, che i loro insegnanti si fanno vedere in videoconferenza (laddove possibile, con lo smartphone e il tablet , o con una semplice telefonata che con sono stati lasciati soli. Certo c’è un dato oggettivo che non va trascurato: l’imprevedibilità dell’evento e la sua diffusione repentina hanno trovato a volte impreparate le scuole: ma sul piano direi oggettivo, soprattutto, della dotazione di mezzi e risorse, vincolate all’ esser chiuse in quanto luoghi di potenziale allargamento del contagio. In fondo nell’esperienza storica della didattica a distanza il sistema scolastico italiano poteva contare su un precedente illustre ma isolato, una vera eccellenza poi imitata dal resto dei sistemi scolastici europei: quello dell’istruzione domiciliare a favore di alunni a casa per malattia, convalescenza post-ospedaliera, infortunio ecc. . In quel caso veniva attivata una linea ADSL a domicilio che consentiva agli alunni di rimanere in contatto con la classe, quasi in situazione di presenza differita. Inoltre c’erano i docenti che si recavano a casa del bambino o del ragazzo, assente da scuola, per completare l’intervento della didattica individualizzata domiciliare. Due pre-condizioni che sono precluse in questa fase di didattica a distanza: in primis a motivo della chiusura delle scuole e quindi del venir meno elle classi come riferimento stabile nell’interlocuzione didattica e in secondo luogo nell’isolamento domiciliare degli alunni, che non potevano e non possono ricevere visite se non a rischio di incolpevole contagio. Quindi ci si è trovati di fronte a una fattispecie del tutto nuova e imprevista, un qualcosa “tutto da inventare”. Gli insegnanti hanno dovuto offrire la propria disponibilità di mezzi e dotazioni da casa propria e gli alunni hanno contato su questa “offerta” e si sono avvalsi, laddove è stato possibile, dell’aiuto casalingo delle famiglie. Questo è stato – lo si nota – a maggior ragione più proficuo e importante per gli interventi di didattica a distanza a favore degli alunni svantaggiati o con disabilità. Per conoscenza diretta di alcune situazioni si può affermare che i migliori

risultati sono stati realizzati laddove gli insegnanti hanno agito con creatività, spirito di iniziativa, prevalenza dell’approccio relazionale e umanitario, rispetto a evidenze di super-controllo da parte di alcuni dirigenti scolastici, forse più preoccupati di dare risalto a un accreditamento e a un riconoscimento sociale delle iniziative esperite o piuttosto a una certa enfasi degli aspetti documentaristici e burocratici, come se si potesse restituire sul registro di classe o nei verbali di riunioni in realtà virtuali le puntualiz
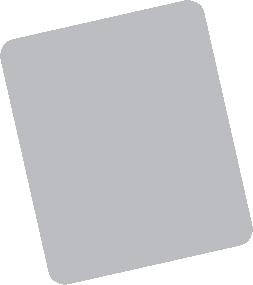
zazioni e le precisioni che di solito si riscontrano nella consueta prassi organizzativa in situazione. L’attesa delle famiglie riguardava e riguarda diversi aspetti, che sono venuti improvvisamente a mancare con la chiusura degli edifici scolastici; un dato oggettivo e incontrovertibile ma certamente non imputabile a nessuno: né ai comandanti, né ai mozzi o marinai delle navi-scuola, per riprendere la metafora ministeriale. Ma più di tutti sembra abbia prevalso la sensazione avvertita dalle due parti coinvolte – dirigenti/docenti da un lato e famiglie/alunni dall’altro che il contatto umano, anche se mediato dalle tecnologie e interrotto dalle distanze, riesce a trasmettere sensazioni che precedono qualsivoglia risultato docimologico: il non sentirsi soli, il poter stabilire relazioni empatiche, il cercare motivazioni e profondere impegno per imparare che in ogni contesto esistenziale - In primis quello educativo – ciò che conta è sapere e capire che l’umanità prevale, sempre.
FRANCESCO PROVINCIALI

È stato insegnante, dirigente scolastico, dirigente ispettivo del Miur. Ha fatto parte dell’Osservatorio minori di Regione Lombardia. Da alcuni anni è Giudice esperto c/o il Tribunale per i minorenni di Milano. Ha pubblicato moltissimi volumi e saggi tra cui ricordiamo: Tutte a casa. Storie di donne, di adolescenti e di bambine, Erga (2010); Figli smarriti, Ed.San Paolo (2011); Dove va la politica? Dialoghi con protagonisti della politica italiana, Selecta (2011), Scuola e dintorni (2017). Collabora a Minori Giustizia, organo dell’AIMMF (Associazione italiana magistrati minori e famiglia) e con diversi quotidiani nazionali
La collana L’Albero dei libri vuole proporre ai ragazzi della Scuola Primaria racconti e romanzi che rispettino i loro gusti e la loro graduale capacità di leggere e comprendere una storia. La collana si compone di quattro livelli di difficoltà sia linguistica che tematica contraddistinti da un diverso colore: verde, giallo, arancione e rosso.