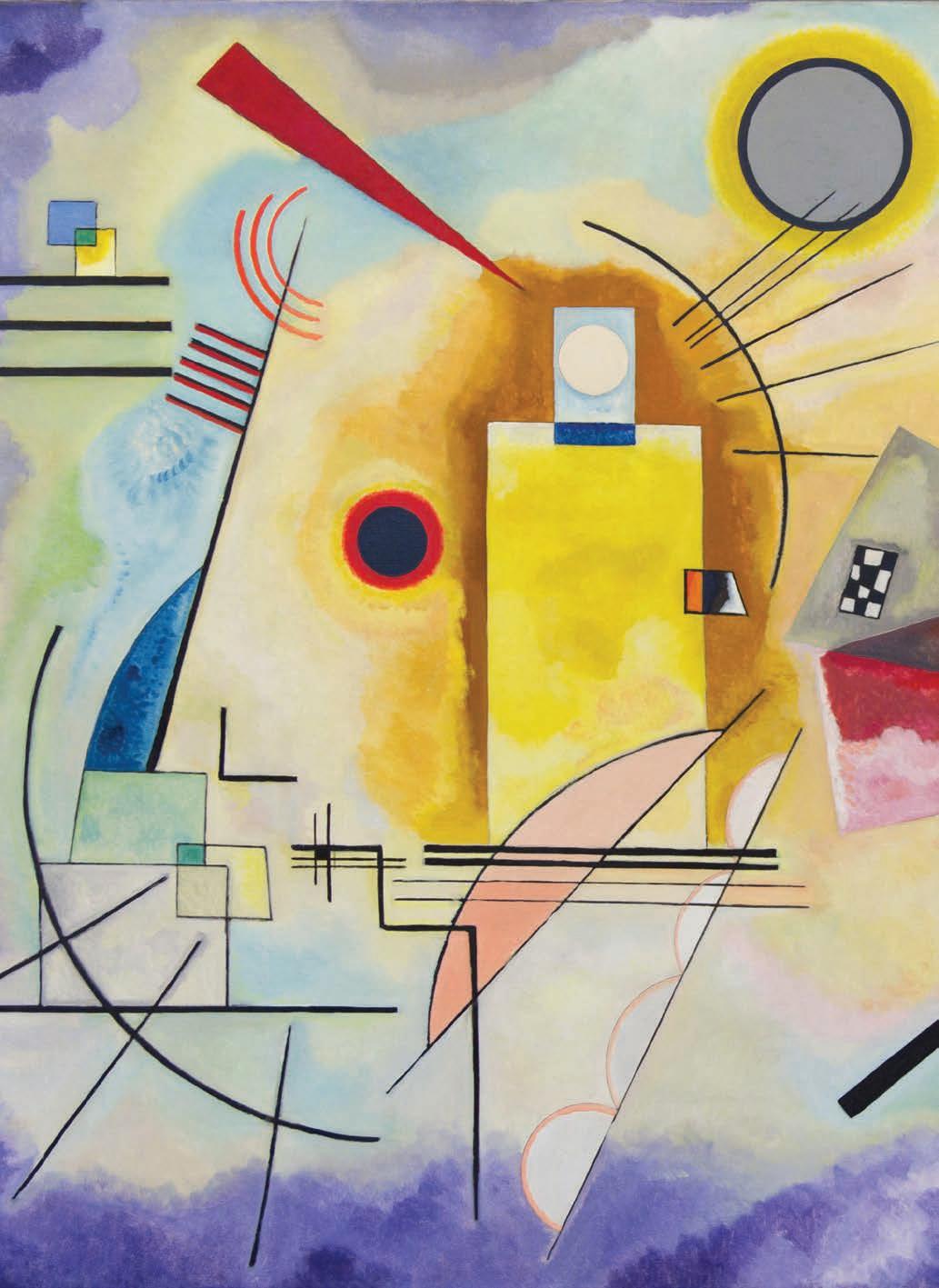14 minute read
Adolescenti social network e quarantena Maria Rita Bartolomei
ADOLESCENTI SOCIAL NETWORK E QUARANTENA
di Maria Rita Bartolomei
PAROLE CHIAVE: ADOLESCENTI, DIGITALIZZAZIONE, DIPENDENZA COMPORTAMENTALE, SOCIAL NETWORK, APP DI GIOCO.
La crescente digitalizzazione ha contribuito a modificare sia il concetto e le modalità della comunicazione, sia i nostri comportamenti individuali e collettivi. Il ricorso massiccio alle risorse online durante l’attuale periodo di quarantena potrebbe acuire i sintomi caratteristici della dipendenza, soprattutto nelle nuove generazioni. Utilizzati come contenitore emotivo, i social network e le app di gioco possono trasformare le modalità relazionali del soggetto e influenzare negativamente i costrutti relativi all’autostima, al perfezionismo patologico e alle credenze metacognitive. Nel prendere piena consapevolezza del problema, gli adulti dovrebbero dare il buon esempio e favorire processi di digital detox, anche attraverso proposte di attività alternative, in grado di responsabilizzare i giovani rispetto al loro futuro.
La pandemia da Coronavirus Covid-19 che si sta rapidamente diffondendo a livello globale inevitabilmente condiziona i nostri stili di vita e modifica non solo le abitudini, ma anche il modo di pensare e di comprendere gli eventi, costringendoci a rivedere molti degli assunti sui quali si basava la nostra esistenza. Le interpretazioni circa la sua possibile eziologia sono molteplici: pura casualità, messaggio di madre natura, virus sfuggito ai laboratori scientifici, arma batteriologica appositamente immessa in circolazione per arricchire ulteriormente i padroni della finan
za globale, e così via. Un aspetto sul quale invece sembriamo essere tutti d’accordo, concerne il ruolo decisivo giocato in questo frangente dai media, soprattutto dai social media e, in generale, dal World Wide Web. In effetti, in una situazione di grande confusione e di inedito disorientamento, le risorse digitali di cui disponiamo contribuiscono a mantenere la società abbastanza funzionante e coesa. Le varie forme di smart working e di didattica a distanza, per esempio, ci consentono di continuare a lavorare e a studiare. Le nuove tecnologie, inoltre, ci offrono la pos
sibilità di tenerci costantemente aggiornati e di distrarci: in un periodo di social recession esse ci permettono di restare in contatto con gli altri e di conservare una vita sociale attiva, seppur del tutto virtuale. Le innumerevoli possibilità di collegamento offerte dalla rete contribuiscono a neutralizzare o a superare il senso di disagio, di isolamento e di solitudine, magari anche la paura, l’ansia o lo sconforto che emergono quotidianamente. Tuttavia, sorvolando su tali aspetti positivi, vorrei soffermarmi sull’incremento di effetti collaterali tossici che con molta probabilità
l’attuale eccesso di digitalizzazione produrrà, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. La crescente digitalizzazione che caratterizza l’epoca contemporanea ha contribuito a modificare in modo radicale sia il concetto e le modalità della comunicazione, che ormai ha assunto un carattere globale, sia i nostri comportamenti individuali e collettivi, in specie le relazioni interpersonali. Basti pensare che nel mondo si registrano più di quattro miliardi di utenti internet e tre miliardi di utenti social, rispettivamente cinquanta e trentacinque milioni in Italia. Le applicazioni più utilizzate sono: YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, TikTok, Hangouts (Report Digital 2020, wearesocial.com). La possibilità di una connessione costante e regolare offerta dai moderni devices ha trasformato completamente il modo di frequentare la rete. I social network, per esempio, sono ormai parte integrante della nostra vita e ci influenzano al tal punto da non riuscire quasi più a farne a meno: il loro utilizzo giornaliero è diventato automatico e inconsapevole. Proprio perché il mezzo privilegiato per l’accesso a internet non è più il computer ma lo smartphone, l’utente è portato ad una consultazione compulsiva del telefono per controllare l’arrivo di notifiche, di mail o di messaggi, ma anche per scorrere una bacheca o per guardare foto o post altrui, a prescindere da qualsiasi input reale o circostanziale. Per non parlare della grandissima diffusione delle app di gioco, le quali vincolano il giocatore attraverso un meccanismo psicologico analogo a quello presente nel gioco d’azzardo (Serpelloni 2013). Ovvero, il cosiddetto “loop ludico”: una serie continua di cicli di incertezza/anticipazione e di feedback/ ricompensa appositamente studiata per creare dipendenza. Nello speci
fico, si tratta di un complesso sistema di “ricariche virtuali” di vite e/o di bonus in premi o in denaro collegate a determinati intervalli temporali (mezz’ora, un’ora, sei ore, un giorno, etc.). Per accumulare risorse gratuite che gli permettono di continuare a giocare, l’utente è quindi costretto a riattivare in continuazione il gioco e, perciò, a visualizzare tutti i contenuti pubblicitari proposti incessantemente. Il fine ultimo di queste app è proprio quello di agganciare definitivamente il giocatore, anche attraverso la possibilità di acquisire privilegi particolari che gli permettono di elevare la sua posizione diventando, per esempio, “vip member”. Pur di sentirsi parte attiva del gioco stesso e membro permanente della community, il soggetto sarà disposto ad acquistare “pacchetti speciali” che gli conferiranno uno status di livello “superiore” rispetto ai normali giocatori non paganti. È pertanto inevitabile che l’uso inadeguato o eccessivo di suddette tecnologie abbia un impatto significativo sui fruitori, tanto da indurre dipendenza psicologica e sviluppare disturbi psicopatologici (King, Delfabbro, 2018; Mannino et al., 2017; Naskar et al., 2016). Già verso la metà degli anni Novanta, la psicologa statunitense Kimberly Young aveva elaborato l’espressione Internet Addiction Disorder (IAD) per indicare l’uso disadattivo delle nuove tecnologie virtuali, predisponendo anche un apposito questionario per diagnosticarla, l’Internet Addiction Test (IAT) (1998a;1998b). Ivan Goldberg ha poi indicato i criteri diagnostici utili al riconoscimento delle situazioni di abuso/dipendenza dal web, tuttora validi (1995). I maggiori sintomi patognomici sono analoghi ai quadri clinici assimilabili all’uso di sostanze psicotrope: assuefazione, sintomi da astinenza e craving, incapacità di controllo razionale delle proprie azioni, irritabilità, aggressività e scarsa tolleranza alla frustrazione (Caretti, La Barbera 2005). I comportamenti volti al soddisfacimento immediato del piacere reale o presunto tendono a prendere il sopravvento sulla vita del soggetto, interferendo negativamente sulle sue relazioni familiari e sociali e sulle prestazioni lavorative e di studio. Sebbene questo nuovo tipo di dipendenza non sia stato ancora incluso nella sezione III – dedicata appunto alle dipendenze comportamentali – del DSM-5, o Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il problema sussiste, e la proporzio
ne della dipendenza da smartphone preoccupa medici, neurologi e psichiatri. Le manifestazioni più serie riguardano i social network, il cyber sex e le app di gioco, e coinvolgono soprattutto le nuove generazioni: bambini, adolescenti e giovani. Anche in Italia fioriscono studi scientifici sempre più numerosi in materia (Rusconi et al. 2012) e pubblicazioni che lanciano l’allarme rispetto all’alterazione strutturale dei processi cognitivi ed emozionali nei nativi digitali. All’esame con RMN, infatti, essi presentano una «riduzione della maturazione e dello sviluppo delle reti neurali nella corteccia frontale, con concomitante iperattivazione dell’amigdala, condizioni che portano a difficoltà cognitive e di autocontrollo degli impulsi» (Pincherle 2018, p. 27). Invero, i dati ISTAT segnalano che quasi il 95% dei ragazzi tra i 14 e 19 anni utilizza internet e che sono proprio gli adolescenti – almeno tre-
centomila – a soffrire maggiormente di dipendenza digitale (internet@italia2018); tanto che, per denunciare il fenomeno, nel 2020 il Codacons ha lanciato la campagna “Si selfie chi può”, attraverso la realizzazione di un calendario contenete immagini decisamente provocatorie. Con riferimento all’attuale periodo di quarantena, la mia ipotesi è che il ricorso massiccio alle risorse online possa innescare o acuire i sintomi caratteristici della dipendenza, soprattutto nei giovani e, tra di loro, non solo nei soggetti più a rischio. In letteratura sono considerati fattori scatenanti prioritari: eventuali psicopatologie preesistenti, condotte a rischio, eventi esistenziali sfavorevoli, potenzialità psicopatologiche della stessa rete (Rusconi et al. 2012). A tale proposito, ritengo che la drammatica situazione che stiamo vivendo possa essere considerata alla stregua di un evento esistenziale sfavorevole e che i social network e le app di gioco – che, come già detto, sono volutamente progettati per creare dipendenza – conferiscano ancor più di prima l’illusione di ri

spondere al bisogno di sperimentare vissuti importanti, di vivere emozioni forti pur sentendosi protetti dall’anonimato, di suscitare sentimenti di onnipotenza e derive narcisistiche. Utilizzati come “valvola di sfogo” e “rifugio per la mente” (Steiner 1996), le loro potenzialità positive possono facilmente degenerare e produrre effetti perversi che trasformano le modalità relazionali del soggetto; ovvero, la sua capacità di relazionarsi: con se stesso, con gli altri, con la realtà circostante. Poiché si tratta di una situazione contingente e totalmente in fieri non esistono evidenze scientifiche né studi specifici, se non qualche articolo di giornale e sparute dichiarazioni di medici, di psichiatri, di psicoterapeuti e/o di operatori sociali che, come Giuliana Guadagnini (2020) gestiscono sportelli di ascolto online. Di conseguenza, le riflessioni che propongo si basano esclusivamente su tali report, nonché sulla mia attuale esperienza di insegnante, di antropologa e di counselor con i ragazzi con i quali, più o meno ogni giorno, continuo a restare in contatto virtuale. Nella piena consapevolezza di affrontare un tema estremamente complesso, poliedrico e, per certi aspetti, ancora piuttosto sconosciuto, tra i vari costrutti maggiormente correlati al fenomeno della dipendenza (autostima, ansia, depressione, perfezionismo patologico, credenze metacognitive) (Fregni et al., 2020), mi limito a prendere in considerazione: l’autostima, il perfezionismo patologico e le credenze metacognitive. Nel momento in cui scrivo, in cui ogni contatto sociale reale è precluso, sembrerebbe che i giovani dedichino ancora più tempo ed energia di prima a costruire la loro vita per come deve apparire, piuttosto che a viverla effettivamente. Continuano ad in-
dossare una maschera e ad esporre in vetrina solo il lato migliore di sé, spesso falso e artificiale. Parlare di se stessi e autocelebrarsi stimola i centri del piacere e i vari riconoscimenti digitali procurano sensazioni immediate e intense di benessere. Grazie al rilascio di dopamina da parte del “sistema della ricompensa”, il soggetto sperimenta un effetto gratificante ed eccitante che può essere percepito anche come “sedativo/inibente” di pensieri negativi o di ansie esistenziali. Tuttavia, le gratifiche ottenute, oltre ad alimentare lo stato di engagement – la convinzione, cioè, di essere incluso in una comunità virtuale e la necessità compulsiva di farne parte in modo attivo e partecipativo – contribuiscono ad accrescere la dipendenza dalle opinioni e dai giudizi altrui. Esemplare in questo senso è il caso della tennista russa Maria Sharapova, già campionessa mondiale. Ritiratasi nei primi mesi del 2020, pur di rimanere in contatto con i suoi 27 milioni di followers, ha pubblicato sui canali social il proprio numero di telefono ufficiale, invitando tutti a contattarla (https:/www.rainews.it, 4 aprile 2020). L’egocentrismo e il narcisismo aumentano, ma i livelli di autostima si abbassano. Contrariamente a quanto si possa pensare, infatti, i narcisisti hanno una bassa, bassissima autostima (Nanetti 2016). Di conseguenza, le fragilità individuali si accentuano in modo esponenziale, e la capacità di relazionarsi con il proprio Sé sfuma completamente, favorendo l’insorgere di sintomi fisici e psicologici poco piacevoli: cefalea, disturbi visivi e del sonno, disforia, noia, rabbia, mancanza di autocontrollo, riduzione delle energie fisiche e mentali, disturbi del comportamento alimentare, distorsioni nella percezione della propria immagine corporea, e così via (Hawi, Samaha, 2016). Il concetto di Sé e la propria autostima sono minati anche dal confronto costante tra la propria vita reale, che sembra triste, noiosa, banale e ripetitiva, per nulla paragonabile a quella degli altri utenti, la quale appare invece affascinante, speciale e perfetta, proprio perché assolutamente inventata e virtuale. Nelle interazioni sociali subentra quindi la ricerca del perfezionismo; non di un sano perfezionismo, nel quale non si teme il giudizio altrui e ogni errore è considerato una possibilità di crescita e di miglioramento. Al contrario, prende il sopravvento il perfezionismo patologico, caratterizzato da un atteggiamento ipercritico nei confronti di se stessi e dei propri errori, dalla svalutazione dei risultati ottenuti e dalla costante paura di fallire (Hamacheck 1978). Nel sogget

to si radica la convinzione che, per essere accettato e apprezzato dalla comunità virtuale, deve dimostrare il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi e di standard elevati. Nello sperimentare l’impossibilità esistenziale di controllare tutte le variabili implicate nell’immagine di sé e nelle proprie prestazioni e, quindi, di evitare del tutto l’errore, il ragazzo inizia a sentirsi colpevole, inefficace e inadeguato, e ad assumere condotte disadattive, che possono anche condurre al cyberbullismo, a diventare influencer paranoico e perverso o, addirittura, hater. Ciò inevitabilmente determina un ulteriore abbassamento dei livelli di autostima e una progressiva incapacità di sviluppare abilità sociali e di relazionarsi in modo adeguato e concreto con le persone reali. Suddette distorsioni cognitive alimentano un circolo vizioso che incentiva l’utente a rifugiarsi ancor più nell’universo virtuale, erroneamente vissuto come contenitore emotivo, e favoriscono la comparsa di comportamenti di ritiro sociale e di disagi quali la mancanza di empatia, il senso di solitudine, l’aggressività, l’isolamento sociale, e finanche la depressione (Spitzer 2016). Evidenti manifestazioni di ansia sociale sono sia la nomofobia, o timore ossessivo di restare privi di connessione, sia la paura morbosa
di essere rifiutato, e dunque escluso, dalle interazioni online. Indicata con l’acronimo FOMO (fear of missing out), è una vera e propria fobia che induce il soggetto a trascorrere ancora più tempo sulle varie piattaforme online al fine di migliorare le proprie performance e la propria immagine (Dossey 2014). Non riuscendo a distogliere la mente dai pensieri ossessivi connessi alla dipendenza dall’esperienza virtuale, l’adolescente presenterà sia disturbi cognitivi concernenti la memoria, l’attenzione, la comprensione, la concentrazione e la creatività (Firth et al. 2019), sia analfabetismo emotivo o alessitimia; ovvero, la difficoltà a riconoscere e a descrivere verbalmente i propri stati emotivi e quelli altrui, nonché a distinguere gli stati emotivi dalle percezioni fisiologiche (Fiumana et al. 2011). La prevalenza di messaggi iconico-visivi su quelli verbali-immaginativi impoverisce il linguaggio e l’attività simbolica, mentre si rafforzano i meccanismi del rimuginio e della ruminazione, e le credenze metacognitive diventano sempre più distorte. Il confine tra reale e virtuale si assottiglia fino a scomparire, e il soggetto rimane intrappolato in una percezione affatto alterata della realtà spazio-temporale che si autoalimenta. Il venir meno di una corretta metacognizione, intesa come consapevolezza dei propri stati interiori cognitivi, affettivi ed emotivi e, contemporaneamente, come capacità di riflettere su di essi, altera lo sviluppo dei processi identitari così come la capacità di relazionarsi adeguatamente all’ambiente naturale e sociale circostante. Per concludere, il sospetto che le multinazionali del web approfittino di questo periodo per accrescere ed incentivare la nostra demenza digitale non è forse così remoto: dal tempo di permanenza degli utenti sulle varie piattaforme dipendono i loro incalcolabili introiti. Purtroppo, il processo in base al quale la dipendenza comportamentale, da patologia residuale a carattere prevalentemente individuale si sta trasformando in un fenomeno strutturale di portata sociale globale, è già iniziato da tempo. Esso coinvolge soprattutto le nuove generazioni: proprio il fatto di essere nativi digitali e ormai soggetti dipendenti dalla rete, impedisce alla maggior parte dei bambini e degli adolescenti di dedicarsi a pratiche alternative di certo più salutari, come leggere un libro, studiare, ascoltare buona musica, fare sport, dipingere, dedicarsi al giardinaggio o al bricolage, meditare o pregare. Personalmente, ritengo che gli adulti, in specie i genitori, gli insegnanti e gli educatori, debbano prendere piena consapevolezza del problema, iniziare a dare il buon esempio e favorire processi di digital detox (Carciofi 2017; Goodin 2019; Price
2019). Oltre ad ampie campagne di sensibilizzazione e a percorsi di psicoterapia, sarebbe opportuno: elaborare programmi contenenti attività effettivamente alternative e coinvolgenti; invitare i giovani a riflettere seriamente sul senso che intendono dare alla loro vita; responsabilizzarli rispetto ad un impegno comune per migliorare il pianeta e gli esseri umani che lo abitano.
• Guadagnini G. in Coronavirus, psicologi: “Dipendenza tecnologica e disturbi alimentari in crescita”, 24 marzo 2020, http://www.rainews.it/. • Pincherle M., “Nuove evidenze sul funzionamento cerebrale dei nativi digitali”, InnovatioEducativa, 1/6-7/2018, pp. 27-31. • Rusconi A.C. et al., “Internet addiction disorder e social network: analisi statistica di correlazione e studio dell’associazione con l’ansia da interazione sociale”, Rivista di psichiatria, vol. 47, 6, 2012, pp. 498-507. • Young K.S., “Internet Addiction: the emergence of a new clinical disorder”, Cyberpsychol & Behavior, vol. 1, n. 3, 1998, pp. 237-244.
Bibliografia e sitografia
MARIA RITA BARTOLOMEI

È Dottore di ricerca in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche, avvocato e counselor per l’orientamento interpersonale integrato. Ricercatrice indipendente di Antropologia giuridica e culturale, ha svolto numerose ricerche sul campo, oltreché in Italia, anche in India (Kerala) e in Africa (Costa d’Avorio, Tanzania e Zambia). Già professore a contratto presso le Università di Macerata, Messina e Catania, ha partecipato come relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali ed è autrice di più di trenta pubblicazioni scientifiche.
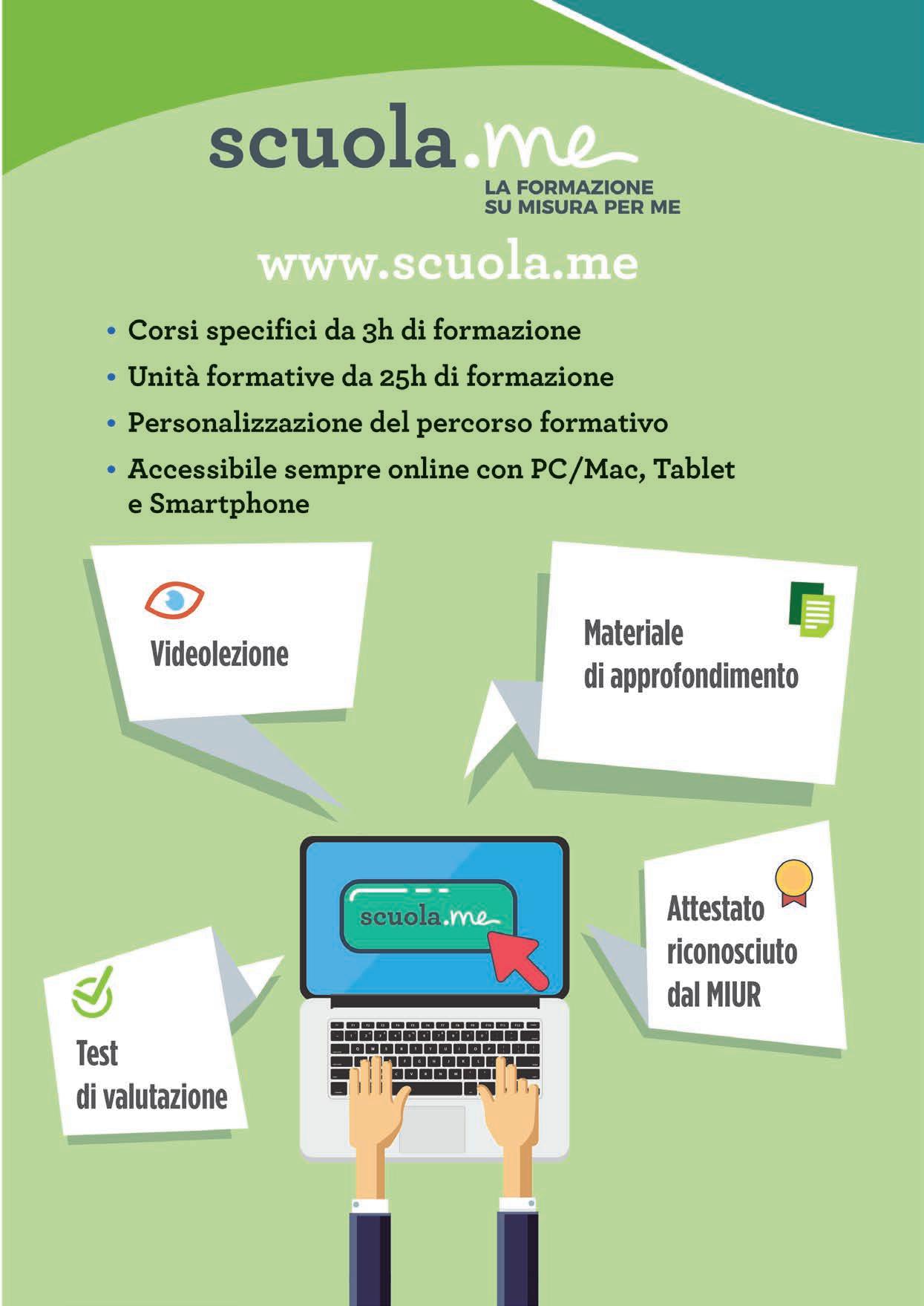
27