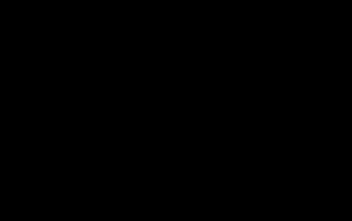7 minute read
n ARTICOLI
from Pasta & Pastai 180
by Avenue media
di Lorenza Vianello Sustainability Consultant per Futuro Anteriore Academy

Advertisement
L’era post pandemica mette le imprese agricole italiane di fronte a due grandi sfide: l’innovazione e la sostenibilità. Il successo andrà a chi riuscirà a valorizzarle reciprocamente
Non è facile parlare di innovazione, e dall’uso delle risorse”(1) e dove “nessuna persona più ancora di innovazione tecnologi- e nessun luogo sia trascurato”, come cita il testo ca, in ambito agricolo. Esiste, da un stesso della Commissione europea. lato, una sorta di disagio, di diffiden- Questo piano d’azione, il Green Deal appunto, vaza, nell’associare la tecnologia alla produzione di rato nel dicembre del 2019, intende “trasformare cibo e, dall’altro, un ben più concreto ritardo strut- l’Unione in un’economia moderna” e dichiarataturale e culturale. Su questi due aspetti l’Italia è mente “pulita e circolare”, ed è considerato parte chiamata a rispondere a livello istituzionale per tener fede agli impe- Occorrono integrante della strategia comunitaria per attuare l’Agenda 2030 e gni dell’European Green Deal ma, 25 anni gli obiettivi di sviluppo sostenibile ancor prima, a non ignorare tali im- per trasformare delle Nazioni Unite. Come si legge pegni perché rischia di far uscire le realtà produttive del Paese dalla competizione dei mercati. Una competitività in cui la crescita ecoun settore industriale e tutte le catene nei documenti programmatici, per conseguire gli obiettivi di un’economia circolare e a impatto climatico zero è necessaria la piena monomica deve essere “dissociata del valore bilitazione dell’industria e la capa-


cità dei Paesi membri di far leva sulle potenzialità della trasformazione digitale e delle cosiddette tecnologie pulite. Il cammino sarà lungo e non privo di ostacoli, ma dal momento che, come la stessa Unione europea sottolinea, occorrono 25 anni per trasformare un settore industriale e tutte le catene del valore, le decisioni e le azioni per quella che è stata definita una “transizione giusta” devono essere prese ora.
Le sfide del mondo agricolo
All’interno del Green Deal sono elencati molti obiettivi, tutti ambiziosi e indispensabili. Primo fra questi, una sorta di faro che indica la via per le altre azioni, quello di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050. Due strategie, in particolare, interessano il settore agricolo: Biodiversity e From Farm to Fork (in italiano “dal produttore al consumatore”), che dovrebbero portare il cibo europeo, già noto per essere sicuro, nutriente e di alta qualità, a diventare il riferimento mondiale per la sostenibilità. Proprio in quest’ambito l’Unione europea fa un chiaro riferimento alle nuove tecnologie. Gli obiettivi di Biodiversity e From Farm to Fork impattano, a diversi livelli, su tutta la filiera: - riduzione dell’uso di agrofarmaci chimici del 50% e di fertilizzanti del 20% entro 10 anni; - aumento delle superfici a biologico (almeno il 25% dell’intera superficie agricola dell’Unione europea entro il 2030); - promozione di nuovi modelli per la sicurezza degli approvvigionamenti e l’equità dei redditi degli agricoltori; - riduzione degli sprechi alimentari e degli imballaggi non ecologici/riciclabili. Appare evidente da questi obiettivi quanto il mondo agricolo non possa che concepire se stesso, ed essere inteso, come parte rilevante di un sistema alimentare i cui soggetti non possono prescindere

gli uni dagli altri in uno sforzo comune di creazione del valore. Un sistema che va dal campo alla tavola, appunto, e che si prende cura in egual modo del pianeta, delle persone e, non ultimo, della prosperità.
Il neo Ministero della Transizione Ecologica e i circa 250 miliardi di euro (di cui poco meno di 200 sono Fondi europei) stanziati dal Piano per la Ripresa e la Resilienza del governo Draghi (recentemente inviato alla Commissione europea), sembrano essere un segnale importante della volontà di risolvere le tante debolezze strutturali, le “storiche fragilità”, come le ha chiamate il Presidente del Consiglio, del nostro sistema, che fino a oggi hanno certamente frenato, se non fermato, la capacità del Paese di far fronte all’emergenza climatica e di mettere in atto un meccanismo produttivo volto alla sostenibilità. Volontà che si esplicita nei 50 miliardi di euro messi a disposizione per la digitalizzazione e nei quasi 70 dedicati, appunto, alla transizione ecologica. Tra le conseguenze immediate della transizione ecologica c’è la realizzazione di un’agricoltura sostenibile e, più in generale, la sostenibilità del territorio. Governare l’impatto ambientale delle attività agricole è fondamentale: si tratta di ipotizzare, condividere e mettere in atto interventi di conservazione, valorizzazione, salvaguardia e tutela. Ma la transizione ecologica, a livello europeo, mira anche a fornire una definizione comune di attività economiche sostenibili. Il fine è quello di aumentare la trasparenza sui mercati finanziari e premiare i comportamenti virtuosi.
TRANSIZIONE ECOLOGICA
È la necessità di una trasformazione del sistema produttivo verso un modello sostenibile, che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, quella industriale e, più in generale, lo stile di vita delle persone. Una trasformazione che investe tutti i settori della vita e dell’economia, cambiando il paradigma del nostro modello di sviluppo in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente e garantire il benessere.
Tutti i settori devono fare uno sforzo comune di creazione del valore

Documento del "Green Deal europeo" relativo alla nota 1

Per questo la Commissione europea ha stabilito dei criteri tecnici per la classificazione delle attività che serviranno a valutare il grado di sostenibilità di un’attività. Questo parametro comune rappresenta un passaggio molto importante del piano di azione dell’Unione europea per portare avanti il concetto di sostenibilità nella produzione e, in linea di principio, in economia e finanza. A questo serve la tassonomia(2), che identifica le attività economiche sostenibili attraverso criteri quali le azioni nei confronti del cambiamento climatico, il riciclo, la prevenzione dell’inquinamento, le emissioni. Attualmente la tassonomia verde Ue copre 13 settori. Nel complesso riguarda circa il 40% delle aziende europee che sono responsabili dell’80% delle emissioni dirette di gas serra in Europa. Entrerà in vigore nel 2022 e, fino ad allora, potrà ancora essere modificata in ogni sua parte. Quello che è stato reso pubblico dalla Commissione a fine aprile, infatti, non è il testo definitivo ma un “atto delegato” passibile di nuovi emendamenti. Purtroppo, tra i settori affrontati l’agricoltura non figura. Con ogni probabilità si attende il via libera finale alla riforma della Pac (la Politica agricola comune) per inserire criteri dedicati all’agricoltura nella tassonomia verde Ue. Non è ancora stato chiarito in che modo (se ne occuperà la piattaforma della Commissione eu-


ropea) la tassonomia sarà il riferimento per attribuire gli incentivi, ma è certo che sarà uno strumento indispensabile per le aziende che vorranno (o dovranno) rendicontare le informazioni non finanziarie.
L’Unione si è impegnata a lavorare affinché il sistema finanziario europeo diventi più sostenibile attraverso un solido quadro normativo in materia finanziaria. Il regolamento tassonomia dell’Unione europea, il regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento Indici di riferimento costituiscono la base per un’auspicata maggiore trasparenza e dovrebbero aiutare le imprese nel loro percorso di transizione. Se tecnologie, agricoltura di precisione, supporti finanziari e direttive comunitarie sembrano aver trovato, almeno sulla carta, una direzione, non resta che trovare l’energia e l’entusiasmo per superare le indecisioni culturali e affrontare il futuro con occhi e menti aperte. Entusiasmo e cuore che vanno affiancati a competenze solide e sempre più condivise. In un recente studio, la Commissione europea ha messo in luce come, tra le aziende europee, il primo ostacolo all’utilizzo dell’agricoltura di precisione siano le limitate dimensioni aziendali e il costo di accesso, ma anche la ridotta conoscenza di tali tecnologie. L’agenda dell’Ue in materia di ricerca e innovazione adotterà l’impostazione sistemica indispensabile per raggiungere gli obiettivi del Green Deal, ponendo l’accento sulla sperimentazione e chiamando in causa tutti i settori e le discipline perché, come essa stessa afferma, “limitarsi agli approcci tradizionali non sarà sufficiente.”

TASSONOMIA
Il Regolamento (Ue) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il “Regolamento tassonomia dell’Ue”) è entrato in vigore il 12 luglio 2020. La tassonomia è un sistema di classificazione, uno strumento destinato alle imprese e agli investitori, che introduce criteri di prestazione chiari e condivisi per stabilire quali attività apportano un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal.
Photo by Matt Wajtas on Unplash
Con la transizione ecologica deve aumentare la trasparenza sui mercati finanziari
Lorenza Vianello
lorenza.vianello@futuroanteriore.academy
NOTE:
(1) Il Green Deal europeo. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Bruxelles, 11 dicembre 2019. (2) Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, marzo 2020. Ue Technical Expert Group on Sustainable
Finance.