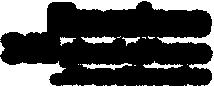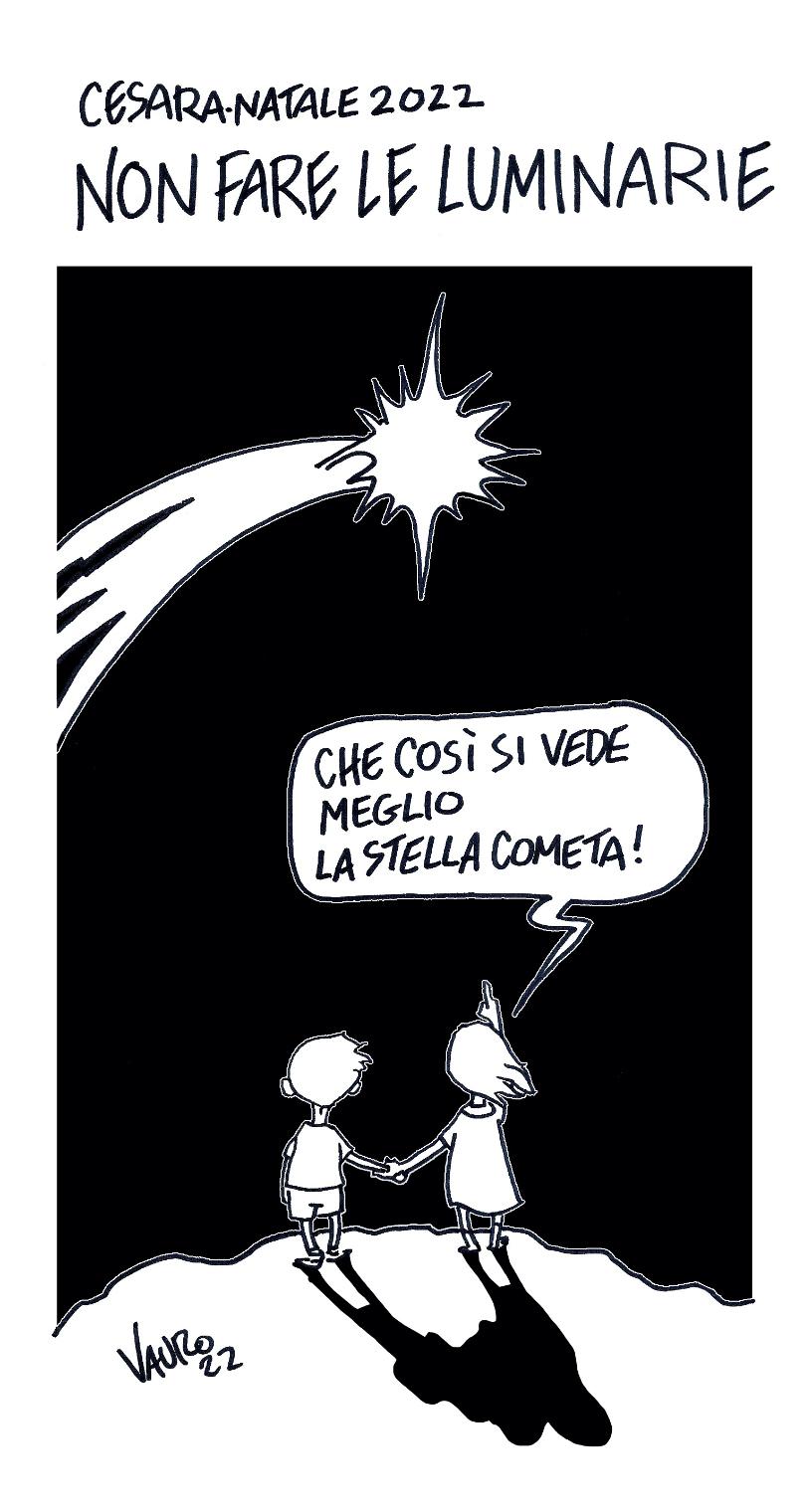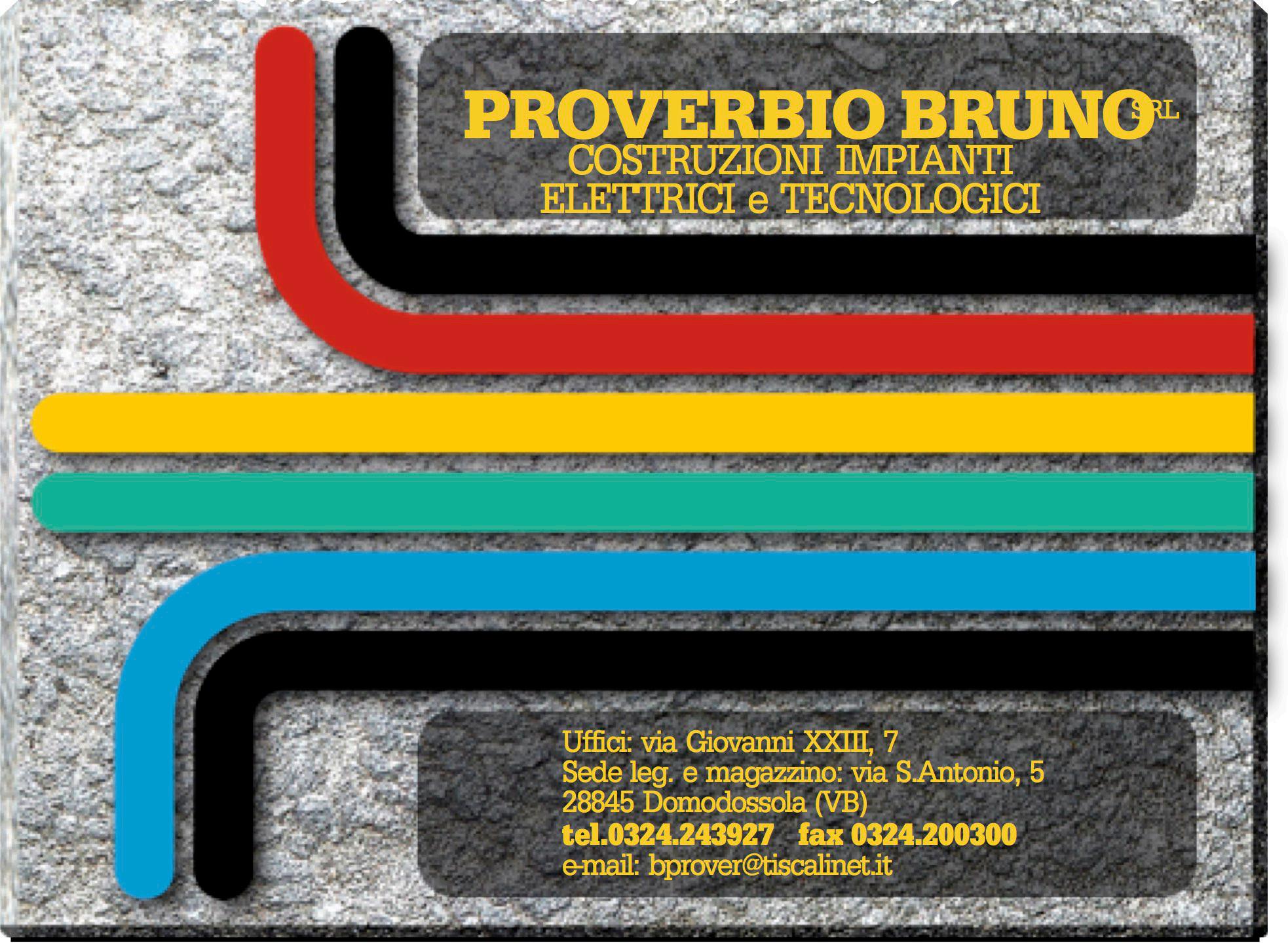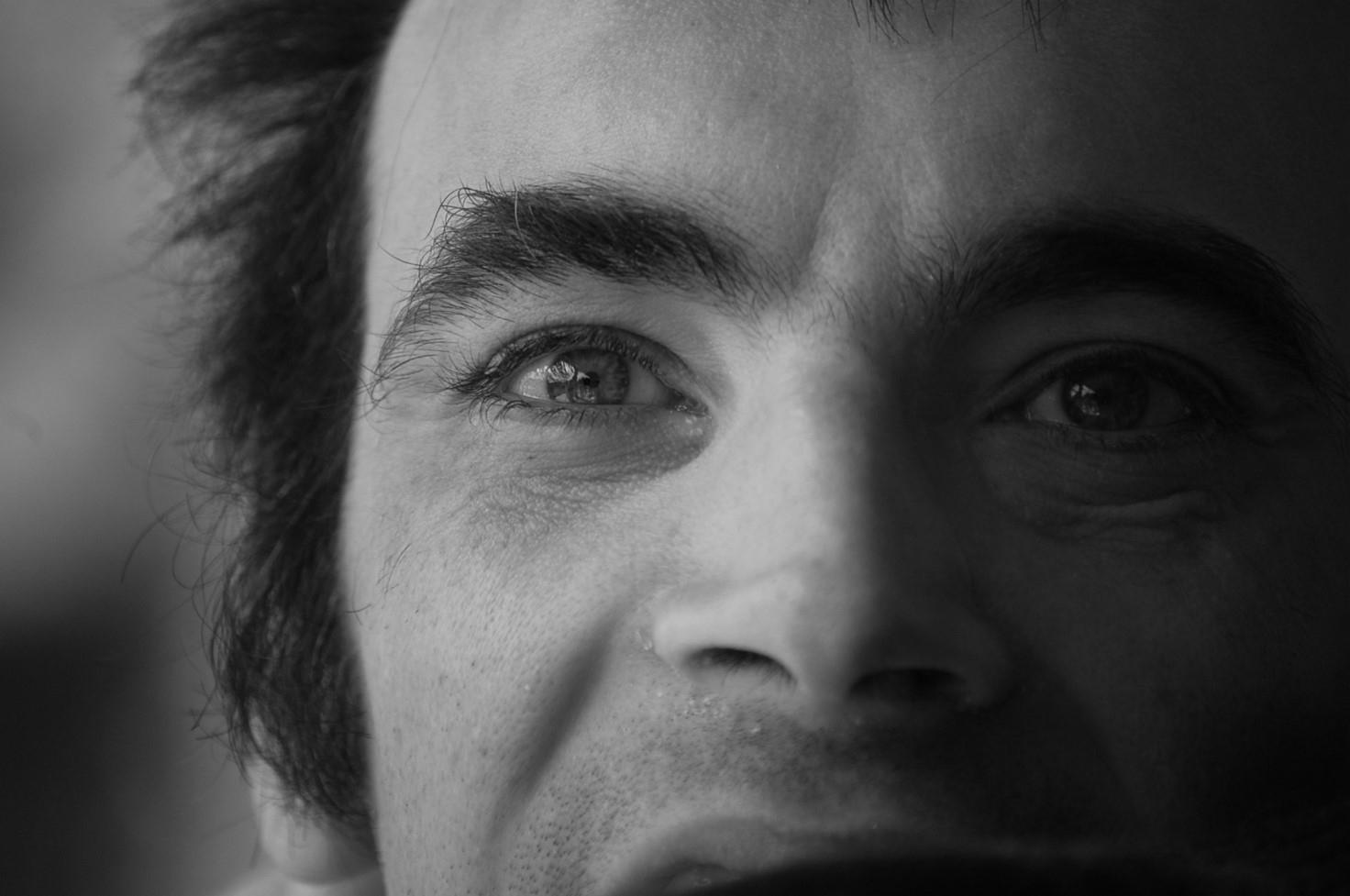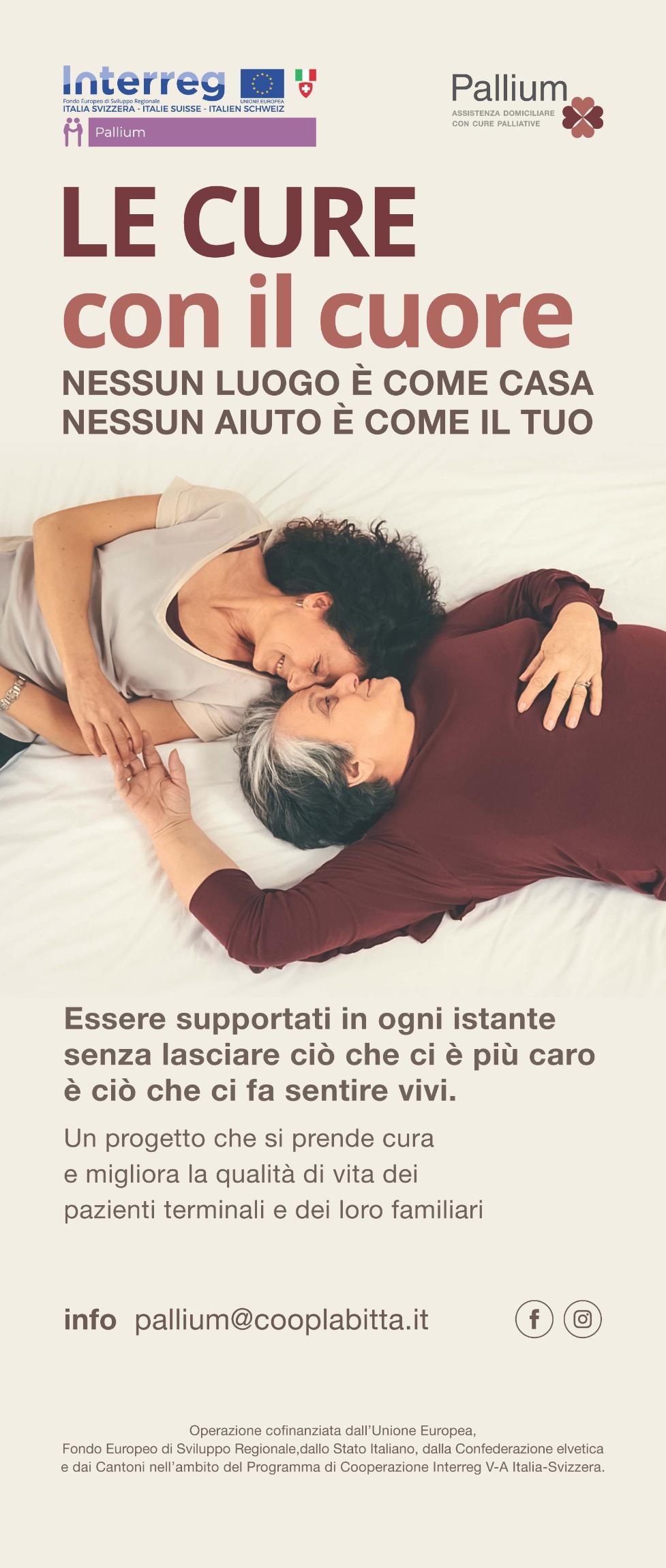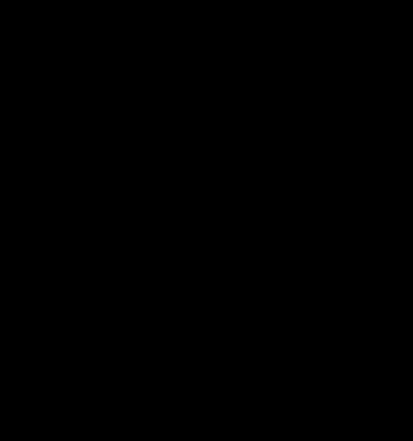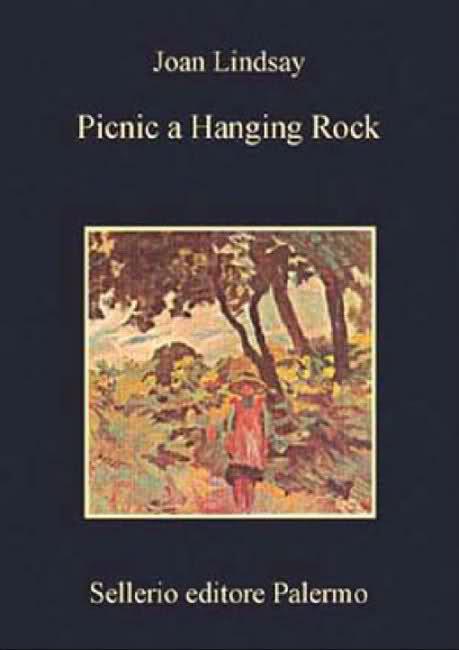n.4
In questo numero:
Il sistema salute fra diritti e sostenibilità La Notte della politica sulla sanità del Verbano-Cusio Ossola Per una nuova visione della Medicina e della sanità nel VCO La salute. Un diritto della persona e un bene sociale Pallium: le cure con il cuore “Aiutami a fare da solo!”
PERIODICO DI CULTURA E IMPEGNO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAA... Spedizione in abb. postale GR.IV Pubbl. Inf. 70%






Direttore Responsabile:
Clemente Mazzetta
Redazione:
Samantha Brandini (segreteria)
Diego Brignoli
Maurizio Colombo
Laura Luisi (coordinamento)
Roberto Negroni
Alvi Torrielli
Simonetta Valterio
Grafica:
Dario Martinelli
Impaginazione: a cura della redazione
Distribuzione: a cura della redazione
Stampa:
Press Grafica Srl
Rivista n. 4 Anno 2022
Periodico di cultura e impegno sociale dell’Associazione Alternativa A ONLUS
Domodossola Via dell’Artigianato 13
SOStienici con una donazione
IBAN IT21X0200845360000103728938
Carlo Bava, medico, musicista, fotografo
Cristina Barberis Negra, ufficio stampa Consorzio Link VCO
Chiara Bonolis, laurea magistrale in Giurisprudenza, con la tesi“L’eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi di cultura tra diritto e inclusione”, Università dell’Insubria, 20.07. 2022.
Nerina Dirindin, associazione“Salute Diritto Fondamentale”, docente di Economia Pubblica e Economia Sanitaria all’Università diTorino, già direttrice generale del Ministero della Sanità
Luca Gondoni, direttore UO Riabilitazione Cardiologica IRCCS, Ospedale San Giuseppe, Piancavallo di Oggebbio(VB)
Oleksandra Koval, classe IV A liceo linguistico "Giorgio Spezia"- Domodossola
Alessandro Magrì, associazione Cineforum Domodossola
Fabrizio Marta,“viaggiatore rotante”, Cavaliere della Repubblica per il merito ad aver contribuito alla divulgazione dei diritti dei disabili e al turismo accessibile
Simona Pedroli, Presidente Associazione Terra Donna
Giannino Piana, teologo, già docente di Etica cristiana e di Etica e economia nelle università di Urbino e Torino
Paola Sau, neuropsicomotricista, Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Verbania
Salvatore Seminara, chitarrista, compositore e didatta, musicista dall'intensa attività artistica
Claudio Zanotti, titolare del blog verbaniasettanta.it, già sindaco di Verbania e presidente di ConserVCO e i redattori: Laura Luisi, Roberto Negroni, e Alvi Torrielli.
Hanno collaborato con scritti a questo numero SOMMARIO Editoriale Sanitàeterritori Laredazione Pgg.4-5 Ambienti territori scenari contesti Ilsistemasalutefradirittiesostenibilità N.Dirindin 6-7 LaNottedellapoliticasullasanità delVerbano-CusioOssola C.Zanotti 8-9 PerunanuovavisionedellaMedicina edellasanitànelVCO L.Gondoni 12-13 Riflessioni analisi commenti Lasalute. Undirittodellapersonaeunbenesociale G.Piana 18-19 Immagini.Lemani,losguardo, relazioni,emozioni P.Sau 20-21 Contributi Novax C.Bava 22-23 Barrierearchitettoniche einclusionesociale C.Bonolis 24-25 Cosa avviene in casa d’altri prendere esempio da... Rotellando F.Marta 28-29 non prendere esempio da... Quantoècomodolostereotipo! R.Negroni 30-31 Progetti Pallium:lecureconilcuore C.BarberisNegra 32-33 Connessiconl’ambiente C.BarberisNegra 34-35 Ilwelfareculturale S.Negroni 36-37 Protagonisti e testimonianze “Aiutamiafaredasolo!” C.BarberisNegra 38-39 Notizie e cronache Io,Noi,unaComunità UfficioStampaLink 40-41 Tornanoi“Lampi”aSpazioSant’Anna UfficioStampaLink 42-43 Le rubriche di A L’importanzadelleparole O.Koval 44-45 Terradonna S.Pedroli 46-47 LaScuolaFloreanini diDomodossola-34annisuonati S.Seminara 48-49 ÈstatalamanodiDio A.Magrì 50-51 Senegal A.Torrielli 52-53 PicnicadHangingRock L.Luisi 54-55 GliappuntidiPadreMcKenzie Orfanidelpassato,reclusinelpresente R.Negroni 56-57

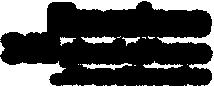
SANITÀ ETERRITORI
I
nquestonumerodellarivistaintroduciamoun nuovo approccio che saltuariamente potrà caratterizzare anche alcuni dei prossimi numeri. Senza alterare la struttura della rivista per sezioni, che ormai la contraddistingue dall’inizio del 2022, questo numero, soprattutto relativamente alle prime due sezioni Ambienti, territori, scenari, contesti e Riflessioni, analisi, commenti, ha un tema conduttore: la sanità e i territori.
In questo momento di serrato confronto relativo alla sanità sia a livello nazionale che a livello provinciale ci sembra opportuno dare spazio a riflessioni approfondite sia sulla sanità in generale che sulla sanità nel Verbano Cusio Ossola, ospedale unico-due ospedali-case della salute. Le riflessioni sono quindi relative alla salute come diritto costituzionale, alla sanità pubblica comedirittoditutti,allasanitàimplementatasui territorieinparticolarenelVerbanoCusioOssola.All’internodiquestotemaconduttorelalinea guida è quella, comune a tutti i contributi, del raggiungimento del massimo beneficio per tutti einparticolareperipazienti.
Per approfondire questo tema abbiamo coinvolto Nerina Dirindin dell’Associazione Salute Diritto Fondamentale, già docente di Economia SanitariaecomponentedellaCommissioneparlamentare Igiene e Sanità, che affronta l’argomento della salute come diritto costituzionale, Claudio Zanotti, già sindaco di Verbania, che ricostruisce puntualmente dal punto di vista politico la problematica sanitaria nel Verbano CusioOssolanegliultimi40anni,LucaGondoni, direttore della Riabilitazione Cardiologica dell’OspedaleSanGiuseppediPiancavallo,che approfondisce dal punto di vista medico quali sono le modalità più efficaci per assicurare le migliori cure al paziente, Giannino Piana, teologogiàdocentediEticaedeconomia,cheoffre uncontributoimportantesullasalutecomedirittodellapersonaecomebenesociale.Achiudere i contributi relativi alla sanità una raccolta fotografica relativa ad interventi riabilitativi con adultieunraccontorelativoall’esperienzadiun medicocondottoinunavalledelnostroterritorio nella sezione Contributi. Sempre nella sezione Contributi un articolo dedicato alla inclusione socialeeallebarrierearchitettoniche. Nella sezione Cosa avviene in casa d’altri abbiamouncontributodedicatoalturismosostenibile nel Verbano Cusio Ossola, che si collega
al tema dell’inclusione sociale in particolare nell’accoglienza turistica, e una riflessione relativa a pregiudizi e preconcetti quali diffusori di distorsioni e false conoscenze. Nelle altre sezioni Progetti e Protagonisti e testimonianze importanticontributiciraccontanodialcuniprogetti, parte dei quali collegati al tema della salute: “Pallium”, relativo alle cure palliative, “Aiutami a fare da solo” di housing socio-assistenziale e “Connessi con l’ambiente” che vede ilcoinvolgimentodiscuoleeragazzidellanostra provincia.
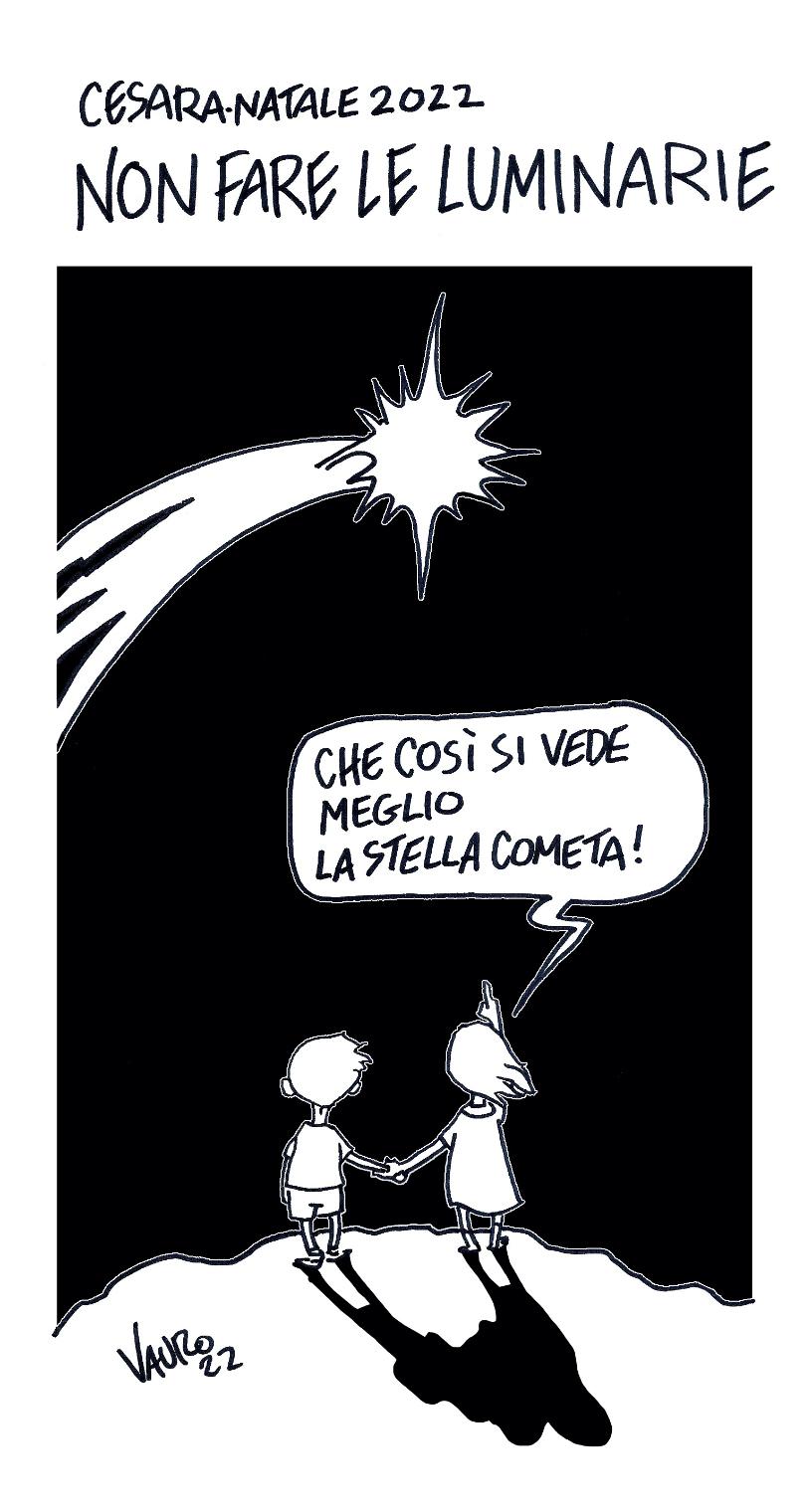
La parte finale della rivista, le Rubriche, vede il debutto di una nuova rubrica, la Musica, con un interessante articolo dedicato ad una scuola musicale del Verbano Cusio Ossola, accanto ai contributi ormai conclamati relativi alla Scuola, allo Spaziodonna,al Film,al Viaggio,alla Lettura e agli ormai tradizionali Appunti di padre Mckenzie, relativi alla cancellazione del passato equindialladifficoltàdicapireilpresente.
Questo trimestrale è nato con il primo numero del 2022, dopo una fase di preparazione che ha occupato buona parte dell’anno precedente, ed è il prodotto del lavoro di un gruppo di volontari. Dopo i primi due numeri, pubblicati anche in cartaceo, la pubblicazione avviene soltanto in digitale, annullando, quindi, anche i costi di stampa e di spedizione e rendendola più eco-sostenibile. La produzione della rivista è pertanto quasi a costo zero, ma per“Alternativa A”, l’associazione Onlus che ne è l’editore, poter contare sul sostegno dei lettori rappresenta un aiuto a continuare ad operare come luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto in una logica di collaborazione, scambio e legame con il territorio.
Vi chiediamo allora di sostenerci con la vostra donazione, versando, con bonifico bancario, un contributo sull’IBAN di Alternativa A IT21X0200845360 000103728938 con la causale “donazione per la rivista”. Grazie!
Aeditoriale
Laredazione
La redazione e l’Associazione vi augurano Buone Feste
IL SISTEMA SALUTE FRA DIRITTI E SOSTENIBILITÀ NerinaDirindin
Da qualche anno, il dibattito italiano sulla sanità pubblica sembra polarizzato su posizioni contrapposte, spesso infondate e in gran parte strumentali.
Forti correnti di pensiero denunciano la insostenibilità economica del servizio sanitario pubblico, proponendo dati di contestochenontrovanoriscontronelle statistiche internazionali, mentre, nonostante tutte le debolezze, il nostro sistema di tutela della salute continua a essere classificato fra i migliori al mondo (almeno fino a un paio di anni fa).
I media danno risalto ai casi di malasanità, di sprechi e di inefficienze, sicuramente da deprecare ma che oscurano i tanti casi di dedizione, competenzaesobrietàchesirilevanoin molteregioniitaliane.
Il dibattito più recente sulla corruzione nella pubblica amministrazione sembra guardare alla sanità pubblica come al luogo per eccellenza della immoralità, ma a ben guardare, i (pochi) dati disponibilidiconochesonoledimensionidel settorearenderlo in assoluto un terreno di interesse per speculatori e affaristi, mentre in termini relativi non ci sono evidenze su una maggiore presenza di illegalità.
Secondo altri luoghi comuni, la sanità pubblica sarebbe preda della peggiore politica, mentre il Servizio sanitario nazionaleèl’unicocompartodellapubblica amministrazione che negli ultimi decennisièdotatodiunapparatotecnico e di sistemi di governance che non
hanno eguali negli altri comparti pubblici (come riconosciuto anche dalla Corte dei Conti). Ciò non significa che la sanità non sia oggetto di continue pressioni da parte della cattiva politica, maèaltresìverochelasanitàèunsettore che necessita di un importante intervento pubblico (della buona politica) a correzione delle inefficienze dei mercati e a promozione degli obiettivi diequitàpropridiunambitodiparticolare interesse per l’individuo e la collettività.
Le accuse ai dipendenti pubblici, che sarebbero tutti fannulloni e improduttivi, colpiscono anche gli addetti alla sanità, ma i dati rivelano che nel nostro Paeseilnumerodeidipendentipubblici è,interminicomparati,eccezionalmente basso e che gli operatori della sanità producono mediamente risultati non inferioriaquellidialtriPaesisviluppati, come hanno dimostrato anche durante la pandemia. Anche in questo caso l’affermazione vale con riferimento ai dati medi nazionali, mentre ci sono livelli locali di disorganizzazione e inefficienzechenonpossonoesseretolleratiedifesi.
Gli esempi potrebbero continuare, ma sonosufficientiatestimoniareundibattito sorretto più da convinzioni ideologiche e posizioni strumentali che daevidenzescientifiche.
Un dibattito che ha contribuito a dare dellanostrasanitàpubblicaun’immagine distorta, peggiore di quella reale, e che ha favorito un graduale, costante peggioramento del sistema di tutela
della salute. Pregiudizi e ideologie che sono funzionali al superamento di un sistema (il Servizio sanitario nazionale) lacuiesistenzadeprimeleambizionidi profitto di importanti settori economici (dal mondo assicurativo alla finanza privata,daiproduttoridiapparecchiaturetecnologichefinoaiproduttoriprofit) le cui strategie stanno diventando semprepiùinsidioseespregiudicate. Suquestodibattitohafattoimprovvisamenteirruzioneilcoronavirus.
La pandemia ha colpito il nostro paese in un momento in cui il Servizio sanitario nazionale aveva raggiunto il suo punto di massima debolezza. Personale dipendenteridottodioltre40milaunità nell’ultimo decennio, mancato ricambio generazionale di medici e infermieri,aumentodelprecariatoedel ricorso a personale esterno (attraverso l’esternalizzazione di importanti servizi, come il Pronto soccorso), ospedali obsoleti e insicuri, servizi territoriali impoveriti, scarsa cultura della prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, dotazionedipostilettoospedalierifrale più contenute dell’Europa continentale (abbiamo4postilettoper1000abitanti: il60%inmenodellaGermaniaeil45% in meno della Francia), diseguaglianze geografiche e socio-economiche in crescita,disimpegnodeiverticidecisionali atuttiilivelli.
Fortunatamente il Coronavirus sembra (oforsesembrava)averapertogliocchi anche ai peggiori detrattori della sanità pubblica.
Di fronte alla diffusione del contagio
A ambienti territori scenari contesti
Il Servizio sanitario nazionale. I suoi punti di forza e le sue debolezze. La necessità di difendere la sanità pubblica.
tutti hanno elogiato il nostro sistema sanitario,inostriprofessionisti,iprincipi alla base del Servizio sanitario nazionale.Durantelapandemia,nessun italiano ha pensato che sarebbe preferibile passare a un sistema diverso, un sistema che inevitabilmente potrebbe prendersi cura solo di chi può pagarsi l’assistenza e ha un lavoro stabile. Ognuno ha ben chiaro che Covid-19 puòcolpirechiunque(anchesecolpisce dipiùipoverieifragili),chedall’emergenza nessuno può uscire da solo (né come individuo né come nazione), che è interesse di tutti limitare la diffusione dell’epidemia, che la sorveglianza, l’identificazione e il trattamento precoce della malattia sono la strada maestra per vincere questo virus (come tutti gli altri agenti infettivi). Insomma, abbiamo capito che quanto previsto dalla legge 833/78 istitutiva del Servizio sanitario nazionale è quanto ci serve e chedobbiamoripristinareciòchenonè stato realizzato o è stato realizzato in modoparziale.
Maicomedurantelapandemia,lasanità pubblica è apparsa a tutti un patrimonio prezioso di cui essere orgogliosi, da salvaguardare e potenziare. L’insopportabile ritornello sulla insostenibilità del Servizio sanitario nazionaleèscomparsoimprovvisamentedaldibattitoquotidiano,ma–ahimèforsesolotemporaneamente.Lamartellante pubblicità delle assicurazioni privatedimalattiasièdissoltanelnulla, ma al venir meno dell’emergenza ha subito ripreso a riproporci offerte seducenti. Durante la pandemia, l’assordante silenzio delle forme integrative di assistenza (mutue aziendali) ha reso evidente il carattere non indispensabile, spesso superfluo, della loro offerta assistenziale, ma sapranno presto riposizionarsi sul mercato alimentando consumismo, inappropriatezzaediseguaglianzefralavoratorieil resto della popolazione. Gli erogatori privati di prestazioni diagnostiche si sono rapidamente posizionati offrendo test sierologici senza alcuna capacità diagnostica a livello individuale (a bassa specificità e sensibilità), sfruttando vergognosamente le paure degli italianieoffrendoprestazionidiagnosticheevisitespecialistichecheilServizio sanitario nazionale purtroppo non è più
ingradodidare,ancheperchésfiancato dallapandemia.
Tuttociònoncifabensperareperquando l’epidemia sarà definitivamente superata, ma bisognerà ricordare a tutti che è proprio grazie alla Costituzione e alla legge 833 del 1978 che l’Italia ha potuto affrontare l’emergenza Coronavirus senza aggiungere alla sofferenza dellamalattiaeallapauradellamortela preoccupazione del costo di trattamenti che potrebbero essere insostenibili per lagranpartedellefamiglie(unricovero per problemi dell’apparato respiratorio con respirazione assistita per oltre 4 giorni è tariffato poco meno di 16 mila euro; trattamenti più complessi superanoi50milaeuro).Nonsolo.Graziealla Carta costituzionale e al Servizio sanitarionazionalenessunapersonaesposta al rischio di disoccupazione (rischio sempre più elevato a causa della grave crisi economica che imperversa) deve temerediperdere,oltrealpostodilavoro,ancheildirittoallecure.Nonèpoco. Ecenestiamorendendocontosoloora. Manonbasta.
La pandemia ci ha ricordato che l’assistenzadeveessereerogataneiluoghidi vita e di lavoro delle persone, nell’ambito del Distretto socio sanitario, privilegiando la domiciliarità (e non solo l’assistenza domiciliare), rinnovando profondamente le cure primarie e la medicina di famiglia, evitando ogni forma impropria di istituzionalizzazione e facendo concretamente lavorare insieme i servizi sociali e i servizi sanitari. Ma tutto ciò nonèsufficiente,perchél’indebolimento della sanità pubblica ha raggiunto livelli troppo preoccupanti. I fondi del PNRR sono fondamentali, ma il SSN deveesserestrutturatoinviaordinariae stabile, con personale, luoghi di cura accoglienti, sicuri, riconoscibili e “amici”dellepersonepiùfragili. Da molti anni, le scelte di politica economica hanno colpito pesantemente il settoresanitario.Sesiescludelapandemia, da molto tempo, le diverse coalizioni che si sono succedute al governo non hanno inserito nella loro agendapoliticailtemadellatuteladella salute, o lo hanno inserito in modo del tutto marginale. Il ruolo delle politiche perlatuteladellasalutequalestrumento fondamentaleperilbenesseredelleper-
sone e per la coesione sociale è al massimo declinato come dichiarazione di principio, ma non è tradotto in azioni conseguenti.Soloisettoriadaltatecnologiaeintensitàdiricerca,inparticolare il farmaceutico, sono oggetto di attenzione,mentreisettoriadaltaintensitàdi lavoro (la gran parte dei servizi sanitari e sociali!) sono percepiti come improduttivi, costosi, poco qualificati, superati e da considerare marginali. E invece il futuro è in buona parte nelle mani di chi sa programmare ed erogare percorsi di cura sul territorio, in cui la tecnologia si intreccia con le relazioni umane, l’assistenza primaria ha la stessa dignità dell’alta specializzazione, le persone sono assistite prevalentemente nel loro ambiente familiare, la qualità è perseguitaintuttiicontestiassistenziali, la sicurezza e il decoro delle strutture è parte integrante del servizio, i malati e glianzianinonsonoconsideratiunpeso ma persone colpite da rischi a cui tutti siamo esposti e che vorremmo fossero affrontaticonilcontributoditutti. Di fronte a tali debolezze, dobbiamo tutti impegnarci affinché la fase che stiamo affrontando, nella quale dobbiamo ricominciare a strutturare il nostro sistema sanitario tenendo conto di quanto abbiamo imparato nell’emergenza, non sia di nuovo succube delle vecchiericette.Dobbiamo ricominciare infatti, non ripartire da dove ci siamo fermati.Edobbiamodifenderelasanità pubblica.
Pgg. 6-7 Alternativa
LA NOTTE DELLA POLITICA SULLA SANITÀ DELVERBANO-CUSIO OSSOLA
“Nell’arco di un ventennio sulla“questione sanità”la politica – intesa come realtà organizzata e strutturata territorialmente in forma di partito o movimento – si è scoperta prima debole, poi impotente e infine inesistente. Sulla scena sono rimasti sindaci e amministratori comunali, che spesso con miopia autolesionista hanno rivendicato distanza dai partiti ed estraneità alla politica, quasi fossero – l’ostentata distanza e la rivendicata estraneità – titoli di merito e punti di forza della loro azione e non già gli indicatori di una conclamata incapacità di assumere in tutta la sua complessità la questione della sanità (ospedaliera e territoriale) della provincia e di lavorare a una sintesi e a una mediazione alta tra interessi contrastanti e spinte divergenti. Sintesi e mediazione che possono essere raggiunte solo attraverso una visione più ampia dei problemi, sottraendo il dibattito alla logica distruttiva dei localismi municipali che ormai intrappolano gliamministratorientrolacintadaziariadeirispettivi Comuni”. Maperquestoservirebberodeipartitiorganizzati su base provinciale, degli amministratori locali consapevoli di un’appartenenza politica che si estende oltre i confini del proprio municipio, dei cittadini interessati a confrontarsi su questioni di vivo interesse e di stringente attualità. E forse quello che servirebbe non c’è.
Il dibattito sulla sanità provinciale sembra ormai un nonsense avvitato da quasi tre anni intorno all’interrogativo diqualestrutturaospedalieradotareilterritorio(ospedale unico baricentrico, ospedale nuovo nell’Ossola, ospedale “per poli”, ospedale unico plurisede), dando per acquisita la presenza del COQ di Omegna e la sua natura di ospedale pubblico/privato per prestazioni polispecialistiche d’elezione. L’ultimo pronunciamento dell’Assemblea dei Sindaci delVco (inizio luglio) è consistito nella bocciatura della proposta di mantenimento del Castelli edel San Biagio formulatadallaRegionePiemonte (vedi qui e qui) e nella contestuale richiesta che sia la Regione stessa a individuare il sito ove costruire il nuovo ospedale unico provinciale (nel 2021 la Regione aveva parlatodiospedalenuovoperilVcoinquestodocumento). Non è intenzione di chi scrive riprendere e analizzare i contenutidelleproposteformulatenell’ultimotriennio(chi fosse interessato può trovare qui una silloge di articoli tematicamente omogenei e cronologicamente ordinati), ma organizzare una ricostruzione della tormentata vicenda dellasanitàdelVCOpotrebbeaiutareacapirechealmarasma di oggi non è estranea la notte della politica che nel corso di quarant’anni è calata sempre più fitta sulla nostra comunità provinciale.
Il primato della politica (1980-1992)
La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (n. 833 del 1978), estendendo a tutta la popolazione le garanzie di tutela della salute sino ad allora assicurate da un’eterogenea organizzazione mutualistica, attribuiva ai cittadini –rappresentatidairispettiviComuni-il“governo”delsistema, incardinato territorialmente sulle Unità Sanitarie Locali. Osservato con le lenti dell’antipolitica oggi dominante, quel mondo ci appare incomprensibile. Eppure…Eppureleelezioninazionalidel’76avevanocertificato un’affluenza degli elettori superiore al 90% e più
ClaudioZanotti
dell’80% dei consensi era appannaggio di tre soli partiti (38% DC, 34% PCI, 10% PSI). Era dunque del tutto naturale che i cittadini eletti in Parlamento, nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni su liste di partito si sentissero pienamente legittimati ad agire in virtù della delega loro conferita dai cittadini. Nel caso del VCO, i consiglieri comunali delle tre USSL (la 55 del Verbano, la 56 dell’Ossola e la 57 del Cusio) in elezioni di secondo grado sceglievano il Presidente e i componenti del Comitato di Gestione, organo di governo dell’USSL: amministratori che erano dunque diretta espressione delle forze politiche votate nei Comuni, a garanzia del carattere democratico di quegli organismi.
Perunadecinad’anni,suddivisiindiduecicliamministrativi (1980-1985 e 1986-1991), la politica esercitata dai partiti ha orientato e guidato l’attività delle tre Ussl del Vco, costruendo dalle fondamenta un sistema integrato di servizi sanitari e sociali articolato in tre grandi settori di intervento:la sanità specialistica e ospedaliera,incardinata sui presidi territoriali del Castelli, del San Biagio e del Madonna del Popolo che nell’arco del decennio hanno visto crescere – in attuazione degli indirizzi nazionali e regionali di politica sanitaria – le strutture edilizie, le divisioni ospedaliere, i servizi specialistici e le attrezzature diagnostiche, terapeutiche e riabilitative; la sanità territoriale e di prevenzione, attraverso l’istituzione e il progressivo potenziamento nelle sub-aree delle Ussl dei Distretti Socio-Sanitari di Base; le prestazioni socio-sanitarie rivolte a situazioni di fragilità, con specifica attenzione ai minori (comunità-alloggio, adozione/affido, sostegnoeducativodomesticoescolastico,consulenzapsicologica…), alle persone disabili (assistenza domiciliare, inserimento lavorativo, comunità diurne…), agli anziani con problemi di autosufficienza (assistenza domiciliare e realizzazione di residenze sanitarie assistenziali), alle persone con fragilità psichiatrica e da dipendenza (servizi
A ambienti territori scenari contesti
territoriali, comunità-alloggio).Il fatto che gli amministratori delle USSLfossero in larga misura cittadini impegnati in politica e direttamente investiti di un mandato elettorale espresso dalla comunità locale attraverso liste riconducibili a partiti di rilevanza nazionale, ha da un lato legittimato democraticamente la loro azione nelle nuove istituzioni socio-sanitarie, dall’altro ha responsabilizzato gli amministratoridifronteallecomunitàcittadineeai media locali, che non hanno mancato di chiedere puntualmente conto delle scelte compiute, dei progetti avviati, della qualità e delle inevitabili disfunzioni delle prestazioni, del rapporto tra i costi sostenuti e i servizi erogati. E dove localmente la politica ha saputo contrastare con successo lo scadimento delle idealità e la deriva criminogena dei comportamenti che hanno portato al tracollo della prima tangentopoli (1992),ilconfrontodialetticotraforzediverseeildibattito cittadino si sono spesso nutriti di importanti questioni di rilievo sociale e sanitario, i cui contenuti – declinati sul pianolocale–eranopadroneggiaticoncognizionedicausa proprio grazie al coinvolgimento diretto degli esponenti politici del territorio negli organi di governo e di amministrazione delle USSL.
Non si tratta di affermazioni generiche. Chi vorrà, potrà trovare qui la raccolta dei quaranta numeri (ognuno preceduto da un sommario degli argomenti trattati) di un’artigianale rivistina che un gruppo di giovani amministratori della sinistra DC di Verbania pubblicò tra ’89 e il ’93. Molti articoli furono dedicati a un puntuale e documentato approfondimento di tematiche socio-sanitarie di forte impatto politico e amministrativo, di viva attualità ora come allora: l’ampliamento della struttura e dei servizi dell’ospedale Castelli; i bisogni socio-assistenziali e sanitari degli anziani; il fenomeno dell’interruzione di gravidanza e le politiche a sostegno della maternità; il problema della diffusione dell’Aids; le politiche e i servizi acontrastodellatossicodipendenza;lacreazionedistruttu-
re per persone non autosufficienti; l’emergenza infermieristica e il fenomeno dell’assistenza privata in ospedale; l’inserimento scolastico e lavorativo di persone disabili. E molto altro ancora, come potrà verificare chi avrà la pazienza di scorrere i sommari dei numeri e magari leggere qualche pezzo. La legittimazione politica e la responsabilizzazione degli amministratori, riconosciuti comeespressionedirettadellavolontàdeglielettori,perun decennio garantì un buon livello di osmosi tra la classe politica locale impegnata nell’amministrazione delle tre USSL e la popolazione che fruiva dei servizi socio-sanitari, ai quali era riconosciuta una qualità complessivamente apprezzabile. Poi tutto cambiò.
La punizione della politica (1992-2000)
L’effettocombinatoditangentopoliedellacrisifinanziaria muta radicalmente e repentinamente il quadro politico nazionaletrail’91eil’92.Ildegradonelleamministrazioni pubbliche e l’esplosione della spesa pubblica (il ’92 è l’anno di Tangentopoli, del prelievo forzoso sui conti correnti, della svalutazione della lira, dell’uscita della nostra monetadalloSMEedellamanovrafinanziaria monstre del governo Amato per 90.000 miliardi) impongono una profonda revisione del sistema delle USSL previsto nella legge 833, spazzando via insieme al malaffare anche le esperienze di buona gestione. Gli amministratori espressi dai Municipi vengono sostituiti da commissari e da amministratori straordinari (poi direttori generali) di profilo cosiddetto “tecnico” nominati dalla Regione, mentre i servizi socioassistenziali già in capo alle USSL vengono stralciati e riassegnati a consorzi di Comuni. Le tre USSL dellaprovinciasonounificateinun’unicaaziendasanitaria (ASL VCO), in cui gli enti locali sono rappresentati dalla Conferenza e dalla Rappresentanza dei Sindaci, cui la legge assegna compiti (sulla carta) di indirizzo, verifica e valutazione, ma che di fatto nel corso degli anni si sono
Pgg. 8-9 Alternativa
rivelatiorganisostanzialmenteestraneiallavitadelleASL. Insomma, la politica del territorio, additata all’opinione pubblicacomeunicaresponsabiledelloscadimentogestionale della sanità, esce definitivamente di scena. Cancellato l’ambizioso disegno di integrazione sanitaria e socio-assistenziale in un unico ente e consegnata all’irrilevanza la sfida “territoriale” delle politiche costruite sui Distretti socio-sanitari, la nuova ASL a vocazione “aziendale” si concentra sulle grandi strutture ospedaliere, la cui triplice articolazione (San Biagio, Castelli, Madonna del Popolo) si rivela progressivamente inadeguata a reggere i radicali mutamenti scientifici, tecnologici, organizzativi e gestionali che negli anni ’90 investono la sanità ospedaliera: una vera e propria rivoluzione, che avvia la trasformazione dei nosocomi da generiche, ipertrofiche strutture di ricovero da misurare in posti-letto, in presidi specialistici riservati in via largamente prevalente alle patologie acute a elevata intensità di cura e organizzati per prestazioni erogate e non per posti-letto occupati. Bastano duenumeriperfotografareconevidenzailprocessocheha caratterizzato l’ultimo trentennio: nel 1989 il solo Castelli disponeva di 405 posti letto, mentre oggi l’ultima proposta targata Asl/Regione ipotizza 360 posti complessivi tra Castelli e San Biagio.
L’impotenza della politica (2001-2018)
Acavallo del decennio gli squilibri finanziari e le perdite a bilanciodell’ASL,causatidallaprogressivainadeguatezza delle prestazioni offerte dai tre ospedali e dalla conseguente mobilità passiva, costringono a fine 2000 l’allora direttore generale Mario Vannini a presentare il primo di una lunga serie di Piani di riorganizzazione della sanità ospedaliera del VCO. La proposta, passata alle cronache come Piano Vannini-Reschigna, diventa oggetto di una durissimabattagliacheopponeforzepoliticheaforzepolitiche e territori a territori, riaccendendo i furiosi conflitti che avevano opposto Verbano, Cusio e Ossola nel decennio precedente dopo l’istituzione (1992) della nuova provincia.Lapropostadel Piano (integrazionedel Castelli e del San Biagio e coinvolgimento di privati al Madonna del Popolo di Omegna) viene inopinatamente bocciata (qui una ricostruzione): mentre l’ipotesi pubblico-privata di Omegna viene stralciata e porterà in breve tempo all’avvio della sperimentazione del Centro Ortopedico di Quadrante, l’integrazione dei due ospedali viene abbandonata in favore del nuovo ospedale unico a Piedimulera approvato dalla Regione con il Piano Aress. La debolezza di questa proposta (qui un’analisi critica) innesca una serie di reazioni che tra il 2003 e il 2006 porteranno prima alla celebrazioni di referendum popolari a Verbania e in Provincia e successivamente alla predisposizione e all’approvazione da parte dell’ASL (direzione Robotti), dellaConferenzadeiSindaciedellaRegionePiemontedel progettodi Ospedale Unico Plurisede (quiun’illustrazione in sintesi).
Tra il 2009 e il 2010 le istituzioni politiche locali (Comune capoluogo e Provincia) e la Regione Piemonte cambiano “colore” politico: al Centrosinistra subentrano maggioranze di Destra e la progressiva attuazione del progetto di
Plurisede sibloccaperlaconcomitantevolontàdelleburocrazie sanitarie e dei nuovi referenti politici. Nel caotico quinquennio contrassegnato dal traumatico scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale di Verbania (2013) e dell’amministrazione Cota (2014), dal dissesto finanziario dell’amministrazione provinciale e dall’esplosione della rimborsopoli in Regione Piemonte, torna in auge (qui un’analisi critica) una visione degli ospedali organizzati per poli (medico e chirurgico), chedi fatto prefigura per l’ospedale “chirurgico” (San Biagio) lo status di “ospedale cardine provinciale” e per l’ospedale “medico” (Castelli) quello di ospedale a medio-bassa intensità di cura.L’impotenzadecisionaledellapoliticaelasordaresistenza delle burocrazie consegnano la programmazione della sanità ospedaliera al binario morto dell’inconcludenza.
Lì vi rimane sino a novembre 2014, quando l’insostenibile situazione finanziaria della sanità piemontese (commissariata) induce la neoeletta Giunta Chiamparino a mettere il VCO di fronte a un aut-aut: decida la Conferenza dei Sindaci se sarà il Castelli o il San Biagio l’ospedale cardine provinciale (qui una ricostruzione in tre articoli). La Conferenza decide tra mille lacerazioni per il secondo, ma per un anno la Regione non fa nulla. Solo un anno dopo, traottobreenovembre2015,colpodiscenaesecondo autaut: la Regione è disponibile a finanziare un ospedale unico e nuovo, a patto che in brevissimo tempo la Conferenza dei Sindaci indichi una localizzazione. A metà novembre la scelta è fatta: la collina di Ornavasso (qui una ricostruzione in quattro articoli). Dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Comuni,ASLe Regione per la realizzazione dell’opera trascorrono quattro anni, ma la procedura avanza su ruote quadrate: nel 2019 la Destra scalza Chiamparino da palazzo Lascaris, mentre sulla collina di Ornavasso nulla è stato fatto.
Invent’annisisonocombattuteestenuantilogomachie,ma l’unico progetto di riorganizzazione dei tre presidi dotato di interna coerenza e inserito formalmente nel Piano Socio Sanitario Regionale è stato quello dell’Unico Plurisede, la cui mancata attuazione è una delle cause dell’inarrestabile degrado della sanità ospedaliera del VCO. Precocemente sganciato dal treno impazzito del riassetto delle due strutture pubbliche, il vagone rappresentato dal COQ di Omegna è invece giunto felicemente a destinazione, consentendo alla sanità d’elezione a gestione pubblico-privata di conquistare segmenti importanti di prestazioni specialistiche,benoltrel’originariaOrtopedia.Insomma,iltrionfo dell’impotenza della politica.
Il prezzo più elevato della sterile logomachia ospedaliera è stato pagato dalla cosiddetta sanità territoriale, che la riforma del ’78 incardinava sui Distretti Socio-Sanitari di Base, pensati dal legislatore come presidi di tutela della salute importanti almeno quanto le strutture ospedaliere in forza dei compiti fondamentali ad essi attribuiti (educazione sanitaria, prevenzione, salubrità degli ambienti, salute procreativa, salute mentale, medicina di base e scolastica.. .). L’estromissione della politica locale dalle USSL/ASL ha reso afone le comunità municipali e irrilevanti le rappresentanze territoriali degli amministratori, nonostante
A ambienti territori scenari contesti
l’altisonante attribuzione ai sindaci della qualifica di Autorità Sanitaria Locale. Oggi la medicina distrettuale del VCO è di fatto ridotta alla rete dei medici di famiglia e ai tentativi più o meno riusciti di dare vita alle Case della Salute (o Case della Comunità, secondo le indicazioni del PNRR).
La scomparsa della politica (2019-2022)
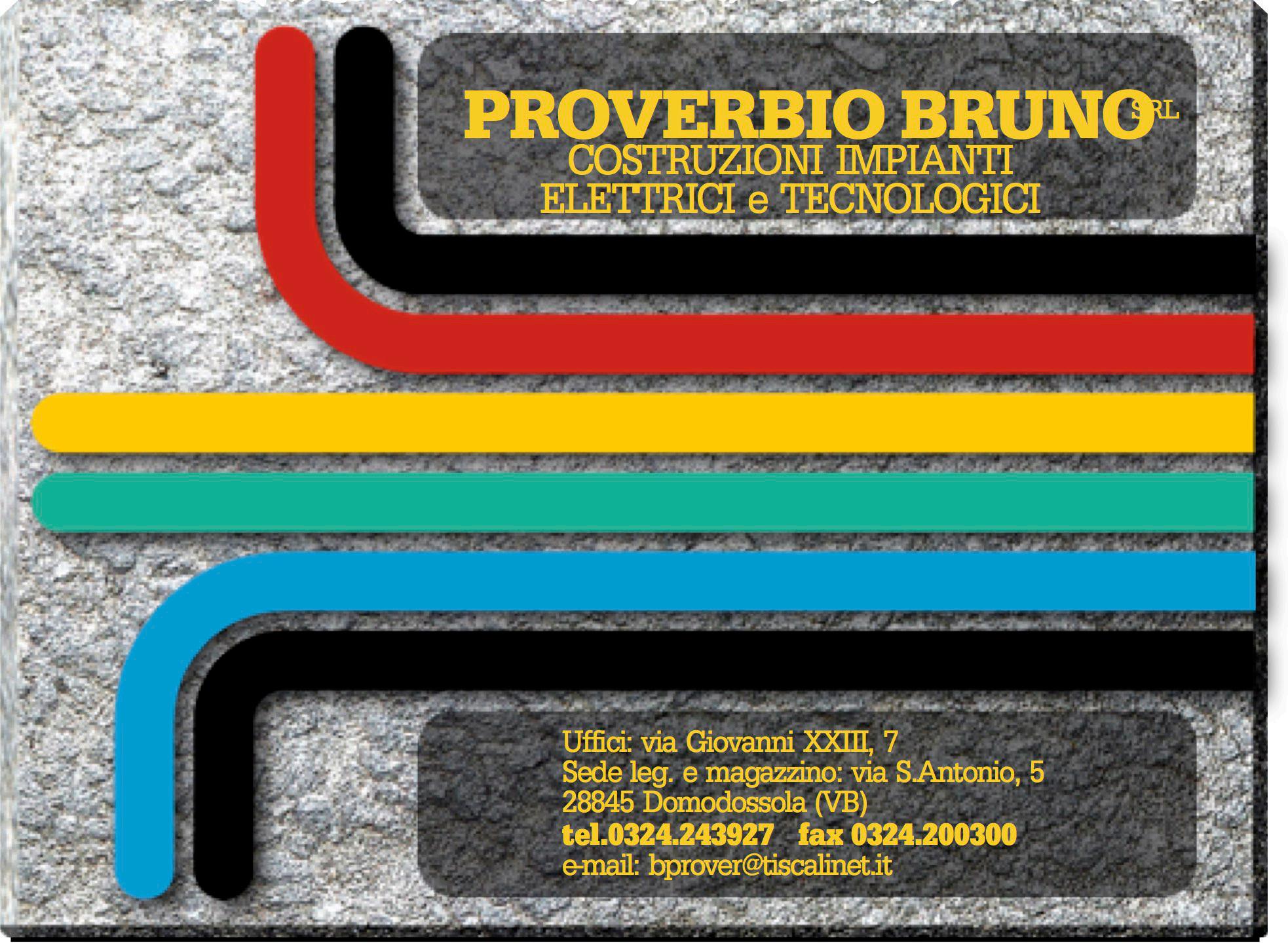
Come Chiamparino nel 2014, Cirio e la neoeletta (giungo 2019) Giunta regionale di Destra si presentano in autunno nel VCO con la proposta di trasferire la previsione di nuovo ospedale unico dalla collina di Ornavasso alle porte di Domodossola (qui una ricostruzione in più articoli). Ma ilprogettononc’èedevepassareunannobuonoprimache l’idea prenda forma in un abborracciato documento di una ventina di pagine (qui, in apertura di articolo, un’analisi critica) elaborato dall’Ires, nel quale si delinea sulla carta il nuovo ospedale di Domodossola - multispecialistico di capacità (?) – dotato di 250 posti-letto; non passa un anno – siamo ormai nella primavera 2022 – e sempre da Regione e ASL viene diffusa un’altra proposta di riorganizzazione ospedaliera radicalmente diversa dalla precedente: mantenimento dei due ospedali esistenti con posti-letto equipollenti (180 ciascuno), ma con profili organizzativinoncertoequipollenti(quiun’analisicritica).
Nell’arco di un ventennio nel VCO sulla “questione sanità” la politica – intesa come realtà organizzata e strutturata territorialmenteinformadipartitoomovimento–sièscoperta prima debole, poi impotente e infine inesistente. Sulla scena sono rimasti sindaci e amministratori comunali, che spesso con miopia autolesionista hanno rivendicato distanza dai partiti ed estraneità alla politica, quasi fossero – l’ostentata distanza e la rivendicata estraneità – titoli di merito e punti di forza della loro azione e non già gli indicatori di una conclamata incapacità di assumere in tutta la suacomplessitàlaquestionedellasanità(ospedalieraeterritoriale) della provincia e di lavorare a una sintesi e a una mediazione alta tra interessi contrastanti e spinte divergenti. Sintesi e mediazione che possono essere raggiunte solo attraverso una visione più ampia dei problemi (qui una ricognizione non troppo invecchiata dei temi in discussione), sottraendo il dibattito alla logica distruttiva dei localismi municipali che ormai intrappolano gli amministratori entro la cinta daziaria dei rispettivi Comuni. Ma per questo servirebbero dei partiti organizzati su base provinciale, degli amministratori locali consapevoli di un’appartenenza politica che si estende oltre i confini del proprio municipio, dei cittadini interessati a confrontarsi su questioni di vivo interesse e di stringente attualità. E forse quello che servirebbe non c’è.
Pgg. 10-11 Alternativa
PER UNA NUOVAVISIONE DELLA MEDICINA E DELLA SANITÀ NELVCO
Alice arrivò a un bivio sulla strada e vide lo Stregatto sull’albero.“Che strada devo prendere?”chiese. La risposta fu una domanda:“Dove vuoi andare?”“Non lo so”, rispose Alice.“Allora, – disse lo Stregatto – non ha importanza.”
Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie
(1) Misembraimportantefareuna precisazioneterminologica:lostatotutela esoddisfaildirittoallasaluteenonoffre unarispostaaibisognidisalute,realio presunti,dellapopolazione.Diritto, secondolaTreccaniè“…ciòcheè giusto,oèsentitoodovrebbeessere sentitocomegiusto,comeappartenente cioèoimprontatoaquelcomplessodi principimoralicheregolanoirapportitra gliuominiunitiinsocietà”.Bisognoè invecequalcosachepuòancheessere indottoeaddiritturapuòesserepubblicizzato,perincrementareladomanda,anche incamposanitario,senzarispettoperun benecosìfondamentalecomelasalute.
Primadiprenderequalunquedecisioneinmeritoallesceltepermigliorarelanostra sanità, come del resto in qualunque ambito, dobbiamo avere ben chiaro cosa vogliamo ottenere. Penso che l’obiettivo sia abbastanza ovvio e condivisibile: con le nostre possibilità, nel contesto reale in cui ci troviamo a vivere e non in un mondo ideale e teorico, vogliamo cercare di ottimizzare la qualità del servizio sanitario che offriamo ai cittadini. E dobbiamo farlo in modo da rispondere a quello che ci raccomanda la Costituzione all’articolo 32: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” (1)
Credo che il nostro modo di comprendere il sapere medico sia alla base delle scelte organizzative che faremo e credo anche che ci sia molta confusione nel sentire comune rispetto alla natura reale della medicina. Qualche osservazione generale può essere di aiuto.
Noi corriamo il rischio che i modelli che utilizziamo per cercare di comprendere la realtà, una volta consolidati nel tempo, diventino dogmi. In ambito scientifico un modello viene rivisto o abbandonato quando non riesce più a dare conto di tutti dati: la forza della scienza è quella di accettare la critica e accettare quindi che le sue proposizioni possano essere rese false. Il dogma invece è qualcosa che comporta un percorso opposto: i dati discrepanti sono scartati o forzati per adeguarsi al modello. In campo medico, secondo il modello/dogma bio-medico, tutti i fenomeni che riguardanolanostrasalutedevonoessereconcettualizzatiinterminidiprincipifisicochimici e tutto ciò che non è spiegabile con questa visione deve essere escluso dalla categoria delle malattie; ovvero la definizione di malattia non si applica se non si dimostranomodificazionidellostatobiochimico.Nonsolo:inambitomedicol’incertezza, che ha raggiunto ormai da tempo uno status quasi ontologico con la fisica quantisticaeilprincipiodiindeterminazione,vieneancoraconsideratafruttodierrori di misura e non una condizione ineliminabile. Indubbiamente passare da un modello strettamente bio-medico ad uno che, accettando l’incertezza, contempli l’inclusione degli aspetti psicologici, sociali e affettivi sarebbe una profonda riforma, quasi rivoluzionaria, del modo di intendere la medicina: possiamo dire che una riforma è la correzione di errori e prevaricazioni, ma una rivoluzione è un vero trasferimento di potere che farebbe del paziente il nuovo centro decisionale per quello che riguarda la propria salute.
(2) G.Engel.Theneedforanewmedical model:achallengeforbiomedicine. Science1977;8:129-136
Il cosiddetto modello bio-psico-sociale non è propriamente una novità essendo stato proposto dallo psichiatra americano George Engel nel 1977 (2). Nonostante gli anni trascorsi, la novità non è riuscita a scalfire le convinzioni, che potremmo definire positivisteerazionaliste,dibuonapartedeglioperatorisanitari,periqualiaggiungere nella loro pratica quotidiana le variabili psicologiche e sociali rappresenta evidentemente un ostacolo quasi insormontabile.
Per “scendere” dal modello interpretativo alla realtà dei fatti possiamo farci alcune domande di base: ad esempio chiederci perché il paziente cerchi un medico. Una
A ambienti territori scenari contesti
LucaGondoni
indagine del 2013 relativa alla Regione Veneto (3) evidenzia come il tasso di accesso al Pronto Soccorso sia, per oltre l’80% dei casi, in codice verde o bianco, il che chiaramente non vuol dire che tali accessi siano sempre inappropriati, almeno se teniamo in conto la soggettività del paziente, ma si tratta comunque di numeri che ci parlano di una motivazione che va al di là del problema clinico in senso stretto.Tanto è vero che uno studio inglese di qualche anno fa (4), nel descrivere le variabili chiave che spingono le persone a cercare l’aiuto di un medico, identifica la percezione soggettiva di vulnerabilità alla malattia, la percezione della gravità della malattia stessa,lapercezionedelpotenzialebeneficioottenibile.Quellocheèinteressantenon sonotantolevariabiliinsé,mailfattocheciòchepiùcontaèlapercezionesoggettiva dei parametri sopra descritti e non la loro “reale” ed “oggettiva” entità. Sembra evidente da queste poche considerazioni preliminari che la componente soggettiva e quindi, almeno in senso lato, psicologica dei nostri problemi sia determinante nel definire la nostra percezione della salute.
Chiaramente queste premesse sono molto parziali, ma vorrebbero cercare di scardinare il modo in cui abitualmente percepiamo la medicina e aprire sguardi diversi sul problema della sua gestione. Riferendomi in particolare alla gestione ospedaliera, di cui ho esperienza diretta, per rispondere all’esigenza di avere la sanità migliore possibile, ritengo, abbastanza ovviamente, che ci siano alcuni aspetti fondamentali da considerare: la struttura, le persone che all’interno della struttura lavorano e il modo, ovvero il modello organizzativo, con cui lavorano. La struttura, l’edificio, l’ospedale per intenderci è importante, ma non può essere l’aspetto decisivo per guidare le nostre scelte. Anzi la scelta della struttura e quindi, facendo riferimento alla situazione del VCO, la sua unicità con la conseguente nuova (o vecchia?)sede,piuttostocheilmantenimentodellevariesediattualinonèunasceltasolo politica, tra l’altro con posizioni molto mutevoli nel corso del tempo da parte dei vari schieramenti, cosa che getta più di qualche ombra sul ragionamento sotteso, ma una decisione che deve emergere da altre considerazioni che proveremo a fare sommariamente.
Credo molto convintamente che i medici e gli infermieri debbano essere parte attiva nella definizione dell’organizzazione aziendale e che questo sia il punto chiave di tutta la questione: ovviamente, questi aspetti vanno affrontati prima di deliberare fisicamente la struttura dove il lavoro verrà svolto. Parlando dei medici (mi limito alla parte medica per questioni di esperienza personale) individuerei alcuni settori su cui lavorare, a partire dalla definizione di competenza professionale che hanno elaborato due medici dell’Università di Rochester (New York) descrivendola come “uso abitualeegiudiziosodicomunicazione,conoscenza,capacitàtecniche,ragionamento clinico, emozioni, valori … per il beneficio dell’individuo e della comunità per cui si presta servizio” (5). Per i miei scopi semplificherò arbitrariamente e di molto i vari temi e suddividerò la discussione in tre ambiti: la competenza tecnica, la competenza relazionale e la competenza gestionale. Vedremo che, in realtà, le varie competenze sono strettamente interconnesse e la distinzione sarà forse un po’ fragile, ma comunque utile per semplicità espositiva. Anche l’analisi dei temi che affronteremo diseguitosarànecessariamenteparziale,piùutileperaprireundialogoeunconfronto che per esaurire gli argomenti ed arrivare a conclusioni certe. Diciamo che si tratta di un primo piccolo passo. Competenza tecnica. Da questo punto di vista, i problemi e le eventuali carenze sono, a mio modo di vedere, relativamente modesti, anche se qualche controllo sulla preparazione dei medici andrebbe fatto e ne parleremo brevemente dopo. L’Università da sempre è attenta a formare gli studenti sulle conoscenze specifiche del sapere medico. Abbiamo l’obbligo della formazione permanente con aggiornamenti scientifici ogni anno: sono eventi migliorabili sia nella qualità che nella scelta di argomenti, ma comunque garantiscono un aggiornamento accettabile. Parlando di Cardiologia, settore nel quale ho qualche conoscenza in più, ci sono le linee guida regolarmente pubblicate e aggiornate da varie società scientifiche indipendenti (6). Anche chi non ha tempo o voglia di seguire regolarmente le riviste specifichedelpropriosettoredicompetenza,trovanellelineeguidaottimicompendi, di grande aiuto nella pratica quotidiana. Un’osservazione aggiuntiva può emergere dalla riflessione condotta: ho parlato di
(3) https://www.ser-veneto.it/public/ reportps_2013.pdf
(4) SMCampbell,MORoland.Whydo peopleconsultthedoctor?Family Practice1996;13:75-83
(5) EpsteineHundert(RMEpstein,EM Hundert.Definingandassessing professionalcompetence.JAMA2002; 287:226-235)identificanosette macroareedicompetenze:cognitive, tecniche,integrative,dicontesto, relazionali,affettive/moralieattitudinali. Ancheinquestocasogliaspetti psicologiciesocialiemergono ampiamente.
(6) Leprincipalisocietàscientifiche cardiologichesonolaEuropeanSociety ofCardiology(https://www.escardio.org/ Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines) eleduegrandisocietàamericaneche spessopubblicanodocumenticomuni (AmericanHeartAssociation-https:// professional.heart.org/en/guidelines-andstatementseAmericanCollegeof Cardiology-https://www.acc.org/guidelines)oltreadaltreorganizzazionichesi occupanodirevisionedellaletteratura, come,percitaresolounesempio,la CochraneCollaboration-https://www. cochranelibrary.com
Pgg. 12-13 Alternativa
(7) Proviamoadimmaginareilpaziente chedebbadescriverealmedicounsuo sintomo:hainmenteunacerta sensazionefisicae/opsichicaecercale parole(nelsuovocabolarioenellasua grammatica)piùadatte,ospessosolo quellemenoinadatte,perdescriverela propriasensazione.Ilmedicopuòavere accessoalleparoledelpazientee,seè personaattenta,anchealsuononverbale, manonaipensieriemenchemenoalle sensazioni.Nellasuamenteilmedico riformulerà(nelsuovocabolarioenella suagrammatica)leparoleperrestituireal pazienteunapossibilespiegazionedel disturboriferito:nonsempreleparole avrannounaperfettacorrispondenzacon quantoilmedicohapensato.Eilpaziente ascolteràecomprenderàquesteparole percomeglièpossibileconlasuacultura,ilsuomomentoemotivo,emagari saràimbarazzatoachiederechiarimenti perqualcheconcettononbencompreso chequindirimarràtale.Insommaun problematicotelefonosenzafiliche distorceinevitabilmenteilreale contenutodelpensierodelpazienteedel medico.
settoredicompetenzasottintendendolaparolaspecialisticae,anchesesonoconvinto che sia quasi impossibile conoscere tutto della medicina attuale, non possiamo dimenticare che nel nostro lavoro di medici ci troviamo di fronte a persone “intere” contuttalalorocomplessitàenonaduncuore,adunfegato,adun’articolazione.Una delle competenze che andrebbe ripresa e sviluppata è proprio quella di una visione integrata dell’individuo che non trascuri le opportunità tecnologiche che la scienza attuale mette a disposizione, ma che riesca poi a confrontarsi con i problemi dell’individuo considerato in toto con la sua componente affettiva ed emotiva. Credo anche che questa capacità possa essere aiutata dal cambio di paradigma che proponevo prima: includere le variabili psicologiche e sociali nel nostro armamentario professionale farebbe di molto crescere la nostra capacità di considerare l’individuo nella sua reale e integrale complessità.
Competenzarelazionale.Sottoquestoaspetto,intesocomecapacitàdicostruireuna relazione con il paziente, con i colleghi e con i collaboratori anche non sanitari, i problemi mi sembrano più seri e le carenze abbastanza gravi. L’Università non si occupa affatto di approfondire questo tema che è lasciato alla buona volontà del professionista che si confronta quindi con una realtà che non ha avuto modo di approfondireprimadell’iniziodellapropriaattivitàlavorativanéteoricamentenécon esperienze pratiche. Perché occorre ricordare che anche le competenze relazionali non sono un dono di natura e, anche se qualche persona è spontaneamente più empatica di altre, possono essere apprese. Gli aspetti relazionali devono essere un elemento guida nella definizione delle caratteristiche del nostro Ospedale.
Partiamo da un assunto di fondo: l’incontro bidirezionale tra medico e paziente deve fare i conti con un’interpretazione dei fatti che non può essere una comprensione esaustivadellarealtàe,datochequestarelazionesibasapropriosullacomunicazione, è inevitabile che essa risenta di una visione del mondo parziale. Possiamo solo limitarci ad interpretare il mondo, non riuscendo mai a comprenderlo completamente: così, anche per la medicina, il modello interpretativo che scegliamo di adottare, più o menoconsapevolmente,implicheràcomeconseguenzaanchelasceltadellamodalità di relazione che utilizzeremo con il paziente (7)
Per la complessità ed unicità di ogni essere umano, la relazione che il medico saprà costruireemantenereconilpropriopazienteèassolutamentefondamentale,anchese spesso trascurata. Quello che viene poco considerato dal medico, che è spesso un convintoorganicista,è,comeabbiamogiàdetto,l’aspettopsicologicoedemotivodel paziente. Già Platone affermava: “Oggi, questo è l’errore che fanno gli uomini, ossia che alcuni cercano di essere medici della saggezza o della salute, ma separatamente l’una dall’altra”. Non abbiamo fatto molti passi avanti, anzi possiamo addirittura spingerci oltre e definire la malattia stessa come una “creazione” della medicina che ha artificiosamente raggruppato sintomi e segni per costruire uno schema nosologico utileperunaschematizzazione,manonnecessariamenteperaiutaree,soprattutto,per prenderci cura del paziente.
Stabilire e far crescere la relazione è ovviamente una precondizione necessaria per qualunque successo terapeutico, che potrà poi realizzarsi o meno, ma quello non è il nostro obbligo, non essendo noi onnipotenti: l’unico vero obbligo di qualunque operatore sanitario è la relazione con il paziente, sempre ricordando che non ci sono buone relazioni in assoluto, ma solo relazioni adatte ad un determinato contesto. Il primo passaggio nella costruzione di questa relazione è necessariamente l’ascolto, parola che etimologicamente significa porgere attentamente l’orecchio ed è molto di piùcheudireosentire.Bastipensarechenellinguaggiobiblicoilverboshemàindica contemporaneamente ascoltare e obbedire. Il vero ascolto è quello che ci impone di “obbedire”all’altrocheciparlaeciracconta,essendounpaziente,delsuostaremale. La risposta che all’ascolto deve necessariamente seguire non può più strutturarsi seguendo il modello paternalistico, come per anni si è fatto: il medico deve saper tollerare incoerenza e incertezza e saper condividere ogni decisione con il paziente. Un aspetto che va a porsi a cavallo tra aspetti relazionali, l’ascolto in particolare, e aspetti organizzativi e manageriali è quello del tempo.Viviamo e lavoriamo in effetti in un contesto particolare che, almeno a partire dell’aziendalizzazione degli ospedali, richiede al medico di essere produttivo e quindi di non “perdere tempo” con i pazienti. Anche i medici di medicina generale, con lunghe attese fuori
A ambienti territori scenari contesti
dall’ambulatorio, hanno per forza di cose tempi stretti, così come gli specialisti ambulatoriali che hanno un minutaggio definito dal datore di lavoro entro il quale devonochiuderelavisitaespessocisonopochimarginidimanovra.Glianglosassoni dicono:“Takeyourtime”dovelaparolabellaèyour,cioèquellocheservealpaziente e non quel poco di tempo che ha il medico! La soluzione sta probabilmente nel cambiare la modalità di valutazione di produttività: per chi fa i conti economici è importante solo la quantità di prestazioni erogate, ma per chi di quelle prestazioni ha bisogno conta chiaramente molto di più la qualità della prestazione stessa (8). Passare da una logica del profitto ad una di servizio sarebbe davvero una grande rivoluzione culturale che gli amministratori in genere faticano a digerire.
Una proposta che sta crescendo e che, pur avendo il difetto di essere di moda, presenta molti aspetti interessanti è la cosiddetta medicina narrativa che propone un modello relazionale che accoglie la narrazione autobiografica orale o scritta come aiuto terapeutico. Si tratta di uno strumento che aumenta la consapevolezza del paziente che si impegna in questo lavoro personale. Già l’anamnesi, se condotta in modo adatto, lasciando il dovuto spazio al paziente, può essere anche l’inizio di un percorso narrativo e avere un ruolo quasi terapeutico. Parlare delle emozioni e delle storie della malattia, dare un nome ai problemi è il primo passo per superarli. Nella narrazione i fatti restano tali e restano decisivi, ma sono inseriti in un contesto personale e la narrazione assume un valore ermeneutico: si ricavano significati che aiutano a comprendere il quadro e quindi indicano le azioni corrette da intraprendere (9) Competenza gestionale. Come detto all’inizio di queste riflessioni, vorremmo arrivare alla definizione della struttura in senso fisico e in senso organizzativo tenendodituttoquellochecisiamodetti:ladiscussionedellecompetenzerelazionali, apparentemente una digressione rispetto al tema di fondo, è in realtà il nodo della questione. Il nostro ospedale deve consentirci di (nel senso che deve essere pensato per) rispettare i diritti del paziente e supportare il medico, come singolo e come organizzazione, nel compiere il suo dovere (10). La struttura deve quindi aiutarci a soddisfare questi requisiti: esempi apparentemente banali potrebbero essere: avere adeguati spazi per i visitatori, sale d’attesa confortevoli, locali per visite mediche che davvero rispettino la privacy e consentano un incontro in un ambiente bello e piacevole, con spazi per l’elaborazione della narrazione.
Vale la pena di approfondire un aspetto assolutamente fondamentale dei diritti del paziente: l’accesso ad un servizio di qualità. Qui si pone una domanda chiave: come definiamo la qualità? Era questo in fondo il nostro punto di partenza alla base di tutta la riflessione condotta e mi sembra che si tratti del momento più alto di sinergia tra amministratori, medici e infermieri. Se ci limitiamo a definire la qualità come il soddisfacimento delle esigenze percepite dal cliente (la parola cliente usata nella definizione di Customer’s satisfaction già dice molto) a mio avviso, pur avendo iniziato a porci il problema, siamo ancora lontani dalla verità. La Agency for Heal-
(8) Peravereun’ideadelledimensionidi questoproblema,unostudiopubblicato sulBritishMedicalJournal(GIrvinget al.Internationalvariationsinprimary carephysicianconsultationtime:a systematicreviewof67countries.BMJ open2017;7(10):e017902)haanalizzato oltre28milionidiconsultazionidimedici dimedicinagenerale.Lemedieeuropee varianomolto:sivadai5minuti dell’Austriaai7.6dellaGermania;simigliorainGranBretagna(oltre9minuti)e inDanimarca,OlandaeSpagna(circa10 minuti).Vamegliolasituazionein Francia(16minuti),inSvizzera(17 minutiesoprattuttoinSvezia(oltre22 minuti).Sembraesistereunabuona,del restologica,correlazionetraspesa sanitariaprocapiteeduratadellavisitae, cosadecisamentepreoccupantee rilevante,unacorrelazioneinversatra lunghezzadellavisitaeprescrizionedi farmaci:ovvero“spendere”tempoconil pazientefarisparmiareterapie verosimilmenteinutilioquantomeno nonindispensabilialpazientestessoe, ovviamente,soldiallacollettività. Purtroppo,inquestostudiononèstata analizzatal’Italia,manonsembrano essercidatiparticolarmenteconfortanti.
(9) Lestorienarratenonparlanodella realtà,madifattonesonosempreuna deformazione.Ènecessarioarrivarea riconoscerelareciprocitàtrala“realtà” centratasullamalattiaequellacentrata sullaricercadisignificatodelpazientein modochesimantenganoviveanchele ambiguitàelemolteplicitàdeisignificati.
(10) Rispettoaidirittidelpaziente considerereialcuniaspettibasilari: contrattareconilmedicomantenendoun pianodiaccordoreciproco,esseretrattati conriservatezza,poterrifiutareuna terapiaancheseconsigliatadalproprio medico,essereinformatisullapropria condizionedisalute,sulleopzioni terapeutiche,suilororischiebeneficie sulleeventualiopzionialternative,poter accederealserviziochelostatodisalute richiede,neitempichelostatodisalutedi richiede,avereildirittodiusufruiredi procedurediagnosticheeterapeutiche innovative,ildirittodinonsubiredanni derivantidalcattivofunzionamentodei servizisanitariodaerrorimedicieil dirittodipoterusufruirediunelevato standarddiqualità.Traidoveridel medicoconsiderereiilnoncausaremale, procurareunbeneficio,mantenereun correttoequilibriotrairischieibenefici ovveroagirecon“giustizia”,rispettarela libertàeladignitàumanasempree comunque.Nonbasta,maèunbuon puntodipartenza.
Pgg. 14-15 Alternativa
(11) https://www.ahrq.gov/
thcare Research and Quality (11) identifica varie modalità di misurazione della qualità in sanità affrontando alcuni aspetti quantitativi come numero di sanitari per paziente, titoli acquisiti dai sanitari, aspetti organizzativi come per esempio le cartelle cliniche informatizzate. Possono avere indubbiamente valore ed è bene considerarli, ma ci stiamolimitandoaparametrielementarienonqualitativi.Altriindicatorisioccupano di vagliare l’apparato documentale e la sua attuazione: alcuni ospedali hanno una certificazione di qualità secondo lo standard ISO che si occupa dei processi, senza tuttavia definirne i contenuti che sono lasciati all’organizzazione. Un’altra modalità di certificazione fa riferimento allo standard JCI (Joint Commission International) che prevede invece contenuti già definiti e mirati per le strutture sanitarie. Per ogni processo viene definito a priori uno standard da raggiungere e si può poi valutare se il risultato desiderato viene raggiunto.
Forse qualche esempio di indicatore può aiutare a comprendere meglio il ruolo del medico nella gestione della qualità che non deve assolutamente essere appannaggio esclusivo della parte amministrativa.
(12) Adesempiolarootcauseanalysis
Se ci riferiamo ad un indicatore di processo, potremmo considerare un esame diagnostico ritenuto fondamentale per i pazienti con una definita condizione patologica (ma lo stesso potrebbe essere valido anche per una prescrizione terapeutica). Il controllo consiste nel verificare, su un campione o sulla intera popolazione che è affetta da quella malattia, che quell’esame sia effettivamente stato eseguito. Se davvero la cosa è vitale allora vogliamo avere il 100% dei pazienti che hanno eseguito l’esame necessario. Il controllo ci consente di identificare quanti e quali pazienti non hanno eseguito l’esame, indagare le ragioni di questo scostamento dallo standard desiderabile, attraverso varie tecniche che gli esperti di qualità hanno messoapunto (12),equindimettereinattolemisurenecessariearisolvereilproblema emerso.
(13) Semprepercapircimegliocitoun esempiodistandardJCI:“Ilricoveroeil trasferimentoda/inunitàditerapia intensivaoadaltaspecializzazionesono determinatidacriteriprestabiliti”.In pratical’organizzazionedevedimostrare diavereun’adeguatadocumentazione scrittadiquesticriteri,saperespiegare perchésonostatiscelti,comeviene verificatal’effettivaapplicazione,etc.Un altroesempiosullacompletezzadella letteradidimissione:“Laletteradi dimissionecontieneilmotivodel ricovero,lediagnosielecomorbilità, contienel'obiettivitàfisicariscontratae gliaccertamentisignificativi,contienele procedurediagnosticheeterapeutiche eseguite,contienelaterapia farmacologicasignificativa,compresala terapiaalladimissione,contienele condizioni/lostatodelpazientealla dimissioneeleistruzionidifollow-up”.
(14) EpsteineHundertcit.Interessante notarechetralemolteareedi competenzaindagatecisonolacapacità dicostruireunarelazione,dicondividere informazioniconilpazienteelacapacità diautovalutarsi.
Se invece ci riferiamo ad un indicatore di esito possiamo considerare un parametro numerico misurato all’inizio e alla fine del ricovero per documentare un miglioramento (un esame di laboratorio, un questionario che studi i sintomi, etc.) oppure, per esempio, valutare quanti pazienti sono costretti a rientrare in ospedale entro 3 mesi dalla dimissione, o qualunque altro parametro, purché misurabile. Definiamo a priori uno standard, di regola basato sui dati della letteratura o da nostre analisi dello storico della nostra struttura e, come prima, mettiamo in atto misure correttive se non otteniamo i risultati desiderati (13). Anche se questi strumenti sono fondamentali e consentono di attuare politiche di miglioramento continuo, sono tuttavia convinto che la qualità “vera” sia qualcosa di più sottile e complesso, difficilmente misurabile: semplificando molto potremmo considerarla come il giusto mix di competenza ed empatia. Del resto, non necessariamente avere titoli accademici o meriti scientifici in abbondanza, anche se garantiscono buone competenze tecniche, fanno di noi dei bravi medici; l’organizzazione che è perfetta nell’esecuzione degli esami, ha ottime statistiche di efficacia, ma lascia i pazienti con dubbi e insoddisfazioni non riesce a dare al paziente quello che la persona sofferente realmente desidera e richiede.
Un argomento spinoso da affrontare, ma che merita considerazione, è il tentativo di valutare, con strumenti relativamente obiettivi, l’effettiva competenza professionale deimedici.Neavevamoaccennatosopra:credocheunaqualcheformadivalutazione potrebbe aiutarci se non nella selezione del personale, almeno nell’attribuzione di particolariresponsabilità.Nonèmaifacileaffrontareserenamentequestoaspetto,ma sarà necessario farlo se vogliamo evitare che si faccia carriera solo invecchiando o, peggio, per “meriti” non professionali (14). Purtroppo, a monte di eventuali strumenti di valutazione, sarà necessario affrontare il problema per cui la sanità del VCO non riesce e reclutare i medici di cui ha bisogno. Forse, costruire un modello nuovo, efficiente, ma anche attento alla persona e davvero centrato sulle esigenze del paziente potrebbe essere un molla vincente. Vorrei affrontare solo di sfuggita ancora un punto che mi sembra sia critico: temo che manchi una corretta integrazione tra competenze mediche e infermieristiche che è invece un momento fondamentale per avere una sanità di qualità. Ognuno deve agire con il rispetto del proprio ruolo, ma anche con un’attenzione che a volte i medici non dimostrano nei confronti del personale infermieristico. Così come decisiva sarebbe
A ambienti territori scenari contesti
una condivisione e una sinergia di intenti tra la parte sanitaria e la parte amministrativa: solo remando nella stessa direzione, che non può essere unicamente quella del contenimento dei costi, si può costruire una sanità di qualità. Sia pure in modo molto parziale, abbiamo affrontato il tema della capacità e competenza professionale, relazionale e manageriale del medico e abbiamo abbozzato un possibile modello generale di sanità ideale. Tornando alla nostra realtà locale, ci resta da dire dove e come andremo a realizzare concretamente il nostro progetto. Ribadendo che nessuna organizzazione potrà funzionare bene se i suoi componenti non sono adeguatamente preparati e motivati, cerchiamo di immaginare quale possa essere la struttura adatta per riuscire ad offrire un servizio qualitativamenteequantitativamenteadeguato.Èimportanteribadirecheunastrutturanuovaed efficientenonbastaagarantireunabuonasanità:sarebbecomelimitarsiariverniciare le pareti di una casa che sta crollando, senza mettere mano alle strutture portanti, partendo dalle fondamenta per un vero salto di qualità. Non credo che ci sia una ricettafacileoscontataepensoche,inquestoperiododidifficoltàeconomiche,vadano analizzati molti aspetti, parecchi dei quali esulano totalmente dalle mie competenze. Costruendo un unico ospedale nuovo avremmo l’indiscutibile vantaggio di avere un edificio allo stato dell’arte, anche dal punto di vista energetico, cosa tutt’altro che irrilevante in questo momento storico e avremmo probabilmente la possibilità di risparmiare razionalizzando i servizi e la logistica, rendendo uniche le direzioni ed evitando i doppioni dei reparti. I lavoratori sarebbero in buona parte costretti ad adattarsi a una sede meno vicina a casa, ma sicuramente non perderebbero il loro posto di lavoro. Anche i pazienti avrebbero spesso più strada da percorrere per accedere all’ospedale, ma non credo che questa sarebbe una barriera impossibile da superare. Mantenere le 2-3 sedi attuali potrebbe essere un vantaggio per la popolazione che avrebbe un facile accesso ad un punto di primo soccorso (non necessariamente ad un DEA) vicino a casa. E potrebbe forse anche essere un risparmio, almeno nel breve termine. È tuttavia evidente che si dovrebbe procedere ad una razionalizzazione delle attività: una sola Medicina, una sola Ortopedia, una sola Cardiologia e così per tutte le specialità. Ci sarebbe la questione di come suddividere le attività tra le varie sedi, ma non credo sia una questione insormontabile, se si riesce ad applicare del sano buon senso. Comunque sia, si tratta di una soluzione necessaria, anche se si optasse per il nuovo ospedale unico, nell’attesa della sua costruzione. Qualunque opzione andrebbe integrata con un potenziamento dei servizi extraospedalieri: non intendo affrontare questo tema, ma mi sento di poter dire che il percorso in questo settore sarà lungo e accidentato. La scelta finale può basarsi su molti validi ragionamenti purché consideri le vere priorità delle persone. Solo una cosa riterrei inaccettabile: agire per pure scelte elettorali e campanilistiche, trascurando il bene della collettività che dovrebbe essere il primo interesse di ogni scelta politica degna di questo nome.
Pgg. 16-17 Alternativa
LA SALUTE. UN DIRITTO DELLA PERSONA E UN BENE SOCIALE
Superare i limiti dell’attuale sistema sanitario significa ispirarsi a una visione della realtà che intrecci in perfetto equilibrio“personale”e“sociale”, in piena corrispondenza con il dettato costituzionale
GianninoPiana
La salute è un diritto fondamentale della persona (di ognipersona),dirittocheècompitodelloStatotutelare e promuovere. Lo afferma con chiarezza la nostra Costituzione, laddove scrive: “La Repubblica tutela la salutecomefondamentaledirittodell’individuoeinteresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art. 32). La formula costituzionale mette in evidenza, pur nella sua stringatezza, i due aspetti sotto i quali la questione della salute deve essere considerata: quello soggettivo di “diritto della persona” e quello sociale di “bene collettivo”. Questa definizione corrisponde pienamente all’intero impianto costituzionale, ispirato a una visione della realtà nella quale “personale” e “sociale” si intrecciano in perfetto equilibrio, dando vita al binomio libertà-giustizia come pilastri fondamentali della vita associata. Il personalismo sociale, che costituisce il supporto culturale della nostra Costituzione, consente infatti il dispiegarsi diunrapportocorrettotra“dirittisoggettivi”–idiritticivili e politici – e “diritti economico-sociali”, conferendo alla salute, insieme al lavoro e all’istruzione, carattere di bene irrinunciabile che la Repubblica deve assicurare ad ogni cittadino. Lo Stato italiano è, da questo punto di vista, in pienaregola.L’assistenzamedicaelapossibilitàdifruizione delle strutture sanitarie è garantita a tutti i cittadini a prescindere dalla propria condizione sociale.
I limiti dell’attuale sistema
Diverso e meno positivo è tuttavia il giudizio che si deve dareapropositodelsistemaorganizzativoe,piùingenerale, della conduzione complessiva dell’apparato sanitario dove emergono consistenti limiti. I tempi di esecuzione di esami clinici o di visite specialistiche in ambito pubblico continuano a prolungarsi con evidenti difficoltà per molti cittadini costretti a ricorrere al privato, l’assenza di presidi territorialicheaffrontinosituazioniperlequalinonsiesige necessariamente il ricovero ospedaliero, la mancanza in alcuni settori di un personale sanitario sufficiente a far frontealladomandadiintervento,l’intasamentodeipronto soccorso con le lunghe file di attesa sono altrettanti segnali di uno stato tutt’altro che ottimale che crea un evidente disagio nella popolazione bisognosa di cure. La recente (e
non del tutto superata) pandemia da Covid-19 ha reso trasparente in modo inequivocabile la gravità di tale situazione ed evidenziato l’esigenza del ricorso a interventi immediati e risolutivi.
Ma il limite ancora più preoccupante dell’attuale esercizio dell’attività sanitaria è rappresentato dal verificarsi di una sempre maggiore distanza tra il personale sanitario (il medico in particolare) e il malato. L’introduzione di tecnologie sempre più sofisticate e l’avanzare costante delle specializzazioni sottraggono inevitabilmente spazio allo sviluppo del dialogo e del confronto personale. Da un lato, la rilevazione dei dati clinici relativi alla situazione del malato, tradizionalmente reperiti attraverso l’anamnesi, è oggiottenutamedianteilricorsoalletecnologie;dall’altro, l’attenzionedeimedicièsemprepiùincentratasull’organo malato, con la tendenza a non prendere sufficientemente in considerazione la situazione complessiva dell’organismo. Nel primo caso – l’uso esorbitante delle tecnologie e dell’affidamento ad esse – a venire a mancare è la conoscenza delle dinamiche psicologiche e delle condizioni sociali del malato, fattori che rivestono una importante funzionesianelladefinizionedelladiagnosisianelladeterminazione della cura. Nel secondo caso – l’eccesso di specializzazione – a venire a mancare è la conoscenza piena della condizione del malato, la possibilità cioè di fruire di un quadro organico della sua situazione – come vuole la medicina olistica – non potendo di conseguenza intraprendere un’azione curativa, che tenga nel dovuto conto i diversi risvolti della malattia.
Due proposte per l’umanizzazione
I limiti delineati (e ve ne sono altri) impongono la ricerca di alternative adeguate che restituiscano alla cura della salute un carattere umanizzante. Due piste (tra le molte) meritano, al riguardo, di essere percorse.
La prima è costituita dalla restituzione di centralità alla persona del malato. La malattia – ce lo ricorda l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) – è un fenomeno complessonelqualeentranoingiocodinamichepsicologiche e condizioni sociali, che implicano, per essere colte nella loro concreta e specifica consistenza, la disponibilità
ARiflessioni analisi commenti
del medico ad un confronto dialogico con il malato. La cura non può ridursi a una semplice considerazione della parte malata; comporta un “prendersi cura” della persona con un coinvolgimento, che crea le condizioni per una relazione fiduciale, la quale ha ricadute altamente positive anche sullo sviluppo della cura.
Ciò appare oggi ancora più evidente se si considera il primato assunto dal principio di autodeterminazione nella moderna bioetica; primato per il quale la decisione circa le modalità della cura, e prima ancora circa la scelta di sottoporsi o meno ad essa, sono demandate alla volontà del malato. Il che non fa che confermare del resto quanto è presente nella seconda parte dell’articolo 32 della Costituzione già segnalato, il quale recita: “Nessuno può essere obbligatoaundeterminatotrattamentosanitariosenonper disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Lapossibilitàchelarelazioneinterpersonalericuperipiena centralità è legata, oltre che alla sensibilità del medico e del personale sanitario, ad un iter formativo che, accanto alle conoscenze scientifico-tecniche assolutamente indispensabili, le quali, grazie alla rapidità del progresso in campo medico-biologico, costituiscono gran parte degli studidimedicinaedimpongonouncostanteaggiornamento, faccia sempre più spazio alla conoscenza delle scienze umane, scienze che concorrono alla acquisizione di una mentalità aperta al dialogo e forniscono gli strumenti utili per perseguirlo.
La seconda pista riguarda la necessità di una riorganizzazione del sistema sanitario che tenga conto delle attuali esigenzedellapopolazione.Ilpassaggiodaunasocietàstatica come quella del passato, dove lo scambio sociale si sviluppava su un territorio ristretto, a una società aperta e dinamica, nella quale la possibilità di comunicazione, sia a livellofisicocheculturale,èenormementecresciuta,rende necessario un radicale riassetto delle strutture sanitarie per offrire un servizio efficiente. La presenza di una molteplicità di ospedali su un territorio ristretto con pochi reparti e pochespecializzazioninonèpiùgiustificata,stantelarapidità con cui possono avvenire gli spostamenti anche a
distanze rilevanti.
Si impone dunque una revisione del sistema che sappia mediare e far interagire tra loro ospedali e presidi territoriali. Questo esige anzitutto una consistente riduzione del numero degli ospedali con la possibilità, in ragione della loro concentrazione, che ciascun ospedale venga dotato di molte specialità e che si garantisca in questo modo maggiore sicurezza per i malati, che possono, in caso di complicazioni, disporre con facilità di un’area allargata di competenze specialistiche per un’immediata consultazione e, in caso di necessità, la possibilità di trasferimento da un reparto all’altro. Ma esige anche, in secondo luogo, un forte incremento e una alta qualificazione dei presidi sul territorio con il coinvolgimento dei medici di base e con la presenza di specialisti in grado di affrontare una serie di stati patologici senza dover ricorrere alla ospedalizzazione. Questo processo di razionalizzazione consentirebbe una maggiore agibilità della conduzione dell’attività ospedaliera e rappresenterebbe un indubbio vantaggio per i malati ai quali in molti casi verrebbe consentito di non abbandonare le proprie case per essere curati. Sono considerazioni che non esauriscono certo i molti risvolti di una tematica – quella della tutela e della promozione della salute – che necessita di essere affrontata senza pregiudizi ideologici e senza interessi campanilistici e con un serio approccio interdisciplinare, avendo come riferimento il perseguimento del bene della persona e della comunità.
Pgg. 18-19 Alternativa
IMMAGINI. LE MANI, LO SGUARDO, RELAZIONI, EMOZIONI
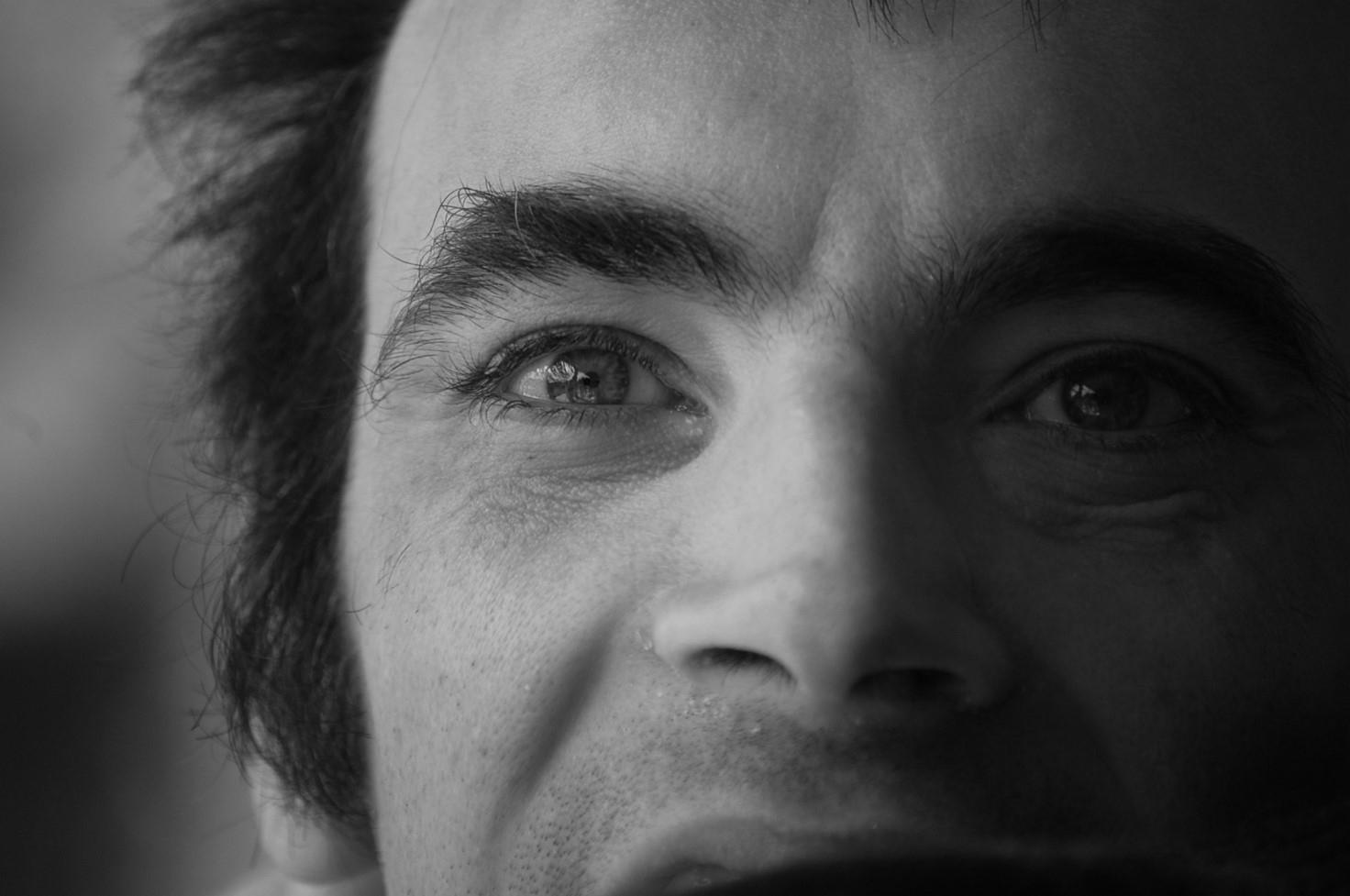
Le immagini dello slideshow raccontano del tempo dedicato all’intervento di psicomotricità rivolto ad alcune persone residenti e frequentanti il Centro Diurno in “Fondazione Istituto Sacra Famiglia” di Verbania.
Le persone a cui è dedicato l’intervento sono adulte e presentano, con sfumature differenti, abilitàpsicomotoriecompromesse,conschemidimovimentofissi,scarsamenteusatiininterazione e in autonomia, limitato o assente linguaggio verbale.
Il profilo identitario appare debole, il movimento è in prevalenza rigido, fisso e l’azione non marca nessuna differenza in quanto ripetitiva, stereotipata o inibita. È allora importante restituire senso al movimento sollecitandolo attraverso un setting definito, mediato da oggetti e materiali semplici che risveglino la sensorialità in condivisione.
Dove l’azione è inibita o assente il tempo ciclico si ferma e annulla l’identità, questo lavoro immette nella temporalità a partire dai “semplici” movimenti delle mani, attivando il tempo ciclico connesso all’identità, favorendo lo scambio con l’altro anche attraverso lo sguardo.
Accedi alla narrazione fotografica (durata: 4’e 47'') per vedere alcuni momenti dell’attività.
ARiflessioni analisi commenti
PaolaSau


Pgg. 20-21 Alternativa
NO VAX
Le personali considerazioni di fondo sulla sanità territoriale di un certo periodo storico, si intrecciano con l’analisi sulla validità o meno di un certo sistema o modus operandi in sanità
CarloBava
Fu un cenno della caposala ad indicarmi il telefono. Mi suonòstrano.
Quel mattino il primario aveva già detto tutto, e di più, sullemiediagnosichereputava,perlomeno,stravaganti.Non bastava?
La voce alla cornetta, di fatto, non era la sua: “Sei tu il Bava, il medico di Cannobio? Sono ***, ho bisogno di te, non dire dino,dopodomanivieniaPallanza”.
Ilmodoruvido,eancheunpo’insolente,rendevainutileogni ulteriorepresentazione:erailDirettoreSanitario.
Le pagine di Cronin, che per anni mi ero cucito addosso, prendendoinprestitounimmaginarioimprobabile,sistavano riaprendo a mia insaputa. Emozioni e suggestioni racchiuse ne“LaCittadella”o“Lavaligettadeldottore”,avrebberoprestoriempitodicoloreilmiofuturo.
Itantoattesi“anniottanta”,utopiadiuncambiamento,erano lìaportatadimano:parevachenessunodovessepiùrimanere indietro e qualcuno mi stava chiedendo di prenderne parte. Bastòquellatelefonata,perritrovarmiMedicoCondottodella ValleCannobina:operaiodellasalutesuunterritorio,lamontagna, che più di tutti stava soffrendo di quella precarietà facilmentetravestitadaanticameradell’abbandono.
Luoghiamicieamiciinqueiluoghi,divennerounaquotidianità fatta di sentimenti semplici, legati alla gioia e alla sofferenza,allavitaeallamorte.
Sullo sfondo, una valle infinitamente verde, dove, tra pieghe profonde, stavano racchiusi paesi minuscoli.Alcuni attaccati al mondo da nastri di mulattiere, dai mille e più gradini, apparentemente isolati, ma con un cuore ancora pulsante: la scuola.
Nelle due più isolate, scelsi di iniziare la mia avventura della Medicina Scolastica, con quattro bambini da una parte e tre dall’altra. Davvero pochi. Troppi, tuttavia, per non aver mai goduto delle tante attenzioni da sempre riservate agli scolari di città.
Spazzoliniedentifricio,trovaronounpostoinfondoaglizainetti.Unanovità.
Persinoipidocchi,visti“inmacro”,parevanosimpaticienon piùresponsabilidiinutiliediscriminanti“rapateazero”.Ben presto,ogniscuoladellavalle,confarmacie,dietiste,casefarmaceutiche e docenti, si ritrovò attore inconsapevole di una storianuovache,atratti,regalavailsaporediunafiabaalieto fine.
Godevo del privilegio di lavorare in un microcosmo, luogo dell’anima, favorito da un regalo ignaro dei miei genitori: il
dialetto.
“Avrai davanti persone, non malattie. Esseri umani con sensibilità, affetti e paure: avranno stima e fiducia in te quanto più riuscirai ad essere vero e credibile”:Alberto Malliani mio professore, poi amico fraterno, cosìmiguidava.
Eroun“battitorelibero”.
Avevo carta bianca su qualunque idea privilegiasse il benessere di quanti erano lì a resistere, testardi nel dimostrare amore per una terra e una quotidianità sempre più faticosa, ma ancora più affascinante per la sua manifesta e inesorabile fragilità.
Erano anni in cui le stagioni tenevano il ritmo dei giorni con la loro primordiale regolarità. Inverni severi, con gelo e neve chemutavanorealtàecoloriquandoagiornofattomispalancavano la valle e la sera me la richiudevano alle spalle per riaccompagnarmialcaldodiunavecchia“stufaeconomica”. Era un mattino di febbraio, carico della neve di carnevale. NellascuolapiùgrandedellaValle,lemaestre,chemalcelavano una certa apprensione, mi aspettavano con un caffè bellocaldo:dovevovaccinare.Annidisituazionicomplicate, nonavevanogarantitoregolaritànellecopertureobbligatorie: l’entusiasmo per una seria campagna vaccinale fu, quindi, la nuova “mission”. Le pluriclassi, “in istantanea”, erano la “coorte”giàsuddivisaperfascedietà:visiallegrieperniente turbatidall’ideadiqualcosachealcuninonpotevanonemmenoricordare.
Leinsegnanti,amorevoli,ciavevanolavorato.
Tuttofilavaliscio,senzaintoppi.Bambinigratificatieconsolatidaleccaleccaallafragola,egenitoripresidallaserietàdel momento: avevo giocato la carta dell’infermiera anziana. Gesti,calibratiesolenni,mettevanounacertasoggezione. Quando chiamammo l’Antonio, il vano della porta si riempì di una presenza statuaria. La mamma appariva in tutta la sua monumentalità. Incarnava quella femminilità che la montagna aveva via via trasformato, per necessità. Giovani donne subivano l’oltraggio delle fatiche che inesorabilmente le rendevano massicce e mascoline. Per mano teneva il più rubicondodellamattinata.
Biondo, occhi azzurri, le gote rosse come solo il freddo sa segnare.Maglionedilanagrezzaeindimenticabilicalzonidi vellutoacoste.I“pedù”,aipiedi.
Dasolozompòsuiduegradinidellascaletta,unpo’incuriosito, ma tranquillo. Chiesi alla mamma di porlo a pancia sotto con un gluteo scoperto. Senza complimenti lo spiaccicò sul
Acontributi
1
lenzuolino, chiappe all’aria e pantaloni tirati alle caviglie. Appena quegli occhi di falco, puntati in alto e di traverso, inquadraronolasiringa,successeilfattaccio.L’Antonio,sgusciato a scatto dalle braghe, prese a correre intorno al lettino. Girava e correva, correva e girava. Ad ogni giro, da quelle mani grandi, che nel frattempo avevano mollato i calzoni a coste,partivaunasventola.
Algridodi“fermatTogncheatamazzi”(fermati Antonio che ti ammazzo), non sbagliava un colpo. Lui … continuava a girare. Non so quante orbite contai,ma,all’ennesimosberlone,mimisidimezzo.
Dalbassodellamiaautorità,eraildoppiodime,fuilapidario: “sciora l’al porta a cà, se a nem avanti inscì stu fieu u crepa primadebottchedetetano”(signoraloportiacasa,seandiamo avanti così questo bimbo muore prima di botte che di tetano).
Quantoquelmondomiappartenesseequantogliappartenessi era ormai evidente. Ogni giorno, però, si aprivano squarci di un’umanità nascosta e quell’improvviso, inaspettato impulso No Vax partorì un pensiero doloroso da accettare e
ancora oggi vivo. Chiuso nel profondo di un cuore ormai anziano. Stavo davvero lavorando ad un modello di sanità nuovo,essenzialeachilesueradicitenevastretteasé,oppure cercavodirenderemenosoffertaecrudal’agoniadiunaciviltàchesiandavaspegnendo?
Nontrovaiononvollicercareunarisposta.
VissilaCannobinaperunadecinadianni.
L’estate scorsa, tornandoci, lungo la strada, quasi ad ogni curvamiapparivaunacasaconVENDESIscrittoingrande. DiAntonio so che è uno specialista di muri a secco e tetti in piode.
Haunooduebambinieviveancoralà.
Aottoanniavevadimostratochenonavrebbemollato,mai.
Con questo breve racconto autobiografico, l’autore ha vinto il primo premio per la narrativa al Concorso internazionale 2022“Salviamolamontagna”,dedicatoadAndreaTestoree Plinio Martini.

Alternativa
2
BARRIERE ARCHITETTONICHE E INCLUSIONE SOCIALE
Sembra realistico aspettarsi che i tempi siano maturi per un salto culturale che agevoli l’affermazione di una visione più completa della condizione delle persone con disabilità in tutti gli spazi sociali, sia quelli fisici che relazionali ChiaraBonolis
Quale impostazione?
(1) UnitedNations,Conventiononthe RightsofPersonswithDisabilities (CRPD),NewYork,13dicembre2006.
(2) Legge3Marzo2009(GUn.61del1403-2009).
(3) SchianchiM.,Disabilitàerelazioni sociali,2021,CarocciEditore,Roma.
Nel corso degli ultimi decenni l’approccio alle questioni sociali che si usa ricomprendere sotto il termine disabilità, è stato oggetto di una lenta e graduale evoluzione di cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1), ratificata dal Parlamento Italiano nel 2009, (2) è una significativa espressione.Alle vecchie e brutali pratiche di segregazione e isolamento è succeduto progressivamente un approccio che vede nell’assistenzialismo il punto nevralgico. Ora ci si trova in una fase in cui forse si è intrapreso, a più livelli, un percorso di superamento persino di quest’ultima impostazione che risulta molto radicata anche perchésitrasponeincorrispondentieconsolidateprassi.Unaprassicheconsidera,in via esclusiva, la persona con disabilità destinataria di misure e sostegni medico-assistenziali-reddituali (peraltro necessari e molto spesso insufficienti) che ha radici in una cultura della normalità e dell’abilismo tutt’oggi prevalente. In questa visione riaffioranoancorameccanismimentali,atteggiamenti,comportamenti,azionidiinferiorizzazione e marginalizzazione (3) delle persone con disabilità, considerandole una categoria speciale o a parte dell’universo umano.
(4) Questoincisonullavuoletogliere all’importanzadellinguaggioedalla pregnanzadiquelleparole.Siè consapevoli,alcontrario,delloro caratteredinamico-evolutivo,edella necessitàdiriappropriarsene adeguandoloallarealtà,appuntoperché, comeperladisabilità,visioni, concezioni,atteggiamenti,ideemutano neltempoeconesselasemantica.A questopropositosivedanodue convergentipubblicazionidifonte diversa(unaistituzionale,unaaziendale): AgenziadelleEntrate,DisabilitàIniziamodalleparole,2021;Intesa Sanpaolo,Leparolegiuste-Mediae personecondisabilità,2021.
Si tratterebbe, allora, di costruire e diffondere una nuova consapevolezza che non pensi più la disabilità in termini di estraneità rispetto a una condizione-modello della persona che si valuta funzionalmente regolare, equilibrata, normale. Dunque, la consapevolezza che la disabilità è insita e propria della condizione umana, costituisce il presupposto affinché l’inclusione sociale delle persone sia effettiva, perseguita, tangibile e sia vera solo se riguarda tutte le dimensioni del vivere, non ultima quella fondamentale delle relazioni. In questo modo si cercherebbe, finalmente, di superare quel frequente abuso linguistico (“inclusione”, “fragilità”, “diversità”, “empatia”, “resilienza”…) a cui, in particolare nei discorsi pubblici e con altrettanta frequenza, non corrisponde la concretezza delle azioni e che, perciò, rischia di rimanere puro esercizio retorico. (4)
Contesti complessi
È in questo solco che nel recente lavoro di tesi di laurea in Giurisprudenza (Università dell’Insubria) ho cercato di collocare le riflessioni concernenti l’ampia e articolata problematica dell’abbattimento delle barriere architettoniche - specificamente con riferimento ai luoghi pubblici di cultura.
La vastità e complessità del tema con cui ho dovuto confrontarmi è principalmente riferibile a due sue dimensioni intrinseche: da una parte, l’eterogeneità delle disabilità per tipologia (fisiche, sensoriali, mentali, altamente diversificate al loro interno) e
Acontributi
gravità; dall’altra, l’altrettanta variabilità degli ambienti fisici con le loro specifiche caratteristiche strutturali. In particolare, ambienti costruiti nei quali le barriere erano proprio componente ed elemento progettuale necessario o voluto. In questi casi, riferendosi prevalentemente a edifici antichi, si tratta del mero “superamento delle barriere architettoniche che il costruito storico presenta, [e che sono] ad esso strettamente connaturate.” (5) Al di fuori di queste situazioni, tuttavia, dovrebbe essere del tutto evidente che termini quali eliminazione delle barriere, accessibilità, visitabilità, agibilità, fruibilità, assumono un significato molto più ampio dovendo rispondere a quelle complessità. In questo senso, ovunque sia possibile, non è sufficiente agire su singole parti di un luogo ma occorre avere una visione d’insieme che colga tutte le possibili interazioni con l’ambiente e le sue componenti (non limitandosi all’eliminazione - peraltro essenziale - di una scala, un cordolo, un rialzo…).
Questa filosofia è alla base di quella impostazione progettuale denominata Universal Design (o, in alternativa, con analoghi inglesismi Design for All, Inclusive Design, Barrier-free Design) (6) termineintrodottoneglianni‘80perindicare “la progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, nella maggiore estensione possibile, senza necessità di adattamenti o ausili speciali”. In altri termini si tratta di realizzare “ambienti utilizzabili da parte di chiunque, nella maggiore estensione del termine, indipendentemente dall’età, dalle abilità o dalla situazione [...] persone giovani e anziane, con abilità eccellenti o ridotte, in condizioni ideali o in circostanze difficili.” (7)
Ovviamente, ove si debba intervenire su ambienti già costruiti - non potendo ripensarli ex novo - si tratterà di operare adattamenti, aggiustamenti, modifiche nella medesima logica o, qualora non vi sia possibilità, di ottemperare al mero superamento della barriera di cui si è detto più sopra.
Due interessi
Quest’ultimo necessario tipo di interventi sul patrimonio di edilizia antica, se invasivo, presenta un grado di complicazione tanto maggiore quanto più è alto il valore storico artistico da preservare, condizione assai ricorrente di buona parte degli edifici pubblici destinati ad attività di interesse culturale (musei, sedi storiche, sedi istituzionali, siti archeologici, teatri…).
Emerge qui il problema di conciliare conservazione e tutela di questo patrimonio e l’interesseall’indistinta(di tutti)einclusivaaccoglienzaambientale.Èquestounalto gradodiproblematicitàcheimponeuncorrispondentelivellodicompetenzaedesperienza che riesca a bilanciare efficacemente la massima accessibilità/fruibilità con la minima o nulla incidenza e invasività al complessivo valore storico-artistico delle strutture. D’altra parte, frequentemente, certe caratteristiche costruttive e identitarie di un sito storico o di sue parti (ad esempio certe cupole, torri, campanili…) rendono gli interventi ardui se non impossibili, con il rischio di arrecare un grave pregiudizio a questa identità.
È opportuno qui richiamare la specifica articolata normativa in merito, che nel corso degli ultimi decenni è intervenuta cercando di fornire strumenti che consentano di mantenere gli interventi in un quadro omogeneo e univoco.
Alla fine degli anni ‘80 risale una prima significativa iniziativa legislativa, la legge n. 13/1989 (8) che pur disciplinando, come si deduce dalla sua titolazione, gli interventi su abitazioni private, delinea una procedura autorizzativa (condizionata dalla verifica della sussistenza di quel pregiudizio) per le opere di adattamento di edifici sottoposti a vincolo artistico-architettonico e quindi considerandole nel novero delle possibili riqualificazioni.
Solo nel 2008 sono state emanate le già citate Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (9) che, richiamando come fontiispiratriciiprincipidiuguaglianzaepariopportunitàcontenutinellaCostituzioneItalianaenellaConvenzioneONU,regolamentanoinmodoorganicoerigorosole tipologie d’intervento finalizzate a rendere accessibili i luoghi di cultura. Tuttavia, l’impostazione di questo documento intende “superare la logica da manuale di progettazione, evitando di suggerire soluzioni preconfezionate.” evolendo essere “... strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata [...] al fine di superare la prassi corrente della mera
(5) MinisteroperiBenieleAttività Culturali,Decreto28Marzo2008,Linee guidaperilsuperamentodellebarriere architettonicheneiluoghidiinteresse culturale(GUSerieGeneralen.114del 16-05-2008-Suppl.Ordinarion.127) AllegatoAPremessa.
(6) DiRuoccoG.(acuradi),Ilpianodi eliminazionedellebarriere architettoniche,2018,FrancoAngeli Editore,Milano.p.14.
(7) Ibidem.
(8) Legge9gennaio1989,n.13 Disposizioniperfavorireilsuperamento el'eliminazionedellebarriere architettonichenegliedificiprivati(GU n.21del26-01-1989).
(9) Sivedanota5.
Alternativa Pgg. 24-25
(10) Ibidem.
“messa a norma” [...]. Si tratta, pertanto, di un documento sempre rivedibile e aggiornabile in quanto, avanzando le conoscenze e gli studi, esso dovrà necessariamente adeguarsi ai futuri sviluppi e alle esperienze elaborate.” (10) Questa visione ‘aperta’e flessibile ben coglie e soddisfa quella vastità, variabilità, complessità delle disabilità e non può che riferirsi alla necessità di un adeguamento costante delle conoscenze in materia.
Cogenza
ÈquiopportunoevidenziarechequestoprofilodinamicodelleLineeGuida,nonallude, tuttavia, ad un presunto grado di incertezza sul dover fare o ad una possibile discrezionalitàdell’adempiere edell’eseguire. Alcontrarioilsuocarattere‘adattivo’, superando ogni rigidità predeterminata delle soluzioni, rappresenta lo strumento più efficace per l’imprescindibile ricerca di quelle più adeguate al singolo caso.
(11)
Più in generale, il carattere necessariamente cogente delle prescrizioni è esplicitamente riaffermato, considerando che “Il rispetto delle numerose leggi vigenti è un obbligo per i tecnici e gli amministratori, non un “optional”. “Le norme e le prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche devono essere applicate costantemente in ogni progetto o attività [...]” e rispettate al pari “ [...] delle altre prescrizioni normative” (11)
(12) Ibidem.
Questa imperatività non esaurisce la qualità ed effettività degli interventi e delle relative soluzioni adottate, perché deve essere, doverosamente, accompagnato da un salto “di tipo culturale, che va compiuto per ottenere davvero risultati positivi [...]” considerando “[...] tali norme non come un ‘vincolo’penalizzante, ma una ‘opportunità’ positiva, finalizzata ad un beneficio generalizzato. Non, quindi, rigide norme per le persone con disabilità, ma provvedimenti operativi e linee guida per ottenere un ambiente che sia più confortevole e sicuro per “chiunque” (12)
Come visto, con riferimento qui a tutti gli ambienti e non solo ai luoghi di cultura, non può sfuggire l’importanza del richiamo al carattere cogente e vincolante dell’apparato regolatorio, smentita dalla constatazione di inadempienze o approssimazioni (di abbattimenti e adattamenti) in molte situazioni urbane e altrettanti edifici pubblici.
Azioni necessarie
È opportuno, dunque, orientare lo sguardo sulla sequenza delle azioni preparatorie che dovrebbero sfociare nel concreto e tangibile adeguamento degli ambienti. Il raggiungimento di questo traguardo può essere ottenuto tramite il perfezionamento di quelle azioni in successione: è necessario preventivamente osservare luoghi e ambienti,rilevarnelecaratteristichestrutturalieognitipodibarrierapresente,mettere a fuoco le priorità ovvero stabilire una scala di urgenze di intervento, predisporre un piano esecutivo. Sulla strada della prospettiva inclusiva, di cui si è detto sopra, tutte queste fasi preparatorie e, in generale, l’intervento in senso complessivo, dovrebbe presupporre una gestione aperta e partecipata (appunto la cosiddetta progettazione partecipata) attraverso il coinvolgimento diretto di utenti/fruitori e delle loro associazioni. Questo coinvolgimento, oltre a rappresentare una declinazione reale di democrazia diretta, può svolgere una funzione di controllo-stimolo (contrappeso) dell’azione amministrativa e concorre a ridurre la distanza tra la previsione normativa, per sua natura astratta e standardizzata, e l’esigenza di una soluzione adeguata calata nella situazione concreta.
(13) Art.32c.21Legge28febbraio1986 n.41(GUn.49del28-02-1986-Suppl. Ordinarion.13).
Ora,potrebbeessererelativamentecomprensibile,manonperquestolegittimoogiustificabile, che le Amministrazioni procedano lentamente e senza sollecitudine (uno dei tratti tipici dell’atteggiamento burocratico) negli adempimenti di quella sequenza di azioni la cui dilazione o ritardo integra inequivocabilmente i caratteri di un’omissione. Tanto più che quanto sopra, schematicamente descritto, è anch’esso previsto dalla specifica normativa che ha introdotto lo strumento del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) (13) - sia per l’edilizia privata che per i luoghi di cultura - e che si definisce in un quadro molto articolato di atti e operazioni. Atitolo esemplificativo ed illustrativo, si può richiamare il caso del Comune di Milano, con inizio del percorso di costruzione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) conAtto della Giunta Comunale del 07/03/2014 e conclusosi con Deliberazione della stessa solo del 02/03/2018 (dopo quattro anni - ! - certo
Acontributi
Ibidem,1.3.1,Normativainerentele barrierearchitettoniche.
afrontediunterritoriomoltovasto).Questacostruzionesièstrutturatanelleseguenti componenti, attraverso, appunto, un itinerario partecipato: analisi del quadro normativo di riferimento; metodo di costruzione del Piano; inquadramento e verifica di compatibilitàdelleazioniestrumentiindividuatinelPiano diabbattimento dellebarriere architettoniche con gli altri strumenti di pianificazione e governance; analisi dellostatodifattodiedificiespazicollettivi; mappaturadellecriticità; lineediintervento del piano; focus sulle barriere percettive e fisiche (linguaggi Lis e Loges, dimensioni e misure minime); determinazione dei costi standard.
Due casi
Tornando ora al lavoro di tesi, merita menzionare la parte nella quale si è cercato di osservare ed esaminare alcuni dei luoghi di cultura diVerbania. L’intento prefigurato è stato quello di verificare il livello di rispetto delle disposizioni esaminate e di quanto le questioni legate all'inclusione sociale fossero prese in considerazione nelle soluzioni adottate.Atitolo esemplificativo, si menziona il caso del Centro Eventi “Il Maggiore”, una struttura di recente costruzione, che presenta un tipico modello di eliminazione di impedimenti all’accesso di persone con carrozzina, sostanzialmente conforme al generico obbligo di abbattimento. Specificamente, nella sala teatrale la collocazione di queste persone è stata predisposta presso l’ampio spazio-corridoio che separa la platea superiore da quella inferiore: esse si posizionano in questa area piana e agevolmente percorribile, senza far parte e integrarsi nelle file dei posti a sedere. Se ne deduce che si tratti di una scelta che ha ritenuto sufficiente prevedere uno spazio libero - privo di ostacoli - in cui è possibile stazionare con la carrozzina davanti alla prima fila della platea superiore: dunque ritenendo indifferente o marginale prevedere il suo inserimento nella stessa fila in condizione paritaria di affiancamento con gli altri posti a sedere. Una soluzione semplificata che non pone attenzione su aspetti, apparentemente trascurabili, riecheggianti una pratica che separa, distanzia, distingue. Certo verrebbe da commentare che questi sono dettagli irrilevanti o pretenziosi di fronte all’essenziale: ‘è già tanto se si eliminano gli impedimenti alla mobilità’.
Viceversa, sembra realistico aspettarsi che i tempi siano maturi per un salto culturale che agevoli l’affermazione di una visione più completa della condizione delle persone con disabilità in tutti gli spazi sociali, sia quelli fisici che relazionali. Nell’osservazione menzionata della realtà verbanese, non sono mancati, tuttavia, esempidibuonesoluzioniall’accessibilitàancheincomplessicasidiedificiristrutturati. È opportuno qui menzionare l’importante lavoro di restauro-adeguamento di Villa Simonetta che, nonostante l’alto valore storico da preservare, è stata resa completamente ed efficacemente accessibile e fruibile da parte di tutti.
Un auspicio
L’attualitàdeltematrattatoemergeanchedaalcuniprogrammielettoralidellerecenti elezionipolitiche.Èprobabilecheilrichiamoadinterventidiabbattimentodellebarriere architettoniche sia consuetudinario e, dunque, rituale in una sede nella quale prevalgono le promesse. In effetti di tre programmi esaminati due ne accennano con affermazioni di principio ed in modo molto generico. Uno solo fornisce indicazioni più precise su alcune priorità rendendo la promessa più attendibile. Vadasécheilcamminosiaancoramoltolungo,segnatocom’èdisegnalipositivima non sempre univoci in capo alla determinazione con cui leAmministrazioni dispongono e perseguono decisioni in merito. Ci si augura che tutti gli attori sociali e i soggetti coinvolti (cioè tutti i cittadini) le incalzino.
Alternativa Pgg. 26-27
PREN DERE ESEM PIO DA...
ROTELLANDO
Diffondere e incentivare ilturismo accessibilee l’accoglienza per tutti, promuovere le attività volte alla rimozione dellebarriere architettoniche e culturali, sono gli obiettivi di Rotellando,che propone il turismo dal punto di vista del rotellato, ovvero di chi utilizza una sedia a rotelle, per far nascere un nuovo sguardo sul mondo della disabilità
FabrizioMarta
avorare per l’accessibilità significa rendere un territorio accogliente per tutti, sviluppandolo in armonia con la comunità cheloabita,rendendoloprotagonistaprincipale.
Un territorio accogliente per i turisti con disabilità è più accogliente anche per i cittadini che lo abitano.
La Cooperativa Differenza, attraverso l’Associazione di promozione sociale “ROTELLANDO”, che si occupa di turismo accessibile e di sensibilizzazione alla disabilità,harealizzatoilprogetto“TurismoperTutti. Tutti Turisti”, finanziato in parte dalla Fondazione Comunitaria del VCO e con l’apporto del Distretto dei Laghi e delle Valli dell’Ossola.
Obiettivo prioritario del progetto: la creazione di un sistema integrato di servizi e attività, ricettive e turistiche, in grado di fornire risposte soddisfacenti a qualunque richiesta e diffondere le informazioni necessarie a rendere il territorio del VCO attrattivo per i turisti con esigenze specifiche, perché possano sapere dove fare certi tipi di esperienza, indipendentemente dalle caratteristiche personali.
È stata realizzata una campagna organica con la messa a sistema di risorse e informazioni dedicate a persone disabili, residenti e turisti, per costruire nel VCO un'offerta integrata di strutture e supporti disponibili, finalizzati a rendere il territorio fruibile ed accogliente per tutti, avviando un sistema di comunicazione idoneo a fornire le informazioni necessarie ai disabili per una programmazione consapevole delle escursioni in natura.
Altro obiettivo del progetto è quello di promuovere la diffusione della cultura dell’accessibilità, di realizzare e descrivere una catena di accessibilità alla persona con bisogni speciali, affinché possa decidere in modo autonomo se un luogo è consono alle
proprie esigenze.
“Turismo per Tutti. Tutti Turisti”, nel descrivere e mappare i luoghi dal punto di vista dell’accessibilità, consente alle persone interessate di scegliere, in base alle informazioni ricevute e alle loro possibilità, se visitarli oppure no.
Il territorio del VCO ha ancora grandi lacune in termini di accessibilità e di servizi per l’accoglienza di tutti, in particolare relativamente ai mezzi di trasporto. Ma proprio perché sotto tale aspetto è un territorio vergine, è un luogo in cui è importante investire e soprattutto progettare in termine di for All Un territorio ospitale dà stimoli, suscita interesse in chi lo visita, e offre benefici a chi lo vive.
Sono state individuate delle zone all’interno del VCO che, per importanza turistica e per caratteristiche territoriali possono essere idonee ad accogliere persone con diverse esigenze.
Per ogni itinerario è stata creata una scheda che tiene conto degli interessi turistici e naturalistici del luogo in chiave di accessibilità. Ogni percorso è stato mappato e schedulato seguendo i sottoelencati criteri:
-Descrizione della località e delle cose da vedere;
-Descrizione dell’accessibilità e delle difficoltà per persone con mobilità ridotta; lunghezza e durata del percorso;
-Informazioni relative ai parcheggi, ai siti della Polizia Municipale, dell’Ufficio Turisticoedeiserviziigieniciaccessibili,sepresenti; Sono state pertanto mappate le seguenti località:
-Arona;
-Isola dei Pescatori e GiardinoAlpinia;
-Baveno;
-Cannobio;
-Domodossola, Vogogna e dintorni;
-Trontano;
A cosa avviene in casa d’altri
L
-Santa Maria Maggiore;
-Macugnaga;
-Crodo, Premia, Formazza e Alpe Devero.
Oltre alla mappatura dei percorsi turistici sono stati segnalati, con il sostegno dell’Ente Parco Val Grande, ed in particolare delle sue guide naturalistiche, alcuni itinerari naturalistici all’interno del Parco stesso, luogo morfologicamente poco praticabile. I percorsi mappati sono:
-Riserva Naturale del Fondo Toce a Verbania;

-Sentiero per Tutti a Caprezzo;
-Piancavallo–MorissoloaOggebbio;
-Bosco Tenso a Premosello Chiovenda.
D’importanza fondamentale è stato anche il supporto del Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli dell’Ossola, che ha pubblicato in 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) gli itinerari for All sulle pagine del sito ufficiale, nella sezione
OUTDOOR – PERCORSI TEMATI-
CI:
https://www.distrettolaghi.it/it/percorsi?tid=All&tid_1=All&tid_ 2=All&tid_4=All&tid_5=460&term_ node_tid_depth_i18n=All
Il Distretto dei Laghi ha inoltre pubblicato un e-book che raccoglie tutti i percorsi, tradotto anche in inglese e facilmente scaricabile dal sito stesso.
Tutti i percorsi sono inoltre consultabili sul sito di Rotellando nella sezione VCO FOR ALL – DOVE ANDARE-https://rotellando.it/doveandare/ Infine ogni scheda è stata inviata ai comuni e agli uffici del turismo del territorio, per una diffusione capillare delle informazioni.
Per coinvolgere il più possibile i cittadini del VCO con disabilità nella fruizionedeipercorsi,sonostateorganizzate passeggiate inclusive, in particolare con gli ospiti della Sacra Famiglia di Verbania che hanno
potuto visitare l’Isola dei Pescatori e hanno effettuato un laboratorio naturalisticoalgiardinoAlpiniadiStresae nel Bosco Tenso di Premosello.
Dopo un lungo periodo di forti restrizioni sociali dovute al Covid, questi soggiorni hanno permesso agli ospiti ditornareallanormalità,offrendoloro momenti di svago e divertimento, favorendo l’autonomia e potenziando le loro competenze relazionali.
Il progetto di mappatura e soprattutto di creazione della rete è stato abbastanza complesso e articolato, sia perché nato in periodo di pandemia, sia perché è ancora difficile e complesso divulgare le informazioni nel circuito turistico.
Riteniamo però che l’obiettivo del progetto sia stato ampiamente superato, in quanto si è riusciti a costruire una raccolta di pubblicazioni e informazioni utili nel tempo a persone con disabilità, residenti o in transito nella nostra provincia.
28-29 Alternativa
Pgg.
Lago d’Orta – Foto di Giulia Virgara
QUANTO È COMODO LO
STEREOTIPO!
Pregiudizi e preconcetti circolano per ignoranza, per negligenza e contribuiscono a diffondere idee e valutazioni sbagliate, distorsioni del pensiero, falsa conoscenza RobertoNegroni
(1) Ist. dell’Enciclopedia Italiana “G. Treccani”, Vocabolario della Lingua Italiana, Vol. IV, Roma, 1984, p. 589.
(2) Ibidem, Vol. III**, pp.1055 e 1065.
tereotipo è sostantivo piuttosto diffuso, deriva dal francese stéréotype che originariamente indicava un particolareprocedimento diriproduzione della stampa, ma nel linguaggio corrente significa: “locuzione o espressione fissatasi in una determinata forma e ripetuta quindi meccanicamente e banalizzata”, o anche: “opinione precostituita, generalizzata e semplicistica, che non si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli casi ma si ripete meccanicamente” (1). È parente stretto di altri vocaboli più consueti e di più immediato significato, come preconcetto (concepito prima): “convincimento, idea, opinione privi di giustificazioni razionali e non suffragate da conoscenze ed esperienze dirette” e pregiudizio: “idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti delle persone e delle cose tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore” (2) Di stereotipo parlava, qualche giorno prima delle scorse elezioni di settembre, l’antropologo Marino Niola in un’intervista (huffpost) a proposito della tradizionale calata elettorale al Sud e, nello specifico, a Napoli e in Campania, della schiera di dirigenti dei gruppi politici in competizione tra loro a magnificare le inenarrabili colate di aiuti, sostegni, sussidi, prebende e sinecure in prossimo arrivo a beneficio del popolo ben votante;
con buona pace di più di un secolo di meridionalismo, di Giustino Fortunato, di Gaetano Salvemini diAntonio Gramsci e di Pasquale Saraceno. Niola si riferiva a “l’antico stereotipo, idiota, (…) Sud = assistenzialismo (…). Un'idea, declinata in vari modi, secondo cui Napoli è la città dei soldi a fondo perduto. (…) In realtà (…) dopo gli anni '80 il Sud nella ripartizione dei fondi non ha esattamente fatto la parte del leone. Inoltre, questo stereotipo offusca i poli di eccellenza che ci sono in zona. Non viene vista come città produttiva, invece lo è”.
Niola aveva ragione, al di là di tutto quanto si possa dire e discutere intorno all’equazione Sud = assistenzialismo (che se riformulassimo in Sud = disoccupazione sarebbe almeno più appropriata), l’applicazione pura esemplicediunsiffattostereotipo a vaste realtà dinamiche e complesse da parte dei maggiorenti della classe politica del Paese non è certo un’operazione sagace. Appare, piuttosto, come un espediente volto a perpetuare un pregiudizio, facendo d’ogni erba un fascio, che sbrigativamente ingabbia una realtà articolata e composita (quanti sono i Sud d’Italia?) in una banale semplificazione, oltre tutto, di dubbia efficacia, come, in quella stessa occasione, Niola confermava: “Spostano qualcuno che fa parte della massa degli indecisi, ma non di più. (…) Il voto dei napoletani viene considerato, a posteriori, come un voto d'istinto,
A Cosa avviene in casa d’altri
NON PREN DERE ESEM PIO DA... S
fatto senza ragionamento politico. Anche questa narrazione è falsa”. Ma allora, perché questo irrazionale modo di proporsi di quei politici? Tutti sciocchi, sprovveduti? In parte sì,puòdarsi,maipiùnodicerto.Sisa che quella è una banale generalizzazione di una realtà multiforme, ma è vantaggioso raccontarla così, fingendo di credere e, soprattutto, facendo credere che quella realtà sia omogenea nella sua infantile semplicità. Si getta una rete con due tanto auspicati quanto probabili risultati: si accalappia qualche sprovveduto e, soprattutto, si dà plateale conferma che il popolo è bue, e tale è opportuno che resti.
Detto in altre parole, se spesso lo stereotipo è utilizzato in buona fede da chi lo ritiene un giusto pensiero, non meno di frequente è impiegato in modo consapevolmente strumentale per abulica inerzia o, peggio, per specifico interesse; perché, raccontiamocela giusta, lo stereotipo spesso è comodo, risolve un approccio con una battuta, dissimula superficialità e pressapochismo, evita l’impegno di una spiegazione accurata, di complicati distinguo. E poiché lo stereotipo, come una muffa, vegeta e prolifica non solo nella cartella del politico, ma nelle tasche di tutti noi (i confirmation bias della psicologia cognitiva), i problemi che nascono dalla sua circolazione, consapevole o meno che sia, assumono dimensioni planetarie. L’intera società ne è brodo di coltura e, conseguentemente, tutti ne siamo, spesso inconsapevolmente, portatori. Pregiudizi, preconcetti e stereotipi, grandi o piccoli che siano, circolano con facilità e fanno proseliti: per ignoranza, per negligenza, per
sciattezza e contribuiscono a diffondere idee e valutazioni sbagliate, distorsioni del pensiero, falsa conoscenza.
Nessun settore del vivere sociale ne è esente,nemmeno(edèciòcheinqueste pagine più interessa) i molteplici ambiti in cui si esplica l’impegno e il lavoro in campo sociale, ma qui, come in altri ambiti sensibili della società, i danni che provoca quella circolazione rischiano di essere particolarmente gravi, perché approcci filtrati da stereotipi producono la deformazionedellestessefondamenta su cui l’impegno e il lavoro poggiano, cioè la conoscenza della realtà in cui si deve operare, che fin dal principio viene banalizzata, deformata, oscurata, compromessa. Non prendiamo, perciò, cattivo esempio da certo ceto politico. Tra chi opera, a qualsiasi titolo, in campo sociale, la caccia a pregiudizi, a preconcetti e a stereotipi deve essere aperta dodici mesi all’anno, e non serve licenza.
Pgg. 30-31 Alternativa
PRO GET TI PALLIUM: LE CURE
CristinaBarberisNegra
l progetto Pallium è stato attivato alloscopodifacilitarel’accessoalle cure palliative al maggior numero di pazienti possibili, in particolare nelle aree periferiche, dove attualmente ne usufruisce solo il 40% dei potenzialifruitori.L’ambitodellecure palliative riguarda quel momento molto delicato della vita in cui, sospese le cure attive per l’irreversibilità dellasituazionedimalattia,ilpaziente ha bisogno di una serie di trattamenti che gli consentano di migliorare la qualità della propria esistenza, riducendo al minimo sofferenza e dolore. Le cure palliative riguardano anche, parallelamente, i familiari del malato che vengono assistiti e sostenuti in questo processo di accompagnamento.
I partner
Al progetto hanno aderito partner pubblici e del privato sociale di Italia e Svizzera: La Bitta Società cooperativa Sociale Onlus, capofila italiano, Hôpital du Valais, capofila svizzero, ASL VCO, Fondazione Comunitaria del VCO ed Emisfera Società Cooperativa.
Loscopodell’iniziativa,oltreagarantire l’accesso alle cure palliative, è di favorire la permanenza a domicilio dei pazienti, con tutti i benefici correlati alla qualità di vita ma anche, in una prospettiva di sostenibilità degli interventi, alla riduzione dei costi relativi alla cura e assistenza. Il pro-
getto è anche un’occasione per creare una cultura, una conoscenza e una sensibilità più diffusa su questo tema.
Le azioni
Le azioni progettuali prevedono un approccio transfrontaliero che si concretizzerà in:
-sviluppo di una soluzione tecnologica, in chiave di tutoraggio di comunità, che aiuti a creare una rete di assistenza formata e informata e permetta ai pazienti e ai loro familiari di avere un quadro preciso delle procedure, dei servizi e dei supporti disponibili in materia di cure palliative, costruendo un livello di consapevolezza e di assistenza più puntuale e accurato;
-intensificazione del supporto psicologico per caregiver e pazienti, che riguarderà almeno 250 nuclei familiari, per sostenere la permanenza a domicilio dei pazienti;
-sviluppo di percorsi formativi articolati che coinvolgeranno almeno 200 operatori, risorse di volontariato, caregiver e medici di medicina generale e di continuità assistenziale dei due territori che operano nell’ambito dell’assistenza e cura dei pazienti terminali.
L’APP
La piattaforma tecnologica raccoglierà le informazioni relative alle procedure da applicare ai pazienti; presenterà le strutture presenti
nell’area geografica di interesse; consentirà la visualizzazione delle informazioni in merito al paziente collegato, al caregiver o al professionista di riferimento, con la creazione di una propria bacheca personale di informazioni; darà notizie di eventi in programma, coerenti con i temi delle cure palliative e dell’educazione alla morte. L’App fornirà anche approfondimenti su temi di carattere più ampio inerenti alle cure palliative, quali la legislazione, le equipe multidisciplinari, i diritti dei pazienti; illustrerà, in linea con i bisogni dei malati e delle famiglie, il percorso delle cure palliative e il ruolo del caregiver; offrirà informazione scientifica certificata e collegamenti ad altre piattaforme.
La formazione
Perquantoriguardaleconoscenzeele competenze, si intendono sviluppare percorsi formativi per gli operatori, per i volontari e per i caregiver che intervengono nei processi di cure palliative, allo scopo di favorire il consolidamento di una cultura comune, nell’approccio e nella gestione delle stesse, entro una modalità di intervento di rete.
Si è pensato a un’erogazione dei materiali online per garantire la massima accessibilità e diffusione. La forma scelta daCREMIT - Università Cattolica di Milano, è statadi due MOOC (Massive Open Online Corses) resi disponibili, a chiunque sia
La Cooperativa La Bitta è il capofila italiano del progetto Interreg dedicato alle cure palliative, volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari
I
CURE CON IL CUORE
interessato, tramite piattaformawww.learn. eduopen.org.
Il primo, già in corso, è un’edizione di “Tutor di Comunità” per riflettere sul bisogno di un approccio sistemico nell'affrontare percorsi inerenti alle cure palliative e su come, per farlo, sia necessario ripartire dalla comunità.
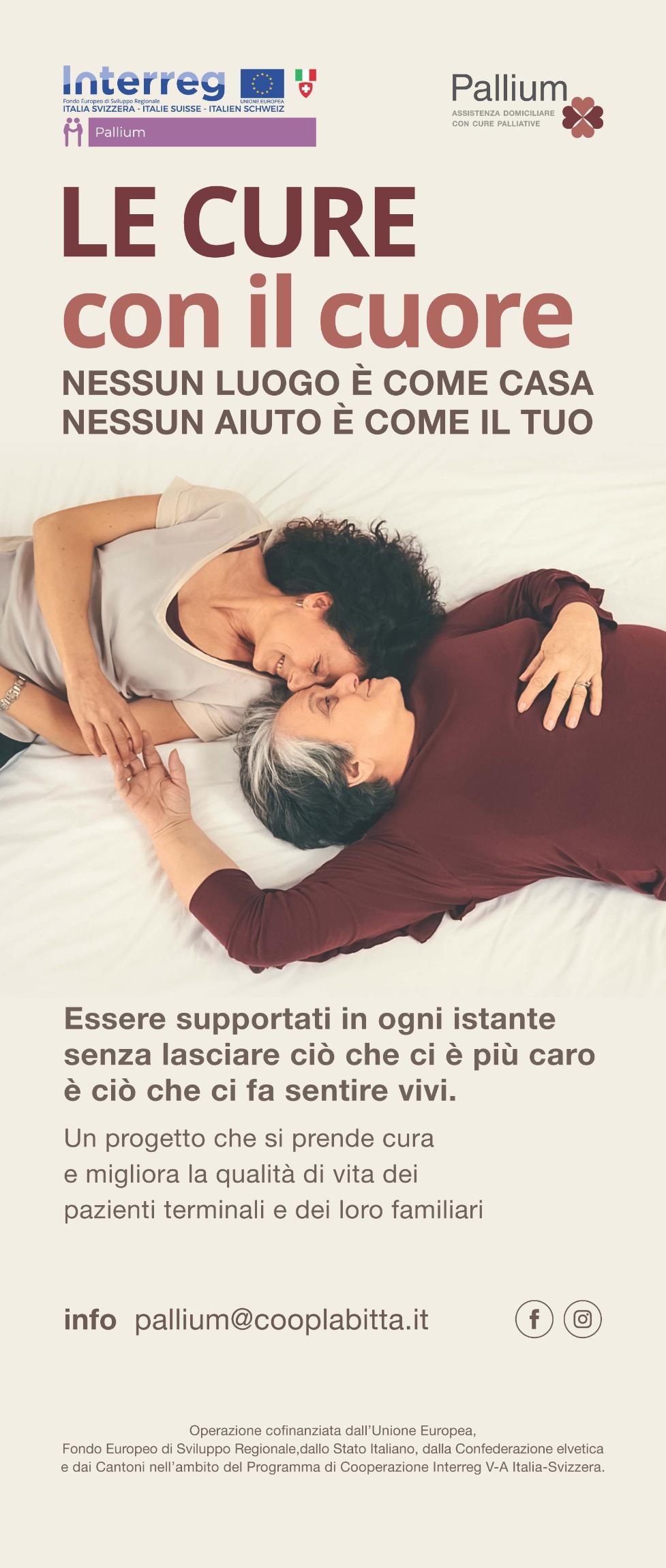
Il secondoMOOC “Pallium" è in fase di sviluppo e affronterà temi specifici: le cure palliative, affrontare il dolore, il ruolo dei volontari, il ruolo della tecnologia, etc., con uno sguardo al modello italiano e a quello svizzero. Il percorso online saràintegrato, per il personale del VCO, con 4 laboratori in presenza, previsti per la primavera 2023, che avvieranno un confronto con personale medico-sanitario, psicologi, assistenti sociali, volontari assistenziali e di supporto psicologico, per sviluppare una cultura delle cure palliative che sia multidisciplinare.
Altre attività
In un recente tavolo transfrontaliero in Svizzera, in cui il team italiano di progetto ha avuto modo di visitare l’Hôpital du Martigny e la Fondazione Maison Azur, è emerso, in maniera ancora più evidente, come la dimensione esistenzialedeipazientiedeilorofamiliarirappresentiunelemento fondamentale per la qualità della loro vita. Uno studio (Reed, 1999), condotto su pazienti in fase di malattia avanzata, ha osservato come la qualità di vita dei pazienti terminali sia più correlata alla loro capacità di dare un senso all’esperienza vissuta che alle oggettive condizioni fisiche. Molto interessante è stato, a tale proposito, l’approfondimento di due iniziative già attive in Svizzera: i Cafés Mortels, nati dall’idea del sociologo svizzero Bernard Crettazche,nel2004haavviatosituazioniinformali“dabistrot” nelle quali “rilasciare in modo spontaneo e selvaggio una parola sulla morte”; il corso di ultimo soccorso per imparare ad affrontare le domande più profonde che emergono nel momentoincuiunavitastaperterminareeoffronostrumenti e letture per entrare in tematiche quali: la morte fa parte della vita; anticipare e prendere decisioni; alleviare la sofferenza; dire addio.
Pgg. 32-33 Alternativa
CONNESSI CON L’AMBIENTE
Un progetto per sensibilizzare i ragazzi alla tutela del territorio e del pianeta, condotto dalla Cooperativa Risorse e partecipato dalle scuole elementari
CristinaBarberisNegra
alunni, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, che hanno partecipato ai laboratori; oltre cento insegnanti che hanno frequentato i corsi di formazione; 3 Istituti coinvolti (I.C. Intra - I.C. Anna Antonini - I.C. Rina Monti Stella) con i relativi Comitati genitori; 27 classi di 9 scuole primarie; 49 classi di 3 scuole secondarie di I grado; 10 mesi di attività, da novembre 2021 a settembre 2022; 1.280 ore di progetto di cui 824 ore di laboratorio e 456 ore di uscite sul territorio; 340 trasferte in pullmino; 9 diverse tipologie di laboratorio: due dedicate alla pietra e al lapideo, tre all’arte e alla scoperta del patrimonio del Verbano Cusio Ossola, due alla tradizione del legno, uno alle api e ai prodotti dell’apicultura.
Questi in sintesi i numeri del progetto Connessi con l’ambiente, condotto dalla Cooperativa Sociale Risorse, scritto dal Consorzio Link e dal Comitato Genitori di Intra, che ha portato in dote la preziosa esperienza maturata negli scorsi anni, e finanziato dal bando My future di Fondazione Cariplo, impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.
Ogni anno, infatti, grazie ai finanziamenti di Fondazione Cariplo, vengono realizzati più di 1.000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto
sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee.
Il progetto “Connessi con l’ambiente” ha visto anche il sostegno e il cofinanziamento di Comune di Verbania, Assograniti ed Ente Parco Nazionale Val Grande.
Il Patto di Comunità
La buona riuscita dell’iniziativa è da attribuirsi al Patto di Comunità.
Il patto, sottoscritto dal Comune di Verbania, Assessorato alla Pubblica Istruzione,daitreIstitutiComprensivi, dai Comitati dei Genitori di Intra, Trobaso e Pallanza e dal Consorzio LINK Cooperativa Sociale, si pone come principali obiettivi:
•Favorire l’organicità degli interventi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) tra i diversi Istituti e lo scambio di buone prassi.
•Consentire ai docenti e agli allievi, senza discriminazioni di alcun tipo, di poter usufruire di attività e servizi del Patto Educativo di Comunità.
•FavorirelaricadutadelPattoEducativo di Comunità attivando un circolo virtuosodiretetraidiversiattoricoinvolti.
•In particolare vuole rispondere agli stimoli promossi daAgenda del ONU 2030;svilupparee/oottimizzareserviziEducatividiComunitàperdocentie allievi e per tutta la cittadinanza in generale;aumentarel’adozionecondivisa di progetti formativi e stimolare sinergie tra i diversi soggetti locali pubblici e privati coinvolti e coinvolgibili nelle progettazioni; contribuire al perseguimento dei principi orizzontali del Fondo Sociale Europeo di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e parità tra uomini e donne (vedi POR FSE 20142020 Sezione 11).
Lo scopo del progetto
Il progetto “Connessi con l’ambiente” è stato individuato, dai sottoscrittori del Patto di Comunità, proprio perché estremamente coerente con gli obiettivi prefissati. L’iniziativa, infatti, è stata finalizzata a costruire insieme proposte formative integrative, rivolte agli studenti degli Istituti comprensivi, di età compresa fra i 9 e i 14 anni, e ai loro insegnanti con l'obiettivo di generare cultura e consapevolezza ambientale, conoscenza del territorio e delle sue arti preziose.
«Abbiamo deciso di essere capofila di questo progetto - spiega Vittorio Zacchera, presidente della Cooperativa Sociale Risorse - forti della vocazione ambientalista della nostra organizzazione e dell’attenzione che abbiamo sempre dato alle persone e al territorio. Sin dalla sua fondazione, la Cooperativa si occupa di cura dell’ambiente, attraverso la gestione del meno nobile dei prodotti: il rifiuto. Proprio nella nostra attività quotidiana, abbiamo preso ulteriore consapevolezza di come l’educazione e la conoscenza possano rendere il singolo individuo parte di un cambiamento virtuoso delle abitudini e conseguentemente attore di una sempre maggior cura all’ambiente che lo circonda. La stessa raccolta differenziata, se fatta correttamente e con coscienza, è un modo per il singolo cittadino di mettersi in gioco in prima persona».
L’attività della Cooperativa Risorse si inserisce al 100% nel concetto, sempre più attuale, di economia circolare. I suoi operatori, infatti, sono impegnati non solo nella raccolta, ma anche nella selezione dei rifiuti e nella categorizzazione di vetro, alluminio, plastica, legno, etc.
Oltre alla raccolta e alla selezione, la
e medie di Verbania
1674
Cooperativa si occupa della massima valorizzazione possibile del rifiuto avviandolo al processo di riciclo, sia in impianti propri, sia presso impianti terzi che diano garanzia di serietà.
Proprio la possibilità di attingere a moltissime risorse preziose dai rifiuti urbani prodotti da ogni cittadino, stiamo parlando di circa 500 kg in peso, pari a circa 2.500 litri in volume, per ogniabitanteognianno,èstataalcentro dei laboratori condotti da Risorse e destinati agli insegnanti coinvolti in “Connessi con l’ambiente”.

«L’economia circolare - conclude il presidente Zacchera - prima di essere un’affascinante sfida tecnologica, è un traguardo culturale. Fondamentale, in questo processo, è la conoscenza dei diversi materiali con cui veniamo a contatto quotidianamente e alle tre principali matrici originarie: organica, minerale e sintetica. Conoscere facilita la comprensione dei percorsi logici che i materiali devono seguire per ritrovare la strada del loro riutilizzo e aiuta, chi deve formare le nuove generazioni, ad acquisire consapevolezza e senso civico».
Tutte le attività previste da “Connessi con l’ambiente” sono state gratuite per i partecipanti e nessuna spesa è stata a carico delle famiglie. Tutti i professionisti che hanno animato corsi, uscite e laboratori sono del territorio del VCO.

Pgg. 34-35 Alternativa
Foto-RiservaFondotoce
Foto-RiservaFondotoce
IL WELFARE CULTURALE

Arte e Cultura per la salute delle persone e dei territori
ArteelaCulturasonoimportanti risorse di salute per la cura, la promozione della salute e la costruzione di equità e di qualità sociale. La Cultura è strettamente connessa allo sviluppo individualeecollettivo.

Da alcuni anni una rete di soggetti lavora nel quartiere Sassonia di Intra – caratterizzato da una importante presenza di alloggi di edilizia popolare - sviluppando il progetto “Teniamoci Vicini”: un esempio di intervento sociale orientato allo sviluppo di comunità che favorisce la compenetrazione tra il mondo dell’arte e della cultura con quello del sociale, finanziato da FondazioneComunitariaVCOeComunediVerbania. L’equipe di lavoro vi invita a una mattinata di formazione perché pensiamo di poter crescere collettivamente rispetto a questi temi, mettendo in comune esperienze e pratiche. Pensiamo che ispirarsi a un quadro teorico comune possa aiutarci a parlare lo stessolinguaggioeadagireconpiùconsapevolezzasul nostroterritorioprovinciale. Si intende coinvolgere i presenti alla mattinata formativa in un momento di attivazione, riflessione e scambio sul potere delle arti e della cultura sulla salute dellepersoneedellecomunità. La formazione è innanzitutto un’occasione di sviluppo e consolidamento delle competenze che si agiscono nella pratica e rappresenta un momento di raccordo tra elementi teorici e pratici, di riflessione attorno a temi e anche di rilettura di alcune pratiche. Il taglio della formazione è di tipo interattivo e circolare: verranno proposte attivazioni e lavori di gruppo e riflessioni condivise tra i presenti utili anche a far emergere e valorizzare esperienze o visioni già presenti e attive. Verranno poi introdotti alcuni concetti chiave del welfare culturale utili ad accrescere consapevolezza e intenzionalità attorno ad alcune pratiche e presentate alcunebuoneprassi.
Ilfineultimoècontribuireavalorizzareneipresenti la spinta verso la bellezza, l’armonia e la trasversalità con cui certe forme artistiche permettono a persone e contestidiesprimersi,rafforzarsiecrearesocialità.
IformatoridiMitaforme:Mitadesapswww.mitades.it
Silvia Baldini, pedagogista, psicomotricista e TNPEE, esperta in welfare culturale (Cultural Welfare Center) FrancescoPisa,pedagogista,formatore,docente.
L’
SilviaNegroni


Pgg. 36-37 Alternativa
“AIUTAMIAFAREDASOLO!”
Isola Verde si è sempre occupata, sin dalla sua fondazione negli anni ’80, di inserimento lavorativo di soggetti disagiatiefragili.PietroSpadacini,per tutti Piero, è uno dei soci fondatori, oggi presidente onorario, ed è stato il primo inserimento lavorativo di Isola Verde.
Piero ha 70 anni, ha concluso il lavoro in cooperativa, ma continua a mantenere un rapporto stretto con il gruppo che negli anni è diventata la sua famiglia.Tre giorni alla settimana si alza di buon’ora e a piedi raggiunge la fermatadelbuscheloportaaPallanza,dove prende quello che sale a Vignone per raggiungere la sede della cooperativa, oppure approfitta del passaggio dei suoiamicivolontari,RenatoBacchetta e Mauro Menzaghi, o del suo tutore Mauro Francioli, per trascorrere qualche ora nel “suo posto” con le “sue persone”.
LeorechePierotrascorreincooperativasonoilsuogancioconlavita,conla quotidianità e con l’autonomia.
«Prevedibilmente l’invecchiamento di Piero - spiega Mauro Francioli, anche socio fondatore della cooperativacomporterà la perdita progressiva delle autonomie e la necessità di interventi assistenziali più consistenti e specialistici. La prospettiva offerta dal progetto è quella di consentire a Piero di restare nella sua casa fino alla fine dei suoi giorni, garantendogli le migliori cure sanitarie a domicilio, evitando di dover ricorrere al ricovero in struttura».
Ed è proprio il futuro di Piero a essere stato il primo stimolo che ha mosso Isola Verde ad avviare il progetto “La casa di Piero”, un’iniziativa molto più affine alla mission di una cooperativa A, ma che corrisponde invece fortemente alle attitudini di questa organizzazione.
L’invecchiamento di Piero ha consentito a Isola Verde di trasformare il problema abitativo di una singola persona, in un’occasione per il territorio dicreareunmodellodihousingsociale del “Dopo di noi”.
«Riprendiamo con “La Casa di Piero” un aspetto che è nel nostro DNA – spiega Massimo Forni, Presidente di Isola Verde - il senso dell’accoglienza anche al di fuori del lavoro. Una vocazione che è con noi sin dalla nostra fondazione e che ci ha sempre messi al fianco delle nostre persone per aiutarle anche in situazioni di inclusione sociale, che parte dal lavoro ma si concretizza nella quotidianità del vivere. Riteniamo importante, in questo momento della nostra storia, accettare un’altra sfida, così come abbiamo fatto 40 anni fa, diventare interlocutori di una co-progettazione territoriale, in cui siano riconosciuti i ruoli di Enti pubblici e Terzo Settore, per la creazione di una nuova cultura e di una nuova idea di abitare sociale».
La legge 22.06.2016 n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, incoraggia infatti la pratica della donazione di immobili di proprietà a fronte del mantenimento della persona disabile all'interno della propria abitazione per l'intera durata della sua vita, escludendo il ricorso all’istituzionalizzazione.
“La Casa di Piero” ha preso avvio dalla cessione con atto notarile, mediante la stipula di un contratto di mantenimento autorizzato dal Tribunale di Verbania, dell’immobile di proprietà di Piero alla Cooperativa Sociale IsolaVerde.
“La Casa di Piero” diventerà una comunità alloggio per 5/8 utenti con disabilitàmedieolievidelterritorio,ai quali sia venuto a mancare il nucleo
familiare originario, e una palestra di autonomia per 2 utenti. Gli ospiti verranno indirizzati dal Consorzio dei Servizi Sociali delVerbano (CISS).
L’obiettivo della Casa è quello di evitare a queste persone l’inserimento in strutture socio-sanitarie non idonee che invaliderebbero i percorsi di integrazione scolastica, sociale e lavorativa conquistata negli anni. Il progetto offre, infatti, una soluzione abitativa assistita, ma con dimensioni familiari, in cui poter mantenere il più a lungo possibile le autonomie gestionaliacquisite(accreditamentosociale).
“La Casa di Piero” si inserisce in un contesto territoriale, quello del VerbanoCusioOssola,chesindaglianni‘80 è stato interessato da importanti investimenti pubblici per l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti con disabilità intellettiva. Come indicato dal Piano Programma 2019-2021del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano (CISS), uno dei progetti strategici è quello di stimolare la diffusione di esperienze a sostegno del “DopodiNoi”perlepersonecondisabilità, sulla base di dati territoriali che rilevano la crescente età media dei frequentanti il Centro Diurno Centroanch’io (41% degli ospiti con età superiore ai 45 anni). Per questa ragione, il CISS evidenzia una crescente richiesta di long term care in moduli di residenzialità il più simile possibile ai contesti familiari. Il piano programmatico del CISS, così come il progetto “La Casa di Piero” sono volti a soddisfare un bisogno manifestato dalle famiglie. Anche nel recente convegno “La casa che vorrei: soluzioniabitativeperilDURANTEE DOPO di NOI nel VCO”, promosso da ANFFAS VCO in collaborazione con la Cooperativa Isola Verde e il CentroServiziNO-VCO,sonoemerse
AProtagonisti e testimonianze
La Cooperativa Sociale Isola Verde ha attivato LA CASA di PIERO, un progetto di housing sociale socio assistenziale per persone con disabilità media e lieve
CristinaBarberisNegra
chiaramente queste necessità, già evidenziateduranteiseminarisulDopodi Noi organizzati nel 2019 dal CISS, nonché dai dati raccolti da ANFFAS VCO.
«I nostri ragazzi - hasottolineatoproprio la presidente dell’ANFFASVCO, Ottavia Camona che, durante il convegno, ha aperto lo sguardo sulle famiglie e sulla preoccupazione per i propri congiunti disabili - sono la prima generazione che vive a lungo e dobbiamo prendere consapevolezza e trovare soluzioni per il nostro e il loro invecchiare. Nelle piccole comunità i nostri ragazzi stanno bene, hanno stimoli maggiori anche rispetto a quelli che hanno in famiglia. Ci sentiamo come ANFFAS di sostenere un progetto come “La casa di Piero” per i futuri ospiti e per la comunità. È una realtà che risponde a un bisogno effettivo».
«Accompagnare Piero con la realizzazione di questo progetto - racconta MauroFrancioli- è proprio esaudire il sogno dei suoi genitori: permettergli di vivere nella sua casa fino all’ultimo giorno, nella migliore e maggiore autonomia possibile».

Ilprogetto“LaCasadiPiero”sipropone quindi di aumentare l’offerta di alloggi sociali per il “Dopo di Noi”, ponendo anche attenzione al risparmio energetico e all’abbattimento dei gas serra; attivando percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia delle persone accolte, integrandoli alla rete dei servizi esistenti.
Nello specifico intende:
-Ristrutturare un immobile privato per l’autonomia e l’inclusione sociale di persone con disabilità lievi e medie (Delibera Regionale 18/6836 del 2018).
-Costruire un modello sperimentale del “Dopo Di Noi” che coinvolga gli stakeholder (cooperative sociali A e B, associazioni, famiglie, enti pubblici e imprese) e gli ospiti della Casa, connettendosi al sistema territoriale di housing sociale.
-Sperimentare percorsi di accompagnamento socioeducativi e socioassistenziali sperimentali che superino le logiche dell’accreditamento e favoriscano una stretta connessione con il territorio e la comunità locale.
-Sensibilizzare e promuovere il “Dopo
Di Noi” tra le famiglie, gli stakeholder territoriali, incentivando la replicabilità del modello sperimentato.
-Costruire con gli stakeholder un sistematerritorialedel“DopodiNoi”.
«La “macchina” è partita. - conclude Massimo Forni - Attendiamo a breve
l’avvio del cantiere. Nel frattempo con Pieroabbiamopiantatoilprimoalbero. Come imprenditore sociale sono orgoglioso di riuscire a mettere in campo un progetto che è l’esaudirsi di un sogno».
Pgg. 38-39 Alternativa
Entro
febbraio 2023 la Cooperativa La Bitta prevede l’inaugurazione della ristrutturata
Casa Anziani della Valle Antrona. E le persone saranno sempre più al centro di questa nuova ri-partenza.
ome raccontare il cambiamento? Come trovare le parole per parlare della fatica e di un’attesa lunga due anni tra pandemia e un cantiere aperto? Come dare voce all’amore e alla rabbia, alla passione per il proprio lavoro e alle difficoltà? Come narrare le emozioni di chi conclude la propria vita in un luogo altro che deve imparare a chiamare casa?
«Pensare all’inaugurazione della rinnovata Casa Anziani della Valle Antrona – spiega Simonetta Valterio, direttrice della Casa - è stata un’occasione per farci tante domande, per riguardare tra le pieghe della quotidianità operativa e per provare a trasformarle in un’occasione per valorizzare chi, all’interno della nostra organizzazione, ogni giorno da senso a una mission che non è solo parole ma vita vissuta».
Così la direzione ha pensato di intrecciare queste vite e queste storie con il futuro della Casa stessa, donando a ciascuno l’immortalità che solo l’arte sa donare.
Oss, personale infermieristico e amministrativo e alcuni ospiti sono diventati infatti i protagonisti di un progetto di arte relazionale condotto a tre mani daAntonioSpanedda,artista relazionale, diplomato in scultura e dottorato di ricerca in Arte Sacra all’Accademia di Belle Arti Brera di Milano; Lorenzo Camocardi, fotografo, videomaker e regista; Cristina
Barberis Negra, giornalista e facilitatrice di narrazioni autobiografiche, terapeutiche e di comunità. Che cos’è un progetto di arte relazionale?
«L’essenza risiede nell’invenzione e costruzione di relazioni frasoggettispiega l’artista Antonio Spaneddasi comincia con la proposta di abitare un mondo in comune; il mio lavoro insieme ai diversi protagonisti diventa una trama di rapporti che genera altri rapporti, e così via, all’infinito: da chi agisce, a chi crea, a chi fruisce del risultato dell’opera stessa. Io oggi penso a questo progetto di relazioni come una struttura collettiva che nasce dal voler far partecipare tutti all’opera, contribuendo a determinarne il senso. Il risultato sarà manifestato attraverso la creazione di una visione comune che dà forma a una crescita collettiva, attraverso una nuova consapevolezza».
I protagonisti hanno così partecipato a laboratori di narrazione, shooting fotografici, video interviste che insieme hanno costruito “la materia” da cui prenderà forma un’opera d’arte permanente che verrà svelata ai partecipanti, in forma privata, il prossimo dicembre e al pubblico il prossimo febbraio, in occasione dell’inaugurazione ufficiale.
«Ho accolto con interesse e curiosità la proposta di Cristina Barberis Negra - spiega Simonetta Valterio -
quando insieme, qualche mese fa abbiamo cominciato a parlare dell’inaugurazione della Casa e del nostro desiderio di valorizzare le nostre persone che tanto avevano collaborato, e sopportato, durante questi due anni complessi. Trovare nuove narrazioni per raccontare il nostro mondo e chi tutti i giorni si adopera per portare avanti impegno e valori, ci sembrava un bel modo per celebrare insieme questo traguardo. Adesso siamo curiosi di vedere il risultato.
Di certo la giornata di laboratorio è stata un’occasione per riguardarci tutti, comprendere il nostro valore di squadra e l’impegno che mettiamo o vogliamo mettere in ciò che facciamo. L’apprezzamento degli ospiti poi ci ha davvero reso felici, è come se gli avessimo regalato un piccolo sogno».
UfficioStampadelConsorzioLink ANotizie e cronache C
IO, NOI, UNA COMUNITÀ



Pgg. 40-41 Alternativa
FotoBackstage set fotografico
TORNANO I“LAMPI”A SPAZIO SANT’ANNA
Dopo alcuni anni la celebre rassegna sarà nuovamente sul palco di via Belgio a Verbania. Una collaborazione tra Consorzio Link e Associazione Lampi sul Teatro
Sonoiniziateil26novembre,eproseguiranno sino al 6 gennaio, le prevendite della rassegna teatrale “Lampi sul Loggione”, una stagione raffinata e d’autore, vera e propria tradizioneperlacittàdiVerbania. «Poterla ospitare nuovamente a Spazio Sant’Anna, dove è nata ed è andata in scena per molti anni -sottolineaDavide Lo Duca, direttore del Consorzio Link chegestisceloSpazio- èunveropiacere e onore. L’iniziativa si muove nella direzione che abbiamo intrapreso e che vuole orientare sempre più la proposta culturale dello spazio verso la qualità e la creatività. Spazio Sant’Anna alla sua

identitàdicasadiquartiereedipuntodi incontro del mondo cooperativo, con uno sguardo attento alla crescita e al tutoraggio di comunità, vuole, infatti, integrareanchequelladifucinaedipromotoredicultura».
La collaborazione tra il Consorzio Link e l’Associazione Lampi sul Teatro, che da 36 anni, sotto la direzione artistica di PaoloCrivellaro,curalarassegna,èuno deipassiinquestadirezioneeconsentirà di riportare a conoscere e a frequentare lo Spazio Sant’Anna un pubblico attento, esigente e interessato alla cultura teatrale e non solo.Asostegno della stagione, l’Amministrazione Comunale di
VerbaniaelaFondazioneCariplo. Cinque gli spettacoli in calendario per il 2023.
Venerdì 13 gennaio, La Felicità di Emma:liberamenteispiratoalromanzo di Claudia Schreiber, con Rita Pelusio, una tra le voci più originali dell’arte comica contemporanea che, attraverso questa storia, affronta con coraggio il tema del fine vita, continuando il suo impegno per un teatro civile che non abbiatimorediconfrontarsicongliargomenti più delicati. La regia è di Enrico MessinaelaproduzionediPemHabitat Teatrali,PiazzatoBianco.
Sabato 25 febbraio, Mammamia!: di e
UfficioStampadelConsorzioLink ANotizie e cronache
Foto EMMA@gianni-giacovelli-11
conMariaCassi,prodottodallaCompagniaMariaCassiCircoloTeatrodelSale Firenze. In questa performance l’attrice mette una lente sul suo/nostro mondo e celomostraconunacarrellataesilarante dipersonaggiecarattericheevidenziano le millenarie differenze tra ragazze e ragazzi,uomoedonna,parlandodicibo e di amore tra Firenze, Parigi e New York.
Sabato 11 marzo, Dentro - Una storia vera,sevolete:drammaturgiaeregiadi Giuliana Musso, in scena con Maria Ariis, coproduzione La Corte Ospitale e Operaestate Festival Veneto. Lo spettacolo indaga il tabù dell'abuso
intrafamiliare e ci spinge a interrogarci sulvaloredellaverità,esploratoconstrumenti affini al giornalismo d’inchiesta e poi traslato in una drammaturgia limpida,coinvolgenteesempreconsapevole. Sabato22aprile,Sullamortesenzaesagerare: di e con Giovanni Longhin, AndreaPanigatti,SandroPivotti,Matteo Vitanza; ideazione Riccardo Pippa; produzioneTeatrodeiGordi,TeatroFranco ParentiMilano.Unospettacolopertutti, dai10anniinsu.Inscenamascherecontemporanee di cartapesta ispirate a Otto Dix, figure familiari che raccontano con ironia, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii. Un
omaggio alla poetessa polacca, premio Nobel,WislavaSzymborska.
Venerdì 12 maggio Il condominio: di e con Cinzia Spanò, produzione Teatro Dell'Elfo. In un condominio di Milano, sin dal mattino i vicini di casa si scambianomessaggiperassicurarsichenulla turbi la pace della piccola comunità. La vita condominiale diventa metafora della condizione umana e delle dinamichecheregolanoirapportitralepersone.
Per informazioni e prenotazioni www. lampisulteatro.com

42-43
Pgg.
Sulla morte senza esagerare
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE
onleelezionidellanuovaPresidentedelConsiglio,Giorgia Meloni,primadonnainItalia aricoprirequestotitolo,sièscatenato il dibattito: è più corretto utilizzare il maschileoilfemminileperlecariche istituzionaliricopertedadonne?
Come risulta dalla comunicazione delsuoufficiostampa,laneopremier ha richiesto che venga utilizzato il maschile nei documenti ufficiali e quindihadecisodifarsichiamare“il presidente”, nonostante sia una donna,comeleistessaavevasottolineato con decisione in un comizio (“Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre,sonocristiana”).
Questo fatto ha suscitato numerose reazioni; il Corriere della Sera ci riportaquelladiCeciliaRobustelli,linguista dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che afferma “è
un’assurdità. Certe regole di grammatica non si possono scegliere"; la docente ha aggiunto che nessuno penserebbedidefinireDaciaMaraini “scrittore” o Federica Pellegrini “campione”. "Perché - continua la Robustelli-fareeccezioneperinomi cheindicanounacaricaistituzionale?
Tanto più che Nilde Iotti si ricorda come senatrice e Angela Merkel comecancelliera”.
ForseGiorgiaMelonihapaurachela carica declinata al femminile le conferiscamenoautorità.
Sonotanted'altraparteledottoresseo leavvocatessechesifannochiamare “dottore” o “avvocato” e può essere chelapensinoallastessamaniera;c'è dadirechequesteoscillazionitraformamaschileefemminileperledonne si riscontrano soltanto per professioni che fino a non molto tempo fa

erano svolte unicamente da uomini (ad esempio, al contrario, le maestre non si fanno chiamare “maestro”). Malagrammaticaènormaenondovrebbe ammettere libere interpretazioni.NonacasoClaudioMarazzini, presidentedell’AccademiadellaCrusca, conferma sulle pagine del Corriere che “i titoli al femminile sono legittimisempre”.
Leparolechenoiutilizziamoraccontano al mondo chi siamo, ma possono anche essere pericolose e alimentarelediscriminazioni.Risolvendola questione linguistica delle professioni esercitate da donne e rendendo la lingua italiana meno sessista, non si supereràdeltuttolasocietàpatriarcale, che ancora persiste, ma è un ottimopassoversolaparità.
A
dalla scuola
OleksandraKoval
C
Fonte:“parole-MyBlog”
ABiTo veste Dry Tech
Velocità Antisismicità Efficienza Energetica
Costie tempi certi Sostenibilità ambientale Nessun limite compositivo
INostri Servizi
NUOVE COSTRUZIONI SU MISURA
RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI
EDIFICI MODULARI

Via Cesare Battisti, 31 13876 Sandigliano (BI) Tel. 015 099 16 42 info@abito.casa www.abito.casa



Pgg. 44-45 Alternativa
TERRA DONNA
Simona Pedroli
erra donna” è nata nel 2008 per volontà di un’associazione torinese, “Almaterra”, che ha voluto far nascere, anche nel nostro territorio, un'associazione chesioccupassedicontrastoallaviolenzasulledonne,accoglienza ed integrazione, in particolare, delle donne migranti. Nelcorsodegliannil'associazionehacollaboratocondiverse istituzioni private che si occupano di temi affini, come ad esempio Giù le mani, lo Sportello Donna, Arcigay Nuovi Colorisolopercitarnealcuni.
Adifferenza di organizzazioni più istituzionali, fra i membri dell'associazione non sono presenti professionalità specifiche ma, semplicemente, persone che hanno deciso di dedicareilpropriotempoeleproprierisorsealprossimo.Le iniziative messe in atto sono pertanto rivolte prettamente all'ambito della sensibilizzazione alla violenza di genere, al contrasto della discriminazione, all'integrazione culturale e sociale.
Nel tempo sono stati attivati diversi corsi di lingua italiana che fossero da supporto, in modo particolare, alle donne migranti affinché potessero inserirsi facilmente nel tessuto sociale italiano. Molta attenzione è stata posta al sostegno di iniziative di contrasto alla violenza di genere, attraverso la diffusionedeinumeridipubblicautilità,conoscenzadeiservizi, creazione di rete tra associazioni e istituzioni, attivazione di uno sportello di ascolto e supporto, che permettesseallevittimediesseremesseincontattoconiservizi antiviolenza presenti sul territorio, o di essere aiutate e supportate nella creazione di una rete sociale, cosa che spesso vieneamancareincasidiviolenza.
L'obiettivo dell'associazione pertanto non è mai stato quello
disostituirsiaiprofessionistiappositamenteformati,bensìdi esserne un supporto in attività più marginali ma altrettanto importanti per le vittime. Oltre ai corsi di italiano, fra le iniziative più pregnanti, possiamo ricordare quelle del microcredito, finanziamenti di piccola entità che venivano assegnatiadonnevittimediviolenza,individuatedallosportello antiviolenza, affinché le stesse avessero le risorse minimenecessarieperusciredallalorosituazioneericominciare una nuova vita. Molte sono state invece le iniziative di sensibilizzazione, fra queste ad esempio l'inaugurazione di alcune panchine rosse, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, e con il richiamo e la diffusione del numero 1522, numero nazionalecontro laviolenzadigenere. Da qualche anno abbiamo in essere una collaborazione con Radio Esseeffe grazie alla quale, nella rubrica "storie di donne", affrontiamo temi femminili attraverso letture, interviste, approfondimenti.
Giunta ormai all'ottava edizione è invece la nostra rassegna cinematografica"Ciaksiparla":ognianno,attraversolaproiezione di film, combinati con interventi di esperti, si proponeunariflessionesuitemicariall'associazione.Discriminazione, violenza, collaborazione, forza e caparbietà, sonoalcunidei filsrouges chehannocollegatoifilmdell’ini-

Aspazio donna
“T
ziativa. La rassegna del 2022 ha voluto affrontare il tema della violenza psicologica, considerandone le varie sfaccettature, a partire da quella all'interno della coppia, famiglia, gruppofinoadarrivareaquelladellemasse. Ilprimofilmpropostoquest’annoèstato“Mipiacelavorare - mobbing” (2003) di Francesca Comencini, con Nicoletta Braschi, con il quale abbiamo affrontato il tema del mobbing, approfondito dalla Dott.ssaAssunta La Iacona. Quindi con“Howmuch…”(2018)ildocufilmdiAntonioGuadalupi abbiamo affrontato il tema della tratta delle donne; Simonetta Valterio, per conto della Cooperativa La Bitta è intervenuta per analizzarne il contenuto. A seguire i film L’onda (2008) di Dennis Gansel, Angoscia (1944) di George Cukor e Foxfire – ragazze cattive (2013) di Laurent Cantet con cui abbiamo rispettivamente trattato l’influenza psicologica nel gruppo, il fenomeno del gaslightingelapressioneesercitatadallesettesugliadepti,iltuttoapprofonditograziealcontributodellaDott.ssa BarbaraAlbanese. Infine, tema pregnante per l’associazione,laviolenzapsicologicaall’internodellacoppia,con ilfilm“Primoamore”(2004)diMatteoGarrone.Leproiezioni sono state affiancate dall’approfondimento dagli operatoridi“Giù lemani”.
Al 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo invece dedicato il concertospettacolo CANTARDONNA in collaborazione con la Cooperativa La Bitta, titolare del servizio antiviolenza “Giù le mani”: il gruppo di canto popolareArSunàCanta dell’associazione passAmontagne ha intrattenuto gli spettatori cantando le battaglie che donne di tutto il mondohannocombattutocontroogniformadiviolenza. Portare avanti l'associazione presenta numerose problematiche, sia per le difficoltà, comuni a tutto il mondo del volontariato, quali trovare persone disposte ad impegnarsi senzaunritorno,anteponendoil“noi”all’”io”,siaperilrapportoconleistituzioni,definibilea“macchiadileopardo”:a fronte di persone disponibili all’ascolto, adeguatamente formate, si incontrano altre che, vuoi per preconcetti, vuoi per caratteristiche personali, sono refrattarie ai temi di nostro interesse; la diffidenza o, al contrario, l'attenzione verso i nostri temi può fare la differenza: capita così che, ad esempio, comuni piccoli riescano a mettere in campo più energie dicentridimaggioredimensione,cheassociazionidivolontariato riescano ad essere più efficienti di quelle di professionisti, che funzioni preposte al ruolo rispondano in maniera del tutto diversa a seconda della loro sensibilità al tema.
Probabilmente è anche questa una caratteristica dei nostri tempi ma, nonostante ciò, non smettiamo di provarci: ogni annoincontriamonuovepersoneenuovigruppicheciaiutano a portare avanti i nostri ideali e a realizzare progetti che, unpassodopol'altro, portino un po' disperanza.

Pgg. 46-47 Alternativa
LA SCUOLA FLOREANINI DI DOMODOSSOLA - 34 ANNI SUONATI
Salvatore Seminara
Il panorama musicale del VCO è costituito da numerose realtà didattiche che offrono svariate opportunità ai più giovani di avvicinarsi al meraviglioso mondo delle sette note. In questo contesto spicca tra tutte la Scuola Media “Gisella Floreanini” di Domodossola che nella sua offerta formativa vanta uno degli indirizzi musicali più longevi e accreditatialivellonazionale.In34annidiattivitàmusicale la Floreanini (già Giovanni XXIII) ha saputo, attraverso l'infaticabile progettualità dei suoi docenti e la lungimiranza dei dirigenti che vi si sono susseguiti, creare una struttura strategicamente articolata che ha offerto a migliaiadigiovanil'opportunitàdivivereun'esperienzamusicale pratica e completa. Sono tanti coloro che ne portano ora le improntenelpropriobagaglioculturale.Alcunihannocontinuato a tenere accesa la passione per la musica proseguendo l'attività in gruppi e bande, altri hanno passato il testimone ai loro figli, altri ancora hanno fatto della musica la propria ragione di vita divenendo riconosciuti professionisti. Ma non meno importante è stata l'esperienza per coloro che se ne sono (apparentemente) distaccati, perché quando ci si immerge nella musica se ne esce con qualcosa in più. La musica è un sistema di comunicazione complesso e multisensoriale che porta a sviluppare abilità su più fronti: dal pensiero all'azione pratica, dall'immaginazione alla motricità più minuziosa, la musica è una disciplina che unisce rigore e libertà rivelandosi di grande impatto sul piano educativo.
Ilfaremusicaascuola,conglistrumentioconlavoce,con particolare riferimento all'attività orchestrale e corale, porta gli allievi a sviluppare competenze affettive e relazionali per maturare sicurezza interiore; suonare e cantare in gruppo li pone nella condizione di mettersi in ascolto dell'altro e di coglierne le intenzioni e le emozioni imparando a conoscere e gestire le proprie.
In questi (e in molti altri) benefici la scuola Floreanini ha da sempre creduto investendo energie e risorse al fine di creareemodellareneltempoquellastrutturaorganizzativa che oggi costituisce non solo un fiore all'occhiello per il sistema scolastico provinciale, ma un vero e proprio modellodiriferimentoalivellonazionale.Pertaleragione, già nel lontano 1999, l'orchestra della scuola è stata invitata ad esibirsi a Roma presso la sede del Ministero dell'Istruzione su invito del comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica presieduto dall'On. Luigi Berlinguer. Non si contano i primi premi assoluti conseguiti in concorsi nazionali e le performance tra cui spicca, ancora nella capitale, quella in presenza di Papa Francesco nel 2019, in occasione dei festeggiamenti del
trentennale dell'indirizzo musicale, in una gremita Piazza San Pietro.
Ma qual è il segreto di questo successo? Quale ricetta magica? In realtà non ve ne sono. La scuola ha semplicemente riconosciuto il valore della musica e ne ha armonizzato la sua pratica strumentale in modo strutturato e strategico all'interno dell'orario scolastico, alla pari delle altre materie. Le lezioni di strumento, che si svolgono in piccolissimi gruppi di studenti, trovano poi nell'attività orchestrale la loro ragion d'essere perché è proprio nell'orchestra che avviene quell'incontro speciale in cui ciascuno contribuisce nel proprio piccolo al raggiungimento di un comune obiettivo. L'orchestra nasce dalla fusione di più classi e questa grande classe allargata è il luogo di condivisione di qualcosa di molto concreto ed effimero allo stesso tempo che, all'insegna della bellezza, lascerà il segno nelle giovani vite dei ragazzi.
Alla Floreanini le ore settimanali dedicate allo strumento (unità di 50 minuti) sono quattro (tra strumento, orchestra o coro) e si inseriscono nell’orario scolastico alternandosi alle altre materie in rapporto paritetico alle stesse, sia al mattino che al pomeriggio. A queste si aggiungono le due tradizionali unità di educazione musicale pari a tutte le scuole. Nella classe prima si affianca all'insegnamento dello strumento l'attività corale e in seconda e terza (ma anche sul finire del primo anno), cioè al raggiungimento delle competenze necessarie, ha inizio quella orchestrale. Il nutrito team di professori musicisti è costituito da due docenti di flauto traverso, due di clarinetto, due di violino, due di chitarra, due di pianoforte, uno di saxofono, uno di percussioni, uno di coro e uno di potenziamento, oltre ai docenti di educazione musicale.
Il format didattico è dinamico: durante le ore di strumento i ragazzi si distaccano dalle classi per recarsi nelle diverse aule di strumento (appositamente attrezzate di strumentazione musicale e recentemente insonorizzate nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio scolastico), una modalità innovativa in una scuola che si misura tutti i giorni col cambiamento dei tempi.
La scuola offre agli alunni il prestito d’uso completamente gratuito per la maggior parte degli strumenti. Questa opportunità è resa possibile anche grazie alla presenza in sede dell’Associazione Culturale “Insieme in Musica” che da 24 anni contribuisce organizzativamente e finanziariamente alle attività musicali della scuola. L'Associazione, costituitadagenitoridialunnieinsegnantidistrumento,ha acquistato nel tempo una parte cospicua della strumentazione scolastica.
Amusica
Sono attivi accordi di rete con le scuole primarie del territorio e con le scuole secondarie ad indirizzo (Liceo musicale) per promuovere la musica e lo studio dello strumento in tutte le fasce d’età. In tale ambito la suddetta Associazione organizza a scuola corsi strumentali riservati aibambinidelleclassiquarteequintedellescuoleprimarie cittadine. Il progetto denominato “Parto in Quarta”, che si svolge presso gli stessi spazi ad uso dei ragazzi della scuola media, ha quindi la finalità di introdurre con due anni di anticipo i bambini alla pratica strumentale. L'iscrizione all'indirizzo musicale è subordinata a una prova attitudinale che i ragazzi sono chiamati a svolgere in inverno: un momento costruttivo e non selettivo di incontro e conoscenza con i nuovi iscritti, al fine di coglierne inclinazioni e bisogni educativi in una più ampia logica inclusiva. All'inizio della classe prima, i ragazzi avranno
poi modo di provare a rotazione tutti gli strumenti in un percorso propedeutico che li porterà a fare una scelta ragionata con gli insegnanti e la famiglia, sulla base delle loro predisposizioni e aspettative.
In questa modalità operativa anche i soggetti più fragili hanno trovato accoglienza e un percorso personalizzato all'interno del progetto musicale; emerge qui l’esperienza fondamentale dell’orchestra, cuore e momento di massima inclusione e condivisione pratica e umana.
Al mio 21° anno di docenza di chitarra alla Floreanini posso affermare con una certa consapevolezza che un ambiente musicale così stimolante, specie in una fase cruciale della crescita, favorisce uno sviluppo armonico dei ragazzi fornendo loro un'occasione per diventare adulti un po' più sensibili e preparati alla complessità di una società sempre più esigente.

Pgg. 48-49 Alternativa
Concerto di primavera 2022, Domodossola, piazza del Comune – Foto di Andrea Pavan
È STATA LA MANO DI DIO
Alessandro Magrì
In Italia si producono film quasi ai livelli degli anni ’60, più del doppio degli anni scorsi, ed erano già troppi. Qui ne è arrivata la maggior parte e vi assicuro che abbiamo visto una quantità di cose orribili.” Comincia con questo commentolapidariodiAlbertoBarbera,direttoredelFestival di Venezia, un articolo-inchiesta sullo stato del cinema in Italia post-Covid, pubblicato su Repubblica alla fine di ottobre.
Il quadro tracciato dall’articolo è al contempo tragico e surreale.Gliincassidellesalealivellonazionalesonocrollati durante il Covid (come nel resto d’Europa) ma non si sono più ripresi (a differenza del resto d’Europa), eppure il numero di pellicole prodotte annualmente è in crescita costante: mentre se ne producevano 141 nel 2010, lo scorso anno sono state ben 481.
Come è possibile? Secondo Repubblica la risposta sta “nel sistemadiincentivipubblici,fondiecreditid’imposta,che nel nostro Paese consentono all’opera di ripagarsi prima ancora di uscire. Questo fa sì che sul cinema italiano a rischiare del suo sia rimasto soltanto lo Stato, mentre per il produttoreifilmèsufficientegirarli.L’esitodelbotteghino è del tutto irrilevante, come dimostrano i vari titoli che hanno incassato pochino e di cui pure sono stati subito messi in cantiere i sequel”.
L’articolo ha un approccio decisamente tranchant al tema, che non è piaciuto ad alcuni produttori e distributori, ma è un fatto che di quei 481 film (un’enormità), solo 153 sono stati distribuiti in sala.
FabrizioAccatino conclude il pezzo con il colpo di grazia: “La pioggia di denaro pubblico, che incentiva la produzione di film che in larga parte nessuno vedrà mai, non contribuisce nemmeno alla qualità del prodotto. Innanzi tutto, perché – per andare sul sicuro con i finanziamenti –i produttori scelgono come interpreti i soliti noti, e questo lascia al palo la nuova generazione di attori emergenti. […]Traicriteririchiestidaibandicisonopoiitemisociali e civili, che gli sceneggiatori finiscono per infilare dappertutto”.
Per risollevarci da questo quadro desolante, ma volendo restaresulcinemaitaliano,noncirestacheandaresulsicuro e segnalare di un Grande Film, uno dei pochissimi tra quei 481 prodotti nel 2021: È stata la mano di Dio, ultima opera di Paolo Sorrentino, presentato a Venezia lo scorso anno, dove ha vinto il Leone d’Argento, distribuito per un brevissimo periodo nelle sale per poi arrivare su Netflix (qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo sulle cause del crollo degli incassi in sala).
Il riferimento calcistico del titolo (che richiama il gol di mano di Diego Armando Maradona ai mondiali di calcio del 1986) è solo un pretesto per inquadrare con un’immagine di grande forza evocativa tanto un punto di svoltadel film (e nella vita dell’autore) quanto l’essenza di una città. È infatti proprio questo, È Stata la Mano di Dio: una reinvenzione autobiografica di quando Sorrentino perse i genitori a 16 anni, e quindi un film sui legami, sulla famiglia,sull'identitàesull'elaborazionedelluttoealcontempo un ritratto partecipato e lontano dallo stereotipo dello spirito di Napoli.
Molti lo hanno visto come il film più intimo, magico ed essenziale di Sorrentino. Un racconto maturo e commovente che si lascia alle spalle manierismi eccessivi e riesce avalorizzareuncastumanamentevincente.Elofaconuna continuatensionetracommediaetragedia,conrisatesguaiate che si alternano a momenti di grande intensità, a volte mischiandosi in maniera dissacrante.
Come dice il Mereghetti, il film è adatto “per chi ama Sorrentinoeperchinontanto,mavuoleriappacificarsiconlui”.
SCHEDADELFILM:
Regia: Paolo Sorrentino
Sceneggiatura: Paolo Sorrentino
Fotografia: Daria D’Antonio
Montaggio: Cristiano Travaglioli
Scenografia: Carmine Guarino
Interpreti principali: Filippo Scotti (Fabietto Schisa), Toni Servillo (Saverio Schisa), Teresa Saponangelo (Maria)
Produzione: TheApartment, Fremantle
Distribuzione italiana: Netflix, Lucky Red
Durata: 130'
Origine: Italia
Data di uscita italiana (Cinema): 24/11/2021
Data di uscita in streaming (Netflix): 15/12/2021
A il film

SENEGAL
sentiero (lo vogliamo chiamare sentiero? Si cammina tra erba alta, rocce sdrucciolevoli e senza l'aiuto dei ragazzi sarebbe praticamente impossibile vederlo) si arrampica sul lato della montagna e, per un attimo, ci si scorda di essere in Senegal, se non fosse che a ricordarcelo è il caldo e l'umidità appiccicosa che ci circonda.Ad ogni scivolata la domanda fa capolino: ma ne valeva la pena arrivare qua nella regione del Kedougou, a due passi dalla Guinea, a rischiare le caviglie solo per visitare il villaggio bassari di Iwol? La rispostaarrivadicolpo,appenasuperatalachina,davanti alle stupende capanne cilindriche immerse nel silenzio della selva africana, dove questa antica popolazione vive in un'economia di sussistenza, tra agricoltura, allevamentoedartigianato.
Tutti i villaggi animisti senegalesi hanno un albero sacro, di solito un fromager dal tronco immenso e dalle radici gigantesche che come lame enormi si diramano tutto attorno, disegnando ampi spazi per feticci e per la spiritualità profonda degli abitanti: ad Iwol è un baobab, senzalegrandiradici,maaipiedidelsuomaestosofusto, quest'aspettoperdecompletamentedisignificato.

Veniamo accolti dai pochi abitanti del villaggio che non sono al lavoro: un vecchio che, come capita spesso qua, ha un'età indefinita, scavato dalle rughe e dalla magrezza e alcune donne che ci avvicinano, incuriosite, mentre noi ci perdiamo nella bellezza di questo villaggio capace di riportarciall'essenzialitàdell'esistere.
Lenostreimprovvisateguidesonoduefratelli,figlidiuna signora che, dopo un passaggio in autostop, ci ha voluto invitare nella sua capanna ai piedi della montagna e al loro semplice pasto: è in occasioni come queste che le differenze storico-culturali si annullano e ci si sente davveropartediunasolagrandefamiglia,quellaumana. Il nostro viaggio è iniziato solo da qualche giorno è già abbiamo cominciato a comprendere la bellezza di questo paese, la gentilezza delle persone che lo abitano, a cogliere il concetto di “teranga”, quel misto di accoglienza, condivisione, empatia, attenzione che è un trattopeculiaredeisenegalesi.
Pochi giorni prima scivolavamo sulle acque del delta del Sine-Saloum, immersi nel silenzio del reticolo infinito delle mangrovie che ci circondavano, rotto solo dai racconti dei due “piroguero” (la pirogue è la barca piatta e lunga tipica di questi luoghi) che ci hanno permesso di capire molte cose del Senegal, delle difficoltà che, in Africa, sono sempre presenti, perché, come disse Senghor, “inAfrica nera non esistono frontiere, neppure tralavitaelamorte”;ecosìlamentevaga,tralacrudezza della vita quotidiana e la maestosità di una cattedrale
A il viaggio
AlviTorrielli
Senegal:albero“fromager”-FotodiAlviTorrielli
naturale, un isolotto verde dove, al calare della sera, una moltitudine di uccelli ritorna per la notte, riempiendo quegli immensi spazi vuoti del loro vociare, regalando colori e suoni, sotto un cielo che ha smesso di essere giorno senza esser ancora oscurità. Il ritorno verso Toubakouta è pura sospensione,immersiinunimbruniresilente,tralalucedella lunaediuncielononancorabuio,conlapuntadelleditache sfioranol'acquaesoloilsuonodellosciabordiodellapirogue comecolonnasonora.
La natura è la vera padrona di queste terre: più arida al nord, avvicinandosi alla Mauritania, ricca nella zona montana e addirittura lussureggiante a Casamanche, la regione del sud, dove un ambiente tropicale, tra palme e risaie, fiumi e mare, accoglieilviaggiatoreregalandogliangolimeravigliosi.
Qui è possibile immergersi totalmente nella natura, visitare isole e villaggi, respirare l'atmosfera coloniale di Ziguinchor e,volendo,prendersiunapausasullespiaggediCapSkirring difronteall'oceano.Nonsiamocertotipidaspiaggiamadopo tutti quei chilometri su strade piene di buchi, con rallentatori stradali(verimuridaaffrontaredafermi),ilbrulichiodiadulti edeimoltissimibambini,ilcaosdimotorini,animali,carretti e quant'altro nei centri urbani, una mezza giornata a lanciarsi nellegrandiondediventapiacevolissima.
Il Senegal è un paese a prevalenza islamico ma totalmente tollerante: basti dire che sia a Ziguinchor che sull'isola di conchiglie di Joal-Fadiout ci sono cimiteri misti per cattolici e islamici! Solo nella parte nord è percepibile una maggior attenzioneaiprecettiislamici:lamaggioranzadelledonneha il capo coperto e il numero delle moschee è notevolmente maggiore ma, anche in questa zona, la tolleranza religiosa è assolutamentepercepibile.

Proprionelnordciinfiliamoinunalungapistasterrata,inun ambientebucolicotragreggidicapreemuccheperterminare in una zona allagata che ci costringe a ritornare sui nostri
passi; sembra una banalità far riferimento alle greggi visto che le mucche e, soprattutto, le caprette sono onnipresenti in Senegal ma la cosa curiosa è che, nelle altre zone, queste giranolibereesoloallaseraritornanoneiloroovili. Un capitolo a parte merita l'isola di Goree, di fronte a Dakar: sarebbe bello poter dire che è la bellezza dei suoi vicoli, la puliziachelacontraddistingueolacalmaplacidachelarende totalmente avulsa dal caos della capitale, ma la verità è che ciòcherestadavverodiquestopostoèlavisitaallaCasadegli schiavi, che per oltre trecento anni, fino al 1848, è stato il punto di partenza verso le Americhe di milioni di africani; l'animaècolpitanontantodallestanzetteangustedove,come bestiame, venivano ammassati o da quelle ancor più piccole perirecalcitranti,nondallecatene,collariecavigliereesposte aricordo,madaunaporta,unospaziovuotoversoilmare,il luogo da cui venivano imbarcati, la porta del non ritorno: sembra quasi di sentire l'urlo silenzioso delle speranze perdute,degliaddiiaduncontinente,adunavita...
C'èquestoemoltoaltroinquestaterra:imeravigliosispazidi Palmarin, dove l'infinito sembra essersi perso, le grandi moscheeolechieserisuonantideicantiafricani,lafantastica cucina, con grande varietà di sapori, le spesse conchiglie usate per erigere case o l'adobe, impasto di fango sabbia e paglia, che si sta riscoprendo per costruire abitazioni naturalmente fresche nei caldi giorni d'estate, i sorrisi dei tantissimibimbieilrispettoperglispazidichièstraniero,le imbarcazioni di pescatori al rientro e i mercati del pesce improvvisati sulle spiagge, il Lago Rosa che, purtroppo, è di quel colore in un altro momento dell'anno e che sembra invitarci a ritornare. Forse, però, quello che più di altro resta è il senso di comunità che si contrappone al nostro individualismo,lospiritodell'Africade“Lasaggezzaècome unbaobab;nessunsingoloindividuopuòabbracciarla”…
Pgg. 52-53 Alternativa
Senegal-FotodiAlviTorrielli
PICNIC AD HANGING ROCK
Nota preliminare dell’autrice:
“Se Picnic ad Hanging Rock sia realtà o fantasia, i lettori dovranno deciderlo per conto proprio. Poiché quel fatidico picnic ebbe luogo nell’anno 1900 e tutti i personaggi che compaiono nel libro sono morti da molto tempo, la cosa pare non abbia importanza”.
Australia, Contea di Macedon Ranges, anno 1900. Le prime pagine del libro raccontano l’inizio di una giornata che sembra nata sotto i migliori auspici, il giorno di San Valentino del 1900, una splendida mattina d’estate che risveglia le creature della macchia australiana, e non solo quelle, inondandole di sole.
Le studentesse ospiti del prestigioso Appleyard College (tutte meno la piccola Sara Waybourne, in punizione per il suo scarso rendimento), contagiate dall’euforia di una natura così bella, si preparano per l’evento dell’anno: il picnic di San Valentino che si farà alle pendici della maestosa Hanging Rock, una formazione di roccia preistorica che si erge nel mezzo del fitto bush australiano. Per l’occasione indossano i loro abiti e accessori più belli …Un incipit che,ritraendoilfrusciaredimussoleepizzi,di guanti e cappelli, insieme agli scambi di biglietti augurali e romantici in onore del Santo, le chiacchiere, i commenti e i pettegolezzi, raffigura i simboli di una giovane e inquieta popolazione femminile della borghesia di Melbourne.
Felici di lasciare anche soltanto per un giorno il lugubre college e la sua perfida direttrice, la signora Appleyard, le ragazze si avviano, insieme a due insegnanti, verso la carrozza che le condurrà alla meta.
Ed ecco che, dopo un viaggio attraverso la soffocante pianura dell’estate australe, “ …la Hanging Rock era apparsa spaventosa all’improvviso. Immediatamente davanti a loro, la grigia massa vulcanica tutta lastre e pinnacoli come una fortezza sorgeva dalla deserta pianura gialla. Le tre ragazze a cassetta riuscivano a scorgere le linee verticali delle pareti rocciose, squarciate qua e là da ombrature azzurrine, chiazze di cornioli grigioverdi, massi affioranti immensi, formidabili perfino da questa distanza”. Un’immagine così potente non può che esercitare un’irresistibileattrazioneinquelletreragazzecheperprime l’hanno vista, Miranda, Marion e Irma, le “elette” dal destino per sondare le viscere e i segreti di quella stessa roccia.
Saranno loro, seguite dalla piccola e ottusa Edith, dopo il picnic, ad allontanarsi dal gruppo, per esplorare Hanging Rock.
Il terzo capitolo è il cuore del romanzo e ne preannuncia il dramma …
La descrizione della lenta ascesa di quattro ragazze vestite di bianco, il silenzio, il sole cocente, un’atmosfera dove realtà, spazio e tempo perdono significato, hanno un impatto fortissimo su chi legge ed evocano tristi presagi.
LauraLuisi
Lassù più nulla le trattiene, non la paura dell’ignoto, né le convenzioni,nonlafatica,néirichiamiangosciatidiEdith. Le tre “elette” avanzano verso la sommità in un’atmosfera sospesa,attrattedaunafataleconnessioneconquellastrana natura e con il mistero che la pervade, fino a sparire nella feritoia di un monolite.
L’oscuro mistero di quelle millenarie formazioni vulcaniche rimane nascosto all’interno di fenditure del terreno e nei passaggi molto stretti che sembrano condurre ad una dimensione “altra”. Soltanto Miranda, che guida la spedizione, personalità gentile, empatica e quasi profetica, sembra consapevole che la sua vita è a una svolta.
E intanto Edith, confusa, lacera e terrorizzata, tornerà indietro per dare l’allarme, spettatrice inutile e incapace di raccontare ciò che è successo alle sue compagne e all’insegnantedimatematica,GretaMcCraw,avventuratasi alla loro ricerca.
Il seguito del romanzo racconta il frenetico susseguirsi di ricercheeindaginichecondurranno,grazieall’interventodi Mike e Albert, personaggi non secondari nello svolgersi degli eventi, al ritrovamento della sola Irma. Anche Irma, incredibilmente viva nonostante la lunga permanenza sulla Hanging Rock, e vittima di amnesia, non potrà testimoniare.
Ricercheedomandesenzarispostasicollocanoattornoalla sparizione di Miranda, Miriam e dell’insegnante, come fosse un buco nero nel tessuto della realtà.
Unbuconerodiventatocausadiunacatenadiavvenimenti, scelteedesclusionichesideterminanolungoilpercorsodel romanzo.
Nel ricordo, nei sogni e nell’immaginario di coloro che le hanno conosciute, ammirate, accudite, e che forse avrebbero voluto specchiarsi in loro, le ragazze scomparse continuano ad essere presenti come una ricchezza.
Al contrario, per chi le ha considerate semplici allieve del Appleyard College, non lasceranno tracce, se non presagi infausti che porteranno alla rovina delle loro stesse vite.
Le conseguenze coinvolgeranno le giovani compagne delle scomparse, il personale del collegio, la direttrice, travolta dallo scandalo, e la stessa struttura del college. Un impatto drammatico che distruggerà quella piccola comunità, regolata da troppe leggi e da relazioni ambigue mascherate dal perbenismo vittoriano.
L’autrice ha voluto enfatizzare il mistero e dilatare le curiosità del lettore oltre lo sviluppo dei fatti, per consentirgli una interpretazione personale.
Se alla domanda: “che cosa è successo lassù?”, la risposta più ovvia, e cioè che le vittime si trovano in un punto irraggiungibile di quella cattedrale di lava vecchia milioni dianni,nonsoddisfaillettore,colpitoinvecedall’atmosfera inquietantecheattraversatuttoilromanzo,altreprospettive gli si possono offrire.
Una roccia non è soltanto un’enorme escrescenza della
Ainvito alla lettura
superficie terrestre, con rientranze e rilievi simili a volti umani, attraversati da nuvole rosse, ma forse è anche un punto dello spazio dove si perdono le tracce, luogo che collega terra e cielo, naturale e soprannaturale; Hanging Rock è il cuore del Bush, della macchia australiana, uno spazio immenso, sconfinato, selvaggio e sconosciuto, con quelleconnotazionidiinviolabilitàcheappartengonoanche aUluru(AyersRock),ilgigantesacrodeinativiaustraliani. E forse è anche un luogo senza tempo o, meglio, in cui il tempo non ha importanza, nel giorno di san Valentino, in un’ora imprecisata, perché gli orologi si sono fermati. Al libro di Joan Lindsay, pubblicato nel 1967, si ispirò il film omonimo (1975) - ora visibile su Prime Video - diretto da Peter Weir, regista australiano. La grande visibilità internazionale che ottenne, mostrò la bravura del regista, divenutosuccessivamentefamosoperaltrifilmdisuccesso, come “L’attimo Fuggente” (1989).
IL LIB RO
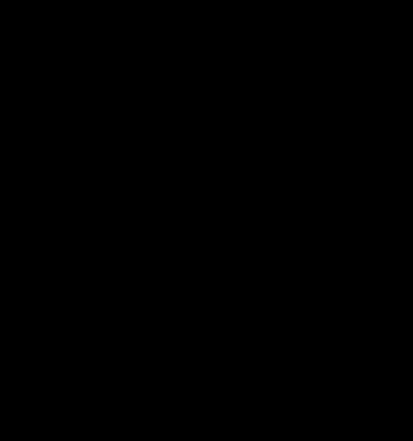
LIB RO
Autrice: Joan Lindsay
Titolo: Picnic a Hanging Rock
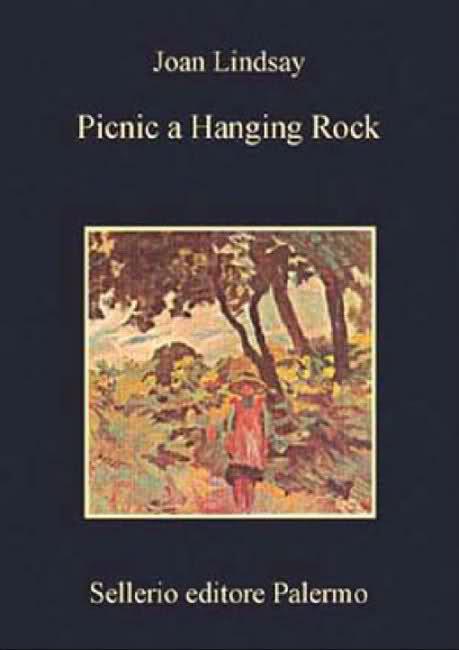
Editore: Sellerio editore Palermo
Anno edizione: 2008
Traduzione: Maria Vittoria Malvano
Pagine: 281
Il libro fu pubblicato - in seguito ad un accordo “strategico” tra l’editore e l’autrice - privo dell’ultimo capitolo, il n. 18. Capitolo finale che la Lindsay consentì di divulgare soltanto dopo la sua morte, avvenuta nel 1984. Così, nel 1987 fu stampato, soltanto in Australia e in Gran Bretagna, un libretto intitolato “The secret of Hanging Rock”. Si tratta di un piccolo volume, mai tradotto e pubblicato inItalia, di 58 pagine diviso in tre parti, una della quali, di appena 12 pagine, contiene il capitolo diciotto.
A proposito del quale riporto la recensione di un lettore: “…il testo presenta il finale pensato dall'autrice non pubblicato. Difficile dire se sia un finale convincente. forse l'ambiguità della storia narrata nel libro e nel film era più intrigante. non mi sento di rivelare di più a chi volesse leggerlo”.
Pgg. 54-55 Alternativa
P.S.
GLI APPUN TI DI PADRE MCKE NZIE
“Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear”
(Padre McKenzie scrive le parole di un sermone che nessuno ascolterà)
“Eleanor Rugby”, Lennon-McCartney, 1966
ORFANI DEL PASSATO, RECLUSI NEL PRESENTE
L’assenza di passato congela il presente e cancella il futuro. È concepibile un’esistenza ingabbiata in un claustrofobico hic et nunc?
RobertoNegroni
Quasi trent’anni fa, Eric Hobsbawn, uno dei maggiori storici del XX secolo, scriveva in apertura della sua opera più celebre: “La distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. La maggior parte dei giovani allafinedelsecoloècresciutainunasorta di presente permanente, nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui vivono” (1) Due segnali d’allarme: il rapido assottigliarsi finoadissolversidiqueifilideltempoche nelle società danno continuità alle esperienze di vita delle diverse generazioni e l’inconsueta condizione di una moltitudine di giovani privati del passato storico del loro tempo. Due segnali che oggi hanno perso quel carattere che allora avevano di prodromi e descrivono una realtà ormai diffusa e sempre più consolidata: un tempo, un mondo senza storia (2). Scrive infatti Adriano Prosperi: “Viviamo da tempo immersi in una ideologia dominante che assegna alla storia uno spazio vicino allo zero nella formazione dei giovani e nella vita sociale. Le cause fondamentali risiedono in una affermazione di valori e obbiettivi sociali dettati dalla svolta neoliberista e da un dominante populismo chestasvuotandolademocraziadellasua sostanza (…). Si tende all’obbiettivo della formazione di persone capaci di entrare presto nel mondo del lavoro e di eseguirvi compiti tecnici e ripetitivi che non richiedono cultura generale né buone
letture” (3) .
È innegabile la responsabilità del sistema scolastico, che ha penalizzato ed emarginato l’insegnamento della storia dando un decisivo apporto all’allontanamento dal passato, a un suo progressivo oblio. È però evidente che il discorso non può finire qui: attribuire alla sola scuola una simile responsabilità sarebbe una semplificazione fuorviante. Certo la scuola una responsabilità ce l’ha, ma è una responsabilità derivata o secondaria, cioè assunta per ossequio al mainstream ideologico. Un orientamento dominante indirizzato soprattutto a una declinazionedelsaperecome“saperfare”, in cui la formazione, in una sola parola, “umanistica” (quella tesa alla ricerca dell’araba fenice del “saper essere”), è spesso un accessorio secondario, in particolare per l’insegnamento della storia. “Lo scarso peso che registra la disciplina negli anni della frequenza scolastica non fa fatica a tradursi poi, nel momento in cui si esce dal circuito formativo,indisinteresseperlastoria tout court associato alle ben note lacune cognitive” (4) .
In questo scorcio di tempo tra i due secoli siamo anche partecipi (o travolti?) dei grandi cambiamenti indotti dalla rivoluzione digitale, da un progresso tecnologico e scientifico in accelerata evoluzione e da un sovvertimento culturale che “ha allontanato vertiginosamente il presente dal recente
(1) E completava: “Questo fenomeno fa sì che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è ricordare ciò che gli altri dimenticano, siano ancor più essenziali alla fine del secondo millennio, di quanto mai lo siano state nei secoli passati”. Eric J. Hobsbawn, Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1997, pp. 14-15.
(2) Adriano Prosperi, Un tempo senza storia. La distruzione del passato, Einaudi,Torino, 2021; Francesco Germinario, Un mondo senza storia? La falsa utopia della società della poststoria,Asterios,Trieste, 2017.
(3) Prosperi, cit., p. 21.
(4) Germinario, cit., p. 22.
passato” (5). Abitudini quotidiane e stili di vita sono frontalmente investiti da innovazioni portatrici di profondi mutamenti, e le giovani generazioni sono le componenti sociali più radicalmente coinvolte. La distanza da un passato anche prossimo appare tale da non avere precedenti. Ma la possibilità di avere rapidamente accesso nello sterminato web, con strumentisemprepiù friendly,adunaquantitàinfinita di informazioni e di conoscenze è uno dei maggiori potenziali offerto dallo sviluppo tecnologico, un potenziale di facile accesso per la gran parte della società.
Uno dei fenomeni in evidenza in questo ambito è la consistenza che ha assunto il circuito domandaofferta di conoscenza storica, un fenomeno probabilmente indicativo di un bisogno da parte di molti di compensare ciò che non è più acquisito per altravia;indicatoreforsediunacuriositàmaanchedi unbisognopiùprofondodireagireeporreunqualche rimedio all’affermazione di un presentismo avvertito come depauperante. Web, reti radiofoniche e televisiveabbondanodiunavarietàdivideo,podcast, programmiecontributiassortitiinmateriadistoria,in parte pure di buona qualità; alcuni esperti divulgatori sono diventati famosi personaggi degli spazi mediatici. Si tratta certamente di un lodevole impegno, anche se non disgiunto da logiche commerciali, utile a mettere una pezza alla conclamatacarenzadiconoscenzastoricadellanostra società, una pezza che rimane inevitabilmente cosa diversa da ciò che si può acquisire in normali corsi di studio,adattaafornireciòcheèmegliodiniente,cioè pillole, prime sommarie infarinature, ma che corrono peròancheilrischiodiseminare,neipiùsprovveduti, proprio per i limiti insiti nei mezzi impiegati, competenze illusorie.
C’è però qualcosa che non torna tra questo crescente oblio del passato e quanto si è detto in questa stessa rubrica qualche tempo fa (6), a proposito della retrotopia, cioè della propensione diffusa nelle odiernesocietàaguardarepiùchealfuturo,percepito come imperscrutabile incerto e infido, al passato, ovvero a tempi considerati fidati e rassicuranti perché già vissuti e, soprattutto, mondati da tutto ciò che potrebbe smentirne l’oleografica immagine. Ricorrendo, cioè, al consueto processo di ricostruzione-reinvenzione proprio della nostra memoria, che seleziona, sfronda e ripulisce i nostri ricordi, acconciandoli al presente che viviamo (7). Ma di quale passato si vaneggia se il passato non lo si
(5) Prosperi, cit., p. 13.
(6) Alternativa, n. 2 anno 2022, pp.50-54.
conosce? Se la storia, anche quella recente del XX secolo, dell’ultimo cinquantennio non la si studia? La risposta è intuibile, i due fenomeni sono interconnessi: è proprio l’inconsistenza della conoscenza che induce a bearsi di ipotetici passati, approssimativamente e lacunosamente abbozzati nella mente come erronee memorie. Un processo che taglia,esclude,omette,semplificaebanalizzapezzidi storia, spesso imbellettandoli e riducendoli a simulacri,adistorsioniprive,oltrechedituttociòche non si conosce, di quello che si è consapevolmente o meno dimenticato o cancellato, avviando tanti sprovveduti e spensierati cappuccetti rossi a spasso nel bosco ignari del lupo che vi scorrazza. “Secondo i dati del sondaggio 2020 Eurispes Italia, oggi il 15,6 per cento della popolazione italiana crede che la Shoah non sia mai esistita. Nel 2004, era il 2,7 per cento. Che cosa è accaduto e che cosa non ha funzionato nella trasmissione delle conoscenze?” (8) “Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla” sta scritto in trenta diverse lingue a Dachau. Spesso questa inclinazione per il passato assume la veste nobile della tradizione, perché ritenuta l’assolvimento del dovere etico di conservare e trasmettere (tradere), al fine di perpetuare, particolari conoscenze,memorie,riti,ricorrenzeoquant’altrosia reputato patrimonio fondativo o storicamente rilevante di una comunità. “Ciò che è distintivo della tradizione è che essa definisce una specie di verità. Per chi segue una pratica tradizionale, le domande non hanno risposte alternative: per quanto possa cambiare, una tradizione fornisce sempre un quadro per l’azione che ben di rado viene messo in discussione (…) la tradizione rappresenta il concetto basilare del conservatorismo, dal momento che i conservatori credono che essa contenga una saggezza accumulata nel tempo” (9).Anche in questo caso, però, come nel caso poco sopra ricordato a propositodellamemoria,c’èunasecondafacciadella moneta. “L’idea di tradizione (…) è una creazione della modernità, (…) si potrebbe dire che tutte le tradizioni sono inventate, (…) tradizioni e costumi sono sempre stati inventati per una molteplicità di ragioni, (…) sono imposti più di quanto siano cresciuti spontaneamente, sono usati come strumenti
(7) Un aneddoto che raccontava (non ricordo dove) Umberto Eco, ben illumina questo fenomeno. L’ambiente è uno sfavillante salotto di un palazzo parigino negli anni della Restaurazione: un crocchio di giovani nobili attornia un’attempata contessa che tiene banco con ricordi della sua vita. “Ah, che fantastico anno fu il ’93!”, esclama estasiata ad un certo punto nella foga del racconto la nobildonna. “Ma come… signora contessa! - azzarda sgomento uno dei giovani ascoltatori – il ’93, il 1793?! ... l’anno del Terrore! del Comitato di Salute Pubblica! Robespierre! la ghigliottina!!!”. Nell’improvviso silenzio degli astanti, “Ah sì, …già - mormora svagata la contessa – ma sa, caro amico…, io allora avevo vent’anni!”.
(8) Prosperi, cit., p. 12.
(9)
mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 58.
Pgg. 56-57 Alternativa
Anthony Giddens, Il
GLI APPUN TI DI PADRE MCKE NZIE
di potere” (10). “Molto di quanto noi consideriamo tradizionale e radicato nella notte dei tempi è in realtà un prodotto al massimo dell’ultimo paio di secoli, e spesso ancor più recente” (11) . Se i grandi mutamenti epocali e un passatismo ammalato sono all’opera nel ridimensionare l’importanza del passato nella società odierna, tristemente coadiuvati dalla scuola, altri media, altre agenzie competono o, meglio, competevano per contrastare questo orientamento. Spiegava Adriano Prosperi in un’intervista a Micromega in occasione dell’uscita del suo libro: “Nella società italiana c’era una grossa presenza di partiti di massa divisi dalle ideologie ma concordi nell’orientamento generale del governo del paese e c’erano le strutture organizzative create dal movimento operaio. Poi tutto questo è scomparso. E insieme ai diritti dei lavoratori, e ai lavoratori stessi come categoria, è scomparsa la memoria come dimensione collettivadellavitasociale.Alsuopostosi è installato qualcosa di completamente diverso, l’idea dell’identità italiana”.E anche: “il sindacato, il partito politico, la fabbrica, il laboratorio artigianale, quando esistono e resistono ancora, non sonopiùluoghidisociabilitàedirelazioni di scambio, dove si ha la formazione di culture e la trasmissione di saperi e di memorie” (12). La presenza di forme di aggregazione civile, largamente presenti nella società italiana nella seconda metà del secolo scorso, fiancheggiava l’opera delle agenzie istituzionali con un prezioso surplus di valore aggiunto: la capacità di connettere la piccola storia, quella dei singoli, delle famiglie e dei gruppi, alla grande storia. L’affievolirsi di queste presenze rappresenta una perdita non meno importante del disimpegno del sistema scolastico.
Esisteva anche un'altra via lungo la quale correva la conoscenza del passato, il racconto ai giovani da parte delle vecchie generazioni di vicende familiari e dello sfondo storico che le ammantava: un trapasso di piccola storia che costituiva però il collante tra le esperienze di vita dei nuclei parentali e i contesti in cui si sviluppavano. Le memorie custodite in ambienti familiari, amicali, di lavoro
narrate e tramandate dotavano di elementari strutture di conoscenza e consapevolezza storica figli e nipoti, memorie che la scuola si sarebbe poi incaricata di contestualizzare entro i grandi processi storici. Anche in questo caso,canalidicomunicazionecheigrandi mutamenti epocali, cui si è fatto sopra cenno, hanno in larga misura prosciugato con il distanziamento tra le generazioni e l’indebolimento del ruolo delle più anziane avvenuto nella società contemporanea.
La separazione da quel complesso processo che è la sua storia arreca una lesione alla stessa natura umana. Cosa rimane senza un passato, senza il bagaglio di ricordi e di memorie che ciascuno porta con sé e che lo rende ciò che è? È concepibile un’esistenza ingabbiata in un claustrofobico hic et nunc? In un irrisolvibilepresente,inunattimochenon fugge mai, in un carpe diem piatto e tedioso? La dinamica tra un prima e un dopo è connaturata all’esperienza di vita umana, conoscere il prima e le nostre connessioni con quel prima, il nostro prima, è un fondamento della personalità, è la sostanza di cui si compone la cognizione di sé, quel bagaglio di consapevolezze che consente di vivere il presente in una cosciente dimensione dinamica che permette di guardare anche in avanti, di pensare, di ipotizzare, di progettare il transito verso il futuro. L’assenza di passato congela il presente e cancella il futuro. È il legame con il passato, con la Storia, che contraddistingue il nostro essere umani.
(12) Prosperi, cit., p. 17. (10) Ibidem, p. 56. (11) Ibidem, p. 54.

Pgg. 58-59 Alternativa