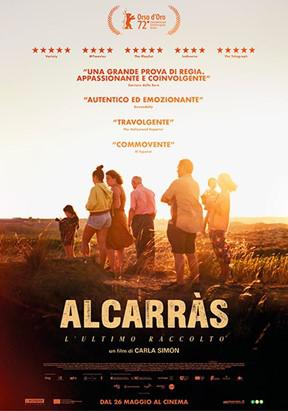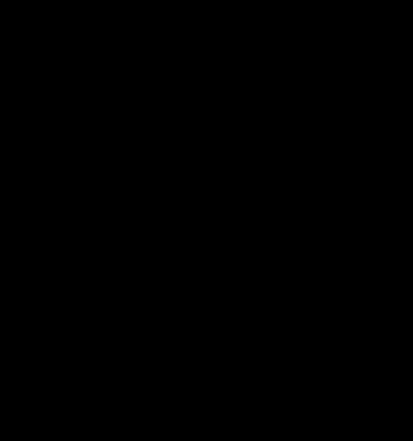n.3
In questo numero:
I giovani nel VCO Il disagio giovanile e la crisi dei valori Per una scuola del merito o della cura?
Bambini e tecnologie digitali tra opportunità e rischi Il disagio psichico dei bambini e degli adolescenti dopo la pandemia
Come i giovani progettano per non essere progettati Noi fragili, noi immortali
PERIODICO DI CULTURA E IMPEGNO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAA... Spedizione in abb. postale GR.IV Pubbl. Inf. 70%






Direttore Responsabile:
Clemente Mazzetta
Redazione:
Samantha Brandini (segreteria e coordinamento)
Diego Brignoli
Maurizio Colombo
Laura Luisi
Roberto Negroni
Emanuele Puccio
Carlo Rocchietti
Simonetta Valterio
Maria Pia Zocchi
Grafica:
Dario Martinelli
Impaginazione: a cura della redazione
Distribuzione: a cura della redazione
Stampa: Press Grafica Srl
Rivista n. 3 Anno 2023
Periodico di cultura e impegno sociale dell’Associazione Alternativa A ONLUS
Domodossola Via dell’Artigianato 13
SOStienici con una donazione
IBAN IT21X0200845360000103728938
Cristina Barberis Negra, giornalista e facilitatrice di narrazioni terapeutiche e di comunità
Francesca Bologna, manager di rete della Comunità Educante VCO
Nives Cerutti, docente scuola primaria, psicologa, psicoterapeuta
Maura Cottini, volontaria Associazione Karma
Catia Fornara, psicologa, psicoterapeuta a orientamento analitico, libera professionista
Alessandro Magrì, associazione Cineforum Domodossola
Arturo Palmeri, vicepresidente di 21 Marzo APS
Lorenzo Pavesi, scrittore e insegnante
Giannino Piana, teologo, già docente di Etica cristiana e di Etica e economia nelle università di Urbino e Torino
Paola Sau, Neuropsicomotricista dell’età evolutiva
Chiara Rinaldi, educatrice presso la Cooperativa La Bitta
Elisabetta Sfondrini, coordinatrice del Centro per la Famiglia della Cooperativa La Bitta
Serena Melica, educatrice presso la Cooperativa La Bitta
Alvi Torrielli, redattore di“Alternativa”in gap year e viaggiatore
Paola Veggiotti, psicologa presso l’Ass. Centri del VCO
Matilde Zanni, progettista sociale di 21 Marzo APS e i redattori: Samantha Brandini, Diego Brignoli, Maurizio Colombo, Laura Luisi, Roberto Negroni, Carlo Rocchietti, Maria Pia
Hanno collaborato a questo numero SOMMARIO Nota redazionale I ragazzi stanno male…? La redazione Pgg. 4-5 Ambienti territori scenari contesti I giovaninelVCO M. Colombo 6-7 Riflessioni analisi commenti FORUM - Il disagio giovanile nel VCO M. Colombo e R. Negroni 10-11 Il disagio giovanile e la crisi dei valori G. Piana 14-15 Per una scuola del merito o della cura? M.P. Zocchi 16-17 Contributi Bambinietecnologiedigitali traopportunitàerischi P. Sau 18-19 Il disagio psichico dei bambini e degli adolescenti dopo la pandemia C. Fornara e P.Veggiotti 22-23 Cosa avviene in casa d’altri prendere esempio da... Chi c’è allo sportello? D. Brignoli 28-29 Progetti Come i giovani progettano per non essere progettati A. Palmeri e M. Zanni 30-31 Bambini e adolescenti al centro E. Sfondrini 32-33 Protagonisti e testimonianze Dare una mano ai ragazzi perchè trovino “un proprio posto” C. Rocchietti 34-35 Karma M. Cottini 38-39 La vita che non mi aspettavo C. Barberis Negra 40-41 Nuove rotte e nuove narrazioni di migrazione C. Barberis Negra 41-43 ESOM, una storica presenza verbanese rinnovata C. Rinaldi e S. Melica 44-45 Notizie e cronache Noi fragili, noi immortali C. Barberis Negra 46-47 Comunità educante F. Bologna 48-49 Nell’officina di Nel silenzio e nel vento L. Pavesi 50-51 Le rubriche di A Scuola primaria: tra scuola e famiglia N. Cerutti 52-53 Breve viaggio nel femminismo… L. Luisi 54-55 Asbestas eAlcarràs A. Magrì 58-59 Pedalate tedesche A.Torrielli 60-61 Come d’aria L. Luisi 62-63 Gli appunti di Padre McKenzie Giovaniefuturo:aspettativeeincubi R. Negroni 64-65
Zocchi
BIKE PARK - NOLEGGIO MTB - TREKKING

PARCO AVVENTURA - PARCO GIOCHI - GONFIABILI
BEACH VOLLEY - EVENTI - BAR E RISTORANTI

I RAGAZZI STANNO MALE…?

Iragazzi stanno male lo dicono i giornali, i media, le ricerche e, anche il mondo della scuola, osservatorio privilegiato del mondo giovanile,riportaunmalesserediffuso. Pare verosimile che i due anni di Covid-19 abbiano acuito un disagio già presente e importante. Ma come se la passano davvero i giovani nel nostro territorio? E soprattutto, come adulti, cosa dimostriamo di fare per loro e con loro?
Da questa riflessione è sbocciato un numero insolito, potremmo dire monografico, quasi interamente dedicato al tema del disagio giovanile (14 articoli su 22); forse per la vastità e la complessità dell'argomento, per la preoccupazione di non tralasciare troppi aspetti le parole hanno preso il
sopravvento ed ecco a voi il risultato. In queste pagine cerchiamo di fornire una fotografia della situazione della Provincia per conoscere il territorio e l’ambiente nel quale operiamo. Partendo dai dati, con una lettura dal punto di vista demografico, scolastico e lavorativo, la redazione ha scelto di dedicare ampio spazio al Forum sul disagio giovanile e di dare la parola a chi con i giovani lavora quotidianamente. Questo sembra essere un tempo assai duro per i ragazzi e le ragazze che cercano di crescere e di trovare la loro strada in una società che fa perdere speranza nel futuro. Grandi, infatti, sono le responsabilità di una società che, oltre alle molteplici ragioni di inquietudine che
riversa sull’insieme della popolazione, riserva alle giovani generazioni un abbondante supplemento. Il malessere dei ragazzi è di certo una sfida aperta al Paese, ma che cosa cambia quando si permette loro di essere protagonisti? Quando ai ragazzi si dà spazio veramente, e non solo a parole, accadono cambiamenti incredibili perché nati da una realtà osservata con i loro occhi, ne sono un esempio il Kantiere di Possaccio e l’Associazione Karma di Domodossola.
Occorre credere che le cose si possano cambiare e comprendere la forza della collettività, solo in questo modo fioriranno progetti e politiche al passo con i tempi.
La pubblicazione del trimestrale Alternativa dal 2022 avviene in digitale, l'idea è stata di renderla più eco-sostenibile riducendo i costi di stampa e di spedizione.
Laproduzionedellarivistaèpertantoquasiacostozero,maper“AlternativaA…”,l’associazioneOnluscheneèl’editore, poter contare sul sostegno dei lettori rappresenta un aiuto a continuare ad operare come luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto in una logica di collaborazione, scambio e legame con il territorio. Vi chiediamo allora di sostenerci con la vostra donazione, versando, con bonifico bancario, un contributo all’Associazione Alternativa A… ONLUS
IBAN: IT21X0200845360000103728938 con la causale “donazione per la rivista”. Grazie!
Anota redazionale
La redazione
Immagine di kjpargeter su Freepik


I GIOVANI NEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Demografia, scolarità e lavoro della popolazione giovanile 15-24 anni
 Maurizio Colombo
Maurizio Colombo
Questo numero della rivista, come avrete già potuto vedere dal sommario, ha un filo conduttore tematico: i giovani e in particolare il “disagio” giovanile. Ecco allora il perché di questo articolo. Vogliamo presentare in modo sintetico la popolazione giovanile del Verbano Cusio Ossola dal punto di vista demografico, scolastico e lavorativo. Una questione che si è subito posta è stata quella relativa a quale fascia di età rivolgere l’attenzione. Si è giovani da quando? Da 15 anni, da 18 anni? Fino a quando si è giovani? Fino a 24 anni, fino a 29 anni, fino a 35 anni? Le opinioni sono molteplici e tutte
hanno un fondo di validità. Abbiamo fatto la scelta, senza ritenere che sia l’unica giusta, di porre la nostra attenzione sui giovani da 15 a 24 anni, ritenendo che questa fascia di età, interessata dalla scuola e spesso dall’entrata o, meglio, dall’auspicata entrata, nel mondo del lavoro, sia un periodo di transizione essenziale per la vita futura.
Demografia
Innanzitutto,comegiàvistoinprecedentiarticolidella rivista, ilVerbano Cusio Ossola si caratterizza per una popolazione sempre più anziana.
A ambienti territori scenari contesti Alternativa
Nel 2021 l’indice di vecchiaia, rappresentato dal rapporto fra la popolazione oltre i 65 anni e quella di età inferiore a 14 anni, era nel nostro territorio del 253,5%, vi erano, cioè, 253 over 65 ogni 100 under 14, mentre a livello regionale era del 214,8% e nazionale del 182,6%.
Proviamo ora a verificare quanto pesa la fascia di età 15-24annisultotaledellapopolazione.Nel2022èdel 8,96%, quindi meno di 1 ogni 10 abitanti, a livello nazionaleèdel9,80%eregionaledel9,17%.Vediamo adesso quanti sono i giovani di questa età in valore assoluto. Nel 2022 sono 13.827 di cui 7.240 maschi e 6.587femmine;perunmaggiordettaglio,cheutilizzeremo poi per una riflessione sulla scolarità, 6.756 hanno fra i 15 e i 19 anni e 7.071 fra i 20 e i 24 anni. Un dato curioso: di questi 116 sono già coniugati e 6 già divorziati.
Dei 13.827 giovani di questa età, 5.709 vivono nei tre centri urbani maggiori del territorio,Verbania, DomodossolaeOmegna,eirestanti8.118neglialtricomuni di minori dimensioni, a sottolineare anche in questo caso una urbanizzazione diffusa.
Scolarità
Dopo questi dati demografici sintetici ma che già dannounaprimafotografiadellapopolazionegiovanile 15-24 anni nel Verbano Cusio Ossola, proviamo ad analizzare qualche dato relativo alla scolarità. I giovani di questa fascia di età sono interessati da due cicli formativi: la scuola secondaria di II grado (15-19 anni) e l’università (20-24 anni). Come abbiamo visto la popolazione 15-19 anni nel 2022 è di 6.756 unità, 373 stranieri, di cui 1.359 di 15 anni, 1.342 di 16, 1.384 di 17, 1.393 di 18 e 1.278 di 19.
I dati disponibili a livello provinciale sugli iscritti alla scuola secondaria di II grado indicano in 7.178 la popolazione studentesca nell’anno 2022/2023, di cui 3.173neilicei,2.703negliistitutitecnicie1.302negli istituti professionali. Non è possibile fare confronti diretti fra popolazione 15-19 e iscritti alla scuola per i flussi in entrata e uscita dai territori limitrofi e per l’impossibilità di recuperare i dati aggregati per provincia di residenza.
Una ricerca di Openpolis rileva a livello regionale un tassodiabbandonoscolasticodell’11%neigiovanida 19 a 24 anni (12,7% a livello nazionale). Utilizzando questo tasso a livello provinciale, dove non è stato possibile recuperare il dato puntuale, si può stimare che siano circa 900 i giovani di età 19-24 anni che hanno conseguito solo la licenza media. Un dato più aggiornato e interessante che abbiamo recuperato è quello relativo ai candidati alla maturità nel 2023, 1.304. Da una precedente ricerca svolta da Openpolisnel2020lapercentualedineodiplomatidel Verbano Cusio Ossola immatricolati all’università era del 43,9% contro il 52,9% in Piemonte e, per un confronto con territori limitrofi, il 57,9% a Novara e il 53,8%aVarese.E’evidentechequestotassodiimmatricolazione sconta anche la necessità per la quasi
totalità dei neodiplomati del territorio di iscriversi ad università fuori provincia con trasporti e sistemazioni logistiche spesso non facili se non proibitive. Per rimanere in campo universitario dai dati Ustat. Miur gli immatricolati nel 2022/23 delVerbano Cusio Ossola erano 619, di cui 374 femmine e 245 maschi. Applicando la percentuale di immatricolazione di Openpolis si può stimare che nel 2023/24 dovrebbero immatricolarsi circa 570 giovani.
UnultimodatointeressantesempredaUstat.Miur:gli iscritti del nostro territorio a tutte le università nel 2021/22, ultimo dato disponibile, erano 3.201. Il dato per classe di età è disponibile solo a livello nazionale; applicando la percentuale rilevata a livello nazionale si può stimare che i giovani 20-24 anni del Verbano Cusio Ossola iscritti all’università possano essere circa 1.800.
Lavoro
Poniamo ora attenzione al mondo del lavoro, alla presenza dei giovani 15-24 anni nel mondo del lavoro. I dati Istat 2022 sulle forze di lavoro ci danno a questo propositoindicazioniimportanti.Iltassodiattività1524anni,datodaigiovanioccupatie/oincercadioccupazione sul totale dei giovani, nel 2022 è pari al 31,1%,inparticolareal35,0%perimaschieal26,8% per le femmine. E’ questo un valore superiore sia al dato nazionale, 26,0%, che regionale, 28,1%, a indicareprobabilmenteunauscitapiùprecocedaipercorsi scolastici. Dal dato percentuale possiamo stimare in circa 4.300 i giovani 15-24 anni occupati e/o in cerca di occupazione, di cui 2.500 maschi e 1.800 femmine. Passando ad esaminare il tasso di occupazione si rileva un numero di occupati 15-24 anni di circa 3.600 unità, pari al 26,2% del totale, di cui 1.950 maschi (27,2%) e 1.650 femmine (25,1%). Anche per questo indicatore, e in misura maggiore, si rileva un valore significativamente superiore rispetto al dato nazionale (19,8%) e regionale (22,3%).
Da ultimo, relativamente alle forze di lavoro si rileva un tasso di disoccupazione nel Verbano Cusio Ossola del15,8%inferioresiaaquellonazionale(23,7%)che regionale(20,6%),determinatoperòdaunandamento fortemente differenziato nella componente maschile, dove è del 22,2%, e nella componente femminile, dove è decisamente contenuto, del 6,4%. Da questi dati si ricava un totale di circa 560 maschi e 120 femmine in cerca di occupazione fra i giovani 15-24 anni. Per qualificare maggiormente le modalità occupazionalideigiovanibisognerebbeavereildatoprovinciale relativoaicontrattiatempodeterminato,unindicatore importante relativo alla precarietà lavorativa, dato che purtroppo non è disponibile. Il dato nazionale 2022 disponibile per gli occupati dipendenti dà a questo proposito indicazioni assolutamente rilevanti; il 59,5% degli occupati dipendenti 15-24 anni ha un contratto a tempo determinato. Una simile proporzione a livello provinciale darebbe una cifra di circa 2.100 occupati a tempo determinato su un totale di
A ambienti territori scenari contesti
3.600 unità, un dato che consideriamo realistico, forse al ribasso, considerata la presenza rilevante di alcuni settori dove il contratto a tempo determinato ha una forte prevalenza, quale ad esempio quello turistico. Per completare la disamina sintetica relativa al lavoro due dati complessivi disponibili grazie all’Agenzia Piemonte Lavoro e alla Regione Piemonte. Dagli archivi dell’Agenzia risultano nel 2022 nel Verbano Cusio Ossola 4.147 occupati e 2.245 disoccupati di questa fascia di età. I dati dell’Agenzia regionale non possono essere confrontati direttamente con quelli relativi alle forze di lavoro per le diverse modalità di rilevamento,campionariquestiultimiamministrativii primi.
Da ultimo esaminiamo un dato all’attenzione di tutti gli operatori socioeconomici, quello relativo ai neet. Nonèstatopossibilerilevareundatopuntualeprovinciale; si sono quindi rilevati i dati europei, nazionali e
regionali per giungere ad una stima del dato provinciale. Eurostat nel 2021 rilevava le seguenti percentuali di giovani 15-24 anni che non studiano e non hanno lavoro: Europa 10,8%, Italia 19,8%, Piemonte 17,7%.
Applicandoiltassoregionaleaidatidellapopolazione giovanile15-24annidelVerbanoCusioOssolasiarriverebbe a stimare in circa 2.400 i giovani neet in provincia.
Unamodalitàdiversadistima,partendodaldatototale dei giovani e sottraendo i giovani 15-19 che studiano (6.100), i giovani 20-24 iscritti all’università (1.800) e gli occupati (3.600), indicherebbe in circa 2.300 unità ineetnelnostroterritorio,undatomoltovicinoaquello stimato con la percentuale Eurostat nazionale. In ambedue le stime il numero dei neet in provincia risulterebbe ugualmente rilevante.

Pgg. 8-9 Alternativa
FORUM – IL DISAGIO GIOVANILE NELVCO
Puccio – Siamo qui per provare a delineare insieme il quadro del problema del disagio giovanile in questo territorio. Sappiamo che si tratta di un problema complesso originato da un insieme di concause, non esauribile in un incontro, ma il concorso di varie professionalità, abituate a collaborare in analisi e progetti, può permettere di tracciare almeno le linee essenziali. Per avviare il confronto, mi chiedo, ad esempio, come il problema risenta delle contingenze del momento storico: Covid, post Covid, guerra, pressioni emotive suscitate da emergenza energetica e da cambiamenti climatici?
Felisi – Un fattore che traggo da una mia recente esperienza professionale di presa in carico dei familiari dei ragazzi è la carenza della funzione paterna, della regola del limite, non solo perché a volte questa figura manca fisicamente, ma perché nessuno la sostituisce. Il coinvolgimento dei familiarièimportantequandoc’èunasituazionedidisagio di un ragazzo, ma è un percorso difficile perché non c’è la domanda di affiancamento e a volte è vissuta come colpevolizzazione; ma se questa responsabilizzazione manca, il ragazzo da solo può arrivare solo fino a un certo punto. È poi necessario distinguere la psicopatologia dal disagio, non sempre si sovrappongono e sono realtà differenti che richiedono approcci diversi. Oggi siamo qui perché tutti crediamo nel lavoro di rete, però, se manca qualcuno che la tenga tesa, la rete si ingarbuglia: ci si mette in rete ma poi è difficile coordinarsi, è necessario che ci sia almeno un referente del caso e ciò avviene più facilmente quando si lavora in strutture o comunità; negli altri casi, malgrado la buona volontà, è più difficile.
Puccio – É però necessario che ci sia una conoscenza dei vari nodi della rete. Quanto, ad esempio, gli altri servizi conoscono quale parte svolge la scuola e quanto la scuola conosce gli altri servizi?
Borretti – Sono soprattutto gli insegnanti di sostegno, più di quelli curricolari, i meglio informati e che fanno da tramite con la rete dei servizi. I problemi sono rilevanti e influenzano l’attività didattica. Anche la scuola dovrebbe
esercitare quel codice paterno ricordato da Felisi, ma in realtà ciò non avviene più; tende semmai a prevalere un codicematerno,perchél’emotivitàelefragilitàdeiragazzi irrompono nella didattica e condizionano i processi di apprendimento. Si crea confusione: la scuola, cui compete esercitare il codice paterno, per meglio accogliere in un contesto di utenza che è sempre più caratterizzato da difficoltà e disagi, ripiega soprattutto sul codice materno. Lapreoccupazionedellefamiglieperlariuscitaneglistudi, anche come gratificazione personale del ragazzo, mantiene alto il valore della performance, con il carico di ansie e angosce che conseguono e che generano, a volte, chiusure, rifiutoopeggio.Ildocenteinsegnalasuamateria,ma,sempre più, il suo lavoro non si ferma lì, perché si percepisce un disagio crescente che non può essere ignorato.
Lunardon – Mi collego al tema della rete. La “Comunità Educante”, il progetto avviato da poco grazie al bando “Con i Bambini”, cerca la soluzione al problema di chi tiene tesa la rete e la figura indicata è il manager di comunità, la persona che presidia l’intero progetto, allacciando e mantenendo connesso alla rete ciascun partecipante. In questa rete ci sono i tre CISS, soggetti del terzo settore, la Neuropsichiatria dell’ASL VCO. A me la parola ‘disagio’ mette a disagio: spesso il malessere, la fragilità di ragazze e ragazzi non viene ben capita, viene fraintesa ed è bene che ci sia attenzione per capire cosa non va. Perché anche chi appare spensierato risente di fattori di turbamento collettivo, come l’ansia da prestazione, o suscitata da problemi ambientali o di identità personale, che possiamo definire disagio. Occorrono luoghi in cui le persone non si sentanoscomode,sbagliateequestoèunprimopasso.Poi, qui soccorre lo strumento della comunità educante, perché al fondo di quel disagio c’è spesso una povertà educativa, bisognosa del supporto di una rete di soggetti della comunità. E anche nella frequentazione della rete e dei social, chenonsonoperunragazzomondiseparati,possonovenire apporti positivi in termini di disinibizione, di libertà di espressioneemanifestazionedisé,sonospazidipartecipazione del mondo che c’è intorno.
ARiflessioni analisi commenti
Fare una rivista che parla al sociale è stato il nostro primo passo, poi ci siamo accorti che talvolta questo è insufficiente e allora proviamo a suscitare confronti da cui possono partire e/o rafforzarsi collaborazioni e conoscenze in realtà che sembrano necessitare di questi momenti.
Maurizio Colombo, Roberto Negroni su registrazione audio di Samantha Brandini
L’incontro è avvenuto lunedì 3 luglio presso Casa don Gianni a Domodossola.
Hanno partecipato:
Rossana Borretti, docente Liceo G. Spezia, referente problemi giovanili;
Monica Felisi, psicologa, Centro per la Famiglia della Coop. La Bitta;
Andrea Gnemmi, psicologo, Ass. Contorno Viola;
Sabrina Lunardon, animatrice del gruppo I.S.A. (identità sessualità affettività);
Francesca Paracchini, pedagogista, Ass. Contorno Viola;
Stefania Vozza, direttore S.O.C. Neuropsichiatria Infantile ASLVCO.
Ha condotto l’incontro per la redazione di Alternativa: Emanuele Puccio.
(Per un contrattempo è saltata la prevista partecipazione di Chiara Fornara, direttore CSS Verbano)
Felisi–Larealtàdeisocial,cosìabitataericca,favoriscela frammentazione dell’identità. Dove finisce l’intimità in questa frammentazione di sé? In ciò forse la psicoterapia può aiutare a recuperare quella dimensione. Quando sui social l’immagine di sé è del tutto sconnessa da ciò che lorosono,lasituazionesifaangosciante,dovesireintegrano quei frammenti di identità?Tu dici nel luogo dove sono a mio agio: a casa mia. Ma chi non ha questo luogo rimane disperso. Occorre allora costruirli questi spazi, dove magari si possa realizzare anche il contatto con ragazzi più grandi, capaci di svolgere un ruolo educativo senza presentarsi come educatori, come la peer education
Gnemmi – La peer education ha seminato un po’di cultura tra tanti ragazzi di Verbania, l’aver fatto di loro dei volontari non giudicanti in relazioni paritarie ha permesso tante diverse esperienze.
Paracchini – In vari e differenti contesti oggi si trova quanto la peer education abbia seminato e quanti ragazzi si siano avvicinati al sociale grazie a quell’esperienza vissuta a scuola. Anch’io, come Sabrina, sono a disagio di fronte alla parola ‘disagio’, è sempre necessario non generalizzare e contestualizzare. Quest’anno, a scuola, mi sono creataunosservatoriocome“insegnantedicorridoio”,non ho una classe, ma ragazzi che intercetto usando contesti informali come occasioni di incontro. Questo giocarsi nell’informalità,dovelascuolaècodicepaterno,maanche materno, perché così deve essere come vocazione. In queste esperienze, soprattutto quest’anno, nella fragilità dei ragazzi traspare quella degli adulti, vedo spesso questa triangolazione:adolescentiinfantilizzatioadultizzatieadulti adolescenti, come una nuova genitorialità. Mi chiedo se la scuolasianonsolocapacemaanchecompetenteadaffrontare questa realtà. Non mi farei invece spaventare dai social, dalla tecnologia: sono cambiamenti, strumenti, ambienti, identità. Quale sia il confine tra intimità e “fuori” è poi un tema che riguarda i ragazzi ma anche gli adulti, spessoesibitoridiun’intimitàchenonandrebbecosìesposta.
Gnemmi–Chisonoigiovani?Quandosicominciaaesse-
re giovani? Lo si diventa sempre prima.A11 anni, a 13, a 15 si è bambini o giovani? E quando si smette di essere giovani?A20,25,29?CisonoparametriISTATperiquali si è giovani fino a 39. Su cosa si basano queste soglie? Sui consumi,suglistilidivita:a39annisigiocacomea20con la play station, si fanno le canne, si vive magari con i genitori, si ha la cameretta? È giusto così? Che uno faccia le stesse cose a 15 a 25 o a 39 anni, se no si sente in colpa, è un sintomo di disagio della società? Qui identità e mercato si mischiano e nei social ancora di più, nell’identità digitale ci si toglie almeno dieci anni e la categoria dei giovani si dilata senza limite. Quando di parla di giovani bisogna capire di chi si parla: chi va a scuola, chi lavora, chi ha un’autonomia, chi si “sente” giovane? I confini tra bambino, adolescente, età adulta sono stati frantumati perché molto di ciò che era proprio della gioventù è diventato patrimonio degli adulti; ciò genera confusione e i social hanno dato il colpo di grazia. Se noi oggi dobbiamo pensare a un aggettivo per i giovani, il primo è senz’altro “pochi”, i giovani sono pochi, il tasso di natalità da decenni continua a contrarsi, non c’è più ricambio, il rapporto giovani/anziani si è da tempo invertito e si accentua sempre più e questo cambia e cambierà le relazioni. Neppure gli immigrati ci salveranno perché ormai se ne vanno anche loro dove si vive meglio e pure il luogo comune che ifiglisifannosoprattuttoalSudècapovolto,sifannodove cisonopiùservizi,alNord.Perigiovanidioggicisaranno pensioni misere ma, in una sorta di welfare rovesciato, tantianzianievecchidacuiereditare.Perconcludere,tutto ciòfarifletteresuquestiragazzidioggi,unpo’nevrotizzati e carichi di pressioni, ma anch’io penso che il disagio che ne consegue non sia, almeno non sempre, patologia, perché il disagio in un contesto malato è, in fondo, un segno di salute.
Puccio – Soffermiamoci ora sui servizi che questo territorio offre ai giovani. Nella mia esperienza, direi che qui forse i servizi sono meno che nelle grandi città, ma qui sono ancora attive le reti familiari che integrano. Per altri tipi di servizio, mi pare almeno un po’ carente il sostegno psicologico alle condizioni di disagio.
Pgg. 10-11 Alternativa
Vozza –Il nostro osservatorio raccoglie situazioni di grave sofferenza che sconfinano nella psicopatologia, e i dati allarmano, questa è un’emergenza nell’emergenza. Ci siamo concentrati sull’emergenza della pandemia, ma non abbastanza su questa del disagio giovanile, non stiamo investendo abbastanza su questo che è il nostro futuro. Confrontandoidatidelnostroservizioconquellinazionali edialtriPaesi,nell’ultimoventennioc’èstataunaprogressiva crescita dei casi sempre più gravi e complessi, che la pandemiahafattoimpennare.Moltesituazioninecessitano di servizi specialistici per casi conclamati per l’infanzia e l’adolescenzaingravesofferenza,chesonopochiovunque e qui non ci sono; eppure dal duemila a oggi i casi che richiedono interventi di alta specializzazione sono drammaticamente aumentati, ma i posti letto della neuropsichiatria infantile sono pochissimi. Ci troviamo a dover ricoverare ragazzi in posti impropri come la psichiatria per adulti o la pediatria, la quale da anni ci aiuta accogliendopiùadolescentichebambini,maglispecialisti della sanità non ce la fanno più a contenere e a dare risposta. Quest’onda per ora non tende a decrescere, i servizi sono insufficienti.Anche i colleghi psicologi, anche quelli che operano nel privato, sono stati investiti da questa esplosione della domanda e non riescono a soddisfarla, siamo in un Paese che non ha saputo prevedere la preparazione delle necessarie competenze in campo sanitario; in questo territorio (ASL VCO) a gestire questa emergenza siamo solo in due medici, dovremmo essere in cinque, ad arrangiarci a fare di tutto in tutti gli ambulatori. L’anno scorso abbiamo avuto 724 richieste di visite, di cui il 12% urgenti,equest’annonelprimosemestre385.Inunquadro generale di continuo calo della popolazione infantile del territorio si registra un costante e sostenuto incremento dei casi che a noi si rivolgono. Con situazioni delicate, complesse che richiedono interventi multidisciplinari e, talora, ricoveri in comunità sanitarie in altri territori. Pensando al lavoro diquestianni, stando accanto aragazzimolto sofferenti, io trovo una grande solitudine, ragazzi poco ascoltati, lasciati andare, come se nessuno se ne fosse preoccupato, nessuno avesse visto quella sofferenza. Dov’erano gli adulti? Nella grande fragilità dei giovani io trovo la grande fragilità di un mondo adulto incapace di vedere e ascoltare. Per noi medici incontrare e ascoltare è perciò il primo fondamentale passo, e a volte quando arrivano da noi è già troppo tardi e qui si pone allora tutto il tema della prevenzione. Forse quel ruolo paterno di un tempo non esiste più, tutto è cambiato anche solo da com’eravent’annifa;dobbiamotrovareunnuovomododi declinare il paterno e il materno, bisogna cambiare paradigma, cambiare la mente, io non posso fare la neuropsichiatra come vent’anni fa, neppure come due anni fa, bisogna rimettersi in discussione, riuscire a riprendere in mano questa situazione. Non è un bello scenario; personalmente sono preoccupata.
Puccio – Tutti, con le differenze che comportano i diversi punti di osservazione, stiamo percependo una situazione molto critica. Un ultimo quesito: quali strategie di prevenzione possiamo immaginare di fronte a un quadro di
analisi tanto severo e al rischio di arrivare troppo tardi a comprendere e a intervenire?
Vozza – Credo che in tema di prevenzione la fascia di età 0-6 anni sia quella sulla quale è necessario investire di più, non solo nei termini di rendere più consapevoli e competenti i genitori, ma di poter disporre di servizi a supporto della famiglia, perché tutti gli studi confermano che ciò che avviene in questi primi anni ha una proiezione potentissima sullo sviluppo della personalità e su quello che succederà dopo. Cerchiamo di recuperare nelle età successive tutto ciò che è recuperabile puntando su quelle risorse e su quelle resilienze che spesso comunque ci sono, ma è indispensabile puntare a quella fascia di età, e questa è una scelta culturale, sociale, politica, educante, sanitaria; altrimenti è sempre troppo tardi… è troppo tardi!
Gnemmi – Sono convinto che sia necessario investire su impianti sportivi, sale prove, strutture che creano inclusione, con la collaborazione di agenzie educative informali come il Kantiere e Alternativa A, dove ragazzi, adulti e istituzioni si incontrano, si confrontano e dove si possono fare cose importanti. Se invece, come sta accadendo sul territorio, il campo da calcio viene dato alla scuola calcio della Juventus, la sala prove non si può fare per il rumore e lo spazio verde diventa un condominio, la direzione è sicuramente sbagliata. E’chiaro che poi ci vorrebbero dei livelli assistenziali adeguati che sembrano non esserci. In questi anni sono stati aggrediti i diritti fondamentali alla salute. Se in tutta l’ASLci sono solo due neuropsichiatri è evidente che non sono garantiti i servizi essenziali.Aquesto si aggiunge che anche il privato non sembra offrire molte alternative.
Vozza – L’azienda ha fatto un bando per le assunzioni senza riuscire a trovarne. Non ci sono più medici per la sanità pubblica; forse non è più appetibile, è troppo faticoso, forse è una missione che non si vuole più prendere. Il risultato comunque è questo.
Puccio – Quali sono i punti di forza e quali le criticità sul territorio?
Felisi - La bellezza naturale del territorio è sicuramente un aspetto positivo.
Vozza – Il territorio è molto carente nei trasporti pubblici. Questo rende problematico, soprattutto per i giovani, utilizzare anche le eventuali strutture a loro dedicate e rende difficiliancheleconnessionifraivariterritoriefraigiovani. Questa è davvero una criticità rilevante, anche per i costi dei trasporti esistenti, che frammenta ulteriormente il territorio aggravando isolamento e solitudine dei giovani.
Puccio – E’ evidente che in altre realtà urbane, come ad esempio Milano, il livello dei servizi è diverso; nel nostro territorio è necessario poter attivare servizi che suppliscano alle carenze esistenti.
ARiflessioni analisi commenti
Paracchini – Uno dei punti di forza del nostro territorio è sicuramente la presenza di tantissime associazioni di volontariato verso il sociale e la cultura. Nello stesso tempoquesterealtàpresentanodelledebolezze;accantoad associazioni giovani ci sono associazioni dove manca il ricambio generazionale creando spesso una separazione fra le varie associazioni, fra giovani e meno giovani. Gli adolescentihannobisognodiesserevisti,diessereascoltati; è necessario che gli adulti parlino con i giovani, gli stiano accanto. E’ quindi necessario superare questa separazione; è necessario mettere i ragazzi al centro dell’attenzione altrimenti rischiamo di parlare di mondi che non conosciamo più e che rischiamo di osteggiare invece di aiutare. Bisogna quindi continuare a frequentare i ragazzi, provare ad ascoltarli; è anche questo il modo di fare prevenzione.

Puccio – Esiste sul territorio un consorzio delle associazioni, una “casa” delle associazioni?
Paracchini–C’èilCentroServiziTerritorialechesupporta le associazioni dal punto di vista burocraticoinformativo, ma non esiste una “casa” delle associazioni. C’è l’esigenza ma non esiste.
Lunardon – Relativamente ai punti di debolezza vedo innanzitutto la mancanza di luoghi di partecipazione. La scuola potrebbe essere un luogo molto importante; purtroppo, a volte ci si scontra con realtà chiuse.Ad esempio, c’è una scuola importante del territorio dove non esiste la possibilitàdiassembleestudentesche.Lascuoladeveessere più aperta per evitare che da luogo di partecipazione diventi un luogo opprimente. La presenza di luoghi di partecipazione diventa un punto di forza; in questo caso i giovani sono in grado di cogliere le opportunità, di crescere insieme. La possibilità di utilizzare e gestire spazi li attivainmododavveroimportante.Un’altradebolezzaèla scarsità dei fondi per le politiche giovanili che ormai sono solo a livello europeo, dove non è facile muoversi e accedere alle risorse disponibili. A livello nazionale sembra non esserci interesse, forse perché i giovani sono pochi,
non sono consumatori. Quando i ragazzi hanno la possibilità di autodeterminarsi hanno la capacità di creare; mi viene in mente a questo proposito l’esempio del Consiglio comunale dei ragazzi con le sue iniziative.
Felisi – I classici spazi di aggregazione di una volta come, ad esempio, gli oratori non funzionano più tanto. Nei ragazzi c’è il bisogno di vicinanza ma spesso c’è l’impossibilità, l’incapacità di viverla. La scuola potrebbe essere il luogo già esistente più favorevole a favorire la vicinanza e la partecipazione.
Puccio– Fiducia e prestazione devono procedere insieme; oggi forse la scuola nel suo modello richiede prestazione, ma dà meno fiducia e partecipazione.
Boretti – La scuola deve lavorare tanto. Ha difficoltà a integrare mondi diversi, culture diverse. Si rimane ingabbiatiinalcunemodalitàprestazionali,adesempiol’Invalsi, che rendono difficile, accanto alle necessità quotidiane e burocratiche,comelaconclusionedelprogramma,attivare modalità di partecipazione. Qualche anno fa, ad esempio, al liceo si sono attivati dei momenti teatrali con risultati davvero soddisfacenti che purtroppo il Covid ha per ora interrotto. Bisogna sicuramente promuovere più momenti partecipativi;nonèperòfacile.Cisonounaseriediproblemi quali la sicurezza, la responsabilità, la burocrazia che rendono veramente difficile metterli in atto.
Puccio – Grazie a tutti per la vostra partecipazione. L’obiettivo era quello in prima battuta di raccogliere i vostri contributi per un articolo della rivista, ma c’era anche la volontà di creare circuiti virtuosi di conoscenze e relazioni.
Vozza – Sarebbe bello, attivando una mappatura delle competenze, potesse nascere una rete di collaborazione, mantenendo i propri ruoli ma creando maggiori sinergie. Incontrarsieconfrontarsièancheilmododiaverereferenti conosciuti per ogni soggetto della rete.
Pgg. 12-13 Alternativa
IL DISAGIO GIOVANILE E LA CRISI DEI VALORI
Sono note le problematiche che affliggono le ultime generazioni, quindi ricercarne le cause e i rimedi dovrebbe diventare la“mission”per un cambio di rotta. Bisogna allora analizzare, oltre i profondi e rapidi mutamenti intervenuti a livello socioculturale, la crisi di valori morali e civili, in passato sostegno imprescindibile nel processo formativo di una personalità solida e sicura. A questo aspetto etico-culturale sono dedicate le note qui proposte
Il disagio giovanile ha raggiunto in questi ultimi anni proporzioni allarmanti, con l’emergere di non infrequenti situazioni patologhe. Molte e di diversa natura sono le cause di tale fenomeno, che è divenuto oggetto di accurate indagini sociologiche e di analisi psicologiche che ne hanno evidenziato le varie sfaccettature, risalendo alle sue origini e fornendoindicazioniprezioseperaffrontarloinmanieraadeguata. Un ruolo determinante nel provocare la crescita del disagiohannosenz’altroavutoiprofondierapidimutamenti intervenuti a livello socioculturale con l’affermarsi del paradigmatecnologicoeladifficoltàafareadessocorrispondere unparalleloadattamentodellacoscienza.L’influenzaesercitata dai social con il rischio di pesanti condizionamenti, l’assenza di serie prospettive per il futuro – si pensi soltanto alla questione del lavoro – e la scarsa incidenza sul tessuto sociale (anche a seguito della riduzione del numero dei giovani a causa della denatalità), con la conseguente egemonia di modelli culturali espressione dei valori di un mondo di adulti e di anziani sono altrettanti fattori che concorrono ad alimentare il disagio, che assume sempre più i connotati di un vero epropriomalessereontologico. Ma, al di là di questi aspetti, che meritano peraltro grande attenzione,allaradicediquestostatodidisorientamentoedi paura,vièsenzadubbiounaprofondacrisideivalorimorali e civili, che facevano in passato da supporto al processo formativo della personalità, conferendo ad essa solidità e sicurezza, A questo aspetto etico-culturale sono dedicate le brevinotechequiproponiamo.
Le ragioni della crisi valoriale
La crisi dei valori ha le proprie radici nel processo di secolarizzazione, i cui inizi coincidono con la nascita della societàmodernamachedivienefenomenodimassaapartire dalla fine del secolo scorso, trasformandosi gradualmente in secolarismo, con effetti che vanno oltre la critica (talora giustificata) del “sacro” fino ad assumere una valenza etica, mettendo in discussione, o peggio accantonando come anacronistiche, le grandi questioni del senso e del fondamento.
Al venir meno della domanda religiosa si associa dunque (e con essa interagisce) l’assenza di prospettive valoriali per l’affermarsi di quel “politeismo dei valori” (o dei “sistemi valoriali”) – come Max Weber lo definisce – conseguenza
Giannino Piana
del “disincantamento del mondo”. Il crollo delle grandi narrazioni religiose, del pensiero metafisico e dei progetti ideologici toglie all’etica le basi tradizionali su cui fondarsi, lasciando il posto nel valutare e orientare l’agire a criteri meramenteutilitaristi.
A dare contenuto a questi criteri è la logica del “mercato”, divenuto “pensiero unico”, che ha come obiettivo da perseguire l’efficienza produttiva e il consumo. A contare è, in altri termini il “fare” e l’ “avere”, dunque non l’ “essere”, cioè la crescita interiore della persona e la ricerca della sua vera identità. A questo si associa l’avanzare di una cultura individualista, che reagisce alla tensione socio-politica degli anni70delsecolopassato;unaculturanellaqualeaprevalere è la ricerca della autorealizzazione, la quale accentua le spinte privatistiche, individuali o corporative – il neocorporativismo è uno dei tratti identitari della cultura oggi dominante – che hanno come effetto la lacerazione del tessuto sociale.
L’assenza di figure genitoriali autorevoli e la debolezza della scuola
Aquesto stato di cose, già di per sé allarmante, si aggiunge l’assenza di figure genitoriali che sappiano (e possano) esercitareconautorevolezzalapropriafunzione.Equestosiaper la debolezza della propria personalità, vittime anch’essi del relativismo culturale ed etico imperante, sia per l’approfondirsi del gap generazionale dovuto al ritmo accelerato dei cambiamenti in corso. Il rapporto dei figli con le figure materna e paterna rischia di ridursi a un livello utilitaristico: la soddisfazione dei bisogni materiali e la richiesta di protezione sono le ragioni del mantenimento del rapporto, senza una vera comunicazione per la distanza, non superabile, delle rispettive concezioni della vita e dell’universo valoriale. I genitori tendono allora, per conservare la relazione, a considerare e a trattare i figli come amici, difendendoli in tutte le circostanze, anche quando sbagliano, con la conseguente difficoltà delle altre agenzie educative di intervenire – la scuola anzitutto – esercitando il proprio compito formativo.Neèriprovailripetersidicasidiveraepropriaviolenza di studenti nei confronti dei loro insegnanti; casi che rimangono senza azioni punitive adeguate a causa delle minacce spessoavanzatedaigenitoricheassumonosempreecomun-
ARiflessioni analisi commenti
queunaposizionedifensivaneiconfrontideiproprifigli. Asua volta, la scuola, vive in una condizione di particolare sofferenza. E non solo per la ragione già ricordata – la difficoltàdirapportotragenitorieinsegnanti–maperragioni più profonde ascrivibili al modello culturale che continua a proporre e che non corrisponde alla sensibilità dei giovani dioggifiglidiunasocietàdigitale,dovelatecnologiaincontinua evoluzione non si riduce a semplice strumento, di cui occorrevalutare,divoltainvolta,l’usochesenefa,maincide, per la sua pervasività, sulla coscienza provocando una vera mutazione antropologica. Il rischio è dunque che quanto si insegna non venga assimilato, se non superficialmente e in maniera nozionistica, e che si sovrappongano tra loro due mondi senza possibilità di conciliazione, con il risultato di non riuscire ad evidenziare i rischi in cui si incorre con l’adozione del paradigma tecnologico e a non proporre risposteplausibilialledomandedisenso;rispostecheèpossibile fornire solo mediante il ricorso al patrimonio della tradizioneumanistica.
Ma questo non basta. La debolezza della scuola è anche motivata da una progressiva disaffezione del corpo insegnante – la scarsa retribuzione economica è una delle cause –e,inalcunicasi(noninfrequenti),anchedall’abbassamento del livello culturale, considerando, una parte di essi, la scuola come un ripiego per assicurarsi uno stipendio, anche secomesièdettopiuttostoesiguo,ededicandosiprevalentemente ad altre attività meno frustranti e più remunerative. Sono sempre stato contrario alla meritocrazia – don Milani non ha mancato di metterci in guardia a tale riguardo – ma sono convinto che, come è ingiusto trattare in modo diverso prestazioniuguali,cosìèaltrettantoingiustotrattareinmodo uguale prestazioni diverse. L’omologazione cui oggi si assiste con giudizi e voti sempre più alti – è anche questa una delle conseguenze del timore delle reazioni dei genitori –denuncia uno stato di rilassamento che nuoce alla serietà dell’impegnoscolastico,conricadutenegativeanchesulterreno educativo. Se in passato vi era una eccessiva severità nei giudizi, oggi si è caduti nell’eccesso opposto con una svalutazionedifattodelvaloredellascuola! Come affrontare l’emergenza del disagio Afaredacatalizzatoredeivariaspettideldisagioèsoprattutto la condizione di solitudine che gli adolescenti e i giovani vivono. I rapporti con la famiglia e con la scuola, quando sussistono, sono puramente formali: il che accentua lo stato diisolamento,cheliportaachiudersisusestessispingendoli adunusosemprepiùsmoderatodelcomputer,cheriducegli spazidisocializzazioneconicoetaneiefavorisceilricorsoa relazionipuramentevirtuali.Larecentepandemiada Covid19 haaggravatoinmodoserioquestasituazione:adolescenti e giovani si sono trovati per circa due anni con uno spazio assai limitato di possibilità di socializzazione ed hanno sofferto particolarmente per questa situazione, con uno stato generalediforteinsoddisfazione–sonostatidifattolemaggiori vittime a livello psicologico – e con la crescita delle patologie.Difronteaquestasituazionechefare?Milimitoa suggeriretreconsiderazioni.
La prima chiama in causa la questione valoriale. Pur nel pienorispettodelpluralismodeisistemivalorialioccorretrovare anche oggi un terreno comune attorno a cui convergere
nellaricercadiun ethos civile.Credochelapossibilitàsussista,seppuregrossesianoledifficoltàperraggiungerequesto obiettivo. Il metodo da seguire è quello fornito dall’etica della comunicazione delineata da Habermas, la quale presuppone il reciproco rispetto delle posizioni dei vari gruppi sociali e la seria volontà di cooperare tra loro in vista di una possibileconvergenza.Unmodelloesemplareèrappresentato, a questo proposito, dal lavoro fatto a suo tempo dai Costituenti–sipensiaiprimidodiciarticolidellaCostituzione – che hanno elaborato un ethos civile, tuttora attuale, anche se ci si trova oggi in una situazione diversa per la caduta di quelle “evidenze etiche” che in passato garantivano l’esistenza di una piattaforma comune quale base da cui partire.Lasperanzaèchequestosiavveriintempibrevifornendo ad adolescenti e giovani un indispensabile puntofermosu cuicontare.
La seconda considerazione ha come oggetto la famiglia Importante è che i genitori esercitino la propria funzione educativa, non avendo paura di fare ricorso al principio di autorità. L’educazione comporta infatti anche la capacità di dire di “no” ad alcune richieste del figlio o di correggere alcuni suoi comportamenti sbagliati: solo così lo si aiuta a crescere. Ma comporta anche (e soprattutto) la trasmissione di valori ai quali i giovani possano conformare le proprie scelte esistenziali. Entra qui in gioco l’autorevolezza dei genitorichedevonodiventareconlalorocondottailmodello di riferimento: non si educa per quello che si dice ma per quello che si è e si fa. Tutto questo senza dimenticare che il finedelprocessoeducativoèquellodimettereincondizione ilfigliodiagireinmodoautonomo;ilchesignificachel’educatore deve gradualmente arretrare, fino a scomparire, mettendoincondizioneilfigliodiacquisirelaproprialibertà didecisione.
La terza considerazionefariferimentoal processo educativo della scuola.Unacondizionefondamentaleè,alriguardo,la proposta di un modello culturale, che sappia partire dalle istanze proprie del modo di percepire la realtà proprio di coluichesièchiamatiadeducare–istanzelegatealladipendenza dal paradigma tecnocratico – e sappia nello stesso tempo fornire gli strumenti per una loro lettura critica. Per conseguire questo obiettivo diviene necessario dare vita ad unmodelloculturaleincuiculturascientificaeculturaumanistica si integrino tra loro, evitando tanto la caduta in una forma di arido scientismo quanto di una forma di umanesimo ideologico. A questo deve poi accompagnarsi il superamento dell’attuale situazione di lassismo per trasformare la scuola in istituzione impegnata a fornire gli strumenti essenziali per la crescita della persona, facendo dell’istruzione un momento imprescindibile dell’attività educativa.
A queste condizioni, e soltanto a queste, è possibile aiutare adolescenti e giovani ad uscire dall’attuale stato di disagio, restituendolorolasperanzainunfuturopromettenteedando lorolapossibilitàdidiventarearteficidelpropriodestinoedi quellodell’interaumanità.
Pgg. 14-15 Alternativa
PER UNA SCUOLA DEL MERITO O DELLA CURA?
Passare giorno dopo giorno in aula, Mac, significa vivere in un altro mondo
FRANKMcCOURT
Ma io con che coraggio ho creduto di poter affrontare degli adolescenti americani? Col coraggio dell'ignoranza, ecco. Siamo nell'era Eisenhower e sui giornali si parla della grande infelicità che affligge i giovani americani, i cosiddetti "figli perduti dei figli perduti della generazione perduta".Quest'infelicitàvienedescritta nei film, nei musical, nei libri: Gioventù bruciata, Il seme della violenza, West Side Story, Il giovane Holden.Igiovanifannodiscorsidisperati:lavitanon ha senso, gli adulti sono tutti ipocriti, a che scopo vivere? [....] L'infelicità è tanta che gli adolescenti si organizzano e danno battaglia ad altre bande: e non sono delle zuffe come quelle che si vedono al cinema, con amori tormentati e colonne sonore martellanti, ma risse cattive in cui volano grugniti e bestemmie, risse in cui italiani, neri, irlandesi, portoricani si affrontano. con i coltelli, le catene, le mazzedabaseballemacchianol'erbacolsangue,che è sempre rosso, a prescindere da chi l'ha versato. Poi se ci scappa il morto l'opinione pubblica si indigna e punta il dito, sostenendo che se le scuole e gli insegnanti facessero il loro dovere queste cose tremendenonsuccederebbero. 1
Così, Frank McCourt nell'introduzione del gustoso libro autobiografico sulla sua esperienza di insegnante, Ehi, prof!, uscito nel 2005, introduce i lettori a seguirlo nei suoi primi passi da insegnante, inesperto e pieno di dubbi sulle proprie capacità, fino alla conquista di un meritato riconoscimento dellesuedotiprofessionalieumane.Mentrescrivoquestidue aggettivi,miinterrogosuqualescrivereperprimo,qualesiail più importante e, infine, se si possano scorporare nel difficile compito dell'insegnare. Insegnare, cioè lasciare un segno. Mi sembra evidente che l'uno senza l'altro non possa essere efficace.Ripensoadalcuniesempidiprofessorechehotrovatoin letteratura, nei romanzi: l'italiano Starnone, Frank Mc Court, Daniel Pennac, autori che con grande auto-ironia hanno saputo narrare la propria carriera senza retorica e mettendo al centrodellororaccontolafragilitàpropriaedeipropristudenti, un po' alla volta legati in una relazione particolarissima, quella del docente che sa farsi adulto di riferimento per loro, dopoaverneconquistatofiduciaeunpo'diaffetto.... Nel raccontarsi in cattedra hanno ben presente nella memoria le proprie esperienze di studente, e di studente non brillante,
1 Frank McCourt, Ehi, prof! Adelphi, Milano, 2005, pp.27-28.
2 Limes, 1/23, Caoslandia
abbandonatonelleretroviedeisenza-speranzadirecupero. Forseperquestosonoparticolarmenteattentialclimadilavoro,allosguardoconcuiosservareitantistudenticoncuisono incontratiindiversiindirizzidistudio.
Ilbranochehocitatoinaperturamihacolpitoperilriferimento al tema tanto attuale anche oggi: il malessere dei giovani, già emergenza nazionale negli Stati Uniti allora, anno 1958. Che l'adolescenza sia sempre un'età di passaggio e quindi, necessariamentedifragilitàediinsicurezza,diamoriedolori intensi, di nuovi bisogni non èniente dinuovo, ma nel nostro presente, quello che Miguel Benasayag definisce l'epoca "delle passioni tristi", il pessimismo diffuso e la solitudine interioredeterminatadaunindividualismosemprepiùspinto, sono diffusi segni di malessere nei più giovani sotto gli occhi ditutti.Ilnostroèuntempodicrisi,anziditraumi:unanatura abusata e sfruttata al di là dei limiti, disuguaglianze sociali sempre più marcate, 28 guerre in corso sul pianeta 2, l'ultima dellequalicosìvicinaanoi,unapandemianonancoradeltutto debellata.Sembraunparadosso:tecnologiaescienzasembravanoingradodirisolveretuttiiproblemidell'umanità,manel presenterivelanoilororischi,laloroincapacitàdigarantireun futuropienodipositivitàeungrevepessimismosoffocasogni esperanzedelfuturo.
Èevidentechesiamoinun'etàdicrisiediconseguenzalacrisi deipiùgiovaninonèsolounmalesseredegliadolescenti,ma èunacrisidellasocietà,nellaqualegliadolescentisisonoabituatiavivere.Alladifficoltàdicresceresisommaladifficoltà divivereinunmondochenonhamantenutolepromessefatte balenare. E la nostra scuola, in questo contesto, deve continuareafarelasuaparte.
Glistudisullarealtàscolasticadelnostroterritorio,inparticolare dall'osservatorio dell'Istituto Cobianchi, dove ho insegnato per molti anni, hanno segnalato che a partire dagli anni '90 c'è stato un cambiamento nel profilo dei nostri studenti: "come docenti, abbiamo avvertito una difficoltà crescente nella comunicazione con gli studenti, percepiti, rispetto alle generazioni precedenti, come meno coinvolti nell'attività didattica, meno consapevoli del senso e delle finalità della istituzione scolastica e delle sue norme implicite, più fragili ed inseriti in dinamiche relazionali tra pari decisamente più difficili da leggere. Ad un certo punto abbiamo smesso di parlare di" nuovi studenti" ed abbiamo cominciato a parlare di "nuovi adolescenti", caratterizzati, tra l'altro, da una scarsa identità di ruolo quali studenti (essere studenti ed essere adolescenti si equivalgono: praticamente tutti i pari di età conosciuti sono studenti) ed abbiamo iniziato a confrontarci su questi temi fra noi e con il dibattito esterno alla scuola."
Questiaspetti,colpassaredeglianni,sisonoresipiùmarcatie
ARiflessioni analisi commenti
Maria Pia Zocchi
3
.
3 Gianmaria Ottolini, Marina Beretta, Guido Boschini, Barbara Pesce, Pratiche di formazione e manutenzione del gruppo classe, in Nuovi saperi
i nuovi studenti evidenziano sempre maggiori aspettative riguardo alla loro formazione individuale, spesso più interessati all'ambito relazionale e della socializzazione che a quello istituzionaledell'apprendimento.

Purtroppo questo individualismo si è trasmesso, loro malgrado, anche ai docenti: la stabilità delle équipe di lavoro che avevano garantito nei consigli di classe fisionomie definite ai diversicorsiscolasticisièincrinata,acausadioraridicattedra sempre più spezzettati e di insegnamenti e completamenti orarisupiùcorsi,ancheperunasceltadavveromiopedialcuni dirigenti scolastici di spezzare équipe affiatate con l'intento di diffonderepratichedidatticheomogeneenellascuola,comese gli insegnanti potessero essere utilizzati come talee, sradicate eimpiantatequalàinunconsigliodiclasseoinunaltro. E anche questo segna un impoverimento dell'offerta scolastica, perché gli studenti percepiscono come un valore il lavoro di un consiglio di classe che si presenta compatto e che sa lavorareinsintonia.Neilibricuiaccennavoprima,sistagliala figura dell'insegnante che usa il suo fascino e il suo carisma percoinvolgereglistudenti.
Ogni classe ha la sua personalità. Ci sono classi simpatiche che ti fanno pregustare la lezione. Gli alunni sanno che con loro stai bene e a loro volta stanno bene con te. Di tanto in tanto ti dicono che hai fatto una bella lezione e tu ti senti al settimo cielo. In qualche modo questo fatto ti infonde energia e mentre torni a casa ti viene voglia di cantare.
Ci sono classi che vorresti imbarcare sul traghetto per Manhattan e non vorresti vederle più. L'atteggiamento ostile con cui entrano e escono dall'aula ti fa intuire cosa pensano di te. Ma siccome le tue potrebbero essere tutte fantasie, cerchi di capire come conquistarli. Ricorri a trucchi che con altre classi hanno funzionato. Però non serve e il motivo è quella certa personalità. 4
Unapersonalitàcheaffascinaèunvaloreaggiunto,maquello che secondo me dà maggiori garanzie di riuscita è il lavoro di un'équipe di professionisti dell'educazione che seguono,giornodopogiorno,conunosguardoattento,i loro studenti, facendo tesoro di buone pratiche studiate e sperimentateconsuccesso.Soloperquestoaspettononconcordo conletesisostenuteneiromanzicitatienelsaggiodiRecalcati L'ora di lezione, 5 dove il ruolo del docente-star troneggia, rendendo l'ora di lezione impagabile. Certo, la "personalità", lo stile unico del docente può fare la differenza, ma non è sufficiente, se non si inserisce in un contesto condiviso di metodi e di orientamenti perseguiti da un ConsigliodiClasse.
Mi è capitato recentemente di leggere su La Stampa la bella intervistaaundocentedifilosofiatorinesecheper40anniha insegnato con passione e serietà e, giunto al pensionamento, èstatosalutatocontestimonianzedigrandeaffettodaglistudenti del liceo, tanto da meritare tre articoli sul quotidiano torinese. Afferma: "Fare l'insegnante vuol dire dare il pro-
Alternativa
5 Massimo Recalcati, L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, Einaudi, Torino, 2014
4 Frank McCourt, cit, pp. 101-102.
per la scuola, Marsilio, 2007, p.161.
Immagine di Freepik
prio piccolo contributo a passare da una generazione all'altra. Ed è una cosa che va fatta." 6
Questo mi sembra un giusto presupposto da cui partire, perché nellavoroinclasseèfondamentalecontribuireacreareunrapporto di fiducia negli adulti, premessa per includere le nuove generazioninellavitacivileesociale:ma cosa ciproponiamodi passaredaunagenerazioneall'altra?Unoggettodelsapere?Un metodo?Unatteggiamento?Direituttiquestiaspetti.
"La scuola apre mondi",comeaffermaRecalcati,el'insegnante, sospeso continuamente tra la ricchezza delle conoscenze che vuoletrasmettereel'aspirazionearinnovare,classedopoclasse, allievo per allievo, il gusto della scoperta di un nuovo mondo, gioca in un equilibrio che rende affascinante questo lavoro.
"Loro erano convinti che stessi insegnando. Ne ero convinto anch'io. In realtà stavo imparando." 7
La classe è - o dovrebbe essere - il luogo in cui si parla e ci si ascolta, senza una finalità valutativa, giudicante, performativa. Sono rari gli altri spazi del mondo in cui questo avviene quotidianamenteeleparolechesiesprimononell'aulaappartengono atutti,adesseèaffidatoquelmomentodiformazionedell'essere umano che può avviare il processo dell'apprendimento. E l'apprendimento non procede a senso unico, ma si costruisce soloselostudentepuòvalutarecriticamenteesentirsiarricchito daciòcheneèl'oggetto.
Come dice poeticamente Pennac, "a ogni incontro ti accorgi che una vita è sbocciata, imprevedibile come la forma di una nuvola", ma a una condizione, come scrive lo stesso insegnante Pennac: "la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla mia". 8
Negliannidellascuolasipuòcostruirequelpontetragenerazioni di cui si parlava, se la passione dell'insegnante è, almeno in parte, contagiosa, se si costruisce un rapporto di fiducia con gli studentiesesisatrasferireconsapevolezzariguardoalpercorso dell'apprendimento che la classe sta vivendo insieme e individualmente. Questi aspetti, in cui ho creduto negli anni del mio insegnamento, trovano una conferma importante nelle parole degli studenti raccolte nelle interviste pubblicate recentemente inunostudiorealizzatodainsegnantiattivineltrentenniodisperimentazione dell'Istituto L. Cobianchi di Verbania. Ne riporto alcune:
"Si aveva la sensazione di essere speciali...io mi sentivo tutelata dai professori che tenevano al nostro benessere
Ci si poteva esprimere e immediatamente portare un pezzo di sé che non coincideva con quello che gli altri fuori vedevano
Mi sono sentita subito responsabilizzata, più grande fin dalla prima
È stata una scuola che ha creato passione... poi nella vita queste passioni sono rimaste e mi sono servite
Non era solo apprendimento, ma apprendimento e formazione di sé andavano di pari passo... era una formazione completa
Io studiavo, apprendevo, ma mi divertivo, ero felice di andare
8 Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 86 e p. 103.
10 Michele Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli, 2013, p.107.
11 Daniel Pennac, cit., p. 137
a scuola
Ho trovato un gruppo di docenti che andava d'accordo Io sapevo che l'obiettivo, al di là del mero apprendimento, era quello della costruzione di uno spirito critico e io, al contrario di tanti miei coetanei, sapevo anche di poter mettere in dubbio quello che mi veniva insegnato Speranza e fiducia negli adulti. Stupore. Capacità di osare." 9
Disagio e mondo giovanile non coincidono necessariamente:l'aiutochelevecchiegenerazionipossonofornireèquello dioffrireoccasionidiconoscenzaelibertàdiespressioneper nuoviprogetti,perinventareecostruireunarealtàdiversada quellaricevuta.Ogninuovagenerazionesièdatanuovistrumentidiinterpretazionedellarealtàehacostruitounmondo cheleprecedentinonsapevanoimmaginare.Èlamoraleche Michele Serra pone in conclusione del suo romanzo Gli sdraiati: un padre, ormai deluso e scoraggiato dal tentativo checredevavanodiscorgerenelfiglioifruttidellasuaeducazione, nel cercare somiglianza nei suoi comportamenti, insiste, nel corso del racconto, a invitarlo a scalare insieme unamontagnacomeavevafattolui,quandoeraunbambino, con suo padre. Probabilmente esasperato dall'insistenza del padre, il figlio accetta e partono insieme verso la vetta, ma quando il padre, impegnato nella fatica della salita si volta, nonvedeilragazzodietrodilui:sisentechiamareelovede. "Eri in alto, molto più in alto di me, quasi un chilometro avanti... Mi avevi sorpassato e seminato senza che me ne rendessi conto, immerso com'ero nei miei rendiconti con i massimi sistemi [...] Salivi veloce, con un passo elastico, che esprimeva destrezza, sicurezza, forse felicità, quella felicità che, solo a dirla, in relazione a te e agli altri della tua tribù, le lacrime mi velano gli occhi." 10
I nostri studenti, che aspirano, come ogni giovane, a soddisfarequeldirittoallafelicitàealsuccessocuilasocietàillude findabambini,possonoancoratrovarenellascuolaglistrumenti per crescere, anche attraverso l'educazione all'impegno,allacondivisione,allapassione,avoltepurtroppo anche alla sconfitta ma alzando lo sguardo oltre gli steccatidellatradizione,comesololoropossonofare. Neltempodellascuola del merito,aunascuolachepuntapiù sulla trasmissione dei contenuti e sulla valutazione degli apprendimenti,preferiscounascuoladella cura, doveognuno faccia del proprio meglio per "fare in modo che ad ogni lezione scocchi l'ora del risveglio" 11
9 Marina Beretta, Francesca Paracchini, Luca Sarasini, La voce degli studenti, in Aa.Vv., Sperimentare la scuola. Storie di buone prassi, Blonk Editore, 2022, p.103 e segg.
7 Frank McCourt, cit. p. 34.
ARiflessioni analisi commenti
6 Lodovico Poletto, Dopo 40 anni sono io a dover dire grazie, intervista a Enzo Novara, in La Stampa, 9 luglio 2023
BAMBINI ETECNOLOGIE DIGITALITRA OPPORTUNITÀ E RISCHI
Dobbiamo“apparecchiare”lo schermo perché il punto non è disconnettere ma connettere bene
Paola Sau
Nuovi progressi antichi dilemmi
Come anche scriveva Emanuele Bottazzi 1 nel 2018, nell’utilizzare questo nuovo strumento gli studenti “non useranno più la memoria”, “non saranno più in grado di imparare”, “perderanno il contatto con la realtà”: non sono i commenti di psicologi e pedagogisti contemporanei, ma i pensieri di Socrate 2, per il quale la parola,pronunciataenonscritta,consenteunoscambioche nessuno scritto può sostituire. Possiamo, per paradosso, far risalire le prime accuse alle “nuove tecnologie” addirittura al V secolo avanti Cristo.
Èbanalericordarechedifronteaognicambiamentoepocale nel progresso di nuovi strumenti di conoscenza e apprendimento vi sono sempre duplici approcci: entusiasti ottimisti sostenitori da un lato, critici pessimisti dall'altro. Così è stato ad esempio anche per l’avvento della carta stampata, e quando i libri sono diventati consuetudine alla finedelXIXsecolol’oggettodicriticaèdivenutoaddirittura la scuola pubblica: “esaurisce il cervello e il sistema nervoso dei bambini con studi complessi e molteplici, e rovina i loro corpi con un imprigionamento protratto"; pubblicava una rivista medica del tempo (The Sanitarian). Poi è stato il turno della radio, della televisione, del walkman e oggi tocca alle tecnologie digitali, smartphone, tablet,ecc.Inseguendoilfilodiquestipensierinonpuònon riaffiorare alla memoria ciò che scrive Douglas Adams: “Ho trovato tre regole che descrivono le nostre reazioni alla tecnologia: qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo, ci pare normale e usuale e riteniamo che faccia per natura parte del funzionamento dell’universo; qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercorso tra i nostri quindici e i nostri trentacinque anni è nuova ed entusiasmante e rivoluzionaria e forse rappresenta un campo in cui possiamo far carriera; qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto trentacinque anni va contro l’ordine naturale delle cose.” 3 . Ecco, la tecnologia digitale non va contro l’ordine naturale delle cose ma è nell’ordine delle cose, sia che si sia d’accordo oppure no, è una datità.
La rivoluzione tecnologica
Oggi viviamo quella che ormai è da tempo definita la rivoluzione tecnologica, un’evoluzione fulminea, immersiva, separatanotevolmentedaunpensieroconsapevole.Unatra
1 In scienzainrete 2018.
le tante differenze fra le “nuove invenzioni di ieri” e questa di oggi consiste nella velocità e nella pervasività con cui essastaavvenendoe,comeperilpassato,cisichiedequale impatto ha sullo sviluppo dei bambini e con quali conseguenze. Per i bambini vale il pensiero diAdams, ovvero la tecnologia digitale fa parte per “natura” del loro mondo: sono,secondol’espressionediMarcPrensky, nativi digitali.
Interrogarsi su questo tema, ovvero sul rapporto tecnologie digitali e infanzia, è ineludibile e quanto mai necessario. Non sono solo la quantità di tempo trascorso nell’uso dei device e la qualità dei contenuti i fattori determinanti che condizionanol’esperienzadeibambiniedellebambine,ma è la stessa “natura” del mezzo che impatta significativamente sullo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini, e ciò può avvenire sia in senso positivo stimolando nuovi modi di apprendimento, sia, all’opposto, in senso negativo inibendo potenzialità di sviluppo o, ancor peggio, determinare patologie.
Il rapido sviluppo della digitalizzazione offre certamente opportunità per l’educazione e la cura dell’infanzia - pensiamo semplicemente a nuovi materiali e ad ambienti di apprendimento virtuali, o alla tele-riabilitazione che ha avuto la sua spinta massima nel corso della pandemia - ma allostessotempoladigitalizzazionecreanuovesfideperla vita dei bambini, soprattutto quelli piccoli, sempre più frequentemente esposti a stimoli dove non sempre è facile individuare il confine fra benefici e pericoli.
Bambini e tecnologia
L’esposizione alla tecnologia inizia fin dalla primissima infanzia: tutti noi abbiamo esperienza di bambini piccolissimi ancora sul passeggino, sul carrello della spesa, nella salad’attesadellostudiomedico,coninmanolosmartphone e abili nell’usare il touch screen.Appunto, abili ad usare il mezzo, ma purtroppo spesso non competenti, ovvero ancora incapaci di selezionare con cognizione i contenuti. A differenza di altri mezzi, gli smartphone offrono stimoli non-stop, sono strumenti mobili, quindi sempre disponibili ovunque, in qualsiasi luogo, senza pause; inoltre, molte delle app, o dei video diYouTube, creati con obiettivi educativi, includono finalità commerciali, a volte trasparenti ma altre volte occulte, che costringono di fatto i bambini a rimanere “incollati” e dipendenti. Lo sviluppo neuropsico-
2 [La scrittura produrrà] la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché, fidandosi della scrittura, si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da se medesimi: dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, ma del richiamare la memoria (Platone, Fedro, Rusconi, Milano, 1997, p. 197).
3 DouglasAdams, Il salmone del dubbio, Mondadori, Milano, 2004, p. 72.
Pgg. 18-19 Alternativa
motoriodelbambinonecessitaditempoedi esperienza per giungere a una maturazione. Sappiamo quanto l’ambiente, nella sua accezione più ampia, sia fondamentale nell’orientare e definire le traiettorie di sviluppo, e sappiamo anche quanto l’esperienza vissuta, concreta, legata alla dimensione corporea sia altrettanto fondamentale, e ancora come le prime esperienze di apprendimento siano correlate alla motricità, alla concretezza: manipolare, toccare, esplorare a livello senso-motorio. È sull’esperienza, il vissuto in relazione che si costruisceilsensodelsé,dellapropriaidentità e si impara a fare esperienza del mondo. Il sistema motorio è sistema cognitivo e relazionale, l’esperienza libera dei bambini con gli “oggetti” del mondo sviluppa il linguaggio, la pianificazione, la cooperazione e si potrebbe continuare ancor più nel dettaglio. La società Italiana di Pediatria sconsiglia l’uso dello smartphone prima dei due anni, sempre durante i pasti e prima di dormire; tra i due e cinque anni ne limita l’utilizzo al massimo ad un’ora al giorno, e sottolinea che l’uso deve essere condiviso con il caregiver, mai usato come ricompensa e meno che mai come baby-sitter.
L’Istituto Superiore di Sanità nella sintesi sulla“Sorveglianzabambini0-2anni”,pubblicata nel marzo 2023, riporta i dati della frequenza giornaliera di esposizione agli schermi (Grafico.1 e 2).


Daniela Lucangeli 4 nel corso del quarto convegno nazionale di epigenetica descrive chiaramente a quali estremi può portare l’uso non controllato dello smartphone nei bambini piccolissimi: ovvero vera e propria dipendenza dopaminergica con crisi inconsolabili di tipo psicotico. Anche il video, in cui una bimba molto piccola sfoglia delle riviste come fossero uno schermo pone di fronte al quesito sull’impatto che le tecnologie possono avere sullo sviluppo.
Con l’introduzione dello smartphone la digitalizzazione è diventata pervasiva, gli schermi interferiscono massicciamente nella nostra vita quotidiana, e soprattutto in quella dei bambini, abituati all’uso dei media digitali sin dalla tenera età. Per questo è importante aumentare la cognizione digitale dei genitori, degli educatori, degli insegnati in particolare, per promuovere nei bambini competenza digitale e quindi benessere digitale. L’educazione digitale dovrebbeavvenireperfasced’etàefindalla
4 Docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento.
Acontributi
primissima infanzia, periodo in cui è fondamentale rendere consapevoli i genitori dei danni potenziali dello smartphone quando dato al bambino per consolazione, o usato come babysitter. Ogni tappa evolutiva va supportata con indicazioni precise di utilizzo dei media digitali, fermo restando che la condivisone del mezzo con il genitore è il presupposto imprescindibile.
Tanti sono i bambini che incontro nel mio lavoro che sono esposti precocemente a contenuti digitali non adatti alla loro età (games, YouTube, piattaforme, ecc.) che manifestano disagi profondi con alterazioni comportamentali, affettivo-relazionali e, nei più piccoli, anche ritardo in aree dellosviluppo,inprimisillinguaggio.Mihannoparticolarmente allarmato, lo scorso anno, i comportamenti e racconti di paura e angoscia di bambini di età compresa fra i quattro e i sette anni. L’oggetto delle loro inquietudini era HuggyWuggy, un enorme mostro di peluche, di colore blu con denti aguzzi e zampe lunghe dotate di artigli. Questo mostro è il protagonista di un videogioco, apparentemente innocuo, Poppy Playtime,cheinrealtàappartienealgenere horror e si rivolge a bambini dai 12 anni in su. Chi gioca esploraunafabbricaabbandonatadigiocattolieilpupazzo/ mostro Huggy Wuggy, dopo essere stato abbandonato, prendevitaeinsegueilgiocatoreconl’intentodiucciderlo. Il videogioco sfrutta i jumpscars 5 per mettere paura: il mostro appare all’improvviso davanti allo schermo, con forti e inquietanti effetti sonori, così da provocare reazione di panico e fuga. In rete vi sono inoltre molti video in cui influencer famosi (Me contro Te, Lyon, ecc.) giocano a questo videogioco enfatizzando le emozioni di paura e terrore e trasferendo il pupazzo anche in luoghi reali, sia travestendosi da peluche o con fotomontaggi, con effetto terrorizzanteneibambini,chepossonoavereincubi,insonniaedessereportatipersinoacrederediessereinseguitidal mostro e che sia possibile incontrarlo ed essere uccisi davvero. È solo un esempio che pone in evidenza la necessità, a mio avviso urgente, di educazione digitale, in primo luogo dei genitori che spesso sono inconsapevoli dei rischi a cui espongono i propri figli.
Possibili rischi
Nellapuntatadel20marzodiquest’annodi“PresaDiretta” è andato in onda un’interessante intervista al direttore scientifico del Laureate Institute for Brain 6 , lo psichiatra MartinPaulus;ilcentrochedirigestasvolgendoilmaggiore studio a livello mondiale per capire l’impatto sul cervellodeibambiniedeiragazzichepassanotanteoresui social e sui cellulari. Conclusioni definitive non vi sono ancora, lo studio richiede tempi lunghi, ma i primi dati emersidenuncianochelalungaesposizionesullepiattaforme social e sui cellulari provoca variazioni al cervello sul pianocognitivoedemotivorelazionale,conlacomparsadi disturbi da ansia/stress, dell’attenzione e del linguaggio. I ricercatori hanno mostrato il verificarsi di un disallineamento nel cervello nei ragazzi monitorati 7, ovvero la parte
che elabora le informazioni visive è più sviluppata mentre l’areadicuiabbiamobisognoperelaborareinostrigiudizi, le nostre preferenze, mostra uno sviluppo minore rispetto alla media. Quest’area, continua lo psichiatra, “si chiama corteccia prefrontale ventromediale, ed è una parte importante del cervello perché da questa dipende come valuti te stesso e come valuti gli altri, come elabori le tue scelte etiche, come definisci le tue preferenze, ciò che ti piace, ciò che non ti piace. L’elaborazione più sofisticata dei sentimenti avviene proprio in quest’area ed è relativamente meno sviluppata. Nei bambini con questa differenza di sviluppo nelle aree cerebrali si manifestano più depressione e ansia e anche problemi di rabbia e impulsività.”
Se è vero, come è vero, che rischi per la salute mentale dei bambini e ragazzi esposti ai media digitali si stanno delineando con maggior evidenza scientifica, è altrettanto vero che i fattori di rischio alla base dei disturbi neuropsichiatrici infantili ed emotivi sono complessi e frequentemente riconducibili all’intrecciarsi di più fattori: individuali, famigliari, scolastici e sociali.
Un altro aspetto importante è l’attenzione e il riscontro da parte degli insegnanti della difficoltà dei bambini nel mantenere livelli di attenzione sostenuta in classe e il corrispettivo aumento delle diagnosi da deficit di attenzione e iperattività. Imparare a concentrarsi richiede un tempo lungo, dall’infanzia sino all’adolescenza. Per le piattaforme, per gli editori di videogiochi la nostra attenzione è la loro vera moneta, anche le frazioni di secondo sono monetizzate dai social, tutto viene programmato al fine di “tenerci incollati” per più tempo possibile. Suoni, rumori, luci, monetine, pollici, notifiche, ecc., tutto distrae, ma paradossalmente induce a stare attenti e in allerta in modo frammentatodovel’attenzioneallostimoloesterno(esogena/automatica) prevale a scapito dell’attenzione interna (endogena/controllata o volontaria). Non è difficile immaginare come i bambini siano facilmente influenzabili dalla quantità di stimoli proprio perché la capacità di inibizione si sviluppa nel tempo e oggi questo apprendimento rischia di essere un percorso a ostacoli in una realtà che sollecita continue distrazioni.
Nuove sfide
Le ricerche sembrano dunque confermare che l’attività sul cellulareeisocialmediamodellaeorientailmodoincuiil cervello si sviluppa e che l’uso massiccio e precoce dei device influenza il modo di apprendere dei bambini maggiormente verso modalità visive, a scapito delle informazioni uditive, attenzione esogena prevalente, ecc. Qui si colloca, a mio avviso, una nuova sfida per la scuola, che ha il compito di adeguarsi a questi nuovi stili cognitivi di apprendimento svecchiando la didattica tradizionale della lezione frontale e promuovendo una didattica attiva che impatti principalmente sulle abilità visuo-spaziali per motivare i bambini e prolungare tempi d’attenzione, sempre più brevi, non dimenticandosi però di sostenere in
usata nei film e nei videogiochi horror per spaventare lo spettatore con un evento improvviso o inaspettato. Traducibile in italiano come “salto di paura”.
5
Alternativa Pgg. 20-21
7 Un sottogruppo di bambini che passava molto tempo sullo schermo.
6 Centro di Ricerca Tulsa Oklahoma.
Tecnica
parallelo le competenze linguistiche e di letto-scrittura, ovvero coniugare ed equilibrare metodi tradizionali ancora necessari (ad esempio la scrittura manuale ed in corsivo, la lettura su carta) con innovazione digitale. Anche il gioco infantile, prima palestra di apprendimento, viene trasformato dal navigare online. I bambini oggi hanno meno occasioni di giocare liberi e insieme, di sperimentare nella dinamica del gruppo sfumature emotive sia positive che negative, importanti per la crescita psicologica. Credo sia capitato a tutti di sentir dire: “mio figlio si annoia, non sa cosa fare, i bambini non sanno giocare, ecc.”. Nel gioco di gruppo trasferiscono ciò che “vivono” negli online games ma il confronto con i pari li obbliga ad abbandonare con fatica l’egocentrismo connaturato al giocare da soli, con esiti spesso conflittuali e irrisolvibili (proprio perché non abituati a gestire i conflitti nella relazione), è quindi necessario l’intervento dell’adulto per mediare, aiutare nel definire e condividere regole con i pari in “carne e ossa”.Anche la noia, che ha in sé un potenziale positivoperl’infanziaperchéproiettaversonuovescoperte edesperienzedigioco,diventanoianegativainnaturaleche il bambino lamenta quando gli si chiede di disconnettersi, è una noia che si palesa dal sovraccarico di stimoli digitali, che non produce slanci creativi, ma al contrario li soffoca e limita la possibilità di fare e di scoprire potenzialità nel mondo off-line.
I media digitali possiedono caratteristiche tali che possono influenzare negativamente lo sviluppo dei bambini: l’iperstimolazione, la sovrabbondanza e la frammentazione di contenutichespesso,permancatocontrollooscarsaconsapevolezza da parte dei genitori, non sono adeguati all’età sono tutti aspetti che impattano negativamente su competenza di autocontrollo e pianificazione. I rischi dei media digitali si manifestano quando i bambini ne fanno un uso personale, non guidato dall’adulto, con
connessione permanente. Piccoli gamer 8 che praticano troppo precocemente gaming 9 possono, se abbandonati allo schermo, sviluppare un vero e proprio disturbo da videogioco (Internet Gaming Disorder).
È più che mai necessario che servizi educativi e di prevenzione, scuola e famiglia garantiscano accesso sicuro alla retenelrispettodellediversefasidisviluppoattraversouna gradualità che andrebbe costruita insieme attraverso regole condivise, ad esempio arginare il contesto che spinge ad anticipare sempre più l’uso dello smartphone già nel periodo della scuola primaria, ma ancor più semplice sarebbe iniziare a far rispettare la legge che già esiste e vieta l’uso dei social a minori di 14 anni.
In conclusione, l’uso della tecnologia (internet, app, social media), in generale, offre davvero opportunità di crescita e sviluppo; come sempre, è l’uso che se ne fa e non il mezzo in se stesso a definirne il valore, anche - e soprattuttoetico.
Ècompitodituttalacomunitàeducante,vistoilritmoaccelerato della digitalizzazione, identificare modi efficaci per proteggere i bambini, preparandoli al contempo a crescere bene nell'era digitale. L'educazione in primis degli adulti è ciò che plasma lo sviluppo, l'apprendimento e il benessere dei bambini, e deve svolgere un ruolo significativo nell'affrontareleopportunitàeirischidelladigitalizzazione per i bambini piccoli.
Il punto è fornire alfabetizzazione digitale, creare opportunitàdigitalineicontestisocioculturali svantaggiati,fornire contenuti sicuri in ambiente online, e regolamentare con trasparenza le piattaforme. Non è necessario che noi adulti diventiamo tutti geeks 10, dobbiamo però apparecchiare lo schermoperchéilpuntononèdisconnettere,
Acontributi
maconnettere bene!
10 Nel gergo di Internet, persona che possiede un estremo interesse e una spiccata inclinazione per le nuove tecnologie, ovvero smanettone.
8 Persona che si interessa ai video giochi e trascorre diverso tempo giocando.
9 Giocare soprattutto ai videogames on line.
IL DISAGIO PSICHICO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI DOPO LA PANDEMIA
Catia Fornara e Paola Veggiotti
Il cinque maggio scorso l’OMS ha ufficialmente sancito la fine dell’emergenza sanitaria del Covid19. Nel nostro vissuto quotidiano abbiamo anticipato questa data storica accogliendocontrepidazioneesollievo i segnali finalmente e stabilmente positivi, il miglioramento significativo dei datideiricoveriedeidecessi,l’allentarsi delle restrizioni, la riapertura definitivadellescuole,insommailritorno a una normalità che mai come ai tempidelCovidcièsembratatantopreziosaedesiderabile.
Cosa è successo in termini psicologici durante la pandemia? Possiamo dire di averetoccatoconmanoilimitidell’illusoria onnipotenza in cui cerchiamo di vivereognigiorno-almenonoichenon dobbiamo quotidianamente fare i conti con la fame e con la guerra - : corpi invincibili,morterimossa(Lingiardi). Sappiamo che fin dall’antichità l’umanità ha dovuto fare i conti, con strumenti diversi, a pestilenze e piaghe: non pensavamo che avremmo avuto anche noi la nostra Peste e la nostra Spagnola.
Possiamodefinirelapandemiaun’esperienza traumatica perché ci ha colto impreparati: non è la gravità in sé della patologia che abbiamo dovuto affrontare che ne ha determinato la traumaticitàquantolasuapervasività,il fatto che né l’uomo della strada né gli esperti potessero all’inizio prevedere quantoprofondamenteequantoalungo la nostra quotidianità ne sarebbe stata stravolta.Comeinogniesperienzatraumatica c’è un equilibrio individuale tra l’oggettività della minaccia e la sogget-
tivitàdellarisposta. Come dice bene Lingiardi, le reazioni sono state le più diverse, dalla rimozione (il peggio è passato) alla negazione (basta con le restrizioni, mascherine, ecc.); dalle reazioni fobiche alle proiezioni più o meno paranoiche (con la scusa del virus ci vogliono togliere la libertà); dalle reazioni depressive con sentimenti di impotenza e solitudine al vivere l’altro con sospetto (sono cambiatituttiicodicidell’incontrosociale).
Col confinamento, la chiusura delle scuole e dei Servizi Sociosanitari molti genitori si sono sentiti abbandonati a sé stessi e perciò sono stati incapaci di aiutareiproprifigli.
Inoltre,vadettochenontuttelequarantene sono state uguali: ci sono state quarantene più facili con adulti che hanno preservato il lavoro, con relazioni armoniche, con bambini seguiti, e quarantene difficili con problemi economici,lutti,relazioniconflittuali.
Bambini, adolescenti, adulti e anziani hanno vissuto in modo diverso il confinamento e forse i piccoli e gli anziani sonostatiipiùvulnerabili.
In questo articolo intendiamo proporre una riflessione sul disagio psichico dei bambini e degli adolescenti dopo la pandemia, a partire dal significativo aumento della domanda di interventi che gli operatori sociosanitari hanno rilevato in questi ultimi tre anni, riprendendo quanto svolto il 18 maggio u.s. a Gravellona Toce in un corso di formazione promosso dall’Associazione Centri del Vco e condotto dalle due autrici.PaolaVeggiotticonducedapprima una disamina dei dati
epidemiologici quantitativi e qualitativi sul disagio psichico in età evolutiva emersiduranteenelpostpandemiae,in seguito, Catia Fornara presenta alcune riflessioni su come il confinamento, le restrizioni sociali, la chiusura delle scuoleelaDidatticaaDistanzaabbiano impattato sui compiti evolutivi delle diversefasidisviluppo.
Idatiepidemiologici
Lapandemiahageneratoneglioperatori sociosanitari l'esigenza di riflettere sulla crescente richiesta di aiuto da parte delle famiglie di bambini e adolescentiavvenutainquestiultimitreanni. Da un lato tornare alla normalità e lasciareallespallelapandemiaeleconseguenti restrizioni è stato quello che ognunodinoiauspicava,manellostesso tempo è diventata sempre più impellente la necessità di riflettere sui bambini e sugli adolescenti e su quello che hanno dovuto affrontare durante il lockdown.
Per le finalità del corso si è pensato inizialmente di capire cosa fosse successo nellanostrarealtàlavorativaeterritorialeinterminidiaumentodegliaccessiai Servizi di Neuropsichiatria Infantile, incremento delle urgenze, cambiamento dei quadri psicopatologi, oltre a chiederci cosa fosse successo nelle scuole rispetto al numero di abbandoni scolastici,fobiescolariequadridiritiro in seguito alla Pandemia. Per questo abbiamo avviato una collaborazione con l’Ufficio Scolastico della zona e siamoinattesadiquestidati.Poiabbiamo voluto verificare cosa dicesse la letteratura scientifica - sia a livello
Alternativa Pgg. 22-23
Come le conseguenze psicologiche della pandemia siano state su bambini e adolescenti significative e durature
nazionale che internazionale - sugli effetti della Pandemia da un punto di vistapsicologicosuigiovani. Tutte le ricerche scientifiche concordano nel riconoscere che, se la salute mentaledibambinieadolescentieragià un problema prima del Covid in tutto il mondo,laPandemiahaslatentizzatoun malesserecheeragiàinaumento. Si è registrato ed è stato documentato untrendinaumentodellevisitepsichiatriche urgenti prima della pandemia. Con il lockdown si è passati da un rapporto 1:9 di probabilità che in età evolutiva si possa manifestare un disagio mentale, ad un rapporto 1:6. Il lockdownhaamplificatounasituazione giàpreoccupante.

Per molti soggetti con preesistenti difficoltà adattive (anche senza conclamati disturbi psichici o relazionali) la condizione di isolamento, le restrizioni socialiacuisisonoaggiunteproblematiche di natura economica, hanno aumentatoilrischioperlasalutementale. Si parla infatti a questo riguardo di sindemia: bambini e adolescenti mentalmente e socialmente svantaggiati sonorisultatiipiùcolpiti.
La Pandemia ha colto tutti impreparati,
ma ad oggi si conoscono i fattori di rischio che durante il lockdown hanno avuto un impatto importante sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti.Tali fattori possono essere così sintetizzati:
• accessolimitatoallescuole;
• isolamento sociale (molto faticoso pergliadolescenti);
• accessolimitatoaiservizimedici;
• timore e angoscia di contagio e di morte;
• frequenteesposizioneallutto;
• esposizione prolungata alla rete e a Internet;
• genitori impegnati nel lavoro da casa in assenza di supporti esterni (genitori piùpresentimaoccupati);
• sessofemminile.
Rispetto a quanto successo con il lockdown, un articolo della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile) ha provato a fare il punto sull’impatto del COVID-19, in una revisione compiuta l’estate scorsa, che risulta essere in linea con la maggior partedellericercheariguardoechesintetizzaquantoavvenuto:
•aumento di sentimenti di solitudine, rabbia, irritabilità, noia, paura che
hanno avuto un andamento differente nellediversefasidellapandemia;
•aggravamento dei sintomi nei disturbi del comportamento alimentare nei soggettichegiàpresentavanoquestotipodi problematica;
•maggiore vulnerabilità delle femmine interminidiimpattosullasalutementale;
•fasciadietàpiùarischio:iragazzitrai 15ei19anni.
Riguardo a come hanno reagito i bambini e gli adolescenti alla Pandemia si è constatatocheibambinihannorisentito di quello che viene definito “family effect”, ossia lo stress dei bambini è risultato direttamente correlato a quello dei loro genitori. Mentre per i ragazzi e le ragazze più grandi la situazione è risultata più complicata. Infatti, le manovre di isolamento e distanziamento hanno ostacolato la realizzazione di compiti evolutivi adolescenziali, penalizzando attività di socializzazione definitenonessenziali,macheinquesta fascia di età lo sono, perché contribuiscono ai cambiamenti evolutivi etàspecifici e consentono l’emergere di nuove abilità. Quindi il vissuto secondario all’isolamento protratto correla
Acontributi
Immagine di rawpixel.com su Freepik
conunrischiodidepressione,eilsenso disolitudineconvaririschiperlasalute mentale.
La prima ricerca a valenza scientifica condotta in Italia è stata quella dell'AGIA (Autorità garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza). Per realizzare la ricerca sono stati ascoltati oltre 90 esperti tra neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, psicologi, docenti e pedagogisti. I professionisti interpellati, che nel proprio quotidiano hanno lavorato con bambini e adolescenti nella fase pandemica a sostegno delneurosviluppoedellasalutementale,hannosottolineatochelapandemiae lemisureattuateperilsuocontenimento, hanno impattato in maniera considerevole sulla vita dei minori e delle loro famiglie, determinando un sensodiincertezzaedisorientamentoin tuttalapopolazione.
Hanno riferito un aumento di disturbi delcomportamentoalimentare,ideazione suicidaria, autolesionismo, alterazioni del ciclo sonno-veglia e ritirosociale.Inambitoscolasticopoisono stati riscontrati disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione, del linguaggio, disturbidellacondottaedellaregolazioneemotiva.
Ancheinquestaricercasievincechela pandemia ha acuito delle disuguaglianze sociali, economiche e culturali già esistenti e questo è stato un elemento determinantedell'impattosulneurosviluppoesullasalutementale.Iminoridi età inseriti in un sistema di rete sociale e di servizi organizzati, o che hanno beneficiato della vicinanza della famiglia e/o della comunità, hanno potuto attivare risorse e strategie interne, mentre quelli chi vivevano condizioni di fragilità, oppure in fase di transizione scolastica,comepreadolescentieadolescenti, hanno subìto un aggravamento dei disagi o disturbi preesistenti e in molti casi anche l'insorgere di nuove problematiche.
Da tutti i dati raccolti si evince che durante la pandemia nove milioni di bambini e adolescenti si sono trovati espostialloscenarioemergenzialeealle misurerestrittive.
L’effettodellaPandemiasiinseriscenel contesto del cambiamento della salute mentaledeibambiniedegliadolescenti eglieffettiamedio-lungoterminesono ancora sconosciuti. Inoltre, l’impatto
non sarà uguale per tutti e saranno necessarie soluzioni individualizzate e flessibilità nelle proposte di aiuto. L’aspetto interessante però è che alcuni fattori sono stati riconosciuti come protettivi della salute mentale di bambini e adolescenti in caso di emergenza sanitaria. Tali fattori riguardano la possibilitàdi:
• garantireunaroutine;
• mantenere una comunicazione familiareefficace;
• consentirelasocialità;
• avere a disposizione un appropriato tempoliberoedigioco.
Ibambiniinetàprescolareeil lockdown
Passiamo ora a esaminare le conseguenze psicologiche del confinamento suibambiniinetàprescolare. Sappiamo che i bambini in questa fase dellosvilupposonoallepreseconl’inizio della socialità fuori dalla famiglia, con l’entrata nel mondo dei pari e la relazione con altri adulti significativi come gli insegnanti della scuola dell’infanzia.
A livello intrapsichico il bambino affrontacompitievolutivimoltoimportanti come l’elaborazione dell’onnipotenzainfantilegraziealconfronto con le regole del vivere sociale (elaborare la rappresentazione interna dell’essere uno tra altri pari e non più solamente uno al centro dell’attenzione di vari adulti) e l’acquisizione di una importantetappadelpercorsodiseparazione-individuazione.
Lo sviluppo sociale è un processo interattivo e dinamico che comincia nel primoannodivitaecheapartiredaitre anni comporta un aumento quantitativo e qualitativo delle relazioni: da questa etàicompagnidigiocodiventanosempre più importanti. La qualità delle relazioni cambia: a partire da rapporti essenzialmente strumentali basati sulla soddisfazione dei bisogni, il bambino sviluppa una certa capacità di empatia, di interesse e sensibilità per i bisogni dell’altro.
Albisognodicontattoediattenzionesi affiancano bisogni di approvazione, di aiuto, di ammirazione; aumentano le aspettative e i desideri e si affinano le tecniche usate per soddisfarli: dal piagnucolare allo spadroneggiare al sedurre (Flapan e Neubauer). Si realiz-
zainsommaunenormearricchimentoe affinamento delle sfumature della vita emotivadelbambino.
Sipuòipotizzarechel’isolamentonella famiglia dovuto al lockdown (niente contatti coi pari, niente scuola dell’infanzia, niente parco giochi, nientecompleanni,nientesportdigruppo… per quasi due anni) abbia comportato un ritardo e/o una distorsione dei processi caratteristici di questa fase di sviluppo: nell’elaborazione dell’onnipotenza infantile, nei processi di separazione e individuazione e nella maturazione qualitativa delle relazioni; col rischio di protrarre nel tempo rapporti più superficiali e transitori o rapporti iper dipendenti di aggrappamento.
L’impossibilità di giochi fisici coi pari, a causa della chiusura delle scuole d’infanziaedeiparcogiochi,haprivato ipiùpiccolidiun’esperienzasensoriale indispensabile e ha impoverito la “dieta” del cervello emotivo (Marcella Mauro,CentroNeuropsicologiaHumanitas).
Non sempre per le famiglie è stato possibile compensare l’assenza di giochi all’apertocoipariconunpo’diesercizi quotidiani:maleneuroscienzecihanno mostratochequandoilbambinoèsotto pressione il cervello produce picchi di cortisolo (ormone dello stress) e di adrenalina. Ciò aumenta l’ansia e la disregolazione: quindi le abilità funzionali e di regolazione sociale diminuiscono.
L’eserciziofisicoriduceilivellidicortisolo e di adrenalina aumentando le endorfinecomeladopamina:ciòaiutaa migliorare la regolazione emotiva e a concentrarsi. Inoltre, si è stravolta l’acquisizione delle routine che per il bambino dai tre ai cinque anni ha una funzione cognitiva nell’organizzazione degli schemi spazio-temporali e anche unafunzionediregolazioneemotiva. Anche la mancanza di caregiver significativi come i nonni ha destabilizzato le routine.
I piccoli sono più sensibili agli stati emotividegliadultiespessosisonotrovati a sintonizzarsi con il loro sentimentodiincertezza,diangoscia,di minaccia (per la salute, per la perdita dellavoro)econivissutidilutto. Inquestafaseilcervelloèpiùplasticoe glielevatilivellidistressel’isolamento
Alternativa Pgg. 24-25
possono aver agito sullo sviluppo psichicoinmodopermanente. Infine, dobbiamo anche considerare quanto, tra i quattro e i sette anni, la comprensione del bambino di questa etàsiapermeatadalpensieromagicoei bambini possano fare delle inferenze nonreali:peresempiopensareinmodo onnipotentechelamalattiasialaconseguenza di particolari pensieri o comportamenti (per esempio sia la punizione di qualche loro condotta riprovevole).
Quanti genitori sono stati in grado di spiegareaibambini,conparoleadattee senza omissioni o bugie, cos’era il Covideperchébisognavaadottarecerte precauzioni o accettare certe limitazioni? E poi di ascoltare cosa avevano capitoediaiutarliarielaborare?
A questo riguardo è importante tenere presente che la comunicazione non deveesseresolofattualemaancheemotiva: parliamo anche di come ci sentiamo, altrimenti i bambini possono restareinansiaperlostatoemotivoche percepiscono negli adulti che li circondano.
Bambiniepreadolescenti
Anche i compiti evolutivi dei bambini dai sei anni in su e dei preadolescenti (consolidamento della capacità di stare separato dall’ambiente familiare, inizio della scolarizzazione, arricchimento della struttura dell’Io), processi che avvengono gradualmente e nell’interazione con l’ambiente, possono essere stati ritardati dalla riduzione significativadelleinterazionicoicoetanei,acausa delle minori occasioni di confronto, competizione e identificazione, con l’impoverimentodeivissutiemotivi.
Lamancanzadiunrapportocontinuativo con altri adulti significativi quali gli insegnanti ha comportato il persistere delle dinamiche familiari più infantilizzanti.
Inoltre, sappiamo quanto sia vitale e imprescindibile per i processi di identificazione e per il debutto sessuale il contatto con i coetanei nei preadolescentiallepreseconlapubertà.
Le relazioni senza corpo e l’abusodellarete
Parleremo ora del ricorso alla rete nel periododellapandemiapercompensare le limitazioni sociali poste dal confina-
mento e dalla chiusura delle scuole e dell’impatto della DAD sui processi di apprendimento.
Durante i periodi di lockdown c’è stata una vera e propria offerta di spazi e tempidisocializzazioneonlinecoicoetanei. Ciò è stato necessario e positivo però ha legittimato in modo irreversibile un processo già in atto che il gruppo di ricerca del Minotauro di Milano ha definito“lerelazionisenzacorpo”,cioè la tendenza sempre più pervasiva a vivere in modo mediato la comunicazioneeleemozioni,unprocessocheva capitoestudiato.
Finoall’iniziodell’eradiinternetsitornava da soli da scuola o si giocava in cortile,c’eranospazidirelazionirealial di fuori del controllo degli adulti: adessocisonolepiazzevirtuali.
L’immagine ha assunto un’importanza sempre più preponderante: i bambini sono fotografati, ripresi, immortalati e socializzatidallanascita.
Nei ragazzini (e non solo!) si osserva unaricercadimodellidiidentificazione e comportamentali nei coetanei più popolari sulla rete, negli influencer, negli youtuber e nei personaggi più esposti a scapito dei processi di identificazione negli adulti (perdita di credibilitàeautorevolezza).
L’incrementoesponenzialedell’utilizzo della rete durante la pandemia ha dato ulteriore legittimazione alla società dell’immagine, della popolarità, della competizione, del successo, della caduta del confine tra ciò che è intimo/ privatoeciòcheèpubblico.
LafamigerataDAD
Un altro elemento di riflessione è l’impatto della DAD sull’inizio della scolarizzazione: gli studi parlano di un ritardo dell’apprendimento circa del 35% - come se le vacanze scolastiche andassero da giugno a dicembre! - non compensato ancora a metà 2022 (analisisu42studicondottiin15Paesitracui l’Italia,condottadall’Universitàfrancese Sciences Po e pubblicato su Nature Human Behaviour).
In seguito, tre altri studi hanno confermato questi risultati: McKinsey, Banca Mondiale-Unesco e Università di Harvardaffermanochea10anniil70%dei bambini dei Paesi a basso e medio reddito non era in grado di leggere e comprendere un semplice testo scritto
(undatodrammaticoinséchecomporta anche in conseguenza un rischio di decrescitadelPilmondiale).
Bisogna tenere presente non solo la DAD quando le scuole erano chiuse durante i due lockdown, ma anche il sistema ibrido (metà classe in DAD e metà in presenza) e le successive quarantenepericasidicontagio:èstato coinvoltoil95%dellapopolazionescolasticamondialepercircadueanni.
A giugno 2022, McKinsey rileva un aumento dell’11,6% dei Neet rispetto all’annoprecedente(ragazzitra15e24 anni che non studiano e non lavorano; l’Italia è al primo posto in Europa col 20,7%).
Secondo Tullio de Mauro in Italia la scuola di ogni ordine e grado si regge ancorasul“paradigmadellaSantissima Trinità”: spiegazione con lezione frontale in classe/studio a casa sui libri/ verifica.
LaDADhaevidenziatol’incapacitàdel nostro sistema scolastico a uscire dallo schemadellalezionefrontale:gliallievi si sono dovuti adattare a un ascolto più difficoltosoperchéprivodelleinterazioni con l’insegnante e con gli altri partecipanti alla lezione (Giacomo Stella).
Una lezione frontale in video ha qualche vantaggio se associata alla presentazione di immagini che sostengono l’attenzione, altrimenti sollecita solo l’attenzione uditiva e richiede un carico di memoria di lavoro notevole; sappiamo che queste funzioni sono meno efficienti nei bambini di scuola primaria.
Le famiglie sono state investite di un enorme carico: i bambini, percependo la DAD come poco significativa, avevano bisogno di un continuo rinforzo e dovevanoessereaffiancati.
Inoltre, una ricerca del Censis a fine 2020 ha segnalato che a causa del digital divide (mix di carenza di strumenti, di connettività e di competenze) l’8% degli studenti - che in Italia sono circa ottomilioni-nonèstatoraggiuntodalla DAD e il 18% solo parzialmente. Sono ben2.080.000ragazzi!
Secondo Giacomo Stella, inoltre, l’apprendimento in DAD è favorito nei bambini con buone competenze tecnologiche, con autonomia nello studio, con capacità di autocontrollo e di organizzazione dello studio: tutte doti
Acontributi
carenti in molti bambini BES o con DSAoconminoricapacitàattentive(si èpoicorsiairipari,dallasecondaondata Covid, con la lezione in presenza per questibambini).
Si è così ottenuto un risultato paradossale:lamaggiorpartedeibambiniedei ragazzi hanno manifestato nostalgia della scuola, cioè del contatto umano coninsegnantiecompagni.Nonèmancata l’aula ma la relazione con compagnieinsegnanti.
In conclusione: non si può introdurre uno strumento così nuovo e diverso mantenendo le stesse metodologie e gli stessicontenuti.
I compiti evolutivi dell’adolescente e l’impatto delconfinamento
Prenderemo ora in considerazione i compitievolutidell’adolescenteecome la pandemia può aver influito su questa fasciad’età.
L’adolescenteèallepresecontantietali cambiamentifisici,socialieintrapsichici che si parla di questo processo come diunaveraepropria“secondanascita”, che offre all’individuo l’occasione per rimaneggiareerisolvereancheiproblemirimastiinsolutinell’infanzia. Questi compiti evolutivi riguardano la mentalizzazione del corpo (Charmet), cioè l’integrare nella rappresentazione di Sé la percezione del proprio corpo come generativo, sessualizzato, pronto per il debutto sessuale e la sperimentazioneconl’altro/a.
La mentalizzazione riguarda però anche la percezione del proprio corpo comemortale:l’adolescenzanonèl’età dell’onnipotenza, ma della scoperta della finitezza e della morte (“anch’io possomorire”).
Alcuni giovani si limitano a mentalizzarla altri devono sperimentarla attivamenteequestocispiegacomesia importante in questa fase della crescita l’esperienzadellapaurachevienespesso attivamente ricercata soprattutto dai maschi: “sono cresciuto, se ho paura non corro più tra le braccia della mamma”.Inoltre,cifacapirequantosia importante tra i giovani comunicare l’esperienza di sfida al pericolo, di prova dei limiti, l’essere popolare proprioperchésisocializzaquesta“prova” attraversoi selfie estremi.
Altri compiti evolutivi fase-specifici
sono la nascita sociale e il processo separativo dalla “nicchia psicologica primaria” (Lancini) – cioè, lo scivolamento in secondo piano delle relazioni affettiveconifamiliariafavorediquelle coi coetanei - e la sperimentazione e lacostruzionedellarelazioneamorosa.
Per quanto riguarda questo ultimo aspettoosserviamoche,mentrenelpassato la relazione amorosa era improntata a valori romantici, oggi si modellapiùsuvalorinarcisistici.
Lerelazioninarcisistichechedominano gran parte delle interazioni, esprimono un grande bisogno di essere, se non amato, almeno ammirato, dotato di fan che apprezzano e confermano narcisisticamente il modo di essere dell’individuo.
Perciò la scelta del partner non è più caratterizzata dalla cura dell’altro, ma dalla cura di sé stessi, dal fare in modo che l’oggetto curi il Sé del soggetto, lo sostengaeconferminellesuescelte. Quando questa modalità è reciproca diventa un rispecchiamento narcisistico, la riuscita dell’altro (sportiva, scolastica,professionale,diqualitàestetica)diventaunaconfermanarcisistica.
La fragilità narcisistica è ferita quando il partner non dà le conferme e l’ammirazione necessari: e ciò provoca la vendettaelarabbianarcisistica.
Per esempio, lo stalker ha smesso di amare, ma è attaccatissimo all’oggetto perché attraverso la vendetta cura la feritanarcisistica.
In questo quadro il confinamento può avere incentivato gli aspetti narcisistici che caratterizzano attualmente la relazione amorosa, attraverso la valorizzazione dell’immagine che è tanto peculiare nella comunicazione attraverso la rete (divenuta preponderante durante i lockdown, come abbiamo visto) e può aver favorito la diminuzionedell’interesseperirapporti sessuali che caratterizzano gli adolescentidioggi.
C’è stato un involontario incentivo alle relazioni senza il corpo e al declino dellacorporeità.
Loabbiamovistoanchenellelimitazioni poste alla comunicazione tattile e visiva dal distanziamento e dall’uso dellemascherine:unavoltaeraproibito per legge coprirsi il volto, durante la pandemia per un gran periodo è stato prescrittodallalegge.
Malaprivazionedelsorrisocomplicale identificazioni,imovimentiempatici,il rispecchiamento(anchesehaincentivatol’espressivitàattraversolosguardo). Inoltre, il tentativo di mantenere un minimodisocialitàperifiglihaindotto molti genitori ad accogliere in casa nei periodi più duri delle quarantene il/la partner dei figli: il debutto sessuale spesso è avvenuto “in famiglia”, col tacitoassensodeigenitori.
Ciò che dovrebbe simbolicamente segnareladefinitivaemancipazionedel corpo pubere e del mondo emotivo dal primato materno è spesso avvenuto in unasituazioneinfantilizzante,colfantasmadelgenitorenellastanzaaccanto.
Conclusioni
Abbiamo cercato di argomentare come le conseguenze psicologiche della pandemia siano state su bambini e adolescenti significative e durature, portandoinambitoclinicoaunaumento del disagio psichico, a una modifica deiquadrisintomatologicieaunimportante incremento della domanda di aiuto; e come le limitazioni alla socializzazione poste dal confinamento e l’utilizzo massiccio della rete e della scolarizzazione tramite la DAD possanoaverdeterminatopiùingeneraleuna distorsione di alcuni aspetti dello sviluppo e dei compiti evolutivi fasespecifici. Questi processi e la loro evoluzione richiedono una riflessione da parte degli operatori e dei decisori che dovranno implementare le risorse sociosanitarie necessarie per farvi fronte.
Bibliografia
Lingiardi V., L’anno del pipistrello, in Bambini, adolescenti e Covid-19, acura di Vicari S. e Di Vara S., Erickson Ed., Trento,2021.
StellaG., I bambini e la scuola, Trento, EricksonEd.,Trento,2021.
Ianes D. Bellacicco R., Non uno di meno: bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali alla prova del Covid-19, EricksonEd.,Trento,2021.
Flapan D. Neubauer P., La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia, BollatiBoringhieri,Torino,1981.
Lancini M. (a cura di), Il ritiro sociale negli adolescenti: la solitudine di una generazione iperconnessa, CortinaEd., Milano, 2019.
Alternativa Pgg. 26-27
CHI C’È ALLO SPORTELLO?
Sportello giovani, informazione, orientamento, formazione per un mondo, non solo giovanile, a disagio.
Diego Brignoli
PREN DERE ESEM PIO DA...
Disagio Giovanile. Difficile trovare una corretta definizione del termine “disagio”; circoscriverlo al mondo giovanile comportaulterioridifficoltà:quantisonoigiovani? chi sono? fino a che età lo si è? Una situazione complessa e confusa che complica oltremodo la costruzione di politiche in grado di affrontare il tema.
Le politiche italiane per i giovani sono disciplinate dalla legislazione concorrente: il potere legislativo sulla materia delle politiche giovanilièattribuitotantoalGovernocentrale quanto alle Regioni e alle Provincie autonome.
Le questioni relative ai giovani si basano pertanto su un approccio dal basso verso l'alto.Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, la Repubblicatutelaigiovani“favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Sono poi le Regioni e le Province Autonome a definire le norme che promuovano misure a favore dei giovani, in particolare nei campi di informazione, formazione, orientamento. Temi questi ultimi nei confronti dei quali l’attuale realtà rende sempre più urgente particolare attenzione. Prendendo ad esempio quello che è l’inserimento nel mercato del lavoro, con ogni probabilità il principale strumento di integrazione sociale, i giovani sono oggi a tutti gli effettiisoggettipiùfragili:inItaliaicosiddetti NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, si attestano sul 15% nella fascia 15-24 anni e superano il 25% nella fascia 25-34. Un poco invidiabile primato europeo.
Una rapida e superficiale scorsa delle varie leggi regionali sottolinea sostanziali differenze tra le varie legislazioni regionali.
La Puglia con la Legge Regionale 14/2020
“Misure regionali in favore degli adolescenti” individua nei giovani compresi tra i 14 e i 19 anni i destinatari degli interventi previsti.
Il Friuli Venezia Giulia indirizza la Legge regionale 5/2012 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità” ai giovani nella fascia di età 1435 anni.
In Piemonte la Legge Regionale 6/2019
“Nuovenormeinmateriadipolitichegiovani-
li”, indirizzata alla fascia di età 15-29 anni, mira a sviluppare politiche giovanili in coordinamento con i Comuni e le organizzazioni giovanili.
La Toscana con la legge regionale 81/2020
“Promozione delle politiche giovanili regionali”, i cui destinatari sono giovani dai 16 ai 40 anni, consolida la precedente esperienza
“Giovanisì” per l’autonomia dei giovani, un sistemadiopportunitàstrutturatonellemacroaree di tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, studio e formazione, lavoro.
Tale così marcata diversità di approccio e indirizzo è la premessa per servizi che sul territorio nazionale sono estesi a macchia di leopardo, diversissimi nell’attuazione e, ovviamente, nei risultati. Limitando lo sguardo al principale e più diffuso servizio, lo “sportello giovani” che rappresenta il primo accesso ai servizi, possiamo imbatterci in un semplice e banale ufficio informazioni, poco frequentato, male organizzato e sostanzialmente di scarsa utilità oppure in un centro nodale in cui a risaltare sono le esperienze di connessione, coinvolgimento e collaborazione con il tessuto territoriale. Capita così che a Torino le cose vadano così così (bene in alcune zone, male in altre), piuttosto bene a Ivrea e Novara, bene (c’era da aspettarselo) a Modena e Bologna, non male inTrentino. Ma si tratta di opinioni.
Afare talvolta la differenza non è tanto l’indirizzo dato dalle leggi, già di per sé indicativo, quanto dal personale, in particolare il dirigente o funzionario incaricato, dalla sua personale voglia di “sbattersi”, di presidiare l’ufficio piuttosto che impegnarsi sul territorio, scovando, interessando, coinvolgendo esperienze, agenzie educative formali e non, enti pubblici, terzo settore, che quasi certamente esistono dappertutto. Una figura che molto si avvicina a quella di “manager di comunità” richiamata nell’interessante dibattito scaturito dal Forum. La soluzione sta con buona probabilità nel tessuto, nel territorio, nellepotenzialitàchesaesprimeremaoccorre qualcuno che tenga le fila, presidi l’intero iter, mantenga contatti e connessioni.
A cosa avviene in casa d’altri
NON PREN DERE ESEM PIO DA...
Questa Sezione della rivista, denominata “Cosa avviene in casa d’altri” con le sue due finestre (“Prendere esempio da…” e “Non prendere esempio da…”) segnala le buone pratiche e le pessime abitudini presenti nel vasto e composito campo del sociale.
Ciò perché noi della Redazione pensiamo che socializzare, senza intenti celebrativi o polemici, questi aspetti sia un servizio utile a migliorare il lavoro di tutti.
Fino a oggi, questo compito è stato assolto dai redattori, ma, più di noi, sono i lettori che vivono le diverse realtà di quel vasto campo, che meglio vedono ciò che di buono e di meno buono c’è.
Apriamo, perciò, questa Sezione con le sue due finestre a voi lettori, chiedendovi di farvi testimoni, di proporre voi alla Redazione ciò che vi sembra meritorio di essere reso noto, nella forma
• di breve articolo (max 3.000 caratteri o 600 parole) o
• di segnalazione circostanziata, sempre con chiara indicazione e recapito del proponente, a questo indirizzo rivista@alternativa-a.it
Pgg. 28-29 Alternativa
Vi aspettiamo, la Redazione
PRO GET TI
LUNGO I BORDI COME I GIOVANI PROGETTANO PER NON ESSERE PROGETTATI
uando si tratta di politiche giovanili, lo scenario è spesso ripetitivo. L’approccio con cui si affrontano le questioni che riguardano la comunità dei giovani è lo stesso che potrebbe avere nei confronti di un orticello (per fare un paragone un po’bizzarro) una persona priva di spiccate doti di giardinaggio. Se una pianta appassisce, la prima risposta che può venire in mente a chi di piante sa poco è “darle dell’acqua”. La quale è senza dubbio una soluzione logica e tuttavia, in ultima analisi, parziale. Parziale perché non considera tutta una serie di aspetti che riguardano il benessere di una pianta: l’esposizione alla luce, lo spazio di terra in cui mettereradici,ilconcimedautilizzare.Parziale perché non tiene conto della complessità di un orto. Parziale perché, spesso, nasce dalla convinzione un po’ingenua di avere il pollice verde. Tutto sarebbe più facile se le piantine potesseroparlareedirciconlalorovocediche cosa hanno davvero bisogno, o se, addirittura, potessero da sole risolvere le loro difficoltà. Ma allora è evidente che chi, per sua fortuna, sioccupadipolitichegiovanilienondipiante, gode di un considerevole vantaggio: i giovani hanno bocche con cui manifestare una mancanza, menti con cui ideare soluzioni, corpi con i quali metterle in atto.
Il progetto “Lungo i bordi” è la dimostrazione che fare politiche giovanili in maniera diversa sipuòesideve.Questoperchépossiedelarara caratteristica di nascere da un’esplicita richiesta dei giovani del territorio e di svilupparsi sulla base delle risposte che loro stessi hanno
dato a quell’esigenza.
Tuttoinizianeldicembre2020conun’iniziativa di Associazione 21 Marzo, la principale associazionegiovaniledelterritoriodelVerbano, che è animata da un gruppo di circa 50 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 35 anni e che da piùdi10annigestisceilKantierediPossaccio, lo Spazio Giovani della Città di Verbania. L’Associazione aveva proposto ai giovani un questionario, nel quale era richiesto di esprimere quali servizi avrebbero voluto trovare proprio all’interno del Kantiere. Il riscontro era stato netto e inaspettato: cinque ragazzi su dieci avevano chiesto che si aprisse uno sportello psicologico per adolescenti.
Le idee per una possibile risposta a questa esigenza cominciano a farsi più chiare durante la pandemia, quando - pur tra le ombre del momento - si fanno più stretti i rapporti tra 21 Marzo e gli altri attori del territorio che si occupano di politiche giovanili e di benessere psicologico e sociale degli adolescenti: il ComunediVerbania,proprietariodelloSpazio Giovani, il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, ente gestore delle politiche sociali ed educative sul territorio, le cooperative impegnate in educazione e supporto psicologico come La Bitta e Universiis, fino adASLVCO con la Neuropsichiatria infantile e il consultorio familiare. È grazie alla costruzione di questa rete reale, e non di forma, che dopo un periodo di start up sostenuto dal Fondo Povertà di Fondazione Comunitaria VCO nasce il progetto Lungo i Bordi, candidato, a giugno 2022,albando“Attenta-mente”diFondazione
Arturo Palmeri e Matilde Zanni, vicepresidente e progettista sociale di 21 Marzo APS
Q
che la vita funzionasse così, che bastava strappare lungo i bordi, piano piano, seguire la linea tratteggiata di ciò a cui eravamo destinati e tutto avrebbe preso la forma che doveva avere. Perché c’avevamo diciassette anni e tutto il tempo del mondo. Invece sotto gli occhi c’abbiamo solo ‘ste cartacce senza senso, che sono proprio distanti dalla forma che avevamo pensato”.
Strappare lungo i bordi - Zerocalcare
Cariplo, dedicato al benessere psicologico e sociale degli adolescenti. Per costruire l’idea progettuale, la rete si basa nuovamente su una indagine rivolta ai giovani del territorio, che raccoglieinmenodiunmeseibisogni e le opinioni di 350 ragazzi e ragazze dai 13 ai 24 anni. Il 52,5% degli intervistati manifesta la necessità di un servizio di ascolto psicologico, a frontediunageneralepercezionediscarsa accessibilitàdeiservizidisupportogià presenti. Tra questi, il 55,4% preferirebbe un servizio pubblico mentre il 23,7% non potrebbe permettersi altrimenti. L’82,5% vorrebbe che questo servizio prendesse luogo in un ambiente ibrido e informale, come lo Spazio Giovani della città, che abbia al suo interno spazi e occasioni di aggregazione e di comunità che siano antidoto all’ansia e al senso di solitudine ampiamente rilevati dai risultati dell’indagine.
Dunque il quadro è chiaro: nel nostro territorio è presente una grande richiesta di un servizio di ascolto e supporto psicologico,ilqualenonèalmomento adeguatamente accessibile, che dev’esserepubblicoechedevetrovarsi in un ambiente confortevole che non stigmatizzi i suoi fruitori ma li metta a proprio agio senza farli sentire giudicati.
È sulla base di questi risultati che
prende forma il progetto “Lungo i bordi”, che si pone come obiettivo quello di fornire una risposta concreta e accessibile al bisogno di un servizio di supporto educativo, psicologico e di socialità; un servizio flessibile e innovativo,dedicatoagliadolescentie conosciuto, che non si limiti alla fascia giovanile ma che coinvolga anche le famiglie dei ragazzi che ne usufruiscono.
Per concretizzare questi propositi, viene realizzato il progetto Officine Giovani, promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano e da cooperativa Universiis con i Comuni di Verbania e Ornavasso. Officine Giovanièunarealtàdiaccompagnamento educativo e di condivisione della quotidianità, che oggi coinvolge circa quaranta giovani dai quattordici ai diciassette anni, provenienti da situazioni di fragilità socio-economica. Il progetto prende luogo presso l’oratorio della Parrocchia di Ornavasso e a Verbania all’interno del Kantiere, ed è gestito da cinque educatrici professionali che garantiscono quindici ore a settimana di apertura del servizio in ognispazio.LeOfficinepermettonoai ragazzi e alle ragazze di trovare un ambiente che apra loro un’alternativa a quella solitudine sociale che la nostra provincia fa spesso fatica a scongiurare. Sono ormai un punto di
riferimento per chi le frequenta: sono occasione per stringere legami e capire cosa significhi sentirsi parte di una comunità che si prende cura dei suoi membri e di cui, al contempo, prendersi cura. C’è chi porta i compiti da fare arrivando direttamente da scuola, chi viene a giocare a carte, chi a fare merenda o a discutere di tematiche sorte più o meno spontaneamente. E a tutti è chiaro che è possibile arrivare e condividere pensieri, emozioni, esperienze intime, difficoltà a casa, a scuola, con il proprio gruppo di coetanei.
Le Officine sono un esempio di politica giovanile che non si limita a creare unnuovoservizioeadareunarisposta concreta a un disagio sociale. Sono anche in grado di dare lavoro a giovani educatrici che, dopo un percorso di studi inevitabilmente lontano dalla provincia, tornano nel loro territorio e in quegli stessi ambienti che hanno accolto la loro adolescenza, per mantenerli vivi e allo stesso tempo per continuare a viverli. Ma questa volta col compito di accogliere “nuove adolescenze”, per dare loro vedute sul futuroinunaprovinciachespessonon lascia altra alternativa che allontanarsi (per chi può permetterselo), o restare immobile (per chi invece non ne è in grado).
Ma per avere davvero un impatto
Pgg. 30-31 Alternativa
“E allora noi andavamo lenti perché pensavamo
positivo sulla salute mentale degli adolescenti non è possibile ignorare il contesto familiare. La famiglia si trova spaesata o impreparata a gestire consapevolmente una condizione di fragilità e ne è, in alcuni casi, la fonte stessa.
È per questo che, in contemporanea alle Officine, si sviluppa anche un'azionedisupportoalbenesserepsicologico dei genitori presso Spazio Sant’Anna. Qui Cooperativa La Bitta promuove un percorso di counseling, mediazione e rinforzo delle capacità genitoriali, che fornisce sostegno alla famiglia nel suo complesso e garantisce la creazione di ambienti familiari più accoglienti e aperti nei confronti dellenecessitàpsicologichedegliadolescenti.
L’ultimoimportantepassochecompie il progetto Lungo i bordi è l’apertura diunosportellodiascoltopsicologico, che partirà a settembre 2023 e sarà attivo 15 ore a settimana. Sono due gli aspettichelorendonounarealtàrarae coerente coi bisogni degli adolescenti. Ilprimoèchesaràunserviziogratuito e accessibile a chiunque, in un’epoca in cui il benessere psicologico vive strattonato fra due estremi: da un lato la forte rivendicazione da parte dei giovani del nostro Paese - che sono la prima generazione a riconoscerne la centralità in una “società della prestazione” che discrimina e abbandona; dall’altro la spaventosa carenza di servizi accessibili, che rendono, come in innumerevoli altri casi, il diritto alla salute un privilegio di pochi. Il secondo aspetto è che lo sportello aprirà
all’interno dello Spazio Giovani Il Kantiere, che garantisce un ambiente informale accogliente, che non stigmatizza il tema della salute mentale. Si tratta inoltre di un contesto che da anni ospita attività che nascono dai giovani e si rivolgono ai giovani della provincia e che ha fatto fiorire al suo interno una vera e propria comunità, che può facilmente trasformarsi in un punto di riferimento per chiunque decida di intraprendere qui un percorso di supporto.
Dunque, i problemi ci sono. Le soluzioni anche. E la verità è una soltanto: fare politiche giovanili significa mettere al centro i giovani non come campioni da laboratorio ma come chimici a cui lasciare spazio di azione. Ma la storia si ripete, e ai giovani è sempre riservata la parte dei bamboccioni a cui concedere qualche contentinooppurequelladeisognatori instancabili rinchiusi nelle proprie convinzioni. La risposta a questa retorica polverosa è quella che dà il progetto Lungo i bordi: i giovani non sono bamboccioni né sognatori. Sono soggetti politici attivi in grado di riconoscere i propri bisogni, e capaci, a partire da essi, di fornire risposte concrete, ambiziose ma plausibili, che vadano davvero incontro alle loro esigenze. E così la vita può veramente cambiare… “Sto pensando di ricominciare la scuola. Magari per settembre riesco a preparare gli esami peressereammessoallaterzasuperiore per fare il cuoco”, dice F. delle Officine Spazio Giovani, che ha 18
anni e al momento lavora. “C’era un ragazzo nero stamattina in treno. Ascoltava della brutta musica. Dei ragazzi hanno cominciato a sfotterlo e lo hanno rinchiuso nel bagno. Sono intervenuto, l’ho aiutato ad uscire e l’hofattosedereconnoi”,raccontaB., 17 anni. “Nella mia vita voglio poter fare qualcosa, voglio realizzarmi”, “Qui mi sento a casa, posso avere degli amici” dice invece E., 16 anni, che ha abbandonato più volte la scuola.
È chiaro: per avere davvero un’influenza con le politiche giovanili bisogna fare uno sforzo di onestà intellettuale e smettere di considerare i problemi dei giovani come quelli di un’entità astratta e passiva di cui si pensa di sapere ogni cosa. E smettere di considerare un disagio giovanile come qualcosa di diverso e avulso da qualunque altro disagio sociale. Perché ogni problema sociale corrisponde a una responsabilità sociale.Eogniresponsabilitàsocialeè la somma di responsabilità individuali che non hanno età. Certo sono diverse tra loro: la responsabilità di chi ha vent’anni non è la stessa di chi ne ha cinquanta.Maentrambesonoerimangono pur sempre responsabilità a cui non è concesso sottrarsi, responsabilità di cui bisogna prendersi carico insieme, senza distinzione. Perché a questo mondo non c’è chi è nato giardiniereechiènatopiantinadiunorto.
BAMBINI E ADOLESCENTI AL CENTRO
Elisabetta Sfondrini
Il Centro per la Famiglia, da sempre afiancodellefamigliedelterritorio, vede una sempre crescente partecipazione a progetti e servizi che coinvolgono le fasce d’età dell’infanzia e dell’adolescenza.
Lungo i bordi
Il progetto Lungo i Bordi si è sviluppato in coda ad un altro progettoInsieme - e rappresenta la sua naturale prosecuzione in termini di obiettivi ed attività. È nato in seguito al riscontro, da parte degli operatori dei servizi sanitari,socioassistenziali,delmondo cooperativo ed associazionistico, dell’impatto negativo della pandemia sulla vita delle persone, che ha fatto emergere problematiche estremamente rilevanti legate al malessere psicologico della fascia degli adolescenti e alla loro necessità di socializzazione e di contrasto alla diffusa povertà educativa.
Il progetto mira ad incrementare la capacità di risposta territoriale ai bisogni di supporto psicologico degli adolescenti (fascia 13-18 anni), attraverso una strategia di rete condivisa con i servizi pubblici già attivi. Nello specifico, il Centro per la Famiglia mette a disposizione psicologi e mediatori familiari e offre percorsi di counseling, mediazione e rinforzo delle capacità genitoriali per le famiglie dei minori presi in carico negli altri servizi della rete, fornendo un sostegno e un supporto non solo al minore ma alla famiglia nel suo complesso e garantendo in questo modo la creazione di ambienti familiari più
accoglienti e aperti nei confronti delle necessità e delle situazioni psicologiche degli adolescenti.
Il progetto è particolarmente interessante e funzionale perché ha come presupposto il consolidamento della rete dei soggetti partner per il coordinamento e l’invio dei casi tra gli attori che si occupano del benessere psicologico degli adolescenti, offrendo una risposta diversificata e specifica a seconda delle esigenze e dei bisogni rilevati in ogni singola situazione accolta.
La merenda diArchimede
Continua a Domodossola e riprenderà anche sul territorio di Verbania, la Merenda di Archimede, un servizio di doposcuola specializzato voluto dagli operatori del Centro per la Famiglia, pensatocomeserviziodisupportopsicosociale e di promozione culturale della Cooperativa La Bitta di Domodossola.
Il progetto è rivolto a studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) e a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche dovute a carenti capacità organizzative, insicurezzaoscarsamotivazioneallostudio. La fascia d’età a cui si rivolge il servizio è molto ampia, dai 6 ai 18 anni. L’obiettivo è massimizzare le potenzialità dei ragazzi, promuovendo una maggiore competenza nell’approccio allostudio,aiutandoliatrovarelestrategie di apprendimento che possano meglio rispondere alle esigenze individuali e proponendo strumenti utili a compensare le aree problematiche.

Il servizio è reso possibile dalla partecipazionediinsegnanti,tuttivolontari, e da tirocinanti, supervisionati da psicologi esperti nel supporto didattico ai minori.
È stata sperimentata anche una collaborazione con alcuni Istituti di Scuola Secondaria Superiore del territorio coinvolgendo i ragazzi attraverso l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO).
Gli incontri avvengono a seconda delle disponibilità incrociate di volontarieutentidelservizio(nonc’èorario fisso), di solito una/ due volte alla settimana.
Ilserviziometteadisposizionelafigura di una psicologa esperta coordinatrice, che si occupa di valutareicasi,dicoinvolgereilvolontario più idoneo e di predisporre il primo contatto per la presa in carico. La psicologa si occuperà anche di organizzare degli incontri informativi/ formativi per tutti i volontari dove si affronteranno tematiche relative alle attività svolte e alle varie tipologie di problematiche dei bambini/ragazzi seguiti.
Pgg. 32-33 Alternativa
Crescere insieme a 360°
Certificazioni e potenziamento per DSA
Il Centro per la Famiglia ha, all’interno della sua équipe, psicologhe che si occupano di somministrare testistica e rilasciare la certificazione DSA, il documento che attesta la presenza di disturbi specifici dell’apprendimento. Al di là dell’etichetta diagnostica, la certificazione contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà dell’alunnoodellostudente eprevede l’applicazione delle misure previste dalla legge

Sulla certificazione è indicata una descrizioneaccuratadelprofilodifun-
zionamento del bambino/ragazzo, in modo da aiutare i soggetti coinvolti nel suo percorso di apprendimento (insegnanti, tutor, genitori) a supportare nel miglior modo possibile l’alunno.
Nel caso ci fosse la necessità e la condizione per farlo, è possibile attivare un percorso di potenziamento delle abilità cognitive e scolastiche, attraversoilqualestimolareepotenziarele abilità più fragili, insieme a fornire gli strumentinecessariavalorizzarepunti di forza e peculiarità del ragazzo.
Logopedia e psicomotricità
Altre risposte specialistiche sono offerte dai trattamenti di logopedia e
dai percorsi di psicomotricità. I trattamenti logopedici sono per ora proposti sulla sola sede di Verbania, mentre da settembre partiranno dei percorsi di psicomotricità presso la sede di Domodossola, rivolti a bambini di due fasce d’età (3-5 anni e 6-8 anni).
Entrambi i servizi vanno ad integrare le proposte di accompagnamento e di sostegno scolastico rivolto ai bambini più piccoli.
Coordinatrice Centro per la Famiglia
La Bitta
DARE UNA MANO AI RAGAZZI PERCHÈ TROVINO“UN PROPRIO POSTO”
Intervista a don Alberto Andrini responsabile dell’Oratorio di Villadossola
Carlo Rocchietti
La Parrocchia di San Bartolomeo costituisce, per la Città di Villadossola, il principale punto di riferimento per le attività collegate alla Pastorale dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie della Comunità. Questo polo educativo è caratterizzato dalla presenza dell’Oratorio San Domenico Savio, riferimento per le attività rivolte ai ragazzi di Villadossola, della Valle Antrona, della ValleAnzasca e dei comuni limitrofi.
Questo Oratorio ha sempre favorito lo sviluppo di attività einiziativepensateperiminori,perigiovanieperlefamiglie del territorio, anche con l’obiettivo di offrire spazi e tempo formativo.
La stabile collaborazione dell’Oratorio con l’Amministrazionecomunale,iServiziSociali,gliEntidelTerzoSettore e i Comitati di quartiere cittadini consente di intercettare e recepire i bisogni emergenti che il territorio esprime e tradurli in azioni coerenti con il contesto di riferimento.
In quest’ottica è stato avviato, nel dicembre 2021 (con il contributo economico della comunità, di alcune aziende private del territorio, della Fondazione Tami, della Caritas diocesana, della Fondazione Cariplo e della Regione Piemonte) il progetto ‘Tutti in Campo’, con il quale verranno rinnovati gli spazi esterni dell’Oratorio, realizzato aumentandoemigliorandol’offertadiattivitàeducativeesportive per i giovani.
Abbiamo chiesto a donAlbertoAndrini, responsabile delle attivitàdell’Oratorio,diraccontarciconchespiritol’Oratorio si rivolge alle proprie comunità.
Che cosa è in grado di offrire l’oratorio di Villadossola a chi è attivo al proprio interno e a chi invece è un po' più ai margini?
Piùcherisponderesucosa siaingradodioffrirel’Oratorio di Villadossola, e più in generale ogni Oratorio nelle Comunità cristiane di riferimento, mi sembra opportuno riportare una delle ultime definizioni redatte dalla CEI, durante un convegno di più di dieci anni fa, quando l’Oratorio è stato proposto così: “esso accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto
e la passione educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio sono quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio”.
Questa prospettiva dà una bella direzione al lavoro che abbiamo davanti e che, in una piccola parte è stato avviato negli anni anche nelle comunità di Villadossola e della valleAntrona.
Il verbo “accompagnare” è il più azzeccato per descrivere l’offerta dell’Oratorio: sia per chi sceglie un cammino di crescitaumanaespiritualeaccogliendolepropostedurante l’anno e nei mesi estivi, sia per chi gravita in Oratorio in altro modo, magari semplicemente come spazio di ritrovo con gli amici, al di là di una scelta di fede o di impegno educativo a favore dei più piccoli.
L’offerta formativa spazia nell’ambito di un cammino promozionale dell’umanità e della fede dei ragazzi preadolescenti, adolescenti e giovani, intercetta la possibilità di svolgere sport e attività ludico-ricreative e negli ultimi anni l’opportunità di un tempo e uno spazio dedicati allo studio, attraverso il metodo della peer education, il quale ha il pregio di coinvolgere il mondo giovanile con la sfera dei più piccoli, mettendo a servizio competenze e qualità che arricchiscono chi riceve, ma anche chi si mette in gioco.
Perquantoriguardairagazziunpo’piùai“margini”-come si diceva nella domanda – mi pare che sia compito primario della Comunità accogliere con simpatia e accompagnare con sensibilità questi giovani, laddove ci permettonodientrare,sfruttandoognioccasionechesipresenta per offrire una proposta credibile e impegnativa: è il seme gettato nel terreno di cui ci parla Gesù nel Vangelo, non saremo noi a vederne i frutti probabilmente, ma certamente quel seme porterà vita.
Negli ultimi anni anche la riflessione riguardo l’Oratorio sta mutando molti aspetti, alcuni oggigiorno parlano della pastorale dell’incrocio: una bella immagine per concretizzare l’impegno che ogni occasione (ogni incrocio) con la vita dei ragazzi, dalla più banale alla più seria, possiamo
AProtagonisti e testimonianze Alternativa
renderla significativa; uno sguardo come questo ci permette di poter “dire” qualcosa anche al mondo giovanile che intercettal’Oratoriopermillemotividiversi,senzamaifrequentarlo fino in fondo nelle sue proposte formative.
Con quale messaggio cerca di essere attuale e interessante l’oratorio anche per i ragazzi un po' in crisi?
Da quello che ho potuto osservare l’Oratorio e la comunità giovanile cristiana che lo compone hanno un grande orizzonte davanti a sé, perché il messaggio proposto non deve essere rivoluzionato, piuttosto la sfida riguarda il rinnovamento dei canali e degli strumenti attraverso i quali esso possa essere traghettato (“insegnato” – mettere un segno dentro) alle nuove generazioni giovani. Ciò che propone l’Oratorioè–ancora–estremamenteattuale,vera“ariafresca”perigiovani:rappresenta,infatti,unluogoeuntempo diincontro,discambio,diespressione,dirielaborazione,di sostegnoeconforto,diricercadisenso,direlazionetrapersoneenellaricercadellarelazioneconDio,dicondivisione di obiettivi, di scoperta reciproca di qualità e valori, di racconto della propria vita nell’ascolto di chi ci sta davanti, di esperienze da poter vivere insieme ad amici e coetanei e non da soli, di impegno e servizio, di un tempo libero e liberante…elalistapotrebbeandareavanti:credochequesto mix renda ancora attraente l’Oratorio (forse la parte più impegnativa è accompagnare fino alla soglia i ragazzi e i giovani!).
Anche il messaggio di fede è reso attuale e più comprensibile ai ragazzi attraverso le attività dell’oratorio?
Il messaggio di fede è al centro dell’impegno oratoriano, ma viene declinato in molti modi, potremmo dire a diverse velocità, tenendo presente che nel mondo odierno manca unabasecristiana,primaveicolatadirettamentedallefamiglie e nell’ambiente sociale, che veniva affinata dal catechismo e dal cammino cristiano giovanile, oggi questo non esiste più per la quasi totalità dei bambini, ragazzi e giovani, che si trovano a conoscere Gesù e il suo messaggio molto più avanti nell’età rispetto a prima. Questo rappresenta una sfida importante per la Comunità cristiana, non ancora del tutto consapevole del cambio di paradigma in atto (ormai da molti anni) e che interpella le comunità cristiane a cercare nuove vie di evangelizzazione rivolte soprattutto alle famiglie e alle nuove generazioni (che saranno le famiglie del domani).
Certamenteciòcherendepiùattualeepiùcomprensibileai ragazzi il messaggio di fede è la presenza e l’impegno di coloro che sono un po’più avanti negli anni (animatori ed educatori) che rappresentano spesso non solo un esempio, masoprattuttounatestimonianzadiqualcosadipiùgrande, che apre l’orizzonte di vita, che interroga, che pur impegnandoti ti rende libero.
AttraversolaloropresenzasiavveraciòchegiàpapaPaolo VIscrivevaneglianni’70: L’uomo contemporaneo ascolta

AProtagonisti e testimonianze
più volentieri i testimoni che i maestri [...] o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. (Evangeliinuntiandi)

Quanto l’oratorio, oltre ad essere un punto di incontro per i ragazzi, può essere un luogo di sostegno e confronto anche per le famiglie?
Siccome gli strumenti e i linguaggi dell’Oratorio sono quelli dell’esperienza quotidiana, le famiglie giocano un ruolo determinante nello stimolare i figli alla partecipazione, anche quando questa richieda un po’ di sacrificio e impegno. Svolge un ruolo centrale perché l’Oratorio deve inserirsi in una logica di quotidianità: esso è grande perché quotidiano, vicino, a portata di mano, una seconda casa, con esperienze semplici ma reali, calibrato sulle possibilità del paese in cui è inserito.
Se pensiamo l’Oratorio così, come una casa accogliente, le famiglie hanno il loro posto privilegiato: il bene da perseguire è il bene dei ragazzi, già questo è sufficiente per chiarirecomenelcamminodeigiovaninessunopuòsentirsi escluso o legittimato a demandare ad altri la crescita dei propri figli, questo certamente vale nell’ambito della scuola, della comunità dell’Oratorio o degli altri approcci educativi vissuti dai bambini, ragazzi e giovani. Ritengo che dovremmo impegnare almeno le stesse risorse edenergie,cheutilizziamoperlenuovegenerazioni,anche per le famiglie: coloro che sono genitori, che hanno la bellezza di far crescere una famiglia, l’impegno di rendere i propri figli persone robuste e libere, avrebbero lo stesso diritto di spazi e tempi di confronto e condivisione. L’Oratorio rappresenta per il nostro territorio un’opportunità da scegliere in questa direzione: non manca il coinvolgimento, che diventa un volano per far crescere ancora di più la passione educativa verso i più giovani. Occasioni di sostegno e condivisione sono proposte, ma alle volte mi pare di poter dire che è anche nel semplice confronto fraterno, in amicizia che emergono i migliori elementi di riflessione e
di positività per gli adulti e i genitori che, in diverso modo, “incrociano” l’Oratorio.
I Vescovi sono così convinti di questa cosa che ne fanno addirittura un elenco: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio. Gli ambiti della vita dei ragazzi, appunto, con l’intenzione (mi pare) di non escluderne nessuno: tempolibero,tempodell’impegno,tempodell’espressività, tempo delle attività strutturate… Tutto diventa educativo e non esiste nulla, nella vita dei ragazzi, che possa essere escluso da questa attenzione. Non c’è niente in quello che loro possono fare o proporre che non possa essere degno di stima: ogni interesse è di per sé educativo e va coltivato in questa direzione. Soltanto uno sguardo miope e piccolo distingue azioni educative da altre non educative; ma di certo questo non può essere lo sguardo dell’oratorio.

Qual è la benzina che attiva un processo di aggregazione e solidarietà tra i pari così partecipato come quello che muove oggi l’oratorio di Villadossola?
Dasemprenotoquestaparticolarecaratteristicadell’Oratorio di Villadossola: è ben voluto dalla gente, da tutta la Comunità, da quelli che una volta venivano chiamati “i vicini e i lontani”, dalla comunità marocchina, dai bambini fino ai nonni… ha un qualcosa che attira simpatia e che genera positività. Questo non sarà la benzina, ma aiuta!
La Chiesa oltre ad essere “giusta” ha bisogno di essere anche un po’ “simpatica”: cioè avere una disposizione d’animo favorevole verso tutti e ciascuno. I bambini in questo hanno spesso una marcia in più, e quindi da loro impariamo e lasciamoci educare ad uno sguardo benevolo, accogliente e “lungo”, che sappia scorgere nel tempo libero,neltempodell’impegno,dell’espressivitàedelleattività strutturate per i nostri ragazzi un tempo sempre “educativo”,dovelaparolacheguidailnostroagireèciòcheaveva scoperto don Bosco e prima e dopo di lui tanti altri: l’educazione è cosa del cuore (se no, non è).
Pgg. 36-37 Alternativa
i sarà capitato, almeno una volta, di imbattervi nel termine “Karma”, e sicuramente soffermandovi sulla lettera iniziale, lettera insolita per essere una parola italiana, avrete capito essere un termine estero, moderno,prestato,arrivatoanoidapostilontaniilcuisignificato rispecchia però verità senza tempo. Il termine Karma deriva dal sanscrito, lingua dell’India, e la definizione che delinea meglio il concetto e l’ideale di questa parola è la seguente: il Karma è la diretta conseguenza delle azioni di ciascuno di noi, seguente il principio di “causa-effetto”, chetradottoinpensieripiùaffiniallanostraculturasiriassume in il bene che si fa tornerà indietro. Questo nome, e il concetto associato, è stato scelto dalla giovane associazione domese che ne ha fatto il suo proposito e dal 2019 anima la cittadina di Domodossola con i suoi eventi.
CHI É
L’associazioneKarmaèun’associazionenoprofitcheconta oggiunatrentinadiragazzivolontaritrai18e29anniimpegnati nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventisocioculturalichevedonointeressatitargetdipubblico differenti, dai più giovani ai… meno giovani.
IMPEGNO
I ragazzi dell’associazione hanno riflesso i principi del Karma sulla cultura e ne hanno fatto la loro missione: si impegnanoquindiattivamenteproponendoeventiediniziativesulterritoriodomeseconl’intentodidiffonderecultura, ricevendoincambio,secondoiprincipidelKarma,nonsoltanto altra cultura ma anche più consapevolezza e gratitudine.
BORNTHISWAY
Iragazziossolanichenel2019hannodecisodiintraprendere i primi passi a favore di questo progetto, sono stati mossi dal desiderio di creare collettività e collaborazione sul territorio e proporre eventi che potessero interessare ed intrattenere anche il pubblico di più giovani, sempre più spesso “costretti” a recarsi altrove in cerca di svago. Consci delledifficoltàcheunterritorioframmentatoinvariefrazioni e valli, come quello della Val d’Ossola, comporta non si sono lasciati scoraggiare dalle difficoltà iniziali (complice anche il ben noto periodo del Covid), hanno accettato la sfidaeoggi,dopo4anni,moltoimpegno,parecchiimprevisti e tanta voglia di mettersi in gioco, godono di discreta notorietà, la stessa che fa crescere in loro il desiderio di migliorare. Vedere il loro impegno premiato dal successo degli eventi e dai feedback positivi dei vari partecipanti è sicuramente la soddisfazione più grande.
EVENTI E PROPOSTE
“La collaborazione è la chiave per il successo”.
È quindi doveroso menzionare il sostegno da parte di sponsor a km0 e del Comune di Domodossola che, con la loro cooperazione,aiutanol’associazionenellarealizzazionedei vari progetti.
Uno degli eventi marchio dell’associazione Karma è KONFERENCE: conferenze sotto forma di intervista di vari ospiti esterni che portano in tavola diversi argomenti. Questo tipo di evento, che si svolge solitamente in periodo primaverile, è un ottimo spunto per aprire al confronto e al dialogo e far riflettere su temi che posso essere o sembrare lontani da noi. Grazie a questo tipo di evento è nata anche una collaborazione con L’Enaip Piemonte di Domodossola e con il Formont, con lo scopo di far avvicinare i giovani e gli studenti al confronto e allo sviluppo di un pensiero critico. La prima edizione di Konference, svoltasi nei mesi di gennaio, febbraio e maggio, 2022 ha visto come ospiti:
-DonAlbertoRavagnanicon“Averetuttosenzaniente”,un giovanissimodondiBustoArsiziochehaspiegatocomeha abbracciato la vita dei voti senza temere di perdere la sua libertà e come il possesso di poco possa rendere ricchi;
-Chicoria con “Cronache di periferia”, rapper romano che conilsuoraccontobiograficohacondivisocomesceltesbagliate possano portare in brutte situazioni e di come la musica invece l’abbia salvato da una vita criminosa, facendo luce su quanto la prevenzione sia importante per maturare consapevolezza;
-Pietro Morello con “Io ho un piano”, musicista con il, più che raro, orecchio assoluto che con grande umiltà ha raccontato come spendere la vita per gli altri possa essere una ricompensaecomelesueesperienzedivolontariatoumanitario l’abbiano fortemente toccato, tanto da cambiare prospettive.
Lasecondaedizionedellaprimavera2023èstataunaduplice intervista con Daniele Cassioli e Davide Morana, due atleti italiani paraolimpici, che, con due storie differenti ma altempostesso affini,hanno mostrato comegliimprevistie gli incidenti della vita possano essere un’opportunità; non a caso il titolo dell’evento è stato “Più forti di tutto”. Se la vostra curiosità si è risvegliata sappiate che tutte le Konference sono state registrate e sono disponibili gratuitamente sul canale youtube al seguente link https://www. youtube.com/@AssociazioneKarma o su spotify alla pagina Konference.
Un altro evento Karma che merita menzione è il KARMAGEDDON. Fiore all’occhiello dell’associazione, si tratta di unfestivalnelcuoredell’estateinunadellelocationpiùiconiche dell’Ossola: Domobianca 365. Il protagonista dell’eventoèlamusica,piùprecisamentemusicalivecondj diuncertospessore.Lasecondaedizionedel2023,dapoco conclusa, è stata un successone: ha avuto un’enorme affluenza, lasciando sia pubblico che staff sorpresi e soddisfatti e ricevendo recensioni più che positive. La proposta
Una associazione culturale di giovani a Domodossola che progetta, organizza e realizza eventi socioculturali
KARMA
AProtagonisti e testimonianze V
Cottini Maura
offertadall’associazionerichiedegrandemaestrianelriuscire a combinare un evento della portata di 2.000 persone ospitando artisti di fama internazionale per un totale di 12 ore di festa, in collaborazione con lo staff di Domobianca, adingressogratuito.Lenovitàdell’edizione2023sonostate tante, per menzionarne una: la degustazione di vini del territorio grazie all’azienda vinicola di Edoardo Patrone. Migliorando di anno in anno si punta sempre più in alto per promuovere divertimento e cultura. Un altro evento di rilievo è SILENT DISCO. Nel caso non sappiatecosasiaunasilentdiscoèprestospiegatatraducendo il termine: una discoteca silenziosa. Si sente parlare spesso di inquinamento acustico, ovvero l’inquinamento causato da suoni e rumori di alta intensità. Essendone Domodossola quotidianamente affetta, soprattutto nelle ore odiernevistiiltrafficoeivaricantieri,comemetteredunque d’accordoicittadinidomesi,chevorrebberopaceetranquillità, per lo meno durante la sera, e i giovani che invece vorrebberoun’offertadieventivariegata?Optandoperquesta alternativa si è trovato il giusto compromesso per tutti. Gli eventi di silent disco, firmati Karma, sono stati la soluzione ottimale per ovviare a questo problema: le date a Piazza Mercato, Piazza volontari per la libertà e allo Stadio Curotti, hanno avuto grande partecipazione e ottime recensioni. In questo modo nessun vicino potrà essere infastidito dalla musica ad alto volume perché la musica la si ascolta tramite delle cuffie. Ma la discoteca silenziosa è una proposta versatile, infatti è stata indicata anche per un progetto al chiuso: SILENT MUSEUM. Per questo evento è stato crucialedareunosguardoinpiùsuciòcheoffreilterritorio.Ed ecco qui che combinando della buona musica con un po’

d’artesiottienel’eventoperfetto:unamostrad’arteaPalazzo San Francesco, nel cuore di Domodossola, condita con musica di sottofondo silenziosa. Un’iniziativa che mette d’accordo giovani e adulti e un motivo in più per frequentareimuseidelterritorio,avoltesottovalutati,epassareuna serata diversa.
KEEPINTOUCH
IragazzidiKarmasonomoltoattivisuisocialsoprattuttosu Instagram e su Facebook, dove le loro pagine @associazione_karma e Karma Associazione Kulturale hanno un grande seguito e la pubblicazione di contenuti non si fa attendere. A ridosso di ogni evento non mancano, e non mancherannodicerto,volantiniemanifesticontuttalaprogrammazione. Ulteriori informazioni si possono trovare anche sul loro sito web www.associazionekarma.com Non va dimenticato che, trattandosi di un’associazione no profit,unpiccolosupportoèsemprebenaccetto.Perquesto motivo chi fosse interessato e/o si trovasse in linea con gli ideali dell’associazione e volesse supportare il suo operato, siaonlinecheduranteglieventi,puòtesserarsiperdiventare socio Karma: con un piccolo contributo simbolico di 10€ si può ottenere la tessera Karma grazie alla quale si può godere di benefit e sconti durante l’anno di validità della tessera. Unpiccologestopuòfareladifferenzaperunapiccolarealtà facendola crescere.
Per qualsiasi e ulteriore informazioni la chat dell’associazione Karma è sempre attiva e la porta sempre aperta: per dubbi, domande, info, ringraziamenti o semplicemente lasciare feedback non esitate a mettervi in contatto.
Pgg. 38-39 Alternativa
LAVITA CHE NON MI ASPETTAVO
Intervista a Sissoko M’Bouille, florovivaista della Cooperativa Sociale Risorse
Iniziamoconquestonumerounciclodiintervisteaiprotagonistideldocumentario Migrazioni - Storie di umana rinascita in un’economia in trasformazione, realizzato dalcineoperatoreeregistaverbaneseLorenzoCamocardi. Hoavutoilpiaceredicollaborareconluiallarealizzazionedel documentario e ho avuto modo di incontrare e parlare con i tanti giovani operatori della Cooperativa Risorse che, per i motivipiùdiversi,hannodovutolasciarelelorocaseeiniziare unviaggiosenzadestinazione,versounfuturochehannosperatomigliore.
L’ospite di questa prima puntata della rubrica “Migranti” è Sissoko M’Bouille, arrivato in Italia dal Mali nell’aprile del 2014,diprofessioneflorovivaista.
Come e perché sei arrivato in Italia?
Non avrei mai immaginato di dover migrare. Ma nella vita succedono cose inaspettate e arrivando qui ho dovuto ricrearmiunavita,comesefosseilprimogiornoditutto.
Com’era la tua vita prima? Che lavoro facevi in Mali?

Fino ai 22 anni ho sempre studiato; ho frequentato economia e commercio e, proprio prima di partire, stavo facendo uno stage. Nel 2012 è scoppiata la guerra e sono scappato, sono l’unicouomodellamiafamigliaelasituazionesistavafacendo davvero molto pericolosa per i figli maschi.A casa sono
rimastemiamammaelemiesorelle.
Cristina Barberis Negra
È stato un viaggio tosto, duro e complicato, lungo due anni. Nonloauguroanessuno.
Ora dopo quasi dieci anni in Italia, come stai? Cominci a sentirti a casa?
Mitrovobenissimoqui.Nonpossonegarecheall'inizio,appena arrivato, ho sofferto tanto. È stato difficile imparare una linguachenonavevomaisentito,neppureintv.Peròmiincuriosiva l’italiano, perché non è parlato solo con la voce. Ricordo il primo giorno, appena sbarcati, i Carabinieri parlavano davanti a noi, gesticolando. In Mali non si gesticola parlando,maquestomièpiaciutosubitotantissimoemisono detto: non so come sarà questa lingua ma la imparerò.Ecosì hofatto:andavoinbibliotecaastudiaresuidizionariesututto quellochemipotevaaiutare.Adessoloparloelocapiscoequi inItaliastodavverobene.
Cosa ti manca della tua terra?
Mimancalamiafamiglia,siamodistantimigliaiadichilometri,èdura,ecredochequestodolorenonsicancelleràmai.Mi mancano le piccole cose, anche la cucina della mia mamma chemifacevasempretrovaretuttopronto.Adessocucinoemi piacetantissimolapizza,quellanessunomelapuòtogliere.
Hai in programma di tornare dalla tua famiglia o di far venire loro qui?
Spero sempre di tornare a casa, voglio rivedere la mia famiglia.
Come hai incontrato Risorse?
SonoentratoinCooperativagrazieaMarinaCaretti,un’amica conosciuta nel 2016 a Biganzolo, dove facevo volontariato. Per me è come una seconda mamma, è lei che mi ha fatto incontrareVittorioZacchera,ecosì, dalfebbraio2016,lavoro inRisorse.
Cos’è per te il lavoro e cosa ti piace di quello che fai?
Illavorochesvolgoincooperativaècomesefossemio,come sefossecasamia.Quellochepiùmipiaceèvedereilrisultato di quello che faccio. Mi sono specializzato nelle talee, nelle piccolepiante;civuolepassioneepazienzaavederecrescere lecosechecreimalasoddisfazioneègrandissima.
Cosa speri per il tuo futuro?
Distarebene!Nonsipuòsaperecosaaccadràdomani,macon iltemposipuòfaretuttoquellochesidesidera.
Sevoleteconosceremeglioilnostroospite,Nel2016Sissoko M’Bouillehascritto,insiemeall’amicaLuisaAnchisi,unlibro daltitolo“Viaggioasensounico”,doveraccontalasuastoria: l’esperienzaquiinItalia,lepersoneegliamiciconosciutiche pocoallavoltal’hannofattosentiredinuovoalpostogiusto.
AProtagonisti e testimonianze
Nuove rotte e nuove narrazioni di migrazione
Venerdì 17 novembre a Casa don Gianni alle ore 21 si parla di flussi migratori, ispirati dal docufilm di CooperativaSocialeRisorse.
OspitidellaseratailprofessorMaurizio Ambrosini, dell’Università degli Studi di Milano e il fotogiornalista
FrancescoMalavolta
Venerdì 17 novembre alle ore 21 a Casa Don Gianni due ospiti d’eccezione per parlare di migrazione e di popoli migranti: il professor Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia delle migrazioni dell’Università degli Studi di Milano e il fotogiornalista Francesco Malavolta
La serata offrirà anche l’occasione di vedere il docufilm del regista verbanese Lorenzo Camocardi “Migrazioni - Storie di umana rinascita in un’economia in trasformazione”
Ildocumentario,volutodallaCooperativaSociale Risorse, raccoglie le testimonianze di soci e lavoratori provenienti dai più diversi paesi: le loro fughe, i loro viaggi, il loro arrivo in Italia e la nuova vita che sono riusciti, anche grazie alla cooperazione, a ricostruirsi. Uno sguardo lucido sul fenomeno migratorio, senza vene polemiche o propagandistiche, una disanima della situazione attraverso le voci di chi quotidianamente vive questa realtà, di chi la studia e di chi ne ha capito il valore e la potenzialità.
In attesa di ascoltarli dal vivo abbiamo posto qualche domanda ai due relatori per conoscerli meglio e per cominciare a orientarci nel tema della serata.
Come si diventa un fotogiornalista e un esperto di migrazioni, come mai una scelta così particolare?

Malavolta: La mia decisione di fotografare “le personeinmovimento”èstataabbastanzacasuale: negli anni ‘90 facevo il militare al porto di Brindisi e, passeggiando con la mia vecchia Canonapellicola,misonotrovatodifronteauna barca di migranti che arrivava dall’Albania. Da allora ho cominciato a orientare il mio lavoro verso gli aspetti più sociali del mondo e oggi il tema delle migrazioni rappresenta il 90% dei miei scatti.
Negli ultimi 15 anni il mio interesse personale sull’argomento, che è così vasto, doloroso, drammatico e sempre in aumento è ancor più cresciuto e si è focalizzato. Ho deciso di occuparmi non solo del viaggio, ovvero delle frontiere, dei salvataggi, dei passaggi all’interno dei paesi, ma di raccontare anche i luoghi di partenza,quellichevedonoiprotagonistipartireper
cercare una vita migliore.
Ambrosini: Direi che è stata una combinazione tra propensioni personali e circostanze esterne. Mi sono laureato in Cattolica alla fine degli anni ’70 e ho cominciato a collaborare con il dipartimento di sociologia; per oltre 10 anni mi sono concentrato prevalentemente su lavoro, relazioni sindacali, partecipazione delle imprese, disoccupazione, lavoro precario.Alla fine degli anni ‘80 l’Italia scopre di essere diventata un paese di immigrazione e nasce una domanda di ricerca e conoscenza su questo tema. Il mio maestro, il professor Michele Colasanto, mi coinvolse in alcuni progetti dell'Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia in cui iniziavamo a interessarci al lavoro degli immigrati. Quella era anche la Milano del Cardinal Martini, ricordo che in un incontro per presentargli un rapporto sulla città, ci chiese: “Avete parlato degli immigrati in questo rapporto?”. Non lo avevamo fatto. Fu uno stimolo. Era un periodo in cui nel mondo cattolico c’era grande sensibilità. Ho lavorato parecchio con la Caritas Ambrosiana, perché accanto agli interventi pratici, c’era una volontà di capire e approfondire, c’era una domanda formativa di operatori e volontari. Questi diversi aspetti, accademici, sociali, legati agli ambienti che frequentavo e alle domande del territorio, mi hanno spinto sempre di più a lavorare su questi temi. Quando uno sviluppo dicarriera mi ha portato a Genova come professore associato, abbiamo istituito il primo corso universitario in Italia di Sociologia delle migrazioni; abbiamo creatolarivista“MondiMigranti”,lascuolaestiva di sociologia delle migrazioni, il “Centro Studi MEDÌ, migrazioni nel Mediterraneo. Al mioritornoaMilanolastradaeratracciataequesto è diventato il mio principale tema di ricerca.
Ogni volta che si parla di migranti si parla di emergenza, ma è davvero così? Come si è trasformato il fenomeno migratorio dagli anni ’80 a oggi? Sono cambiati i protagonisti? Sono cambiati i motivi che spingono i popoli e le persone a spostarsi?
Ambrosini: Non è cambiato molto, già negli anni ’80 la gente, compresi i colleghi del mondo accademico, si stupivano quando raccontavo che molti immigrati trovavano lavoro in Italia. L’immigrazione era percepita come un fenomenochecipiovevaaddossodall’esterno,eche,nel migliore dei casi, chiedeva assistenza, nel peggiore rappresentava una minaccia e un problema per la società. C’era sempre questa idea di un’emergenza, di un fenomeno non voluto e non richiesto, per molti aspetti problematico. Questa visione persiste, ha assunto volti diversi, preso di mira componenti diversi della migrazione: ini-
Pgg. 40-41 Alternativa
Intervista al professor Maurizio Ambrosini e al fotoreporter Francesco Malavolta
zialmente quelli visti come problematici erano i nordafricani, i marocchini; poi c’è stata la fase degli albanesi, poi quella dei rumeni, ogni 10 anni all’incirca c’è un nuovo gruppo di immigrati malvisti, che diventano l’occasione per preoccuparsi degli immigrati in generale, adesso è il momento dei rifugiati africani. Forse oggi si sono inaspriti i toni, il tema è diventato più rilevante nell’agenda politica, più divisivo per il paese e forse ha assunto connotazioni razziali più marcate che all'inizio.
Da dove arrivano oggi i migranti, ci sono nuove rotte?
Malavolta: Oggi le rotte sono tante e le più numerose non sono quelle che arrivano in Italia e nemmeno in Europa. Secondo le Nazioni Unite sono state oltre 100 milioni, lo scorso anno, le persone che si sono spostate all’interno del mondo per vari motivi: guerre, conflitti, devastazione climatica, mancanza di ogni tipo di libertà e di accesso ad acqua e cibo. Sono tanti i motivi che spingono le persone a migrare, e spesso verso sud, all’interno degli stessi continenti. La percentuale delle persone che arrivano via terra e via mare in Italia, è veramente minima. Inquestomomentoprevalelarottatunisina,checoinvolge le persone in fuga dalla Tunisia e provenienti da tutta l’area del centro Africa, messe al bando dal governo di Tunisi.LazonadiSfaxèilpuntopiùcaldoperlepartenze. In Italia si parla solo nell’estate di 100.000 arrivi. Continuano ad essere attive le rotte che partono dalla Libia; dalla Turchia verso la Grecia (anche se i numeri sono bassi); dalla Bulgaria per la cosiddetta rotta balcanica.
Una rotta poco conosciuta, che riguarda sempre l’Europa, è quella verso le Canarie, che abbraccia la zona da MauritaniaeMaroccofinoalSenegal:circa50milaarrivinegli ultimi 3 anni, con un numero importante di vittime, dati i tempi lunghi della traversata da Dakar a Lanzarote.
Si parla quasi sempre di fenomeno migratorio quando accadono i fatti di cronaca, per la maggior parte delle persone i migranti sono quelli che arrivano con i barconi. Qual è invece la realtà?
Ambrosini: C’è uno scarto molto forte tra l’immigrazione raccontata e l’immigrazione effettiva, una parte del mio lavoro è proprio dedicata a cercare di chiudere questo divario. In Italia abbiamo 5 milioni e 300 mila immigrati regolari, e si stima circa 500 mila irregolari, eppure discutiamo, ogni giorno, dei 340 mila richiedenti asilorifugiati, di cui almeno il 40% Ucraini, che sono stati accolti nel nostro paese. Un altro mito da sfatare è la convinzione che gli immigrati siano giovani uomini che arrivano dall’Africa o dal Medio Oriente, mentre la maggioranza sono donne, e quasi la metàsonoeuropeee 2milionie350milahannounlavoro regolare in Italia.
Aproposito di lavoro, sfatiamo un altro luogo comune “i migranti vengono qui a portarci via il lavoro”!
Ambrosini:Rispondoconunabattutatrattadaunavignetta diAltan, dove uno dei suoi personaggi mostruosi chiede all’altro: “Cosa potremmo augurare ai razzisti di casa nostra?” e l’altro mostro risponde: “Una badante vendicativa”.
Facciamofaticaarendercicontocheunapartedellanostra società e dei nostri fabbisogni di forza lavoro dipendono da persone che arrivano dal resto del mondo. La casa è l’ambito fondamentale; il settore lavorativo in cui è più alta l’incidenza dell’immigrazione è quello dei servizi domestici e assistenziali, dove gli stranieri sono circa il 70% degli occupati regolari. È proprio nell’intimo delle nostre case che si sviluppa in realtà questa complementarietà tra immigrati e i nostri fabbisogni, le nostre necessità, anche le nostre relazioni e i nostri bisogni di ascolto e di compagnia. Dovremmo partire da noi stessi, dallenostreretiparentaliedalnostrovicinato,perrenderci conto che la nostra società è più intrecciata con il resto del mondo e con chi arriva dall’esterno, di quanto forse siamo disposti ad ammettere.
Quanto è importante fare cultura della migrazione? Come possiamo provare a trasformare la narrazione propagandistica, in narrazione reale sulla migrazione?

Malavolta: Fare cultura e fare chiarezza è necessario! Incontro spesso gli studenti di scuole medie e superiori; i ragazzi, per vari motivi, non accedono all’informazione corretta: sono distratti dalle fake news e da un “sapere” che passa solo attraverso i social media. Entrare nelle scuole e portare la giusta informazione significa dare un mezzo di conoscenza e non solo di opinione. Negli ultimi 15annisonotantissimiiragazzieleragazzechehoincontrato. Nei primi minuti trovo un atteggiamento di chiusura e disinteresse, ma basta poco, è sufficiente raccontare la storia di quelle persone, spesso loro coetanei, la quotidianità delle migrazioni, la vita di chi sceglie di lasciare la propriaterraelapropriafamiglia,e,allafinedellalezione, mi ritrovo con studenti che mi chiedono contatti, che vogliono partire come volontari, che vogliono preparare tesi e ricerche sull’argomento, e molti che, anche dopo, mi seguono sui social per continuare a informarsi. Mi sono inventato un gioco da fare in aula: mostro una foto con un barcone strapieno di persone, spesso solo uomini, e invito i ragazzi a scrivere la frase o la parola che gli evoca quell’immagine. Lo stesso faccio alla fine: dopo avere raccontato qualche viaggio e qualche storia, si passa da “ci invadono” a “dobbiamo fare qualcosa per loro/dobbiamo aiutarli”.
Ambrosini:C’èundatopositivocheemergedagranparte dei sondaggi e ricerche sul tema, e anche persino dai risultati elettorali dei vari paesi: chi conosce gli immigrati, chi ha modo di interagire con loro, ha meno paura, meno resistenze e pregiudizi rispetto a chi non li conosce. Basti pensare al voto per Donald Trump, alla Brexit, al voto in Germania: chi mostra, votando, più ostilità nei confronti degli immigrati vive in contesti dove ce ne sono pochi. Ugualmenteneisondaggidiopinionequandosichiede“tu
conosci/hai rapporti con gli immigrati?” chi risponde di sì è più probabile che abbia meno pregiudizi e meno difficoltà a interagire e ad accettare l’immigrazione. Ne discende che se si moltiplicano i luoghi, le occasioni, le opportunità di incontro, di esperienza effettiva, di relazione con l’altro, anche le difficoltà e le paure tendono a scemare. Porto un esempio di esperienza reale: oggi nelle case popolari di Milano ci sono due popolazioni che occupano gran parte degli appartamenti: gli anziani italiani, spesso donne vedove, e le giovani famiglie immigrate. Questi due mondi, pensati come incomunicabili e ostili tra di loro, in realtà spesso si incontrano. La nonna italiana sola, che non sa come passare il tempo, i figli e i nipoti sono cresciuti e non sono lì con lei, al pomeriggio vede arrivare da scuola i bambini delle famiglie di immigrati, i cui genitori sono al lavoro, e li invita a casa sua, prepara la merenda, guardano la tv, non dico gli fa fare i compiti ma li accoglie; nascono delle relazioni, degli incontri a livello di pianerottolo. Bisogni reciproci diventano opportunità.
Prossimi impegni?

Malavolta: A ottobre andrò in Togo, poi tornerò in Kossovo, per completare la documentazione, intervistando i kossovari albanesi, e in Tunisia, dove ho lavorato in passato, proprio per trovare storie di persone in fuga verso l’Italia. Poi dipende dalle rotte, nel caso delle migrazioni gli scenari possono cambiare rapidamente. Voglio tornare anche nell’area balcanica; se ne sta parlando poco, ma ci sono passaggi importanti e numeri molto alti all’interno di quei paesi. L’inverno è durissimo e provoca molti morti, vorrei comprendere se sono cambiate le politiche rispetto ai blocchi, ricordiamo tutti quello che accadeva al confine tra Bosnia e Croazia, con i respingimenti.
Ambrosini: Uscirà in autunno un piccolo libro,dedicatoproprioaltemadeirifugiatiper cercare di fare chiarezza su questo nodo così controverso e problematico. Si intitolerà “Stato D’assedio - Perché la questione dei Rifugiati ci rende peggiori” editore Egeacasa editrice dell’Università Bocconi. Cerco peralmenounapartedelmiolavorodimettermi in dialogo con l’opinione pubblica e di cercare, se posso, di dare qualche elemento per migliorare il tenore del dibattito pubblico su questi argomenti.
migrazioniM igrazioni
parler les gens
Pgg. 42-43 Alternativa
aiuto
F
migration communication renaissancecomunicare uggire Brexit rotte CULTURA narrazione fear survival dibattito Faire
ESOM, UNA STORICA PRESENZA VERBANESE RINNOVATA
Un viaggio nel percorso lungo e stimolante di questo Istituto che ha segnato profondamente studenti, genitori e insegnanti, grazie al suo continuo evolversi nel riflettere i cambiamenti sociali, economici e culturali succedutisi nella storia recente del nostro paese
Chiara Rinaldi e Serena Melica
Mi chiamo Francis, ho 12 anni. I miei genitori sono arrivatidalSenegaltantiannifa,iosononatainItalia. Frequento la scuola media, i miei professori dicono che sono una ragazzina curiosa e che ho tanta voglia di imparareedèvero.Vogliosaperelecose,vogliocapireciòche è stato, comprendere quello che mi circonda, voglio andare beneascuola,sognounfuturoincuipoterviverefelice,realizzata. Quando mi chiedono cosa voglio fare da grande ho le idee abbastanza chiare, so che mi devo impegnare e lo faccio percomelosafareunaragazzinadellamiaetà,credo. Mifido degliadultichemicircondano,professori,educatrici,cercodi vedere in loro quello che potrei essere ma anche quello che nonvorrei. Avoltepensodiessereconsideratainbasealcolore della mia pelle, alla mia nazionalità, credo che si pensi che ho desideri diversi dagli altri, comportamenti legati alle mie origini,iocredodiesserecometutteledodicennicheconosco, diverse per carattere, per gusti ma uguale, credo che ci accomunino le stesse paure, le stesse bellezze, le stesse domande, le stesse certezze che si hanno a 12 anni e le stesse incertezze su quello che sarà. Sento il desiderio di essere apprezzata, di farebenelecose,distarebeneconlepersonechemicircondano, chi non lo vuole? Spesso a casa, chiusa in camera mia a fare i compiti mi sembra di non riuscirci, ma forse ho solo bisogno di qualcuno che stia al mio fianco, che mi spieghi quandononcapiscoeanchequandocapiscovorreisentirmelo dire,chehofattobene,chesonocapace,chevalgo. Un giorno a scuola ho sentito parlare di questo centro dove due educatrici aiutano a fare i compiti. L’iscrizione è gratuita, allora ho pensato che forse vale la pena provare ad andarci, perchéno?Mipreoccupavaunpo'ilpensierodichiavreitrovato,altricompagnidiscuolacheconoscevoemagariconcui non avevo mai parlato. Le educatrici saranno simpatiche? Saranno brave? Sapranno capirmi, aiutarmi davvero? Ho decisodiiscrivermie,nonostanteilprimogiornosiastatadura (sono molto timida e ho bisogno di tempo per fare amicizia con le mie coetanee), ho trovato un posto particolare. Mi aspettavo un luogo dove sedermi e fare i compiti, chiedere aiutosenoncapivoqualcosa,stareinsilenzio,imparare. Invece sono entrata in un luogo dove ho scoperto che fare i compiti non è poi così noioso, che per imparare non è necessario solo stare seduta ad ascoltareunaspiegazione, aleggere
dasola,aripeterelalezione.Hoimparatochesiimparaanche parlando con gli altri, anche collaborando con quelli che non hannoimieistessicompiti,chesiragionasullecoseconpunti divistadiversiecheognunadiquesteprospettiveègiusta.Ho imparatochenonc’ègiustoosbagliatomacheognunohauna visione diversa delle cose, ho imparato ad aprirmi, ho capito che ci sono persone che non ti giudicano ma che forse hanno pauraanchelorodiesseregiudicateechehannotimorediparlareadaltavoce,propriocomeme.Imieivotiascuolasisono alzati,noncheprimaandassimale,maoramisembradicapire megliolecose.Hoscopertochecisonodeigiochetti,pernientenoiosi,cheallenanoaragionaresullecoseenonmollofino alla fine, fino a che non trovo la soluzione e mi piace farlo in compagnia, seduta su una sedia, per terra, sdraiata, in piedi, a volte è come se il cambio di posizione mi aiuti a cercare un’altra strada per arrivare al risultato, è come se nel cervello qualcosa si muovesse e si accende la lampadina.Avolte no, ma sto imparando anche questo, a volte ci arrivano prima gli altrievabenecosì,nientegare,nienteprimisecondioultimi, tutti lì a condividere per imparare. Durante l’anno eravamo divisi per classi elementari e medie, finita la scuola abbiamo fatto gruppo anche con bambini/e delle scuole elementari, oltreafareinostricompitidellevacanzeleeducatricicihanno proposto di aiutare i più piccoli nei compiti. Mi è piaciuto. Avreivolutodurasseancora,maafinegiugnoilcentroèstato chiusoperl’estate,sperodipoterciritornarel’annoprossimo.” Pensieri di una dodicenne, Francis
IlcentroacuisiriferisceFrancisèl’EnteScuolaeOccupazione per Minori (E.S.O.M.), riconosciuto giuridicamente come “Fondazione” che opera dal 1970 nell’ambito del privato sociale a sostegno dell’educazione culturale e promozione umana dei minori (scuola dell’obbligo). È una Fondazione in memoriadiMariaPiaeFrancoMenotti,presentesulterritorio verbanese, sostenuta dal comune di Verbania, dal Consorzio dei servizi del VCO, da Fondazione Comunitaria del VCO e da volontari attraverso le oblazioni. Dopo quasi tre anni di chiusura a causa della pandemia da covid-19, quest’anno il progetto è ripartito. I fruitori del progetto provengono da Marocco,Egitto,Albania,Jugoslavia,UcrainaeItalia. Avremmo potuto scegliere altre storie, ma in questa c’è tutto
AProtagonisti e testimonianze
“
ciò che abbiamo cercato di fare al Doposcuola ESOM. Sta proprio qui il cambio di prospettiva: riconoscere l’unicità dei minori al di là di quello che può rappresentare la posizione socialeelanazionalità,sicuramenteinformazioniutilimanon sufficienti quando si ha a che fare con minori. Unicità intesa come punto di partenza da condividere: partiamo tutti dalla stessalineama,nelmomentoincuil’adultointervieneedàun significatoalleparoleenonalleemozioni,alloratuttocambia. Le frasi “potrebbe ma non si impegna”, “è un po' lento”, “ha bisogno di potenziamento perché è un po' indietro”contribuiscono a costruire distanze, che poi nel tempo diventano situazionidifficilidacomprendereedagestire.Inizianoaformarsi i gruppi di chi sta davanti e chi dietro. Invece, come ci ricordaFrancis,siamotuttiaccomunatidallestesseemozioni, dagli stessi bisogni, ciò che cambia è il modo in cui vengono espressi.Accoglienza prima di tutto, ascolto, condivisione, a cui noi abbiamo cercato di dare la priorità, prima del luogo, prima dei compiti, prima dei voti. Perché una bambina che impara a riconoscere le proprie emozioni e a gestirle si apre all’altro,accomunatodallestessepaureedallastessavogliadi liberarsene. Infatti, nonostante bambine e ragazze che hanno frequentato il centro arrivassero da sei/otto ore di scuola, era forteildesideriodi“lavorare”.Abbiamocercatodicreareuno spazio dove si potesse stare bene, senza doversi preoccupare di rispondere a richieste di performance da parte degli adulti. Unospaziodoveimparareagestireleansieelepreoccupazioni, garantendo così una maggior efficacia nel rapportarsi con glialtriediproblemsolving,approccioutileadaccompagnare i ragazzi verso un’attività scolastica con maggior sicurezza. Tuttoquestoèstatocreatoaffiancandoaimomentidisostegno scolastico l’attività ludico - ricreativa che ha visto gli utenti impegnatiinmomentidigioco,disegnoliberoeconfrontotra pari.L’obiettivoprincipaleèsemprestatoquellodimigliorare ilrendimentoscolastico,senzamaidimenticarequantoquesto aspetto sia strettamente legato e condizionato dall’avere uno spazio a disposizione all’interno del quale ci si possa sentire accolti,accompagnatiacomprendereeasviluppareleproprie abilità personali e relazionali. Questa modalità ha portato a una condivisione del senso delle regole e dei limiti, a una più efficace e cosciente assunzione di responsabilità delle proprie azionieaunapiùconsapevolecondivisionediesperienzeedi spaziconl’altro.
Nontuttiisoggettichehannofrequentatoilcentrohannoade-
ritocomeFrancisdipropriainiziativa,perlamaggiorpartelo hanno fatto consigliati dalle loro insegnanti, alcuni inviati dai servizisocialiemoltiportatidaigenitori,questiultimipresenti eattentiallapreparazionescolastica.Abbiamoriconosciutoin loro quel desiderio di una vita migliore per i propri figli che passa per l'importanza data allo studio e all’integrazione, sentimento che accomuna tutti i genitori, disposti a cogliere ogni occasione per permettere che ciò avvenga. Tre ragazze/i, su ottantachedurantel’annohannofrequentatoilcentro,qualche mese prima della fine della scuola hanno scelto di non continuare, certe situazioni hanno bisogno di più tempo per instaurarelagiustarelazione,percapirequalidinamichemettereinattoeilmodomiglioreperfarlo.Alcunifannopiùfatica dialtriacapirediaverbisognodiaiutoenonsannocomechiederlo, oppure non sanno cosa chiedere, a volte non ci si sa leggere dentro e non ci si rende conto che non fermarsi in un posto equivale a perdere una possibilità. È soprattutto in queste occasioni che per noi educatrici diventa importante mettersi in discussione, per comprendere in che modo cambiare direzione, rimanendo aperte a nuove prospettive che si avvicininosempreunpo'dipiùaquestenuovepersonalitàche sivannoformandoechesiaffidanoall’adultoperesserecapite,ascoltate,guidateelasciatelibere.
Numerosisonostatigliobiettividiquestoprogetto:prevenire l'abbandonoscolastico,individuareibisognidellafasciad'età presainconsiderazioneepromuoverelamaturazioneel'identitàpersonale,riconoscendoesviluppandocompetenzeutilia favorirel'inclusionesociale.
Pertuttiquestimotivi,l’esperienzapotrebbeessereconsiderata un elemento di prevenzione primaria, potrebbe aiutare nell'impedire che le difficoltà, qualora incontrate da bambini, ragazzi e dalle loro famiglie, raggiungano livelli avanzati che necessiterebberodiinterventispecializzatiacaricodeiservizi, giàoberatidalletanterichieste.

Un altro aspetto che ha caratterizzato il progetto è pensato in relazione ai legami che si creano tra tutti i soggetti (Esom, scuola, servizi, territorio, volontari), avendo come obiettivo comune il benessere dell’individuo, in questo caso i minori, con l’intento di prevenire o gestire le problematiche esistenti. Epoi,comepertuttelebelleesperienze,arrivalafine,trafoto, balli e messaggi che ci accompagneranno mentre ognuno di noi sarà impegnato, coscientemente o meno, ad affrontare la vita.Grazie!
ABiTo veste Dry Tech

Pgg. 44-45 Alternativa
Velocità
INostri Servizi
RISTRUTTURAZIONI
EDIFICI
Via Cesare Battisti, 31 13876 Sandigliano (BI) Tel. 015 099 16 42 info@abito.casa www.abito.casa
Antisismicità Efficienza Energetica Costie tempi certi Sostenibilità ambientale Nessun limite compositivo
NUOVE
COSTRUZIONI SU MISURA
E RIQUALIFICAZIONI
MODULARI
NOI FRAGILI, NOI IMMORTALI
Proseguono gli appuntamenti di sensibilizzazione e informazione del progetto Pallium Chelamortecicolgavivi:NOIFRAGILI,NOIIMMORTALI Tra gli ospiti della rassegna: il giornalista Domenico Iannacone, padre Guidalberto Bormiolini e l’attrice


Laura Curino

Dopo il successo della rassegna estiva “Che la morte ci colga vivi”, progetto Pallium propone, per l’autunno, un nuovo ciclo di appuntamenti gratuiti, aperti al pubblico, per parlare di relazioni, fragilità, morte e del ruolo che i mediaelatecnologiahannonellaloro narrazione.
“
Dall’esperienza di questi mesi –spiega Elisabetta Sfondrini, tutor di comunità per Pallium – è emerso chiaramente il bisogno di tante persone, senza limiti di età, di entrare a contatto con questi temi. È come se ci fosse una sorta di urgenza. Lo hanno dimostrato la presenza numerosa ai Death cafè e al LARP (gioco di ruolo) in cui i partecipanti hanno avuto una parte fortemente attiva; e le centinaia di persone che hanno assistito all’intera rassegna proposta: dal cinema, al teatro, alle conferenze”. Per gli appuntamenti autunnali sono stati invitati alcuni nomi significativi della scena culturale, sociale e spirituale italiana: il giornalista Domenico Iannacone, in tour con il reading CHE CI FACCIO QUI, ispirato all’omonimo programma televisivo, in onda dal 2019 su Rai 3; padre Guidalberto Bormiolini, monaco e teologo, della comunità dei Ricostruttori nella preghiera, che si occupadiaccompagnamentospiritualedeimorenti;LauraCurino,autricee attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione, con il suo nuovo spettacolo Big Data B&B; numerosi professionisti del territorio, impegnati nel delicato mondo delle cure palliative e del fine vita, che incontrerannoilpubblicopermomenti di confronto e informazione.
“Un progetto partito in sordina –sottolinea il project manager Davide Lo Duca – che ha trovato nella rete e nelle molteplici competenze messe in campo la forza di cambiare rotta e incontrare il bisogno del pubblico, anche al di là delle necessità pratiche. Nell’adempimento del percorso progettuale che ha portato alla realizzazione di una piattaforma tecnologica dedicata ai portatori di cura (caregiver familiari e professionali) e a un incremento del supporto psicologico anche territoriale per i pazienti e le loro famiglie, si sono intercettati altri bisogni e con delicatezza e attenzione si sono trovate strade e linguaggi per cominciare a soddisfarli”.
In questo nuovo capitolo, il focus della rassegna si è orientato, come richiama il titolo “Che la morte ci colga vivi: NOI FRAGILI, NOI IMMORTALI”, sulla presa di coscienza, forse amplificata dai due recenti anni di pandemia, della precarietà delle nostre esistenze e sulla ricerca di significato del nostro viaggio terreno.
Dopo il Covid, “Fragili” è diventato una categoria di cui nessuno può dirsi estraneo. Forse allora la fragilità va compresa e inclusa come parte della vita, come struttura portante, e non essere considerata un aspetto da nascondere, a fronte di un’invincibilità poco umana. Pallium è anche questo: un’occasione per interrogarci e comprenderci nelle nostre “parti molli”, vedere se, sotto al carapace della nostra ostentata forza, possiamo attivare i superpoteri dell’ascolto e dell’accettazione.
Cristina Barberis Negra,
ANotizie e cronache
Domenico Iannacone
Guidalberto Bormiolini
Laura Curino
CALENDARIORASSEGNA
Pallium:appuntamentidisettembre
UltimiappuntamenticonlarassegnaChelamortedicolga vivi organizzata, nell’ambito del progetto Interreg Italia –Svizzera Pallium, per sensibilizzare al tema delle cure palliative, dellafragilitàedell’accompagnamento allamorte.
Domenica17settembre, ore18.00
IlKantiere-Possaccio/Verbania
GIOCODIRUOLO:ASPETTANDOILVOLOGO901
Facilitatore:MauroDiluca
Un’esperienza immersiva nell’incertezza del destino delle persone che amiamo e nei pensieri che ci affollano la mente durante la loro attesa, conducendoci sommessamente nello sgomentoperlaperditadiqualcuno vicino anoi.
Giovedì21settembre, dalleore17.00 alle19.00
CasadonGianni- Domodossola
DEATHCAFÈ
Facilitatrice:FrancescaOliva,psicologa,formatriceesupervisoreoperatorievolontariHospiceSan Rocco
Inunclimainformale,un’occasionediriflessionecondivisa, sensibilizzazioneeformazioneperacquisireconsapevolezza e porsi interrogativi sul tema vita e morte. Momenti preziosi peraffrontarecollettivamentepaureeturbamentiriguardanti ilsensodell’esistenzaelasuaconclusionesenzatabù.
Venerdì22settembre,ore21.00
Spazio Sant’Anna-Pallanza/Verbania
TALKSHOW:SI PUÒDIRE MORTE
DavideSisto,filosofoetanatologo
MarinaSozzi,filosofa,direttriceSAMCO OdV
Interventiteatrali: SilvaCristofari
Conduce:FrancescaOliva,psicologaeformatrice
Perché evitiamo la parola morte? Perché ne deleghiamo la gestioneallamedicina?Comeaffrontiamoillutto,comeelaboriamo la perdita? Con l’aiuto di due filosofi, esperti nel rapporto vitamorte - tecnologie, proveremo a fare luce su alcunitabùcontemporanei,interrogandocisullenostrepaure ancestrali, e ponendoci domande sulla nostra memoria ed ereditàdigitale.
Ingressogratuitofinoaesaurimento posti
Che la morte ci colga vivi: NOI FRAGILI, NOI IMMORTALI
Domenica8 ottobre, ore20.30 - SpazioSant’Anna
Ilvaloredellatecnologiaedelconfrontotransfrontaliero acuradiSimonaFerrari, coordinatriceCREMIT eDavideLo Duca, projectmanagerdiPallium
Aseguirespettacoloteatrale
BIGDATAB&BdiLaura Curino.
Sabato14ottobre, ore21.00- CasadonGianni
Conferenza: INCONTROAROMATICO
Prendersicura con…l’Aromaterapia
Relatore: Rosella Tolini, Coordinatrice Infermieristica dell’Hospice San Rocco ASL VCO; Infermiera esperta in disciplineolistiche
Giovedì26 ottobre,ore18.30 -CasadonGianni
AP(P)ERICENA
Workshopinformalerivoltoaicaregiver,aifamiliarieatutte le persone interessate al tema delle cure palliative e del fine vita.Un’occasionediincontrodirettoconlefigureprofessionalidisupportomultidisciplinareallecuredomiciliari.
Aseguirealleore21.00
Conferenza: UNABBRACCIO INTEGRALE
Prendersi cura di corpo, psiche e spirito per dare un sensoallasofferenza
Relatore: padre Guidalberto Bormiolini, religioso, scrittore,tanatologo.
Domenica19novembre, ore20.30
TeatroIlMaggiore-Verbania
NOI FRAGILI,NOI IMMORTALI
Le evidenze emerse con il progetto Pallium: il bisogno di parlaredellanostraprecarietàumanaediprendercenecura. PresentazionediGLOSSARIOFRAGILE
ProgettoeditorialenazionalediLegacoopSocialicheesplora eridefinisceleparoledellafragilità.
Aseguire
Readingteatrale: CHE CI FACCIOQUI diecon DomenicoIannacone.
Perinformazionipallium@cooplabitta.it
Pgg. 46-47 Alternativa
1a edizione
Per una cultura delle cure palliative Bisogni, protagonisti e ruolo della tecnologia
Percorso formativo gratuito online

a cura di CREMIT - Università Cattolica in collaborazione con i partner Pallium

Rivolto a personale sanitario (medici palliativisti, infermieri, OSS, medico di medicina generale, altri specialisti), psicologi, volontari, caregiver familiari


5 moduli per approfondire le cure palliative: il modello italiano e il modello svizzero la cura spirituale , il ruolo del volontariato sul territorio e nella relazione con il paziente e i familiari il ruolo della tecnologia nelle cure palliative , dall’analisi delle soluzioni tecnologiche esistenti allo sviluppo di un ’app per il caregiver

Ogni modulo prevede videolezioni e approfondimenti tematici in lingua italiana e francese. Per favorire l’apprendimento, i materiali, fruibili in qualsiasi momento della giornata , saranno rilasciati gradualmente e sarà possibile contare sul supporto di un tutor e partecipare a forum di discussione .
Per ParteciPare è necessario registrarsi alla piattaforma eduopen https://learn.eduopen.org/ e iscriversi al MOOC entro il 1 ottoBre 2023

PER INFORMAZIONI:
serena.triacca@ unicatt.it - martina.morreale@unicatt.it
Per chi lo desidera l’attestato di partecipazione è rilasciato dalla
CREMIT _cremit_

ANotizie e cronache
MOOC Massive Open Online Course
Operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
Capofila italiano Capofila svizzero Partner In collaborazione con
piattaforma EduOpen dopo aver superato i test a conclusione di ogni modulo
COMUNITÀ EDUCANTE VCO
“Comunità educante
collettività che ruota intorno ai più giovani. Una comunità che cresce“con”loro, e non solo per loro; che educa gli adulti del domani, ma che si fa anche educare e cambiare da loro. Per far nascere una comunità educante è necessario coinvolgere tutti i soggetti del territorio nei progetti per riportare i ragazzi e le loro famiglie al centro dell’interesse pubblico. Condividendo strumenti, idee e buone pratiche è possibile raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita di bambini e ragazzi, che diventano non solo destinatari dei servizi, ma soprattutto protagonisti e soggetti attivi delle iniziative programmate e attivate” – (Fondazione Con I Bambini)
Francesca Bologna
Sul territorio del VCO si sta avviando una progettualità che porterà, nel corso dei prossimi due anni, alla costituzione e al potenziamento di una Comunità Educante a livello provinciale.
Grazie alla vincita del bando Comunità Educanti di Fondazione Con I Bambini, con il progetto Comunità In Crescendo V.C.O. - Voce, Coro, Orchestra!, una rete pubblico-privata, ad oggi formata da 21 Marzo APS, CISS Verbano, CISS Ossola, CISS Cusio, La Bitta, Gruppo Abele di Verbania,Associazione Tra il Dire e il Fare, Associazione Culturale Mastronauta, EN.A.I.P. Piemonte, VCO Formazione, Associazione SuoniAMO e Comitato Territoriale CSI, con tutti gli enti che nel corso del progetto si uniranno alla rete, avrà l’opportunità di lavorare alla costituzione di unaComunità Educante attiva su tutto il territorio provinciale.
Una Comunità Educante ambisce a configurarsi come punto di riferimento educativo saldo e duraturo nel
tempo, per contrastare la povertà educativa e potenziare il protagonismo giovanile, a partire dalla premessa che ciascun attore a livello territoriale è importante per creare le condizioni necessarie a raggiungere questi obiettivi. Da quest’ultima consapevolezza nasce l’impegno concreto nell’attivazione di azioni di rete che si estendano sui tre poli della provincia.
Tra queste, l’avvio di un’analisi competente e una mappatura dei dati sulla povertà educativa e sulla situazione giovanile a livello provinciale, sia a partire dai bisogni dei beneficiari sia in relazione all'offerta dei servizi attivi a livello territoriale, grazie alla consulenza di un attore esperto e competente come Codici e al sostegno parallelo di un attore come Fondazione Comunitaria VCO.
Punto di primo interesse è anche la realizzazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione diversificati e indirizzati ai soggetti interessati dal tema educativo e giovanile nel VCO,
come docenti, maestri, policy makers, rete degli psicologi, con l’obiettivo di fornire capacità di lettura e attenzione ampia e diffusa al problema della povertà educativa e del benessere degli adolescenti, ma anche percorsi di arricchimento delle competenze della Comunità Educante rivolti a operatori e soggetti responsabili “sul campo”.
La Comunità Educante si occuperà anche di offrire percorsi di sostegno alla genitorialità, attraverso approcci differenti e co-definiti con i genitori stessi, allo scopo di creare il contesto migliore per la piena espressione e per la definizione di uno spazio di ascolto attivo.
Nel corso dei due anni di progetto, la rete lavorerà anche all’integrazione della Comunità Educante territoriale con gli istituti scolastici del territorio e alla realizzazione di corsi ed eventi ludico/artistici/culturali/sportivi in coprogettazione con i giovani coinvolti.
Pgg. 48-49 Alternativa
è l’intera
NELL’OFFICINA DI “NEL
SILENZIO E NEL VENTO”: VIAGGIO VERSO LA COSTRUZIONE DI UN ROMANZO
La nascita e la crescita di un libro sono esperienze che richiedono studio, determinazione, pazienza e tempo; è come affrontare un’avventura tra i propri sentimenti e i personaggi che dovranno impersonarli per accendere nella mente del lettore quello che c’è nella mente dell’autore. Quello che segue è proprio il viaggio verso la costruzione di un romanzo.
Lorenzo Pavesi
Non posso negare che, una mattina del giugno scorso, leggendo il messaggio che mi era appena arrivato dalla redazione della Rivista di Alternativa, ho provato un po’ di timore. “Ciao Lorenzo, ti farebbe piacere se ti chiedessimo di scrivere un articolo sul tuo libro?”. Era la prima volta che qualcuno mi chiedeva di scrivere un pezzo su me stesso, o quantomeno su un mio lavoro. E non avevo la minima idea di come farlo senza risultare oltremodo pesante. Da un lato c’era il rischio di scadere nell’autocelebrazione: terribile e inopportuno. Dall’altro il pericolo di inondare la pagina di retroscena, minuzie e dettagli totalmente incomprensibili per chi non avesse letto Nel silenzio e nel vento. Ci ho pensato un po’, poi ho deciso. Invece di parlare del contenuto del libro, avrei raccontato un’esperienza: quella che un autore dilettante ha vissuto cercando di dare vita a un romanzo. Un viaggio durato cinque anni: un’avventura vera e propria, da cui sono emersi degli spunti che penso possano essere interessanti.

Autoanalisi e scrittura: un ciclo continuo Dicono che la trama di un romanzo, per funzionare, deve guidare il lettore verso la risposta a una domanda fondamentale. Beh, quella di Nel silenzio e nel vento è senza dubbio: “Riusciranno i due protagonisti a superare il lutto che hanno subito ricominciando ognuno la propria vita?”. È la stessa domanda che mi sono posto io qualche anno fa. E, come me, le tantissime persone che hanno subito la perdita di una persona cara in modo tragico, soprattutto se accaduto prematuramente. La scrittura di questo libro non è partita a tavolino con l’obiettivo di seguire il sogno di una pubblicazione, ma è iniziata come un’esigenza personale: quella di esprimere qualcosa che avevo dentro e che facevo fatica a esternare. Ho cercato di raccogliere le idee, di capire ciò che quel lutto mi aveva lasciato e mi aveva insegnato. Quindi, ho pensato
come avrei potuto far vivere un’esperienza simile a dei personaggi che avrebbero potuto racchiudere molte più cose, infinite sfaccettature di un percorso che ha un solo passaggio obbligato: lo scorrere del tempo. Pensavo che in quattro e quattr’otto una buona storia avrebbe preso vita: non sapevo che, invece, anche in quel caso sarebbe stato necessario far scorrere parecchio tempo. E, soprattutto, non mi ero reso conto che non avevo mica le idee così chiare, in fin dei conti. Grazie alla scrittura ho scoperto nuovi aspetti di me e nuovi stimoli per andare più a fondo; allo stesso tempo, ho capito che l’elaborazione di un lutto è un percorso che trova sempre nuove dimensioni.
Istruzione a rischio distruzione
“Ho dovuto seguire molti corsi di scrittura, sai? Beh, ma tu sei laureato in Lettere, non ne hai certo bisogno”.
ANotizie e cronache
Ricordo molto bene queste parole che un’autrice, un paio d’anni dopo l’inizio del mio lavoro, mi rivolse quando le raccontai del romanzo che stavo scrivendo. Mi sono rimaste impresse perché contengono alcuni stereotipi che continuano a farmi riflettere.
Passava il tempo, la prima stesura era conclusa ma quel romanzo continuava a non convincermi. Quando chiedevo a qualcuno di leggerlo mi accorgevo che c’era un problema di fondo: era come se non riuscissi ad accendere nella mente del lettore quello che c’era nella mia. Non venendone a capo, ho iniziato a seguire anche io qualche corso di scrittura privato. Mi si è aperto un mondo. Ho scoperto che oltre all’analisi critica di un’opera esistono una marea di studi sui processi creativi e sulla costruzione concreta di un testo letterario di cui non avevo mai sentito parlare. Nel mio romanzo c’erano, disseminati ovunque, difetti legati alla struttura, alla focalizzazione della vicenda sui personaggi, alla centralità del tema di fondo. E io non me n’ero mai accorto. Da quel momento si sono susseguite un paio di riscritture complete del libro, e una serie di revisioni piuttosto corpose. Insomma, l’ho rivoltato come un calzino finché non ne sono stato convinto. Allo stesso tempo, ho tratto un insegnamento importante per quello che è il mio lavoro, il docente di Lettere. Ovvero che, di qualsiasi ambito si tratti, le persone hanno bisogno di imparare non solo ad analizzare il lavoro degli altri, ma anche di creare qualcosa di proprio. E, se questa componente manca nell’offerta formativa, rischia di ottenerla solo chi, in seguito, ha le possibilità per pagarsi il superamento delle lacune pregresse.
Dal pc alla carta
Quando un libro è concluso non è altro che un file Word, e così era Nel silenzio e nel vento. Il percorso per trasformare un file in un libro stampato è un’avventura a sé, specialmente per un esordiente che non ha certo milioni di follo-
wers su Instagram. Pubblicare un libro, oggi, segue sostanzialmente due strade: il self publishing o un campo minato in cui ti devi preparare a ricevere un sacco di porte in faccia. Ho escluso da subito la prima opzione perché ero consapevole di non essere in grado, poi, di commercializzare il libro, e mi sono preparato a una serie di disavventure piuttosto demoralizzanti. Lo scopo di un editore, in fondo, è vendere più copie possibili di un’opera, e pubblicare quella di un ragazzo che non ha nemmeno trent’anni e una rete di conoscenze essenzialmente locali sarebbe stato evidentemente un azzardo. Sembra assurdo parlare di difficoltà ad arrivare in libreria se si pensa che in Italia ogni anno vengono pubblicati quasi 80mila titoli. Un po’ meno quando si scopre che questo mare magnum pullula di proposte editoriali a pagamento, pubblicazioni a edizione singola, contratti irregolari o addirittura assenti. L’aiuto di qualche conoscente e una
buona dose di fortuna mi hanno assistito, permettendomi di incontrare un’editrice seria, affidabile e soprattutto chiara. “L’ambientazione mi piace e la trama pure: se hai pazienza qualche mese te lo pubblico in una collana della mia casa editrice”. Alla fine, complice qualche ultimo ritocchino, c’è voluto ancora un annetto. Ma poi è iniziata finalmente quella parte di storia che oggi continua nelle librerie. È stata la conclusione di un viaggio e, allo stesso tempo, l’inizio di un altro. Che è tutt’ora in corso.

Pgg. 50-51 Alternativa
SCUOLA PRIMARIA: TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Da più di trent’anni lavoro nella stessa scuola primaria, sulle colline di Verbania, seguo il naturale avvicendarsi delle classi e, ogni cinque anni, al cambio del gruppo di alunni, tra colleghe e colleghi si commenta quanto cambino i bambini e quanti problemi emergano sempre di più, nella gestione quotidiana dei rapporti tra pari e tra bambini e adulti. Negli anni si sono aggiunte anche frizioni relazionali, sempre più abituali, tra insegnanti e genitori, proprio per la visione differentesullestrategieeducative.
I cambiamenti più rilevanti riguardano i disturbi comportamentali legati alla gestione e alla regolazione degli impulsi e allaconseguentedifficoltàasostenerelefrustrazioni. Perquestomotivo,concrescentefrequenza,ibambinivengono inviati presso i servizi di Neuropsichiatria Infantile, ma molti disagi rimangono sommersi e diventano problemi nella gestionequotidianadellaclasse. Glieducatori,ipedagogistieglipsicologirilevanoedescrivono i malesseri dei bambini, che spesso vengono classificati comepatologieinfantili,sintetizzandoneledescrizioniecomunicandoirilieviattraversocategoriediagnostiche.Negliultimi anni a scuola sono sempre più in uso acronimi come, DSA, DAA, FIL,ADHD, DOP, DC,ASD 1, ampiamente utilizzati neltentativodicapireedescrivereledifficoltàdiapprendimento,lesofferenzepiùesplosive,caratterizzatedamanifestazioni comportamentaliprovocatorie,aggressiveedistruttiveversole cose o le persone, o ancora, le espressioni mute, implosive di chiusura e allontanamento dalle relazioni, dalla vita sociale e dall’accogliereperimparare.
Nell’Istituto Comprensivo presso cui lavoro, per vari anni mi sono occupata dell’osservazione delle espressioni del disagio sommerso nei bambini, dalla scuola materna alla scuola primaria.Anchegrazieaquestaesperienzamicapitadipensaree dirifletteresulleproblematicheemergenti.Trefilonidipensiero si manifestano con una certa costanza, relativamente a ciò che sono i bambini, al ruolo delle famiglie e al compito della scuola.
Guardoibambiniesonosemprepiùconvintachesianoentità chenoncambianoneltempo. Sonoefannoibambinidasempre: vogliono subito ciò che desiderano con tutte le forze, non intendono fermarsi se ciò che stanno facendo è irresistibile, contrattano o protestano con ogni mezzo per mantenere i propribenefit.
Ciòchevamodificandosièlamodalitàdellaprotesta,finalizzata al riaffermare e al permanere nella situazione di confort, perché cambia l’approccio del mondo adulto alle emozioni e
agliaffettideibambini,soprattuttonelleespressionipiùscomode.
I bambini sono le avanguardie dell’evoluzione dei gruppi sociali, osservandone i comportamenti si possono cogliere le anticipazioni dei cambiamenti non ancora contemplati e scorgere il sentiero imboccato dalla società umana, così la comprensionedeldisagiodell’infanziaciconsentediriflettere suimutamentidelruologenitorialeeingeneraledegliadulti.
Grazieallestorichelottediemancipazioneealboomeconomico, negli anni ’80 e ‘90 sono cresciuti l’ambizione, l’affermazione personale e professionale dei genitori, si è ampliata la possibilità di mantenere un’attiva vita sociale e l’idea di migliorare la propria esistenza e di investire sui figli. Piùrecentemente,invece,l’introduzionedella“flessibilità”del lavoro, ha reso il contesto sociale ed economico instabile e sempre più caratterizzato da incertezza, qualitativamente più precarialavitadellefamiglie,cosìlasocietàèdiventata“vulnerabilizzante”.Leideedifuturoediriscossapersonale,sempre presenti,orasonodensediinsidie,difficoltà,timorieinvidie.
Dall’investimento narcisistico positivo dei figli, si è passati a limitarel’investimentodelfuturonelfigliounico,conlapaura dellanonriuscitaedellarabbiaversol’altro.
Come ben espresso da Matteo Lancini 2, si è passati dalla “Famiglia narcisistica”, caratterizzata dall’investimento sui bambini delle aspettative e degli ideali, frutto della proiezione genitoriale,allapiùrecente“Famigliapostnarcisistica”.
Oltre a crescere bambini caricati dei desideri e degli ideali dei genitori,quindisollecitatiprecocementedapiùesperienzeportatrici di successo e popolarità, si assiste al crescente allontanamento dai bisogni e dalle emozioni dei bambini: i genitori non vogliono confrontarsi e specchiarsi nei vissuti di pauraenell’insuccesso.
Gliadulticredonodistareaffettivamenteviciniedisostenerei propri figli affinché si affermino, ma secondo l’ideale genitoriale, inoltre, entrano nella loro mente per indicare la qualità e la tempistica delle emozioni, negando l’autenticità del bambinocherimaneinascoltatoeinesistentecomesoggetto.
Sipotrebbeparlarediipocrisiaoforsemegliodidissociazione, allabasedellerichiesteeducativeattraversolequalisiindicaai bambinicosapensare,cosaprovareenelfornirelespiegazioni elemotivazioniallabasedeicomportamenti.
Il bambino è negato, così come le sue emozioni e i suoi sentimentiautentici.
Igenitorisorveglianocomemastinilaformazioneperfettadei figli, attraverso un’organizzazione serrata dell’istruzione, che comprende anche i momenti ludici, ormai snaturati e regola-
1 DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento. DAA, DisturbiAspecifici dell’Apprendimento. FIL, Funzionamento Intellettivo Limite. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Disturbo da DeficitAttentivo e/o Iperattività. DOP, Disturbo Oppositivo Provocatorio. DC, Disturbo della Condotta.ASD (Autism Spectrum Disorder), Disturbi dello SpettroAutistico.
2 M. Lancini, Sii te stesso a modo mio, Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta, Raffaello Cortina Editore, 2023
Adalla scuola
Nives Cerutti
mentaticomeunlavoro.
E,peribambinipocoprestanti,ochenonvoglionostareaquesto gioco, si ricorre agli esperti. Le sigle diagnostiche citate, l’usoestremizzatoepresuntuosodelledescrizionidiciòcheil bambinoviveemotivamente,segnalanounallontanamentoda ciòcheesprime,daciòcheè,genuinamente.
Oggi,ancorpiùdisempre,misembrasianecessariorinforzare lefunzionigenitorialinegliaspettidiascoltodelbambino,per partecipareconluiallesueesperienze,perstareconunbambino reale, anche quando non corrisponde ai canoni adulti del bambinoimmaginato.Sonosemprepiùfrequenti,nellaquotidianità delle famiglie, situazioni in cui si alternano attività superorganizzate e performanti, a momenti di assenza, nei quali si concede di continuare nelle occupazioni desiderate, ampliandoitempi,accordandodilazionienoncontrollandole situazioni emotivamente immersive, come i giochi elettronici, social,cellulari,purdinongestireleprotesteegliattacchirabbiosi, che mettono a disagio e generano anche sensi di colpa nei genitori, perché alimentano vissuti di inadeguatezza e non affettività.
L’aspettodissociativoèvisibileosservandoibambinichecrescono e vivono in compagnia di adulti molto apprensivi, ma non in ascolto. Le famiglie forniscono attenzioni e stimoli e sono sempre vigili su possibili errori dei delegati alla crescita dei figli. Ma l’essenza dell’infanzia è l’invisibilità emotiva: i bambininonsonomaisoli,masonosempresoli.
Un bambino si arrabbia quando viene ignorato, quando non vieneascoltato,perquestosonoincrescitaidisagicaratterizzatiodall’accumulodirabbiachepuòdiventareesplosivaeagita sudiséesulmondo,oppurecausareunritiroemotivoeaffettivo.
Nell’adulto manca l’accoglienza dei conflitti, delle sofferenze edeidoloridell’infanzia,tuttiaspettinegatiperchéincontrasto conilbambinoidealizzato;gliaffettirimangonosenzaparole, senza espressioni elaborative e si trasformano in comportamentieazionidiscarico.
Quanti esempi di genitori che intervengono durante le attività sportive, ignorando la presenza dell’istruttore, ignorando il bambinoeimpartendocomandiabordovascaocampo!Quante storie scolastiche in cui i genitori criticano o arrivano a denunciareinsegnanti,persceltevissutecomelesivedeldiritto del proprio figlio, negando la possibilità dell’assunzione della responsabilità,ancheseilfiglionondàsegnididisagioversoil personalescolastico!
Il ruolo della scuola nella crescita dei bambini è centrale. Gli insegnanti ricevono obbligatoriamente la delega educativa, nonprivadiambiguitàedicostanticritiche. Lascuolasioccupastabilmente,perparecchieorealgiorno,di offrire la stimolazione necessaria allo sviluppo delle funzioni cognitive, della conoscenza, delle competenze relazionali, affettive,socialiediquellelegateallaproduttivitàfutura. Le critiche costanti alla scuola sono centrate soprattutto sull’esseresempreunpassoindietrorispettoallasocietà.Della scuolasidicecheoffraesperienzevecchieechearranchidietro alle galoppanti evoluzioni tecnico scientifiche. Forse questo aspetto è critico a livello delle scuole secondarie, che devono poteroffrireunambientecheproiettiprestonelmondo.Ma,a livello della scuola primaria, dove l’aspetto principale è la primaformazionedellerelazionisociali,secondoilmiopunto di vista, il difetto diventa un inconsapevole punto di forza.
L’organizzazionerigidaeirapportitraglioperatoridellascuola, obsoleti e retrogradi, l’inefficienza nello stare al passo, propone costantemente un ambiente vecchio e tradizionale, cheportaconsél’aspettoeticoemorale,frenoalladerivaedonistica ipertrofica dei bambini. Numerosi e in crescita gli episodiincuisiassisteacontestazionideigenitori,ancheviolente, nei confronti di insegnanti che hanno messo in atto disposizionivissutecomelimitantienontollerabili.Credoche il punto di partenza per il rinnovamento della scuola possa essereladiscussioneelacondivisionedell’importanzaeducativa delle funzioni di ascolto, di regolamentazione, di attribuzione di significato ai conflitti che i bambini vivono e dellasupervisione“adistanza”deimomentidigioconondirettodall’adulto.
Durantelamiaformazionealcunidocenti,chehoavutolafortuna di incontrare, tenevano molto allo sviluppo della conoscenza degli autori classici della psicologia e della pedagogia. La riflessione implicita in questo percorso era la seguente: “Solo passando attraverso la completa assimilazione dei fondamentali si può criticare, superare, cambiare, e modernizzare.”.
Inogniepoca,lascuoladeveorganizzareun’innovativametodologiaeducativo-didattica,legataalleevoluzionidellasocietà umana, senza però cedere alla tentazione di utilizzare come rigurgiti le varie metodologie che in passato hanno avuto l’intuizione e la possibilità di esprimersi e rinnovare. In momentistoricicruciali,densidigrandicambiamentiosuccessiviamomentioscuriedolorosi,sonoemersitalentichehanno proposto visioni rivoluzionarie e prassi pedagogiche all’avanguardia. Ciò che in ogni tempo, al di là di ogni teoria pedagogica, psicologica e sociale, rappresenta il bene trasversale è l’offerta di una visione e riflessione etica dei comportamenti umani e, nel concreto quotidiano del lavoro educativo,deisoggettichelascuolalafanno.
Quandolascuolaricercauncambiamentovolgendosialpassato è come se sentisse l’urgenza di una trasformazione importanteenecessaria,senzaesserecapacedidarevitaauna nuova rivoluzione, come se mancassero una spinta forte e un pensiero creativo, capaci di coniugare delle idee audaci e coraggioseconibisognisocialiemergenti.
Daqualcheannolascuolaprimariaèinfermentomaleproposte sono ancora troppo indeterminate. Si introducono nuove terminologie supportate da riesumate esperienze, ancora forti nell’immaginario dell’innovazione, ma scollegate dai bisogni edailimitidellasocietàattuale.
Inogniperiodostoricoladidatticadeveevolvereinosmosicon la realtà ma, ciò che deve restare, come fondamentale di ogni azioneeducativa,èlafunzionedicura,diprotezioneediascoltodell’adultoversol’infanzianell’immediatoecomeprogetto futuro.
Sempre, genitori, educatori e insegnanti hanno il compito di tutelare fisicamente e psicologicamente i bambini. In ogni momentodevonocontrollare,valutare,regolamentareeanche vietare azioni che potrebbero rivelarsi dannose. Devono saper proporre,incoraggiareesostenerelenuoveesperienze.Insomma, accompagnare, indirizzare, proteggere, stimolare, lasciar fareesoprattuttostareinascolto,essercieaiutarenelsostenere lefatiche,lepaureenell’elaborarel’erroreeildolore.
Pgg. 52-53 Alternativa
BREVE VIAGGIO NEL
FEMMINISMO, IL MOVIMENTO CHE HA CONTRIBUITO A FARE LA STORIA DEL NOSTRO PAESE
Laura Luisi
Tantissimoèstatoscrittoafavoree contro il femminismo, un movimentofattodipluralitàdiintentie di forme, pieno di luci e di ombre. Nel corso della storia abbiamo assistito all’evolversidivariecorrentidipensiero, spesso in contrasto tra loro su molti fronti, ma responsabili di aver contribuito, ciascuna a modo suo, ad abbracciarepiùsoggettinellerispettive specificitàedifferenze. Un fatto indiscutibile è la preziosa eredità che il femminismo ha lasciato a generazionididonneediuomini,molti dei quali non del tutto consapevoli del prezzochetalelascitoharichiesto. Difficilepresentarlonellasuacomplessità, quindi iniziamo a conoscere la definizione che ne dà l’Enciclopedia Treccani:“Movimentodirivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne; in senso più generale, insieme delle teorie che criticano la condizione tradizionale della donna e propongononuoverelazionitraigeneri nella sfera privata e una collocazione socialeparitariainquellapubblica”. Nonostante le sue diverse tappe ed espressioni, l’opinione comune vede nel femminismo il permanere, nei decenni, di alcuni elementi di continuitàediconvinzioniideologiche,taliche è considerato, ancora oggi, un fenomeno radicale e ribelle, fattosi strada attraverso manifestazioni e proteste di piazza. In realtà, il femminismo è stato un movimento che ha combattuto per porrefineallosfruttamentodelledonne eall’oppressionesessista,prefigurando una ridefinizione della politica, dando il via a rivolgimenti profondi, indivi-
dualiecollettivi.
I percorsi, gli intrecci, le forme diverse assunte dall'azione collettiva, testimoniatidallevocidelleprotagoniste,sono statipubblicatidal“Centrodistudistorici sul movimento di liberazione della donna in Italia” nel 1985, e rappresentano un patrimonio prezioso, non solo per la storia di una generazione di donne,maperlaletturadelpresente. Anche se influenzato dalle esperienze vissute al di fuori dei propri confini, il femminismo italiano rimane ben radicato nella realtà sociale, politica e culturale della storia del paese, innestandosiinparticolareinunatradizione di lotte del movimento operaio, e presentandosi come movimento di liberazione della donna, aspirante a un cambiamento sociale generale e profondo.
Il femminismo italiano inizia sotto la spinta della contestazione studentesca nel ’68, con l’obiettivo di ricostruire una nuova identità femminile liberata dairuolitradizionali.
Sulla scia della protesta giovanile e operaia italiana degli anni SessantaSettanta, fortemente orientata ad una politicizzazione marxista, il femminismo si trova di fronte a due grandi culture politiche di riferimento, quella marxista e quella democristiana, profondamente restie alla condivisione delle istanze della contestazione. Da qui l’avversione che caratterizza il rapporto delle istituzioni con quello che si definivail“paesereale”,econledonne in particolare.
Dopo la prima fase del’68, durante la quale il privato aveva invaso gli spazi
pubblici, occupando piazze e università, in una condivisione collettiva anche divitaquotidiana,ledonnecominciano ad affrancarsi dai propri “fratelli” portando la politica (la propria politica) dentro casa. Così dalle grandi aule, dalle piazze e dalle manifestazioni, le donnesitrasferiscononeisalottienelle cucine delle proprie case, dove cominciano a incontrarsi per discutere tra loro, segnando un’inversione simbolicapotente.
In quei piccoli contesti emergono i vissuti e le esperienze di ogni singola donna:lafamiglia,ilrapportocoigenitori, con l’ambiente, con gli uomini; entrano i primi discorsi su contraccezione, educazione sessuale e controllo delle nascite: in una parola nasce l’autocoscienza.
In Italia l’aborto è ancora un divieto morale insuperabile, ma nel 1953 a Milano nasce l’A���,Associazione italiana per l’educazione demografica, chenel1955apreaRomailprimoconsultoriodiassistenzacontraccettiva. Nasce così il movimento femminista degli anni Settanta, il femminismo della “differenza” ovvero la separazionedaicompagniedallapolitica.Nasce come conseguenza della presa d’atto che in quel momento storico de donne non avrebbero potuto avere voce in capitolo, soprattutto nei grandi contesti delle assemblee. Femminismo della “differenza”, (per approfondimenti: LiaCigarini,“Laseparazionefemminile”diLiaCigarini,in“Sottosopra”Blu 1987, risposta alla Carta delle comuniste con la quale si dichiarava di voler fare politica a partire dalla propria
Aspazio donna
differenza sessuale. Il testo è ora in http://www.universitadelledonne.it/ separazione%20femminile.htm supportato dalla convinzione che l’entrata delle donne nel mondo produttivo e politico maschile avrebbe inibito ogni possibilità di espressione e presa di coscienza, avrebbe impedito ogni possibilità di misurarsi con le dimensioni politiche ed istituzionali e di esprimere “la differenza” all’interno delle strutturedipotere.
“Tremate,tremate,lestreghesontornate…”, una vecchia filastrocca per bambini diventa lo slogan che scandisce la battaglia di una generazione, quella del movimento femminista italiano, in particolare durante il periodo trail1970,annoincuiesceil“Manifesto di rivolta femminile”, e il 1981, anno in cui dal codice penale escono finalmente due norme sciagurate, il delitto d’onore e il matrimonio riparatore, che davano grandi attenuanti agli autori di violenze sulle donne.
Sull’altro versante rispetto al pensiero della “differenza” si collocano quei gruppi e collettivi che pensano di poter conciliare identità ed emancipazione, liberazione e diritti, e che ritengono necessario misurarsi con le istituzioni, per ottenerevantaggie norme giuste per tutte.
Quest’area di attiviste così eterogenea e articolata, in grado di aggregare posizioni assai diverse e influenze partiticopolitiche (essenzialmente marxista e radicale, spesso foriere di tensioni e fratture), e di raggiungere unaconfluenzadiintenti,hapermesso di avviare battaglie di grande importanza nel corso degli anni Settanta. In nome dell’autodeterminazionedelledonne, si organizzano grandi manifestazioni e si progettano soluzioni su temi quali consultori, aborto, lotta contro la violenza sulle donne. Si costitui-
scono centri per la salute delle donne e consultori.
In Italia ci sono ancora il matrimonio riparatore, il delitto d’onore, l’autorità del marito. La violenza sessuale è un reato contro la pubblica morale, il divorzio non esiste, si muore di aborto clandestinoelacontraccezioneèpenalmente perseguibile. Le “conseguenze dell’amore” sono tutte a carico delle donne, prigioniere del comune pensare e di leggi anacronistiche, donne consapevoli e pronte a rivendicare il diritto ad una sessualità affrancata dalla riproduzione.
Al centro dell’area laico libertaria è il Movimento Liberazione della Donna (Mld),natonel1970,associatoalpartito radicale, dal quale si allontanerà negli anniseguenti.

Il Mld, che avrà un ruolo centrale nelle
grandi battaglie femministe degli anni Settanta, si mobilita per il raggiungimento di una vera “liberazione”, intesa come autodeterminazione sulle scelte riguardantilavitalavorativa,familiare, politicaesessuale.
Tra la fine del 1973 e l’inizio del 1974 apre a Roma il primo Centro per la salute della donna, che svolgerà un ruolo centrale nella riflessione e nella pratica sui temi dell’autodeterminazione, della salute sessuale e della contraccezione.
Ormai la situazione nel paese sta mutando: nel 1974 la maggioranza dellapopolazioneitalianasipronuncia, attraverso un referendum popolare, in favore del mantenimento della legge che nel 1970 ha introdotto il divorzio, portandoaunasvoltaepocale.
Nel 1976 il Mdl occupa un grande palazzo abbandonato al centro di Roma, che diventerà la prima Casa delle donne, primo e fondamentale modello di autogestione femminista. Essoavviauna serie di iniziative, fra cui il consultorio self –help e apre il primo “Centro contro la violenza sulle donne”,drammatica esperienza vissuta, nel silenzio e nell’impotenza, in famiglia, sul lavoro, nei luoghi pubblici.
Dal Centro parte quindiunaproposta di iniziativa popolarecontrolaviolenza dalle donne che vuole cancellare le norme più lesive per la dignità femminile del codice Rocco (ilcodice penaleitaliano del 1930, noto come "codice Rocco", dal nome del Ministro di grazia e giustiziadelGoverno Mussoliniche principalmente ne curò l'estensione), ancora in vigore (all’articolo1°dellapropostaèla richiestachelostuprosiaconsiderato un reato contro la persona e noncontro l’onore).
Segue la nascita di un Comitato promotore che raccoglie le sigle
Pgg. 54-55 Alternativa
Image: Freepik.com
del femminismo più attivo in Italia e che presto darà vita a tante sedi in tutta lapenisola.Lacampagnachenesegue, hailpregiodicoinvolgeretuttoilpaese in dibattiti intensi e condivisi, prima drammatica presa di coscienza collettiva non solo delle norme penali che ancora regolano il paese, ma anche della reale esperienza di aggressioni e maltrattamenti, fino allo stupro che vivono quotidianamente tante donne. Alla fine della campagna contro la violenza sessuale e lo stupro che si svolge frail1979eilmarzo1980,lefirmeraccoltesonoben300.000.
La vasta e capillare sensibilizzazione che ne scaturisce, i mesi di raccolta dellefirme,ilcoinvolgimentodeipartiti, vengono considerati la vittoria più significativa da parte delle proponenti, nonostante la proposta venga approvatasoltantonel1996.
Un’altra grande battaglia vinta, per quelle stesse attiviste, l’organizzazione di una campagna in difesa della legge sull’aborto, conclusasi con successo nel 1981, grazie al voto della popolazione italiana contro la modifica della legge194/1978approvataappena3anni prima. Fu abolito l’istituto del “matrimonioriparatore”(cheestingueilreato di stupro nel caso il violentatore sposi la vittima) e del delitto d’onore (che permette al giudice di comminare pene minime nel caso in cui il delitto sia stato commesso per causa “d’onore”), conunamaggioranzaschiacciante. Con queste lotte si chiude la fase delle grandi battaglie femministe di taglio collettivo. Nel 1982 l’Udi, con una decisioneassemblearedigrandevalore politico e simbolico, sceglierà di tagliare i suoi tradizionali rapporti con ilPciperfareproprieleistanzefemministe.
Daallorailfemminismosiapreaduno sguardo più aperto, esplorando il terreno di altre lotte, facendo fronte a problemi di identità “intersecanti” che le donne devono affrontare, come la “razza”, la classe sociale, la sessualità, e altre discriminazioni basate sulla “sovrapposizione di diverse identità sociali,nonsoloquelladigenere”. Diventa allora importante aprire spazi per tutte quelle donne, facenti parte di più di una minoranza, in quanto appartenentiallaclasselavoratrice,migranti, casalinghe, disoccupate, di etnia diver-
sadaquellaoccidentale. Ecco così che, tra gli anni 80 e 90,il femminismo, forte di una consapevolezza maggiore delle problematiche della diseguaglianza, costituisce reti di appoggio, consultori e centri antiviolenza, che vengono trasformati in servizipubblici.
I social network sono l’elemento chiave del più recente femminismo e gli esempi di attivismo digitale sono tantissimi. Il primo è #MeToo, lanciato contro le molestie sessuali negli Stati Uniti nel 2017, seguito a ruota dagli hashtag di altri paesi: in Italia esiste #QuellaVoltaChe, “progetto narrativo estemporaneo per raccontare le volte in cui siamo state molestate, aggredite, ma anche le volte in cui ci siamo sentite in pericolo e non sapevamo bene perché, e ci davamo delle cretine per esserci messe in quella situazione. Perché il patriarcato che non ti crede è lo stesso che cerca di colpevolizzarti per quello che ti infligge”, lanciatodaGiulia Blasi (scrittrice, formatrice e fomentatrice a vario titolo). L’utilizzo dell’hashtagdovevaavereilcompitodi coinvolgere anche ragazzi e uomini nella lotta contro la violenza sulle donne.
Grazie alle conquiste del passatole ventenni di oggi possono dirsi fieramente "non femministe". Si sentono libere ed è un’ottima notizia. “Chi è nato negli anni ‘90 è cresciuto con la certezzadivivereinunmondoincuile disparitàtrauomoedonnaeranoormai superate. Poi, un giorno, a una riunionelei diventa ‘signorina’, mentre il collega maschio assume automaticamente il titolo di ‘dottore’.Ma il problemanonerarisolto?”
Purtroppo i dati continuano a raccontare un’altra storia. In Italia il divario tra generi nei tassi di occupazione è uno dei più alti d’Europa, e i risultati peggiorano se si guarda agli stipendi e alle presenze nei ruoli di vertice. Nel 2020 sono state uccise 112 donne, 119 nel 2021, 120 nel 2022, 57 dal 1° gennaio al 25 giugno del 2023, quasi tutte in famiglia o all’interno di una relazione.
Lanostrastoriapiùrecenteinsegnache la strada è ancora lunga e la memoria è necessaria.
Il clima generale di tensione, le crisi, i conflitti e le emergenze globali, come
anche il cambiamento climatico, in questi anni hanno ulteriormente intensificato laviolenza contro le donne. Anche ladigitalizzazione, sempre in rapida espansione, ha portato a unaumento della violenza online contro donne e ragazze, rendendo più facile per chi commette abusi raggiungeregliobiettivideboli.
Perfortunaacrescereèanchelaconsapevolezza che qualsiasi tipo di abuso fisico e psicologico sia da condannare. Lariduzionesulargascaladellaviolenzacontroledonnepuòessereraggiunta anche facendo rete tra l’attivismo femminista, le forze dell’ordine, la giustizia,lasanità,lafinanzaealtrisettori.
Oggi possono fare la differenza il potenziamento dei servizi per le donne chesubisconoviolenza,lecaserifugio, la consulenza e tutto il supporto di accoglienza e psicologico; la raccolta di dati pertinenti per conoscere al meglio il fenomeno; il potenziamento di meccanismi di protezione più forti per prevenire ed eliminare la violenza, le molestie, le minacce, l’intimidazione, facendo norme ad hoc; il sostegno dellaleadershipdelledonneedellarappresentanzaneiruolidecisionali. Leduericorrenzechevedonoancorale donne protagoniste, “La giornata internazionaledelladonna–8marzo”e“La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne – 25 novembre”,nonrappresentanosoltanto isimbolidiunpassatodilotte,masono opportunità di incontri e di nuove progettazioni, affinché le donne non smettano di difendere i diritti conquistati, oggi forse in pericolo, e di raggiungere traguardi che sembrano ancoralontani.
“Penso alle donne che hanno combattuto per l'uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti… Quelle che hanno lavorato per assicurare e proteggere il nostrodirittodivoto…Iostosulleloro spalle”
Kamala Harris PrimavicepresidentedonnadegliUsa
Aspazio donna
I principali cambiamenti giuridici:
1. abrogazione del delitto di adulterio è del 1968;
2. legge1º dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” che introduce il divorzio;
3. sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 16 marzo 1971 che pone su un piano di legalità le pratiche contraccettive;
4. legge 19 maggio 1975, n. 151 “Riforma del diritto di famiglia”, che sancisce l’uguaglianza giuridica dei coniugi e la fine della potestà maritale;
5. legge quadro 29 luglio 1975, n. 405 “Istituzione dei consultori familiari”;
6. legge 9 dicembre 1977, n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”, che articola fattivamente il divieto, già costituzionale, di discriminazioni lavorative fondate sul sesso;
7. legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontariadellagravidanza”,chesancisceildirittodiunabortopubblicoegratuitoecancellal’articolo 553 del codice penale contro la diffusione dei contraccettivi;
8. legge 5 agosto 1981, n. 442 “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore” che poneva termine al delitto d’onore e al matrimonio riparatore, sanciti dal codice Rocco;
9. legge 15 febbraio1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”, che trasforma lo stupro da reato contro la pubblica morale a reato contro la persona;
10. il17 maggio 1981, gli italiani furono chiamati al voto per i due referendum abrogativi che volevano modificarelalegge194/1978approvataappena3anniprima.Daunapartec’eralapropostadeiRadicali su una piena liberalizzazione dell’aborto, dall’altra quella del Movimento per la Vita sull’abrogazione della legge 194. Gli italiani alle urne respinsero tutti i quesitiscegliendo di preservare la leggeche consentiva nei primi 90 giorni di gestazione l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, tra il quarto e il quinto mese solo per motivi di natura terapeutica, e ai medici l’obiezione di coscienza;
11. legge n. 69 del 2019 - Codice rosso, che ha introdotto la procedura d’urgenza per i reati di violenza di genere e domestica e ha inasprito il quadro sanzionatorio.
Fonti
• “Che cos’è il femminismo oggi?” articolo di Claire Larkin, BabbelMagazine, 3.3.2023, https://www.youngwomennetwork.com/
• Avoce alta Storia del movimento femminista – RAI Cultura
• Atlante minimo del femminismo italiano - “L’altra rivoluzione - Dal Sessantotto al femminismo” di Elisa Bellè, Editore Rosenberg & Sellier, 2021, pubblicato su OpenEdition Booksil 6.10. 2021
• Stralcio del “Seminario di studi momenti e questioni di storia delle donne”, a cura di Beatrice Pisa, per gli studenti del Dipartimento Scienze Politiche Università Sapienza Roma – a.a. 2017-2018
• “Breve storia del femminismo – Le quattro ondate, dal diritto di voto all’attivismo social” di Maddalena Cerruti, pubblicato il 31.1.2021 su “Discorsivo -MILLENNIALALPOTERE”
• “Dal movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni Sessanta agli anni Ottanta” - FrancoAngeli, Milano 2004.
• “Storia del Femminismo in 4 capitoli: dal 1789 ai Social”–articolodiBeatriceGilettadaElectomagazine, pubblicato Storia In Rete, 4.12.2021.
• Lea Melandri: “Il femminismo non ha fallito, sta cambiando il mondo” scritto da Letizia Giangualano il 13 .12.2022 –Il Sole 24 ore-alleyoop-13.12.2022
• C'è ancora bisogno di femminismo – Elena Ciccarello direttrice responsabile lavialibera-5 marzo 2021 “lavialiberapensieri nuovi, parole diverse”
Pgg. 56-57 Alternativa
AS BESTAS E ALCARRÀS
Sgomberando subito il campo dagli equivoci, chiariamo che il complicato titolo di questo articolo non è il nome di un film, bensì l’unione di due film diversi, “As bestas – La terra della discordia” e “Alcarràs – L’ultimo raccolto”,deiquali parliamo qui parallelamente, date le molteaffinitàeipuntidiincontro:alcuni più immediati, altri meno evidenti ma piùsignificativi. As bestas e Alcarràs sonoentrambispagnoli, entrambi distribuiti nel 2022, entrambi prodotti con un budget ridotto che non ne ha impedito l’approdo ai grandifestivalinternazionalielavittoria di premi prestigiosi, ma soprattutto entrambi hanno un’ambientazione e dei temidecisamenteaffini.

“As bestas” in lingua galiziana significa “lebestie”.Ilfilmèambientatoinfattiin unpiccolopaesedipocheanimeinGalizia, nel nord-ovest della Spagna, dove il franceseAntoineelamoglieOlgahanno decisoditrascorrereiltempodellamaturitàdellalorovita,comprandounterreno dove coltivare verdure ed ortaggi in
modo biologico e risistemare vecchi rusticidipietra,perattirarenuovituristi.
I loro vicini, gli allevatori Xan e Loren, non riescono a sopportare che due francesisisianotrasferitiinquelpostodacui loro, che ci sono nati, vorrebbero solo scappare.
La loro occasione di fuga viene da un consorzio che vorrebbe installare delle pale eoliche, comprando i terreni dei nove proprietari della zona. Antoine però, assieme ad altri due, si è opposto, facendonaufragareisognidiXan.
L’ostilità tra di loro non si ferma alle parole e, da qualche scherzo di cattivo gusto al sabotaggio del raccolto, prosegueinunclimadiviolenzacrescenteche porterà i due a tendere un agguato ad Antoine e farlo sparire. Olga non si dà pervintaementrecercaostinatamentedi ricostruire la verità sulla scomparsa del marito,decidediperseguireillorosogno comune, nonostante la figlia cerchi di dissuaderla e di separarla da quel paese maledetto:inqualchemodol’ambientee isuoicodicihannoavutolamegliosudi lei, che sembra essersi adattata interamenteallaculturalocale.
Alessandro Magrì
AsBestasèilraccontolucidodiundoppio assedio: il primo lo subisceAntoine da parte dei suoi vicini, l’altro è quello della maledizione della terra, che tiene incatenatiisuoifigli.
Ilgiocoalmassacrosinutredelleincomprensioni e dei pregiudizi di due culture diverse, non solo per nazionalità: i colti francesidicittà,chesegnanounidillioin mezzoallanaturaeiduefratelliallevatori, che “puzzano di letame” e temono semprediprendereunafregatura.
“Alcarràs” è il nome di un vero paesino catalano, nell’interno rurale e agricolo, lontanouncentinaiodichilometrieanniluce dalle spiagge e dagli eccessi della costa.
Ilfilmraccontalastoriaditregenerazioni della famiglia allargata Solé, composta da genitori, figli, nonni, zii e nipoti,chedasempretrascorrel’estatein un podere di Alcarrás. Qui gli adulti si occupano della raccolta delle pesche, la cui commercializzazione sembra essere l’unica fonte di reddito della famiglia. Anche i bambini, all’occorrenza, includono piccoli aiuti agricoli ai loro giochi.
ASBESTAS:
Regia:RodrigoSorogoyen
Sceneggiatura:IsabelPeña,RodrigoSorogoyen
Fotografia:ÁlexdePablo
Montaggio:AlbertodelCampo
Scenografia:RogerRosenberg
Interpreti principali: Marina Foïs (Olga Denis), Denis Ménochet (AntoineDenis),LuisZahera(XanAnta)
Produzione: Arcadia Motion Pictures, Caballo Films, Cronos
Entertainment,LePacte
Distribuzioneitaliana:MoviesInspired
Durata:137'
Origine:Spagna,Francia
Datadiuscitaitaliana(Cinema):13/04/2023
DatadiuscitainDVD:23/08/2023

A il film
Il possesso della terra è basato da un accordooralechesiperdenellanottedei tempi e la famiglia Solé non ha alcuna difesa contro i piani del legittimo proprietario, erede di colui che aveva fatto l’accordoverbaleconilnonnoSolé,che vuole installare sul terreno, al posto dei peschi,unadistesadipannellisolari.
In entrambe le pellicole, le premesse paionoquellediunfilmdidenunciacontro la modernità, contro i poteri forti a scapitodeipiùdeboli,control’industrializzazione a tutti i costi e la fine del mondo rurale, per quanto rappresentata dall’avvento di energie rinnovabili (moltopiùdiffuseinSpagnacheinItalia, peraltro).
Ma, in entrambi i film, l’avvento delle paleeolicheodeipannellisolariinluogo dei campi coltivati non rappresenta altro che un pretesto, una premessa che si esaurisce nei primi minuti di pellicola e che ha il solo scopo di scatenare, e raccontare,iconflittiinternidellacomunità. Una comunità ristretta e chiusa, dove si parla una lingua incomprensibile a chiunquenonsiadellazona(ilgaliziano
in un caso e il catalano nell’altro) e che richiede quindi i sottotitoli anche per lo spettatorespagnolo.
Nelcasodi As Bestas,quindi,ilracconto si fa più interessante nell’epilogo che nella costruzione drammatica iniziale. La fotografia livida punta ad evitare qualsiasi idealizzazione del paesaggio naturale. E il segreto del film non sta tantonellapartethriller,quantoinquella finale,segnatadaunatestardaresistenza femminile, che trova anche il modo di risolvere le questioni in sospeso con la riaffermazionediunmatriarcatodifatto, più lucido e tollerante della bestialità degliuomini.
InAlcarràs,doveipresuppostifarebbero immaginare una guerra di nervi tra la famigliamandataviadaunaterracheha sempre considerato sua e i costruttori pronti a distruggere tutto, l’unica battaglia messa in scena è quella degli agricoltori contro le grandi distribuzioni sulprezzosvilentedatoailoroprodotti.I camion che trasportano i pannelli solari entrano in scena molto più tardi e sem-
brano scalfire appena la quotidianità della famiglia Solé. La minaccia di perderetuttoèinizialmentesoloaccennatae non diventa mai il problema che fa passare tutto in secondo piano. Quest’assenzafainmodochearisaltare siano altre questioni che stanno più a cuorealregista,tutteinrelazionetraloro: lacrescitaeleprospettivedeigiovani,la trasmissionedeivaloritragenerazioni,la sintesipossibiletramodernitàetradizione.
Un ultimo parallelismo tra i due film sta nell’ottimo successo di critica e pubblico: Alcarràs ha vinto l’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2022, As bestas ha invece dominato i premi Goya (il più importante riconoscimento del cinema spagnolo), vincendo, tra gli altri, quelli permigliorregista,attore(protagonistae non),sceneggiaturaefotografia.
ALCARRAS:
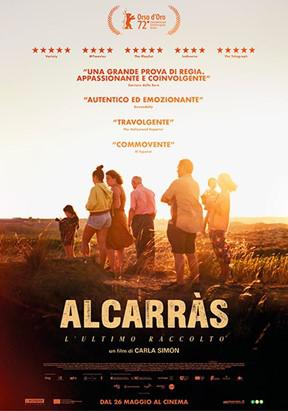
Regia:CarlaSimón
Sceneggiatura:ArnauVilaróeCarlaSimón
Fotografia:DanielaCajías
Montaggio:AnaPfaff
Scenografia:MónicaBernuy
Interpreti principali: Jordi Pujol Dolcet (Quimet), Anna Otin (Dolors)
Produzione: María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera e SergiMoreno
Distribuzioneitaliana:IWonderPictures
Durata:120'
Origine:Spagna,Italia
Datadiuscitaitaliana(Cinema):26/05/2022
DatadiuscitainDVD:17/01/2023

Pgg. 58-59 Alternativa
Qualche imprevisto è sempre da mettere in conto quando si è in viaggio, ma la rottura del blocco pedali in un tour ciclistico è davvero fastidiosissimo: se non altro, basta alzare gli occhi al cielo, non per trovare chissà quale aiuto, ma per ammirare il Reichsburg Cochem, che dalla collina domina la cittadina di Cochem, al tempo importante citta commerciale sul fiume Mosella. Come il suonomesuggerisce,èuncastello imperiale ricostruito dopo l’incendio che lo distrusse quasi interamente, ad esclusione della torre delle streghe, luogo di uccisione delle povere vittime della superstizione e della stupidità umana.
Risolto il problema il nostro viaggio può continuare. Siamo partiti da Trier, la più antica città della Germania con il nome romano di Treviri, città natale di
Karl Marx, procedendo sulla Mosella fino a Coblenza, dove confluisce nel Reno, e poi fino al confine con la Svizzera. Praticamente tutto su ciclabile, è un percorso che, come spesso capita nel turismo lento, porta con sé un doppio viaggio, nello spazio esteriore e in quello interiore. La Mosella è un immenso serpente che, tra anse gigantesche percorre un territorio collinare coltivato a vite, attraversando piccoli paesi dove è possibile trovare torri fluviali, castelli medioevali oltre che alcune case Jugendstil, Art Nouveau tedesca a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo. A proposito di espressioni artistiche, divertenti sono le etichette del vigneto Kröver Nacktarsch (letteralmente fondoschiena nudo) che raffigurano scene con al centro ragazzini sculacciati, probabilmente per
aver rubato e bevuto il vino che, va detto, è di buona qualità. LaMosellaèsoprattuttounasensazione di pace, di armonia, nel verde delle colline che si specchiano nel fiume, nei grandi barconi che lo navigano, nei villaggi tranquilli che sembrano aver assunto lo stesso essere posato che caratterizza il fiume. È quasi epidermica la differenza che si coglie con il Reno, non perché non sia splendido anche questo tratto, ma per la differente atmosfera che caratterizza le regioni attorno ai corsi d’acqua. Già Coblenza sembra segnare un punto di rottura, non solo per il suo essere grande città o per l’enorme differenza di portata e di larghezza tra i due fiumi, ma anche per il modo in cui la strada, finendo in un grande piazzale come fosse la prua di un’immensa nave, sembra lanciarsi verso il Reno sotto l’occhio vigile del

A il viaggio
Alvi Torrielli
PEDALATE TEDESCHE
Deutsches Eck, l’immenso monumento equestre che dall’alto dei sui 37 metri benedice l’unione tra i due corsi d’acqua.

Da qua in poi prendiamo l’Eurovelo 15, la pista ciclabile che segue il Reno dalla Svizzera fino alla sua foce nel Mare del Nord, in Olanda. Il percorso è molto piacevole, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista storico: il territorio è puntinato di castelli che raccontano meglio di molti libri l’importanza che, come linea di confine, il Reno ha avuto nel secolare confronto franco-germanico; ed è forse questo essere terra di mezzo, o forse la grande ricchezza economico-produttiva del territorio, che determinano un’atmosfera diversa, meno rilassata rispetto al tratto precedente.
Non mancano angoli di grande
bellezza, lunghi tratti su canali, cigni ed altri uccelli acquatici che osservano perplessi queste strane creature che, arrampicate su improbabili attrezzi metallici, pedalano sotto il sole cocente: già, chi l’ha detto che in Germania sarebbe stato fresco?
S’incontrano diverse città sul percorso, Manneheim, Karlsruhe, e, sconfinando in Francia, Strasburgo. Sembra quasi incredibile pensare a quanto distante sia quel mondo in cui un semplice passaggio di frontiera era così complesso o, addirittura, impossibile.Primaperòunadeviazione a Mainz seguendo il Meno fino a Francoforte dov’è imperdibile la Römerberg, la piazza principale, circondata da caratteristicipalazzi con travature in legno, alcuni dei qualirisalenti a sei secoli fa, la Rathaus, il municipio cittadino, e la centrale Fontana della giustizia, luogo di scambio per i
mercanti. Il nostro percorso termina nei pressi di Basilea, ma è quasi d’obbligo raggiungere le cascate del Reno e la splendida cittadina di Stein am Rhein, con le sue case dipinte. Le cascate hanno la più grande portata d’acqua d’Europa, avendo un bacino largo 150 metri per 23 di caduta e, a renderle ancor più spettacolari,un'enormerocciaalcentroe, sul fondo, il castello di Laufen. Settecento chilometri di pedalate, luoghi meravigliosi, goduti pienamente per la bassa velocità con cui li si è ammirati; castelli e fiumi, enormi barche che li navigano e che sembrano levitare su quelle placide acque, momenti di relax e attimi di sconforto per il sole tiranno, ma quello che più resta sono le sensazioni, gli attimi di silenzio, lo scorrere dei pensieri e delle emozioni che risuonano dentro di noi…
Pgg. 60-61 Alternativa
COME D’ARIA
ntenso e doloroso, storia del grande amore che lega una madre alla figlia e rappresentazione della disperazione, della paura e del coraggio che tale amore richiede, “Come d’aria” è il romanzo autobiografico dell’esordienteAda D’Adamo, vincitore postumo del Premio Strega 2023.
Ada D’Adamo, già ballerina, coreografa, e studiosa di danza, nel 2013 iniziaascrivereperlafigliaDariaquesto romanzo, divenuto la sua testimonianza e il suo testamento. Ad esso ha dedicato dieci anni di lavoro, gli ultimi dieci della sua vita, prima di morireil1°aprilescorso,perleconseguenze di un tumore, nel corso della selezione per l’assegnazione del Premio Strega.
Già nelle prime pagine le due diagnosi “oloprosencefalia”perDaria,e“tumore metastatico della mammella al quarto stadio” perAda, come due sentenzedicondannaannuncianolastoria di due destini intrecciati indissolubilmente.
Le protagoniste sono Daria, la figlia pluridisabile sin dalla nascita a causa di una mancata diagnosi prenatale, e Ada stessa, la madre, che sulla soglia dei cinquant'anni scopre di avere un tumore.
La “malattia” pervade di sé l’intera storiae,comeunabeffa,ladisabilitàdi Daria scompone e sconvolge tutti i canoni di bellezza, di armonia e di equilibriocheispiravanolavisionedel mondo diAda, un passato di ballerina, allaricercacontinuadelgestoperfetto, del gioco e dell’armonia delle proporzioni. Così parla alla figlia “Fin dal principioiltuocorpoinsortosièimposto con una forza che contravviene a qualsiasi regola […]. Ben presto avevi cominciato a piangere. Un pianto ininterrotto, inconsolabile, che non riuscivo a decifrare”.
Uno stravolgente cambio di passo diventerà la sua “missione”, conciliare la cura faticosa, estenuante e totalizzante, con un’esperienza di amore illimitato, che supera ostacoli, crisi, angosce. Una missione che include inoltrelaresponsabilitàdi“nontacere” la verità, raccontandone anche la parte piùoscura,perdarevoceaquellafiglia che ha voce unicamente attraverso il pianto.
In una lettera aperta a CorradoAugias, pubblicata su “la Repubblica” nel febbraio 2008, Ada confessa: "Un bravissimo medico non è stato in grado di leggere da un’ecografia che mia figlia sarebbe nata con una grave malformazione cerebrale. Oggi la mia bimba, poco più che due anni, è persona pluridisabile, invalida al cento per cento”[…]“l’abortoèunasceltadolorosa per chi la compie, ma è una scelta evagarantita.Anchesemihastravolto la vita, io adoro la mia meravigliosa figlia imperfetta. Ma se avessi potuto scegliere, quel giorno, avrei scelto l’aborto terapeutico”.
Tutto quel che segue è il racconto preciso e lucido di due vite, le fatiche di ogni giorno, la rabbia per la solitudine in un’impresa titanica, la lontananza del marito, l’assenza colpevole delle istituzioniel’impreparazionedelsistema sanitario. Ada ha lottato contro un mondoostile,fattononsolodibarriere fisiche, ma anche di limiti mentali e burocratici. Una realtà che ancora oggi, nonostante due importanti leggi di riforma sociale (la 104 del 1992 e la 227 del 2021) gran parte della nostra società continua ad ignorare.
Il racconto di un vissuto quotidiano di lunghe battaglie e di infinita pazienza, nel quale le sofferenze incessanti di Dariasimescolanoallostessocalvario di Ada, ma anche a momenti di tenerezza e di speranza, si snoda in una narrazioneincalzanteesenzareticenze
diqueltempotrascorsoinsieme,sedici anni,trarimandiericordiinuncostante intreccio di passato e presente. Tra tutti, il ricordo di un bambino mai natodàvitaaunadellepaginepiùdelicate e intense del libro (pag. 65), nella quale vengono svelati rimpianti, rimorsi e pentimenti. “Non posso fare a meno di chiedermi che ne sarebbe stato di me se avessi fatto una scelta diversa, e dopo la tua nascita questa domanda è diventata una voragine dentro la quale sono sprofondata più volte, trascinata da fiumi di congetture …”
Il legame perfetto che unisce madre e figliapassaattraversoilorostessicorpi fragili che, grazie al potere degli abbracci, dialogano, si riconoscono, condividono il dolore e la malattia in una reciproca dipendenza. “Spesso la malattia separa, allontana, distrugge. Qualche volta invece genera, allaccia, moltiplica l’amore”.
La dedizione che Ada offre a Daria, anche durante il proprio percorso di cura del cancro, è un sentimento totale che presuppone un nuovo concetto di solidarietà, ma che procura un nuovo, enorme e insuperabile dolore: la coscienza di dover abbandonare una figlia malata.
“Come amare sapendo che la separazione ci aspetta?
Comeesserepienamenteesapersparire? Non lo so.
Sono le leggi della vita, le sue imperscrutabili coreografie, danzepernonvedenti,unsoffioleggero ci sfiora la faccia
elemaniepurnonvedendosappiamo: la danza continua”.
Chandra Candiani, Questo immenso non sapere, Einaudi, Torino, 2021 (Citazione finale dell’autrice – n.d.r.).
Nell’ultimo capitolo “Incorporazione”, ovvero “Attenzione a quel che metti nel tuo corpo perché non uscirà
Ainvito alla lettura
Laura Luisi
più – Steve Paxton”, così si esprime: “È così che, ancora e ancora, continuo a identificarmi con te. Il mio corpo sperimenta, seppur in misura ridotta, i limiti del tuo. Prima li conoscevo, li sentivo, li toccavo attraverso te; poi ho cominciato via via a incorporarli. Incorporazione: un concetto centrale nelcampodeglistudisulladanza.Haa che fare con la nozione di corpo come luogo della memoria, con la trasmissione e l’apprendimento, con il
passaggiodacorpoacorpodiinformazioni,praticheetecniche,quindiconla capacità del corpo di creare conoscenza. Non so se e come questo processo arriverà a compimento. Cecità? Immobilità?”
La chiusura voluta da Ada D’Adamo finalmente dà senso anche al titolo.
“Finirò col disciogliermi in te? Sono Ada. Sarò D’aria…”
Unastoriatragicaecupa,parolepotenti e infinite emozioni, ma il risultato
LIB RO IL LIB RO
finaleèlagrandesensibilitàchepervade tutta la narrazione e che emana una luce misteriosa.
Leggere questo libro fa bene perché obbliga chi lo legge a confrontarsi con la qualità della sua vita, a riflettere sull’uso del tempo, e insegna ad apprendere la “compassione”, perché c’è un mondo nascosto, a chi la malattia fortunatamente non tocca, che tutti hannoildoverediconoscere.Ladiversità fa paura ma è necessario scoprirla.
Autrice: Ada d’Adamo
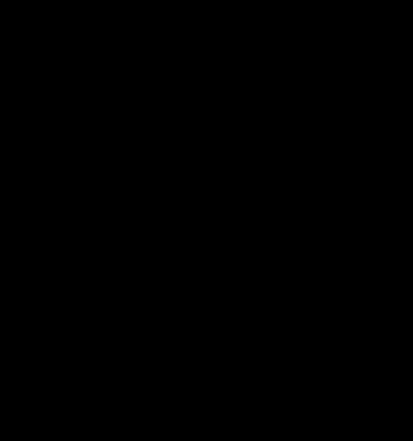
Titolo: Come d’aria

Editore: Elliot
Anno edizione: 2023
Pagine: 132
Nata a Ortona (CH) nel 1967,Ada D'Adamo si è diplomata al Corso diAvviamento dell'Accademia nazionale di danza a Roma e ha conseguito due lauree: una in Lettere e una in Discipline dello Spettacolo.Appassionata di balletto e musica classicafindall'infanzia,lungolacarrierahalavoratoprincipalmentenelmondodelteatroedelladanzacontemporanea. Nel2013 lascrittricehainiziatolastesuradiquestosuoprimoromanzo,pubblicatodallacasaeditriceElliotnelgennaiodel2023.Il1º marzoseguente, Come d’aria èstatoufficialmenteinclusotralecandidaturealPremioStregadellostessoanno.
Pgg. 62-63 Alternativa
GLI APPUN TI DI PADRE MCKE NZIE
“Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear” (Padre McKenzie scrive le parole di un sermone che nessuno ascolterà)
“Eleanor Rugby”, Lennon-McCartney, 1966
Da quando formarsi è diventato secondario rispetto al performare?
GIOVANI E FUTURO: ASPETTATIVE E INCUBI Q
ualche tempo fa, così esordiva Umberto Galimberti nel primo di alcuni libri dedicati al tema della condizione giovanile: “I giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il ‘nichilismo’, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui; (è) la loro stessa vita, che più non riesce a proiettarsi in un futuro capace di far intravedere una qualche promessa ” 1 .
Nel riaffiorare di quel sostantivovirgolettato,tantoevocativo ecaricodistoria,“nichilismo”, stailrichiamoallagravitàdiun fenomeno radicato nella nostra società che è necessario provare a comprendere, perché “l’individuo è solo la vittima di una diffusa mancanza di prospettive e di progetti, se non addirittura di sensi e di legami affettivi” 2 . E il problema che ne sta alla base non riguarda soltantolegiovanigenerazioni; la crescente difficoltà a perce-
pire con fiducia il futuro è un fenomeno collettivo, corale, che investe la società nel suo complesso.
Abbiamopersoilfuturo–scrivevo un paio d’anni fa su questepagine-Èavvenutolentamente, neppure ce ne siamo accorti. Abbiamo smesso di pensare al domani come al tempo in cui si potrà vivere meglio. Abbiamo smesso di pensare al futuro come territorio del desiderio e della speranza;anzi,inavvertitamente ma sempre più, il domani si è fatto incerto, allarmante, angosciante, temibile. Non è statounabbagliocollettivo;gli ultimi decenni hanno offerto abbondante materiale utile a maturareincertezzaepauraper il tempo che deve venire, per perdere fiducia nel domani 3 . Drammaticamente per tutti, tragicamente per chi è più giovaneeproiettanaturalmentein avanti aspettative e speranze e più degli altri ne viene defraudato, perché, come avverte Galimberti, il futuro si è trasformato da promessa in minaccia: “la mancanza di un futuro come promessa arresta il desiderio nell’assoluto presente” 4 e la minaccia non è
Roberto Negroni
certo un buon viatico per andare verso il domani: induce paura, chiusura, isolamento, sordoindividualismo. Intendiamoci, all’idea di un futuro tutto roseo, quello delle sorti magnifiche e progressive, nessuno di buon senso ha mai creduto. Anche nel quarto di secolo post-bellico, della ricostruzione, dell’espansione economica e del benessere, quandol’ottimismoelafiducia nel futuro avevano tutte le ragioni d’essere, una qualche cautela e un po’di timore non mancavano e anche per i più spericolati c’era pur sempre l’ala nera della proliferazione nucleare a mitigare gli entusiasmi; poi, già nei primi anni Settanta suonavano i primi campanellid’allarme 5
La ricerca del Censis “Generazione Post Pandemia”, pubblicata un anno fa, rilevava che fra i giovani prevalgono incertezza (49%) e ansia (30%), ma anche paura (15%) epessimismo(13%).Il45%di loro preferiva passare a casa più tempo possibile, il 47% diceva di sentirsi fragile, il 32% di sentirsi solo. Soffrivano di ansia e depressione dopo
1 Umberto Galimberti, L’ospite inquietante (il nichilismo e i giovani), Feltrinelli, Milano, 2007, p. 5.
2 Ibidem, p. 6.
3 Ma la perdita di fiducia nel futuro non è fenomeno solo di oggi. Verso la fine del XVI secolo scriveva Montaigne: “Coloro che accusano gli uomini di andare anelando sempre alle cose future, e ci insegnano ad impossessarci dei beni presenti e riposarci su di essi, perché non abbiamo alcun potere sulle cose a venire, anzi ancor meno di quanto ne abbiamo sulle cose passate, toccano il più comune degli errori umani” in Michel de Montaigne, Saggi, Bompiani, Milano, 2014, p.13
4 Galimberti, cit., p. 20.
5 Ricordiamone due tra i più famosi. Nel 1972 veniva pubblicato in Italia I limiti dello sviluppo, una ricerca commissionata dal Club di Roma al M.I.T. di Boston (quattro edizioni nel solo primo anno) edito dalle Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, il cui titolo già era un pugno nello stomaco con quell’accostamento inusitato di due sostantivi che apparivano inconciliabili: limiti allo sviluppo? quando mai? ebbene, si: in poco più di 150 pagine si dimostrava che la crescita economica e lo sviluppo mondiale non avrebbero potuto mantenere trend sempre positivi.
il Covid il 49% degli under 25. Il 69% nonsisentivarappresentatodallapolitica.Il77%ritenevachedifficilmenteun giovane vedrà riconosciuti l’investimento e le energie spesi nel lavoro e nellostudio.
Che le giovani generazioni siano più espostedellealtreallericadutenegative dellaperditadivisionepositivadelfuturo, della percezione della sostenibilità dellasfidaècomprensibile,perchésono quelle che più dovranno farci i conti; ma che ciò giunga fino a spalancare le porteall’ospite inquietante,aundiffuso nichilismo lo è un po’ meno. Spiega Galimberti: “se l’uomo (…) è un essere volto alla costruzione di senso, nel deserto dell’insensatezza che l’atmosfera nichilista del nostro tempo diffonde, il disagio non è più psicologico, ma culturale. E allora è sulla cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale che bisogna agire, perché questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza di un’implosione culturale di cui i giovani, parcheggiati nelle scuole, nelle università, nei master, nel precariato, sono le prime vittime” 6 .
Grandi sono le responsabilità di una società che, oltre alle molteplici ragioni di inquietudine che riversa sull’insieme della popolazione, riserva alle giovani generazioni un abbondante supplemento. In primo luogo, oggi i giovani sono pochi,lalorovoceèflebile;limitiamoci a un esempio di casa nostra: la fascia 15-29annidelVCOcostituivanel1971 il20,20%dellapopolazione,nelgennaio di quest’anno il 13,72%; pochi per farsisentire,pochiperincideresuimercati e i centri di potere che contano 7; siamo a siderale distanza dai tempi delle rumorose moltitudini di giovani boomer.
In secondo luogo, oggi molti giovani si trovanoincondizionidideprivazione.Il Rapporto Annuale dell’ISTAT 2023, resopubblicoaluglio,individuacinque fattori decisivi per il benessere giovanile: “Istruzione e Lavoro, dove si valuta la partecipazione al mercato del lavoro e a percorsi educativi; Coesione socia-
le, dove si tiene conto della partecipazione sociale e politica e della fiducia nelle istituzioni; Salute, in cui si considerano la salute fisica e mentale e gli stili di vita; Benessere soggettivo, nel quale si valutano diversi aspetti della soddisfazione personale; Territorio, nel quale rientrano la soddisfazione per il contesto paesaggistico e ambientale in cui si vive e la difficoltà a raggiungere i servizi essenziali”.Irisultatiinquietano. Il 47,1% dei giovani 18-34enni presenta segnali di deprivazione in almeno uno dei cinque fattori indicati; le quote maggiori di deprivazione riguardano le aree Istruzione e Lavoro (20,3%), Coesione Sociale (18,2%) e Territorio (14%);seguonoSalute(9,4%)eBenessere Soggettivo (6,8%). La fascia di età inmaggioredifficoltàèilsegmento2534 anni, mentre quello che ha risentito maggiormentedellafaseCovidèilsegmento 18-24 anni. Nel corso del 2022, il 15,5% dei 18-34enni risulta multideprivato (due o più aree); anche qui è la componente più anziana 25-34 anni in maggiore difficoltà (17,2% contro 12,9% dei 18-24enni). Più accentuata è la multi-deprivazione nel Meridione (19,5%, contro il 13,7% del Nord e il 12,3% del Centro). Le differenze di genere appaiono però trascurabili. Rispetto al 2019 i multi-deprivati sono diminuiti (erano il 17,5%), malgrado l’aumentoregistratonel2021(18,25)in piena fase Covid. La quota dei giovani in cerca di lavoro da almeno 12 mesi (8,8%) è tripla di quella comunitaria. Ancora, la quota di partecipazione al lavoro dei giovani (15-29 anni) è il 33,8%, il 15% in meno della media europea;quelladeglistudentilavoratori è del 6% a fronte di una media europea del16,7% 8 .
DecisamenteelevataèlaquotadeiNeet (Not in employment, education or training),giovanidietà15-29annifuorida percorsi di studio, di lavoro o di formazione, che sfiora il 20%, supera di oltre 7puntiilvaloremedioeuropeoerisulta penultimotrai27membridell’Unione. Unvaloreprossimoaltassodidisoccupazione giovanile (18%), anch’esso
superiore di quasi 7 punti alla media europea.LacondizioneNeetfemminile supera quella maschile (20,5% contro 17,7%); tra i giovani 25-29 anni un quarto è Neet, con punte al Meridione di 27,9%; nel Nord-est sono il 12,5%, nel Nord-ovest il 14,2%, al Centro il 15,3%, in Sicilia è Neet quasi un terzo dei15-29enni.
INeetcomprendonononsolochirinunciaalavorareestudiare,maanchechiè incercadilavoroechièimpossibilitato temporaneamente a farlo. Circa un terzo è disoccupato, nella metà dei casi da almeno 12 mesi (62,5% al Sud, 39,5% al Nord). Quasi il 38% “non cerca lavoro né è disponibile a lavorare immediatamente. Quest’ultimo gruppo si divide in proporzioni simili tra chi è in attesa di intraprendere un percorso formativo (il 47,5 per cento tra i ragazzi), chi dichiara motivi di cura dei figli o di altri familiari non autosufficienti (il 46,2 per cento tra le ragazze) e chi indica problemi di salute”. Il 76,5% dei Neet vive nella famiglia d’origine e solo il 33,7% ha avuto precedenti esperienzedilavoro.Circa20%èdiplomato ohalalicenzamedia,il14%èlaureato. Nel 2010 emigravano circa 3,2 maschi e 1,9 femmine di 25-34 anni ogni mille laureati; nel 2021 i rapporti sono saliti rispettivamentea9,5e6,7,inundecenniosono,cioè,triplicati 9
Mettiamo un argine a questa alluvione di numeri, ma così succede quando per documentare quanto si va dicendo è necessario rivolgersi a fonti statistiche. Vi è, però, almeno un terzo sovraccarico che aggrava quell’abbondante supplemento di motivi d’inquietudine, di cui si diceva, che la società odierna riserva alle giovani generazioni. Il passaggio dalla fase adolescenziale a quella adulta ha sempre costituito, in tutte le società, uno snodo critico, spesso enfatizzato ritualmente: il superamentodiunacondizioneprotetta di minorità per una adulta di responsabile autonomia. Un passaggio cui a lungo ci si prepara, accuratamente, con impegno, con fatica, che nelle nostre
Ilsecondocaso,ancorapiùfamoso,èdell’annodopo,il1973,ederalaprimaconfermadelleprevisionidell’annoprima:loshockpetrolifero,quello delle domeniche senza auto, la crisi che per la prima volta impose limitazioni al consumo energetico.
6 Galimberti, cit., p. 7.
7 Nello stesso periodo, la fascia 65 anni e più è passata dal 12,75% al 28,06%. Elaborazioni su dati ISTAT.
8 Rapporto Annuale ISTAT 2023, pp. 43-47.
9 Rapporto Annuale ISTAT 2023, pp. 100-102.
Pgg. 64-65 Alternativa
GLI APPUN TI DI PADRE MCKE NZIE
società coincide, prosaicamente, con la conclusione degli studi e l’ingresso nel mondo del lavoro. Una fase dell’esistenza in ogni caso carico di aspettative,ditimoriediansie, divenutoinquestotempostorico e in questo Paese, come evidenziano i dati sopra esposti, sempre più problematico, incerto,prostrante,logorante. Qualche mese fa, durante la cerimoniad’aperturadell’anno accademico dell’Università di Padova, la Presidente del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti Emma Ruzzon ha scosso la platea con una accorata denuncia delle gravi condizioni di disagio che il sistema universitario impone agli studenti. Dopo una breve introduzioneincuihaalternato la citazione di alcune magnificazioni mediatiche di record scolastici con notizie di suicidi di studenti, ecco un puzzle di frammenti di quel discorso. “Il numero dei suicidi è in crescita, siamo stanchi di piangere i nostri compagni. Siamo sottoposti ad aspettative asfissianti… Occorre il coraggio di mettere in discussione l’intero sistema merito-centrico e competitivo. Da quando studiare è diventato una gara? Da quando formarsi è diventato secondario rispetto al performare?...
Il mancato raggiungimento di un risultato è da attribuirsi soltanto alla colpa del singolo di non essersi impegnato abbastanza, ma molti degli ostacoli che incontriamo sono strutturali: una politica della residenzialità studentesca inesistente, non disporre di risorse per affittare una casa, non poter frequentare le lezioni, migliaia di borse di studio riconosciute ma non erogate… Quella abitativa come quella economica sono emergenze. Non è rispettato il diritto costi-
tuzionale di poter studiare… È
‘codardo’che si affidi al singolo studente di trovare il modo di arrivare alla fine del percorso indenne, superando ostacoli che è compito delle istituzioni rimuovere, e ciò pure in assenza o grave insufficienza di supporto psicologico a fronte della costante pressione competitiva cui siamo sottoposti in una fase già critica dell’età… Stare male non deve essere normale, ma in questo contesto di precarietà ci vien richiesto pure di eccellere”… Nel 2022, nel corso della celebrazione degli 800 anni dell’università di Padova, alla presenza del Presidente della Repubblica, l’intervento di Emma Ruzzon era stato dello stesso segno. “Solo il 29% della popolazione giovanile riesce a laurearsi, penultimi in Europa… Ci viene insegnato che studiamo per poter lavorare, e non per accrescere la nostra cultura, per poi ritrovarci in un mondo del lavoro che ci chiede di ringraziare per l’opportunità di essere sfruttati, perché è così che si fa esperienza… Ci dicono che le opportunità ci sono, che è il merito quello che conta; sono desolata, ma temo sia un’affermazione che non trova riscontro nella realtà”… 10
Quanto fin qui esposto non è certoesaurientepermotivarela presenza tra le giovani generazioni dell’ospite inquietante di Galimberti, altro sicuramente concorre. Andrebbero, ad esempio, attentamente considerati quei fenomeni e quei processi responsabili, nell’ultimo trentennio, dello sgretolamento dei tessuti connettivi del Paese, quei fattori involutivi che ne hanno rallentato, bloccato, quando non invertito, il cammino. Ma anche ciò non sarebbe suffi-
ciente, perché non tutti i danni prodottiearrecatisonodaiscrivere a nostro esclusivo merito: tanta è la parte derivata da dinamiche e processi che sovrastanol’angustadimensione nazionale (evoluzione tecnologica, globalizzazione, cambiamenti climatici, guerre, ecc.). Ma questa è un’altra storia, che richiede ben altro che unpaiodipaginetteanchesolo peresseredelineata.Accontentiamoci, perciò, di questi pochi spunti, con una piccola chiosa finale.
Il libro di Galimberti merita di essere letto tutto, non solo sbocconcellato come fatto qui nelle prime righe, anche perché,dopoavervagliatoafondo il problema, vi si prospetta una via d’uscita: “È come se lo sguardo senile della cultura occidentale non avesse più occhi per la condizione giovanile che potrebbe portare un rinnovamento, e perciò la lascia ai margini del proprio incedere, parcheggiata in spazi vuoti e privi di prospettive”. “Forse un modo per oltrepassare il nichilismo, almeno nelle sue catastrofiche ricadute giovanili, è quello di risvegliare e consentire ai giovani di dischiudere il loro segreto, spesso a loro stessi ignoto (…)” 11 Un potenziale da scoprire.
10 In questi tre ultimi capoversi sono assemblati, con qualche libertà formale, spezzoni dei due discorsi.
11 Galimberti, cit., pp. 146 e seg. Su questa questione, si può trarre giovamento anche dalla lettura di Sabino Cassese, Una volta il futuro era migliore (Lezioni per invertire la rotta), I Solferini, Milano, 2021.
Palissandro® marble. A one-of-a-kind.
Il marmo Palissandro® è unico al mondo e viene estratto esclusivamente dalla cava di Crevoladossola Italia, di proprietà del Gruppo Tosco Marmi. Trattasi di una roccia molto dura e di straordinaria bellezza, ideale per tutti gli utilizzi in architettura. L’autenticità del Palissandro® è garantita dall’apposito marchio ‘The Palissandro® marble’.
Palissandro® marble is solely owned by Gruppo Tosco Marmi. The only quarry in the world is found in Crevoladossola, Italy. A very hard durable rock of extraordinary beauty, ideal for all archtecture uses.
The authenticity of Palissandro® marble is backed by ‘The Palissandro® marble’ trademark.

Pgg. 66-67 Alternativa
Luxury Hotel, Paris. Palissandro® Bronzo, Bronzo Brown, Oniciato, Classico. Granite Eclisseo.


SCOPRI LA GAMMA ELETTRICA www.borgoagnello.it/elettrico Lo stesso DAILY di sempre. Semplicemente elettrico. SPECIAL CAR Off. autorizzata IVECO e FIAT Professional SPECIAL CAR 0324 45029 info@specialcargroup.it Viale dell’artigianato, 10 - 28845 Domodossola












 Maurizio Colombo
Maurizio Colombo