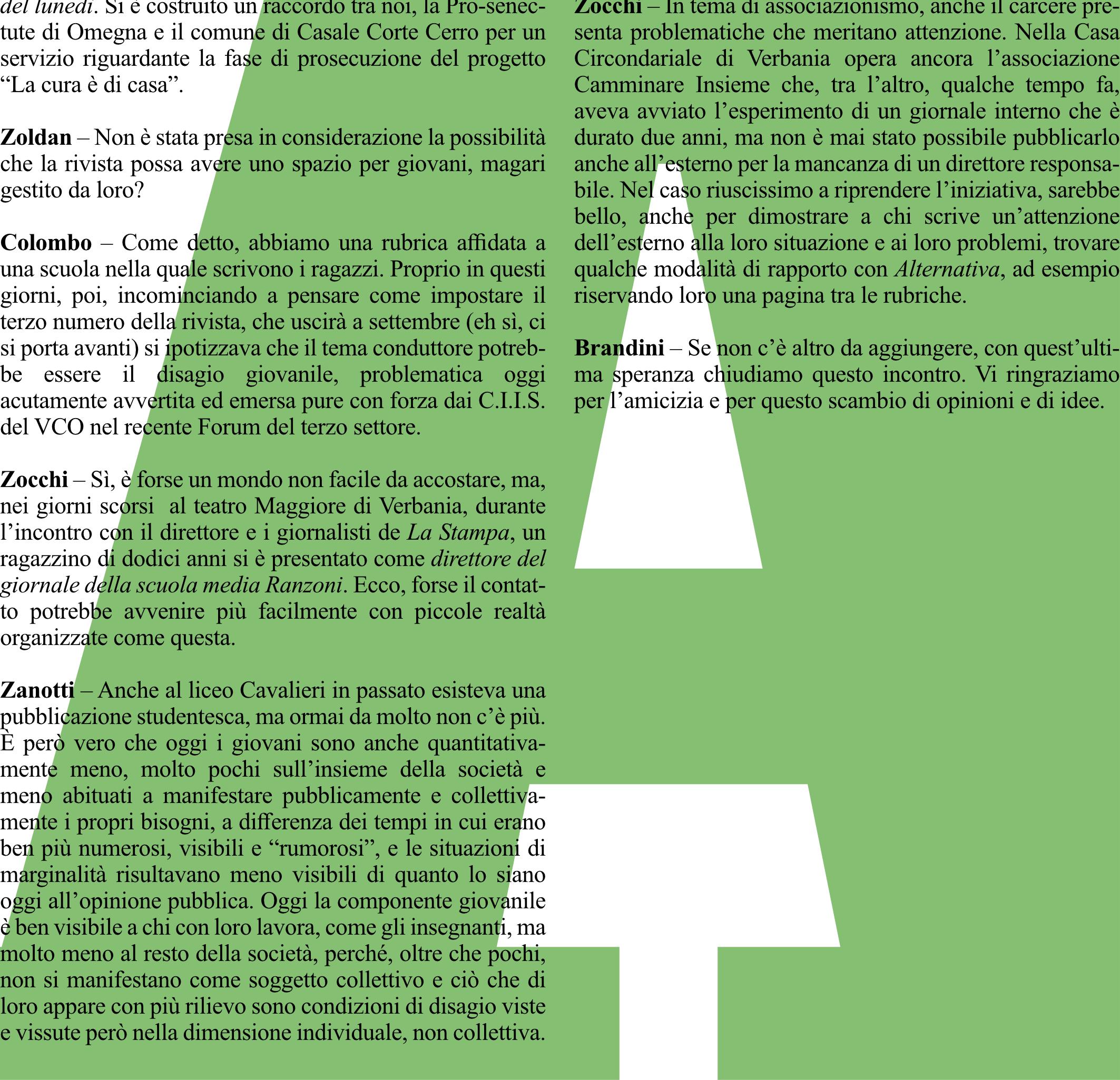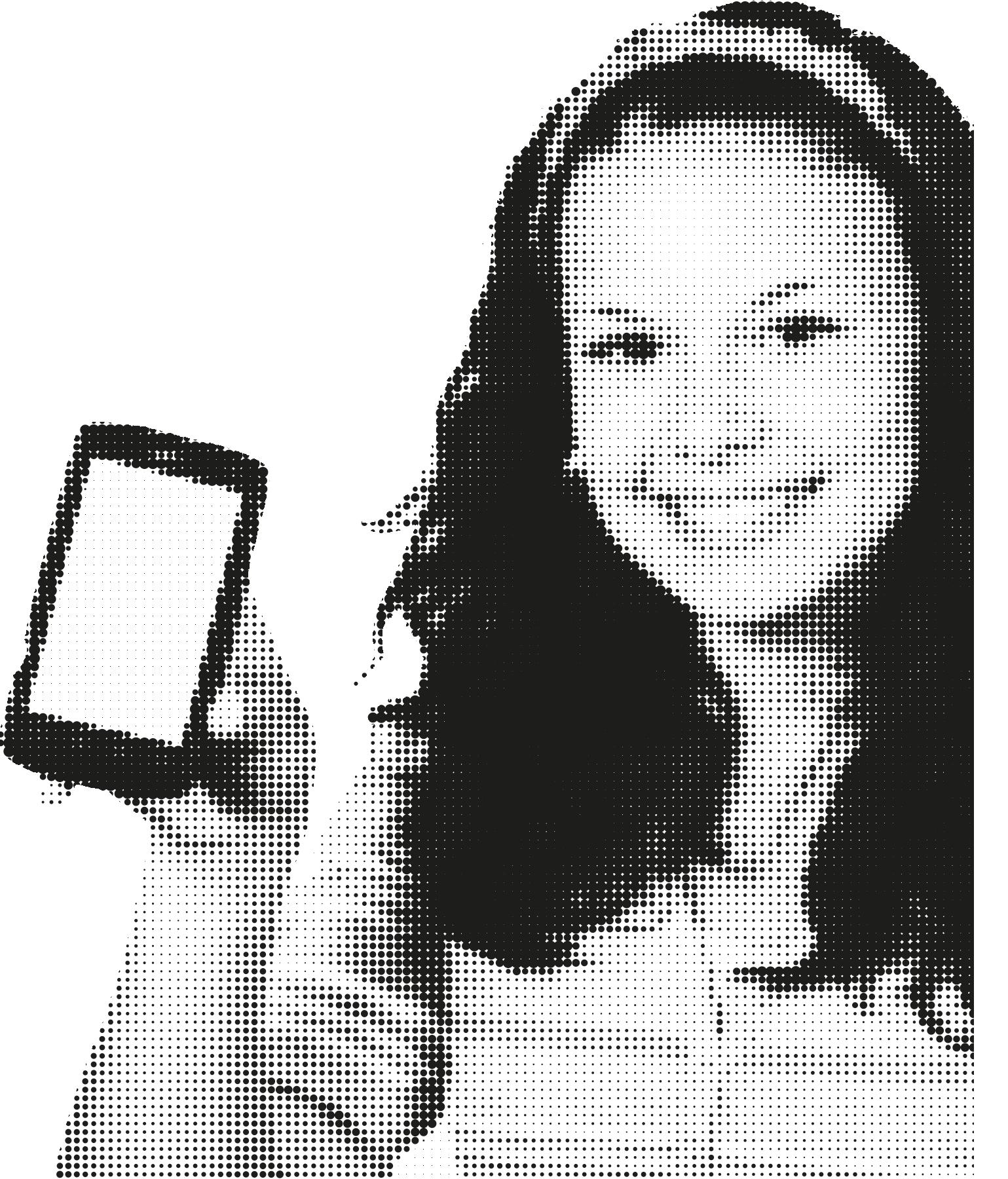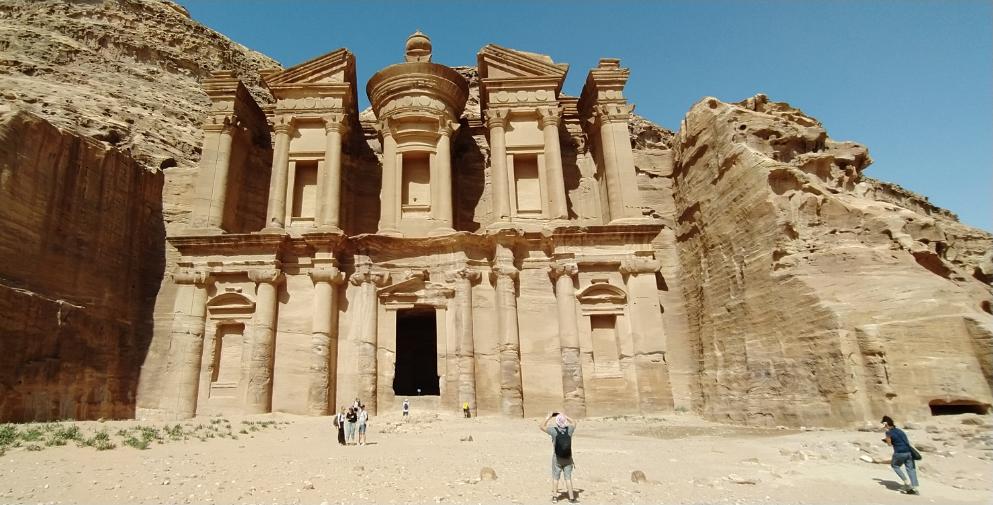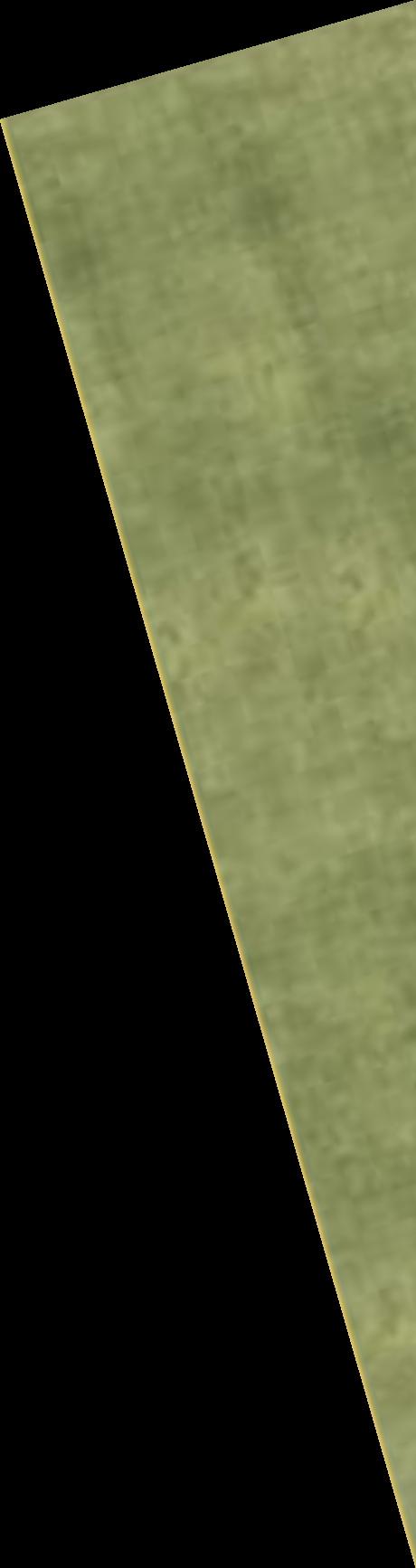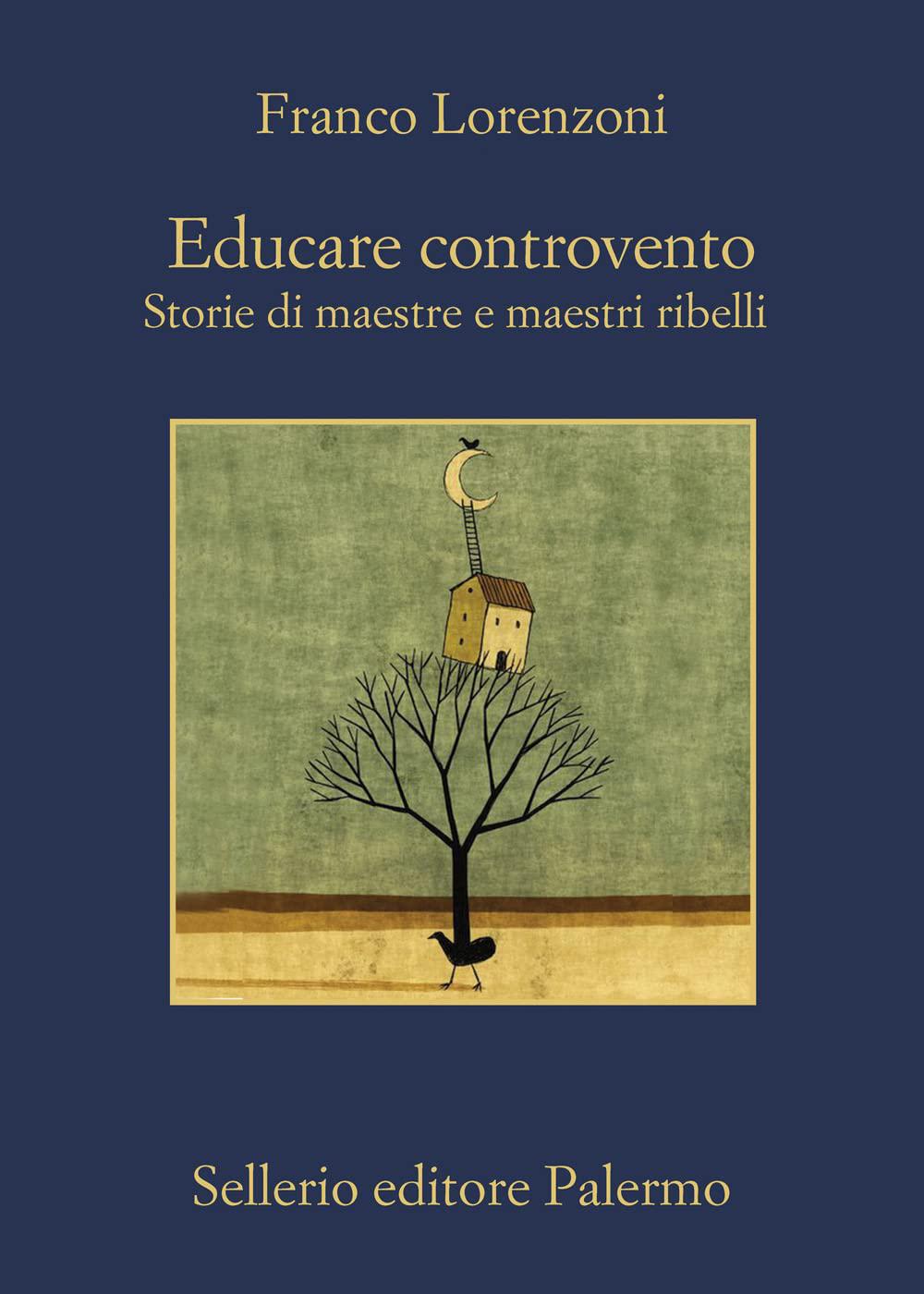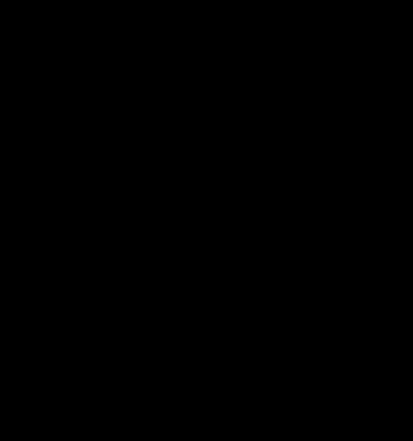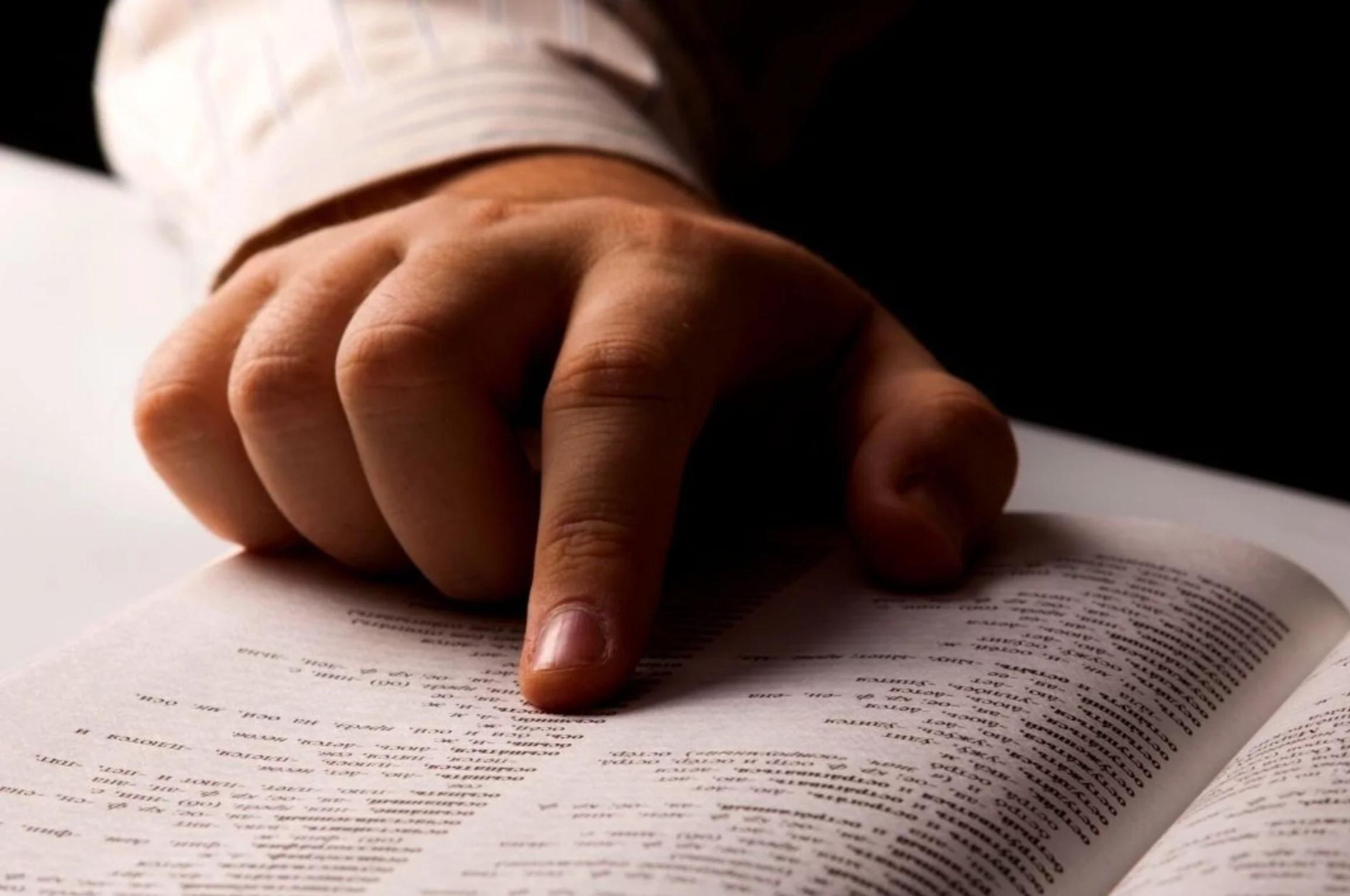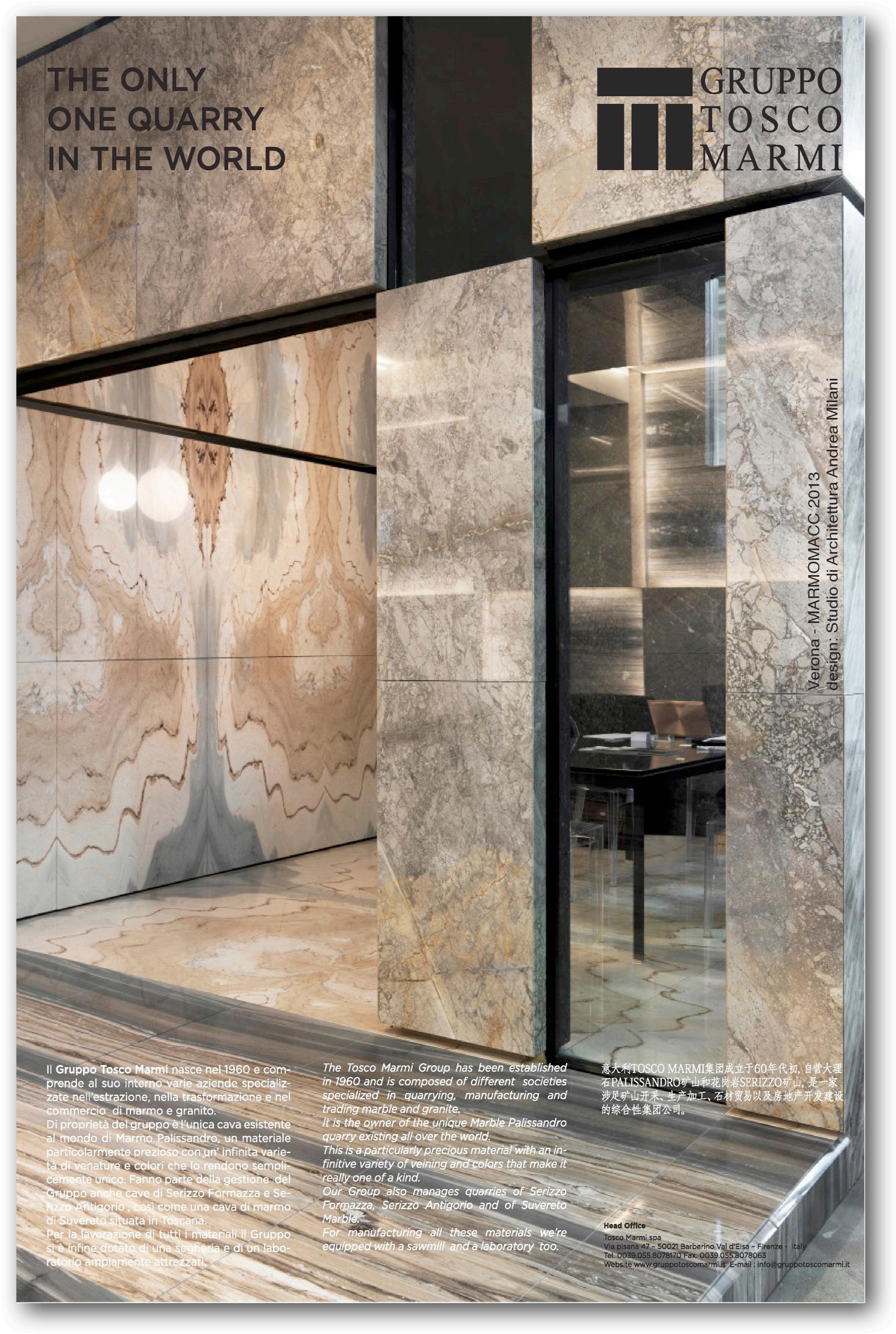n.2
In questo numero:
Tempo di verifiche: cosa, come e con chi comunichiamo Rischi e opportunità delle nuove modalità comunicative nella PA FOCUS Un anno di “Alternativa”, confronto con i lettori Etica della comunicazione Fondazione di comunità del VCO non solo un ente di erogazione Migrazioni: calamità o benedizione?
PERIODICO DI CULTURA E IMPEGNO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAA... Spedizione in abb. postale GR.IV Pubbl. Inf. 70%






Direttore Responsabile:
Clemente Mazzetta
Redazione:
Samantha Brandini (segreteria e coordinamento)
Diego Brignoli
Maurizio Colombo
Laura Luisi
Roberto Negroni
Emanuele Puccio
Carlo Rocchietti
Simonetta Valterio
Grafica:
Dario Martinelli
Impaginazione: a cura della redazione
Distribuzione: a cura della redazione
Stampa: Press Grafica Srl
Rivista n. 2 Anno 2023
Periodico di cultura e impegno sociale dell’Associazione Alternativa A ONLUS
Domodossola Via dell’Artigianato 13
SOStienici con una donazione
IBAN IT21X0200845360000103728938
Nota redazionale
Tempo di verifiche: cosa, come e con chi comunichiamo La redazione Pgg. 4-5 Ambienti territori
Cristina Barberis Negra, ufficio stampa del Consorzio Link VCO
Guido Boschini, dirigente dell’I.C. di Verbania-Intra, già docente ai corsi di Maxi Sperimentazione e poi dirigente dell’I.I.S.“L. Cobianchi”di Verbania
Monica Cupia, psicologa psicoterapeuta del Centro per la Famiglia della cooperativa La Bitta
Angelo Iaderosa, docente di scuola secondaria di primo grado, già referente ai temi dell’inclusività dell’Ufficio Scolastico del VCO
Alessandro Magrì, associazione Cineforum Domodossola
Alyosha Matella, insegnante e volonatrio dell’Associazione Alternativa A… ONLUS
Clemente Mazzetta, giornalista professionista, direttore responsabile di questa rivista
Giannino Piana, teologo, già docente di Etica cristiana e di Etica e economia nelle università di Urbino e Torino
Gianmaria Ottolini, già docente ai corsi di Maxi Sperimentazione del“Cobianchi”di Verbania, coordinatore e autore di studi e pubblicazioni in ambito educativo e formativo
Carlo Pasquali,
Alvi Torrielli, redattore di“Alternativa”in gap year e viaggiatore
Maria Pia Zocchi, docente di lingua italiana (L2) a studenti internazionali, già docente ai corsi di Maxi Sperimentazione del“L. Cobianchi”di Verbania e i redattori: Samantha Brandini, Diego Brignoli, Maurizio Colombo, Laura Luisi, Roberto Negroni
Hanno collaborato a questo numero
SOMMARIO
scenari contesti Rischi e opportunità delle nuove modalità comunicative nella PA C. Mazzetta 6-7 Per una vera trasparenza della PA… …e non solo M. Colombo 10-11 Riflessioni analisi commenti FOCUS Un anno di “Alternativa”, confronto con i lettori M. Colombo e R. Negroni 12-13 Etica della comunicazione G. Piana 16-17 Contributi La comunicazione nei percorsi educativi G. Ottolini 18-19 Un deserto che noi rifugiati dobbiamo attraversare M.P. Zocchi 22-23 Cosa avviene in casa d’altri prendere esempio da... Comunicazione e salute. La patente per lo smartphone D. Brignoli 26-27 non prendere esempio da... Il peggiore di tutti R. Negroni 28-29 Progetti Fondazione di comunità del VCO non solo un ente di erogazione F. Corda 30-31 Radioseipiù, uno strumento alternativo alla didattica tradizionale A. Iaderosa 32-33 Protagonisti e testimonianze Migrazioni: calamità o benedizione? C. Barberis Negra 34-35 Terra donna A.Torrielli 36-37 Notizie e cronache Incontro con Luca Mercalli C. Pasquali 38-39 I giovani si confrontano su Identità, Sessualità eAffettività C. Barberis Negra 40-41 Le rubriche di A La maxi sperimentazione del Cobianchi G. Boschini 42-43 Giustizia Negata M. Cupia e L. Luisi 44-45 Gli spiriti dell’isola A. Magrì 46-47 Viaggio in Giordania A. Torrielli 48-49 Lorenzoni Franco, “Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli” A. Matella 50-51 Gli appunti di Padre McKenzie Elogio del vocabolario R. Negroni 52-53
BIKE PARK - NOLEGGIO MTB - TREKKING

PARCO AVVENTURA - PARCO GIOCHI - GONFIABILI
BEACH VOLLEY - EVENTI - BAR E RISTORANTI

TEMPO DIVERIFICHE: COSA, COME E CON CHI COMUNICHIAMO
Dopo più di un anno e cinque numeri di Alternativa pubblicati, si è avvertito in redazione un bisogno di aprire una parentesi, di soffermarci un poco, senza interrompere il consueto ritmo di lavoro, a riflettere su ciò che si sta facendo e, più in particolare, per provare a verificare e a valutare la bontà, l’effettiva utilità di quanto andiamo pubblicando. I dati numerici desunti dal sistema di monitoraggiodegliaccessialsitociconfortano,sipuòcerto fare meglio, ma l’avvio non delude. Però, quanto andiamo pubblicando è davvero utile a chi legge?
Noi siamo partiti agli inizi del 2022 con una piattaforma di linee di indirizzo, e conseguentemente di scelte operative, puramente ipotetiche. Innanzi tutto la scelta di dar vita a “uno strumento di servizio e di aiuto per chi, nel più vasto ambito provinciale, opera in campo sociale, come professionista o volontario, in enti, istituzioni, cooperative e associazioni”, cioè una platea vasta, composita e differenziata. Poi, la scelta di un preciso approccio che possa distinguere dalla pubblicistica di settore già esistente, cioè provare a rispondere alla “necessità di connessione dell’azione e dell’intervento in campo sociale con il contesto, con l’ambiente in cui si esplica; l’importanza della conoscenza degli scenari, degli sfondi, dei territori, in cui si opera e delle loro dinamiche” e, completiamo, dei soggetti, degli attori che vi operano. Quanto questi intenti si traducono in utilità concrete? quanto incontrano positiva accoglienza?
Un antico adagio spicciamente raccomanda: se non sai una cosa,primadiimbarcartiinmacchinoseindagini,chiedilaa chi può saperla. Ecco, appunto, chi può sapere quanto sia o non sia gradito e utile ciò che stiamo facendo meglio di chi queste pagine legge? Da qui, l’idea di un primo confronto con un gruppetto di lettori - un po’pomposamente denominato Focus - desunto dal sistema di monitoraggio degli accessi, un incontro informale, uno scambio e, soprattutto, un ascolto di opinioni e di valutazioni, cioè un circuito di comunicazione in cui un problema viene tradotto in poche semplici domande poste a interlocutori, le cui risposte alimentano nuovi confronti.
Sisa,però,cheunaciliegiatiral’altra.Tuttisappiamoquanto sia importante la comunicazione per chi opera in campo sociale,quantofrequenteemultiformesiailricorsoaessae quanto non sempre facile l’impiego corretto.Abbiamo così pensato che l’episodio del Focus, cioè di un esperimento di circuito comunicativo tra lettori e redazione, sarebbe stata unabuonaoccasioneperfaredellacomunicazioneunasorta di filo conduttore di questo numero della rivista. Non una raccolta di saggi sul tema, che tanta pubblicistica cartacea e on line già abbondantemente offre, ma, come sempre ci si propone di fare, qualche caso, qualche riflessione, qualche concreta esperienza di questo territorio. Ecco, perciò, che l’articolo che racconta il confronto del Focus costituisce un po’ il perno intorno cui ruota buona parte di questo numero di Alternativa, subito affiancato da una riflessione sull’etica della comunicazione, mentre nello spazio che precede, dedicato agli scenari e ai contesti, ci si occupa di comunicazione pubblica, per il rilievo che per la societàassumeilrapportoconlapubblicaamministrazione. Il percorso continua con l’osservazione di due particolari ambiti della comunicazione, quello dei percorsi educativi e formativi (la scuola, in primo luogo) e quello del rapporto e confronto tra diverse culture. In tema di buoni e di cattivi esempi, due particolari casi: uno strumento per educare i giovani all’uso corretto dello smartphone e un caso emblematico di disastro comunicativo. Poco avanti, il racconto dell’originale recupero di uno stagionato medium per un esperimento di comunicazione tra le scuole della provincia e,nelleultimepagine,ciòchesipuòcogliere,apropositodi comunicazione, sfogliando il vecchio vocabolario. Ma, non essendo monografico, non di sola comunicazione vive questo numero. Si parla anche di un’importante istituzione di questo territorio, la Fondazione Comunitaria del VCO; di una storica epopea del sistema scolastico locale, la Maxi Sperimentazione del Cobianchi, nella rubrica dedicata alla scuola; di un importante incontro a Casa don Gianni e, ancora,diun’impresadellacooperativaRisorseedialtriprogetti delle cooperative locali. E, infine, le consuete rubriche perprovaread accontentareanchechinon èmaicontento.
La pubblicazione del trimestrale Alternativa dal 2022 avviene in digitale, l'idea è stata di renderla più eco-sostenibile riducendo i costi di stampa e di spedizione.
La produzione della rivista è pertanto quasi a costo zero, ma per“Alternativa A”, l’associazione Onlus che ne è l’editore, poter contare sul sostegno dei lettori rappresenta un aiuto a continuare ad operare come luogo di incontro, di lavoro, di formazione, di solidarietà, di aiuto in una logica di collaborazione, scambio e legame con il territorio.
Vi chiediamo allora di sostenerci con la vostra donazione, versando, con bonifico bancario, un contributo sull’IBAN di Alternativa A IT21X0200845360000103728938 con la causale “donazione per la rivista”. Grazie!
Per lungo tempo non è stato possibile accedere allo slideshow annunciato nel n. 4 del 2022 di questarivistaallepp.20-21.
Orailproblemaèstatorisolto,perciò l’esposizionefotografica “Immagini, le mani, lo sguardo, relazioni, emozioni” di Paola Sau è tornata visibile.
Anota redazionale
La redazione


RISCHI E OPPORTUNITÀ DELLE NUOVE MODALITÀ COMUNICATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dall’albo pretorio ai social. La pubblica amministrazione è definitivamentesbarcatanell’eradellacomunicazione on-line. Ma anche questa rivoluzione-“chenonèstatavistaarrivare”- piùchegestitaèstatasubita. Conrisultatidiversi,apelledileopardo, a partire dall’attuazione della legge 150/2000, che disciplina “le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. Legge in parte disattesa e in parte superata. Con esiti, nella nostra provincia che conta 148 pubblicisti e 28 giornalisti professionisti, non proprio incoraggianti per l’occupazione.
Un solo giornalista nei comuni del VerbanoCusioOssola
Dei tre comuni maggiori, solo Omegna ha un Ufficio stampa con giornalista assunto a tempo determinato (a parttime).Verbaniadisponediun“portavoce”, in stretto collegamento e con un rapporto fiduciario con il sindaco. Domodossolanél’unonél’altro;aveva assunto un portavoce solo dal 2002 al 2007. La Provincia del Vco che in passatoavevacuratolepubblicherelazioni con tanto di Ufficio stampa e giornalista,oragestiscelapropriacomunicazione (e marketing) direttamente dall’Ufficio di presidenza e con un sito webpraticoedessenziale,anchesenon esattamente “à la page” con le ultime direttive nazionali sull’online, che vorrebbero format e colori uniformi. (“Lineeguidadidesignperisitiinternet e i servizi digitali della PA”, luglio 2022).
La legge 150/2000 ha rappresentato comunqueunsaltoepocalepericomu-
ni passati dalle ordinanze, dalle deliberazioni, dagli avvisi cartacei affissi in bacheca (anni ‘90), direttamente ai siti web e alla comunicazione on line. Da una cultura del riserbo e della segretezza, che ha da sempre caratterizzato la pubblica amministrazione in Italia, ad unadellatrasparenzaedellacomunicazione,dipassisenesonofatti. Anche nel nostro piccolo. Da Intragna, ilcomunepiùpiccolodelVco(100abitanti) a Verbania, il capofila con i suoi 30 mila abitanti, si comunica on line, imperversano le app, i siti “responsive per mobile”, quelli cioè che si adattano sia al computer da tavolo, al tablet, e ai telefonini. E con i cellulari l’informazioneistituzionaleèsbarcatadefinitivamentesuisocial:ormaiètuttouncomunicare su Facebook,You Tube, Twitter, Instagram.
Un’overdose di informazioni. Un trend in sintonia con i comportamenti delle nuove generazioni, ma sul cui esito finale–larealecomprensionediciòche succede nel “villaggio” e crea consapevolezza – è lecito nutrire qualche perplessità.Fossesolo,comesostieneMarshall McLuhan, che “Lungi dall’essere normale, una comunicazione riuscita è unararità”.
Ma anche perché l’eccesso di dati e di canaliinformativirischiadigenerareun rumore di fondo - un sovraccarico cognitivo-chenelimitalacomprensione: troppa comunicazione, nessuna comunicazione.
Icomuniinformanosuisocial
IlcomunediVerbania,graziealfattodi disporre di un servizio informatico di prima efficienza (4 addetti), ha uno dei
sitiwebpiùperformantidellaProvincia conunamediadi30milavisitemensili. La città è presente inoltre anche su Facebook,YouTube,Twitter e suTelegram, quest’ultimo social con circa 2000 iscritti ha sostituito la news letter. Con una comunicazione estremamente efficace Verbania ha il secondo miglior tasso di penetrazione su Facebook in Italia, vale a dire che può contare su 55,8 follower per ogni 100 abitanti, seconda dopo Crotone (69,9 follower ogni 100 abitanti); terza Rimini (54,7). (Rilevazione di FPA sull’utilizzo dei canali social in 108 comuni capoluogo nel2022).
Un risultato estremamente positivo (i socialsonogestitidalportavoce)acuisi aggiunge anche il filo diretto del sindaco, Silvia Marchionini, che imperversa con un linguaggio essenziale, sobrio e senza intermediazioni con un profilo su Facebookcheha5000amicie3979follower, a cui ha aggiunto un’ulteriore pagina Facebook con 3736 follower.A titolodiconfrontoMimmaMoscatiello, sindaco reggente di Omegna da meno di un anno, ha poco meno di 2000 amici, Lucio Pizzi sindaco di Domodossola 2894 amici e 3057 follower. Bruno Toscani sindaco di Villadossola 3455amici. GianmariaMinazzi,sindaco di Cannobio 2651. La pagina facebook di Giovanni Morandi sindaco di Gravellonaconta1703follower.Quella del presidente della Provincia del Vco AlessandroLana,2015.
AncheOmegnaèpresentesuFacebook e su Instagram a cui si aggiunge la possibilità di iscriversi ad una news letter. PureDomodossolainformasuYoutube eFacebook.
A ambienti territori scenari contesti Alternativa
Come ti informo il cittadino nel “villaggio virtuale” del Verbano Cusio Ossola. I sindaci sbarcano sui social per parlare direttamente con la propria gente
Clemente Mazzetta
Tutti e tre, oltre ai siti web istituzionali, ne hanno altri tematici; quello turistico innanzitutto. Verbania, che ha un sito a parteperIlMaggiore(ilTeatro)edEditoriaeGiardini, lohaappenarinnovato, rinominandolo ViviVerbania. Omegna oltre a VisitOmegna ha il sito web del premio letterario Della Resistenza e il Festival di letteratura per ragazzi. Domodossolaproponeduesititematici, Domosofia e Casa40 dedicato alla Repubblicapartigianadell’Ossola.
Trascinati dall’innovazione tecnologica
Ma il salto epocale della comunicazione pubblica è stato più il risultato dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazionedellaPubblicaamministrazione che di una comprensione effettivadelledinamicheedelleesigenzediunacomunicazioneefficace. Sièpensatocioècheisitiweb,realizzati nella maggior parte dei casi da aziendeesterne(infotocopiacomedadisposizione ministeriale) e la presenza automatizzata sui social dei dati e delle notizieinseritidaivariuffici,bastassero ad assolvere il tema dell’informazione con i propri cittadini. In parte è vero, in parteno,perché,comediconogliinformatici “garbage in garbage out”; non è che se butti dentro spazzatura - notizie alla rinfusa, scritte male, senza criterio, senza gerarchie - puoi avere qualcosa d’altro. Il Comune di Baveno, in fondo se n’è reso conto, e in assenza di un supervisor interno, ha assunto e incaricato un portavoce (lo stesso di Verbania)dicurarel’aspettosocialinformativo. Ma più che di portavoce la sua funzionesarebbequelladisocialmedia manager.
L’innovazione tecnologia negli ultimi vent’anni ha così surclassato la legge 150/2000 ormai obsoleta. Legge per molti versi inapplicabile per la gran parte dei comuni d’Italia, Vco compreso, visto che impone di costituire gli stessi uffici per gli stessi scopi indipendentemente dalle dimensioni delle singoleamministrazioni.EcosìgliUrp,gli Uffici di relazione pubblica che avrebbero dovuto occuparsi di comunicazione pubblica esterna ed interna, essere “orientati alla customer satisfacion” (sic!), favorendo l’accesso ai cittadini, garantendo il diritto di informazione, partecipazione… eccetera, eccetera…
nei comuni con meno di 5 mila abitanti sono stati sostanzialmente bypassati. Disattesi. E se si pensa che in Italia i comuni con meno di 5 mila abitanti sonocircail70%(5.229su7.901)siha un’idea della realtà delle cose. Ancor piùchiaranelVco,doveipiccolicomunisuperanoil90%(68su74).
Gliurp“virtuali”operfinta Comprensibile dunque che nella nostra provincia, dove mancano i segretari comunali,equellichecisonosidevono sobbarcareancheunadozzinadicomuniatesta, neicomunisottoi5milaabitanti la soluzione più praticata sia stata quella della semplice targa Urp affissa suunaparetedell’ufficiovirtuale;ovvero di una pagina sul web a spiegare le “magnifiche sorti e progressive” del nuovo ufficio, con l’istituzione di una email Urp@comunedi..., il numero telefonico(einqualchecasoancoradel fax) e dell’attribuzione, ad un qualsiasi impiegato, delle funzioni sopraggiunte di aggiornamento dei dati, trasparenza, contattiesterni,segnalazionedeicittadini...
Mentre il sito web funge da bacheca essenziale (non sempre aggiornata) la comunicazione con i cittadini è gestita “in economia” dai sindaci e dagli amministratoriconunprofilosocialcon risposte e commenti immediati (fenomeno che è cresciuto durante la pandemia) o, come si è sempre fatto, a tu per tu“ontheroad”,all’insegnadel“villaggioreale”.
Lasolitudinedell’addettostampa Dicontrocalailsexappealdeigiornalisti all’interno della pubblica amministrazione nonostante le roboanti dichiarazioni dell’ex ministro della Funzione Pubblica Fabiana Dadone (M5s), che nel 2020 aveva annunciato una riforma della legge 150: “Le amministrazioni non potranno trasformarsi davvero in una casa di vetro se non si rilancia e si riconosce il lavoro dei professionisti e delle nuove figure della comunicazione pubblica”. Solo che nell’assunzione degli addetti stampa per un accordo Anci-Fnsi viene sostanzialmente applicato il contratto degli enti pubblici (cat. D1, euro 1.844 lordimensili)enonquellonazionaledei giornalisti (redattore esperto, euro 2.939).
Una retribuzione che non qualifica il ruolo, il “peso specifico” del professionista dell’informazione che lavora a scadenza, “compresso” all’interno di una struttura pubblica a compartimenti stagni.Dovefaticaaritagliarsiunruolo. Provate voi a spiegare ad un “capo settore” le banali regole di un comunicato stampa secondo le vecchie regole dell’Ansa, ovvero che una notizia non può essere più lunga di venti righe, ciascunadellequalidi64battute.Chedeve avere un attacco, un “lead” di 530 battutealmassimo.Chestareinnoverighe è più efficace che scriverne 10. Che è megliomenochepiù.Checertimodidi dire, come “espletamento di procedure concorsuali”sonoridicoliprimaancora cheincomprensibili.
Un linguaggio ostrogoto, inutilmente complicato
In questo contesto, appare evidente comelaLegge150/2000-ancheladdove applicata - sia nei fatti superata. Si dovrebbeparlaredisocialmediamanager, di personale formato e capace di comunicare e di interagire con l’utenza attraverso i social, più che di portavoce odiufficistampa,nétantomenodiUrp, cheavrebberodovutocambiareilmodo di comunicare delle pubbliche amministrazioni entrando anche nel merito della “produzione” degli atti. Ovvero del linguaggio utilizzato. Sarà perché, come osservava Gramsci che “a differenza dei funzionari francesi e inglesi, che scrivono per il popolo, quelli italiani scrivono per i propri superiori”, fatto sta che gli enti pubblici continuano a costruire un linguaggio ostile alla comunicazione. È esperienza comune di ogni addetto stampa che nei comuni si continua a parlare in ostrogoto, dove il biglietto del bus si “oblitera” e non si timbra, il servizio si “eroga” e non si offre, un palazzo si “aliena” e non si vende, la gente “interloquisce” e non parla, i rifiuti si “conferiscono” e non si scaricano, i cani non lasciano “escrementi” ma deiezioni. Un linguaggio erroneamente colto, semplicemente complicato.Astruso.
Ma è con questo linguaggio che si presentano sul web, con una comunicazione istituzionale, ancora unidirezionale. Dall’alto al basso, con i social pronti a costruire una nuova torre di Babele per
A ambienti territori scenari contesti
tutta una fascia di popolazione “non nativa digitale”, gli anziani, ma non solo – gli immigrati, gli analfabeti o senza titolo di studio (il 4,6% della popolazione sopra i 9 anni, circa 2,5 milioni in Italia, quasi 10 mila nella nostra provincia), gli analfabeti funzionali stimati al 27% dall’Ocse - che faticanoadistricarsifraunclickeunaltro. Ilpragmatismodeisindaci
Morale? Lo dicevamo prima: di fronte adunacomunicazioneingessataoburocratica, o iper-tecnologizzata della pub-
blica amministrazione, la risposta più efficacerisultaesserequellacheinstaurano i sindaci; quella diretta con i giornalisti, i media della provincia, ma soprattuttoconlapropriagente. In questo caso il profilo su Facebook che costringe ad essere immediati, evidenzia per numero di “amici” anche la popolarità del sindaco e diventa un mezzo privilegiato dell’informazione politica-istituzionale e della ricerca del consenso.


Con un’avvertenza finale: “In una società satura di voci, di scritte e di informazioni, la differenza è data dalla qualità della comunicazione: chi parla, sinceramente, di ciò che conosce bene, in maniera chiara e sintetica, senza far perdere tempo e pazienza a nessuno”osserva la linguista Vera Gheno, in ‘Potere alle parole’– “Chi comunica in maniera chiara dimostra di sapere chi sonocolorochehadifronte,didareloro importanzaediascoltarli”.

PER UNAVERATRASPARENZA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE… …E NON SOLO
È la norma o la volontà degli enti a dare trasparenza alla pubblica amministrazione?
Maurizio Colombo
La legge 150/2000 ha certamente rivoluzionato la comunicazione della PubblicaAmministrazione in senso molto vasto e allargato. Come abbiamoperòlettonell’articoloprecedente, la sua applicazione è stata disomogenea e in generale molto parziale. L’assenza di sanzioni ha determinato una applicazione legata alla volontà del singolo ente ed in particolare ai suoi vertici. Ben altra incidenza, pur con qualche problematicità anche in questo caso, ha avuto il d.l. 33/2013, modificato dal d.l. 97/2016, sulla trasparenza amministrativa. La sua rigorosità e il suo format hanno davvero portato trasparenza nella Pubblica Amministrazione in senso allargato.
Come recita l’art. 1 “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (…). La trasparenza (…) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”. La norma fa quindi della trasparenza uno dei principi cardini dell’operare della PubblicaAmministrazione.
Per dare concretezza alla norma, la legge prevede già all’art. 2 che l’accesso ai dati e ai documenti della P.A. è garantito tramite la loro pubblicazione e che “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e
dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione”. Una previsione normativa molto puntuale, con riferimento a un allegato, di cui poi daremo una breve sintesi, che ha portato tutti i soggetti interessati a dotarsi nel proprio sito istituzionale di una sezione apposita, denominata “Amministrazione trasparente”, dove pubblicareidatieidocumentiprevisti dalla norma.
Abbiamo fatto riferimento a tutti i soggetti interessati perché la norma non si rivolge solo alla pubblica amministrazione ma anche, come prevede l’articolo 2 bis “a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico (…); c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato,(…) con bilancio superiore ai cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario (…) da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni”. Non solo, lo stesso articolo prevede altresì che, per quanto compatibile, anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti
inerentiall’attivitàdipubblicointeresse, siano sottoposti alla normativa in questione. La legge prevede quindi un campo molto allargato, dalla Pubblica Amministrazione alle società partecipate fino alle associazioni, fondazioni edentididirittoprivato,ancheprividi personalità giuridica, che utilizzano fondi pubblici o producono beni e servizi per la P.A. o gestiscono servizi pubblici. Troverete quindi la sezione “Amministrazione trasparente” non solo nei siti della pubblica amministrazione,maanchedituttiqueglienti, compresisocietàassociazioniefondazioni, che finanziati o controllati dalla P.A. utilizzano risorse pubbliche. La legge prevede anche un ulteriore diritto di accesso ai dati e ai documenti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. In particolare, l’articolo 5 prevede che “chiunque ha diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”.Lanorma prevede altresì che il procedimento di accessodeveconcludersiconunprovvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanzaconlacomunicazioneagli interessati.
Vediamo ora in modo molto sintetico quali sono i dati e i documenti previsti con obbligo di pubblicazione. L’allegato A, cui si fa riferimento è molto puntuale, prevede le singole sottosezioni,lalorosuddivisioneegliarticoli della norma a cui fare riferimento. Per
A ambienti territori scenari contesti
brevità riprendiamo solo i titoli delle sottosezioni che però già danno una ideapuntualedeicontenutiedellaloro completezza: disposizioni generali –organizzazione–consulentiecollaboratori – personale – bandi di concorso – performance – enti controllati – attività e procedimenti – provvedimenti –controlli sulle imprese – bandi di gara e contratti – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – bilanci – beni immobili e gestione patrimonio – controlli e rilievi sull’amministrazione - servizi erogati - pagamenti dell’amministrazione – opere pubbliche – altri contenuti. Come si può vedere anche da questo indice sintetico, l’allegato prevede una quantità e qualità di dati e documenti davvero rilevanti e complete.
La norma, pur con qualche problematica legata agli aspetti sanzionatori, comunque presenti contrariamente alla legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica, ha avuto una applicazione sia quantitativamente che qualitativamente rilevante. Possiamo dire, con qualche minima forzatura, che non c’è pubblica amministrazioneoaltrosoggettointeressato che non abbia dato applicazione. La sezione “Amministrazione trasparente” è sempre presente all’interno dei siti istituzionali. Per poter dare indicazioni maggiori
sulla completezza e tempestività che caratterizza la sezione “Amministrazione trasparente” nei siti istituzionali abbiamo provato ad approfondire le modalità di applicazione in alcuni comuni del territorio. Abbiamo scelto i comuni come enti più vicini al cittadino e quindi a questo proposito più interessati e interessanti relativamente alla trasparenza. Abbiamo scelto a caso 10 comuni campione: 4 con meno di 1.000 abitanti, 3 con meno di 5.000 e i tre più grandi del Verbano Cusio Ossola. Per rendere più efficace e comprensibile la verifica sull’applicazione della norma abbiamo limitato i controlli alle 4 sezioni che riteniamo più importanti: organizzazione, che comprende i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo, l’articolazione degli uffici e i contatti telefonici e di posta elettronica; provvedimenti, che comprende delibere di giunta e di consiglio e determinazioni dei dirigenti; bilanci, che comprende bilanci preventivi e consuntivi e piano degli indicatori e dei risultati attesi; opere pubbliche, che comprende anchegliattidiprogrammazionedelle opere pubbliche.

Dei 10 comuni presi a campione 5, 1 piccolo 2 medi e 2 grandi, hanno dato, nelle sezioni verificate, piena e puntualeapplicazioneallaleggerendendo davvero trasparenti e accessibili i dati
relativi.Glialtri5comuni,puravendo previsto le sezioni indicate, mostrano lacune nella tempestività e nella completezza delle stesse. E’ interessante notare come queste lacune caratterizzano sia alcuni comuni piccoli del campione che un comune medio ed anche uno dei comuni grandi. In particolare, è la sezione Opere Pubbliche a mostrare la minor completezza e tempestività di aggiornamento dei dati. Sono probabilmente dovute alle problematiche legate agli aspetti sanzionatori non efficaci le lacune individuate in questi comuni campione. La norma prevede infatti sanzioni irrogate da un ente terzo, l’Autorità nazionale anticorruzione, solo per alcuni limitati casi specifici mentre per la quasi totalità dei casi è il Responsabile per la Trasparenza, interno a ogni ente, a svolgere l’attività di controllo sugli adempimenti dell’amministrazione relativi all’obbligo di pubblicazione. E’ evidente come questa autoreferenzialità dell’aspetto sanzionatorio di ogni singolo ente possa indebolire l’efficacia dello stesso. Per contrasto questo dà ancorapiùvaloreall’applicazioneuniversaleetempestiva,purconlelacune indicate, della norma determinata certamente dal sistema dei controlli ma soprattutto, laddove più puntuale e completa, dalla volontà del singolo ente e dei suoi vertici.
Alternativa
FOCUS - UN ANNO DI“ALTERNATIVA”, CONFRONTO CON I LETTORI
Abbiamo chiesto a un piccolo gruppo di lettori di sedersi con noi intorno a un tavolo per un confronto, innanzi tutto un ascolto, per una prima occasione di verifica del primo anno di pubblicazioni di“Alternativa”.Vedendo i nomi dei convenuti, qualcuno dirà“avete cominciato dal fondo del registro!”, già… il caso. Quello che segue è il resoconto sintetico di questo incontro.
Negroni - È passato più di un anno da quando è nata la nuova Alternativa. È tempo di avviare un percorso che provi ad accertare l’utilità di quanto stiamo pubblicando. I dati quantitativi del sistema di monitoraggio degli accessi al sito ci danno un riscontro abbastanza positivo. Occorre, però, qualcosa di più solido, cioè comprendere la coerenza che il risultato possiede con i presupposti di partenza, verificare che l’offerta incontri l’ipotetico bisogno di conoscenza dei destinatari. All’origine di questa impresa stanno due scelte. La prima consiste nella platea, dei destinatari, a cui vogliamo rivolgerci: chi lavora, opera o è anche solo interessato all’ambito del sociale, con una priorità per chi si misura con le aree più difficili, il mondo del disagio, della marginalità, delle povertà. La seconda è la scelta del come approcciarsi alla platea dei potenziali lettori, differenziandosi dalla pubblicistica e dall’editoria di settore già esistenti,individuataneltentaredirisponderealbisognodi connessione dell’azione e dell’intervento in campo sociale con il contesto, con l’ambiente in cui si esplica; l’importanza della conoscenza degli scenari, degli sfondi, dei territori, delle loro dinamiche, degli attori che vi operano.
Colombo – Partiamo, allora, con una domanda, la più semplice, più aperta: voi che la leggete, cosa pensate della rivista? Elasciamoperilprosieguoeventualialtredomande più mirate.
Zoldan - Sono legata da tempo a questa associazione, con fasipiùomenointense,malosguardosuquestarealtàl’ho sempre mantenuto. Ho seguito la rivista dal 2004/2005 fino al 2010 come coordinatrice del gruppo di redazione. In quel periodo c’è stato un primo cambiamento. Inizialmente, la rivista è nata come strumento di diffusione della realtà dell’associazione e delle cooperative da essa nate, di legame tra gli aderenti, peccava un po’di autoreferenzialità. Quel primo cambiamento è consistito nell’allargare i contenuti della rivista. Ora mi trovo davanti a un nuovo cambiamento che vedo proprio come una evoluzione: nuove tecnologie e lettura on line che sono adeguate ai tempi e uno stimolo a familiarizzare con queste nuove modalità, anche per il valore di scelta ecologica del risparmio della carta e, comunque, il mantenimento del formato
Maurizio
Colombo, Roberto Negroni su registrazione audio di Samantha Brandini
cartaceocomepossibilesceltaperilpiccologruppodivecchi abbonati legati a quel formato.
Il riferimento al sociale e al terzo settore emerge chiaramente, in coerenza con la scelta operata dalla redazione, e lo ritrovo legato in modo molto favorevole all’intero territorio provinciale, uscendo dall’originario guscio ossolano e promuovendo una visione unitaria di un territorio troppo spesso diviso. Ho apprezzato gli articoli scritti dai direttori dei tre Consorzi dei Servizi Sociali, forse perché sono vicepresidente del C.I.I.S. Ossola; anche perché sistanno svolgendo attivitàin coprogrammazioneecoprogettazione nei e tra i tre Consorzi. Ho notato un equilibrio tra gli aspetti nuovi e quelli tradizionali della rivista: ad esempio, il mantenimento di alcune parti, come le vecchie rubriche (viaggi, cinema, ecc.) fa dell’attuale cambiamento un momento di evoluzione della precedente esperienza e non di rottura. Apprezzo l’impaginazione e la grafica, che sono accattivanti e aiutano la lettura; le firme sono attrattive. Non noto criticità, quindi i risultati di questo primo anno, in relazione all’impostazione scelta, mi sembrano soddisfacenti.
Zanotti – Avevo una conoscenza solo indiretta della rivista, anche se la notorietà dell’associazione e delle sue cooperativenegarantivanolarilevanza,malacircolazione solo ossolana limitava le possibilità di accesso a qualche occasione dettata da qualche mio impegno amministrativo a livello provinciale. Il passaggio al formato digitale, che ha spalancato il potenziale di diffusione, e le notifiche di pubblicazione che si ricevono hanno favorito anche la sistematicità di approccio, che questo formato agevola anche rispetto ai contenuti che risultano più liberamente accostabili, favorendo la diffusione tra un pubblico di lettori digitali ormai abituati a modalità di assunzione dei contenuti diverse da quelle del lettore cartaceo. Il prodotto mi pare buono e accattivante, si vede che ha un suo valore non solo nei contenuti, ma anche come oggetto virtuale nell’impaginazione, nella grafica, nel corredo iconografico, nel ricorso ai link che permette e stimola approfondimenti e digressioni.
La mia lettura è selettiva, come penso per la maggior parte dei lettori: cerco le cose che più direttamente e per le più varie ragioni mi interessano, magari con una prima scorsa
ARiflessioni analisi commenti
P����������� al F���� svoltosi nella sede di Casa don Gianni di Domodossola giovedì 20 aprile 2023.
ClaudioZanotti,politicoverbanese,titolaredelblog VerbaniaSettanta;giàinsegnantedelLiceo Cavalieri,amministratore pubblico e sindaco di Verbania negli anni 2004-09; Maria Pia Zocchi, docente di lingua italiana a studenti internazionali, attiva in varie realtà del volontariato verbanese, già docente all’I.I.S. Cobianchi e ai suoi corsi di Maxi Sperimentazione; Raffaella Zoldan, Vice presidente del C.I.I.S. Ossola, legata fin dalle origini all’associazione AlternativaA di cui ha coordinato in passato la redazione della rivista; e per la redazione di Alternativa: Samantha Brandini, Maurizio Colombo e Roberto Negroni.
e poi una lettura più attenta dove maggiore è il richiamo dell’interesse o della curiosità per il tema o l’autore; ad esempio, con un autore come Giannino Piana non si lascia mai niente di non letto, e penso che questo non valga solo per me. Per altri articoli ho magari meno interesse, come, sempre ad esempio, per la rubrica dei viaggi, perché - la faccio un po’lunga - contrasta con il mio ideale di vita, io sono un teorizzatore della dissipazione morale del viaggiare,sonoperlastabilità loci dellatradizionebenedettina: c’è un ovile e devi vivere in quel posto senza andare mai via. In conclusione, penso che il 60/70% delle pagine della rivista venga letto, magari non di getto, ma con ritorni successivi. Diverso è il problema dell’effettiva ricaduta sul territorio: la diffusione quantitativa (1.200/1.300 notifiche inviate e una media di 500 aperture singole o ripetute per numero) è abbastanza consistente, ma ha forse margini di incremento. Non mi è però mai capitato di sentir citare o richiamare questa rivista in momenti di incontro pubblico, forse anche perché si è indebolita nel tempo quella stimolante dialettica tra soggetti collettivi della società civile e attori della politica e dell’amministrazione pubblica.
Colombo–Nellamailinglistsonopresenti,oltreaindirizzi nominativi, tutti gli enti e le istituzioni riferibili all’ambito del sociale: comuni e amministrazioni pubbliche, C.I.I.S., Centro Servizi Territoriali, enti, istituzioni e cooperative del terzo settore, associazioni di volontariato, A.S.L-V.C.O., istituti scolastici.
Zocchi – Non conoscevo prima questa rivista, la mia conoscenza si basa quindi sui quattro numeri del nuovo corso che ho trovato molto interessanti perché il fatto che analizzino, studino e riflettano della realtà provinciale è un valore; poche sono queste occasioni. Anch’io non leggo integralmente, però trovo molto interessanti lo sguardo sociologico, gli spunti di riflessione e di ricerca sulla realtà locale che altrove non si trovano. Mi è sembrata molto interessante l’iniziativa di realizzare un Forum, cioè un incontro e confronto, con i protagonisti istituzionali e del terzo settore, il cui resoconto rimane leggibile in rete, un’occasione importante, un collante, per stimolare la discussione di importanti problemi in un territorio piuttosto disgregato. Questa può essere un’idea da riprendere in
altre occasioni. Un aspetto che potenzierei è l’ascolto delle varie realtà di volontariato; ad esempio, per conto di un’associazione sono entrata in contatto con il Centro Servizi Territoriali di cui non conoscevo l’esistenza, e mi ha colpitoladisponibilitàasupportareibisognidelleassociazioni, che però operano quasi sempre senza connessioni conaltrepresentinelterritorio;mancaun’azionediraccordo, di messa in rete, che possa produrre sinergie. Trovo la grafica molto piacevole e accattivante, nel complesso è una rivista ben fatta.Anche la scuola sarebbe un mondo da coinvolgere…
Colombo – Tutte le scuole ricevono, ad ogni uscita di un nuovo numero, la notifica con il link, però all’indirizzo istituzionale, quindi non sappiamo, se aprono, chi legge; abbiamo poi nella mailing list parecchi insegnanti; inoltre, la rivista aveva già negli anni passati e ha mantenuto con il nuovo corso, un rapporto diretto con il liceo Spezia di Domodossola,periltramitedialcuniinsegnanti,chegestisceunarubricaincuisonoglistudentiascrivere.Cisiamo posti il problema di un rapporto più ampio con la realtà scolasticaprovinciale,percepiamoladifficoltà,macilavoriamo.
Zoldan – A me piacerebbe trovare che sia indicato il tempo necessario alla lettura di ogni articolo; molte pubblicazioni lo indicano e trovo sia una segnalazione utile.
Zocchi – Anche gli audio articoli sono molto comodi, un servizio utile che potrebbe, tra l’altro, agevolare chi ha problemi di vista. Si potrebbe realizzarli?
Brandini – È necessario disporre di qualche abile lettore, ma non credo sia complicato, sia qui a Domodossola che a Verbania ci sono gruppi che fanno teatro. Si potrebbe fare qualche esperimento per capire l’apprezzamento.
Colombo – Ci avete preceduto, perché una domanda che avevamo in serbo riguarda proprio i suggerimenti in positivo, ma anche in negativo.
Zanotti – Non sono uno sperimentatore scatenato delle novitàtecnologiche,matrovocheil podcast siaunacomo-
Pgg. 12-13 Alternativa
dità, la possibilità d’ascolto anche facendo altro. Può essere utile provare, magari individuando qualche argomento di vivo interesse locale.
Zocchi – Anche la riuscita esperienza del Forum penso possa essere ripresa, proprio come modalità utile a suscitare confronti e dialogo su temi importanti.
Negroni – Quella è stata quasi un’esigenza, di fronte all’importanza di una normativa che rappresenta una grande occasione di valorizzazione del terzo settore nei rapporti con la pubblica amministrazione, abbiamo pensato che limitarsi a proporre qualche articolo fosse troppo riduttivo. Ci siamo detti che il compito di una rivista come questa doveva essere spingersi più in là, non scrivere, ma concretamente farsi promotori di un’iniziativa che favorisse un dialogo e un impegno reciproco tra gli attori. E questopuòessereveroeutileancheperqualchealtrasituazione: attivamente promuovere, non solo scrivere.
Colombo – Questa modalità di tavola rotonda, che non avviene di fronte a un pubblico che ascolta e vede, è più efficace, perché mancano ai partecipanti le sollecitazioni alla spettacolarizzazione, al protagonismo, ad alzare i toni e favorisce invece un andamento più riflessivo e dialogante. L’esperienza fatta ha ben evidenziato questi vantaggi, l’incontro è stato positivo e interessante e l’obiettivo minimochecieravamoassegnatidi“farparlaretraloro”èstato superato per giungere a un più alto “individuare insieme i temi, le materie” che potranno essere oggetto di coprogettazione e di coprogrammazione. Una bella esperienza che contiamo di ripetere, come pure quella di questo focus di ascolto e dialogo.
Negroni – Approfitto di questa intrusione della redazione mettendo sul tavolo un’altra questione. Come detto all’inizio, vogliamo rivolgerci a quel mondo che in provincia operanelsociale,cioèaunaplateavastaecomposita,escludiamo perciò a priori la possibilità di produrre numeri della rivista monografici, perché inevitabilmente mirati a interessi circoscritti che rischierebbero di escludere buona parte dei lettori. Ma tra l’opzione monografica e quella generalista (uno spezzatino che accontenti un po’tutti) ci può stare una formula che presenti una tematica guida per un nucleo limitato di articoli, mantenendo l’eterogeneità per il resto del numero. È quello che già si è fatto appunto negli ultimi due numeri con i temi della valorizzazione del terzo settore e della sanità. Pensate sia una formula che funziona?
Zanotti – Si, è un problema reale, però, disponendo di temi adatti, come quelli usati nei due casi precedenti, la modalità del tema caratterizzante rappresenta un punto di equilibrio avanzato fra la rivista eterogenea, che rischia di rimanere sempre alla superficie dei problemi e quella monografica che può scavarne a fondo solo uno, quindi penso sia una scelta da mantenere.
Zoldan – Importante è mantenere quello che rappresenta ilsensoprofondodellarivista,cioèl’attenzioneaicontesti,
al territorio, mantenere l’idea del lavoro sociale legato agli ambientiincuiiproblemielerisposteaiproblemisigenerano.
Negroni–Finoaogginoidi Alternativa nonabbiamoconcentrato l’attenzione sull’associazionismo, che appare come una realtà diffusa e, in molti casi, solida, ma molto parcellizzata, priva di quei collegamenti e raccordi che sono invece stati creati nel mondo cooperativistico del territorio.
Brandini – Riprendo lo spunto emerso a proposito delle attività del Centro Servizi Territoriali il cui compito potrebbe essere, oltre al sostegno materiale e alla consulenza a singole associazioni, collante e luogo di scambio delle realtà associative, dare spazio a confronto e conoscenza reciproca tra le associazioni e nuove collaborazioni; invece queste occasioni si limitano a iniziative di formazione, pure importanti, ma che si limitano al contingente.
Zocchi – L’esperienza che ho avuto con il Centro Servizi Territoriali è stata anche per me molto positiva, un’accoglienza e una disponibilità veramente inusuali, però concentrate solo sulla risposta alle concrete necessità espresse.
Zanotti – Il Centro Servizi Territoriali ha una rubrica periodica alla televisione locale ed è forse questa l’unica occasionecheilcittadinomediodellaprovinciahadisapere della sua esistenza; certo altra cosa è per chi, vivendo l’associazionismo, frequenta quella sede per i bisogni di cui voi avete detto. Forse questa carenza che noi rileviamo non fa parte dei compiti istituzionali di quell’ente; forse questo compito avrebbe potuto esercitarlo un ente territoriale come la Provincia, non tanto nell’attuale fase di stentata sopravvivenza, quanto prima, nella pienezza di ruoliepoteri,potevaesserestimolataaricoprireilcompito di promuovere la conoscenza e il coordinamento del volontariato.
Colombo – Secondo me c’è anche una debolezza delle associazioni, spesso chiuse nel fare al meglio ciò che la loro mission chiede.Sembraquasiundatoconnaturatoalla fisionomia dell’associazione, un dato strutturale, forse dettato anche dai limiti delle forze e delle risorse di cui un’associazione di solito dispone.
Zanotti–Inpiùoccasionisiècercatodifavorirel’integrazione. Chi aveva la responsabilità politica del governo della città coglieva la necessità di valorizzare certe esperienze in modo che potessero costituire un valore aggiunto rispetto alla semplice somma del valore portato da ciascuno.Civuole,però,ilsoggettocheabbial’autorevolezza,la riconoscibilità, l’investitura per fare un’operazione che forza una certa tendenza isolazionista delle associazioni. Non pare, però, che oggi sia questo un tema all’ordine del giorno nelle nostre città e, meno che mai, nell’intero territorio provinciale, perché le politiche di area vasta
ARiflessioni analisi commenti
richiedono una sinergia sovracomunale che oggi non c’è.
Brandini – Quello che esiste è un data-base che costituisce un po’ l’anagrafe dell’associazionismo provinciale, compilato e disponibile in rete nel portale del Centro Servizi Territoriali.
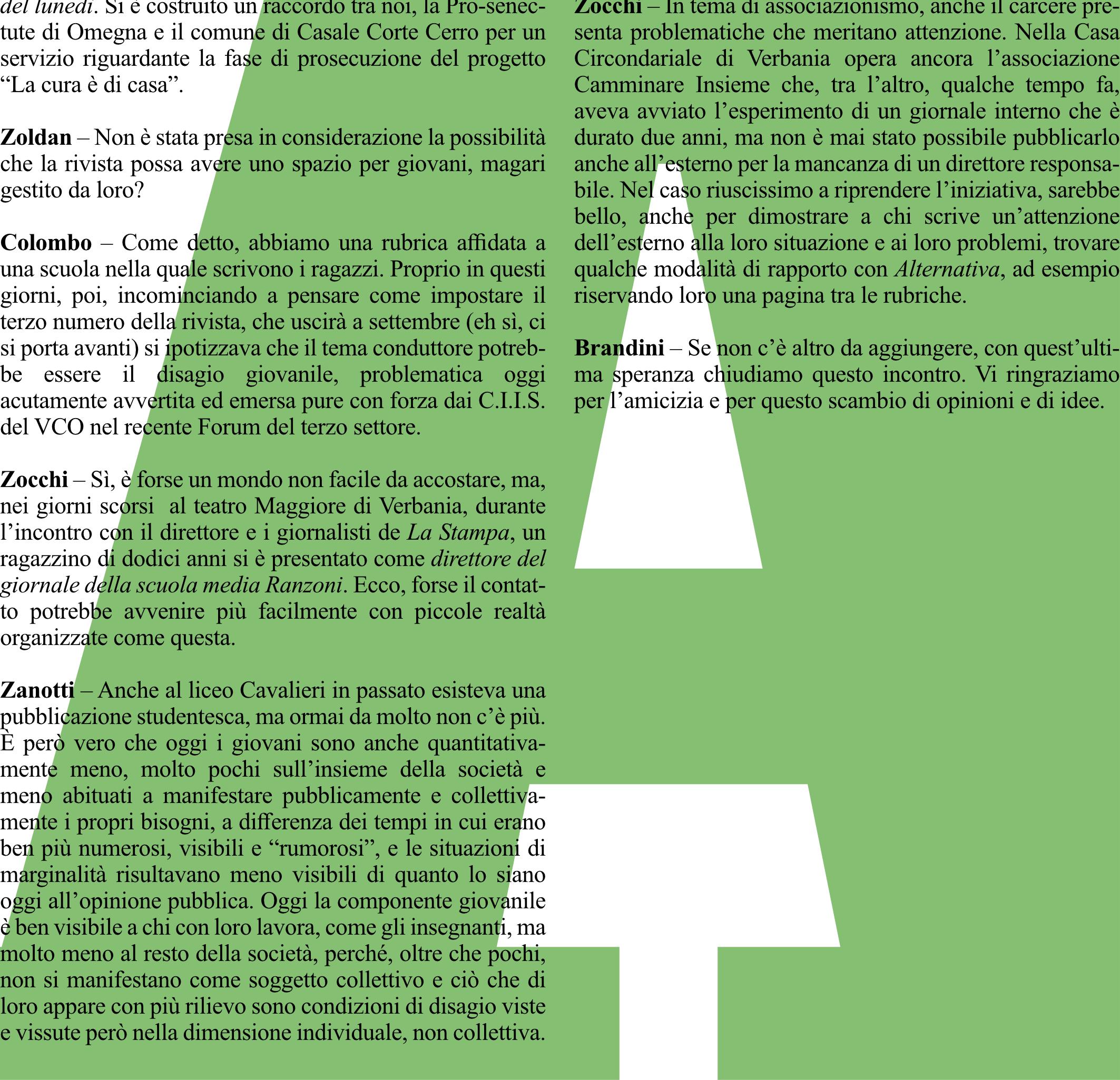
Colombo – Il problema è che il volontariato è molto frazionato, disperso in molteplici nuclei, spesso piccoli o molto piccoli, difficili da raggiungere, spesso anche solo da conoscere, da individuare. Una situazione del tutto diversa da quella che caratterizza l’altra componente del terzo settore, le cooperative sociali, che nel VCO non superano la quindicina.
Brandini – Un modo per tentare forme di raccordo può essere l’aggregazione su temi o progetti specifici, come è capitatoanoidell’associazione Alternativa A con Il salotto del lunedì. Si è costruito un raccordo tra noi, la Pro-senec-
Colombo – Il disagio giovanile è oggi individualizzato e perciò più sofferto, non più collettivizzato come accadeva in passato e, inoltre, è quantitativamente molto cresciuto, cometestimonianocolorochelavoranoneisettorisociosanitari dell’assistenza e della cura.
Zanotti – Proprio il fatto che oggi i migliori conoscitori deidisagidelmondogiovanilesianoiservizisociosanitari, e i CIIS in particolare, testimonia l’avvenuta patologizzazione del fenomeno.
Negroni – D’altra parte, non esistono oggi in questo Paese gruppi sociali che collettivamente facciano emergere, anche in modo conflittuale, i propri disagi o i propri bisogni. È una società frammentata, parcellizzata, atomizzata; la protesta si fa lamento o invettiva, si polverizza nelle recriminazioni domestiche e nei bar.
Zocchi – In tema di associazionismo, anche il carcere presenta problematiche che meritano attenzione. Nella Casa Circondariale di Verbania opera ancora l’associazione Camminare Insieme che, tra l’altro, qualche tempo fa, aveva avviato l’esperimento di un giornale interno che è durato due anni, ma non è mai stato possibile pubblicarlo
bile. Nel caso riuscissimo a riprendere l’iniziativa, sarebbe bello, anche per dimostrare a chi scrive un’attenzione dell’esterno alla loro situazione e ai loro problemi, trovare , ad esempio
ma speranza chiudiamo questo incontro. Vi ringraziamo
Pgg. 14-15 Alternativa
ETICA DELLA COMUNICAZIONE
Paradossalmente nella società odierna, mentre aumentano il numero di informazioni in circolazione e gli strumenti per comunicarle, si perde la qualità della comunicazione stessa. Sì, perché la società digitale non modifica soltanto i fondamenti della vita sociale, ma diffonde una nuova cultura, una visione dell’uomo e del mondo, che condiziona profondamente le scelte dei singoli individui.
Eccoperchéeticaecomunicazione,perchél’unapossadiventarestrumentodisalvataggio per l’altra
Giannino Piana
Il paradosso della nostra società è che, mentre si assiste a unasemprepiùampiapossibilitàdieserciziodellacomunicazione, viene riducendosi la qualità del comunicare. Grazie agli strumenti di cui oggi l’uomo dispone, si moltiplicano infatti le informazioni, che ci raggiungono “in temporeale”dall’interopianetaeaumenta,inmanieraindefinita, la possibilità di estensione della comunicazione interpersonale – grazie a internet e ad altri social ci si può mettereinrelazioneconpersonechevivonoagrandidistanze geografiche –; mentre, a sua volta, crescono a dismisura le possibilità di scambio tra etnie e culture diverse, possibilità dovute ai rapidi movimenti della popolazione mondiale – si pensi ai flussi migratori – con l’apertura di confronti potenzialmente arricchenti.
Tutto questo risulta, a una prima impressione, assai positivo. Ma non si possono non rilevare i limiti connaturati a queste forme di comunicazione. Sul terreno delle relazioni interpersonali il rischio che si corre, quando la mediazione degli strumenti diviene la modalità prevalente (talora persinoesclusiva)dellacomunicazione–dilagaoggisenzaalcun contenimento l’uso di internet o dello smartphone – è quello di produrre inevitabilmente un impoverimento del comunicare,chedivieneartificiale(eartificioso)perlamancanza di un contatto diretto tra le persone, che non sono presenti con la fisicità dei loro corpi. Sul terreno sociale i limiti non sono meno gravi per l’impossibilità di controllo di quanto viene comunicato, gestito da poteri – quello economico e quello politico in particolare – che fanno valere i loro interessi, servendosi peraltro di strumenti sempre più sofisticati e pervasivi che incidono profondamente sulle coscienze esercitando pesanti condizionamenti.
Le riflessioni etiche che qui svilupperemo si muovono sui due versanti ricordati – quello delle relazioni interpersonali e quello della comunicazione sociale – con l’obiettivo principale di mettere in luce a quali condizioni è possibile restituire alla comunicazione una identità autentica, che la metta in grado di dare vita a un processo di vera umanizzazione.
L’etica della
comunicazione interpersonale
Senzademonizzarei media,chehanno,inalcunecircostanze, una importante funzione, se si vuole restituire alla comunicazione interpersonale tutta la sua ricchezza, occorre ridare centralità al rapporto diretto tra le persone; rapporto che consente un coinvolgimento soggettivo reale, il quale implica la presenza della integralità del proprio essere, corpo compreso, e consente che ci si relazioni all’altro anche attraverso movimenti e gesti che conferiscono alla comunicazione un pieno significato umano non perseguibile attraverso la mediazione degli strumenti. Diverse sono le condizioni che vanno rispettate nell’atto comunicativo interpersonale, e che riguardano tanto le modalità del comunicare quanto il contenuto della comunicazione, la capacità cioè di mettersi in gioco con tutto se stessi, non avendo come obiettivo soltanto quello di trasmettere “qualcosa” ma di partecipare all’altro “quello che siè”.Ilcheimplica,daunlato,lacapacitàdilasciartrasparirelapropriaveraidentità,compresigliaspettinegatividella propria personalità; e, dall’altro, l’instaurarsi di un clima di reciproca fiducia, che favorisce la reciproca confidenza. Sul secondo versante – quello dei contenuti – la questione centrale è quella della verità di ciò che si comunica. Il concetto di “verità” non può essere qui inteso in senso rigidamente oggettivo: la verità della comunicazione è una forma di veridicità, in cui entrano in rapporto il dato oggettivo e la dimensione soggettiva; è, dunque, una verità che si costruisce nella relazione e che ha un carattere permanentementeaperto,nelsensochenonèmaitotalmentecatturabile e circoscrivibile, ma sta sempre “davanti” e “oltre” e di cui nonsipuòmaidirediessereentratipienamenteinpossesso.
L’etica della comunicazione sociale
Più complessa è la questione della comunicazione sociale, dove affiorano – come già si è ricordato – potenzialità positive, ma anche consistenti rischi. Gli strumenti a tale proposito oggi a disposizione, hanno infatti, a causa della loro pervasività – la loro presenza invade tutti gli ambiti di sviluppo della vita della persona – la capacità di incidere profondamente sulla coscienza. Il che implica che il giudi-
ARiflessioni analisi commenti
zio morale non possa limitarsi a valutare l’uso che se ne fa – buono o cattivo – ma debba tenere in considerazione anche la mutazione antropologica che, attraverso di esso, si produce.Lasocietàdigitalenonmodificainfattisoltantogli assetti strutturali della vita sociale: è anche (e soprattutto) promotrice di una nuova cultura, di una visione dell’uomo e del mondo, che condiziona profondamente le scelte dei singoli individui.
La caduta delle coordinate spaziali e temporali – si è ormai proiettati in uno spazio illimitato e si agisce anche ad enorme distanza “in tempo reale” (in questo senso si parla di “presentismo”) –; la sostituzione del “reale” con il “virtuale” (o come osserva J. Baudrillard “l’uccisione della realtà“); la crisi del linguaggio simbolico, che è il linguaggio delle relazioni umane, sostituito da quello fisicomatematico proprio degli odierni social; la sostituzione di operazioni che erano in passato proprie dell’attività conoscitiva e mnemonica dell’uomo, con le soluzioni offerte immediatamente dai media – il che comporta una atrofizzazionedellamemoriaedellestessecapacitàconoscitive–;e daultimo(manoninordinediimportanza)l’offertasterminata di informazioni, che amplificano il campo delle conoscenze, ma riducono la possibilità del loro approfondimento – si dà infatti un rapporto inverso tra estensione e profondità – sono altrettanti fattori che rendono ragione della mutazione cui si è alluso e che non possono non avere un ruolo di primo piano nella valutazione dell’uso che si fa degli strumenti tecnologici.
Alla considerazione di questa “non neutralità” degli strumenti si aggiunge, e ha un peso di grande rilievo, il potere di chi li gestisce e che – come si è già accennato – fa capo principalmentealpotereeconomicoche,apartiredaigrandi trust mondiali, persegue la ricerca dei propri interessi, facendo leva su un mercato liberista, che, oltre ad essere mercatounicomondiale,assumeancheiconnotatiideologici di “pensiero unico” – è questo un altro fattore non secondariodellamutazioneantropologicacuisièaccennato –esiispira acriteriutilitaristici–quellidellaproduttivitàe delconsumo–chefinisconoperavereilsopravventoanche nell’ambito delle scelte delle singole persone. La domanda disenso,laqualeconferiscevaloreumanoall’agire,èsostituita dalla domanda circa il perseguimento dell’utile produttivo:ciòchecisichiede,quandocisitrovanellacondizionedidoverfaredellescelte,nonèpiùchesensohaciò si sta per intraprendere, ma è utile o non lo è, serve o non serve.
Sono noti i pesanti condizionamenti di questo modo mercantilistico di procedere tanto a livello individuale che sociale e politico. La potenza dei social attuali esercita una forte pressione sulle scelte dei singoli – si crea, al riguardo una forte dipendenza non criticamente percepita per la qualeanzichésceglieresièscelti–enonmancadiinterferire, in misura determinante, su quelle della politica, spesso ridotta a variabile dipendente del potere economico che le sottrae il proprio spazio di azione e impedisce l’esercizio dellasuaoriginariafunzionediguidadellavitadellasocietà in vista del perseguimento del bene comune. Questo avviene – lo si è visto anche nel caso italiano in occasione delle ultimetornateelettorali–tantoattraversointerventidiretti–
le fake news sono un esempio eclatante di questa modalità che si propone di distorcere la verità – quanto attraverso un sistema più mascherato, e dunque più subdolo, che fa leva sulle “mezze verità” incidendo in questo modo ancor più profondamente sulla coscienza.
La verità della comunicazione, che non è anch’essa “asettica”, ma implica inevitabilmente un processo interpretativo –l’affermazione“ifattisenzaleopinioni”èunafalsificazione della realtà (ogni fatto viene sempre interpretato) – è volutamente distorta per le finalità che si perseguono, e assumediconseguenzauncaratterestrumentaleemistificatorio, che soltanto l’affermarsi di un diffuso senso critico –purtroppo ancora elitario – è in grado (almeno parzialmente) di arginare.
Quali le vie da percorrere per reagire a questa deriva?
La situazione allarmante (e inquietante) descritta non può non sollevare l’interrogativo: che fare dunque per contrastare questa deriva antropologica e sociale? Si è già accennato all’esigenza del senso critico, ma esso ha bisogno, per diventare appannaggio dei comuni cittadini, dell’attivazione di un serio processo educativo – è questa la prima via – che, oltre a sollecitare la nascita della domanda di senso e di fornire un preciso quadro valoriale che presieda alle scelte personali, fornisca anche conoscenze precise dei meccanismi soggiacenti all’azione dei media e degli effetti psicologici e sociali da essi prodotti, contribuendo in questo modo a desacralizzarli e a generare gli anticorpi in grado di contenerne gli effetti negativi. Tutto questo senza dimenticare l’esigenza di un loro uso parsimonioso, che eviti di incorrere in forme di dipendenza patologica, purtroppo assai estese. La distanza tra la rapidità con cui la mutazione tecnologica avviene e la inevitabile maggiore lentezza con la quale la coscienza si evolve non facilita l’esercizio di questo compito: si pensi soltanto all’uso smoderato dello smartphone che si verifica non soltanto nel mondo giovanile, ma anche in quello degli adulti, che tendono ad essere permanentemente connessi, dedicando uno spazio consistente del loro tempo alla trasmissione di messaggi – spesso più ore al giorno – e alle chiamate dirette. Ma questo non basta. È anche necessario – è questa la seconda via – un impegno del potere politico a fissare norme precise che regolino il mercato mediatico, imponendo limitazioni al suo accentramento nelle mani di una ristrettaoligarchiaefissandolimitiancheallaloropossibilità di espressione, senza incorrere per questo in indebite formedicensura,maevitandochelacomunicazioneprovochi un radicale distorcimento del costume e solleciti soprattutto l’uso della violenza. Non è certo facile oggi l’esercizio di questa funzione. La dipendenza segnalata del potere politico da quello economico impedisce spesso di assolvere a questo compito. Essenziale è dunque la ripresa di centralità della politica, che deve uscire dal provincialismo degli Stati-nazione per acquisire una dimensione universalistica e ricuperare credibilità e autorevolezza così da poter incidere con efficacia sui processi economici e sociali, spingendoli al perseguimento del bene dell’intera collettività mondiale. Si aprirebbe qui un nuovo (importante) capitolo, ma non è questo il momento per aprirlo.
Pgg. 16-17 Alternativa
LA COMUNICAZIONE NEI PERCORSI EDUCATIVI
Non si può non comunicare.
Le complesse dinamiche della comunicazione nei percorsi scolastici vengono illustrate con analisi accurate, con ricchezza di esempi, di rimandi ipertestuali e di note
Gianmaria Ottolini
Il primo assioma della comunicazione, insieme agli altri quattro enunciati per la prima volta alla soglia del ’68 da Watzlawick e dai suoi colleghi di Palo Alto, dovrebbero esser entrati da tempo nel senso comune, almeno per tutti quelli che si occupano di educazione. Rispetto al modello logico o “matematico” elaborato un ventennio prima da ShannoneWeaver(emittente–codifica–messaggio–canale, con eventuale rumore – decodifica – ricevente) viene introdotta un’altra dimensione, quella comportamentale e contestuale, o se vogliamo analogica. Il cosiddetto rumore nonèpiùun“disturbo”,maulteriorecomunicazionechepuò arricchire,precisare,maanchecontraddireilmessaggio. Ne derivano alcune conseguenze, o corollari, di cui è utile averconsapevolezza:
•Nonsempresiamoconsapevolidicomunicare
•Nonsempresappiamocosacomunichiamo
Perusciredaquellochepuòapparirecomeundiscorsoastrattomisoffermosuunrecenteepisodiodicuisièampiamente discusso sui media. Un chiaro esempio di comunicazione inconsapevole:sitrattadellacircolaredellapresidedelLiceo “Leopardi”diAulla.
Villafranca, 21 aprile 2023
Circolare n. 644
Ai docenti, agli studenti, ai genitori di tutte le classi sede di Aulla
Oggetto: debate
Giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10.05 gli studenti delle classi succitate, accompagnate dai docenti in orario, si recheranno nella sala Consiliare del Comune di Aulla per partecipare al dibattito sul topico “Noi riteniamo che non sia più opportuno che il 25 aprile venga festeggiato come una festività nazionale”, animato da una squadra mista di alunni dei tre licei lunigianesi.
Al termine dell’attività, presumibilmente intorno alle ore 12.00, si farà rientro in classe per completare l’orario curricolare.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO SILVIA ARRIGHI
Dato per scontato che né la Preside e la sua scuola, né il Comune ospitante avessero intenzione di sostenere le tesi negazioniste della Resistenza e negare il valore del 25 apri-
le, come successivamente “precisato” da entrambi gli enti, il messaggio della circolare nel contesto temporale (a ridosso del 25 aprile) e tematico (le polemiche da parte di esponenti nazionali della nuova maggioranza) produce invece l’effetto opposto. La sua lettura da parte di chi non eradirettamentecoinvoltonellainiziativasembrerebbeconfermare il contrario: ovvero che è lecito e magari anche opportuno abolire la festività nazionale del 25 aprile con tuttociòcheunatalesceltasignificherebbesuivalorifondativi della nostra Repubblica. E così ovviamente è stata letta conilrisultatochel’iniziativa,“perevitareulterioripolemiche”, è stata poi annullata 1
Nel tentativo di chiarire la vicenda la scuola parla della metodologiadel“Debate”,metodologiadidatticacheconsiste in una gara argomentativa, con regole codificate, tra due gruppi di studenti che sostengono tesi opposte a partire da un titolo “topico” che può apparire provocatorio e si dà quale altro esempio la tesi del terrapiattismo.
Non si tratta di una metodologia “locale” ma da tempo praticata in molte scuole e sostenuta dall’I����� 2 che così la definisce:
Debate (Argomentare e dibattere)
Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).
Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività didattica tradizionale (…)
Personalmente ho molte perplessità su questa metodologia didattica che tra l'altro c'entra poco con cooperative learning e peer education.
Cerco di spiegarmi. Il presupposto è che esista una tecnica di argomentazione neutra rispetto ai valori e alle tesi soste-
1 Sul dibattito scaturito dalla circolare si può ad esempio leggere l’articolo pubblicato sul quotidiano locale La Voce Apuana del 24 aprile.
2 Cfr. https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/debate
Acontributi
nute. Ma allora il tema scelto dovrebbe essere estraneo al contestovaloriale.Questopotrebbevalereinambitoscientifico dove le questioni aperte sono però al di fuori della portata di studenti di scuola secondaria, oppure su questioni liberamente opinabili a prescindere dai valori; ma in quest'ultimo caso si andrebbe a discutere su questioni del tutto banali.
Nel caso in esempio (25 aprile) o altri simili (es. pena di morte) come si scelgono poi le squadre? Tra l’altro il sito di Indire che presenta possibili modalità di Debate a più livelli di crescente complessità, su questo punto è invece molto vago. A caso (sorteggio, ecc.) o si tiene conto delle opinioni dei partecipanti? Come? Costringendo magari a sostenere una tesi non condivisa e contraria alle proprie convinzioni e valori?
Il messaggio implicito è che le due tesi siano del tutto equivalenti, ma è evidente che non lo sono. E che comunque le tesi possibili siano dicotomicamente due (tesi “A” e antitesi “non A”) in una logica binaria mentre nella maggior parte dei casi reali prevale una logica fuzzy a più valori.
In sostanza mi pare una metodologia al passo con questi tempidovesembraesserlecitosostenerequalunqueassurdità al di là dell'evidenza e pertanto lasciando libero spazio alle fake news e alla possibile negazione dei valori fondanti di una società democratica (es. razzismo) e dove quello che conta è vincere (il cosiddetto “merito”).
Diverso è il caso del cooperative learning e della peer education che non sono metodologie neutre ma strategie con esplicite finalità valoriali: la cooperazione (e pertanto l’inclusione 3) nel primo caso, la prevenzione nel secondo. Questosignificachenonèopportunosviluppareabilitàlogico argomentative attraverso spazi appositi? Certamente no, anzi! Ad esempio nel 2002, ben prima che si parlasse di Debate, nell’indirizzo di Scienze Umane e Sociali abbiamo datovitaadun Progetto Agorà voltoallaacquisizioneesviluppo progressivo di competenze dialogiche (documentazione, ascolto attivo, comunicazione efficace, strutturazionelogicaedargomentazione,osservazione/autoosservazione e giudizio) attraverso uno spazio di discussione strutturata e monitorata su tematiche culturali, sociali e politiche. Le differenze principali rispetto al Debate: un argomento, scelto alternativamente da studenti e docenti e non tesi dicotomiche; non squadre contrapposte ma fasi di discussione che dal piccolo gruppo arrivano alla plenaria; espressione argomentata da parte dei partecipanti delle proprie posizioni e del loro modificarsi nel confronto; monitoraggio, automonitoraggio e valutazione dell’esperienza. Tra gli argomenti allora affrontati ricordo ad esempio: Possibilità di legalizzazione dell’eutanasia, Altre dipendenze (fumo, alcool, gioco, mode …), Trasmissione televisiva Il Grande Fratello… 4
3 L’opposto della “scuola del merito” non è ovviamente la “scuola del demerito”, ma appunto la scuola dell’inclusione che non è altro da una scuola autenticamente democratica. Le pagine di don Milani della Lettera a una Professoressa sono ancora, drammaticamente, attuali.
4 Non è qui possibile dettagliare il progetto completo che è comunque possibile visionare ed eventualmente scaricare dall’archivio del mio blog: <qui>.
Professione docenti
Non è un refuso. La professionalità docente si acquisisce e si esercita collettivamente e la qualità di una scuola non dipende dalla qualità dei singoli ma dalla capacità dei docenti di lavorare in sintonia all’interno di una programmazione e finalità comuni. Se questo non avviene le modalità didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti che agiscono sugli stessi gruppi classe possono esser fra loro incongrui con risultati contraddittori e negativi indipendentemente dalla competenza culturale e didattica dei singoli. La comunicazione “fra colleghi” non è allora da intendersi fra attività e percorsi paralleli ma di forma circolare, quella appunto che caratterizza una équipe affiatata. Nonèquestal’immaginenormalmentepercepitaaldifuori del contesto scolastico, dalle famiglie e nei media, per non parlare della filmografia dove si è imposto il topos dell’insegnante eroe che, spesso in contrasto con colleghi e dirigenza, trasforma una classe demotivata e disagiata, plasmandola a sua immagine. Tutti, immagino, hanno visto e si sono magari commossi di fronte alle vicende del professorKeatingedeisuoiallievine L’attimo fuggente divenuto il prototipo di film analoghi 5 per trama e dinamiche, altrettanto fuorvianti su ruolo e professionalità docente. Vale alloralapenafareunconfrontoconunfilmapparentemente opposto come L’onda e scoprire che, sia pur con finalità diverse, anzi antitetiche, le modalità didattiche e le dinamiche innestate dall’azione “educativa” di Keating e Wenger siano sostanzialmente analoghe.
No,lacomunicazioneeducativanonavvienefraunsingolo (ildocente)eungruppo(laclasse),maapiùlivelliapartire dalla specifica scuola con le sue regole di comportamento (effettive più che formali), dalla stessa struttura fisica ed anchedalsuoaspettoesteriorediordineecura(oviceversa di incuria), sino alle équipe (gli insegnanti di un Corso e i singoli Consigli di classe) e le classi degli studenti, anche loro con dinamiche e modalità relazionali complesse e non sempre esplicite.
Affinchésirealizzinoéquipebenintegrate,ingradodiagire in sintonia e realizzare progetti didattici congruenti – sia che questi siano da loro stesse concepiti, oppure recepiti da proposte esterne – queste abbisognano di tempo e pertanto di stabilità, cosa oggi non facilitata dalle recenti normative e dalla tendenza a frammentare l’orario con mini corsi di due ore settimanali; e non sempre i dirigenti scolastici sono consapevoli di questa esigenza.
Vi sono comunque pratiche di facile realizzazione che possono facilitare una professionalità condivisa. Quella più diffusa è certamente la compresenza con due o più insegnanticheintervengonosuunaclasseosuclassiriunite:tali attività non solo comportano arricchimento reciproco ma richiedono di mettere in sintonia reciproche modalità, contenuti e finalità.
Un’altra pratica, sperimentata e promossa dall’IRRSAE PiemontequandolacoordinatricestoricadellaSperimentazione del Cobianchi vi si era trasferita, è quella dell’amico
5 Si possono ricordare la variante musicale di School of Rock (2003) e quelle al femminile: Mona Lisa Smile (2003), Freedom Writers (2007) e Una volta nella vita (2014).
Alternativa Pgg. 18-19
critico: un collega interviene durante una o più lezioni in qualità di osservatore con un attento monitoraggio delle interazioni,verbalienonverbali,fraildocenteelaclasse.A tal fine possono essere utili apposite schede su cui riportare tali osservazioni come quelle realizzate al Cobianchi all’interno di un Progetto qualità (1998-2001) sulla Comunicazione verbale e la Comunicazione non verbale 6 Successivamente i ruoli vengono scambiati e l’osservatore diventa osservato.
Ledimensionidelgruppoclasseelasuamanutenzione 7 Selacomunicazioneedinterazionedidatticaavvienefradue gruppi, l’équipe dei docenti da un lato e il gruppo classe dall’altrononbisognasottovalutareilfattocheogniclasseha specifiche caratteristiche date non solo dalla sommatoria dei singoli, ma soprattutto dalle dinamiche che intercorrono fra gli studenti (e fra studenti e insegnanti), dinamiche che possono sia favorire l’apprendimento da parte del gruppo che contrastarlo, dinamiche non sempre facili da leggere. In più casi può essere utile sia l’intervento di un esperto/osservatore esterno che l’utilizzo di questionari o altri strumenti di ricerca che evidenzino le problematiche ed eventuali tensioni sotterranee e permettano l’individuazione e progettazione dipercorsiidoneiad affrontarle 8 .
Ilgruppoclasseèinfattivissutocomeunluogofortedicoinvolgimento emotivo, sia in positivo (le amicizie, le fedeltà, leesperienzeforti)cheinnegativo(rifiuto,sofferenza,solitudine). Inoltre fra il gruppo classe “formale” (l’elenco del registro) e quello informale (quello delle amicizie e degli affetti) può esserci una forte discrepanza; all’interno di quest’ultimo può costituirsi un gruppo classe “segreto” che accettaedincludema,inaltricasi,rifiutaedostracizza(compagni di classe e talvolta insegnanti) e che può muoversi secondoprospettivedeltuttoincongrueconlefinalitàeducative. La vita della classe può diventare allora un vero e proprio inferno con conflitti più o meno latenti, incomprensioni reciproche fra insegnanti ed allievi, estenuanti contrattazioni, ecc. Il luogo meno adatto insomma ad una positivacrescitaculturale,professionale, socialeecivile.
Il bullo che non c’è … ma è presente e assai diffuso il bullismo 9
L’attenzione nel mondo occidentale al fenomeno del bullismo è relativamente recente per poi diventare, da categoria assente, a termine di largo utilizzo, spesso a sproposito. Le primeindaginiapartiredaglianni’70sonoquelledellosvedese Olweus che si concentrava sulla figura del “bullo” e sulle sue caratteristiche. Questa metodologia di ricerca, applicata nei decenni successivi in diversi paesi, Italia compresa, registrava il fenomeno soprattutto nella scuola elementare e media per poi decrescere e scomparire con l’avanzare dell’età.
NellostessoperiodoinGiapponesisonosviluppatiglistudi sull’Ijime, una dinamica di gruppo che tende ad ostracizzare ed emarginare alcuni dei suoi membri. Dinamica spesso ignorata dagli adulti e talora anche, più o meno consapevolmente,dalororinforzata.Lericercheeffettuatenelle scuolesecondarie,anchenelnostroterritorio,hannoevidenziato come proprio questa sia da un lato una modalità ampiamentediffusaedall’altroquellacheproducemaggiore sofferenza nelle vittime. Essere in grado di “leggerla” nella quotidianità significa conoscere e riconoscere le dinamiche che non si limitano a due soggetti (il bullo e la vittima) ma all’insieme delle relazioni nella classe, nella scuola e fuori dalla scuola (es. nei gruppi associativi e sportivi). Dinamiche che hanno a che vedere con la costruzione dell’identità del gruppo e il costituirsi al suo interno di una leadership.
Questa dimensione gruppale ed identitaria della dinamica daunlatoincludeedesclude(ostracizza),dall’altrocostruisce e/o rinforza la leadership del gruppo stesso. La designazionedella/evittima/ecambiapertantocaratteristica daclasseaclasse,dascuolaascuola.Perfareunesempioin una classe può essere vittimizzato il “secchione” che va benissimo a scuola e in un'altra invece lo studente con difficoltà di apprendimento, quello/a che veste elegante e in altro caso quello/a che non indossa capi di abbigliamento firmati, ecc.
6 Consultabili e scaricabili dal mio blog Fractaliaspei: Scheda di Osservazione della comunicazione verbale e dell’interazione didattica < qui > e Scheda di Osservazione della comunicazione non verbale < qui >.
7 Per un’analisi più articolata di questa tematica e l’esemplificazione di alcune pratiche didattiche volte a mettere al centro il gruppo classe e le sue dinamiche rimando ad un contributo collettivo pubblicato nel 2007 dai docenti dell’allora Indirizzo di Scienze Umane e sociali del Cobianchi nel volume Nuovi saperi per la scuola edito da Marsilio e scaricabile < qui >.
8 Un percorso con queste caratteristiche è documentato sulle rivista delle Scuole sperimentali: Competitività, cooperazione, creatività e filosofie ellenistiche in Sensate Esperienze. Rivista trimestrale della scuola secondaria, ottobre 1994. In forma più completa l’esperienza è documentata sul mio blog.
Se non si sa leggere la dinamica di quello specifico gruppo ilrisultatoècheilbullismo(l’ostracismo)peradultiededucatori sia invisibile oppure lo si avverta solo quando intervienequalcheepisodioeclatante.Magariproprioquandolavittima,alungosottopostaapersecuzioni,“esplode”e reagisce anche in modo violento con la conseguenza, non infrequente,diesserleiquellasanzionata.Oppurequandoè troppo tardi perché ha messo in atto la sua strategia di fuga: cambio scuola, abbandono degli studi, ritiro sociale (Hiki-
9 Anche su questa tematica rinvio a contributi sul mio blog: Il bullismo dalla fotografia al video e Bullismo (e Cyberbullismo). Letti con categorie dinamiche.
Acontributi
komori) … o peggio, sino al suicidio 10. Un aspetto da non ignorare è che le vittime normalmente si vergognano e non vogliono che le loro sofferenze diventino pubbliche: il doverammetterediesseresottoposteacontinuisoprusipuò esser fonte ulteriore di enorme sofferenza. Daunpo’diannisiparladi cyberbullismo,ilpiùdellevolte come se fosse un fenomeno a sé stante, indipendente dal
bullismo e addirittura come “un pericolo che viene dalla rete” (testuale da un articolo giornalistico). Il bullismo (l’ostracismo) ha residenza elettiva nella scuola e, secondariamente, in altri momenti aggregativi dei pari: ha radice nellarelazionerealeesemmairinforzoattraversoilwebche per le sue note caratteristiche velocizza le dinamiche e amplifica la platea.
10 La cronaca ci riporta periodicamente alcuni di questi episodi drammatici; ne ricordo due di larga risonanza, apparentemente opposti ma nelle dinamiche sottostanti molto simili: il suicidio dieci anni fa della quattordicenne Carolina Picchio e la recente strage attuata dal tredicenne Kosta in una scuola di Belgrado. Due sofferenze da parte di studenti scolasticamente irreprensibili, portate all’estremo dal gruppo dei pari e ignorate dal mondo adulto. Le parole fanno più male delle botte ha scritto Carolina; del tredicenne serbo le prime testimonianze dicono che era un nerd, considerato sfigato da compagni e compagne ed emarginato, in particolare nelle attività esterne alla scuola (parco giochi, gite ecc.).

Alternativa Pgg. 20-21
UN DESERTO CHE NOI RIFUGIATI DOBBIAMO ATTRAVERSARE
Maria Pia Zocchi
i questi tempi, a proposito di immigrazione, il rumore generatodaunapoliticacheaffrontalaquestioneinuna logicaemergenzialedisturbaunacomunicazionecorretta e distoglie dal desiderio di comprendere e affrontare i cambiamenti necessari, direi inevitabili, che essa genera in ambito sociale. Il mio punto di vista è quello di chi entra in contattoconpersoneadultemigrantiarrivatedirecenteinItalia e che, non conoscendo la lingua e la cultura italiana, devono affrontare un impegnativo processo di integrazione, non solo linguistica. Processo che dovrebbe svilupparsi in chiavesistemica,peressererealmenteefficace,conlacostituzione di poli formativi diffusi sul territorio che forniscano corsidilinguaeculturaitaliana,investendosulfuturodiogni comunitàconstanziamentodifondiadeguati.Purtroppo,non è questa la prospettiva che si intravede, né nelle passate, né nelleattualisceltedigoverno.
Parlare di comunicazione efficace tra e con persone provenienti da paesi lontani implica che, nel considerare i suoi principigeneraliindividuatidaititolatistudiosidell'argomento, si debbano privilegiare aspetti spesso considerati a margine, ma che in un contesto eterogeneo quale può essere una classe di studenti di recente immigrazione, rivestono un’importanzanontrascurabile: background culturale/identità,ascolto/prossimità.
Background culturale e identità
In ogni classe e in modo più evidente in una classe multiculturale è fondamentale ricercare e conoscere gli elementi e gli strumenti comuni da cui partire per avviare un dialogo tra e con gli studenti, al di là dell'aspetto più evidente delle difficoltà che emergono sul piano della comunicazione linguistica. E non penso solo all’incontro studenti italianistudenti internazionali all’interno delle nostre scuole, ma anche alle relazioni interculturali tra persone adulte che seguono corsi di italiano come seconda lingua: la logica e il linguaggio, fondamentali per ogni comunicazione, devono essere tarati su elementi comuni e comprensibili. Purtroppo spesso,nellenostrescuole,cisiaspettacheattraversounprocesso di assimilazione lo studente neo-arrivato magicamente acquisisca lingua, cultura e, addirittura, modi di pensare comuni. In una classe spesso si tende a trascurare ciò che
caratterizza le varie identità linguistiche e culturali degli studenti che provengono da altri paesi e, con l’etichetta “studente straniero”, in un’ottica semplificatrice di processi complessi, si omogeneizza in termini esclusivamente negativi un universo di belle differenze: le etichette non italofono, non originario del nostro paese, evidenziano quello che lo studentenonèequellochenonhaincomunecon'noi'.Così, spesso inconsapevolmente, si raggruppano individui dalle provenienze disparate in un amalgama indifferenziato, in nome di una presunta universalità della cultura, che è poi la nostra. Sioperaquindiunappiattimento delleidentitàedelle culture dei paesi di provenienza degli studenti internazionali, cheinvecesonoportatoridiunalorostoria,diradiciculturali, linguistiche, perfino di un'idea di tempo e di spazio per noi ignote.
Almassimo-e,siachiaro,nonmiriferiscoallescuole,cheda sempre hanno accolto gli studenti senza tener conto di tali distinguo-ladifferenziazionepuòservireadefinirnelostatus giuridico: extracomunitari, richiedenti asilo, rifugiati, legalmente soggiornanti, migranti economici, migranti politici, clandestini, nai,chevorrebbedire"nuoviarrivatiinItalia"… Come sostiene M.Aime 1, “Ognuno di noi è portatore di un mazzo di identità da cui, di volta in volta, per scelta o per costrizione,pescalacartacheritienepiùadatta,olasolache gli è consentito giocare”:senessunacartapuòesseremostrata, si acuisce il senso di frustrazione e la conseguente svalorizzazionedellapersonaedellaculturadiappartenenza. Nella mia esperienza la comunicazione diventa efficace e consente di dare espressione alle diverse identità quando il gruppo è di dimensioni ridotte, quando la comunicazione tra partecipanti è simmetrica e quando ognuno si sente libero di esporsiconunasuastoriapersonale.Aquestecondizionipossono emergere le caratteristiche individuali e si può stabilire un'autenticacomunicazione:apartiredaunagestualitàspontanea, all'enunciazione di gusti musicali, cinematografici o alla narrazione di storie e miti, alle preferenze nelle pratiche sportive, via via toccando ambiti più personali, come le rela-
Acontributi
1 MarcoAime, Cultura, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, p. 81.
D
È la condivisione e la negoziazione dei concetti all'interno del gruppo che consente di comunicare
zioni familiari e amicali, fino a toccare la sfera dell'affettività eaddiritturadeldivino.Inquesticasisipuòparlaredicomunicazione creativa ed efficace. Ho avuto la fortuna di sperimentarlaperòsoloincorsidiitalianoperadultioinlaboratoridipiccoledimensioniperragazzieragazzenellenostre scuolesuperiori.Perchéquestecondizioninonsonorealizzabili facilmente in una classe di adolescenti, dove le diversità legateamodelliculturalitantolontanidaquellidellamaggioranza vanno nascoste. Spesso, inoltre, il disinteresse per il percorso che ha portato in Italia lo studente neoarrivato e per il suo background culturale determina una bassa autostima e talvolta il rifiuto di apprendere la nostra lingua e di inserirsi nel gruppo di compagni; così, può capitare che ragazzi che erano campioni in una squadra di cricket a Sri Lanka arranchinocalciandounpalloneaVerbaniaononapranoboccain classeperperiodianchedimesi.
Ilnostropensierosicostruisceneglianni,inunastratificazione di esperienze, attraverso parole che articolano idee e che impariamo a padroneggiare con sempre maggior esperienza. Un adulto che arriva in Italia come profugo deve in tempi breviacquisireuncodiceespressivocheinmolticasisiriferisceaconcettialienidallasuaesperienzadivita.Selostudente minorenne che non conosce la nostra lingua e che si trova a frequentare una scuola può acquisire strumenti comunicativi inunpercorsopluriennale,utiliadaffrontaredisciplinescolastiche nuove - e questa è comunque, come si è detto, un'esperienza che viene vissuta spesso con un senso di frustrazione per la difficoltà dell'impresa - gli adulti che non hannoavutolapossibilitàdifrequentarescuoleneiloropaesi incontranodifficoltàancoramaggiorinelseguirecorsidialfabetizzazione.Spesso,chinonhaseguitonelpropriopaeseun iterscolasticoedèarrivatoinItaliadopounviaggiodrammatico, durato anche anni, ha fretta di iniziare un percorso lavorativo per sostenere la propria famiglia lontana che ha investitosudiluiestentaacomprendernel'utilità:lascuolaè peribambini,checifaunadultoascuolainvecedilavorare? Questapurtroppoèlapremessadacuipartireeinquestecondizioni il compito dell’insegnante è quello di accogliere e comprendere i diversi bisogni legati ai percorsi di vita degli studentiesolodopoaverneconosciutaunaparte,condividendone le parole faticose con cui possono essere resi, rendere fertile il dialogo dell’apprendimento. Se, durante una lezione semplificata di storia in un corso per adulti di recente immigrazione, parlando delle condizioni degli operai e delle operaiedurantelarivoluzioneindustriale,dellavoroprecario e sottopagato di minori e ragazze nel secolo scorso, una studentessa ivoriana nota: “Ma è quello che succede a noi oggi: quando impariamo un lavoro, veniamo licenziati e viene assuntounnuovotirocinante!”,lacomunicazioneèavvenuta, la nozione storica è diventata viva e diventa motivo di riflessione sul nostro presente. Allora c’è un motivo in più per approfondirla.
E, ricordo, la migliore definizione di “corruzione” mi è stata datadaunragazzomaliano,chehavistolaguerraciviledevastare il suo paese: “La corruzione è derubare il paese”, ha spiegato ai suoi compagni in classe. Come si potrebbe, con maggior efficacia, denunciare questo delitto? è evidente che le parole non sono neutre, ma trasmettono tutta l'ingiustizia dellastoriaimpressanegliocchiesullapelledichistadiven-
tandounostudenteconsapevole.Einmoltialtricasiilracconto dei paesaggi vivi nei ricordi degli studenti migranti ha riempitodicolorelelezioni:abbiamovisualizzatoedescritto leimmaginidellemontagnebianchedeifiocchidicotoneraccolti dalle donne africane, ho imparato che la cernita delle arachidi migliori viene fatta nel centro di un villaggio malianodadonneebambiniehoascoltatoleaccaloratediscussioni sull'impiegodeifruttidellepalme,diversidastatoastatoafricano.
Da questa interazione, dalla volontà di confrontarsi sul proprio vissuto, può nascere il gusto della comunicazione tra pari, della conoscenza dell’altro, premessa per quello che Raimon Panikkar definisce dialogo intraculturale, in cui si disarmano le voci conflittuali delle differenze. In questo periodoinparticolare,quandosiagitanospauracchidi“sostituzioneetnica”,comesipuòevitarecheiconcettidiculturae di identità possano diventare elementi di separazione, da brandirecomearmi?
Èsoloquandoimieistudentiitalianihannoiniziatoarapportarsi con i loro compagni venuti da lontano che si sono resi conto di avere un’identità nazionale. E proprio dal confronto conleaspettative,idesiderioibisognidell'altroèemersauna comune appartenenza al mondo degli adolescenti: non una omogeneizzazione che cancella le differenze, ma una conoscenza fatta di rispetto, in una visione del mondo nuova, plurale. Identità e culture si sono rimodellate. Si è compreso con naturalezza che la cultura non è un'unità compatta, con confiniprecisi,mavavistainmododinamico,perchéfattadi contattiecambiamenti,amaggiorragioneinunmondointerconnesso:sisonosperimentatidiversimodidivederelarealtà edivivere,seguendocriteridiveritàdiversi.
Inquestoprocessodiventanaturalmenteanchefondamentale garantire a tutti gli strumenti indispensabili per lo sviluppo delle competenze linguistiche perché esista comunicazione. Riprendo da un datato testo di Danilo Dolci dal titolo eloquente Dal trasmettere al comunicare: “Il comunicare è condizione per lo sviluppo del linguaggio, della crescita personale e collettiva.... L’aspetto creativo del linguaggio è la capacità di tutte le persone di produrre discorsi adatti alla situazione,anchesemagariinsolita,edicapirequestidiscorsi quando gli altri fanno la stessa cosa…Per certi aspetti fondamentali, non si apprende una lingua; piuttosto, la grammatica cresce nella mente. Quando il cuore o il sistema visivo, oppure altri organi del corpo, si sviluppano nella loro forma matura, si parla di crescita piuttosto che di apprendimento.
Aquestoproposito,ancorariguardoallaquestionedell'identità, vorrei aggiungere un ultimo aspetto, quello del plurilinguismo.Moltideipartecipantiaicorsihannorepertori plurilingue appresi oralmente nel luogo di provenienza in famiglia, in percorsi scolastici o nella loro condizione di
Alternativa Pgg. 22-23
" 2
2 Danilo Dolci, Dal trasmettere al comunicare. Non esiste comunicazione senza reciproco adattamento creativo, 4 ed., Milano, Edizioni Sonda, 2021. La prima edizione è del 1988.
migranti in diversi paesi prima di arrivare in Italia. Questi però spesso vengono passati sotto silenzio, non dichiarati tra le lingue conosciute, quasi fossero lingue di serie B. È la lingua parlata, nel villaggio, nelle città, ma le grammatiche bambara, peul o dagomba non si trovano sugli scaffali delle biblioteche,eallorasitaceunacompetenzaposseduta...Sono invece preziosi aiuti per due aspetti: innanzitutto diventano utilizzabili come lingue-ponte in classe, in secondo luogo sarebbero strumentiutiliperaccrescereinloroconsapevolezza e autostima, con relativa valorizzazione della cultura originaria, spendibili nella nuova condizione di profughi. Succede anche che i bimbi al momento dell'ingresso in una scuola in Italia imparino l'italiano più velocemente delle mamme,spessonon-lavoratricieconpocheoccasionidiparlare italiano e che i piccoli si rifiutino di conseguenza di parlarenellalinguamadreancheincasa.Miècapitato,durante una lezione, di dover spiegare a una mamma le parole che la bimba di tre anni usava di ritorno dalla scuola materna, escludendola di fatto dalla comunicazione: quando è la figlia chepromuovesocialmentelamadre,l'ordinenaturaledeirapporti si deforma. In quel caso, non c'è trasmissione dell'identitàculturalematerna,lalingua-madreperdevaloree lacomunicazionediventafontedisofferenza.
Ascolto e prossimità
Èlacondivisioneelanegoziazionedeiconcettiall'internodel gruppocheconsentedicomunicare;ma,aldifuorideidiversi corsi di italiano come seconda lingua non esiste uno spazio sicuroincuisiafacileperipartecipantiesprimeresestessi:le occasioni di incontro con ragazzi italiani sono scarse e in ambito lavorativo è evidente che non si offrano spazi a chi noncomprendeenonsafarsicomprendere.
Allora può avvenire, come purtroppo capita spesso, che il migrante sia visto come un corpo che lavora, funzionale per certi aspetti alla società, ma vissuto come minaccia o, nel migliore dei casi, come entità invisibile in un mondo, per usareun'espressionediZygmuntBauman, popolato da tribù, cioè da gruppi di individui, monadi che si riconoscono più o meno fanaticamente in valori nazionali, nei termini conflittualidel'noi'oppostoa'loro', Equientraingiocolaseconda coppiadifattori,ascoltoeprossimità.
Quandomancalaprossimità,ovverolaconoscenzadell'altro scaturitadalcontattopersonale,sipossonogenerarefantasmi estereotipiminacciosi.
Le lingue, come aveva ben visto Roman Jakobson, in realtà dipendonomenodalsistemagrammaticale,moltodipiùdalle esperienze non linguistiche condivise tra gli esseri umani, aggiungerei a patto che possano dialogare e confrontarsi, anchesecondocodicisoggettivi,inunaprospettivadiascolto reciproco e di condivisione. Un ascolto attento ed empatico, lo sappiamo, rende la comunicazione autentica e rassicura l'emittente,rendendoloconsapevolechelasuafaticadiesprimersi produce vicinanza. L'ascolto attento di narrazioni di storie personali implica la capacità di cogliere tutti i segnali, anche non verbali, che servono a connotare una fisionomia più precisa e ricca per idee e sensazioni condivise in classe, anchesespessoespresseconterminiapprossimativi.
Questa difficoltà è ben descritta da Agota Kristof quando, ricordando il suo iniziale spaesamento di profuga ungherese
inSvizzera,nonsapevatrovareleparoleperdialogareconun conoscente autoctono: "Come spiegargli, senza offenderlo, e con le poche parole che so di francese, che il suo bel paese non è altro che un deserto, per noi rifugiati, un deserto che dobbiamo attraversare per giungere a quella che chiamano l'integrazione, l'assimilazione." 3
Ma quando le scelte politiche mirano a rendere invisibili le persone emigrate dal loro paese, non istituendo percorsi di integrazionesistematicie,ancorpiùcolpevolmente,agitando spauracchidiinvasioniodisostituzionietniche,riducendole persone a dati statistici senza nome né volto, si assiste ad un processodiseparazionesocialecherendelostranierounanonimo esemplare appartenente a una categoria astratta e stereotipata.Esappiamocheresponsabilitàesolidarietà,fonti diognietica,sonolegatetraloroechesiassisteaunariduzionedellasolidarietàinmisurainversamenteproporzionaleallo sviluppotecnico-economico;aquestosiaggiungacheinparticolare, riprendendo le parole di Bauman, "la responsabilità viene messa a tacere quando si erode la prossimità; essa può alla fine trasformarsi in avversione una volta che i soggetti umani a noi vicini siano trasformati in ‘altri’” 4 Nel nostro mondo interconnesso assistiamo a un paradosso: le persone immigrate con i cellulari comunicano con il loro mondodiprovenienzainunaprossimitàdigitalechesirivela più stretta di quella interpersonale, che potrebbe avere luogo coniproprivicinidicasa. Michiedosenellenostrecittàsaremocapacidicrearenuove occasionicheapranoall'accoglienza,sesapremocondividere spazi e attività adatti a comunicare con persone giunte in Italiadapaesilontani,senzamuriinvisibilifattididiffidenza.
3 Agota Kristof, L'analfabeta, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 2005, p. 41.
4 La citazione è tratta da Zygmunt Bauman, Modernità e olocausto, Bologna, il Mulino, 2010, p.250; ho ripreso una considerazione tratta dalla conclusione del saggio, che studia un comportamento sociale, particolarmente devastante nell'Olocausto, che permane ancora pericolosamente attuale in alcuni tratti delle società burocratizzate di oggi.
Acontributi
Che la morte CI COLGA VIVI
spettacoli, film e incontri per interrogarsi sul senso della vita , della sua conclusione e sulla mediazione delle tecnologie nelle relazioni interpersonali


10.06.2023 |
LINGUAGGI TEATRALI
22.09.2023
Sabato 10 giugno - ore 20.30


VERBANIA - Spazio Sant’Anna - via Belgio 4
AGGIUNGI AL CARRELLO
13 | 20 | 27 giugno e 3 luglio - ore 20.30

VERBANIA - Spazio Sant’Anna - via Belgio 4
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA in collaborazione con: Cinecircolo Don Bosco
Spettacolo teatrale. Compagnia Teatro Paravento - Locarno con Luisa Ferroni, di Luisa Ferroni, Rita Pelusio, Domenico Ferrari. Regia di Rita Pelusio. SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Alternativa Pgg. 24-25
A INGRESSO LIBERO
ESAURIMENTO
SPETTACOLI
FINO
POSTI
Operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
Capofila
In collaborazione con:
italiano: Capofila svizzero: Partner:
www.cooplabitta.it
info pallium@cooplabitta.it
@progettopallium @lamariuccia_p
PREN DERE ESEM PIO
COMUNICAZIONE E SALUTE. LA PATENTE PER LO SMARTPHONE
Una buona idea nata nel VCO
Dopo essere esploso per tremila anni con mezzi tecnologici frammentari e puramente meccanici, il mondo occidentale è ormai entrato in una fase di implosione. […] Ci stiamo rapidamente avvicinando alla fase finale dell’estensione dell’uomo: quella, cioè, in cui, attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente esteso all’intera società umana, proprio come, tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi e i nostri nervi. Che questo prossimo estendersi della comunicazione, cui mirano da tempo i tecnici pubblicitari con riguardo a particolari prodotti, debba o no considerarsi ciò che si dice “un bene” costituisce un problema aperto a un’ampia gamma di soluzioni.” (Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare,IlSaggiatore1967,titolooriginale Understanding Media, 1964)
McLuhan individua una situazione drammatica,ilmediumdiventaessostessoilmessaggio “che modella e controlla la portata e la forma dell’associazione e dell’azione umana”. Strumenti che diventano mezzi in grado di orientare abitudini, gusti, consumi, modi di vivere e di pensare.
Eranogliannisessanta,imediaeranoleradio, i giornali, le televisioni (in bianco e nero), i telefoni (rigorosamente fissati al muro). Archeologia. Oggi a farla da padrone sono i social media, mezzi sempre più sofisticati e sempre più autonomi che ci hanno condotto a vivere pienamente immersi in un mondo di cuirischiamodiperdereilcontrollo.Strumenti di indubbia utilità che ormai fanno parte integrante della nostra vita e che non possiamo assolutamente ignorare, che ci costringono a interrogarci sul tema anticipato da McLuhan: un bene che può costituire un problema.
Dal punto di vista sanitario, della salute pubblica, gli effetti positivi della diffusione dei socialsonoindubbierimarchevoli.Lapromozione e la diffusione di dati e informazioni atti a migliorare le buone pratiche di salute, la possibilità di monitorare le condizioni di
Diego Brignoli
salute in particolare di anziani e fragili, strumenti sempre più efficaci per diagnosi a distanza, la telemedicina. Pensiamo all’importanteruolorivestitodaisocialedalla loro capillare diffusione nel corso della recente pandemia.
Risultati ed effetti positivi che non possono però far cadere l’attenzione su questioni problematiche che possono verificarsi. La disinformazione, estesa anche in ambito sanitario, che imperversa sul web, il rischio di venire usati dai social anziché usarli, la scarsa consapevolezza e la scarsa perizia con cui utilizziamo con disinvoltura strumenti ad elevatissima tecnologia e dagli effetti potenzialmente dannosi.
È il caso della diffusione tra giovani e giovanissimi dello smartphone. Strumento diventato a torto o ragione indispensabile, che vediamo maneggiare con disinvoltura da “nativi digitali”, spesso però inconsapevoli dei rischi annessi al loro utilizzo. I genitori che spesso, temendo di vedere il proprio “nativo” emarginato, cedono alle richieste pressanti, gli regalano lo smartphone e si danno come giustificazione la sicurezza di averlo sempre reperibile, sotto controllo. Sapràilgiovane“nativodigitale”,quasicertamente più abile dei genitori, farne buon uso?
E proprio nella nostra provincia del VCO è nata l’idea della “patente per lo smartphone”, un corso, analogo a quello per la patente per il motorino, per conoscere le modalità di utilizzo, conoscerne le potenzialità e i rischi.
NeabbiamoparlatoconMauroCroce,psicologo, da anni impegnato sul fronte delle dipendenze, e Francesca Paracchini, pedagogista dell’Associazione Contorno Viola.
Perché una patente?
Gli attuali smartphone sono di estrema semplicità di utilizzo, non necessitano di manuali o particolari corsi di apprendimento. Utilizzarli comporta però una forte conoscenza delle potenzialità e dei rischi che possono derivare dal loro utilizzo. Perché i rischi ci
A cosa avviene in casa d’altri
DA...
sono, e non sono pochi: cyberbullismo, fake news, truffe, pedopornografia… Occorre altresì acquisire consapevolezza e responsabilità, degli utenti e della comunità intera. Occorre educare alla cittadinanza digitale.

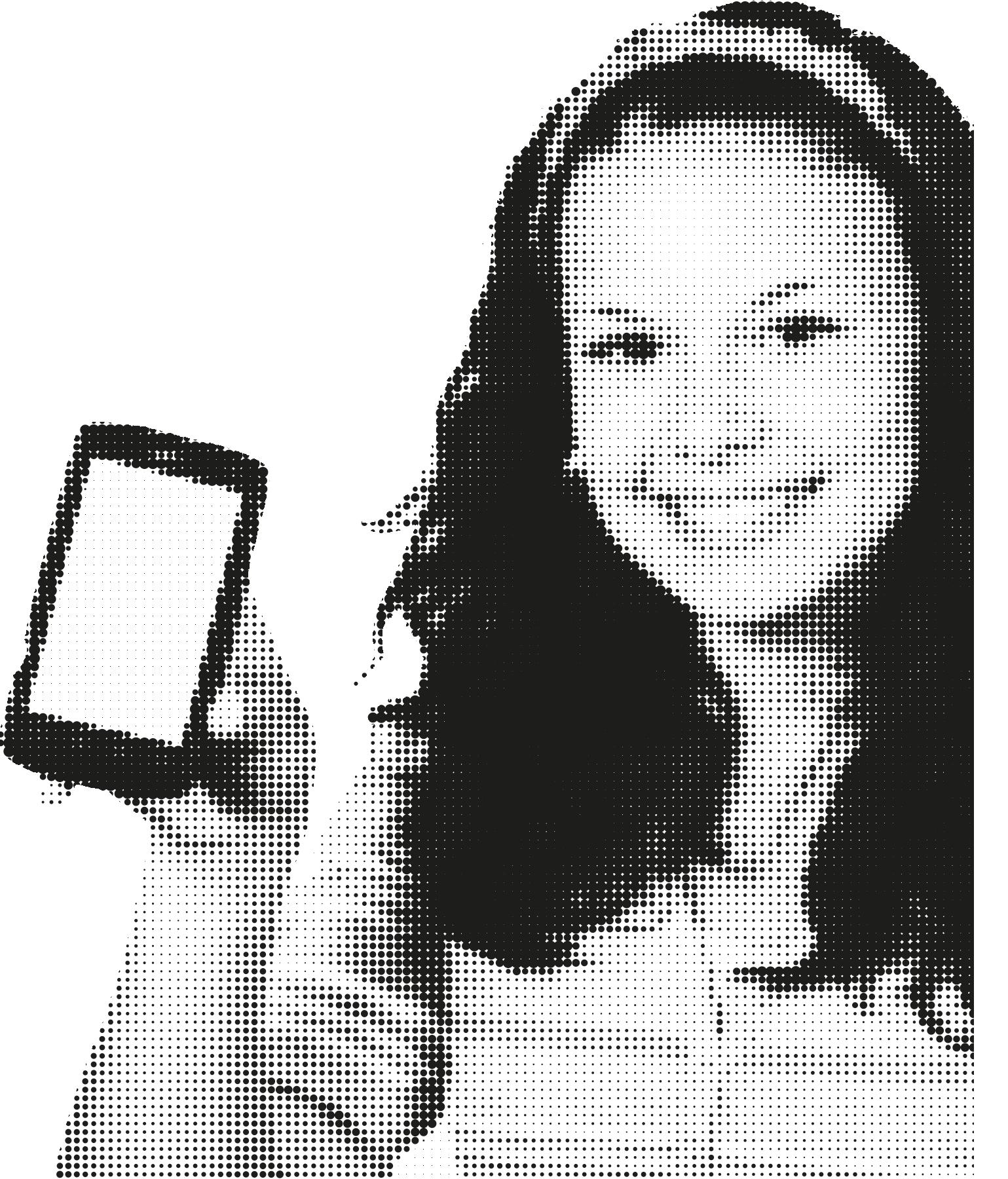
Chi ha collaborato al progetto?
La valenza educativa non può che partire da un’alleanza di più soggetti: la scuola, le famiglie, le forze dell’ordine, il volontariato, la salute pubblica, le amministrazioni. Nel VCO si è riusciti a trovare la collaborazione dei diversi soggetti: l’Ufficio Scolastico Provinciale che ha coordinatoilprogetto,l’ASLVCO,l’AssociazioneContornoViola, laPoliziadiStato.AdaiutarcilaLeggeNazionale71/2017 sul cyberbullismo che prevede un referente in ogni scuola.
A chi è rivolto?
Aragazzidi11-12anni,glistudentidelleprimeclassidella scuolasecondariadiprimogradodituttalaprovinciaealle lorofamiglie.Ilprogettohaperòcoinvoltoancheultrasessantacinquenni, il record spetta a una signora di 89 anni.
Come si sviluppa?
Dopo l’istituzione del gruppo di lavoro coordinato dall’Ufficio Scolastico Provinciale viene realizzato un percorso formativo per gli insegnanti referenti del cyberbullismo di ogni scuola, i quali a loro volta realizzano, in orario scolastico, due unità di apprendimento sui temi individuati come critici che si conclude con un test di verifica dell’apprendimento. Le famiglie vengono poi coinvolte con la stipula di un patto tra genitori e figli come assunzionedireciprocaresponsabilità.Vengonoinfinerealizzate e stampate le patenti che vengono consegnate con una cerimonia pubblica alla presenza di autorità locali e delle forze dell’ordine.
Come far risultare coinvolgente il progetto?
Lo sforzo è stato soprattutto quello di chiarire bene, in maniera volutamente semplice data l’età dei ragazzi, le informazioni di base. Per questa ragione gli insegnanti, debitamente formati, affrontano dapprima i temi dell’identità digitale, dei dati sensibili, della privacy attraverso quesitichestimolinoladiscussionedigruppo. Nellasecondaunitàdidatticasiaffrontainvece più direttamente il tema del cyberbullismosemprestimolandoladiscussione.
La consegna del patentino è comunque assicurata?
No, il test, anche se volutamente semplice, va superato. Aquesto punto viene consegnato il patto che, va riportato controfirmato per ottenere il patentino. È successo anche che il patentino venisse ritirato in alcune situazioni di cyberbullismo o cyber-stupidità, sempre però con una valenza educativa: la patente ti viene restituita ma dobbiamo fare un percorso insieme, da alleati. I ragazzi, gli adulti, la scuola e la famiglia.
Un progetto educativo ma anche sanitario.
Sì, perché salute è anche relazioni, felicità, condivisione, affrontare insieme momenti di tristezza e di dolore. Tutti dobbiamo concorrere nella costruzione della salute e nella difesadellasalutecollettiva.Ancheinunacomunitàdigitale.
Il progetto “patente per lo smartphone” ha superato i confini della provincia?
Sì, Il progetto sperimentale è stato avviato nel 2017, successivamente alla legge contro il Cyberbullismo (n° 71, 29 maggio 2017), la cui prima firmataria è stata la senatrice Elena Ferrara. Il consigliere regionale Domenico Rossi è stato relatore invece della Legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2018 che all’iniziativa del VCO si ispira. Numerose sono poi le realtà locali e le scuole in tutta Italia che hanno adottato o hanno tratto spunto dal nostro progetto. Recentemente la trasmissione di Rai 3 Presa Diretta ne ha realizzato un servizio.
Un progetto interessante, fondamentale per educare, a partire dai più giovani, alla cittadinanza digitale, cittadini consapevoli delle opportunità ma anche dei rischi e dei pericoli dei social media diventati pressoché indispensabili, sempre più sofisticati, sempre più diffusi, inarrestabili. Pensiamo alle crescenti preoccupazioni che sta sollevando l’attuale proliferazione dell’IntelligenzaArtificiale.
Pgg. 26-27 Alternativa
A
IL PEGGIORE DI TUTTI
Quando la comunicazione scivola nel delirio
NON PREN DERE ESEM PIO DA... I
Roberto Negroni
ntorno alla metà di marzo di quest’anno, una notizia ha agitato la quiete di questo estremo lembo di suolo italico incuneato tra laghi e monti, terra di genti che strapazzi e distrazioni della storia hanno reso poco inclini a sensibilità, slanci e passioni per ciò che esorbita il tepore domestico, la cura della bottega o l’ombra del campanile. Ma la notizia è davvero grossa. Se la provincia sobbalza, il capoluogo sanguina: “l’ospedale Castelli di Verbania è il peggiore d’Italia”!Non,sibadi,traipeggiori;no, proprio ilpeggioreditutti! La notizia si affaccia e dilaga in rete; in un momento, solleva un polverone di commenti orientati, più che all’incredulità (come forse sarebbe lecito attendersi in un territorio non proprio sottosviluppato), a mitragliate di recriminazioni, che riscorperchiano i mille risentimenti mai sopiti, generosamente alimentati dal retroterra di ventennali diatribe, inconcludenti quando non soltanto sgangherate, riguardanti le tristi vicende della sanità provinciale, emblematicamente rappresentate dallo storico irrisolto rosario di dilemmi: ospedale unico si o no? e, se si, dove? qui, là, sopra, sotto? e di due sole certezze: da me, non da te, ma se non da me, nemmeno da te! Il grido di dolore ha origine da
un comunicato stampa del 17 marzo di un comitato da anni sostenitore del Castelli, che riprende la notizia, senza ulteriori dettagli, da un giornale on line (ildunque.it) riportandone il link (da tempo non più raggiungibile). La notizia era già apparsa, quanto meno, il 10 marzo (qui), sempre senza informazioni utili a capirne origine e attendibilità, e il 16 marzo anche qui, finalmente corredata da qualche informazione supplementare. A questo punto si incomincia a capire qualcosa: innanzi tutto sembra esserci stata una ricerca dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per il Programma Nazionale Valutazione Esiti (Pne), per conto del Ministero della Salute. Però, dopo averci dedicato una mezz’oretta di ricognizione in rete, la ricerca c’è ma questi dati non si trovano. Bisogna accontentarsi di quanto desumibile dall’ultimo link qui sopra citato. Si scopre così che lo strillo, innanzi tutto, fa d’ogni erba un fascio, scambia la parte per il tutto, perché non è l’ospedale tout court “il peggiore d’Italia”, ma è, semmai, un particolare esito della Cardiologia: il tasso di mortalità nei trenta giorni successivi al ricovero per infarto nel reparto di Cardiologia. Al reparto del Castelli i decessi risultano
Cosa avviene in casa d’altri
essere 25,08%, il tasso più alto di tutti…, pardon, più alto degli ospedali presi in considerazione dalla ricerca, non sappiamo infatti se la rilevazione sia stata condotta sulla totalità degli ospedali italiani o su un campione (come se la cosa fosse irrilevante). Il tutto però “certificato” da un bel grafico colorato, a istogrammi orizzontali, con su in cima, per primo, esposto al pubblico ludibrio, il nominativo “Osp. Castelli – Verbania”, su cui non campeggia però il titolo “Quali sono gli ospedali peggiori”, ma “Gli ospedali con la maggiore mortalità per infarto”, differenza non da poco. Ma nemmeno così va bene. Il Direttore SOC Cardiologia del Castelli, personalmente sotto tiro, però smentisce tassativamente quel dato e il 20 marzo un comunicato ufficiale dell’ASL VCO ribadisce: “E’ di tutta evidenza la natura incompetente, imprecisa e fuorviante delle notizie apparse sul sito internet (…) I dati aggiornati al 2021 reperibili sul Programma Nazionale Esiti di AGENAS riferiti alla cardiologia dell’ASL VCO sono ben diversi e allineati ai dati nazionali, in alcuni casi migliori. Dati che smentiscono categoricamente quanto pubblicato”.
Basta così? No. Poco sotto quell’istogramma, la ciliegina sulla
torta: un’ineffabile annotazione informa che “I dati si riferiscono al: 2007-2011”. Dalla qual cosa si dovrebbe dedurre, astenendosi per una volta dall’andreottiano “a pensar male…”, che sia lecito ricorrere a dati vecchi di quindici anni per descrivere un fenomeno d’attualità; sempre ammesso, ma non scontato, che quei dati siano ineccepibilmente corretti. E ancora non basta: se quell’indicatore (il tasso di mortalità nei trenta giorni successivi al ricovero per infarto) viene rilevato periodicamente, che senso ha indicare un range di un quinquennio?
In conclusione, un incredibile pasticcio. Un’informazione, che qualche dubbio già poteva sollevare fin dal principio, priva delle necessarie verifiche, lanciata e ripresa scriteriatamente da più soggetti che pubblicamente agiscono, che suscita un groviglio di repliche in cui solo a tratti emergono barlumi di ragionevolezza.
Un caso emblematico di corto circuito informativo-comunicativo. Per carità, non soltanto non prendiamone esempio, che è proprio il minimo che si possa fare, ma teniamocene accuratamente alla larga o, se proprio non ci riesce, asteniamoci almeno dal prender parte alla generale e insensata scazzottatura.
Pgg. 28-29 Alternativa
PRO GET TI
FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL VERBANO CUSIO OSSOLA: NON SOLO UN ENTE DI EROGAZIONE
La Fondazione locale quale motore di connessioni, fattore di ricomposizione di reti, sostenitore e accompagnatore di processi e progetti
attività erogativa caratterizza fortemente le Fondazioni di Comunità ma esse si distinguono rispetto ad altri enti erogatori per il loro “essere della comunità”, quindi per la possibilità di introdurre una “cura” e un’attenzione specifica per lo sviluppo delle relazioni col territorio. Se l’orientamento alla qualità e all’efficacia dei progetti è il criterio di riferimento prevalente di tutti gli enti erogatori, la peculiarità delle Fondazioni di Comunità è infatti quella di affiancarvi una seconda finalità: il coinvolgimento della Comunità. Questa caratteristica si riflette tanto nell’attività di erogazione quanto in quella di raccolta fondi: lacondivisionedapartedellacomunità,misurata anche attraverso lo strumento dei bandi con raccolta, può ad esempio diventare conditio sine qua non per la concessione di contributi; parallelamente, la costituzione di Fondi è, di fatto, uno dei modi con i quali la comunità stabilisce una relazione con la Fondazione con la quale condivide il processo decisionale sulla destinazione delle risorse.
La Fondazione di Comunità ha sviluppato relazioni articolate con molti soggetti attivi sul territorio.
Unruolodiprimopianorisultanoaverloibeneficiari dei contributi: le organizzazioni non profit, gli enti pubblici e gli enti religiosi. Tali soggetti, nella maggior parte dei casi, sembrano percepire la Fondazione come punto di riferimento per la realizzazione dei progetti, soggetti affidabili che operano in modo snello ed efficace. In generale sta emergendo come la Fondazione locale sia sempre più percepita come ente d’intermediazione filantropica e non solo di pura erogazione.
In questi anni la Fondazione delVCO ha elabo-
rato un proprio posizionamento nel rapporto con gli enti pubblici, lavorando sull’importanza dellanascitaedelconsolidamentodiretiterritoriali al fine di costruire alleanze stabili in grado di rivitalizzare relazioni e risorse; impresa non facile per le stesse caratteristiche geografiche, storiche e culturali che vedono la comunità del VCO frammentata in tre zone.
Tuttavia la Fondazione comunitaria può essere “piattaforma relazionale” per lo sviluppo dei sistemi di welfare locale all’interno di un contesto spesso caratterizzato da una frammentarietà dei soggetti istituzionali.
In questo contesto la Fondazione valorizza il proprio ruolo di erogatore sul territorio, condividendo con l’ente locale lo sviluppo di progetti in cofinanziamento, mantenendo un ruolo neutro, come soggetto terzo, all’interno delle dinamiche locali.
In sintesi la Fondazione può essere: motore di connessioni, organizzatore di scambi/processi, fattore di ricomposizione di reti, anche nel senso di risorse ed energie; un HUB di condivisione di sguardi in relazione ai diversi contesti. Può sostenere, affiancare, accompagnare i processi e i progetti con i soggetti attivi delle comunità, promuovendo lo sviluppo di progettualità condivise.
Grazie alla capacità di intercettare problematiche e risorse, la Fondazione è sempre più un luogo“cerniera”trasoggettidiversiperlagenerazione di progettualità.
TraicompitidellaFondazionevièanchequello di fare da “incubatore” di coprogettazioni; la prima esperienza, in tal senso, è certamente individuabile ne “La Cura è di Casa”
Attivazione e partecipazione della comunità sono state un elemento di innovatività nella rete
Federica Corda
La Cura è di Casa, che ha permesso al Verbano Cusio Ossola di riscoprire la comunità come tessutosocialedicuicittadini,istituzionieterzo settore fanno parte, comunità in quanto senso di appartenenza a un territorio e voglia di mettersi ingiocopermigliorareerenderepiùforteeprotetto il territorio stesso. La collaborazione tra i cittadini, le istituzioni e il terzo settore si è rivelata fondamentale nella costruzione di un forte senso di responsabilità e appartenenza, innescando un inedito circolo virtuoso. Operatori del pubblico e del privato sociale lavorano in collaborazione con il mondo dell’associazionismo per ripensare i servizi tradizionali, mettendo al centro i bisogni della persona anziana in una logica di sussidiarietà e per sviluppare una cultura di welfare di comunità.
Dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus in avanti, si è prospettato un nuovo scenario nel quale il posizionamento della Fondazione localeèmutatoinmanieraimportante.Comeèstato più volte descritto nei paragrafi precedenti, la Fondazione è sempre più parte attiva nella collaborazione con gli enti locali per la pianificazione di programmi e iniziative di welfare. Un ruolo che risulta essere sempre più strategicoefunzionaleallafacilitazionedialcuni processi decisionali tra i vari soggetti. Questo consente alla Fondazione di sviluppare una prospettiva di valutazione multifattoriale che non si limita a considerare solo la “bontà del progetto” ma anche la lettura dei problemi del territorio e la conseguente individuazione di priorità di intervento, l’ascolto della comunità, la cura delle relazioni con enti del terzo settore e gli altri attori locali.
Pgg. 30-31 Alternativa
PRO GET TI
RADIOSEIPIÙ, UNO STRUMENTO ALTERNATIVO ALLA DIDATTICA TRADIZIONALE.
www.radioseipiu.it la prima radio web delle scuole di un’intera provincia
Angelo Iaderosa
Inverno 2020/21. Siamo ancora in piena pandemia e la scuola vive uno dei suoi momenti più bui. È già il secondo anno che le lezioni avvengono a distanza e l’idea di incontrarsi di personaapparecomeun’utopia.Traglistudentisembranospegnersiapocoapoco la curiosità, la gioia dell’apprendere, la passione per le sfide che fanno crescere… È in questo contesto che nasce Radioseipiù. Una radio fatta dagli studenti per gli studenti, un modo per tornare a divertirsi mentre si impara e per provareasentirsivicinianchequandosi è costretti a stare lontani. L’idea piace a molti insegnanti, che non si rassegnano a replicare senza successo modalità di lavoro per lo più ormai inefficaci; e piaceancheamoltialtri.
Così, il 26 marzo 2021 nasce ufficialmente Radioseipiù, un progetto delle scuole della provincia del Verbano Cusio Ossola, promosso dall’Ufficio Scolastico del VCOin sinergia connumerosi altri Enti e Associazioni del territorio. La sede viene collocata pressol’IIS“Ferrini-Franzosini”diVerbania,doveilsitowebdellaradioprende forma e viene implementato con i podcastprovenientidallescuoleprovinciali.
Le riunioni della redazione si svolgono online e così la prima formazione, che forniràaidocentileregolefondamentali per la produzione di podcast e le conoscenze tecniche per la registrazio-
ne. Gli insegnanti partecipanti sono molti e provengono da tutti i gradi e gli ordini di scuola. Vi è entusiasmo e molto interesse anche da parte di realtà nonpropriointerneallascuola,comela Neuropsichiatriadell’AziendaSanitaria Locale, la Fondazione Comunitaria del VCOealcunigiornalisti.
LaRadiosidàsubitounastrutturaorganizzativa per poter operare coinvolgendotuttelescuole.Nasconocosìil“Consiglio Direttivo”, costituito da tutti i dirigenti delle scuole coinvolte, che determineràlalineaeditorialegenerale; la “Redazione Operativa”, costituita da dirigenti scolastici e docenti con esperienza negli ambiti della tecnologia, della comunicazione, dell’inclusione, che tradurrà nella pratica le linee di principio dettate dal Consiglio Direttivo; le Redazioni Scolastiche, costituite da docenti e studenti, che produrranno, nelle rispettive scuole, i podcast da trasmettereinradio.
Il Regolamento della Radio, pubblicato anchesulsitoweb,chiariscebenelesue finalità:
1.Rinforzare i contenuti di apprendimento e stimolare negli studenti la curiosità e il desiderio di approfondire il sapere esercitando il senso critico;
2.Creareoccasioniformativeimportanti, che rendano gli studenti protagonisti della loro crescita culturale;
3.Valorizzare tutte le potenzialità e le inclinazioni, offrendo la possibilità di
fare esperienze inedite con importanti ricadute anche sull’autostima;
4.Offrireunostrumentodilavorodidattico inclusivo, adatto a tutti i Bisogni Educativi;
5.Creare occasioni di confronto tra studenti di scuole diverse e arricchire il comune patrimonio di idee e conoscenze;
6.Costituireunacontinuitàdilavorotra gradi e ordini di scuola diversi;
7.Consolidare la consapevolezza che il contributo di ciascuno è fondamentale, affinché un progetto comune abbia successo.
E anche il nome scelto “Radioseipiù” vuole rimandare proprio a un luogo, la radio,dovesicreanooccasioniperdare valore a tutti gli studenti: “Sei più di quello che credi, sei più del voto che prendi, non sei più solo ma fai parte di unacomunitàcollaborativadoveilcontributodituttièprezioso”.
SulsitosirealizzaunasezioneTutorial, dove vengono pubblicate anche le indicazioni fondamentali per registrare i podcast e inviarli alla redazione, con i jingle e gli intermezzi da utilizzare per aprireechiuderelatrasmissione.Anche i jingle e gli intermezzi musicali sono realizzati da una scuola della provincia a indirizzo musicale e costituiscono un marchio di riconoscimento inconfondibileperlaradio.
Traiprimipodcast,insiemealleinterviste “possibili e impossibili” ai sindaci,
ad artisti, a opere d’arte e personaggi storici o del mito, arrivano delle canzoni composte dagli studenti per affrontare insieme, con un po’di speranza, le paure e le angosce della pandemia, come i brani “Covid 19” e “Mascherina”, che, come suggerisce la didascalia di accompagnamento, è “un brano nato tra i banchi di scuola e le scrivanie di casa durante l'ultimo anno di lockdown dove alle lezioni in presenza si è alternataladidatticaadistanza. Mascherina descrive in modo crudo e diretto, con laspontaneità dei più giovani, un anno difficileche ha ricordato a tutti quanto sianoimportantilerelazionipersonali”. La Radio prende forma e ben presto acquisisce il sostegno anche delle radio locali,chenediventanopartnertrasmettendo dalle loro frequenze alcuni podcast degli studenti. Anche “VCO Trasporti” viene coinvolta nel progetto e consente di serigrafare sulle fiancate di alcuni autobus le immagini pubblicitariediRadioseipiù,realizzatedall’indirizzo di grafica di una scuola. Resta ancora da realizzare l’idea di trasmettere,sulletrattepiùfrequentatedaituristi, delleinformazionidiarteestorialocale registratedaglistudentiinpiùlingue. Neltempoipodcastprovenientidatutte lescuolesimoltiplicano,andandoatoccare tutte le tematiche d’interesse della radio, dal cyberbullismo alla cultura, all’ambiente, allo sport e ad oggi se ne contano quasi 140, vero record per una radiowebscolasticaeconsolidueanni diattività.Nel2021enel2022laRadio ha promosso l’orientamento scolastico euniversitario,ancheconunospazioin video, in collaborazione con VCO
Azzurra TV. Le interviste dei dirigenti scolasticiedeidocentiuniversitari,poi, hannotrovatospazioanchesulsettimanale locale Ecorisveglio, dando vita a un’ulteriore interessante collaborazione dellaradioconilterritorio. Per le sue caratteristiche di inclusività e per le potenzialità che esprime come strumento didattico, Radioseipiù ha ottenuto anche l’apprezzamento del Prof. Giacomo Stella, uno dei massimi esperti di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) e dei centri SOS Dislessia; tanto che il Professore le ha dedicato un efficacespot,tuttorapubblicatosulsito, e nel 2021 ne ha richiesto la presentazionealVConvegnoNazionalediSOS Dislessia.
DaciòsicomprendecomeRadioseipiù non sia una semplice radio web, ma un progettomoltodinamicoediversodalle altre radio scolastiche fiorite negli ultimi anni. Infatti, pur avendo imparato molto dalle importanti esperienze precedenti nate su iniziative di alcuni bravissimi docenti delle nostre scuole (la Scuola in Ospedale di Piancavallo e la ScuolaSecondariadiprimogradodella Valstrona, per esempio), Radioseipiù si configura come un’esperienza veramentenuova,soprattuttoperilcoinvolgimento dell’intera provincia e di studenti di ogni età e poi per la sua caratteristica di progetto aperto, come dimostranolemoltecollaborazioni(con leradiotradizionali,conigiornalicartacei e on line, con l’azienda di trasporto pubblico)oltrechedisponibileadaccogliereognicontributoproduttivoeinno-

vativo. Questo confermano anche gli artisti (cantanti e scrittori da tutta Italia) che, incuriositi dal progetto, hanno chiestodiessereintervistatiperlaradio. Particolare valore del progetto, inoltre, viene dal fatto che la Radio si fonda su risorseprofessionaliinterneallascuola: professori che sono anche ingegneri, grafici, musicisti, esperti di comunicazioneemoltoaltro.Unicofinanziamento è stato un contributo della Fondazione Comunitaria del VCO, sempre vicina alle scuole, destinato alle spese perl’acquistodeldominio. Quindi, l’esperienza di Radioseipiù è unesempiodicomesiapossibilerealizzare, anche senza finanziamenti specifici,modellidiapprendimentoinclusivi e alternativi alla didattica tradizionale, capacidivalorizzareleattitudiniditutti gli studenti, costituendo un sistema didattico ampio, in una vera comunità di pratiche, pur che vi sia una significativa condivisione di obiettivi da perseguire.
La forza di Radioseipiù inoltre consiste anche nel fatto che essa utilizza i canali di comunicazione familiari e quotidiani per i ragazzi (si ricorda che i podcast viaggiano anche sui social), dimostrando concretamente come il web possa costituire una grande risorsa e contribuendo, nel contempo, all’educazione digitale dei giovani. In questo senso, Radioseipiù integra e prosegue il fortunatoprogettodellapatentedismartphone, nata nel 2017 nello stesso Ufficio Scolastico del VCO per le scuole, con unmodelloorganizzativosimile.
Pgg. 32-33 Alternativa
MIGRAZIONI: CALAMITÀ
Lunedì 5 giugno a Spazio Sant’Anna, Cooperativa Sociale Risorse, in collaborazione con il Gruppo Abele di Verbania, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione rivolta ai giovani e all’intera cittadinanza, sul tema dell’inclusione. L’idea è quella di affrontare il fenomeno della migrazione, senza

falsa retorica, semplicemente raccontando storie umane e lavorative che parlano di sogni, riscatto e quotidianità.
A farlo sono i diretti protagonisti, attraverso le proprie testimonianze raccolte nel docu-film “MigrazioniStorie di umana rinascita in un’economia in trasformazione”, e due
ospiti d’eccezione: il fotogiornalista Francesco Malavolta e il professor MaurizioAmbrosini del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano. A condurre l’incontro Vittorio Zacchera, Presidente della Cooperativa Sociale Risorse di Verbania.
AProtagonisti e testimonianze
Una giornata di sensibilizzazione su un importante fenomeno che sta dividendo il nostro paese, organizzata da Cooperativa Sociale Risorse.
BENEDIZIONE?
Il fotoreporter Francesco Malavolta, dal 30 maggio in libreria con il volume “Troppo Neri”, edito da Feltrinelli, e realizzato in collaborazione con il giornalista SaverioTommasi, è impegnato da oltre vent'anni nella documentazione dei flussi migratori, in costante intensificazione, che interessano il nostro continente. Un


lavoro svolto in un contesto spaziotemporale in continuo mutamento che lo ha portato a viaggiare lungo i confini di una Europa sempre più blindata e difficile da raggiungere via terra o via mare. Da 12 anni collabora con la Comunità Europea, varie agenzie di stampa internazionale comeAssociated Press, nonché organizzazioni internazionali quali UNHCR e OIM.
Il professor Maurizio Ambrosini è docente di Sociologia delle migrazioni all’Università degli Studi di Milano. Insegna da diversi anni all’Università di Nizza e ha insegnato nella sede italiana della Stanford University. È responsabile scientifico del Centro Studi Medì - Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, dove dirige la rivista «Mondi migranti» e la Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni (18a edizione nel 2023). Collabora con «Avvenire» e con lavoce.info. Da luglio 2017 fa parte del CNEL, dove ha presieduto l’organismo di coordinamento delle politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri. Ha pubblicato numerosi libri dedicati alla migrazione e alle sue connessioni con il mondo del lavoro, tra cui “L’invasione immaginaria” (Laterza 2020), “Altri cittadini” (Vita e Pensiero 2020), “Sociologia delle migrazioni” (terza edizione 2020).
La giornata del 5 giugno, divisa in due momenti, al mattino con gli studenti del Liceo Bonaventura Cavalieri e dell’IIS Lorenzo Cobianchi di Verbania, e alla sera per la cittadinanza, non è che il primo appuntamento di un progetto dedicato alla cooperazione e alla migrazione che Risorse insieme a GruppoAbeleVerbania, porterà avanti in autunno con le scuole del territorio.
Pgg. 34-35 Alternativa O
Cristina Barberis Negra


AProtagonisti e testimonianze
FotodiFrancescoMalavolta
TERRA DONNA
Intervista a Simona Pedroli
Simona Pedroli, 46 anni, presidente dal 2017 dell’associazione “Terra Donna”, con sede a Domodossola, che si occupa di contrasto di violenza sulle donne, discriminazione e integrazione sociale.
Quale è stato il percorso personale e sociale che ti ha portato a conoscere “Terra Donna” e a impegnarti in essa?
Hoconosciuto“TerraDonna”partecipandoallapresentazione dello Sportello Antiviolenza di Domodossola; mi ha subito colpita l’importanza del tema e mi sono messa a disposizione ma, non avendo competenze specifiche in materia,mièstatapresentata“TerraDonna”,associazionedi volontariatochecollaboravacon lo sportello.
Mi ha subito colpito la dinamicità dell’associazione, la disponibilità delle volontarie che, pur essendo un numero limitato,sonosempreaperteallenovitàe,inoltre,ètotalmenteindipendente,nonavendoalcunavicinanzapartiticaocon altreformedirappresentanzasulterritorio.
Ci racconti delle tue esperienze, sia positive che negative nell’associazione?
Lenostreattività,chesonoessenzialmentedipromozione,di sensibilizzazione e di raccordo con i professionisti della materia, di solito non hanno un riscontro immediato ma quando, per vie traverse, ci giungono notizie di donne che, anchegraziealnostrocontributo,sonoriusciteadaffrancarsi da situazioni che spesso hanno un esito tragico, questo ci rendedavverofelici.
Penso, ad esempio, ad una donna a cui abbiamo fatto conoscere una app della Regione Piemonte che gli ha permesso diliberarsidell’exmaritochelatormentavadaoltre20anni.
L’aspetto più negativo di quest’attività è lo scoramento che ti coglie quando ti rendi conto che non tutte le associazioni hanno lo stesso nostro spirito collaborativo e che, a volte, dietroaunfiumediparole,c’èilnulladalpuntodivistaconcreto.
La stessa triste sensazione si prova quando si nota la scarsa sensibilità da parte di alcune istituzioni del territorio, per le quali, evidentemente, ilproblemanon ècosìimportante.
Con chi collaborate principalmente?
Per quanto riguarda l’aspetto della violenza sulle donne il nostro interlocutore è il servizio “Giù le mani” della cooperativa “La Bitta”, mentre per quanto riguarda la parte legata alladiscriminazioneabbiamodatempoistauratounrapporto dicollaborazioneinparticolarecon“ArcigayNuoviColori”, “Non SoloAiuto” e, a seconda dei progetti, abbiamo collaboratoanchecondiversisoggettiprivati;perquantoriguarda la istituzione pubbliche che hanno dimostrato sensibilità ai nostri temi, abbiamo lavorato proficuamente con i Comuni diCrevoladossola,VilladossolaeMontecrestese.
Alvi Torrielli
Ci racconti brevemente quali sono le iniziative che avete attuato e quali ci attendono nel futuro?
In questi anni abbiamo cercato di sviluppare iniziative sempre diverse che ci diano la possibilità di costruire una rete di relazioniconaltreassociazionidelterritorioe,soprattutto,di informare e sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne che spesso viene vissuto come lontano e per superare ipregiudizichelo accompagnano.
Un’iniziativa in questo senso è stata quella di distribuire, in alcune attività commerciali domesi, sagome di donne su cui eranodescrittelevicende,reali,didonnevittimediviolenza: donne appartenenti a diverse realtà socioeconomiche, culturaliedetniche,adimostrazionedell’assolutatrasversalitàdel problema.
Abbiamo anche organizzato brevi corsi di autodifesa e incontri di approfondimento psicologico sull’autostima e altritemiconnessiainostritemi.
Recentemente, in collaborazione con “Arcigay Nuovi Colori” e con l’associazione “Teatri di Pietra” abbiamo raccolto fondiasostegno delledonneiraniane.
Un evento che da anni organizziamo, tra ottobre ed il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è Ciak si parla, una rassegna cinematografica sui nostri temi con la quale, attraverso la visione del film ed i dibattitiaseguire, operiamoun’azionedisensibilizzazione.
Quale è la tua visione del futuro di “Terra Donna”?
Molte cose sono cambiate da quando ho iniziato la mia attività in “Terra Donna”: se da una parte la sensibilizzazione sul tema è aumentata decisamente, sono stati fatti notevoli passiavanti,dall’altrasiècomplicato lavitaalleassociazioni dal punto di vista burocratico. Il principio nobile per cui bisogna contrastare il finto associazionismo, che nasconde interessipersonali,nondevediventareunsemprepiùgrande fardello per le piccole associazioni che si scontrano con la necessità di continui aggiornamenti e una sempre maggiore competenzaburocratico-legale.
Unaltroproblemastanelladifficoltàditrovarenuovepersone interessate ad impegnarsi senza averne un ritorno economico:cisonomilleragionidietroaquesto,maèchiaro che il volontariato ha spesso sopperito alle mancanze del pubblicoe,senonsiinverterapidamentelarotta,lacosapuò diventareun problemaamolteplicilivelli.
PerquantoriguardaTerraDonna,ilnostroobbiettivoèquello di implementare sempre più la rete di relazioni per raggiungere sempre più persone sensibilizzandole su nostri temi.
Cipiacerebbepoicoinvolgereigiovaniinprogettichelipossanofarsentireattiviecoinvolti.
Poi, si sa, il domani porta sempre sorprese, speriamo siano positive!
Pgg. 36-37 Alternativa

INCONTRO CON LUCA MERCALLI
Un successo la conferenza a Casa don Gianni
Casa don Gianni, di Domodossola, nel pomeriggio di venerdì 24 marzo ha ospitato Luca Mercalli, climatologo, meteorologo, divulgatore scientifico, noto al pubblico televisivo italiano per la partecipazione alla popolare trasmissione “Che tempo che fa”, che ha tenuto un interessante e attuale incontro. Un successo anche l’affluenza: circa 200 le persone presenti, diverse delle quali in piedi ai lati del salone.
L’appuntamento, organizzato da Alternativa A, è stato introdotto della vice presidente Vittoria Allegranza la quale, dopo aver presentato l’ospite, ha ricordato che l’associazione nei suoi 40 anni di vita è sempre stata attenta alle problematiche giovanili locali.

L’illustre conferenziere, che frequenta l’Ossola da 40 anni, ha affrontato principalmente due temi, proiettando
Il primo tema ha riguardato il riscaldamento climatico e le relative conseguenze, ricordando al proposito l’importanza dell’osservatorio del Collegio Mellerio Rosmini in
Mercalli ha evidenziato che i cambiamenti climatici sono un effetto delle emissioni in atmosfera di oltre un secolo di produzione industriale sempre più accelerata e messo in evidenza gli errori attraverso i quali l’uomo sta compromettendo il precario equilibrio che regola l’ambiente. Una situazione di vera emergenza quella in cui versiamo, aggravata ora dalla guerra in Ucraina. La temperatura su tutto il pianeta in un secolo è aumentata di 1,1 gradi e di 2 sulle Alpi. L’estate 2022 è stata la più calda di sempre in Europa. Se non si rispetta l’accordo di Parigi del 2015 entro fine secolo è probabile un aumento della temperatura di 5 gradi con considerevoli conseguenze per il benessere delle persone e per il pianeta. Il livello del mare potrebbe salire anche di un metro, i ghiacciai in tutto il mondo si ritirano anche perché nevica sempre meno e nelle Alpi rimarranno solo quelli del monte Bianco e del Rosa. Piove molto meno e la siccità crea una serie di problemi all’agricoltura.
Afronte di tutto questo i politici preferiscono dare priorità all’economia anziché ridurre le emissioni di anidride carbonica, principali responsabili dell’effet-
Carlo Pasquali
to serra e del conseguente surriscaldamento dell'atmosfera.
La seconda parte del suo intervento è stata dedicata a quello che ciascuno di noi può fare per contenere le 7 tonnellate annue emesse nell’ambiente da ogni persona. Lo ha fatto presentando il suo libro “Salire in montagna; prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale” che rende sempre più roventi le estati nelle città. Una scelta che Luca Mercalli ha deciso di seguire e affrontare in prima persona. Dopo aver acquistato una baita a Vazon, piccola borgata dell’altaVal Susa, nel territorio di Oulx, a 1650 metri di quota l’ha ristrutturata rispettandone l’architettura originale alpina ma applicando le più moderne tecnologie: l’isolamento termico, i pannelli solari, la pompa di calore e la stufa a legna ad alta efficienza. Ora è la casa in cui vive.

RecuperobaitainaltaValdiSusa: RecuperobaitainaltaValdiSusa: casostudiodisostenibilitàenergeticae casostudiodisostenibilitàenergeticae ambientale ambientale
LucaMercalli–ItalianMeteorologicalSociety, LucaMercalli–ItalianMeteorologicalSociety, Turin,ITTurin,IT-info@nimbus.it info@nimbus.it

ANotizie e cronache
I GIOVANI SI CONFRONTANO SU IDENTITÀ, SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ

Spazio I.S.A. ha partecipato, grazie al Consorzio Link, al Bando Sociale di Fondazione Comunitaria VCO
Spazio I.S.A. cresce. A un anno dalla sua nascita sono tanti gli obiettivi raggiunti e altrettante le aspirazioni e i progetti. Il gruppo, che riunisce spontaneamente giovani del VCO, di età compresa tra i 15 e i 30 anni, si incontra ogni giovedì a Spazio Sant’Anna, per discutere temi riguardanti Identità, Affettività e Sessualità, come indica l’acronimo del proprio nome.
«Spazio I.S.A. – spiega Camilla Mafrica, tra i membri del gruppo –nato in risposta a un bisogno di dialogo e confronto su tematiche considerate tabù, e ha costruito un luogo aperto e sicuro in cui poter crescere e imparare insieme, un luogo di cui i giovani del territorio sentivano la mancanza Dai piccoli incontri informali degli inizi, Spazio I.S.A. ha esteso la riflessione sulle tematiche proposte a un pubblico più ampio e si è attivato per portare un’educazione alla sessualità, rivolta a tutta la comunità, promuovendo una trasformazione profonda in merito al ruolo che Identità di Genere, Sessualità e Affettività hanno nell’ecologia delle relazioni umane. Proprio per rivolgersi a un numero sempre maggiore di persone ha partecipato, attraverso il Consorzio Link s.c.s., al Bando Sociale 2022.1 della Fondazione Comunitaria del VCO, Ente Filantropico, ottenendo, con il progetto “Spazio I.S.A.”, un contributo di 8.000 euro su un valore complessivo di 14.000.
«Il progetto, della durata di 18 mesi, ha attivato come prima azione un percorso di autoformazione per i giovani volontari del gruppo Sabrina Lunardon, tra i primi membri di Spazio I.S.A. -
ANotizie e cronache
Cristina Barberis Negra


Pgg. 40-41 Alternativa
Foto di Lorenzo Camocardi
LA MAXI SPERIMENTAZIONE DEL COBIANCHI
Un viaggio nel percorso lungo e stimolante di questo Istituto che ha segnato profondamente studenti, genitori e insegnanti, grazie al suo continuo evolversi nel riflettere i cambiamenti sociali, economici e culturali succedutisi nella storia recente del nostro paese
Guido Boschini e Luca Sarasini
istituto Cobianchi di Verbania è un’importante e antica realtà scolastica della nostra provincia. Fondatonel1886comeScuoladiArtieMestierigrazie allascitotestamentariodell’industrialeLorenzoCobianchi, nel corso dei suoi quasi 140 anni ha cambiato più voltedenominazione,daScuoladiArtieMestieriaIstituto professionale, poi tecnico-industriale e infine l’attuale Istituto di Istruzione superiore, attivando sempre nuovi corsi: agli originali nel settore meccanico e chimico-tessile si sono via via aggiunti il chimico e l’elettrotecnico, poi l’elettronico, l’informatico, il biologico, il linguistico e le scienze umane e sociali, fino a raggiungere l’attuale assetto con i corsi tecnici (meccanica, meccatronica ed energia - informatica e telecomunicazioni-elettronicaedelettrotecnica-chimica,materialiebiotecnologie)eliceali(liceoeconomicosociale-dellescienzeapplicate-linguistico).
Questetrasformazionidellascuolanonsonostatecasuali, ma hanno sempre riflettuto i cambiamenti sociali, economici e culturali che si sono succeduti nella storia recentedelnostropaese:inparticolareilmovimentodel Sessantottofusenzadubbiounfenomenosocio-culturalecheintrodussenellasocietàmutamentiprofondiacui leistituzioni,elascuolainparticolare,dovetterorispondere.Nonèuncasoquindisenel1974l’alloraMinistero dellapubblicaistruzione-oggiMinisterodell’istruzione edelmerito-chieseauncertonumerodiscuoledipresentare progetti di sperimentazione in previsione di una “imminente” riforma della scuola superiore, realizzata poi nel 2010 dalla ministra Gelmini, sicuramente con presuppostiideologicimoltodiversi.
A quell'invito del 1974 il Cobianchi rispose positivamente elaborando un progetto che venne autorizzato a partire dall’anno scolastico 1974/1975, segnando la nascitadella“Maxi-sperimentazione”.
I documenti elaborati 50 anni fa dagli insegnanti della Sperimentazionesonoancoraattualissimi,introducendo iconcettidionnicomprensività,orientatività,pre-professionalità,gestionesocialeetempopieno.
Ilpuntofortedialloraeraunmodellounitariodiscuola superioreonnicomprensivachesuperasse:
-ilsistemaacanned’organocheforzava,eforzatuttora, unasceltatroppoprecocealterminedellascuolamedia; -la divisione tra cultura umanistica e scientifico-tecnica, tra cultura e professionalità e, per quanto possibile, tra lavorointellettualeelavoromanuale,sostenendolapari dignità degli indirizzi, tutti terminali e propedeutici agli studiuniversitari;
-la divaricazione tra scuola e sviluppo economico, per realizzare un rapporto concreto tra formazione, professionalità, occupazione, fornendo una professionalità di base polivalente e critica a cui fosse complementare la formazioneprofessionaleregionale.
Questa nuova scuola superiore avrebbe dovuto avere una forte finalità orientativa, che in realtà non è mai stata perseguita in modo sistematico, ma che da allora ricompare in molte indicazioni ministeriali e che, ironicamente, è uno dei punti di un piano di matrice completamente diversa: il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)! L’orientatività era intesa non solo come attività di orientamento in vista della scelta del trienniodispecializzazione,masiproponevadifavorire lepotenzialitàindividualielosviluppodellapersonalità in tutti i suoi aspetti; uno degli obiettivi dichiarati era di ridurrel’influenzadeifattorisocio-economicisullefuture scelte degli studenti, per contribuire a realizzare il dirittoallostudioeasuperarelastratificazionesociale.
La riflessione sull’estrema specializzazione delle mansioni tecniche nell’industria, sullo scompenso tra domanda e offerta nel mondo del lavoro per quanto riguardavaitecniciintermedi,esull’impossibilitàperla scuola di rincorrere le innovazioni tecniche e tecnologicheportaronoallaconclusionechelascuolanonpoteva essere professionalizzante, ma pre-professionalizzante: doveva cioè fornire agli studenti gli strumenti di conoscenzaevalutazionecriticadeiprocessiproduttivi, inmododaottenerenonunaddestramentospecialistico, ma competenze di base flessibili e aperte al mutamento
Adalla scuola
scientifico e tecnologico. Ovviamente questo progetto richiedevacorsidispecializzazionedafrequentaredopo il biennio unitario o dopo il diploma quinquennale: in qualche modo venivano prefigurati gli Istituti tecnici superiori(ITS).
Venne sviluppato anche il concetto di gestione sociale dellascuola,derivatodallavolontàdirenderepiùdemocratica la vita scolastica, superando anche i decreti delegati allora appena emanati. La gestione sociale prevedeva riunioni periodiche di insegnanti, genitori e studentiperdiscutereimetodidilavoro,icriterigenerali divalutazionedellavorosvolto,gliargomentideilavori interdisciplinari e le iniziative integrative dell’attività didattica.
Benché dopo pochi anni fosse evidente che nel breve periodononcisarebbestatanessunariformadellascuola superiore, la Sperimentale continuò il suo cammino, cambiando più volte attraverso i contributi di tutti gli insegnanti che negli anni vi lavorarono, cosı come sono cambiati i tempi e il milieu culturale, politico e sociale del nostro paese, fino a quando venne definitivamente chiusadallariformaGelmini.
A distanza di quasi un cinquantennio dagli inizi di tale esperienza, è ancora interessante approfondire alcuni aspettichel’hannocaratterizzataeinparticolare:
-la continua ricerca metodologica effettuata sul campo dagliinsegnanti;
-l’esigenza di formazione e di auto-formazione, intesa comebisognoessenzialedeidocentistessi;
-ladidatticalaboratorialeel’usodelletecnologie;
-ilmetododistudio;
-lavalutazionedegliapprendimenti;
-il lavoro di équipe come caratteristica fondante della professionedocente.
Daquestacontinuariflessionenascel’ideacheildocente deve essere un professionista e un ricercatore, altamente motivato, in formazione continua e in continuocollegamentoconciòcheaccadefuoridallascuola, nellasocietà,nell’economiaenell’accademia.
Per approfondire questi aspetti e per non disperdere i risultatidellariflessioneancoraattualissimachesièsviluppata nei 50 anni della Sperimentale un gruppo di insegnanti ha scritto in équipe (e non poteva essere diversamente) il libro Sperimentare la Scuola. Storie di buone prassi, edito dalla casa editrice Blonk Editore di Pavia.
Il libro ripercorre la storia della Sperimentazione ed è articolato in capitoli monografici che approfondiscono gli argomenti sopra citati: Ricerca e formazione; Laboratori e tecnologia; Chi impara cosa? Il metodo di studio; Numeri in libertà? La valutazione per obiettivi; Il lavoro d’équipe e le sue articolazioni.Ilvolume,inoltre,perarricchireilraccontodell’esperienzadellaMaxisperimentazione, riporta anche la fondamentale voce degli studenti, raccolta attraverso dei focus group fina-
lizzatiaesplorarel’accoglienzaneiprimigiornidiscuola, il metodo di studio, le didattiche innovative, i laboratorieleesperienzevissuteascuolaritenuteancora oggi utili. Concludono il volume due articoli, uno di Roberto Maragliano (ex ordinario di materie di ambito pedagogico,didatticoedelsettoretecnologicodell’area didattica nelle Universita di Lecce, Roma Sapienza e RomaTre)eunodiCristianoCorsini(ordinariodiPedagogia sperimentale e Valutazione scolastica all’Università Roma Tre), ai quali è stato chiesto a che punto sia la formazione docenti in Italia e le prospettive dellascuolaitalianapost-rivoluzionedigitaleepost-pandemia. In appendice sono riportati alcuni documenti significativi.
Inoccasionedellapresentazionedellibro,chesiètenuta venerdì10marzo2023nell’auditoriumdelCobianchi,è statoorganizzatol’evento“Indimenticabiliqueglianni”, a cui hanno partecipato molti ex docenti ed ex allievi dellaSperimentale.Dopoisalutidell’attualeCollaboratore del Dirigente Mauro Agrati, è intervenuta Sara Antiglio, docente distaccata presso l’Ufficio scolastico provinciale, che ha sottolineato come il progetto della Sperimentale sia ancora attuale, offrendo molti spunti alla scuola attuale. È stata poi la volta della sindaca di VerbaniaSilviaMarchionini,cheharicordatolasuafrequenza del corso di Scienze umane e sociali. Lo storico vicepreside Ettore Perelli Cippo e Cristina Bolelli, una delle autrici del libro, hanno ripercorso la storia della Sperimentazione. Il loro intervento è stato seguito da quellodiexallievidegliindirizzidiScienzeumane,Linguistico moderno e Biologico che, grazie a Francesca Paracchini,un’altraautricedellibro,hannoraccontatola loro esperienza scolastica focalizzandosi su tre parole chiave: accoglienza,ricordandol’empatiadeiprofessori e il loro “sguardo profondo” sugli studenti; metodo di studio, incentrato sulla didattica laboratoriale; competenza, prima come studenti e oggi come professionisti e cittadini del mondo. Infine Guido Boschini, un altro degli autori, ha dialogato con l’editore Lele Rozza sulle motivazioni che spingono una casa editrice a occuparsi discuola.
L’interaseratapuòesserevistasuYouTubeall’indirizzo https://youtu.be/TyYTigvzsYw.
Pgg. 42-43 Alternativa
GIUSTIZIA NEGATA
Riflessioni dal Servizio Antiviolenza“Giù Le Mani”della Cooperativa La Bitta
Monica Cupia e Laura Luisi
Dal 27 al 29 gennaio scorso, Monica Cupia, psicologa del servizio “Giù le mani” della Cooperativa La Bitta, ha partecipato a un incontro organizzato a Roma dalla rete Reama.
Reama, fondata da Pangea, riunisce al suo interno molteplici centri antiviolenza presenti in tutta Italia, allo scopo di condividerne pratiche, riflettere sul fenomeno della violenza di genere e acquisire un maggior peso mediatico di fronte all'opinione pubblica.
Le realtà che aderiscono alla rete di Reama sono ormai un centinaio e nell'incontro di gennaio sono emerse alcune criticità comuni rispetto al lavoro delle operatrici con le donne. Un aspetto che spicca in modo prepotente è la scarsa tutela ricevuta dalle donne che decidono di denunciare, sia da parte delle Forze dell'Ordine che dei Tribunali. Non è facile per una donna arrivare alla denuncia; il percorso che porta una vittima di violenza a recarsi presso le Forze dell'Ordine è un percorso lungo, in quanto frutto di riflessioni tormentate, e anche portatore di grande sofferenza.
Spesso e troppo facilmente si chiede alle donne “perché non denunciate?”, ma chi lavora ogni giorno con le vittime di violenza assicura che arrivare alla denuncia non è per niente facile.
Spesso la donna vittima decide di denunciare soltanto dopo anni di vessazioni e di maltrattamenti, spinta dall'esasperazione o dalla paura, e dalla convinzione comune (e spesso errata) che la denuncia sia l'unica modalità per intimare al maltrattante di fermarsi.
La speranza della donna, quando va a denunciare, è che le Forze dell'ordine e gli Organi giudiziari la
tutelino, prendano in carico tutto il peso che lei stessa si porta sulle spalle, mettano in atto da subito le misure che le assicurino protezione, sollevandola finalmente dall’angoscia di dover dovere combattere in solitudine per difendere se stessa, i propri figli e i propri beni. Una donna che va a denunciare “si affida” alla giustizia, contando da quel momento in poi su protezione e aiuto, confidando di vedere finalmente riconosciuti i propri diritti per quanto riguarda, ad esempio, l'abitazione, il denaro, i figli, la sicurezza personale, e si aspetta che tutto questo avvenga in modo rapido: spesso infatti la situazione di pericolo che sta vivendo è molto evidente, molto chiara, molto facile da decifrare: i fatti sono lì e si vedono!
Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi (o almeno questa è l’esperienza della psicologa) tutto questo non avviene, oppure avviene in misura insufficiente rispetto alle aspettative pur legittime della donna.
La realtà dei fatti è che a una denuncia fatta oggi, corrisponde un tempo medio di attesa del processo pari a due anni, periodo durante il quale la donna deve “arrangiarsi da sola” per vivere in sicurezza, maturando nel frattempo la sfiducia nelle istituzioni, in particolare in quelle situazioni in cui tutte le evidenze, le testimonianze, le registrazioni, i video mostrano una realtà incontrovertibile.
Quando un processo è tardivo rispetto all’avvenuto reato, è meno efficace anche per il maltrattante, che, se bloccato invece con un provvedimento tempestivo nel momento in cui commette o reitera il reato, è costretto a prendere atto e consapevolezza delle proprie responsabilità. Un esito veloce inoltre aumentereb-
be la percezione generale di sicurezza e di fiducia nella giustizia.
Tuttavia ancora oggi, la mancanza di urgenza nel trattare i casi di violenza, e la frequente diffidenza nei confronti della donna, rendono i tempi lunghissimi.
Proprio perché la legge non contempla un unico reato di violenza, ma tanti delitti per definire la complessità dei soprusi, in ognuno dei quali sono implicate dinamiche psicologiche profonde e complesse e non sempre riconoscibili, è necessario conoscere bene il fenomeno.
A fronte di diversi tipi di violenza, quali la minaccia, la violenza psicologica, fisica, economica, sessuale e lo stalking, che configurano la violenza domestica, la normativa italiana ha adeguato il proprio ordinamento:
• sia alle prescrizioni della Convenzione di Istanbul (nata all’interno del Consiglio d’Europa nel maggio 2011, la Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, mirato alla creazione di un quadro giuridico completo per la protezione delle donne. Il documento ha definito esplicitamente per la prima volta la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, quali bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela)
• sia alla Direttiva del Parlamento europeo 2012/29/UE, attraverso l’emanazione del“Codice Rosso (L.69/19)”, sorta di “sirena rossa” che apre un canale preferenziale
Aspazio donna
alle indagini e al rafforzamento delle misure penali ed extrapenali e introduce ulteriori circostanze aggravanti, mirate a tutelare le vittime di violenza domestica e di genere e a punire gli autori di tali reati con "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive" (art. 45 della Convenzione).
In sintesi l’applicazione del Codice Rosso comporta procedimenti e scadenze che vincolano gli atti della Polizia giudiziaria e del pubblico ministero: velocità e immediatezza delle indagini sono requisiti imprescindibili al fine di limitare condotte di violenza reiterata.
In pratica, quando si denuncia un sopruso, fisico o psicologico, avvenuto nei confronti di una donna, la polizia giudiziaria è tenuta a comunicare immediatamente la notizia di reato al pubblico ministero. Questi, entro tre giorni, deve sentire direttamente la persona offesa o chi ha denunciato i fatti di reato. Così facendo, il Pm potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al giudice l’emissione di una misura cautelare, quale ad esempio l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Nonostante gli eccellenti propositi e il potenziamento di alcune misure, il Codice Rosso tuttavia presenta ancora numerose ombre. Lacune riconducibili sia “alla difficoltà probatoria”, che all’assenza di una formazione omogenea e specializzata di tutti gli operatori del diritto, dalle Forze dell’ordine agli avvocati, ai magistrati, formazione specializzata mirata ad evitare traumi secondari, disincentivazioni delle denunce, informative di reato non
efficaci, emersione di stereotipi e pregiudizi, formazione idonea soprattutto a riconoscere i casi di violenza psicologica, la più diffusa e la meno denunciata. Altra criticità, le già note tempistiche del sistema penale, non tanto per la mancata celerità dell’iter procedurale, peraltro relativo alla sola parte delle indagini, bensì per l’annoso problema degli organici sottodimensionati delle Procure, complicata dall’assenza di operatori qualificati, in grado di offrire supporto e consulenze di carattere psicologico, per valutare con minori probabilità di errori la reale gravità delle denunce. Altro nodo cruciale è quello legato all’inefficacia dei provvedimenti cautelativi: non è raro infatti che gli ordini di allontanamento emessi dal Tribunale vengano violati e non mancano i casi di uomini che, nonostante tali divieti, ricorrano poi al gesto estremo, ovvero l’omicidio dell’ex compagna, come dimostrato da numerosi casi di cronaca. Non resta che ribadire che “per una giustizia tempestiva”, se su un fronte serve la capacità delle donne di riconoscere i segni della violenza e dei rapporti malati, serve il coraggio del rispetto di sé, sull’altro servono maggiori specializzazione e sensibilità verso ogni forma di violenza, serve un cambio di passo, un’evoluzione culturale degli operatori del diritto.
Fino a quando la giustizia non metterà in campo i suoi elementi migliori, le migliori competenze, le capacità professionali e umane nel giudicare, per una donna vittima – ma anche per le altre - che ha già affrontato un percorso pieno di ostacoli, sarà un’ulteriore sconfitta, una “giustizia negata”!
Pgg. 44-45 Alternativa
GLI SPIRITI DELL’ISOLA
Regia:MartinMcDonagh
Sceneggiatura:MartinMcDonagh
Fotografia:BenDavis
Montaggio:MikkelE.G.Nielsen
Scenografia:TimDevine
Alessandro Magrì
Interpretiprincipali:ColinFarrell(PádraicSúilleabháin),BrendanGleeson(ColmDoherty), KerryCondón(SiobhánSúilleabháin)
Produzione:BlueprintPictures,Film4,MetropolitanFilmsInternational,SearchlightPictures
Distribuzioneitaliana:SearchlightPictures
Durata:114'
Origine:StatiUnitid'America,RegnoUnito,Irlanda
Datadiuscitaitaliana(Cinema):02/02/2023
Datadiuscitainstreaming(Disney+):22/03/2023

Durante i primi mesi dell’anno si concentra spesso la distribuzione dimoltitraipiùattesifilminternazionali della stagione cinematografica italiana. Il percorso della maggior parte di questi film comincia con la presentazioneinanteprimaneimaggioriFestival della stagione autunnale (Venezia e Toronto in primis, ma anche Londra, San Sebastián, Tokyo...). Fanno seguito l’uscita nel Paese d’origine e nei principali mercati mondiali per poi arrivare anchedanoi,spessoconcolpevoleritardo, appunto tra gennaio e marzo. I motivi per cui la distribuzione dei film stranieri in Italia è spesso in ritardo rispetto agli altri Paesi occidentale sono svariati, ma nel caso specifico di quelli cheesconoinquestastagione,sonosolitamente due: evitare la concorrenza del periodo natalizio dei film italiani o dei blockbuster (nome ormai fuori moda perindicareifilmdigrandebudgeteper ilgrandepubblico),eproporsiaridosso dellacerimoniadegliOscar,chesisvolge a fine marzo, nella speranza che le nomination conquistate e gli eventuali premi vinti diano slancio alla partecipazionedelpubblicoinsala.
Tra le pellicole che nel 2023 hanno seguito questa traiettoria, uno dei più attesieraGlispiritidell’isola,delregista inglese (ma di origini irlandesi) Martin McDonagh,candidatoabennovepremi Oscar tra cui miglior film e i 4 attori principali.
Il film è ambientato nel 1923 sulla fittizia, ma del tutto verosimile, isola di
Inisherin,allargodellacostaoccidentale dell’Irlanda,dovelalungaamiciziatrail violinista Colm e l'umile mandriano Pádraics'interrompebruscamentedaun giorno all'altro senza apparente motivo, a causa del rifiuto di Colm di frequentare ancora l'amico. Non c’è un motivo specifico, un casus belli, ma semplicementeiltempodellavitaèpocoeColm preferiscetrascorrerloacomporremusica e riflettere, cercando di lasciare ai posteri una traccia del suo passaggio su questa terra: la futilità delle chiacchiere alpubnonfannopiùpartedellasuavita. Padriac, scioccato e incapace di accettare il comportamento dell’amico, non si dà pace e si confronta con la sorella che passa le sue giornate a leggere sognando di abbandonare l’isola, e con Dominic,ilfigliodelpoliziottodell’isola, lo “scemo del villaggio” che si scoprirànascondereunavitadiabusi. Lasceneggiatura,scrittadalregistastesso, è perfetta nel restare in equilibrio tra commedia e dramma. Da una parte si ridedigusto,conquestiburberiirlandesi dalla battuta sempre pronta, che non fanno altro che curare i propri animali, bere birra scura e suonare il violino. Dall’altra, affidandosi di nuovo a Colin Farrell e Brendan Gleeson, i due interpreti del suo geniale film d’esordio In Bruges,McDonaghcostruisceunduello di caratteri che cresce continuamente di intensità. L’interpretazione di entrambi, a cui per comunicare spesso basta uno sguardocorrucciatooppurepersoieraticamente verso l’orizzonte, è
eccezionale. Eppure, il film è pieno di parole,spessocapacidiparlareall’oggi. Come accade quando Colm cerca di spiegare a Padraic che della bontà degli uomini gentili non rimane nulla e che quello che resta dopo di noi, quello che cirendeuominièlaforzadell’arte,sentendosi rispondere con un’ode inconsapevole al semplice piacere di condividereun’amicizia.
Nel frattempo, ai più deboli non resta che scegliere da sé il proprio destino e chipuòparte,lasciandosull’isolasuperstizioni,ignoranzaenoia.
McDonaghhalaforzadilasciareleconclusioni aperte, provvisorie, come in ognigrandestoria.
Tuttavia la forza del racconto sta nella dimensione metaforica che riesce ad evocareconpochissimitrattidecisivi.In primis, il riferimento ad una guerra fratricida.
Ma se il riferimento alla guerra civile irlandese, in corso proprio in quegli anni, è esplicitato dal regista in una scena in cui i protagosisti ascoltano i rimbombi dei cannoni che arrivano dalla costa irlandese, il legame con l’attualitàeconlaguerrainUcraina,che pure diversi critici hanno riscontrato, appareforzato.
Ma in fondo questo è il fascino dei raccontidipiccolestoriechesiprestanoad essere grandi metafore, perchè permettono allo spettatore di riflettere e di trovare infiniti riferimenti ad altre storie e ad altri pezzi della nostra esperienza passata.
A il film

Alternativa
uaunuomoèprecipitato,a 220 milioni di chilometri da casa, senza alcuna ragionevole possibilità di sopravvivere, ma grazie al suo ingegno ha lottato contro un pianeta avversocambiandoilsuodestino; socchiudendo gli occhi e amplificandoli con la fantasia, sembra di vederlo, Matt Demon, mentre cerca in tutti i modi di sopravvivere a Marte.
Tornando alla realtà, davanti non è Marte di The Martian ma il Wadi Rum, deserto della Giordania, con tutto il suo alieno splendore: le sue rosse rocce, le montagnole di pietra che sembrano disegnare profili di mostri di cui la memoria ha perso il ricordo,lesuedistesedisabbiae,nelle notti fredde, i suoi cieli stellati,

lontani dall’inquinamento luminoso,dovelaViaLatteaapparein tutto il suo splendore.
Qui, sono stati girati molti film, da Laurence d’Arabia a Stars Wars, da Prometheus ad Aladdin, solo per citare i più famosi, proprioperquestosuoesseresospeso trailnostroeun’infinitàdimondi immaginifici.
Sembra che la Giordania si diverta a portare i suoi visitatori in luoghi sospesi tra emozione e razionalità, tra questo mondo e mille altri; mi basta pensare al giorno precedente, al canalone scavato nella roccia che sembra attraversarlasinuosocomeunserpente,aquellesfumaturedirosso, accese e spente dal guizzare della luce, a quell’atteso eppure improvvisomomentoincui,nella fessura lo intravvedi e infine ti
appare davanti, in tutta la sua maestosa magnificenza: il Khazneh, ilTesoro, di Petra.
È il monumento più famoso di questo sito e di tutta la Giordania, lo si è visto un’infinità di volte, eppure, ammirarlo essendoci di fronte provoca un’ondata di emozione. Non ho mai sofferto della sindrome di Stendhal ma raramente un’opera mi ha così colpito.
Petra non è solo questo ovviamente: le pareti delle gole, le loro forme e colori, l’impegnativa camminata che porta ad Al Deir, il monastero che sovrasta gli oltre ottocento monumenti dell’intero complesso, opera che per magnificenza gareggia con il Tesoro, le Tombe reali con il loro porticato doricoepoirisalendoancora,fino a ritrovarsi sopra il Tesoro, guar-
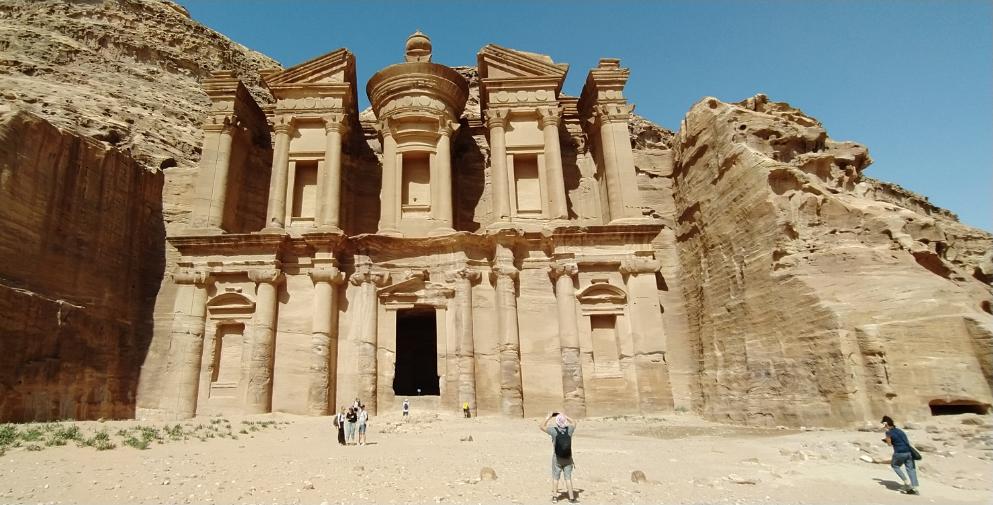
A il viaggio
VIAGGIO IN GIORDANIA Q
Alvi Torrielli
dandolo dall’alto. Se è vero che le visite a Petra e Wadi Rum giustificherebbero da sole un viaggio in Giordania, è altrettanto vero che c’è molto più da vedere in questo meraviglioso paese.

La città romana di Jerash, non a caso definita la Pompei dell’Oriente, con i suoi magnifici resti, la Piazza ovale, circondata da colonne che continuano nella Strada colonnata, il tempio di Artemide, il teatro, testimonianze del massimo splendore, sotto Roma, di una città che esiste da oltre 6500 anni!
I castelli di cui la Giordania è disseminata, da quelli nel deserto a quelli diAjlun e Kerak, i mosaici di Madaba, purtroppo in parte deturpati dalla furia iconoclasta, i monumenti di Amman, antica-
mentePhiladelphia,perproseguire per altri siti archeologici che raccontano di quanto importante è stata da sempre questa parte di mondo.
Ma non c’è solo storia: basti pensare ai magnifici paesaggi attraversati dalla Via dei Re che da Amman arriva a Petra; vallate immense, un continuo saliscendi (altra caratterista di questo paese) che portano sul Monte Nebo da dove si ammira la Terra promessa, dalla terrazza omonima, fino a giungere al Mar Rosso con le sue barriere coralline, i suoi pesci multicolore e, a poche decine di metri dalla riva, i resti di carri armati ed aerei della Seconda guerra mondiale.
E poi il Mar Morto, con le sue acque dove si galleggia senza alcunproblema,doveconcrezioni
saline hanno preso possesso di ogni parte, ivi comprese le travi dei moli, e dove non è inusuale vedere fiocchi di sale, del tutto simili a quelli di neve, sospesi nell’acqua… e una cucina meravigliosa, e un popolo gentilissimo, estremamente accogliente…
In fondo la Giordania è una terra di mezzo, circondata da grandi tensioni, la Siria a Nord, l’Iraq ad est, Israele a Ovest e l’Arabia Saudita a Sud, una terra capace di ritagliarsi una sua identità, aperta al mondo ma anche fedele alle sue tradizioni, lo sguardo al futuro dei tanti che parlano più di una lingua e un mondo antico di pastori che vivono nelle tende, isolati in spazi duri e vuoti… Ma non siamo tutti noi, terre di mezzo?
Pgg. 48-49 Alternativa
LORENZONI FRANCO, “EDUCARE CONTROVENTO. STORIE DI MAESTRE E MAESTRI RIBELLI”
Alyosha Matella.
Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli è l’opera con cui Franco Lorenzoni (docente di scuola primaria in pensione, formatore e autore di numerosi libri) conclude la trilogia inaugurata nel 2014 con “I bambini pensano in grande. Cronaca di un’avventura pedagogica” e poi proseguita con “I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento”.
Tre passi di un cammino entusiasmante e faticoso lungo i sentieriricchi di scoperte, di complessità e di interrogativi- della ricerca educativa, del rapporto tra adulti e minori, della relazione tra scuola e mondo fuori dall’aula,contuttelesuepotenzialità e i suoi rischi.
Se nei primi due volumi l’autore nel restituire le sue avventure pedagogiche pone le bambine e i bambini al centro della narrazione, in “Educare controvento” i protagonisti del libro sono i maestri e le maestre che Lorenzoni ha incontrato nel corso della sua esperienza umana e di educatore e verso cui nutre quel senso di riconoscenza che- sempre secondo il maestro di Giove- è intimamente legato alla conoscenza e alla ricerca. Si tratta di figure molto diverse tra loro, accomunate dalla volontà di dare respiro e gambe a un’educazione capace di riconoscere, affermare e garantire il pieno sviluppo della dignità, della libertà e delle potenzialità di ciascun bambino e bambina. Ognuna di queste personalità viene presentata intrecciando la sua traiettoria con alcune riflessioni di Lorenzoni stesso rispetto ai grandi temi della scuola e della formazione.
Il tema del valore della scuola come strumento principe per la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona (finalità costituzionale inserita nell’articolo 3 della Carta) si incontra così con il percorso umano del costituente Piero Calamandrei che, di ritorno dagli orrori della Prima Guerra Mondiale, dedicò un intenso libro alle osservazioni e alle riflessioni scaturite dal rapporto con il suo primogenito Franco nei suoi primi anni di vita.
Un’esperienza che non può essere scissa dall’attenzione e dalla profondità d’analisi con cui Calamandrei si impegnò nel secondo dopoguerra nel tentativo di gettare le basi per una scuola democratica .
I pensieri intorno alla storia, al tempo e alla memoria sono invece largamente debitori dell’incontro dell’autore con Nora Giacobini, la professoressa che portò nelle scuole medie delle periferie romane la ricchezza dei molteplici linguaggi artistici ed espressivi e che vide nella ricerca storica una battaglia per dare voce agli sconfitti e ai subalterni.
I temi, così attuali e così stringenti, della convivenza tra diversi (sia nella scuola che nella società), della universalità dei diritti e della cura del pianeta conducono chi legge alla (ri) scoperta dell'eredità di Alexander Langer (pensatore e leader ecopacifista altoatesino) e dell’importanza dell’impegno condotto in parti molto distanti del pianeta da due giovani donne, Greta Thunberg e Malala Yousazfai, che con la loro ribellione necessaria hanno molto da insegnare a noi adulti.
E ancora: Emma Castelnuovo, che ha dimostrato come l’apprendimento della matematica e della geometria sia non una procedura arida e avvilente ma un processo ininterrotto di scoperta, liberazione delle intelligenze, creatività; Don Milani e Mario Lodi, così diversi tra loro ed entrambi così appassionatamente impegnati a dare parola a tutti per rendere tutti uguali e liberi; Alessandra Ginzburg, la pedagoga e psicoanalista che si batté per la chiusura delle “classi speciali” e l’inserimento dei bambini con disabilità nella scuola pubblica. Argomenti, riflessioni, storie di vita che rappresentano tracce e suggerimenti per navigare controvento, nel continuo tentativo, individuale e collettivo, di essere adulti ed educatori all’altezza delle domande, dei bisogni e dei pensieri che le bambine e i bambini ci pongono ed esprimono e del loro diritto a costruire e abitare una scuola e un mondo giusti, belli e arricchenti.
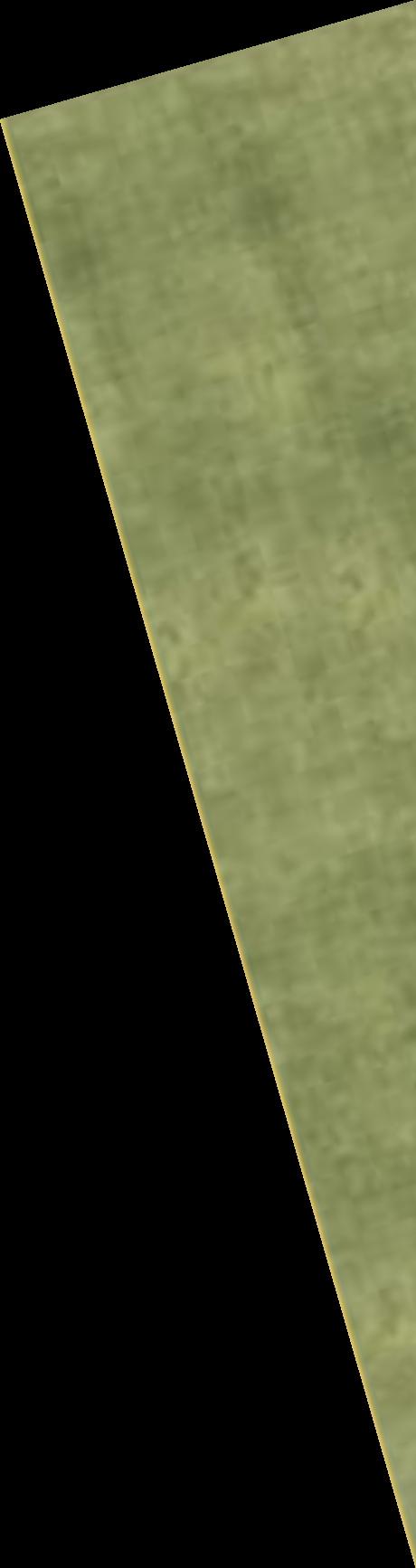
Ainvito alla lettura
LIB RO IL LIB RO
Autrice: Franco Lorenzoni
Titolo: Educare controvento
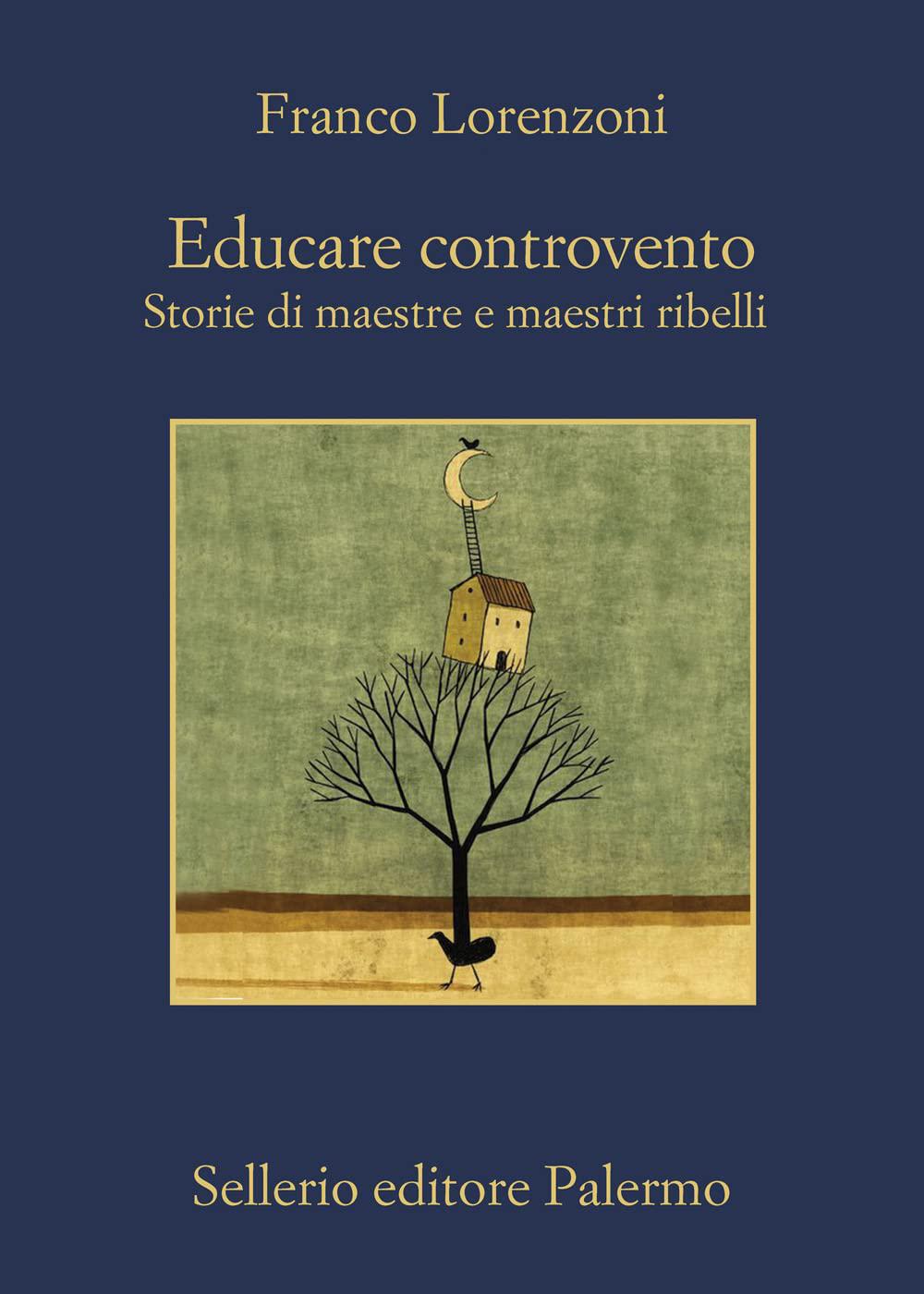
Storie di maestre e maestri ribelli
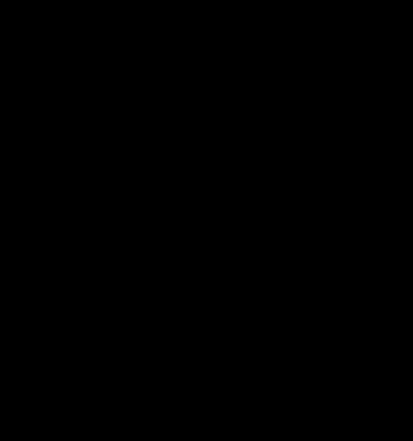

Editore: Sellerio editore Palermo
Anno edizione: 2023
Pagine: 256
Pgg. 50-51
Alternativa
ELOGIO DEL VOCABOLARIO
Comunicazione, comunanza, comunità: le parole del“cum”
Roberto Negroni
GLI APPUN TI DI PADRE MCKE NZIE
n tempo, nelle case, il vocabolario era sempre a portata di mano. Grande e grosso se ne stava accomodato in bella vista sul ripiano più accessibile della libreria o su un angolo della scrivaniase libreria o scrivania nella casa c’erano - oppure sul ripiano della credenza, su una mensola, su una scansia, o in cucina accanto al libro delle ricette, sul tavolino dove si facevano i compiti; ma sempre lì, pronto, disponibile e amichevole con piccoli e grandi, per chi impegnato in compiti e studi domestici, ma anche per placare gli angosciosidilemmicheassalgonoi più quando prendono in mano una penna: “daccordo o d’accordo?”, “qui o quì?”, “io sto bene o io stò bene?”, “qual’è o qual è?”,“coscienza o coscenza?”.
Quando poi giungeva l’amaro appuntamento con il compito in classe di italiano, con il malfamato Tema, le giovani speranze di famiglia si caricavano in groppa o abbracciavano stretto al petto (questione di genere) il pesante tomo, unico argine all’agguato degli strafalcioni che la letale matita rossa e blu avrebbe inesorabilmente falciato.
Un tempo… Poi sono arrivati il computer, il laptop, il tablet,
lo smartphone, siamo transitati dall’analogico al digitale e ora, per dubbi grammaticali, ortografici e sintattici, per sinonimiecontrari,bastaaprireGoogleeinpochisecondiil problema è risolto; con gran risparmio di tutto quel tempo a sfogliare pagine alla ricerca di quella benedetta parola che erasemprequalchepaginapiù avanti o qualche pagina indietro. È stato l’avvento di una nuova era. Per il povero vocabolario è iniziato il mesto tempo dei traslochi: sloggiato dalpostoalsolesucuitroneggiava da decenni, è scivolato verso sempre più dimesse periferie, fino alla tumulazione in uno dei cimiteri domestici in cui riposano le tante obsolescenze della modernità.
Però, diciamolo francamente, il cambio non è alla pari; l’essenzialità delle poche righedispiegazionediGoogle o dei suoi concorrenti sfigura di fronte all’opulenza descrittiva di qualsiasi vocabolario orgogliosamente cartaceo. Torna comodo, a questo proposito, l’esempio del sostantivo che con frequenza ricorre in questo numero della rivista che state leggendo: “comunicazione”. Il Vocabolario della Lingua Italiana Treccani gli dedica quasi due lunghe colonne di una delle
sue dense pagine (Vol. I,A-C, p. 868), che la versione libera on line riproduce fedelmente, masitrattadiun’eccezione.In tutti gli altri casi che Google propone, appare evidente che tra un cartaceo e l’offerta liberaonlinenonc’èpartita;anzi, se si cerca un’ennesima conferma della sostanziale differenza che intercorre tra il mondo della tradizione cartacea e quello della rete: eccola, scodellata bella calda.
Questa semplice verifica permette però di cogliere anche un’altra importante differenza; ed è questa che più interessa porre qui in evidenza. La sequenza alfabetica della disposizione delle voci lessicali del vocabolario, che laricercaonlinenormalmente non mostra perché si limita a estrapolare quanto richiesto, permette di osservare le comunanze e le parentele tra diversi vocaboli aventi radice o etimo comuni.
Scopriamocosìcheilsostantivo “comunicazione” se ne sta in compagnia di più di trenta voci lessicali, spalmate su almenoquattrofittepaginedel Treccani, che condividono le prime due sillabe (co-mu), dalle quali traspare la radice della preposizione latina cum, la nostra con, e la diretta discendenza da termini latini come l’aggettivo communis e
“Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear” (Padre McKenzie scrive le parole di un sermone che nessuno ascolterà)
“Eleanor Rugby”, Lennon-McCartney, 1966
U
i sostantivi communio, communitas e communicatio. Eccoallora,traglialtri, comunanza, comune, comunicare, comunicato, comunicazione, comunione, comunismo, comunità, comunitario.Terminituttichiaramente di medesima derivazione latina (si, anche comunismo, sebbene passato per l’originario francese communisme).
Però, noi, scrupolosi osservanti della sapienziale esortazione del vernacolare milanese “ofelè fa el to mesté”, ben comprensibile (nonché applicabile) anche nelle nostre ridenti contrade,
fermiamoci qui, non addentriamoci in terreni che implicano competenze che nonsipossiedonoelasciamoailinguisti fare il loro mestiere per ogni ulteriore considerazione in proposito. Limitiamoci, però, a rilevare un aspetto che può apparire forse marginale, ma che marginale non è, quello che potremmo definire il comune denominatore semantico di quelle trenta e più voci: il riferimento a situazioni, azioni e condizioni tutte riconducibili a una natura relazionale, implicanti vicinanza, condivisione, socialità, comune appartenenza.
Chiamiamole, per intenderci, le “parole del cum”: del fare con, dello stare con, del parlare con, del vivere con, dello spartire con; insomma, del vivere insieme; le parole della consapevolezza dell’importanza della dimensione sociale dell’esistenza, che, insieme ad altre parole poco prima o poco dopo allocate, come collaborare condividere confidare cooperare, testimoniano, mediante la ricchezza e l’articolazione linguistica, la rilevanza per la vita di un popolo del concetto sovrastante(nonsottostante,comeverrebbe da dire) queste parole.
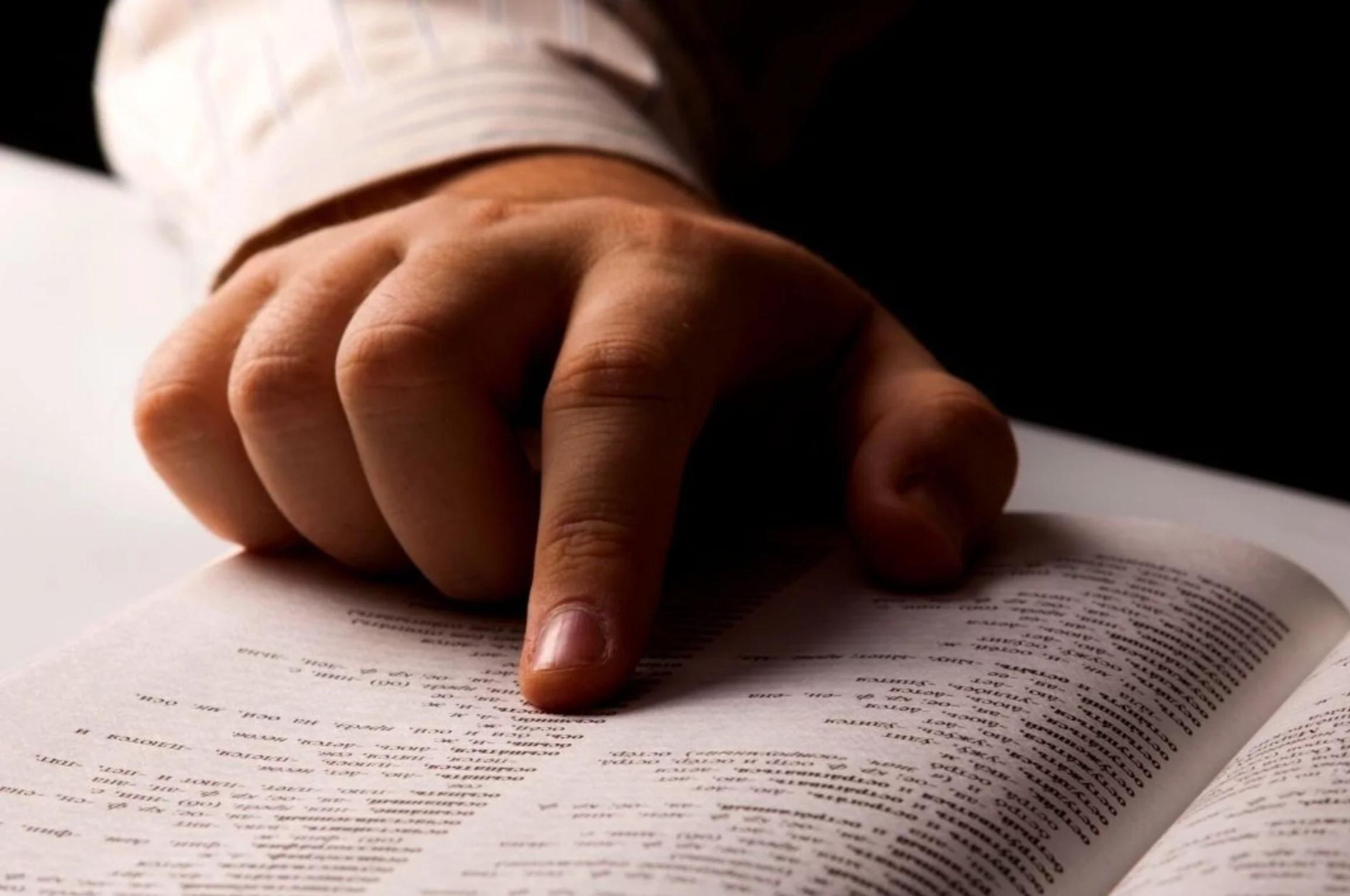
Pgg. 52-53
ABiTo veste Dry Tech
Velocità Antisismicità Efficienza Energetica
Costie tempi certi Sostenibilità ambientale Nessun limite compositivo
INostri Servizi
NUOVE COSTRUZIONI SU MISURA
RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI
EDIFICI MODULARI

Via Cesare Battisti, 31 13876 Sandigliano (BI) Tel. 015 099 16 42 info@abito.casa www.abito.casa



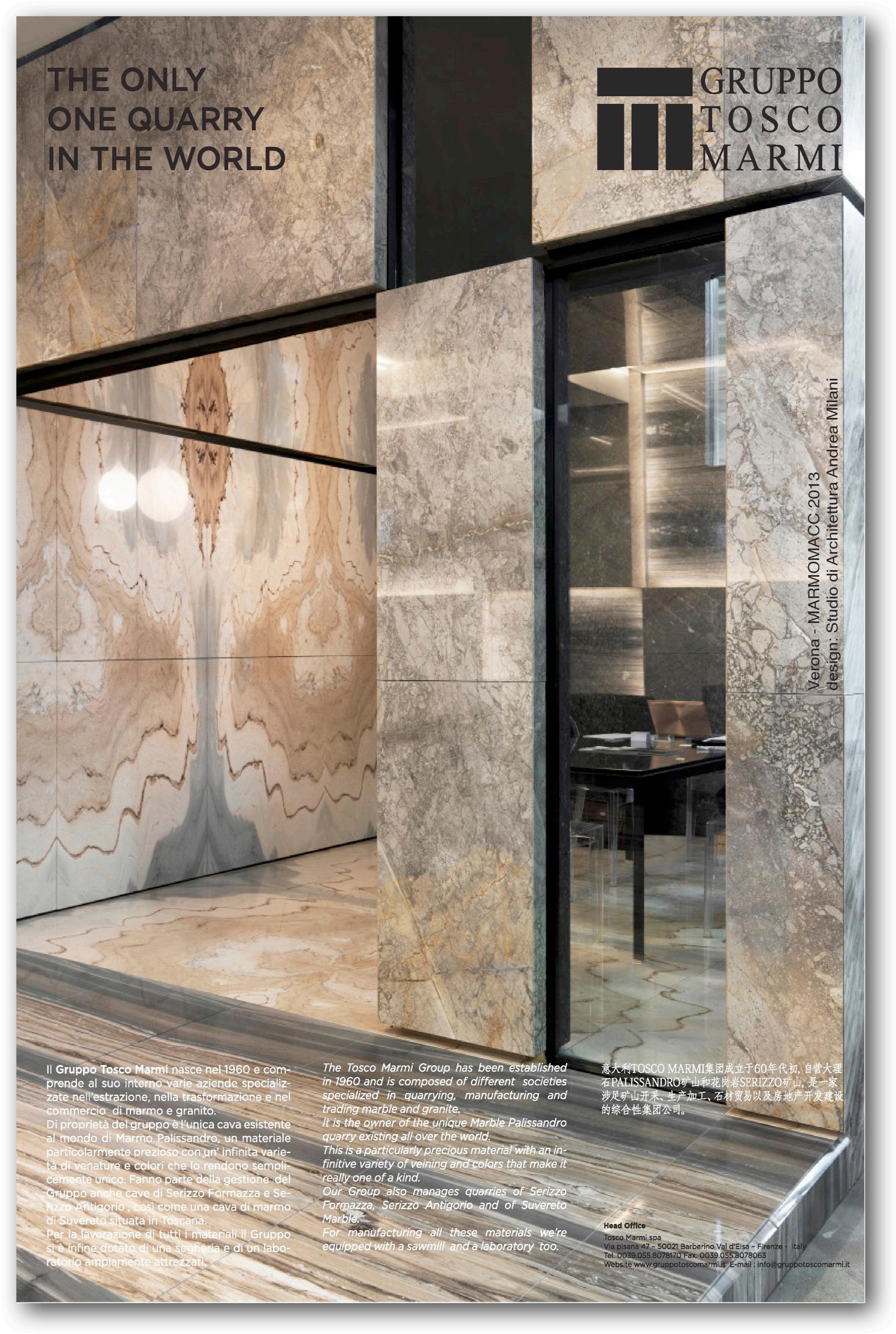
Pgg. 54-55 Alternativa


SCOPRI LA GAMMA ELETTRICA www.borgoagnello.it/elettrico Lo stesso DAILY di sempre. Semplicemente elettrico. SPECIAL CAR Off. autorizzata IVECO e FIAT Professional SPECIAL CAR 0324 45029 info@specialcargroup.it Viale dell’artigianato, 10 - 28845 Domodossola