

NUOVE BUONE PRATICHE
Povertà educativa e comunità educanti, gli apprendimenti delle Comunità di Pratiche promosse dal Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile
A cura di MATTIA SCHIEPPATI
In collaborazione con l’impresa sociale CON I BAMBINI
NUOVE BUONE PRATICHE
Povertà educativa e comunità educanti, gli apprendimenti delle Comunità di Pratiche promosse dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
A cura di MATTIA SCHIEPPATI
In collaborazione con l’impresa sociale CON I BAMBINI
Premessa
Queste pagine ci raccontano un’opera corale di “coinvolgimento riflessivo” da parte di comunità fatte di centinaia di persone impegnate nel lavoro di educare nelle troppe aree difficili d’Italia. Durante un incontro, un’esperta con molti anni di competente dedizione me ne ha riportato il senso così: “La ricchezza di queste comunità di pratiche sta nel fatto che esistano spazi e tempi riconosciuti dove, territorio per territorio, i professionisti che lavorano a vario titolo con bambini, ragazzi e famiglie, possono fermarsi a riflettere, confrontandosi con continuità su ciò che fanno, come lo fanno e come stanno”.
Riflettere sul proprio operare con responsabilità e cura della condivisione rappresenta un miracolo italiano, in forte contro-tendenza con una cultura riflessiva spesso povera o inesistente. È un miracolo che, per ampiezza e diffusione, non ha molti analoghi. Avviene, infatti, entro il cantiere educativo, molto grande e complesso, reso possibile grazie al Fondo di contrasto della povertà educativa minorile e attuato dall’impresa sociale Con i Bambini, che ha finora assegnato, con 21 bandi ed iniziative, 425 milioni per dar vita a 600 reti locali o nazionali con il coinvolgimento di 9.095 organizzazioni e almeno mezzo milione di minori e le loro famiglie.
Il riflettere entro una scena operativa così grande è un valore in sé. Ma acquista valore ancora maggiore per il paesaggio allarmante entro il quale avviene. Siamo una nazione ricca ma che conosce una crisi demografica strutturale terribile. Ci permettiamo di aver triplicato, negli ultimi 3 lustri, il numero di minori in povertà assoluta e raddoppiato quelli in povertà relativa lasciando almeno 2,5 milioni su 9,3 di nostri bambini e ragazzi in una situazione lontana dai loro diritti e dalle loro potenzialità di sviluppo, minando, così, le fondamenta di ogni sviluppo sostenibile. E la scandalosa assenza di un’agenda di priorità politica su questo fronte decisivo per i nostri destini - che, purtroppo, attraversa ogni appartenenza e schieramento – si perpetua nel tempo mentre, intanto, esplode, in mille e mille episodi di sofferenza, la crisi dei modelli educativi, lungamente creatasi con la progressiva eclissi di un’antropologia educativa condivisa.
È in questo paesaggio che l’azione del Fondo rappresenta il più grande cantiere riparativo che abbiamo, che desta un sentimento di orgoglio. E l’accompagnamento sapiente portato avanti dalle comunità di pratiche che qui documentiamo riunisce molti temi e pensieri che scaturiscono dal lavoro vivo di tale cantiere e ne indagano e mostrano sfide, promesse, dubbi, speranze, competenze. Sono pensieri che
potranno estendersi e approfondirsi perché sono generati e raccolti grazie a procedure accorte, proprie dei processi di accompagnamento che permettono alle avventure e alle organizzazioni umane di apprendere, di imparare facendo e di fare imparando.
L’esperienza delle comunità di pratiche sta, dunque, creando una tradizione, promettente e preziosa, che si fa strada grazie a persone che s’incontrano con metodo, combinando teoria e azione, per lavorare meglio insieme, cosa davvero indispensabile per produrre cambiamenti.
Marco Rossi-Doria Presidente di Con i Bambini
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
In Italia quasi 1 milione e 400 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni sono in povertà relativa. La crisi economica ha inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e ragazzi.
La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori.
Un’alleanza per contrastare questo fenomeno è stata messa in campo da Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, Terzo settore e Governo: a fine aprile 2016 è stato siglato un Protocollo d’Intesa per la gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.
Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro. La Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021,
mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria, che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede, quindi, un contributo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro l’anno. Il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 ha poi disposto un’ulteriore proroga per il 2022 e il 2023. La legge di bilancio 2022 (legge del 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso ulteriormente la durata del Fondo fino al 2024. Complessivamente, il Fondo ha un valore complessivo attuale di 800 milioni di euro.
L’operatività del Fondo è stata assegnata dall’Acri all’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud.
L’impresa sociale Con i Bambini, costituita il 15 giugno 2016, attraverso bandi e iniziative, ha selezionato complessivamente oltre 800 progetti in tutta Italia, tra cui oltre 40 idee progettuali legate alle iniziative in cofinanziamento con altri enti erogatori.
Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l’elemento della valutazione di impatto. I progetti approvati coinvolgono oltre mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie. Attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, Enti pubblici e privati, rafforzando le “comunità educanti” dei territori.
INDICE
CAPITOLO 1.
Un modello di intelligenza condivisa per nuove policy sociali
→ Le comunità di pratiche avviate da Con i Bambini pag. 14
→ Un passo indietro. Di che cosa stiamo parlando? pag. 17
→ Il metodo di lavoro pag. 19
→ La voce dal campo: Giovanna Maciariello pag. 25
Sintesi e temi delle tre annualità di progetto
→ Anno 2020/2021 pag. 32
→ Anno 2021/2022 pag. 37
→ Anno 2023 pag. 39
Indagine sulla percezione dei partecipanti pag. 43
CAPITOLO 2.
Le comunità di pratiche, in pratica. I 5 temi focus
→ 1. L’aggancio dei minori e delle famiglie pag. 54
→ La voce dal campo: Fedele Salvatore pag. 68
→ 2. La partecipazione dei minori e delle famiglie pag. 75
→ La voce dal campo: Claudia Silvestri pag. 85
→ 3. Il ruolo dell’educatore pag. 89
→ La voce dal campo: Marco Battaglia pag. 96
→ 4. I patti educativi di comunità pag. 102
→ La voce dal campo: Daniela Cattivelli pag. 114
→ 5. Il benessere psicologico degli adolescenti pag. 120
CAPITOLO 3.
Le sfide future e la voce degli stakeholder
→ Una consapevolezza costruita sul campo pag. 128
→ Le sfide aperte pag. 129
→ La voce degli stakeholder: Barbara Trupiano pag. 132
→ La voce degli stakeholder: Tamara Novati pag. 136


Un modello di intelligenza condivisa per nuove policy sociali
Le comunità di pratiche avviate da Con i Bambini
In anni nei quali ogni riflessione sul futuro pare essere incentrata sugli straordinari e dirompenti orizzonti aperti dalle tecnologie dell’intelligenza artificiale, qui siamo di fronte a un modello di futuro - reale, vivo ed estremamente umano - pensato da un’intelligenza condivisa. Luoghi e momenti nei quali a guidare i percorsi e i pensieri non è l’algoritmo ma è l’esperienza, unita alla professionalità e alla passione, di centinaia di persone che all’interno delle proprie realtà territoriali si impegnano ogni giorno per piantare un seme di speranza nel campo sconfinato del contrasto della povertà educativa minorile.
E dove, anziché stanze piene di server e software di deep learning, la dinamica vincente e produttiva è antica quanto l’uomo: incontrarsi, sedersi in una stanza, e dialogare. Mettere a confronto approcci e vissuti, esplicitare attese ma anche errori e sconfitte, guardare all’altro e ai suoi percorsi non come a un “concorrente” per l’assegnazione di un bando, ma come fosse un setaccio attraverso il quale vagliare le proprie convinzioni e modalità di soluzione dei problemi. Condividere quello che, “in pratica”, ogni giorno ci si trova di fronte percorrendo i tanti e complessi sentieri della sfida educativa.
La parola chiave sta lì: la pratica. Ovvero il fare, l’essere in cammino, il mettersi alla prova concretamente, immergersi
nella realtà - con le proprie idee e i propri modelli - e poi riportarli in superficie affinché diventino esperibili anche da altri. Affinché si trasformino in un patrimonio comune, e non solo: affinché attraverso il confronto delle pratiche si progredisca, insieme, verso il miglioramento di tutti. Aggiustando giorno dopo giorno il tiro, mettendo a punto le proprie convinzioni e abitudini, senza giudizi o pre-giudizi.
È provando a mettere a sistema tutti questi ingredienti e questo approccio complessivo alla riflessione sulle progettualità in atto, che nel 2020 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ha promosso il percorso delle comunità di pratiche avviate da Con i Bambini: spazi di confronto tra gli oltre 700 progetti selezionati in tutta Italia da Con i Bambini e sostenuti grazie al Fondo, con l’obiettivo di creare sinergie tra professionisti e organizzazioni operanti sullo stesso territorio o ambito tematico e far emergere modelli e buone pratiche riproponibili anche nelle policy pubbliche.
Nelle intenzioni dell’iniziativa, decisamente innovativaper l’Italia e non solo - all’interno del panorama del non profit e dello sviluppo delle progettualità a scopo sociale, Con i Bambini si è posta la finalità di far emergere dalle iniziative finanziate modelli e buone pratiche riproponibili non solo nelle proprie azioni future, ma anche nelle policy degli
amministratori pubblici. Al contempo, rafforzare la conoscenza reciproca entro la vasta comunità di chi in Italia lavora nell’ambito educativo e dell’accompagnamento dell’infanzia, creando le migliori condizioni per nuove alleanze tra pubblico e privato sociale. Le “buone pratiche”, insomma, come primo passo di future “buone politiche”, capaci di far nascere e consolidare cantieri di sviluppo educativo locale.
«Fin dall’avvio abbiamo considerato le comuinità di pratiche un’occasione, un’opportunità significativa per le organizzazioni e i professionisti che noi sosteniamo attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per generare spazi di dialogo, per dare corso a un confronto orizzontale, spontaneo, autentico, realmente dal basso, senza obblighi o condizionamenti», spiega Simona Rotondi, Vice coordinatrice Bandi e iniziative di Con i Bambini, che ha seguito fin dall’ideazione i percorsi delle comunità di pratiche. «Ci siamo resi conto che era importante definire dei luoghi, dei momenti dedicati per poter riflettere e far riflettere, ragionare insieme, mettere in circolo opinioni e pareri sulle pratiche educative, sulle attività che ciascuna realtà stava mettendo in campo nel suo territorio. Una condivisione libera da giudizi e valutazioni, orientata a migliorare la pratica di ciascuno e ad aprire nuove finestre di pensiero, mettere in comune la ricchezza di idee e soluzioni che naturalmente
emergono quando ci si impegna a riflettere e a trasmettere le proprie esperienze sul campo».
Con l’iniziativa delle comunità di pratiche, fin dal principio Con i Bambini si è posta tre obiettivi di lungo termine:
• promuovere la messa in rete tra soggetti che lavorano su uno stesso territorio o sugli stessi ambiti operativi favorendo il confronto e l’attivazione di collaborazioni e interventi integrati;
• attivare e animare spazi, fisici e virtuali, di cooperazione, riflessione e approfondimento in cui sperimentare processi di apprendimento basati sulla pratica delle azioni finanziate;
• far emergere dalle iniziative finanziate un repertorio condiviso di modelli di successo frutto di saperi e pratiche distintive, su specifici temi e azioni di intervento, riproponibili anche nelle future azioni di Con i Bambini nonché nelle policy degli amministratori pubblici.
Un passo indietro. Di che cosa stiamo parlando?
Il concetto di “comunità di pratiche”, elaborato nell’ultimo decennio del ’900 nell’ambito della ricerca sociologica nord-americana, ha trovato una sua sistemazione negli studi del ricercatore svizzero Etienne Wenger.
Riducendo il concetto ai minimi termini, le comunità di pratiche, secondo lo studioso, sono dei gruppi che si
costituiscono per trovare comuni risposte a problemi inerenti l’esercizio del proprio lavoro. Esse sono caratterizzate dall’essere spontanee, dal poter generare apprendimento organizzativo e dal favorire processi di identificazione.
I membri della comunità di pratiche condividono modalità di azione e di interpretazione della realtà
I membri di una comunità di pratiche condividono modalità di azione e di interpretazione della realtà, costituiscono nel loro insieme una organizzazione informale all’interno di organizzazioni formali più ampie, articolate e complesse. I partecipanti alle attività delle comunità di pratiche, col loro apporto, accrescono il senso d’identità professionale e creano una rete che può indurre reali processi di rinnovamento. Le comunità di pratiche sono infatti una significativa ed efficace risorsa di aggiornamento delle competenze professionali.
Le comunità di pratiche possono insomma essere definite come dei “sistemi sociali di apprendimento” (la definizione è sempre di Wenger) in cui il contributo del singolo diventa parte del patrimonio della comunità. Si fondano su pratiche di lavoro condivise e distintive basate sul coinvolgimento attivo dei partecipanti all’interno di una iniziativa sociale che, se funziona, innesca un processo di apprendimento virtuoso.
Il metodo di lavoro
Il passaggio dalla teoria alla pratica concreta, come sempre accade, ha richiesto uno sforzo di razionalizzazione e una dinamica organizzativa che fosse al contempo ben definita e flessibile. Anche perché, da subito, l’intenzione è stata quella di avviare il percorso già con un orizzonte esteso a tutto il territorio nazionale, e quindi affrontando le tante e diverse particolarità che ogni territorio esprime.
Operativamente, le comunità di pratiche si sono costituite per gruppi di lavoro suddivisi secondo una logica di prossimità territoriale in tre macro-aree, Nord, Centro, Sud e Isole (in totale, nel primo triennio, 39 gruppi di lavoro nel Nord, 9 nel Centro e 13 nel Sud e Isole). Ai momenti di incontro sono stati invitati a partecipare prevalentemente i coordinatori di progetto, di tutti i progetti finanziati nei diversi bandi via via attivati nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nelle comunità di pratiche sono state coinvolte, inizialmente, le organizzazioni capofila che partecipano ai bandi, e si sono poi allargate anno dopo anno anche ad altri soggetti che potessero essere utili ad arricchire il confronto (professionisti dal mondo della scuola, delle Istituzioni e Amministrazioni locali, di ambito sanitario...).
L’attivazione e l’animazione delle comunità di pratiche è stata affidata a tre facilitatori/facilitatrici esperti/e,
selezionati/e tramite call ad evidenza pubblica, uno/a per ciascuna delle tre macro-aree territoriali.
Ciascun gruppo di lavoro si è ritrovato, per incontri della durata di circa tre ore, ogni 3/4 mesi, creando via via un’assiduità a questo tipo di condivisione e confronto che ha reso progressivamente più efficaci e produttivi gli incontri.
Da rilevare come, proprio nelle settimane di avvio del progetto (inizio 2020), il sopravvenire dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha costretto a una revisione profonda del setting originariamente immaginato per gli incontri (pensati come incontri dal vivo), e ha costretto per il primo anno e mezzo di attività a utilizzare la modalità dell’incontro online, passando poi - una volta terminate le limitazioni sanitarie - a una modalità mista: una parte di incontri hanno continuato e continuano a svolgersi online, una parte dal vivo, a seconda dei calendari e delle tematiche via via definiti dalle facilitatrici insieme a Con i Bambini e agli stessi partecipanti.
«Nelle prime fasi degli incontri», racconta Simona Rotondi, «è stato dedicato un tempo discretamente significativo alla spiegazione di che cosa sono e all’interno di quali cornici si inseriscono le comunità di pratiche. Si tratta infatti di una “entità” abbastanza nuova e innovativa per il contesto
del non profit italiano, e quindi era fondamentale tracciarne un perimetro che fosse chiaro a tutti. Abbiamo cercato di radicare il concetto che le comunità di pratiche sono una componente importante di un programma più grande, nazionale, sperimentale, qual è quello promosso e sostenuto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È importante che ciascuna delle centinaia di organizzazioni e migliaia di professionisti che operano negli oltre 700 progetti che il Fondo sostiene si sentano parte di un “tutto” più grande, come i pezzi di un puzzle. E quindi il loro contributo fatto di esperienza diretta, di idee, di soluzioni concrete, non vale solo per la loro organizzazione, per il loro progetto, per la comunità territoriale nella quale operano, ma è un patrimonio che deve essere valorizzato all’interno di questa cornice più grande».
Complessivamente, il setting degli incontri è stato sviluppato per garantire il maggior coinvolgimento e la più ampia interazione possibile, superando la percezione di distanza imposta dalla modalità online.
Ciascun facilitatore ha guidato l’attivazione del gruppo e la riflessione già nella fase propedeutica ai tavoli, invitando i partecipanti a riflettere, attraverso una scheda, sui problemi, le strategie, le prassi, i risultati e i nuovi bisogni emersi durante la realizzazione del progetto finanziato dal Fondo.
Durante l’incontro in plenaria le riflessioni di ciascuno sono state poi condivise confluendo in una scheda riassuntiva del lavoro dell’intero gruppo.
Negli incontri successivi la partecipazione di ciascun partecipante è stata stimolata attraverso l’utilizzo di immagini, casi di studio ed esercizi di gruppo che hanno favorito l’ascolto attivo e aumentato l’efficacia dei tavoli di lavoro.
Al termine di ciascun incontro i facilitatori hanno elaborato un report finale con le risultanze e gli aspetti emersi, trasmettendolo al gruppo dei partecipanti e a Con i Bambini.
«Le comunità di pratiche avviate da Con i Bambini sono un percorso avviato in una cornice coerente con la “natura sperimentale” che caratterizza le iniziative promosse dal Fondo. È stato ed è un work in progress che presuppone un continuo aggiustamento e miglioramento delle metodologie di coinvolgimento, delle dinamiche di gestione degli incontri, di raffinamento dei follow-up», spiega Simona Rotondi.
«Quando si crea un meccanismo di confronto, un sistema per cui persone di territori diversi che non si conoscono ma fanno cose simili si mettono intorno a un tavolo, si incontrano ogni tre mesi, ripetutamente per tre anni, e solleciti loro degli stimoli, fai in modo che ognuno lo possa liberamente, senza sovrastrutture, senza pregiudizi, parlare e raccontare di quello che sta facendo, delle fatiche, delle cose che
È un percorso avviato in una cornice coerente con la natura sperimentale delle iniziative promosse dal Fondo
funzionano, delle cose che non stanno funzionando... generi una grande ricchezza. Riteniamo che quel che emerge da ogni singolo incontro, e in generale dal percorso che si sta sviluppando, sia un patrimonio eccezionale per la crescita professionale dei singoli partecipanti, e per la crescita delle loro organizzazioni. Ma è uno strumento fondamentale anche per Con i Bambini. Queste occasioni di ascolto sono importante per capire e comprendere se le progettualità previste dai bandi e le specifiche pratiche che vengono attuate abbiano poi una reale un’efficacia, se e quanto siano funzionali al raggiungimento di obiettivi che le nostre attività, i nostri interventi, le nostre iniziative si pongono, se hanno degli impatti reali e duraturi nei diversi contesti territoriali, ovvero se migliorano la qualità della vita dei minori e delle loro famiglie, che sono i destinatari diretti di tutti gli interventi che il Fondo sostiene».
Uno strumento informale e non istituzionalizzato di riscontro “dal basso”, non mediato, che si affianca ai monitoraggi tecnici che, in quanto soggetto attuatore del Fondo, Con i Bambini ha l’obbligo di condurre rispetto a ogni progettualità
sostenuta. «La ricchezza il patrimonio esperenziale di questi operatori è enorme e spesso non emerge in maniera così viva e immediata dai monitoraggi dei progetti, mentre negli incontri delle comunità di pratiche si esprime in tutta la sua forza e bellezza», conclude Rotondi.
Le comunità di pratiche sono pensate come strumenti capaci di innescare soluzioni win-win-win: sono utili per l’arricchimento delle competenze e delle professionalità delle organizzazioni non profit, sono utili a Con i Bambini per orientare i bandi e le progettualità, e sono infine utili per i destinatari, perché contribuiscono a definire modelli di approccio e di attuazione più efficaci.

LA VOCE DAL CAMPO
Giovanna Maciariello
«Le comunità di pratiche? Sono spazi sicuri in cui si apprende per osmosi»
Giovanna Maciariello, sociologa, è la facilitatrice delle comunità di pratiche di Con i Bambini per la macro-area del Sud e delle Isole. Un percorso che l’ha vista coinvolta fin dall’origine, e ha rappresentato, nel suo essere esperienza in itinere, un’importante sfida professionale.
Giovanna, provando a riassumere il vissuto di questi tre anni, al di là delle definizioni accademiche e teoriche, che cosa sono le comunità di pratiche?
Le comunità di pratiche sono dei luoghi di accoglienza, di scambio, di non giudizio, di confronto e di condivisione tra tutti coloro che partecipano a una progettualità. Sono uno spazio neutro all’interno del quale i partecipanti vengono facilitati dalla guida non giudicante di una facilitatrice a confrontarsi su alcuni temi trasversali che riguardano gli specifici bandi di cui sono protagonisti. Sono sostanzialmente delle occasioni attraverso le quali le persone possono riflettere insieme, esprimersi, parlare, contesti nei quali
anche esprimere il proprio dissenso diventa accettabile perché sono spazi “sicuri”, di scambio tra pari, tra persone che nel loro operare sognano gli stessi grandi obiettivi e vivono spesso le stesse, amare difficoltà.
Qual è il metodo per far funzionare bene questi “spazi sicuri”, per fare in modo che siano davvero generativi per chi vi partecipa?
L’avvio delle comunità di pratiche in un certo senso è la fase più complessa, perché si tratta di costruire una comunità tra persone che spesso non si conoscono, e fare in modo che in questa comunità si crei un’atmosfera di dialogo e di collaborazione. Il nostro sforzo come facilitatrici è individuare un setting che possa stimolare una partecipazione sia personale sia professionale. Questo significa operare su diversi livelli, dalla dimensione affettiva dei partecipanti a quella socio-relazionale, fino alla dimensione più cognitiva-razionale. In questi percorsi abbiamo ritenuto che la dimensione personale, effettiva, emotiva sia parte integrante della professionalità delle persone che intervengono nelle comunità di pratiche, ed è per questo che l’avvio del confronto guarda sempre a una dimensione emotiva. Basta una domanda semplice, “come stai oggi?”, “come sta andando il progetto?”, “come ti senti tu come persona all’interno del progetto?”, per aprire questa dimensione e avviare il dialogo
rompendo gli schemi della comunicazione verticale, o frontale, e favorendo il protagonismo dei partecipanti.
Quali sono le dinamiche che scattano durante gli incontri?
Quando si riesce a rompere il muro iniziale della relazione frontale, e si instaura una vera comunicazione circolare, devo dire che le tre ore dell’incontro trascorrono velocissime, grazie alla qualità personale e professionale molto alta delle persone che vi partecipano. Io lo ribadisco in ogni occasione: se non avessimo avuto delle persone così competenti, non avremmo potuto far vivere i percorsi delle comunità di pratiche per tutto questo tempo. Agli incontri partecipano persone molto in gamba che dicono cose belle, importanti, anche dolorose - perché vi assicuro che in certi momenti i racconti sono duri, tragici - ma qui trovano lo spazio e l’occasione giusta per essere condivise. Chi porta vissuti anche negativi sa di poterlo fare, e lo fa con fiducia, perché sa di essere con persone che condividono e comprendono questo tipo di situazioni. Scatta quasi un “effetto normalizzatore” delle difficoltà. Questo è molto importante, perché significa che tu, come operatore, ti senti ascoltato, compreso, ti senti meno sbagliato rispetto a quello che stai facendo. Non sei solo.
Quanti incontri sono necessari per ogni tema?
In genere lavoriamo su tre, quattro incontri per tema, a seconda dei temi. All’inizio eravamo più rigidi, pretendevamo di aver già tutto stabilito a priori, tempi, temi, composizione dei gruppi. Poi abbiamo via via applicato una maggiore flessibilità, perché abbiamo capito che bisognava saper cogliere quello che emergeva incontro dopo incontro e rimodulare il percorso per essere il più possibile aderenti alle necessità. Anche ricomponendo i gruppi, coinvolgendo soggetti esterni - il direttore dell’Usma, il dirigente scolastico, il dirigente delle politiche sociali del Comune... - che portano sempre un valore aggiunto importante, emergono le possibili sinergie ma anche le distanze tra i diversi mondi.
Qual è il follow-up degli incontri? Che cosa a chi vi partecipa?
Dopo ogni incontro noi facilitatrici compiliamo un report che sintetizza gli elementi emersi, e lo condividiamo con i partecipanti in modalità editabile, in modo che ciascuno possa intervenire e specificare quel che ritiene utile. Questo documento rimane quindi a Con i Bambini, e rimane a chi ha partecipato, come traccia di riflessione e di lavoro. Un elemento che comincia a emergere anche nelle misurazioni che Con i Bambini fa sui risultati dei progetti, è che le comunità di pratiche - se pur attraverso una
formula di apprendimento informale, direi quasi per osmosi - hanno accresciuto la capacità di gestire le progettualità. È come se la partecipazione agli incontri e il confronto con le esperienze degli altri alimentasse in ogni partecipante un background di idee e soluzioni che poi riemergono nella pratica quotidiana.
Che cosa generano le comunità di pratiche al di là e oltre i momenti istituzionali di incontro dei gruppi?
Dall’incontro e dal confronto che nasce all’interno delle comunità di pratiche si creano relazioni tra le persone, tra i professionisti delle diverse organizzazioni, che hanno degli sviluppi utili, di aiuto e collaborazione, quando poi si opera sul territorio. La sensazione che ho maturato in questi anni è che più occasioni di incontro e confronto si creano, più ci sono possibilità di far riflettere le persone sui cambiamenti progressivi possibili, sia nelle relazioni al proprio interno, sia nelle politiche di programmazione. Un tema che emerge spesso dai partecipanti è quello legato all’advocacy. Il pensiero, in sintesi, è: “Come facciamo noi che abbiamo un’esperienza radicata sui territori, che vediamo che alcune cose non funzionano e forse sapremmo come farle andare meglio, a incidere sul cambiamento di sistema?”. C’è la consapevolezza che Con i Bambini sia un interlocutore che può fare da tramite con altri soggetti
istituzionali. Provando a fare una sintesi di questi tre anni, possiamo dire che l’esperienza delle comunità di pratiche ha fatto crescere le persone che vi hanno partecipato e ha fatto crescere anche Con i Bambini come soggetto di riferimento per queste persone e per le loro organizzazioni.
Sintesi e temi delle tre annualità di progetto
ANNO DI ATTIVITÀ 2020/2021
Gli incontri sono stati avviati nel mese di novembre 2020, adottando la modalità a distanza nel rispetto delle restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19. Sono stati invitati prevalentemente i coordinatori di progetto, di tutti i progetti finanziati a valere sui primi tre bandi. Complessivamente, sono stati svolti 35 incontri, coinvolgendo 16 comunità di pratiche (o “gruppi”), così distribuite:
Ciascun gruppo è stato coinvolto in due incontri, a distanza di circa due mesi l’uno dall’altro, per ciascuno dei due temi, individuati da Con i Bambini come adeguati all’avvio delle attività: le sfide educative ai tempi del Covid-19; le reti nelle prassi progettuali. Con le comunità di pratiche dei progetti multi-regionali è stato affrontato solo il primo dei due temi.
BANDO N. INCONTRI N. PRESENZE N. GRUPPI
Le sfide educative ai tempi del Covid-19
Il tema è stato affrontato dai facilitatori in modo da far emergere tanto le difficoltà incontrate dopo lo scoppio della pandemia, quanto le risposte messe in campo dai partenariati per perseguire i propri obiettivi educativi in un contesto emergenziale o fortemente mutato rispetto a quello risalente alla fase di progettazione degli interventi. Di seguito la sintesi delle risultanze relative ai diversi bandi.
Bando Prima infanzia 2016. La pandemia ha accentuato l’importanza di prendere in carico l’intero nucleo familiare dei minori, portando a rendere domiciliari alcune attività di progetto e a curare maggiormente la relazione empatica con genitori e minori. Inoltre, ha allargato al Terzo settore le competenze di ideazione e produzione di dispositivi educativi digitali, prima solo commercializzati da grandi aziende.
Bando Adolescenza 2016. La didattica a distanza, se attuata senza accompagnamento, ha accentuato i divari (sia di accesso, sia di efficacia) e il rischio di abbandono scolastico. Si individua nella collaborazione tra attori della comunità educante (soprattutto scuola e Terzo settore), formalizzata nei patti educativi, un correttivo importante sia per la didattica a distanza, sia, più in generale, per la presa in carico collettiva dei percorsi educativi.
BandoNuovegenerazioni2017. È emersa l’importanza della disponibilità di spazi all’aperto e alternativi agli spazi classici dell’educazione e di un uso consapevole e strutturato dell’outdoor education. È urgente inoltre il confronto tra i diversi bisogni educativi (e le conseguenti metodologie operative) delle aree interne del paese e delle aree metropolitane, anche in ottica di integrazione tra servizi educativi e servizi socio-sanitari.
I referenti dei progetti multi-regionali che hanno partecipato agli incontri testimoniano una maggiore complessità di gestione dei progetti, ma anche una maggiore consapevolezza, ai fini della definizione di politiche per l’infanzia, del valore delle sperimentazioni attivate. Tra le risultanze emerse, si segnalano, in particolare: l’importanza delle azioni di prossimità; la scarsa integrazione tra politiche educative e politiche di contrasto delle povertà; la rigidità della scuola, che dovrebbe essere l’istituzione con il ruolo di presidio di normalità e cura, all’interno dei progetti finanziati.
Le reti nelle prassi progettuali
Dopo un’analisi degli stakeholder attraverso un caso di studio costruito sulla base degli elementi raccolti a livello nazionale durante il primo incontro, gli incontri si sono focalizzati su tre filoni: la differenza tra il momento della progettazione
e quello dell’attuazione, il rapporto tra pubblico e privato, la valorizzazione delle competenze nelle reti. Di seguito la sintesi delle risultanze relative ai diversi bandi.
Bando Prima infanzia 2016. È emersa la difficoltà di ampliare la rete degli attori della comunità educante al di fuori del partenariato. Il senso della rete per gli interventi a favore della prima infanzia risiede nella co-progettazione di risposte ai bisogni del territorio. In questo senso, cruciale è l’engagement del personale sanitario che offre i servizi di base, che spesso sono un’interfaccia forte per le famiglie, uscendo dalla logica che vede al centro solo la scuola.
Bando Adolescenza 2016. Si è sperimentata in diversi progetti l’educativa di strada come modello di intervento a bassa soglia, riuscendo a coinvolgere molti più stakeholder. Emerge inoltre la necessità di lavorare anche sulla presa di consapevolezza del ruolo educativo di molti attori territoriali; importanti passi avanti si stanno facendo ad esempio presso le società sportive.
Bando Nuove generazioni 2017. In un’ottica di rete è risultato fondamentale coinvolgere anche la parte politica e amministrativa dei territori, in ottica di continuità, oltre che i portatori di interessi economici, come le associazioni
di categoria. Nella formazione degli operatori dovrebbe essere dedicato più spazio alle competenze di costruzione di reti locali, così da assumere un ruolo affine a quello dei community manager.
Complessivamente, nel primo anno di sperimentazione delle comunità di pratiche si è scelto di adottare una prospettiva di ascolto e di privilegiare temi che consentissero l’avvio della messa in rete tra le organizzazioni finanziate, senza indicare dall’alto degli output precisi per gli incontri e il percorso delle comunità di pratiche. Sono emerse, tuttavia, alcune sollecitazioni importanti che, oltre a incoraggiare la prosecuzione della sperimentazione, potrebbero orientare il lavoro futuro delle comunità di pratiche e la programmazione di alcune iniziative di Con i Bambini. Nello specifico, si segnalano le seguenti sollecitazioni:
• potenziare la messa in rete di attori educativi attraverso dispositivi specifici, quali ad esempio: patti educativi; l’allocazione di risorse alla costruzione di comunità di pratiche interne ai partenariati (misura introdotta in via sperimentale nel bando sulle comunità educanti); azioni di sistema per formare alla messa in rete e alla co-progettazione;
• introdurre nella programmazione dei prossimi bandi la messa a punto di prototipi di progetto a partire da
esperienze esistenti che sono risultate efficaci e finanziarne la realizzazione su territori circoscritti; • elaborare un documento condiviso di strumenti e strategie efficaci di contrasto della povertà educativa, anche in collaborazione con la comunità scientifica, svolgendo azioni di advocacy presso le Istituzioni pubbliche.
ANNO DI ATTIVITÀ 2021/2022
L’attività di valorizzazione delle comunità di pratiche è proseguita nel 2021 e nel 2022 si è estesa a progetti finanziati a valere sui bandi Un passo avanti 2018, Cambio rotta 2019, Ricucire i sogni 2019, Iniziative in cofinanziamento (edizioni 2017, 2019 e 2021) e a nuovi temi in ambito socio-educativo. Gli incontri hanno adottato nel primo semestre 2022 la modalità a distanza nel rispetto delle restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, introducendo dal mese di settembre anche la modalità in presenza, presso la sede di Con i Bambini o presso spazi delle fondazioni di origine bancaria o di enti di Terzo settore. Complessivamente sono stati svolti, nell’anno considerato, 69 incontri, coinvolgendo 432 partecipanti e attivando 33 comunità di pratiche (o “gruppi”).
Nel 2022 è stato deciso, a seguito di riflessioni raccolte dal monitoraggio dei progetti e da quanto emerso nel corso degli incontri svolti, di dare spazio a nuove tematiche: i patti educativi di comunità (in continuità con il precedente lavoro sulle reti), il disagio psichico degli adolescenti, il coinvolgimento delle famiglie, la partecipazione di bambini e adolescenti, la figura dell’educatore, il rapporto tra scuola e terzo settore. I gruppi con i quali sono stati avviati gli incontri nel 2022 (es. progetti dei bandi Un passo avanti, Cambio rotta e Ricucire i sogni) hanno trattato anche il
nel corso della prima annualità delle comunità di pratiche, si era rivelato utile ai partecipanti a familiarizzare con questa modalità operativa. Nel caso dei progetti localizzati in Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria, dove la conduzione delle comunità di pratiche è condivisa tra Con i Bambini e Compagnia di San Paolo, si sono invece definiti dei temi specifici per alcuni incontri (es. il rapporto con scuola, carcere, ospedale).
ANNO DI ATTIVITÀ 2023
L’attività delle comunità di pratiche nel 2023 si è concentrata in modo particolare sui progetti finanziati a valere sui bandi tematici, quali Cambio rotta 2019, Ricucire i sogni 2019, Comincio da zero 2020, A braccia aperte 2019 e il bando per le comunità educanti. Sono stati inoltre conclusi gli ultimi incontri dedicati alle comunità di pratiche dei bandi Adolescenza 2016, Nuove Generazioni 2017 e Un passo avanti 2018. Complessivamente nel 2023 sono stati svolti 57 incontri, con 628 presenze, e sono state attivate 55 comunità di pratiche (o “gruppi”).
Anche nel 2023 è stato valorizzato lo scambio e il confronto tra realtà e organizzazioni che operano nella stessa regione o in regioni contigue, per favorire soprattutto una conoscenza reciproca e generare potenziali forme di collaborazione tra le stesse.
Quadro presenze e incontri terza annualità (2023)
Sei incontri hanno riguardato esclusivamente le iniziative a valenza multiregionale (A braccia aperte 2019, Un passo avanti 2018), i restanti 51 incontri hanno coinvolto prevalentemente i progetti regionali, alcuni dei quali prevedendo nello stesso setting anche quelli multi-regionali (è il caso dei bandi Comincio da zero 2020, Cambio rotta 2019, Ricucire i sogni 2019).
Rispetto alla tipologia dei partecipanti, 27 incontri hanno coinvolto figure di coordinamento (responsabili di progetto),
mentre in 30 incontri sono state invitate a partecipare le professionalità più operative e specialistiche (educatori, insegnanti, assistenti sociali, dirigenti scolastici, psicologi).
È proseguita, anche questo anno, la collaborazione con Compagnia di San Paolo, con cui sono state condivise modalità organizzative, temi e riflessioni emerse, per i progetti localizzati in Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. È stata avviata, per la prima volta, anche una collaborazione con Fondazione Cariplo, per i progetti localizzati nella Regione Lombardia, concretizzatasi in una calendarizzazione condivisa degli incontri, una condivisione delle tematiche e una partecipazione ai gruppi di lavoro.
Nel 2023, essendo ancora attivi i gruppi relativi ai bandi già coinvolti nel triennio precedente (Adolescenza 2016, Nuove Generazioni 2017, Un passo avanti 2018), sono state trattate tematiche già affrontate, quali la figura dell’educatore, la partecipazione dei minori e delle famiglie, i patti educativi, le reti, proponendo un approfondimento ulteriore e declinazioni operative sul campo.
Nuova è stata invece la trattazione di un tema molto ampio e complesso, quale quello dell’innovazione sociale, che ha suscitato molto interesse soprattutto nei partecipanti coinvolti nel bando Un passo avanti 2018.
Le organizzazioni finanziate a valere sui bandi “mirati” (per tema e target) hanno affrontato tematiche quali: l’équipe multidisciplinare, la collaborazione con i servizi territoriali, le pratiche
e gli strumenti per la prevenzione del maltrattamento, i modelli di presa in carico.
Si segnalano due incontri peculiari, con i rappresentanti dei progetti del bando Un passo avanti 2018 e Cambio rotta 2019, frutto di riflessioni e richieste espresse dagli stessi partecipanti, rispetto a questioni specifiche che i progetti finanziati ritengono centrale per il buon esito delle loro iniziative: il rapporto con le Istituzioni (scuola, carcere, ospedale) e il ruolo degli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM).
Indagine sulla percezione dei partecipanti
In linea con le prassi di gestione delle attività di Con i Bambini, anche il percorso delle comunità di pratiche è stato sottoposto a una misurazione qualitativa. Nel mese di ottobre 2023, infatti, ai partecipanti delle comunità di pratiche coinvolti negli incontri del triennio precedente è stato somministrato un questionario pensato per raccogliere opinioni e percezioni sull’esperienza e sull’utilità e l’impatto del percorso rispetto al loro lavoro.
Sono stati 188 i professionisti che hanno risposto al questionario, restituendo un panel interessante di sensibilità rispetto ai punti di forza e alle fragilità del progetto.
Rispetto al ruolo svolto nel progetto finanziato dal Fondo, la maggior parte dei casi vede i responsabili di progetto le persone più attive e disponibili alla partecipazione agli incontri.
TAB. 1 - Ruolo svolto nel progetto
È stato chiesto ai rispondenti di valutare il loro livello di partecipazione agli incontri: il 61,7% ha una positiva percezione lo considera abbastanza elevato.
TAB. 2 - Come valuti, ad oggi, il tuo livello di partecipazione agli incontri di comunità di pratiche?
Rispetto alla qualità degli incontri, nel loro complesso, emerge una elevata soddisfazione (84% la ritiene “molto elevata”).
TAB. 3 - Come valuti, ad oggi, la qualità degli incontri di comunità di pratiche?
Una domanda specifica era dedicata al tipo di apprendimenti che le comunità di pratiche hanno generato nel lavoro quotidiano dei partecipanti:
TAB. 4 - Che tipo di apprendimenti hanno generato le comunità di pratiche nel tuo lavoro quotidiano?
Incremento di competenze tecniche/ professionali
Elevato
Capacità di risoluzione di problemi
Capacità di avere un pensiero divergente/ creativo
Possibilità di confronto con altri professionisti/ scambio di opinioni
Possibilità di riflessione e consapevolezza sul proprio lavoro
Miglioramento dei processi organizzativi all’interno del proprio ente
L’82,4% dei partecipanti riconosce nella possibilità di confronto con altri professionisti/scambio di opinioni il vantaggio maggiormente acquisito grazie ai percorsi di comunità di pratiche (molto elevato l’apprendimento percepito), insieme alla opportunità di riflettere consapevolmente sul proprio lavoro (78,7%). Positiva anche la ricaduta rispetto ai processi organizzativi interni al proprio ente (abbastanza elevato l’apprendimento per il 65,4% dei partecipanti) e il potenziamento
di competenze tecniche e di acquisire un pensiero divergente (abbastanza elevato in entrambi i casi per il 67%).
I temi che hanno suscitato maggiore interesse sono stati quelli relativi alle reti (30,8%), alla figura dell’educatore (18,7%), ai patti educativi (11,1%) e al modello di presa in carico (9,6%).
TAB. 5 - Qual è il tema, tra quelli affrontati nelle varie annualità, che ha suscitato maggiormente il tuo interesse?
TEMI CHE HANNO SUSCITATO MAGGIORE INTERESSE V.A.
Rispetto ai temi che i partecipanti vorrebbero trattare in futuro, emerge fortemente quello relativo alla continuità e sostenibilità degli interventi, in quanto connessa con le possibilità concrete di garantire un proseguo delle attività al termine dei progetti. Il 42,5% lo considera un tema di grande rilevanza. Un altro tema considerato importante è quello dell’aggancio dei bambini e ragazzi e delle famiglie (9,6%), della partecipazione
(9%), e anche della co-progettazione pubblico- privato (12,8), che con l’adozione del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) ha assunto un ruolo fondamentale nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo settore, per la realizzazione di servizi e interventi.
TAB. 6 – Su quale di questi temi vorresti confrontarti in futuro negli incontri di comunità di pratiche?
CHE VORREBBERO TRATTARE IN FUTURO V.A.
i
Il livello di soddisfazione generale verso le comunità di pratiche è connesso anche al fatto che la maggior parte degli intervistati (80%) ritiene di non avere aspetti che vorrebbero migliorare di tale iniziativa. Una piccola percentuale (9,6%) vede nell’organizzazione e logistica gli aspetti potenzialmente migliorabili, la composizione dei gruppi e di contenuti (5,3%) mentre minima è l’esigenza di revisione delle metodologie di intervento e conduzione delle facilitatrici (2,1%).
TEMI
TAB. 7 - Quali sono gli aspetti che vorresti migliorare/cambiare dei percorsi di comunità di pratiche?
È stato, infine, chiesto ai rispondenti se apprezzano maggiormente gli incontri che coinvolgono professionisti della stessa regione o di altre regioni. La maggior parte (50,6%) non esprime una preferenza, ritenendo entrambe le modalità di scambio e di lavoro proficue. Il 35,6% tuttavia apprezzerebbe soprattutto l’incontro con altre regioni.
TAB. 8 - Apprezzi maggiormente gli incontri che coinvolgono professionisti della tua stessa regione o di altre regioni?


→ CAPITOLO 2 Le comunità di pratiche, in pratica.
I 5 temi
focus
I 5 TEMI FOCUS
Nei quasi 170 incontri avvenuti tra i gruppi delle comunità di pratiche tra Nord, Centro, Sud Italia e Isole, sono decine gli argomenti che hanno accompagnato i confronti e le discussioni.
Lasciando però decantare la densità dei momenti di incontro, e leggendo in controluce i report che dopo ogni momento di confronto hanno consentito di riflettere sulle evidenze emerse, si possono individuare alcuni temi “core” che hanno percorso in maniera trasversale i diversi incontri, e che costituiscono dei nuclei di pensiero trasversali anche a tutti i bandi e progetti che costituiscono la galassia di aree di impegno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Al di là degli aspetti numerici e contenutistici di sintesi, che abbiamo raccolto nel precedente capitolo, abbiamo voluto approfondire 5 di questi nuclei tematici trasversali, provando ad aggregare - se pur in maniera ancora necessariamente sintetica - le opinioni e le casistiche emerse, per restituire una fotografia il più possibile ampia, viva e aggiornata dei “pensieri condivisi” emersi dai diversi gruppi.
I 5 temi messi sotto la lente sono: l’aggancio, la partecipazione, la figura e il ruolo dell’educatore, una riattualizzazione dei patti educativi di comunità in funzione del rafforzamento delle comunità educanti e, come ultimo tema ancora “in nuce” rispetto alle progettualità in via di attuazione da parte di Con i Bambini, il tema del benessere e della salute mentale di bambini e adolescenti, tema emergente (e per alcuni versi già emergenziale), rispetto al quale non vi sono ancora percorsi di progetto consolidati ma rispetto al quale il Terzo settore si sta profondamente interrogando.
Negli approfondimenti tematici delle pagine che seguono, oltre all’intervista “dal campo” di alcune/i referenti di Enti impegnati nelle progettualità che chiude ogni sezione, riportiamo all’interno del testo, in carattere corsivo, alcune delle frasi più significative emerse dai partecipanti durante gli incontri delle comunità di pratiche. Delle piccole “sintesi di pensiero” che possono dar vita a ulteriori approfondimenti.
1 DALLA PROSSIMITÀ ALL’INCONTRO:
L’AGGANCIO DEI MINORI
E DELLE FAMIGLIE
Nell’ambito delle progettualità di carattere sociale, quando si parla di “aggancio” dei destinatari si fa riferimento agli strumenti attraverso i quali si prevede di intercettare i destinatari diretti degli interventi. Nello specifico, l’aggancio ha un’ulteriore declinazione nel lavoro con gli adolescenti, specie in considerazione della loro richiesta di protagonismo, da non disattendere per garantire un efficace contrasto della dispersione scolastica.
Il tema dell’aggancio di bambini e ragazzi e delle loro famiglie costituisce un’importante riflessione trasversale a tutti i bandi, sentita in modo particolare dai partecipanti coinvolti nei progetti dei bandi Un passo avanti 2018, Cambio rotta 2019, Ricucire i sogni 2019, A braccia aperte 2019, Comincio da zero 2020. È naturale, quindi, che questo tema sia stato affrontato in quasi tutti gli incontri dei gruppi delle comunità di pratiche, essendo preliminare e imprescindibile e garantendo di fatto un lavoro di qualità con i minori e con le famiglie.
Le dinamiche dell’aggancio sono fortemente connesse a
quelle della partecipazione, perché di fatto è il presupposto imprescindibile per facilitare i processi di protagonismo attivo dei beneficiari.
Per i progetti finanziati, la fase dell’aggancio pone questioni rilevanti al partenariato e ai professionisti coinvolti e spesso diviene un momento in cui la strategia inizialmente prevista in fase di progettazione viene messa in discussione, attivando un processo maieutico di rivisitazione e rielaborazione delle attività. Difatti, quando negli interventi l’aggancio non ha funzionato o si è attivato in maniera poco adeguata, le organizzazioni e i professionisti coinvolti si sono sempre interrogati su come ricalibrare le attività, rivedendo modalità, tempistiche, strategie e strumenti.
Molte sono ancora le questioni aperte, così come le difficoltà da parte degli operatori nel riuscire a dialogare con il pubblico e con gli interlocutori istituzionali, tuttavia emerge una chiara e forte consapevolezza e l’intenzionalità di potenziare questa fase.
Dall’ascolto al protagonismo
La riflessione sull’aggancio parte dall’importante distinzione tra le strategie attivate per gli adolescenti e per i bambini, che passa spesso attraverso l’aggancio delle famiglie. Sia con adolescenti, sia con le famiglie le leve che vengono individuate come fondamentali in ogni strategia sono
L’ascolto e l’interesse sono la leva che permette all’adolescente di continuare a costruire
quelle dell’ascolto e del protagonismo. Per quanto riguarda gli adolescenti, i partecipanti alle comunità di pratiche riconoscono che ragazzi e ragazze richiedono ai professionisti e agli adulti di riferimento una attitudine professionale di lentezza e presenza che garantisca loro la possibilità di ritrovare un tempo di pensiero sulla propria vita, avendo a fianco un adulto capace di sospendere, aspettare, tollerare l’incertezza lasciandogli un margine di autonomia e responsabilizzazione.
Il primo passo è sempre mosso dalla figura educativa verso gli adolescenti, per dimostrare interesse e fiducia nei loro confronti. L’ascolto e l’interesse sono la leva che permette all’adolescente di resistere alla tendenza di distruggere ciò che riesce a costruire, soprattutto quando ciò che si è costruito è una relazione educativa nelle sue prime fasi di sviluppo.
«Mi sento nel ruolo dell’educatore nei momenti dedicati ai ragazzi, in quel tempo tutto nostro dove noi educatori abbassiamo le aspettative su di noi, non dobbiamo portare a casa nulla ma semplicemente stare con i ragazzi, ascoltare, fare in modo che loro stessi generino quello che vogliono».
Per il consolidamento della relazione educativa e del cambiamento rispetto alle situazioni di fragilità, entra in gioco la leva del protagonismo, che parte dall’emersione della voglia inespressa di cambiamento e passa per il riconoscimento degli sprazzi di motivazione, offrendo ai ragazzi e alle ragazze opportunità possibili in cui mettere in campo le proprie capacità. «Dobbiamo lavorare sull’emersione dei talenti e sul ripristino del legame di fiducia tra minori e adulti come chiave dell’aggancio» .
Con i giovani adolescenti diventa quindi importante attivare percorsi in cui essi possano sentirsi protagonisti e co-progettare le attività, ad esempio organizzare e far vivere una web radio o impegnarsi per l’autogestione degli spazi rigenerati.
Per intervenire in modo efficace vanno predisposti diversi contesti di aggancio e accompagnamento anche esterni alla scuola, stimolando ad esempio l’outdoor education ed attività sportive aggreganti. I gruppi delle comunità di pratiche hanno riconosciuto nell’educativa di strada lo strumento e il veicolo per eccellenza per iniziative di aggancio informale, insieme alla valorizzazione di attività di peer tutoring e mentoring.
Per quanto riguarda l’aggancio delle famiglie, la riflessione dei gruppi ha posto questioni leggermente differenti.
Emerge un quadro in cui le famiglie sono fragili e sole, con difficoltà di accesso ai servizi, e l’assenza frequente di una cultura dell’infanzia. I genitori hanno paura di non essere all’altezza, temono la critica sociale, esprimono un frequente senso di inadeguatezza. Occorre fortemente valorizzare momenti informali e non formali, al fine di acquisire la fiducia e condividere insieme un percorso, che spesso li mette in discussione a livello di competenze genitoriali. «È importante comunicare e coinvolgere le famiglie anche con attività di carattere informale e attivandole come protagonisti e non come oggetto dell’intervento».
L’emersione del bisogno e la richiesta di aiuto è spesso legata alla consapevolezza del bisogno stesso e al riconoscimento dell’utilità dell’intervento. Con i genitori è necessario quindi prevedere un tempo utile per farsi conoscere e accettare, superando diffidenze e timori: per evitare un senso di intrusione può essere utile essere presentati e legittimati da figure autorevoli già conosciute.
Molti considerano poco efficace operare in contesti formali, in quanto l’evento formale non crea continuità e coinvolge i genitori meno in difficoltà.
I bisogni emergenti delle famiglie sono in prevalenza: sostegno e accompagnamento alla genitorialità, difficoltà
per le donne di affidarsi, difficoltà a declinare in maniera diversa il proprio ruolo rispetto alla famiglia, per le madri “liberare tempo” per poter lavorare o svolgere attività in qualità di donne e non di madri, per i padri ritagliarsi un ruolo di vicinanza ai propri figli nella primissima infanzia.
Emerge, nella riflessione sull’aggancio, anche il tema dei genitori giovani: spesso sono disorientati rispetto al proprio ruolo e vivono in tali condizioni di marginalità economica (molti sono disoccupati) e sociale da non poter dedicare tempo ed attenzione alla crescita di bambini e bambine. I partecipanti agli incontri hanno auspicato anche una maggiore collaborazione e condivisione tra famiglie, affinché i bisogni di ciascuno vengano visti come i bisogni di tutti e quindi possano essere vissuti senza vergogna e come naturali.
Si assiste oggi a una forte attenzione da parte dei genitori ai bisogni primari dei propri figli (ha mangiato, ha dormito?...) ma non agli stimoli educativi (come ha giocato?). Spesso, però, l’attenzione ai bisogni primari si esplicita in una eccessiva preoccupazione per lo stato di salute del bambino, che genera una iper-protezione da parte degli adulti. Ciò è legato anche al fatto che i bambini nell’ultimo triennio, a causa della pandemia da Covid-19, sono stati molto a casa e cresciuti tra gli adulti, a volte sono stati poco stimolati
e presentano rallentamenti i nello sviluppo motorio e del linguaggio. Occorre quindi stabilire un legame di fiducia nei confronti dei servizi offerti: c’è bisogno di servizi extra familiari e di un’offerta flessibile che incoraggi le famiglie a iscrivere i bambini a sperimentare la loro autonomia.
È importante coinvolgere i genitori nei percorsi educativi dei bambini rendendoli protagonisti attivi e far sperimentare ai genitori un graduale fiducia nei confronti degli operatori che permetta di affidargli i propri figli. «Dobbiamo rafforzare le competenze genitoriali senza avere atteggiamento valutativo».
Chi aggancia? La sinergia tra servizi
La riflessione maturata durante gli incontri ha affrontato anche il tema del coordinamento tra gli attori che potrebbero essere coinvolti nella fase di aggancio. Professionalità chiave sono i referenti dei Comuni (assessori e dirigenti), i servizi sociali, gli insegnanti della scuola primaria, i professionisti del sistema sanitario che assistono bambini e famiglie.
Molti dei progetti sostenuti dai bandi coinvolti dall’attività delle comunità di pratiche, soprattutto quelli caratterizzati da target specifici e problematiche complesse, esprimono l’esigenza di connettere il tema dell’aggancio dei minori alla relazione e collaborazione con i servizi sociali
territoriali. Ciò si spiega anche con il fatto che laddove il beneficiario è legato a una decisione di carattere giuridico che lo riguarda (in particolare per Cambio rotta 2019, A braccia aperte 2019 e in alcuni casi Ricucire i sogni 2019) il Terzo settore per poter intervenire necessita inevitabilmente di una legittimazione da parte delle Istituzioni pubbliche.
Nel caso specifico delle iniziative che coinvolgono minori coinvolti in procedimenti amministrativi (bando Cambio rotta 2019), i professionisti che hanno partecipato agli incontri restituiscono un quadro piuttosto eterogeneo tra le varie regioni di Italia, con una prevalente criticità nell’interazione pubblico-privato al Nord rispetto al Sud.
«Assistiamo spesso a una discordanza di tempo: il tempo che necessita una persona in relazione ai propri bisogni, per la propria crescita educativa e personale, e il tempo delle istituzioni, spesso molto più lento. L’operatore si ritrova nella maggior parte dei casi nel mezzo, a dover fare da ponte tra l’uno e l’altro».
Rispetto al contesto scolastico, esso in prevalenza risulta distante e lontano dai ragazzi presi in carico. Molti partecipanti lamentano una diffusa difficoltà nel coinvolgimento delle scuole all’interno delle attività progettuali. La scuola non viene considerata un luogo del tutto collaborativo,
spesso è autoreferenziale e “chiusa” rispetto all’esterno. «Le scuole spesso non “usano” i progetti offerti dalle associazioni come opportunità per offrire un successivo insegnamento ai ragazzi, quindi non trasformano queste esperienze in spunti per le lezioni scolastiche, ma tengono ben distinte le cose».
Tuttavia, nonostante questa relazione spesso faticosa con le scuole, su tutto il territorio nazionale emerge un forte bisogno da parte degli insegnanti di ricevere informazioni e comprendere modalità di intervento con bambini e ragazzi a rischio. L’aggancio tramite le scuole rappresenta quindi un lavoro faticoso, ma necessario, essendo esse il luogo privilegiato per osservare, segnalare, affrontare i casi di vulnerabilità. Il problema principale risiede nel fatto che non sempre si attiva una alleanza autentica tra la scuola e il territorio. «Accade spesso che gli insegnanti percepiscono a volte chi viene dall’esterno come coloro che vengono a giudicarli» .
Per superare questo atteggiamento di diffidenza occorre costruire fiducia, lavorare insieme nei progetti condividendone obiettivi, strumenti e modalità, e non proponendo alle scuole un “pacchetto preconfezionato” che le fa sentire semplici strumenti per arrivare ai beneficiari. In questa fase il ruolo del Terzo settore è delicato e fondamentale,
esso può rappresentare quel ponte per un dialogo tra scuola e famiglia, un valore aggiunto che va però riconosciuto dagli insegnanti e definito congiuntamente nelle modalità. «I bambini necessitano di essere riconosciuti. il minore è portatore di una rete rizomatica intorno a sé stesso, i cui punti centrali non siamo né noi operatori del Terzo settore né gli assistenti sociali. I punti centrali della rete del minore sono la famiglia e il gruppo dei pari» .
La questione centrale resta, in generale, quella di far lavorare insieme, in equilibrio e collaborazione, gli enti pubblici con il privato sociale.
Pubblico e privato hanno differenti responsabilità ma le differenze non stanno nella lettura del minore che spesso si intreccia perfettamente. La scommessa sta nel trovare la migliore combinazione tra i diversi strumenti operativi per agire nell’interesse del minore, come valorizzarsi reciprocamente. «Il progetto che viene a noi proposto ruota sull’educazione non formale e fornisce la possibilità agli operatori di adottare posture e modalità diverse rispetto al pubblico. Quindi lo sforzo del nostro lavoro di équipe è quello di armonizzare i linguaggi per raggiungere gli obiettivi comuni. Si vince se il minore riconosce l’armonia degli strumenti, ovvero se c’è un filo che tiene insieme tutto» .
L’aggancio è sempre basato sulla lettura congiunta di
diversi professionisti del pubblico e del privato sociale per affrontare bisogni complessi delle famiglie come la povertà economica, gli stereotipi sociali e culturali, le condizioni di violenza o criminalità, le distanze fisiche che non consentono alle famiglie di accedere ai servizi.
La dinamica di lavoro in parallelo di diverse figure professionali rispetto agli stessi obiettivi risulta la chiave di volta per attuare un aggancio solido.
Il ruolo degli educatori nelle strategie di aggancio
Il tema dell’aggancio inevitabilmente porta con sé anche una considerazione sulle competenze che gli educatori devono possedere. L’educatore oggi è chiamato a mettere insieme, collegare, lavorare con la comunità. Occorre fare in modo che gli educatori facilitino i processi generativi, attivando competenze nei giovani e nelle famiglie coinvolte, valorizzando soprattutto i momenti informali. «Per me l’educatore è nei momenti spontanei di relazione e interazione. Assistiamo al paradosso dell’educatore “zerbino” che non viene ascoltato, perciò dobbiamo rimettere al centro la funzione dell’educatore e le sue competenze. Questo è ciò che riconoscono anche i ragazzi: la coerenza, la verità, la capacità di stare su più piani e su più livelli» .
Sono emerse in alcuni incontri le seguenti parole-chiave
connesse al lavoro degli educatori nella fase di aggancio dei minori e delle famiglie:
• disagio educativo: sintetizza l’idea di disagio ricorrente che in vari interventi emerge come fatica per l’educatore, spesso in difficoltà nel calibrare e adeguare il proprio stile a quello dei ragazzi e bambini che ha di fronte;
• la libertà come punto di forza del lavoro educativo e come nodo critico, perché ha a che fare con un bisogno di riconoscimento per contagiare e mettere in moto processi trasformativi;
• l’educatore fa un percorso di creazione di contesti di fiducia, di alleanze, senza sostituirsi all’altro: non diventa indispensabile, ma apre opportunità e sguardi diversi, e questo lo fa a ogni livello nei contesti in cui opera.
«L’educatore è sempre in movimento, va ovunque: ogni spazio è un luogo educativo. Va dove accadono le cose. Non ha bisogno di setting specifici: è l’educatore che costruisce e porta con sé il setting dentro e fuori i contesti formali, sapendo creare ponti tra contesti per superare le frammentazioni tra i servizi che, spesso, non si parlano» .
Molte delle competenze necessarie si costruiscono sul campo e nella circolarità tra esperienza e rielaborazione/studio con il sostegno di attività di lavoro in équipe e supervisione, capaci di restituire tempo alla riflessione e alla “manutenzione” di sé e dell’équipe.
Emerge la centralità delle competenze relazionali legate all’ascolto non giudicante, che separa la natura del comportamento dal valore della persona, legate alla presenza empatica, alla flessibilità che consente incontri trasformativi, alla curiosità che apre alla scoperta dell’altro e dei suoi significati/valori qualunque essi siano, alla capacità di stare nell’attesa di cambiamenti possibili ma non sempre realizzabili («tolleranza della frustrazione»). Infine la necessaria consapevolezza della dinamica impotenza/onnipotenza che può “bruciare” gli operatori e che deve essere accompagnata da apparati di protezione ad hoc (es. supervisione, riflessività) nutrita con momenti rigenerativi.
All’adulto i bambini rivolgono richieste esigenti: quella di esprimersi come figura autorevole e incoraggiante, capace di facilitare e non di ostacolare la formazione della personalità.
La comunicazione tra mondi diversi va facilitata da apposite figure professionali formate. Per fare questo sono necessari nuovi setting per valorizzare e rendere efficace l’incontro tra genitori e tra genitori e scuola, laboratori artistico-espressivi, eventi in cui si partecipa insieme, incontri tra genitori su tematiche educative, sportello civico per servizi alle famiglie, supporto al gap tecnologico, ecc.
• L’AGGANCIO •
La cassetta degli attrezzi
Strategie utili per favorire l’aggancio di genitori e famiglie:
• Investire fortemente sulla formazione formale e informale.
• Utilizzare l’ascolto come strumento per entrare in contatto con i più diversi professionisti.
• Favorire la co-progettazione con altri professionisti degli interventi.
• Adottare l’home visiting, soprattutto nella prima infanzia, in quanto favorisce la definizione di un piano attento, e permette di entrare in contatto con le famiglie in una fase delicata come quella prenatale e rilevare eventuali situazioni di rischio.
• Inserire la figura dell’“operatrice di allerta” anche nella fase prenatale, al fine di individuare i possibili fattori di rischio.
• Snellire le procedure di aggancio e informalità dei contatti, ripensando a modalità di incontro che rendano protagoniste le famiglie e non oggetto di intervento.
Strategie utili per agganciare le famiglie più fragili:
• Dare supporto materiale.
• Dare tempo necessario per acquisire fiducia.
• Favorire un accompagnamento individuale da parte dell’educatore.
• Creare spazi fisici e occasioni ripetute nel tempo.
• Dare spazio e protagonismo ai genitori.
• Fare insieme divertendosi.

LA VOCE DAL CAMPO
Fedele Salvatore
“L’aggancio funziona quando con-fidi nella persona che hai davanti”
Fedele Salvatore è presidente della cooperativa sociale Irene ’95 di Marigliano (NA), realtà capofila del progetto RESPIRO (REte di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali), iniziativa selezionata dalla Fondazione Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che si occupa della tutela dei bambini figli di vittime di femminicidio.
RESPIRO è un’azione multidimensionale, che vede la collaborazione con una rete di 13 partner presenti in sei regioni italiane (nel Sud Italia e nelle Isole).
Senza aggancio, non c’è progetto. Sia che si tratti di contesti complessi e drammatici come quelli degli “orfani speciali”, sia che si lavori nella tessitura di una comunità educante. Salvatore, senza entrare nel merito delle singole situazioni, come possiamo tradurre, nella pratica, la parola “aggancio”?
L’aggancio è la prima forma di legame, e lo scopo del
legame deve essere quello di avviare una relazione. Questa è la cosa fondamentale. Non ci sono tecniche, non ci sono ricette o protocolli. Io dico sempre anche ai miei colleghi, ma anche agli insegnanti: attenzione a prendere delle ricette e ad applicarle sperando che questo magicamente crei l’aggancio. L’aggancio lo crea solo la confidenza, il saper confidare nella persona che si ha davanti. Per agganciare bisogna sapere stabilire delle relazioni.
Come?
In un modo facile, e complicatissimo: imparando ad ascoltare. L’ascolto è innanzitutto capacità di entrare in relazione anche in maniera molto discreta e silenziosa, perché l’ascolto richiede il silenzio, richiede la capacità di stare attenti. L’ascoltare, paradossalmente, inizia da una prossemica, da un modo di stare davanti alle persone, di annuire, di trasmettere l’attenzione e l’apertura rispetto a quello che il tuo interlocutore ti sta dicendo. Invece molto spesso noi diciamo di “ascoltare i ragazzi” e poi mentre loro parlano abbiamo lo sguardo, la testa, gli occhi da un’altra parte.
Quali sono le condizioni che favoriscono questo contesto di ascolto e di avvio di una relazione?
Questi agganci, per funzionare, devono avvenire nella quotidianità. Io sono convinto, ma a questa convinzione
sono arrivato attraverso decenni di pratica educativa, che l’aggancio e la relazione scattano davvero solo in un contesto di informalità. Via via, nella nostra società, siamo andati sempre più verso l’assuefazione a un modo di concepire l’occasione di relazione come un momento di straordinarietà: la festa, l’evento, il concerto... Tutti, sia a livello privato sia a livello pubblico, viviamo in funzione di eventi straordinari. Anzi, se non è “straordinario” l’evento non esiste. È un approccio in qualche modo drogato, perché poi una volta passato l’evento straordinario, che dura un niente, ci resta la frustrazione di non essere riusciti a sedimentare un legame vero. E corriamo verso l’evento successivo. Ma il legame vero nasce nella pratica quotidiana, nella confidenza che si instaura nei piccoli momenti normali, nel dialogo, nel sapere di poter contare su una persona anche per cose non straordinarie.
Che cosa intende per informalità, nell’aggancio di adolescenti e ragazzi?
Significa calarsi nelle loro realtà, mettersi dal loro punto di vista, essere una parte delle cose che costituiscono la loro quotidianità, non pretendere che diventino loro parte della nostra. Il gioco, le arti visive, la musica... gli elementi su cui lavorare sono molti, e questa possibilità di dare una forma all’informalità è da tempo un mio pensiero. Ritrovare
la questione nelle parole e nelle esperienze degli altri durante gli incontri delle comunità di pratiche, socializzare questa cosa, mi ha colpito molto. Significa che è una strada che tanti stanno esplorando, ed è importante vedere insieme esperienze concrete, perché in questi ultimi anni stiamo assistendo a un fenomeno che personalmente mi preoccupa: gli stessi ragazzi si frequentano molto meno tra di loro, anche tra loro si sono ridotte drasticamente le occasioni di incontro informale.
Colta l’occasione, qual è un secondo ingrediente per un aggancio generativo?
Mettere in campo modalità di relazione che diano protagonismo ai ragazzi. Noi a Marigliano, nel nostro progetto Laboratorio di Comunità, insieme agli studenti delle scuole superiori abbiamo immaginato di costruire una “mappa della città educante”, una mappatura dei luoghi dove si fa educazione e socializzazione. Ciascuna scuola, ciascun ragazzo, con le proprie competenze si è impegnato a comporre una parte di questa mappa. Chi aveva competenze più artistiche ha progettato una vera e propria mappa della città. Chi aveva più competenze da operatore sociale ha fatto le interviste sul campo, ha interpellato i vari luoghi educativi della città. Chi aveva competenze informatiche realizzato un’app. Tutto materiale che poi è stato messo a disposizione
delle famiglie e delle associazioni e che ha reso evidente tutte le risorse e le opportunità che stanno all’interno della nostra comunità, ma che non erano mai state portate in luce e riunite in un unico quadro d’insieme. E questo l’hanno fatto i ragazzi, che sono usciti dal ruolo di “beneficiari” di quei servizi, se sono diventati coloro li hanno censiti e messi in circolo.
C’è un’esperienza relativa all’aggancio dei beneficiari che ha ascoltato raccontare da altri durante le comunità di pratiche e che l’ha particolarmente colpita?
Le esperienze che ho incontrato durante i lavori delle comunità di pratiche sono tante, tantissime. Quella che mi ha conquistato, e che io vorrei anche un po’ rubare (non me ne vogliano i miei “colleghi”, ma le comunità di pratiche servono anche a questo, no?), è una formula semplice, piccola, ma molto bella, che esprime generosità, solidarietà, condivisione. Non ricordo in che località è nata questa consuetudine del “caffè con i genitori”. Il lunedì, al momento dell’accompagnamento dei figli a scuola, il dirigente scolastico si trova con il capannello dei genitori davanti alla scuola e si bevono insieme un caffè. Dieci, quindici minuti, un saluto, una battuta, magari anche qualche discorso serio, e poi ognuno va al suo lavoro. Da quando ho sentito raccontare questa esperienza anche io ogni mattina, quando vedo
le frotte di genitori fuori scuola alle otto e un quarto, alle otto e mezza, mi dico sempre: “porca miseria, e proprio qui che dovrebbe avvenire l’aggancio”.
Quando si lavora sull’aggancio bisogna lottare di più con la diffidenza o con l’indifferenza?
Il nemico sono l’indifferenza, l’apatia, atteggiamenti che in questi anni vedo aumentare in tanti ragazzi. Ho fatto per tanti anni l’insegnante, e quindi ho visto i percorsi di diverse generazioni di ragazzi. Non ho mai assistito, come negli ultimi anni - forse da dopo il Covid - questo tipo di “ritiro sociale”, di allontanamento dalla vita attiva della comunità. E forse siamo noi adulti, noi operatori che dobbiamo smetterla di lamentarci di questa cosa e trovare parole e modi nuovi per coinvolgerli. Perché poi la mia esperienza mi dice che, se opportunamente sollecitati e incontrati, i ragazzi poi rispondono.
Chi sono i buoni alleati per un buon aggancio?
Il protagonismo e il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale. Lo è, o almeno dovrebbe esserlo, la scuola, quando dirigenti scolastici e insegnanti riescono a non concepire la scuola come un’azienda fatta di scadenze burocratiche, amministrative, scadenze dei progetti PNRR, progetti sfornati a pioggia per impiegare finanziamenti non sempre ben
focalizzati. Vedo invece ancora in forte ritardo la partecipazione della pubblica amministrazione. Spesso i percorsi delle Amministrazioni vanno da una parte, e i bisogni dei ragazzi dall’altra. Riprendendo una frase di don Lorenzo Milani e della straordinaria esperienza di Barbaiana: “Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica”. Bisognerebbe ripeterselo più spesso.
Questo “sortirne tutti insieme” non sarebbe un bel motto anche per spiegare le comunità di pratiche? È vero. Quella delle comunità di pratiche promosse da
Con i Bambini è un’esperienza di valore. Io ci sono arrivato in qualche modo già preparato, perché il nostro progetto RESPIRO, che sviluppiamo con 13 partner in sei regioni italiane, è già di suo una specie di comunità di pratiche. Diciamo che è piuttosto abituale essere una comunità di idee, una comunità di teorie, perché molto facilmente facciamo riferimento a presupposti scientifici, a modelli teorici sia educativi che organizzativi. Ma poi sono le pratiche che definiscono bene e meglio quello che facciamo. Sono connotate forse da quei tratti di originalità, di prossimità, da cui passa il vero valore.
2
LA PARTECIPAZIONE DI MINORI E FAMIGLIE: IL VALORE
DELLE RELAZIONI DI FIDUCIA
Un tema strettamente collegato e conseguente alla pratica dell’aggancio è quello della partecipazione, che può essere inteso come un continuo e costante consolidamento del principio di relazione che si è aperta con l’aggancio.
Mantenendone viva la curiosità, l’energia, la messa in gioco reciproca.
Anche quello della partecipazione è stato un argomento ricorrente nei lavori dei diversi gruppi attivati dalle comunità di pratiche, e si è declinato in diverse situazioni emerse nello sviluppo concreto dei progetti: il mantenere un ruolo attivo, l’essere coinvolti nelle scelte, il poter contribuire alla presa di decisioni, il poter formulare proposte.
Approfondendo il tema della partecipazione ci si è trovati di fronte a una grammatica già percorsa analizzando le dinamiche dell’aggancio. Quando in famiglia, a scuola, in un’associazione si definiscono delle regole, dei patti di lavoro o di “convivenza”, i ragazzi non accettano di essere i destinatari o i fruitori passivi di scelte operate da altri, fatte dagli adulti e semplicemente loro comunicate o imposte.
Essi desiderano essere co-attori del processo di costruzione delle regole, degli accordi e dei progetti, per potersi mettere alla prova, sperimentarsi concretamente in situazioni anche difficili, “rischiare” così da conoscere possibilità e limiti, potenzialità e vincoli, personali e collettivi.
Le linee di riflessione emerse dalle comunità di pratiche, e i conseguenti modelli operativi, seguono un percorso concettuale molto chiaro.
La partecipazione si realizza, sempre ed inevitabilmente, in un contesto di relazioni significative: la relazione con i coetanei e con gli adulti è un fattore di centrale importanza nella promozione e nella gestione di esperienze di partecipazione.
La partecipazione esprime poi una chiara intenzionalità educativa: è un’opportunità di apprendimento e rappresenta una dimensione cardine del lavoro educativo: non si dà educazione se non in chiave partecipativa. Gli adulti, in sostanza, fanno un buon lavoro educativo quando hanno dato la possibilità ai bambini e adolescenti di acquisire una maggiore consapevolezza, una più adeguata conoscenza di sé, degli altri, del mondo in cui vivono. Conoscenza e consapevolezza sono capisaldi anche di un lavoro educativo che fa della partecipazione il cardine del processo avviato. Conoscenza vuol dire essere tempestivamente ed
esaurientemente informati rispetto a tutto ciò che li riguarda direttamente. Ma l’informazione non basta, non è sufficiente per poter parlare di livelli o processi reali di partecipazione. Questa coincide con la consapevolezza, cioè con la possibilità di comprendere la complessità dei fenomeni e del vivere oggi, superando un’idea semplificata della realtà. «Partecipare vuol dire veder rispettati i propri tempi: quelli del capire (cognitivi) e quelli dell’appartenenza (affettivi). Non sono possibili progetti/percorsi di partecipazione se non sono realmente in sintonia con ciò che i minori avvertono come fattori e condizioni essenziali, irrinunciabili sul piano della qualità relazionale» .
Le esperienze di partecipazione, se gestite con intenzionalità, possono dare un contributo molto importante alla conoscenza di sé e del mondo. Partecipazione è quindi intesa non come informazione, coinvolgimento o esperienza episodica ma un’azione più articolata, un’espressione di sé in una definizione ed elaborazione collettiva, che preveda anche la valutazione del processo e dei risultati. Le azioni che promuovono partecipazione richiedono il contributo e la collaborazione di tanti soggetti, perché si tratta di progetti di elevata complessità, all’interno dei quali la complementarietà delle competenze rappresenta un fattore essenziale per garantire l’efficacia del lavoro.
I processi partecipativi sollecitano quindi tutte le figure adulte coinvolte a rivedere i propri posizionamenti: personali, professionali e organizzativi mettendo realmente al centro i ragazzi.
L’esperienza partecipativa dovrebbe nel complesso porsi come un metodo, uno stile che permea tutto il lavoro con i bambini e gli adolescenti in tutti i loro contesti di vita. «Promuovere un “incontro antropologico” con le famiglie - a volte anche molto distanti da noi per valori e stili di vita».
Il coinvolgimento delle famiglie
Provando a fare una sintesi delle riflessioni condotte dai gruppi, si può affermare che nella relazione con le famiglie, elemento che complessivamente rappresenta una sfida per tutti i progetti, il lavoro si è concentrato sulla creazione dentro e intorno alla scuola di tempi e spazi nuovi, cioè di nuovi setting maggiormente idonei a valorizzare e rendere efficace l’incontro tra genitori e tra genitori e scuola.
Si è riconosciuto che le relazioni tra genitori e scuola e tra genitori e figli passano attraverso una doppia mediazione: quella dell’operatore e quella dell’attività pratica fatta insieme, in quanto tale mediazione facilita la costruzione della relazione e l’avvicinamento tra mondi diversi. Una rinnovata relazione di fiducia tra scuola e famiglia rafforza infatti la fattibilità degli interventi educativi sui ragazzi
(fruizione di servizi ricreativi, accompagnamento a psicologi e psicoterapeuti, ecc..).
Quando dalla scuola arriva un aiuto concreto e tangibile diretto ai ragazzi (per esempio il recupero della licenza media, device tecnologici, ecc.), le famiglie si sentono riconosciute e sostenute nei bisogni del loro quotidiano senza essere giudicate, e questo facilita un loro avvicinamento ai progetti offerti dalle scuole. «Forse la (non) partecipazione non dipende da un generico “disinteresse”, ma da altri fattori che non conosciamo. È importante riconoscere la piena soggettività delle famiglie».
La partecipazione, insieme, di genitori e figli alle attività consente, poi, che avvengano scoperte, rispecchiamenti, supporti reciproci, capaci di incidere sia sul piano individuale, sia all’interno della relazione familiare.
Le esperienze pratiche che hanno ottenuto una maggiore partecipazione sono state quelle “presentate” dal servizio territoriale, al quale viene riconosciuto un ruolo di garante della serietà della proposta e dei proponenti e ha facilitato l’avvicinamento di alcune famiglie, nonché la partecipazione ai primi incontri.
Le attività rivolte alle famiglie funzionano meglio quando esiste una figura di “facilitatore della comunicazione” con un ruolo tecnico riconosciuto e garante della partecipazione di tutte e tutti sul piano della costruzione del discorso collettivo.
• PARTECIPAZIONE DEI GENITORI •
La cassetta degli attrezzi
Strategie utili per favorire la partecipazione dei genitori:
• Focalizzare l’attenzione soprattutto sulle risorse attorno a bambini e ragazzi, sia come nuclei familiari, sia come reti già attive, riconoscendo che, prima della rete socio-educativa che il progetto vuole proporre, esistono reti familiari, amicali, di quartiere che devono essere riconosciute, affermate e coinvolte.
• Mostrare la difficoltà degli operatori alle prese con la complessità dei problemi e chiedere alle famiglie di aiutare ad aiutare i ragazzi, costruendo un’alleanza per l’equilibrio nella loro crescita.
• Rispettare cultura e linguaggio delle famiglie, che spesso si auto-percepiscono come carenti e inadeguate e che nella relazione con le Istituzioni vivono come sotto a una lente, valutante e stigmatizzante.
• Costruire spazi di protagonismo reale: trasformare le famiglie da “oggetti/destinatari” di intervento a “soggetti/protagonisti” di intervento.
• Prevedere setting d’incontro informale (tra le famiglie e i docenti/operatori) che rendano possibili relazioni e processi diversi da quelli che si realizzano nelle normali routine scolastiche.
• Attivare una maggiore orizzontalità dei rapporti tra gli adulti in gioco (genitori, operatori, docenti).
• Consentire agli operatori del terzo settore di avere una “postazione” a scuola che sia riconoscibile e accessibile e offra un’immagine di presenza continua, e di integrazione con il sistema scolastico.
La partecipazione di bambini e adolescenti
Nell’affrontare nello specifico la tematica della partecipazione di bambini e adolescenti è stata ripresa la definizione del sociologo Luciano Gallino, che definisce la partecipazione sia come “capacità di concorrere alle decisioni fondamentali della collettività”, sia come prendere parte in maniera meno frequente, ma, comunque, significativa, alla vita del proprio gruppo di appartenenza.
La partecipazione è dunque una graduale appropriazione di potere da parte degli individui e dei gruppi, facilitata dallo sviluppo di capacità individuali e collettive, per aver sempre più controllo sul proprio destino.
Dagli incontri realizzati nelle comunità di pratiche con i referenti dei progetti emerge un quadro complesso: i ragazzi che posseggono già delle competenze cercano in autonomia contesti di partecipazione, mentre i ragazzi più vulnerabili e fragili, che vengono agganciati dai progetti, non sanno proporsi e a volte non sanno neppure di possedere delle competenze.
Il compito degli educatori è quindi quello di potenziare le loro life skill, per consentire loro di imparare a “maneggiare” le emozioni. Per questi ragazzi, a volte, la partecipazione significa semplicemente intervenire in una discussione.
Il principio che sta alla base del processo di partecipazione è la motivazione; i bambini e i ragazzi possono affrontare e risolvere problemi complessi se sono motivati e se li ritengono
“loro”. Se ai ragazzi si riescono a porre nei giusti termini i vari livelli di un progetto che li coinvolge (e trovare questi “giusti termini” è compito degli adulti), essi potranno intraprendere la strada dello sviluppo comune ed individuale e dimostrare progressiva competenza. Il coinvolgimento, infatti, genera motivazione, che genera processi di capacitazione che generano competenza, che di nuovo aiuta la motivazione stessa per ulteriori opportunità di coinvolgimento. «Ciò che proviamo a far sperimentare ai ragazzi è che non è necessario essere adeguati alla società, ma che la comunità dovrebbe essere accogliente verso diversità; l’importante, quindi, in questi percorsi è stare loro accanto per permettere di sperimentare nuove opportunità di partecipazione».
Il primo aspetto da considerare, quindi, è che ciascuna metodologia o processo messo in campo deve essere personalizzato: i ragazzi sono diversi, partono da competenze di base diverse e possono avere diverse difficoltà a partecipare. Questo richiede una professionalità e una qualità elevata degli operatori.
La metodologia privilegiata per l’acquisizione in tal senso di competenze è la sperimentazione accompagnata dalla presenza di una figura, appunto, esperta.
Altro elemento fondamentale è quello di uscire da una logica prestazionale e da preconcetti che il mondo adulto prova in maniera inefficace a far assumere al mondo giovanile.
Durante gli incontri è stato, inoltre, condiviso lo strumento per valutare e prendere coscienza dei processi di partecipazione attivati di cui si è protagonisti, ovvero la scala della partecipazione di Rogert Hart, dove si definisce la differenza tra cos’è partecipazione e cosa non lo è, su come sia importante essere consapevoli del livello a cui si lavora per promuovere quello che è una graduale evoluzione verso un livello sempre maggiore di partecipazione dei ragazzi. La condivisione di una cornice teorica, che stimolasse il confronto, è risultata molto utile per posizionarsi in modalità meta-riflessiva rispetto alla propria pratica.
Lasciare spazio ai ragazzi di essere protagonisti significa anche permettere loro di sbagliare e di sfidare le regole. Compito dell’adulto, dell’educatore, è creare un “protagonismo accompagnato”: lasciare che i ragazzi, soprattutto quelli più a rischio, possano sperimentare l’autodeterminazione e il successo. Far sperimentare loro il successo aiuta e contribuisce alla creazione di autostima, anche se è vero che partecipazione vuol dire anche assumersi il rischio del fallimento, rimanendo comunque vicini a quei ragazzi che falliscono, per sostenerli nell’elaborazione del fallimento stesso, che è una fondamentale leva di apprendimento umano.
• PARTECIPAZIONE DEI MINORI •
La
cassetta degli attrezzi
Strategie utili per rendere propositiva la partecipazione di bambini e adolescenti:
• Prevedere del tempo prima e dopo il progetto per la partecipazione in modo auto-riflessivo e auto-valutativo.
• Partire dalle esperienze esistenti per agganciare le progettazioni. Personalizzare le forme di partecipazione sulle competenze e le aspirazioni dei beneficiari.
• Curare la formazione sulle tecniche e sugli obiettivi della co-progettazione.
• Migliorare lo sguardo e il linguaggio sull’impegno richiesto a bambini e ragazzi, qualificando allo stesso tempo il ruolo educativo degli adulti. Riattivare un percorso culturale legato alla partecipazione delle ragazze e dei ragazzi che anzitutto riguarda gli educatori: devono tornare a discutere del significato attribuito a questa parola e di quali siano i metodi e le pratiche non formali ma sostanziali per agirla.
• Provare a introdurre una scala delle pari opportunità, che contenga i criteri e i fattori che favoriscono i processi di inclusione sui territori e nei vari contesti; tali criteri permetterebbero, quindi, di misurare il livello di inclusività dei vari contesti (ovvero quanto essi favoriscono l’accesso alle opportunità.).

LA VOCE DAL CAMPO
Claudia Silvestri
“C’è partecipazione quando scatta un’alleanza intorno al progetto”
Claudia Silvestri è responsabile della cooperativa Alicenova, che in partnership con il Consorzio Parsifal (capofila), il Centro Nascita Montessori e l’associazione culturale Casa dello Spettatore ha sviluppato a Montefiascone (Viterbo) il progetto Locanda Infanzia – Spazi, idee e attività per i bambini e la comunità educante, vincitore del bando Comincio da zero – servizi educativi e di cura per la prima infanzia del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Locanda Infanzia, in un casale ristrutturato di 3mila mq, eroga servizi educativi flessibili per lo 0-6 con orario prolungato, propone progetti e attività di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, e promuove seminari formativi e incontri di progettazione partecipata per il potenziamento della comunità educante.
Il tema della partecipazione, quando si definisce un progetto, non si può mai dare per scontato. Quali sono i fondamenti della partecipazione, come la si stimola, come la si rende viva tutti i giorni?
Sicuramente quello della partecipazione è un aspetto molto delicato, che fa in maniera sostanziale la differenza in un progetto. La partecipazione deve avere una doppia chiave di lettura: quella relativa ai beneficiari del progetto - nel nostro caso, le famiglie e i bambini 0-6 anni -, e quella che guarda a quanto e come il progetto viene “partecipato” da tutti gli altri soggetti che fanno parte della comunità e che possono essere considerati parte della comunità educante del territorio: i nidi, le scuole, le altre realtà associative anche non strutturate, fino all’Ente pubblico, il Comune eccetera. Anche questa partecipazione collaborativa della rete di soggetti del territorio è un elemento fondamentale per rendere vincente, attiva, vera la partecipazione di coloro ai quali poi il progetto si rivolge. Se guardiamo alla nostra esperienza, la Locanda Infanzia, una vera e propria “casa” in cui crescere insieme come persone e come comunità, posso dire che la capacità di aver portato un’idea innovativa sul territorio ha generato attenzione e curiosità, che si sono tradotte in partecipazione propositiva. C’era ed era sentita dalle persone, dalle famiglie, la carenza rispetto a servizi di tipo educativo che non fossero quelli istituzionalizzati e più tradizionali.
Come si misura la partecipazione, al di là dei numeri e delle presenze?
La misura della partecipazione è il coinvolgimento che le
famiglie dimostrano. Essere coinvolte significa non essere solo fruitrici di un serivizio, ma partecipare alla sua elaborazione, alla sua declinazione, comprenderne gli obiettivi e le finalità. In questo modo scatta un’alleanza, non solo - appunto - una fruizione. E questa cosa fa assolutamente la differenza. Noi abbiamo sempre mantenuto con le famiglie un dialogo costante, aggiornandole passo passo rispetto alle attività che proponevamo e mantenendo con loro un confronto e un dialogo sempre aperto. Il progetto è cresciuto attraverso questa condivisione. Per esempio, sono stati molto importanti per rafforzare questa condivisione i weekend formativi a cui hanno partecipato tanti genitori, sentendosi parte integrante del progetto e del servizio. Attori di quel che veniva proposto, non utenti.
Per generare questo meccanismo conta di più avere una metodologia chiara e definita o saper in qualche modo anche improvvisare rispetto a quello che la realta concreta propone?
Bisogna essere bravi a integrare e dosare entrambi questi aspetti. Serve assolutamente avere un metodo, frutto di una competenza consolidata, ma poi bisogna essere coscienti del fatto che per quanto si possa avere metodo la realtà quotidiana porta poi a dover affrontare e gestire situazioni non preventivate, quindi bisogna avere lo spirito e la visione per rimodellare gli obiettivi e le pratiche di conseguenza.
Quanto il tema della partecipazione è stato presente nelle comunità di pratiche cui lei ha contribuito?
La partecipazione è sempre presente come pensiero, anche quando non viene esplicitato. Noi, tutti noi, facciamo progetti che hanno senso se sono “partecipati” dalle persone e dalle comunità cui ci rivolgiamo. Dai confronti con i colleghi all’interno delle comunità di pratiche è emerso, sotto questo aspetto, un quadro molto diversificato. Emergevano esperienze rispetto alle quali la partecipazione era scattata da subito, come una scintilla, e altre che avevano dovuto fare i conti con maggiori resistenze, o rimodularsi profondamente per far nascere coinvolgimento.
Sono emerse idee, stimoli positivi che le hanno aperto prospettive nuove anche rispetto alla vostra progettualità?
Senza dubbio. Anche solo il sentire altri che raccontano la loro esperienza ti porta a riflettere in maniera diversa sulla tual, rileggendola sotto nuovi punti di vista. E quindi cogli aspetti, criticità e potenzialità alle quali fino a quel momento non avevi pensato. E poi c’è una sorta di effetto “consolatorio”: quando senti anche altri che si sono scontrati con problemi simili ai tuoi, ti senti un po’ meno sola, capisci che si tratta di sfide che tanti stanno affrontando, non sei tu che stai sbagliando strada.
3 IL RUOLO DELL’EDUCATORE
E IL RAPPORTO NELLA COMUNITÀ
Il tema della figura e del ruolo dell’educatore, all’interno delle comunità di pratiche, è entrato trasversalmente - e non poteva essere altrimenti - in diversi momenti del confronto. Pur nelle diversità di “inquadramento”, alle diverse sfumature che questa figura assume nei diversi contesti territoriali e rispetto ai diversi tipi di progetto e di impegno, complessivamente l’educatore viene considerato dai partecipanti delle comunità di pratiche una figura di prossimità, che permette di svolgere un ruolo di ponte, di facilitazione e fin anche di mediazione tra i diversi contesti: scuola, territorio e famiglia.
La continuità dell’azione educativa tra i diversi luoghi come tra scuola, extra scuola e famiglia rappresenta un elemento essenziale di tenuta e coerenza nella costruzione della rete intorno ai bambini e ai ragazzi. L’educatore deve pertanto possedere e saper utilizzare diversi registri linguistici e organizzare setting flessibili e creativi cercando di rispondere a desideri e bisogni profondi.
Il suo ruolo è sempre di attivatore di risorse nell’altro e di eventuale sostegno, con una grande attenzione a non
accettare deleghe totali alle quali non si potrebbe rispondere. È stata confermata come indispensabile la supervisione e il coordinamento con il gruppo di educatori, necessaria per creare strumenti nuovi e verificarne l’adeguatezza rispetto contesto in cui si lavora. Da diversi interventi è emersa la consapevolezza di come la pandemia abbia dato l’opportunità di rendere meno densi (o, per un periodo, di mettere in pausa) gli impegni del lavoro in prima linea, per dare così modo di recuperare l’importanza degli ambiti e dei compiti di supervisione.
Le competenze acquisite e sviluppate dall’educatore sono molteplici e hanno differenti declinazioni, che vanno dagli strumenti e strategie utili all’intervento educativo, fino a specifiche competenze relative a contenuti disciplinari.
La principale competenza trasversale necessaria per il ruolo è quella della lettura dei bisogni dei bambini e dei ragazzi, ma anche dei propri bisogni, così da riuscire a inscrivere il proprio agire educativo sempre all’interno dell’esercizio di una professione. Dentro a questa competenza sta anche l’ascolto attento ed empatico e la capacità di costruire risposte educative in base ai feedback dei ragazzi, prevedendo una grande flessibilità.
«È fondamentale conoscere i propri limiti per evitare di cadere nella trappola dell’onnipotenza e dell’illusione di poter
“salvare l’altro”. La conoscenza in continuo sviluppo nell’educatore è un po’ come il pensiero di uno scienziato curioso ed esplorativo che va avanti e fa tesoro degli errori e rappresenta un esempio per i ragazzi».
Le competenze specifiche degli educatori, riconosciute dalle organizzazioni all’interno delle progettualità e frutto di continua formazione, sono:
• competenze scientifiche per l’allestimento di laboratori STEM;
• competenze digitali;
• competenze sportive per le attività di carattere sportivo;
• competenze di gestione di gruppi (spesso classi) attraverso l’utilizzo di strumenti come il circle time e il cooperative learning;
• competenze di mediazione e facilitazione finalizzate a mantenere le reti tra servizi e le istituzioni;
• competenze da orientatore nel rapporto tra scuola e mondo del lavoro;
• competenze di sostegno alla genitorialità nel dialogo con le figure adulte di riferimento;
• competenze legate alla capacità di stabilire relazioni in situazioni in cui non è possibile la presenza fisica ma solo virtuale.
• Sono importanti le nozioni sugli stili di apprendimento, sui processi cognitivi ed emotivi, le conoscenze di carattere
normativo e amministrativo, anche se molto si apprende sul campo attraverso l’esperienza e la riflessione.
Quando l’educatore entra in un progetto, si conferma come necessaria una formazione iniziale tra educatori per comprendere a fondo il senso del progetto e il proprio ruolo, condividere linguaggi e metodologie. La formazione iniziale in alcuni casi è stata anche di carattere interprofessionale: ad esempio, ha coinvolto educatori e insegnanti con l’obiettivo di conoscersi reciprocamente come professionisti appartenenti a sistemi diversi. Questo ha permesso di cogliere fin dall’inizio la ricchezza insita nei diversi punti di vista e negli strumenti differenti utilizzati dalle professionalità coinvolte. Inoltre, il lavoro d’équipe o di supervisione in corso d’opera permette un confronto e una riflessione sul vissuto emotivo legato al fare che diventano fondamentali per la tenuta e lo sviluppo della resilienza e la tenuta della comunità educante.
La relazione con la scuola
I progetti hanno investito molto nelle attività che vedevano la presenza degli educatori a scuola, ma la pandemia non ha reso possibile realizzarle come si era auspicato di poter fare. Il coinvolgimento degli educatori in classe è avvenuto con una maggiore facilità nella scuola primaria, mentre ha incontrato maggiori rigidità nella scuola secondaria di I grado.
I progetti hanno sempre previsto una prima fase legata all’analisi dei bisogni della scuola e dei bambini e ragazzi, una seconda fase di co-progettazione con gli insegnanti e infine la realizzazione delle attività in co-presenza. Ciò ha significato spesso rivedere e rimodulare le idee progettuali per andare incontro alle esigenze della scuola, pur nella coerenza con gli obiettivi progettuali. Spesso, la funzione dell’educatore non è stata compresa dall’inizio – a volte è stato visto come un “insegnante di sostegno” - ed è stato necessario riproporre il senso del progetto e delle azioni, sperimentando concretamente le attività.
«Una delle qualità più importanti che l’educatore deve possedere nel momento in cui entra in un sistema complesso come quello scolastico, è quella di saper entrare in punta di piedi, saper osservare e conoscere gradualmente il contesto e porsi come supporto e facilitatore».
L’atteggiamento non valutativo e giudicante nei confronti degli insegnanti è stato il presupposto che ha reso possibile la collaborazione professionale tra insegnanti e educatori. Spesso la diffidenza iniziale da parte degli insegnanti si è attenuata proprio grazie alla flessibilità e alla capacità relazionale degli educatori. Una volta riconosciuta la professionalità dell’educatore, viene molto valorizzato il suo punto di vista diverso sui ragazzi, che permette di arricchire
la visione dei ragazzi stessi e di co-costruire con gli insegnanti interventi più efficaci.
Gli ambiti di azione extra-scolastici rappresentano un ambito privilegiato per il lavoro dell’educatore e possono realizzarsi in luoghi strutturati o in spazi all’aperto (cortili, piazze strade, natura). Mediante la relazione educativa si vuole offrire in modo costante un’esperienza di crescita e di benessere.
Non avere un setting definito ha spesso costretto gli educatori a inventare situazioni di intervento efficaci e a definire ancora meglio il proprio ruolo, come se il setting fosse rappresentato dall’educatore stesso, dalla sua competenza professionale nello stabilire relazioni significative e proporre esperienze coinvolgenti e motivanti nei luoghi di prossimità. « L’extra-scuola è rappresentato da tutti quei luoghi più liberi e meno strutturati che il ragazzo frequenta oppure luoghi pensati “con” loro: lì emergono i bisogni più autentici».
Nei luoghi più strutturati, sia la proposta di attività laboratoriali, sia l’attività di supporto ai compiti, hanno avuto una maggiore valenza laddove è stato possibile connetterle con il lavoro svolto in classe, in modo che la scuola potesse valorizzare il lavoro svolto fuori dal contesto scuola.
• IL RUOLO DELL’EDUCATORE •
La cassetta degli attrezzi
• Gli educatori hanno un ruolo essenziale nei progetti: contribuiscono a determinarne la qualità e la tenuta. La partecipazione dell’educatore al progetto dall’inizio alla fine, la condivisione degli obiettivi e l’organizzazione delle attività, rappresentano fattori fondamentali per lo sviluppo della motivazione, della passione e della resilienza.
• La mancanza di educatori da inserire nei progetti è oggi una difficoltà sulla quale riflettere. Gli educatori, a causa della bassa retribuzione, non paragonabile all’impegno e alla competenza richieste, sono soggetti a forte turn over. Si segnala, inoltre, la rarità di educatori di genere maschile, dovuta al fatto che la cura delle persone è ancora percepita come una professionalità tipicamente femminile. L’incontro con un educatore di genere maschile, invece, consentirebbe, soprattutto nelle famiglie più in difficoltà, un modello maschile aggiuntivo a quello presente in famiglia e potenzialmente arricchente.
• Per quanto riguarda la formazione, appare sempre più necessario un dialogo con l’università per contribuire a dare al profilo professionale dell’educatore un taglio meno “ingessato” e più vicino alle pratiche sperimentate. A livello universitario non è prevista, per esempio, una formazione specifica dell’educatore in campo scolastico.
• Uno strumento molto utile è il tirocinio per affiancamento di educatori senior e la pratica della supervisione a partire dall’azione sul campo e dalla riflessione condivisa sulla stessa.

LA VOCE DAL CAMPO
Marco Battaglia
“Siamo un ponte che unisce mondi distanti”
Marco Battaglia, educatore, è amministratore delegato della Cooperativa sociale Vides Main onlus di Torino. VIDES – Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo – è una Associazione di Volontariato Giovanile, voluta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice o Salesiane di Don Bosco e promossa dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS), per la promozione della donna, dei giovani e dei bambini in condizioni di svantaggio e povertà. Opera da sempre nella Circoscrizione 5 di Torino e vede interagire FMA e laici in un sogno comune: essere casa in una grande periferia della città di Torino.
Che cos’è un educatore?
È un facilitatore. È una figura professionale che sa farsi ponte rispetto alle esperienze di altre professioni più definite, istituzionalizzate. È una figura che sa attraversare i confini e connettere le persone di un territorio - i bambini, le famiglie, gli insegnanti, gli amministratori pubblici
- con un senso di comunità più ampio. Che sa individuare quei punti di connessione che possono contribuire a generare comunità e portare quindi un miglioramento nel contesto in cui la comunità vive e opera. È una figura che deve saper spendere le proprie conoscenze teoriche e tecniche nel “qui e ora” dell’occasione concreta, ed è questa lo cosa davvero molto complicata.
Preparazione e competenze professionali o soft skill personali: come si compongono questi due elementi nella figura dell’educatore?
Ci sono percorsi formativi universitari e post-universitari per la figura dell’educatore, e sono un’ottima cosa, ma io credo - ed è emerso anche nei confronti nelle comunità di pratiche - che a far poi quella differenza decisiva sia la capacità personale di relazionarsi, di saper cogliere in una persona o in un contesto, magari utilizzando il pensiero laterale, tutte quelle sfumature che magari nei percorsi formali è più difficile riuscire a cogliere e strutturare.
Approfondiamo la metafora del ponte e ragioniamo sul primo argine, quello da cui il ponte parte. L’educatore è un soggetto che porta avanti un progetto, è il “volto sul campo” di una non profit o di un’istituzione. Qual è la relazione tra l’educatore e l’ente che rappresenta,
quali sono i mandati, come si rende armonica la relazione tra l’impianto teorico di un progetto e la sua declinazione pratica all’interno delle dinamiche, spesso anche imprevedibili, di una realtà di comunità?
Di fronte a questa domanda devo sdoppiarmi, in quanto io sono educatore, ma sono anche uno che “scrive i progetti”. Porto la mia esperienza personale. Noi siamo una cooperativa di una trentina di persone, che lavorano costantemente a stretto contatto, quindi è molto semplice riuscire a trasmettere il senso complessivo di un progetto, di un’attività, a tutte le diverse figure coinvolte, compresi gli educatori che poi sono sul campo. Tutte le settimane abbiamo una riunione plenaria nella quale condividiamo obiettivi e letture del territorio, ed è un meccanismo che funziona e che ci tiene tutti sempre agganciati alla mission. Se quando si scrive un progetto si parte da un alfabeto condiviso e da una lettura comune, i mandati sono poi più semplici da portare avanti. È vero che nella scrittura del progetto ci sono dei termini, delle frasi, dei concetti da cui non puoi prescindere, e che sembrano magari molto astratti, ma questa astrazione la riduci o la annuli se mentre scrivi il progetto hai ben presente cos’è la povertà educativa nel contesto in cui poi dovrai operare, quali sono le strategie utili, gli alleati, i vincoli, sapendo bene che ci muoviamo in una tale complessità che rende impossibile prevedere tutto
a tavolino. Per questo servono due cose: primo, una grande fiducia negli educatori che vanno sul campo, avere strumenti per accompagnarli, accogliere le loro frustrazioni, che sono tante, e gli spunti positivi imprevisti che sorgono dal territorio, che ci sono e bisogna saper valorizzare. Secondo, concepire sempre l’attività come lavoro di équipe. Io non credo nell’immaginario dell’educatore-messia, che va da solo, salva il mondo e torna indietro. Il processo educativo è sempre un lavoro di équipe.
Andiamo dall’altra parte del ponte, nel territorio delle relazioni che l’educatore deve instaurare con le altre professioni della comunità educante: i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli assistenti sociali... L’educatore è visto come un’alleato nel percorso educativo, o come un concorrente?
Quando si ha a che fare con persone che sanno di avere un ruolo ma sono consapevoli di non “essere” quel ruolo, la relazione nasce sul piano corretto. Perché è ovvio che ognuno nel sistema della comunità ha un suo ruolo e una sua funzione, ma i verbi sono importanti, il ruolo lo si “ha” e non lo si “è”. Quando sei troppo calato nel tuo ruolo, diventa più difficile riuscire a essere aperti e avviare relazioni positive con chi rappresenta altri ruoli. Rispetto alle relazioni dell’educatore portatore del progetto con gli altri soggetti del percorso
educativo, in quest’ultimo decennio si sta poi assistendo a una problematica nuova: sia il mondo dei servizi sociali che quello della scuola è caratterizzato da un fortissimo turnover di persone, per cui i tuoi interlocutori all’interno del progetto cambiano magari ogni anno, e questo rende complicatissimo poter avviare dei percorsi efficaci. Mentre prima la continuità, la spina dorsale, era costituita dalla parte pubblica, e il non profit faticava a dare continuità alle sue persone, ora le cose si sono ribaltate: nella nostra comunità territoriale siamo noi la “memoria storica”.
Qual è invece la relazione che si instaura con le famiglie, con i bambini e i ragazzi, i cosidetti “beneficiari” dei progetti?
Noi, come cooperativa, abbiamo la fortuna di vivere nel quartiere, siamo una realtà attiva qui da trent’anni, le famiglie ci conoscono e sanno che le possiamo accompagnare per un pezzo di strada più o meno lungo, per problematiche più o meno gravi, e le possiamo aiutare a orientarsi anche rispetto ad altri soggetti che - appunto dicevano - cambiano frequentemente “volto”. Soprattutto, il plus dell’educatore della cooperativa rispetto ad altri attori sociali è che dall’educatore le famiglie non si sentono giudicate o valutate. Questo spazio di sospensione del giudizio aiuta a stabilire relazioni più dirette, vere, che vanno al cuore delle
questioni. Possiamo lavorare su un aggancio più informale.
Quali sono le problematiche più urgenti che riguardano la professione dell’educatore?
Un tema che sta emergendo con un urgenza, e che è stato affrontato anche nelle comunità di pratiche, è quello dello squilibrio di genere che condiziona questa professione. Oggi il 96% delle figure di educatori professionali che esce dall’università sono donne. Si continua, culturalmente, a intendere questa professione come una professione di cura, di accudimento materno, un modello ancora fermo agli anni ‘50’60 del Novecento, con uno spostamento della professione che rischia di appiattire soltanto sulla cura, e sulla cura maternage, un ruolo che invece è molto più complesso e molto più ampio. Questo apre dei rischi anche rispetto a quelle che sono le funzioni dell’educatore oggi. Penso all’educativa di strada e all’apporto pedagogico-educativo, per il quale serve dare ai bambini e ai ragazzi che si incontrano modelli più equilibrati, una sensibilità più plurale e non monolitica. Soprattutto quando si agisce in comunità più complicate, dove magari ci sono situazioni relazionali anche sul ruolo uomo-donna molto definite, e il fatto di non poter proporre dei modelli diversi del ruolo maschile toglie delle opportunità di confronto e di crescita ai ragazzi.
4 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ
E SVILUPPO DELLE
COMUNITÀ EDUCANTI
Il concetto di “Comunità Educante” è uno dei temi chiave sul quale si basano i bandi promossi dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Secondo questa visione, la comunità educante comprende l’insieme dei soggetti coinvolti nella crescita e nell’educazione dei minori: in primis scuola e famiglia, ma anche organizzazioni del Terzo settore, privato sociale, istituzioni, società civile, parrocchie, università, oltre (e a partire da) i ragazzi stessi, naturalmente. Comunità educante è insomma l’intera collettività che ruota intorno ai più giovani. Una comunità che cresce “con” loro, e non solo “per” loro; che educa gli adulti del domani, ma che si fa anche educare e cambiare da loro. È un tema vastissimo, ed è su questo tema trasversale a tante progettualità, e sullo strumento poi specifico del patto educativo di comunità (che ha avuto una larga diffusione grazie al richiamo che ne è stato fatto dal Ministero dell’Istruzione nel Piano scuola 2020-2021, contenente le indicazioni per la ripresa delle attività scolastiche nel primo anno scolastico dopo il lockdown nazionale imposto per il contenimento dei contagi da Covid-19), che si sono sviluppati
i confronti delle comunità di pratiche di tutte le macro-aree territoriali. Ben prima delle circolari ministeriali, infatti, si erano diffuse pratiche cooperative che promuovevano patti tra i diversi attori educativi, andando al di là e oltre della “semplice” interpretazione data dal Ministero. Il confronto all’interno delle comunitò di pratiche è ripartito da questo senso più ampio, dall’urgenza di intervenire sul rapporto tra scuola e fuori scuola, più in generale sul senso della presenza dell’educatore a scuola. «La necessità di un dentro e di un fuori, del formale e dell’informale, di didattica e di educazione: in questa logica orizzontale ognuno mette le proprie competenze e non c’è nessuno che vale più di altri, altrimenti si resta nella dinamica per cui si chiama l’educatore quando c’è il “problema”» .
Come è stato ribadito più volte negli incontri delle comunità di pratiche, il patto educativo di comunità può assumere un valore molto superiore se usato per formalizzare alleanze territoriali tra scuole, enti locali, soggetti del terzo settore e del civismo attivo mirate alla costruzione di “comunità educanti”, dove la cura dei diritti e dei percorsi scolastici ed educativi delle bambine e dei bambini, delle e degli adolescenti viene assunta come responsabilità
collettiva tra scuola e fuori. «Nei patti educativi vi è quindi una base minima di soggetti che dovrebbero starci, che man mano si allarga: l’educazione delle bambine e dei bambini è da concepire come “bene della comunità”» .
I patti non sono, quindi, una procedura avviata a valle di circolari ministeriali, né pensati per svilire la funzione pubblica della scuola attraverso la delega ad altri della propria responsabilità educativa: sono piuttosto il momento in cui la funzione di istruzione e di formazione alla comprensione del mondo contemporaneo, a cui il sistema scolastico pubblico deve rispondere, si arricchisce delle specificità e delle chiavi di lettura che la dimensione educativa più largamente intesa suggerisce, favorendo lo sviluppo delle capacità di bambine/i e adolescenti e la crescita delle competenze di cittadinanza di tutte e di tutti. «Si tratta di uno strumento di costruzione della comunità educante che va nella direzione di legittimare, “fissare”, regolare, rendere minimamente stabili le alleanze tra scuola, amministrazione pubblica e le realtà del Terzo settore» .
I patti declinano sul piano educativo il principio di sussidiarietà dell’art. 118 della Costituzione, consentono una programmazione condivisa e permettono di consolidare connessioni tra le reti locali (reti informali, Terzo settore,
scuole, istituzioni, commercianti), promuovendo il ruolo e la consapevolezza educativa di tutti gli attori e spesso coinvolgendo le famiglie con maggiore e stabile protagonismo che in passato.
Vi è la consapevolezza che questo strumento funziona se diventa il risultato di un processo, più che un punto di partenza. Il rischio, altrimenti, è che rimanga un atto formale, slegato dalla riflessione sui bisogni concreti e sui processi di rete. Ne è riprova anche il fatto che i patti di comunità sorti formalisticamente come esecuzioni delle circolari del Ministero non hanno avuto vero sviluppo nei territori. «Non esiste un modello unico per un patto educativo, ma l’elemento imprescindibile è quello di partire dal basso (attori e bisogni) e il dialogo costante tra istituzioni e territorio» .
Emerge come elemento importante la presenza di un ingaggio reale degli Enti del settore pubblico. Questo significa anche ricordare alla cooperazione il ruolo politico che agisce sul territorio, inteso non come rappresentanza, ma come sollecitazione del pubblico e delle istituzioni al loro ruolo sul territorio e alla loro responsabilità. È centrale il ruolo del Terzo settore, quindi, come sensibilizzatore, promotore di una cultura partecipata, massa critica per un cambiamento delle istituzioni sociali, motore di sussidarietà, costruttore di sinergia pubblico e privato per finalità pubbliche.
«I ritmi diversi sono dovuti anche ai ruoli diversi: forse è necessario indagare non tanto chi è più lento e chi è più veloce, ma trovare un ritmo compatibile per tutti, perché ci sono delle scuole molto più avanti degli enti locali e a volte anche del Terzo settore» .
Infine, c’è il tema del radicamento: la comunità educante - e i patti che ne formalizzano (anche solo in parte) il funzionamento - deve essere radicata in un territorio circoscritto, così da poter fare leva sugli elementi di appartenenza identitaria di un contesto delimitato e sullo spirito di comunità locale, legandoli all’apprendimento formalizzato, a quello informale e non formale e alla cura dei beni comuni, nonché ai processi di attivazione/capacitazione. «I patti non sono fiori di campo ma fiori di serra. I patti vanno manotenuti, riscaldati e curati, non solo sul piano tecnico-professionale ma anche sul piano relazionale ed emotivo per far crescere il senso di appartenenza» .
Gli aspetti che rendono i patti educativi efficaci sono:
• l’adozione di una prospettiva di medio-lungo periodo, superando la dimensione dell’intervento emergenziale;
• il coinvolgimento di una significativa rappresentanza delle famiglie;
• la chiara identificazione e distinzione dei ruoli delle
funzioni previsti, a partire dal meccanismo di governance e dalla presenza di figure deputate alla facilitazione della rete;
• il coinvolgimento autentico del pubblico, dalla costruzione di una relazione stabile e paritaria con le scuole al riconoscimento da parte degli enti locali del lavoro di rete, alla previsione di integrare il lavoro della rete con la programmazione territoriale;
• nel caso di presenza di spazi comunitari, riconoscere delle priorità e degli obiettivi condivisi per la gestione degli spazi, superando le logiche di competizione;
• l’adozione di un linguaggio chiaro e trasparente e di meccanismi di condivisione e confronto in itinere regolari e inclusivi;
• la previsione di spazi per la condivisione dei risultati, la comune riflessione, anche in chiave formativa, e l’auto-valutazione del lavoro svolto.
Gli aspetti che invece ostacolano i patti e li rendono difficoltosi sono:
• i limiti del sistema scolastico, indipendenti dalle volontà dei singoli: il turn over dei dirigenti nelle scuole, la scarsità di risorse economiche a disposizione per il personale amministrativo, la rigidità del calendario annuale e delle normative (es. per la privacy o per la sicurezza);
• aspetti organizzativi dei sistemi complessi: sottostima del
lavoro di coordinamento delle reti, tempi di lavoro diversi tra i partner, difficoltà di gestione di reti ampie;
• il rischio di autoreferenzialità nel formalizzare pratiche già esistenti, rafforzando le collaborazioni tra enti a vocazione tradizionalmente educativa, ma senza coinvolgere tutti gli attori formali e non formali sul territorio, in modo da garantire una crescita comunitaria reale e un maggiore impatto degli interventi;
• l’ancora parziale riconoscimento del valore educativo, e non solo di conciliazione familiare, dei servizi per i bambini di età 0-3 anni;
• la difficoltà delle amministrazioni locali e delle scuole a far veramente proprie le azioni proposte, seppur co-progettate con loro e sviluppate su loro indicazione, e di integrarle appieno nei percorsi didattici e formativi, superando la logica del “progettificio”;
• la mancanza di un monitoraggio della sottoscrizione dei patti in Italia e della pluralità delle esperienze che stanno rappresentando.
In generale, tutti gli incontri delle comunità di pratiche focalizzati sul tema dei patti educativi sono stati sempre molto partecipati e ricchi di stimoli, ciò dovuto anche all’interesse nei confronti di un tema complesso e in divenire.
Senz’altro hanno rappresentato per i partecipanti
un’occasione di confronto attivo per coglierne alcune dimensioni operative che motivano a immaginare possibili scenari nei propri territori e per, in alcuni casi, muovere primi passi per renderli fattivi.
Nel ragionare su come sollecitare i territori verso il valore del lavorare in rete è stato riconosciuto un lavoro culturale importante svolto da Con i Bambini. Questo ha portato a ragionare sull’importanza di relazionarsi al di là del rapporto ente finanziatore/progetto, come avviene all’interno delle comunità di pratiche. I partecipanti vedono in Con i Bambini un soggetto importante per sollecitare e fare advocacy su questo tema a livello nazionale.
È emersa poi l’importanza di “ripartire dal piccolo” per generare impatto, come promosso dal bando per le Comunità educanti. Vi è stato anche il riconoscimento di un’opportunità di confronto capace di ‘andare oltre il fare’ e costruire una cultura comune nella lotta alla povertà educativa.
Tra le proposte emerse:
• sarebbe importante inserire in un eventuale vademecum una parte relativa allo sviluppo e all’esercizio delle competenze collettive.
• i bandi molto spesso creano competizione, mentre sarebbe interessante prevedere da parte di Con i Bambini una formazione rispetto alle competenze collettive necessarie alla definizione dei patti.
• PATTI EDUCATIVI •
La cassetta degli attrezzi
Come dare sostanza e sviluppo ai Patti educativi di comunità?
• Il punto di partenza è la definizione della comunità territoriale e l’analisi puntuale e condivisa del contesto e dei bisogni che le sue componenti esprimono.
• Costruire un linguaggio comune sui contesti e le modalità di apprendimento e crescita da parte di bambini e ragazzi.
• La dimensione del patto è determinata dai bisogni. Spesso sono più efficaci patti ristretti e fondati su reti del possibile e obiettivi concreti perché devono rispondere, in prima istanza, ai bisogni di un territorio che ha le sue specificità ed emergenze.
• Il patto si deve configurare come un patto intergenerazionale, che dia voce ai ragazzi, protagonisti e co-costruttori dei propri diritti.
• Il ruolo del terzo settore è centrale, in virtù della sua prossimità alle situazioni di bisogno e delle sue competenze di ascolto e mediazione, di raccordo e di gestione della complessità.
• Occorre coinvolgere necessariamente l’ente pubblico, ribadendone le responsabilità.
• La figura del coordinatore è importante, in quanto garantisce il presidio e la governance del patto.
• Gli spazi e i presidi possono entrare nel patto e offrire opportunità di dialogo a professionalità diverse (es. architetti e insegnanti/operatori, educatori, psicologi ecc.).
Il rapporto tra scuola e Terzo settore
Le scuole sono chiamate a sviluppare, anche in raccordo con gli altri soggetti del territorio (Enti locali, enti di Terzo settore, Centri per l’impiego), progettualità di ampio respiro per il miglioramento e l’arricchimento dell’offerta educativa, che tengano conto delle buone pratiche già in campo, evitando sovrapposizioni e curando anche l’integrazione tra risorse e dispositivi già in essere. Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore avviene attraverso forme di co-progettazione. Le scuole valorizzano, inoltre, il ruolo delle famiglie, rafforzando il rapporto tra genitori e insegnanti, anche con l’offerta di occasioni di formazione e partecipazione, per prevenire possibili conflitti scuola-casa e favorire ogni sinergia tra gli adulti.
Emerge tuttavia dai confronti in seno alle comunità di pratiche che non sempre gli interventi e le proposte che si portano nelle scuole sono accolti: le scuole hanno una serie di incombenze e procedure che le affaticano e spesso vivono una concorrenza tra progettualità simili e vi sono anche conservatorismi e rigidità burocratiche che oltre a limitare le stesse potenzialità formative della scuola limitano le sinergie educative con il territorio.
È necessario avere all’interno della scuola un riferimento per il Terzo settore e/o che sappia facilitare con pazienza le possibilità sinergiche riconoscendo al contempo i diversi ruoli e le differenti funzioni.
I docenti, è evidente, vivono una condizione di costante “affaticamento”, che li porta spesso a perdere la motivazione e lo slancio, necessari per la loro professione. Insegnare non è soltanto un’operazione di accrescimento informativo: alunni e bambini portano con sé la loro storia personale, caratterizzata da curiosità, desiderio e gioia, così come da paure, difficoltà e disadattamento variamente espresso. Il salto concettuale da una scuola “insegnante” a una scuola “educativa” pone ulteriori ma inevitabili fatiche.
Il docente assume spesso la delicata funzione di conoscere la realtà interna, esterna, culturale, sociale e ambientale di tutti i suoi alunni, tiene conto di tutti gli elementi interagenti. «A volte le scuole sono oberate di proposte ed è difficile scegliere le offerte migliori».
È opinione condivisa nei gruppi il fatto che I progetti finanziati da Con i Bambini abbiano arricchito l’approccio e le opportunità per la scuola, i ragazzi e le famiglie. I progetti in molti casi hanno fornito stimoli, input importanti e preziosi. Si evidenzia che la pandemia è stato un elemento che ha svolto un ruolo di collante: gli enti di Terzo settore hanno portato grande benessere agli alunni costretti a stare a casa. Le scuole avrebbero perso tanti più alunni se non ci fossero stati gli operatori degli enti di Terzo settore disponibili a collaborare.
• RELAZIONE CON LE SCUOLE •
La cassetta degli attrezzi
Strategie utili per strutturare una relazione virtuosa con le scuole.
• Occorre partire dall’ascolto dei bisogni della realtà scolastica locale, facendo una accurata analisi, propedeutica alla costruzione di un rapporto di interdipendenza e alla valorizzazione delle competenze del Terzo settore. Occorre evitare di lasciare al Terzo settore solo l’azione per i casi emergenziali, che la scuola non sa gestire, ma costruire insieme interventi preventivi e stabili sinergie fondate sul riconoscimento reciproco.
• Intendere la co-progettazione sia in senso strettamente educativo, sia in senso organizzativo. Le proposte devono essere sostenibili per le amministrazioni scolastiche e per il carico di lavoro degli insegnanti. Non gravare la scuola di procedure amministrative per la rendicontazione agli enti finanziatori; limitare al massimo anche la modulistica da far compilare ai genitori dei bambini e ragazzi coinvolti.
• Lavorare sulla continuità delle iniziative promosse, indipendentemente dal dirigente presente. È fondamentale stabilire un linguaggio condiviso e buoni contatti con gli insegnanti, che possono poi far leva su eventuali nuovi dirigenti.
• Sollecitare la scoperta di risorse del territorio; ascoltare e condividere insieme problemi e iniziative; produrre mappe del territorio per permettere alla scuola di “andare fuori” e al fuori di entrare dentro.

LA VOCE DAL CAMPO
Daniela Cattivelli
“Per fare comunità educanti servono connessioni forti”
Daniela Cattivelli è coordinatrice della Cooperativa sociale La Comunità, capofila a Genova del progetto Co.Di.C.E (Connessione di Comodità Educante), un partenariato vasto e articolato che ha lavorato sul diversi fronti, dalla rigenerazione di spazi a cura dei ragazzi delle scuole alla cura dei beni comuni, alla tessitura di reti nelle comunità, alla formazione del nuovo profilo professionale del facilitatore di Comunità Educante.
Daniela, proviamo a dare un perimetro al concetto di comunità educante. Che cosa si intende?
Possiamo definire la comunità educante una collaborazione tra realtà che, in un determinato territorio, partecipano ai percorsi di crescita e di educazione di bambini, adolescenti e ragazzi, con l’idea che una bambina o un bambino non siano patrimoio solo della sua famiglia, ma dell’intera comunità. Una comunità che va dai soggetti istituzionalila scuola in primis, il Comune, i servizi sanitari -, a quelli
che operano nell’ambito dell’educazione, il Terzo settore, le associazioni sportive, i comitati di quartiere, i commercianti, fino alla comunità tutta, perché i cittadini stessi, nel momento in cui partecipano della vita della comunità, contribuiscono a trasmettere dei valori educativi. Come è emerso nelle comunità di pratiche, la comunità educante assume forme diverse a seconda delle situazioni particolari dei diversi territori, ma a restare ferma è la mission: fare un lavoro collaborativo per dare un contesto di crescita positivo, sano, alle nuove generazioni.
Come si dà concretezza, si istituzionalizza, questo approccio al ruolo della comunità tutta verso i minori, questa mission partecipata?
Il concetto di comunità educante è un concetto che, a livello teorico, appare forse molto astratto, ma se si entra nelle esperienze che sono state condivise con altri progetti nelle comunità di pratiche, emerge una grande varietà di linee di intervento. Poi è vero che la comunità educante diventa tale quando si dà vita a spazi di confronto, a spazi di progettazione comune, perché in partenza non ci sono delle strutture formali che in qualche modo riconoscano il lavoro della comunità educante. Gli strumenti bisogna crearli. Per esempio, nell’attuazione del nostro progetto Co.Di.C.E, abbiamo formato la figura del “facilitatore di
comunità educante”, per rispondere al problema della mancanza di un ruolo di regia, di coordinamento in rete delle attività e di manutenzione della rete. Su ogni territorio ogni soggetto fa attività, ma lo fa spessissimo in maniera autoreferenziale, manca una connessione che ne rafforzi il valore, manca una capacità di co-progettazione. Per questo, abbiamo organizzato un percorso di formazione per una decina di educatori, con degli esperti in facilitazione, degli esperti anche di beni comuni, ecc, per avere persone che sapessero creare connessioni all’interno della comunità educante. In altre parti d’Italia sono stati istituiti dei tavoli di confronto periodici tra cittadini, associazioni, scuole, istituzioni, che sono diventati tavoli di pensiero ma anche di progettazione. Le formule che sono emerse sono diverse.
Parlando di comunità educante, il primo pensiero corre al ruolo della scuola...
La scuola, paradossalmente, resta come istituzione un soggetto difficile e complesso da coinvolgere. Non perché manchi la volontà da parte di dirigenti scolastici e insegnanti, anzi, ma da un lato per motivi contingenti - manca il tempo, mancano le risorse, mancano le persone, mancano le coperture contrattuali - dall’altro perché nelle scuole è difficile trovare la cultura del lavoro in rete. Si riesce a lavorare con la scuola quando la scuola chiama a rispondere a
un bisogno specifico - mi serve un aiuto per l’affiancamento ai ragazzini stranieri - ma se si cerca di coinvolgere gli istituti in percorsi di coprogettazione sorgono le complessità.
Quanto le famiglie sono parte della dinamica di una comunità educante?
Ci sono comitati, gruppi di famiglie danno un apporto importante. Guardando ai nostri progetti, ma è un elemento emerso più volte nelle comunità di pratiche, le famiglie più coinvolte in maniera costruttiva in questo momento sono le famiglie - diciamo così - più fortunate, più consapevoli, più abituate a fare un lavoro anche culturale sul territorio. Le famiglie delle fasce più fragili, invece, sono portatrici di bisogni, ma bisogna ancora lavorare molto per far comprendere che sono o possono essere anche protagoniste positive. Per questo si lavora tanto sul coinvolgimento, sulla proposta di momenti conviviali, feste etniche, cene insieme, allargare i momenti di spontaneismo da cui nascono relazioni, amicizie, una prima tessitura di rete. In queste occasioni, noi del terzo settore dobbiamo essere bravi a fare un passo indietro, fornire “supporto tecnico”, ma poi lasciare che i protagonisti siano le famiglie, i cittadini.
E qual è il ruolo dei bambini e dei ragazzi?
Devono essere i protagonisti della comunità educante,
non - come si dice - i beneficiari, soggetti che stanno a valle delle decisioni e azioni fatte da altri.
Ma si riesce davvero?
Ci proviamo. All’interno del nostro progetto CODICE insieme a gruppi di ragazzi delle scuole medie, indicati dalle scuole come “fragili” abbiamo dato vita a progetti partecipati molto belli, e pensati da loro: l’abbellimento della palestra della loro scuola, la cura di aree verdi vicine agli istituti, la progettazione di un’area giochi in un parco pubblico... Ormai si è creata una strana dinamica, gli adulti danno per scontato che bambini e adolescenti siano soggetti passivi, ma forse perché è più comodo pensare così che non mettersi di fronte a loro e chiedere: bene, voi che cosa vorreste ci fosse in questo parco? Quando glielo chiedi, rimangono spiazzati, non sono abituati a essere chiamati a portare le loro idee, crescono pensando che quel dicono loro, tanto, non conta, che agli adulti non interessa. Per farli crescere come protagionisti della comunità educanti i ragazzi vanno coinvolti nella fase di proposta, non quando c’è da “eseguire” un progetto.
Il lavoro fatto nelle comunità di pratiche ha aperto nuove prospettive allo sviluppo delle comunità educanti?
Molti. Almeno, io opero nel sociale da trent’anni, e ho
trovato in questi momenti di confronto stimoli e spunti nuovi, molto concreti, “pratici”, appunto. Per esempio, le modalità per coinvolgere nelle comunità educanti anche le aziende del territorio, non solo banalmente come sponsor di attività ma come risorse anche di idee e di modalità di progettazione. O il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca, che qui a Genova non mancano, ma abbiamo sempre considerato dei mondi a sé, lontani dal tessuto delle comunità territoriali.
5
IL BENESSERE PSICOLOGICO
DEGLI ADOLESCENTI: STAR BENE
CON SÉ, FAR BENE CON GLI ALTRI
Nei mesi di aprile/giugno 2022, durante la fase di elaborazione del bando sul disagio psichico e psicologico degli adolescenti avviato poi nel settembre del 2023 e che ha preso le mosse da una lunga fase di ascolto dei bisogni di bambini e adolescenti, quattro incontri delle comunità di pratiche sono stati dedicati al confronto sul tema delle criticità e fragilità relative al benessere psicologico dei minori. Emergenza che, purtroppo, ha visto un’accellerazione preoccupante dopo la lunga fase di lockdown e di restrizioni sanitarie legate al Covid-19, che hanno letteralmente sconvolto abitudini, atteggiamenti e pensieri di bambini e adolescenti.
Negli incontri sono stati coinvolti, in modo mirato, operatori attivi nei progetti finanziati dai bandi Adolescenza 2016, Nuove generazioni 2017 e Un passo avanti 2018, in particolare pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti, oltre a educatori e docenti.
Dai territori sono emerse due macro categorie di
manifestazioni del fenomeno: sintomi depressivi/autolesivi e tendenza all’isolamento sociale (verso sé stessi); sintomi con agíti aggressivi e prime condotte nei circuiti dell’illegalità (verso l’esterno/gli altri), con bande giovanili.
Nello specifico, tra i comportamenti più diffusi vi sono:
• comportamenti problematici: aggressività fisica e verbale, diminuzione di autocontrollo, difficile sopportazione della frustrazione;
• difficoltà relazionali che si manifestano tramite ansia (soprattutto rispetto al confronto e al giudizio, non solo di persona, ma anche sui social) o vissuti depressivi che portano mancanza di energia, apatia e difficoltà a riconoscere le emozioni proprie e altrui;
• agìti anticonservativi, autolesionismo, ritiro sociale, abbandono scolastico, uso di sostanze psicotrope e abuso di sostanze alcoliche.
Dopo l’inizio della pandemia tali manifestazioni hanno avuto un forte aumento nella fascia d’età pre-adolescenziale. Le manifestazioni in molti casi risultano subito acutesi registra, per esempio, anche un aumento dei tentativi di suicidio - e costringono a risposte tempestive e “emergenziali”, come l’utilizzo di psicofarmaci. Diventa invece sempre più difficile fare prevenzione.
Le fragilità profonde che si celano dietro a queste manifestazioni, tuttavia, non possono essere ricondotte solo alla pandemia, che ha agito più che altro da acceleratore di un processo già in atto, quanto piuttosto a cambiamenti in corso nella società, nei modelli educativi prevalenti e nelle dinamiche relazionali, sia per gli adulti, sia per gli adolescenti.
Tra queste diverse dinamiche, quelle emerse durante gli incontri delle comunità di pratiche dedicate al tema sono state, in maniera più ricorrente:
• il dileguarsi della presenza di figure di riferimento adulte per gli adolescenti, a partire dai genitori. L’assenza del mondo adulto va intesa sia come assenza fisica, sia come assenza di interesse: mancano strumenti, ad esempio per mediare l’accesso al digitale, pensati per gli adolescenti, mancano riferimenti agli adolescenti nel discorso pubblico, manca dialogo e, al contempo, presidio delle regole e dei limiti;
• la forte pressione sociale che il sistema di valutazione scolastico e la proiezione verso la carriera lavorativa esercita su ragazzi e ragazze;
• l’aumento dell’importanza dell’esposizione di sé sui social e di una narrazione iper-positiva di sé;
• la fluidità che caratterizza le relazioni, amicali e familiari, e le identità di genere.
Questi fattori, uniti all’interruzione repentina e spesso definitiva di attività extrascolastiche, all’irrigidimento del sistema scolastico e alla parallela fluidità tra esperienza virtuale e in presenza, al ridottissimo confronto, intrinseco della fase adolescenziale, con i coetanei rispetto ai cambiamenti del proprio corpo e della propria personalità, hanno reso in molti casi strutturale un disagio che fino a qualche anno fa era transitorio. Come è stato più volte ribadito dagli esperti nel corso dei dialoghi, è importante prestare attenzione come si parla del disagio giovanile: le estremizzazioni e l’enfatizzazione del problema, più che offrire spazi di aiuto, rischiano di creare allarmismo e rafforzare lo stigma che già caratterizza i portatori di un bisogno di tipo psicologico o psichico. È necessario un equilibrio tra offrire spazi e opportunità di ascolto, autenticamente dialogiche, nominando il problema senza timore, e una strumentalizzazione mediatica del malessere giovanile.
I ragionamenti sviluppati all’interno delle comunità di pratiche hanno contribuito alla definizione del bando lanciato poi nel settembre 2023 e tuttora in corso, sul “Benessere psicologico e sociale degli adolescenti”, volto a promuovere - con un ammontare complessivo di 30 milioni di euro - progetti a sostegno di ragazze e ragazzi in condizioni di disagio, con un’azione preventiva e di cura attraverso la sperimentazione di modelli di intervento comunitari.
• BENESSERE PSICOLOGICO •
La cassetta degli attrezzi
Dagli incontri delle comunità di pratiche dedicati al tema del benessere psicologico e sociale degli adolescenti sono emerse le seguenti indicazioni e apprendimenti concreti.
• Individuare nella pro-socialità una importante forma di prevenzione e dunque incoraggiare e ampliare le opportunità di aggregazione e socializzazione.
• Fondamentale è il raccordo tra servizi e attori diversi nel riconoscimento, nella segnalazione e nella presa in carico dei ragazzi e delle ragazze portatori di bisogni di tipo psichico e psicologico. È necessaria una grande flessibilità e disponibilità da parte anche dei servizi pubblici di uscire dai propri schemi per avvicinare i ragazzi.
• Interrogarsi e sperimentare modalità nuove di intercettazione del bisogno e di aggancio. I luoghi di ritrovo dei ragazzi sono mutati (non più la strada o la piazza) e, nel caso del ritiro sociale, l’aggancio può essere ad esempio sul web.
• Pensare l’intervento educativo in maniera personalizzata, coordinata e condivisa, partendo dai bisogni e dai desideri dei beneficiari. Un lavoro per piccoli gruppi, ad esempio, spesso è molto efficace per fronteggiare il problema dell’isolamento sociale.
• Offrire l’opportunità di esperienze di senso e dotate di concretezza, per consentire ai ragazzi di ricollegarsi con le proprie emozioni, col proprio corpo e sperimentare le proprie competenze in una dimensione
reale e, magari, poco conosciuta o accessibile in autonomia.
• Dove necessario, per la presa in carico dell’intero nucleo familiare è importante che gli operatori siano disponibili a ripensare e ristrutturare il proprio setting di lavoro. È importante garantire spazi e competenze specifiche ai genitori e gruppi dove i genitori stessi si possano confrontare tra loro. È fondamentale l’intervento educativo, che richiede anche darsi il tempo necessario, tempo che, a volte, i genitori faticano ad accettare.
• Rinnovare il dialogo intergenerazionale, coinvolgendo e responsabilizzando anche attori diversi da quelli tradizionalmente svolgono la funzione educativa (es. artigiano, commerciante…).

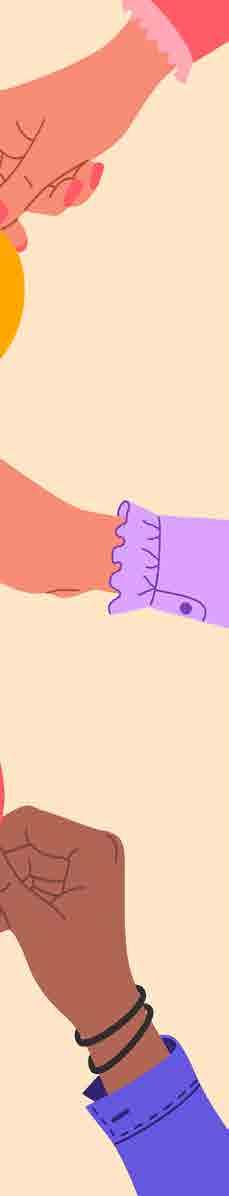
Le sfide future e la voce degli stakeholder
Una consapevolezza costruita sul campo
In tre anni di incontri e confronti, la pratica delle comunità di pratiche ha dimostrato di essere uno strumento importante per promuovere e consolidare, in tutti i professionisti e le realtà coinvolte nei progetti sostenuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la consapevolezza di agire all’interno di un orizzonte che va oltre il proprio perimetro territoriale. E ha dato un assist forte alla condivisione del valore del lavorare in rete, del rompere i confini di autoreferenzialità o di rivalità che ancora limitano la piena espressione di buona parte del Terzo settore italiano.
La consuetudine al dialogo, al confronto, allo reciproco che via via gli incontri dei gruppi delle comunità di pratiche ha consolidato rappresenta, al di là dei temi specifici affrontati, un modus operandi che di per sé rappresenta un obiettivo raggiunto. Una messa in relazione e in connessione destinata a produrre effetti virtuosi, e probabilmente in modi e forme inaspettate, che portano una ricaduta positiva sui singoli progetti, ma più in generale sulla modalità di approccio culturale al proprio impegno e compito all’interno dello smisurato territorio dei bisogni, delle fragilità e della povertà educativa.
Le sfide aperte
Avendo aperto nuove frontiere, come sempre accade, il percorso delle comunità di pratiche svolto tra il 2020 e il 2023 ha anche indicato una serie di nuovi possibili sviluppi e di sfide da cogliere per rendere ancora più produttivo ed efficace questa modalità di crescita condivisa. Provando a fare sintesi tra gli stimoli emersi, e la lettura che Con i Bambini fa dell’esperienza svolta, si possono individuare tre obiettivi che possono caratterizzare l’impegno sul futuro delle comunità di pratiche.
1. Ampliare i confini delle comunità di pratiche e riuscire a coinvolgere in maniera sempre più stabile e continuativa ai gruppi di lavoro soggetti “esterni” alle realtà non profit: referenti del mondo della scuola, della sanità, degli Enti locali, affinché anche questa galassia di soggetti che attualmente rappresentano gli “stakeholder” dei progetti attuati diventino parte anche delle fasi di riflessione e di costruzione della cultura del progetto. Oltre a portare un deciso arricchimento all’interno dei confronti, la presenza organica di questi interlocutori rafforzerebbe anche la funzione di advocacy che le comunità di pratiche possono svolgere, e facilitare così la considerazione, l’attenzione e lo sviluppo pratico dei progetti nei diversi territori.
2. Accompagnare le comunità di pratiche a una progressiva “indipendenza” rispetto allo schema fino a oggi impiegato che prevede un “soggetto promotore” (Con i Bambini) e dei facilitatori/facilitatrici che tengano le fila, gestiscano e indirizzino i percorsi e i momenti di confronto. È pensabile e auspicabile che la modalità di confronto e di dialogo costruttivo tra enti instaurata dalle comunità di pratiche nel triennio sperimentale di avvio dell’esperienza diventi un approccio spontaneo tra realtà che operano nello stesso territorio o su una stessa tematica, diventano uno strumento di quello spirito collaborativo che migliora l’efficacia e la sostenibilità degli interventi progettuali.
3. Essere un luogo di riflessione qualitativa sui progetti. Rispetto al ruolo e ai compiti di ideazione, indirizzo e misurazione proprio di Con i Bambini, le risultanze che emergono dagli incontri delle comunità di pratiche - pur conservando il loro dna di spazi di confronto aperto e non-giudicante - possono essere elementi da mettere in correlazione con le risultanze che emergono dai processi di valutazione di impatto che vengono effettuate su ogni progetto. Le evidenze prodotte dalla misurazione tecnica possono cioè essere lette anche attraverso la lente delle evidenze che emergono - sullo stesso tema - dal dialogo informale che si sviluppa nelle comunità di pratiche, e che possono così assumere nuove e più ricche sfumature di interpretazione, capaci di orientare ancora meglio le riflessioni ex-post.
La voce degli stakeholder
La voce degli stakeholder
Se pur con un coinvolgimento ancora limitato in questa prima fase di sperimentazione delle comunità di pratiche, i diversi soggetti istituzionali (Enti locali, scuole, aziende sanitarie locali, ecc...) costituiscono un interlocutore importante per rendere ancora più ricco ed esauriente il confronto rispetto a percorsi di collaborazione che rappresentano già un terreno comune.
Attraverso le voci di due realtà diverse per ambito e contesto, abbiamo approfondito il punto di vista sul senso che le comunità di pratiche possono avere per questi stakeholder.,

Barbara Trupiano
Dirigente del Servizio Sistema educativo, Comune di Napoli
«Le comunità di pratiche sono un filo diretto con la realtà»
Dottoressa Trupiano, dal punto di vista dell’Ente
Pubblico, qual è il valore delle comunità di pratiche?
I valori che emergono da questa sperimentazione delle comunità di pratiche sono diversi. Sono innanzitutto un’occasione, concreta e viva, per avere un punto di interconnessione tra il Comune e i tanti e diversi soggetti che operano su territorio e poter avere uno sguardo d’insieme su tutte le azioni in
atto. A Napoli con una difficoltà forse particolare, ma credo un po’ in tutte le città e territori in Italia, quel che manca quando si opera negli ambiti del sociale non sono le iniziative o le progettualità, quanto una capacità di visione d’orizzonte e di regia complessiva, che invece sono elementi fondamentali per evitare la dispersione di risorse e di energie, la duplicazione di interventi e la sovrapposizione degli attori in campo. O, magari, il non poter cogliere buone pratiche che funzionano per provare ad applicarle anche in contesti o di fronte a necessità simili. Anche questo rappresenta uno spreco che, sinceramente, a fronte di bisogni che continuano a crescere, non ci possiamo proprio permettere. Seconda aspetto, mi sembra che questi momenti siano utili per far cadere quelle barriere di autoreferenzialità e anche di competizione e fare in modo che tutti i soggetti coinvolti, del pubblico e del privato sociale, riescano ad allineare linguaggi, approcci, metodologie, lettura e rappresentazione sia dei problemi che delle proprie pratiche. Attraverso il dialogo che avviene anche nelle comunità di pratiche si superano queste problematiche che sono epistemologiche, metodologiche, culturali.
Quali sono gli insegnamenti utili per un soggetto istituzionale come il rappresentate di un Comune in questo contesto?
La lezione, ma anche il rammarico, è constatare che
nonostante i tanti anni di impegno e di lavoro sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, ci sia ancora tanto da fare per dare stabilità e per mettere a sistema il lavoro che si fa, insieme, sui territori, sulle particolarità territoriali. Manca ancora una sorta di piattaorma di riferimento comune che possa dare continuità ai percorsi, che non costringa ogni volta a ricostruire ex-novo modalità e relazioni. In questo senso il lavoro che Con i Bambini sta facendo è fondamentale. Non solo perché in questi anni sta iniettando nei territori tantissime risorse e quindi fa vivere le progettualità, ma perché sta aiutando anche gli Enti locali e di prossimità a ragionare nell’ottica delle reti e dell’integrazione tra le reti. Ci sta facendo vedere che intorno ai progetti che quel “valore aggiunto” in più che è dato dalle reti che intorno ai progetti si creano, e possono diventare una risorsa stabile, se pur spesso ancora informale. Una lezione che vale anche per le modalità operative e le organizzative interne all’Ente locale, dove prevale la frammentazione tra servizi - Istruzione, Servizi Sociali, Welfare, ecc - e invece bisogna far crescere una cultura di integrazione, tavoli di lavoro integrati tra più servizi. Questo aiuta anche il Comune ad affrontare e rispondere in maniera più organizzata ed efficace alle richieste delle non profit. Ragionare da subito insieme sui bandi, mettere in atto reali percorsi di co-progettazione, affrontare i temi in maniera organica, non essere solo il soggetto che risponde, all’ultimo momento
e in maniera frammentata, alle richieste di parternariato che arrivano a pioggia il giorno prima della chiusura di un bando...
Quale può essere una prospettiva di sviluppo per questa esperienza delle comunità di pratiche?
Un valore che già le comunità di pratiche hanno prodotto, e che va rafforzato, è la capacità di stimolare tutti, compreso il Comune, la scuola, la sanità, a stare al passo con i cambiamenti che i territori, che i quartieri producono. Sono un filo diretto con la realtà, una realtà che cambia rapidissimamente e molto prima che questo cambiamento venga “tradotto” in documentazione, in policy, in modelli di intervento. Il lavoro dei servizi sociali, della scuola, del non profit non avviene in un laboratorio protetto, ma avviene - ogni giorno - all’interno di una realtà che è spesso dura e complessa. Bisogna avere consapevolezza costante di questa realtà, saperla cogliere e dare risposte, ma bisogna anche essere coscienti del fatto che nessuno dei soggetti che opera o può operare può da solo portare una soluzione: di fronte alla povertà educativa, sociale, economica, culturale che vivono tanti bambini e ragazzi nella nostra città - e non solo - di fronte a una mancanza di legami, di lavoro, di prospettive, serve una presa in carico che sia la più ampia e completa possibile.

Tamara Novati
Responsabile dei Servizi 06 - Comune di Desio
«Un dialogo tra persone senza “etichette”»
Qual è il giudizio che ha maturato dopo l’esperienza delle comunità di pratiche cui ha partecipato?
Sono “entrata in corsa” nel percorso delle comunità di pratiche, ma pur con una partecipazione sporadica posso dire che avere un ambito all’interno del quale ci si confronta un maniera aperta su tematiche educative e pedagogiche, e lo si fa mettendo in condivisione specificità differenti, rappresenta un arricchimento per tutti, sia per le non profit stesse, sia per soggetti come per esempio un servizio comunale, o un dirigente scolastico. Sono momenti che ti costringono, e quindi ti aiutano, ad alzare lo sguardo, a uscire dalle problematiche del tuo contesto e a ragionare anche con gli occhi degli altri. Quel che noto, poi, sono le ricadute positive che questi momenti hanno sulle persone delle organizzazioni del Terzo settore che vi partecipano, e con le quali poi mi trovo a operare. Vedo che questi incontri portano linfa nuova, si vedono i benefici che derivano dal continuo scambio che avviene nelle comunità di pratiche.
Quello che è emerso da questo lungo viaggio nelle comunità di pratiche è che la presenza di soggetti istituzionali è sempre vissuta dai partecipanti del Terzo settore come una sorta di occasione particolare, come se voi foste “ospiti speciali” e non parte naturale del processo... Credo dipenda molto da chi partecipa e dal come partecipa, dall’atteggiamento con il quale noi “ospiti speciali” ci mettiamo in gioco in queste occasioni. Io forse rappresento un caso un po’ particolare, in quanto sono approdata in un Ente pubblico dopo un lungo percorso professionale svolto all’interno del non profit, quindi per me il modus operandi delle comunità di pratiche, il confronto collaborativo, la messa in comune di problemi e soluzioni è assolutamente naturale, fa parte del mio modo di approcciare il lavoro e la relazione, al di là del mio “ruolo” ufficiale. Comprendo però che la relazione tra non profit e Ente pubblico possa assumere diverse forme, a seconda di come il Comune decide di interpretare il proprio ruolo: ci sono realtà che accentrano lo sviluppo del progetto lasciando meno spazio al dialogo, altri invece che mettono in campo un coinvolgimento più ampio. Vero, poi, che la differenza la fanno sempre coloro che sono sul campo, sia lato-Comune che lato non profit. E quindi, anche per quel che riguarda le comunità di pratiche, la differenza la fa chi partecipa, non tanto “l’etichetta” o la carica che ha chi vi partecipa.
NUOVE BUONE PRATICHE
Povertà educativa e comunità educanti, gli apprendimenti delle Comunità di Pratiche promosse dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
A cura di Mattia Schieppati
In collaborazione con l’impresa sociale Con i Bambini www.conibambini.org
Un progetto
VITA Società Editoriale SpA impresa sociale
www.vita.it
Per approfondire le storie e i progetti sostenuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: www.conibambini.org www.percorsiconibambini.it www.nonsonoemergenza.it www.conmagazine.it
Questo volume è scaricabile gratuitamente dal sito vita.it
Stampa
AGF S.r.l. Unipersonale, Via del Tecchione 36, Sesto Ulteriano (MI)

