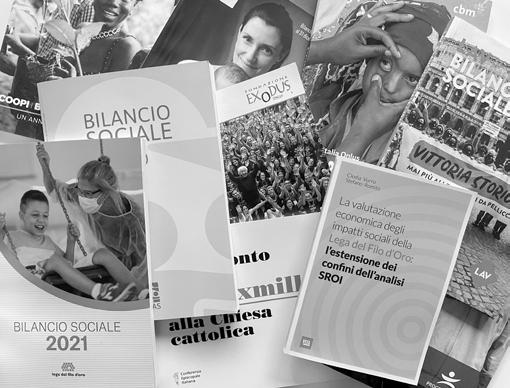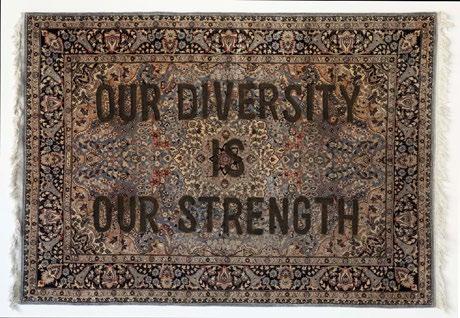6 minute read
Radiografia del regime
La società civile in Russia?
Gli avvenimenti accaduti in questi ultimi mesi in Russia, la decisione del tribunale di liquidare la più antica associazione per i diritti umani, il gruppo Moskovskij Hel’sinskij, l’iscrizione nel registro delle “Organizzazioni indesiderate” del Fondo Andrej Sakharov e il conseguente sfratto dai locali che occupava, così come l’iscrizione nello stesso registro di Medusa, il più popolare tra i portali di informazione indipendenti, che era già stato denunciato come “agente straniero” e l’accesso al cui sito era già stato bloccato dalle autorità (senza dimenticare l’eliminazione di Memorial, che si occupa della memoria storica delle repressioni staliniane, anch’esso inizialmente definito “agente straniero” e cui hanno tolto la sede in modo “illegale”) ci dicono che la società civile in Russia viene, di fatto, soffocata, schiacciata.
Advertisement
Se prima le autorità avevano bisogno di una legittimazione, che ottenevano grazie alle organizzazioni non governative e associazioni, ora, sullo sfondo della guerra in Ucraina, del patriottismo becero e della propaganda, non ne hanno più bisogno. Le maschere sono cadute. Il male allo stato puro ha mostrato il suo vero volto. La paura di perdere il potere muove Putin e chi lo circonda, la paura di trovarsi nel novero dell’indifesa minoranza dei dissidenti muove l’uomo russo, che non capisce ormai più nulla di ciò che sta accadendo. La paura è un’emozione molto potente, attraverso la quale il potere può controllare i propri cittadini, poiché esso sgorga da una solitudine ontologica e dall’apatia. Come è potuto accadere che le organizzazioni della società civile in Russia, il cui scopo era la difesa dei diritti umani, siano state di fatto silenziosamente distrutte senza che vi fosse nessuna reazione da parte del popolo?
Come è potuto accadere che le organizzazioni della società civile in Russia, il cui scopo era la difesa dei diritti umani, siano state di fatto silenziosamente distrutte senza che vi fosse nessuna reazione da parte del popolo?
La solitudine dell’uomo post sovietico è legata alla perdita della sua soggettività, all’assenza del desiderio di riconoscersi, di prendere coscienza di sé come persona. Questo processo di distruzione dell’umanità è durato 105 anni, ed è iniziato nel 1917 con la rivoluzione di ottobre. Tre, quattro generazioni hanno vissuto la propria intera vita in una condizione di straniamento da sé. Non stiamo parlando solo dell’assenza di libertà, ma anche della proibizione di godere la vita, di avvicinarsi alla bellezza. Mi ricordo gli ultimi mesi di vita di mio padre. Era già in ospedale e — con il suo benestare — ho invitato un sacerdote mio amico perché lo confessasse e gli portasse l’eucarestia. All’inizio della confessione non sono riuscito ad allontanarmi abbastanza, e ho sentito la risposta di mio padre alla domanda del sacerdote: «Come è trascorsa la tua vita?». Mio padre ha risposto: «Nel grigiore, senza felicità». Sono rimasto basito: come è possibile dire così, come è possibile vivere così? Purtroppo questa posizione resta in Russia quella della maggioranza della popolazione. Il breve ventennio di paradiso consumista non è riuscito a riscaldare e riempire il cuore delle persone. Ma come ha detto una cara amica, anche sotto questo mucchio di pietre il cuore continua a battere, a bussare. Forse i media e la società civile non hanno fatto tutto ciò che avrebbero potuto fare per risvegliare il desiderio nell’uomo post-sovietico. Trovandosi in una sfera intellettuale orgogliosamente chiusa, non sono stati in grado di mostrare e di raccontare alla gente l’autentica libertà del desiderio, che magari anche attraverso gli errori in un modo o nell’altro conduce sempre alla rinascita dell’umano. Lo schiacciamento che attualmente caratterizza la vita in Russia non può essere l’ultima parola: esiste una speranza. Lego questa speranza alla prima generazione post sovietica di giovani, quelli che ora hanno tra i 20 e i 25 anni. Ora si trovano in una condizione molto complessa di pressione da parte del potere. Da un lato sono chiamati ad uccidere, ad andare a combattere, e dall’altro non pensano nemmeno più alla costruzione di una società di tentazioni consumistiche, che copre di nebbia i desideri autentici, primo fra tutti l’esigenza dell’altro, degli uni verso gli altri. Possiamo dunque aspettarci manifestazioni di autentica solidarietà, di protesta sincera contro il male trasmesso dalle ciniche autorità russe, che non offrono niente altro che grigiore e assenza di felicità.
Monumento ad

Andrej Sakharov dalla pagina Facebook del direttore della
Fondazione Sakharov
Yuri Lukashevsk
Costretti all’interno di campagne di marketing tutte incentrate su “tipicità” ed “eccellenze” ormai esauste e dentro confini sempre più determinati da soli indicatori di efficienza amministrativa ed economie di scala che ne liquefano l’identità, i territori si meritano una nuova narrazione. Se la meritano perché nonostante le condizioni non favorevoli prosegue quel lavorio territoriale fatto di istanze, progetti, programmi, analisi, coalizioni che si raccolgono sotto il cappello di un’innovazione sociale place based ormai giunta a maturazione e dunque pronta a scalare attraverso una nuova narrativa che ambisce a riallineare quanto sta già succedendo con le sfide socio ambientali di quest’epoca.
Tutt’altro che storytelling da agenzie pubblicitarie quindi, ma neanche manifesti engagé incentrati sul “contro” e su proposte poco praticabili. La nuova narrazione territoriale prende forma in modo distribuito e carsico dentro i documenti condivisi che alimentano politiche e progettazioni di sistema, nella diaristica social di chi abita, per davvero, i contesti, e ancora nella riproduzione di conoscenze radicate attraverso approcci di ricerca partecipanti. Ad alimentarla è una comunità variegata, e forse ancora troppo fluida, fatta di ricercatori, consulenti, cittadini attivi, funzionari che preferiscono sempre meno esternalizzarne l’elaborazione a consulenti e think tank tentando piuttosto un approccio di condivisione. Una strada quasi obbligata, e certamente più faticosa, se si vuole contare su una narrativa la cui autenticità consiste nel saper delineare orizzonti di senso per nuovi modelli di sviluppo.

Qualche esempio? A Reggio Emilia un gruppo di operatori culturali e delle politiche sociali organizzano eventi ed elaborano proposte di politica con l’intento di accreditare il welfare culturale come elemento portante di una nuova identità urbana. Nell’area metromontana torinese i distretti della coesione sociale cofinanziati dal programma regionale “we.ca.re” vengono riletti da ricercatori e designer secondo un approccio di sperimentalità che scaturisce non da scenari preconfezionati ma dal sostegno alla capacità di futuro degli attori locali. Così come nella Valsugana trentina, Impact Hub, il nodo di una rete glocale di infrastrutture per l’innovazione, sostiene la rigenerazione di sedi in dismissione della locale banca cooperativa creando una rete di spazi di coworking per lavoratori in smartworking e nuovi abitanti che non è un mero risarcimento ma un nuovo ramo aziendale. E ancora il programma Crearee di Unipol ha incubato una app digitale di project management per i propri presidi territoriali informali che non si limita a tracciare l’execution delle attività, ma a soppesare quello che dovrebbe essere il principale valore che scaturisce dai sempre più numerosi e diffusi progetti locali e di comunità ovvero le interdipendenze in chiave neomutualistica tra i diversi soggetti coinvolti. Uno strumento che potrebbe essere utile anche per Hermete, un’impresa sociale che nella Valdadige veronese lavora per “fare un passo indietro”, lasciando in eredità alla comunità locale risorse materiali e capacità di autogoverno che ha contribuito a costruire negli anni grazie a risorse della filantropia locale. Infine, ma non per ultime, le grandi reti nazionali come il Consorzio Cgm che prova a trasformare il proprio marketplace digitale di servizi di welfare in una vera e propria piattaforma per incrementare la dotazione infrastrutturale dei territori, in particolare delle sue economie sociali e di prossimità. O il Forum Nazionale del Terzo Settore che converte la propria storica formazione quadri in progetti di sviluppo comunitario aperti e inclusivi trainati da enti di Terzo settore soprattutto nelle aree meridionali del Paese. Queste e molte altre attività consentono una sorta di “agopuntura territoriale” che richiede però di individuare punti sensibili come i seguenti. Una politica di missione co-costruita, non eterodiretta e non rituale che sappia declinare in modo originale e autentico le missioni trasformative (ambientali, sociali, tecnologiche) che caratterizzano questa “era delle transizioni” verso nuovi assetti, attraendo e combinando risorse dedicate. Una progettualità sociale che a prescindere dall’oggetto sia caratterizzata da un approccio sistemico in grado di incidere su tendenze strutturali e di lungo periodo rispetto alla protezione e alla coesione sociale, lavorando sulla qualità delle interdipendenze tra i soggetti coinvolti. Una catena del valore che sappia rigenerarsi rimettendo in gioco i suoi fattori di radicamento (risorse, competenze, culture) rispetto ai macro trend trasformativi dell’economia mainstream (digitalizzazione, sostenibilità) recuperando in tal senso capacità d’investimento. Un change maker in grado non solo di innescare ma anche di diffondere elementi di innovazione per disincagliare i modus operanti del “si è fatto sempre così”, potendo contare non solo su capacità e motivazioni proprie, ma anche su infrastrutture di accompagnamento, facilitazione e trasferimento. Certo non è solo agendo su questi punti che si riscrive la narrativa. Occorre, come sostengono le agenzie di sviluppo di nuova generazione quali l’ufficio Svolta del Csv Trentino o Appenninol’Hub nel riminese, una capacità di distillare un profilo territoriale non semplicemente pronto all’uso per attività di policy making o di progettazione, ma rispondente rispetto alle aspirazioni e di chi il territorio lo fa abilitandolo.