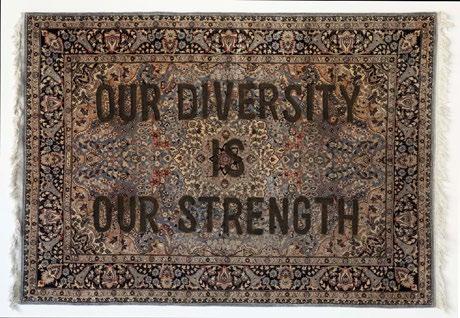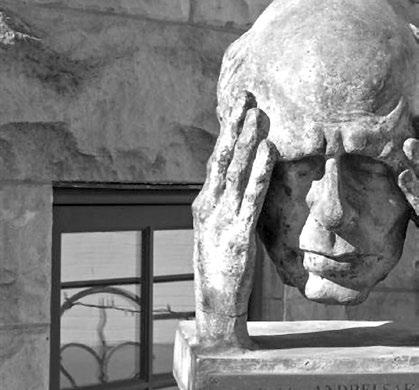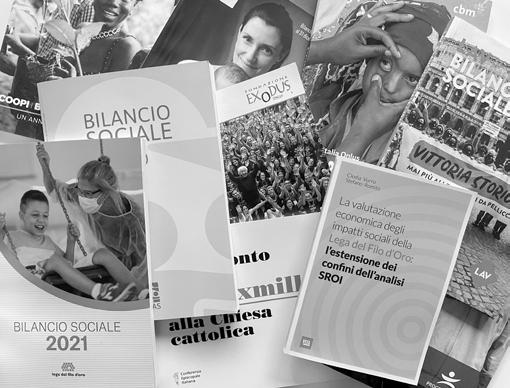9 minute read
5. SCARTO
La mia relazione con papa Francesco ebbe inizio poco dopo la sua nomina a Pontefice. Era il luglio del 2013 e Francesco decise di scegliere come destinazione del suo primo viaggio ufficiale Lampedusa; simbolo della «globalizzazione dell’indifferenza», come la definì lui stesso. Era una chiara presa di posizione, attenzione e sensibilità verso coloro che troppo spesso vengono ingiustamente considerati gli “ultimi” della nostra società (migranti, anziani, donne, indigeni, lavoratori della terra). Sentì da subito un’affinità di intenti con lui; nelle sue denunce di indifferenza verso il prossimo e di condanna della cultura dello scarto vidi rispecchiato il lavoro portato avanti dalla rete di comunità del cibo di Terra Madre (contadini, pescatori, allevatori, indigeni, artigiani), che dal 2004 difendono la diversità di colture e culture alimentari.
Così decisi di scrivergli una lettera in cui esprimevo riconoscenza per la scelta di Lampedusa, e a cui allegavo una copia del mio libro Terra Madre. A seguito di quella lettera, una sera mentre mi trovavo a Parigi per lavoro, ricevetti una chiamata da papa Francesco in persona. Conversammo per una mezz’oretta buona di agricoltura, dell’economia che ha distrutto i contadini e gli raccontai un aneddoto su una cuoca delle mie parti che teneva aperto il locale solo di giorno. Molte erano le richieste da parte dei clienti di tenere aperto anche per la cena. Ma lei rifiutò sempre dicendo che non aveva nessuna intenzione di diventare la più ricca del camposanto. Un’affermazione contadina, che non sottintendeva svogliatezza sul lavoro, ma che si faceva portatrice di un diverso concetto di economia. Un’economia di sussistenza che rigetta la venerazione capitalista del “Dio Denaro” e dà spazio a valori impossibili da quantificare, quali la cura per il territorio e per le relazioni fra le persone. Da quel primo confronto ne sono seguiti molti altri epistolari e fisici, che a dieci anni di distanza riescono ancora a stupirmi.
Advertisement
Nel 2015 le Edizioni Paoline mi chiesero la stesura dell’introduzione alla lettura dell’enciclica Laudato si’. Un testo poetico e politico straordinario in cui ho ritrovato molti dei principi che hanno delineato il mio lavoro negli anni. Nella prefazione scrivevo: «Immancabilmente, parlare di un’ecologia che inizi dentro di noi e si riverberi in tutta la sua potenza fuori con azioni concrete che portino alla pace e a un benessere pieno e condiviso da tutti e tutto, ci fa guardare senza filtri al depauperamento che abbiamo causato alle risorse naturali, alle possibilità future che ci neghiamo, allo svilimento del nostro esistere. [...] Finché una cosa— o un essere vivente, e una persona, purtroppo — serve a uno scopo preciso e mi dà ciò che voglio, la uso o intrattengo con essa una relazione. Nel momento in cui questo bisogno non è più soddisfatto si tronca il rapporto. È la cultura dello scarto, il consumismo che tenta di riempire i nostri vuoti. È quello che facciamo con la natura, ma anche con i nostri fratelli e sorelle che muoiono di fame e malnutrizione, soffrono la povertà, con i quali non abbiamo rapporti diretti e non ci possono dare nulla di cui sentiamo bisogno». Tengo sempre a sottolineare come si tratti di un’enciclica sociale, ancora prima che ecologica, ahimè non ancora ben assorbita né dal mondo laico ma neppure da quello cattolico.
Nel 2019 invece fui invitato a partecipare al Sinodo Amazzonico. Nell’accettare tenni a ribadire al Pontefice di essere agnostico e lui mi rispose in maniera affabile definendomi “agnostico pio”, ossia capace di provare pietas per la natura — tutt’oggi ammetto che è una definizione che mi piace molto — . Poter prendere parte a quell’assise è stata un’esperienza straordinaria, dove ho potuto toccar con mano la potenza del dialogo come metodo e processo di apprendimento, un modo per far sì che l’inculturazione non sia qualcosa di univoco ma diventi scambio mutualistico da cui poter imparare. In quella sede decisi di utilizzare lo spazio di dialogo che mi fu offerto per parlare di due categorie di persone fondamentali per l’alimentazione di tutti noi, ma che più di altre nel tempo sono state bistrattate: le donne e gli indigeni. Le donne ovunque nel mondo sono le garanti della sicurezza alimentare delle comunità. Nella vita di ciascuno di noi c’è una mamma o una nonna che ci ha insegnato a cucinare seguendo l’intelligenza del cuore: che ci ha raccolti intorno a un tavolo, ci ha accuditi trasmettendoci i valori del cibo giusto e sano, o quelli delle ricette che permettevano di riutilizzare gli avanzi. Gli indigeni invece, attraverso la pratica della raccolta, rispettano i delicati equilibri dell’ambiente, tutelano il patrimonio forestale, e salvaguardano la biodiversità garantendone presenza e continuità per le future generazioni.
Nei primi dieci anni del suo Magistero, la relazione tra me e papa Francesco si è basata su una comunanza di intenti che è in realtà universale e riguarda tutte le persone di buone volontà. Mi riferisco all’opposizione alla cultura dello scarto attraverso l’impegno a porre fine alle forme di ingiustizia che impediscono l’emancipazione umana, e l’ascolto del grido della Terra, schiacciata dal peso di un’economia che uccide e preclude un futuro degno per l’umanità su questo pianeta. Nulla ci deve spaventare in questo compito a cui siamo chiamati, credenti o non credenti, laici o religiosi: non possiamo più rimanere indifferenti dinanzi a un’umanità che sta devastando la terra e nel farlo sta procedendo a passo spedito verso il baratro. Anche nel nostro quotidiano e nelle nostre piccole vite si può incidere sul cambiamento.
Se penso a questo decennale di pontificato di papa Francesco non posso che partire dalla parola “pena”, quella dell’ergastolo, che lui volle abolire per la Città del Vaticano, nel luglio 2013, pochi mesi dopo esser stato eletto.
Un messaggio anche per l’Italia. Anche la nostra Costituzione, all’articolo 27, parla di pena, seppure al plurale. Ricorda che “le pene” non possono essere contrarie al senso di umanità. E d’altra parte le nostre carceri sono definite istituti penitenziari, c’era evidentemente già in chi ha scritto questi testi fondamentali, la volontà di punizione che, nel gergo giuridico, sarebbe “retribuzione”. C’è anche la parte risocializzante, come recita l’articolo 27, quando parla di rieducazione: una parte, come sappiamo, che nella realtà lascia molto a desiderare.
Anche nell’immaginario collettivo la pena viene sempre associata al carcere, non si considerano pene le pene alternative, che sono comunque forme di punizione. Non si considera pena la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà. Misure che sono previste dal nostro ordinamento, nel quale sono state rafforzate anche grazie alla riforma Cartabia, la messa alla prova e le pene sostitutive.

Sull’ergastolo, di papa Francesco mi ha colpito moltissimo, perché la reputo di altissimo spessore, sia politico sia giuridico, quella lezione magistrale che fece ai giuristi dell’Associazione internazionale di diritto penale, nel 2014. In quell’occasione infatti cominciò a usare espressioni anche molto forti: «L’ergastolo è una pena di morte nascosta», disse, e quindi è ipocrita cercare di mascherarla. Oppure, anche rispetto al carcere duro, in quella lectio, parlò dell’isolamento e dei luoghi che causano sofferenze psichiche e fisiche che finiscono per incrementare sensibilmente la tendenza al suicidio.
Per me Francesco resta il pontefice che ha lavato i piedi ai detenuti in occasione della messa in Coena Domini. Uno dei massimi gesti di umiltà, lavare i piedi. Cominciò nel carcere minorile di Casal del Marmo, nel 2013, e poi a Rebibbia, a Regina Coeli e ha continuato nelle carceri di Paliano e di Velletri.
Pensiamo a tutti quelli che dicono “buttiamo via la chiave” e pensiamo al pontefice che, chinandosi sui piedi di questi uomini, usava l’espressione: “Perché tu e non io?».
Lo diceva sapendo bene che le persone delinquono e a volte delinquono ripetutamente, in genere provenendo dalle parti più disagiate delle periferie delle città, segnate dalla povertà materiale ma anche dalla povertà educativa.
Con «Perché tu e non io», ricorda che molto dipende da dove siamo nati, da che condizioni di vita e di crescita abbiamo avuto. Fatti purtroppo poco raccontati agli italiani, che così diventano giustizialisti. E anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha recentemente ricordato di voler essere «garantista nel processo e giustizialista nell’esecuzione penale», dimostra così d’essere vittima della medesima mancanza di informazione corretta. Non sa, probabilmente, che ci sono intere parti dell’ordinamento penitenziario — la legge n° 354/1975 — che non sono mai state attuate. E sono le parti, dall’articolo 74 in poi, che più corrispondono al dettato costituzionale sulle pene che «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Quelle parti dell’ordinamento che prevederebbero l’istituzione dei Consigli di aiuto sociale in ogni circondario di Tribunale con la cooperazione, quindi l’azione sinergica e collettiva, del Tribunale di sorveglianza, dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle imprese, delle associazioni, in modo da intervenire nella famiglia del detenuto affinché a fine pena abbia una possibilità che non sia solo quella di tornare a delinquere. Articoli mai attuati. Di Consigli di aiuto sociale c’è n’è solamente uno, a Palermo, istituito non tantissimi anni fa, per l’iniziativa del presidente del Tribunale, Antonio Balsamo, un galantuomo che ascoltandomi protestare a Radio Radicale, decise di metterlo in piedi.
E pensando a papa Bergoglio e al carcere, non posso non ricordare il suo rapporto con Marco Pannella. Quella telefonata al Policlinico Gemelli, durante uno sciopero della sete che Pannella aveva intrapreso nel maggio del 2014, proprio sullo stato dei nostri istituti di pena. Era al sesto giorno e la sua vita era davvero a rischio, si temeva il blocco renale. Una domenica, ricevette questa chiamata dal pontefice, bellissima, che registrammo.
In quella occasione Pannella chiese al Papa di pronunciare la parola “amnistia”, di fare un’uscita pubblica sul tema. Il Papa accettò, Marco interruppe lo sciopero. E successivamente il pontefice mantenne la promessa. Purtroppo, furono inascoltati entrambi.
Di papa Francesco ho poi un ricordo personale e cioè di quando gli portai un libro con le lettere di quasi 20mila carcerati, che avevano digiunato due giorni in occasione della Marcia per l’amnistia che avevamo organizzato proprio per il Giubileo dei carcerati. Un volume che sarà pesato 10 chili.
Glielo consegnai in udienza ed era il periodo in cui lui insisteva sul fatto di portare sempre con sé il Vangelo, enfatizzando il fatto che fosse “tascabile”. Quando vide questo tomo, appoggiato alla balaustra mi guardò e mi disse ridendo: «Tascabile!».
Uno dei primi atti di governo di Francesco fu l’abolizione dell’ergastolo in Vaticano. Lo fece nel luglio 2013, pochi mesi dopo esser stato eletto.
Un messaggio anche per l’Italia: la nostra
Costituzione dice che “le pene” non possono essere contrarie al senso di umanità
Si potrebbe davvero comporre una catechesi sul volontariato spulciando i discorsi, i messaggi e le encicliche di papa Francesco in questi dieci anni, la sua è stata un’attenzione crescente e tutta dentro i passi del magistero pontificio, è a Roma che Francesco scopre il volontariato, il suo valore che non consiste nel volontarismo.
Il Papa che pochi mesi dopo la sua elezione al soglio pontificio, nell’ottobre 2013, aveva avvertito che la Chiesa non è una Ong: «La Chiesa non è un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è una Ong, la Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo; non porta se stessa la Chiesa porta Gesù». Ovvero, la sua ragione sociale non è umanitaria ma sacramentale.
Papa Francesco nel corso del suo magistero ha poi via via incontrato centinaia di volontari e centinaia di gruppi di volontariato, sui territori o nelle udienze e nei lunghi mesi della pandemia ha visto e ammirato la mobilitazione in aiuto dei più fragili quando nelle città dominava il deserto e il silenzio. Si può parlare di una vera e propria scoperta da parte del Papa del volontariato, una scoperta che lo ha portato a dire «Io ho trovato tre cose in Italia che non ho visto da altre parti.
Una di queste tre cose è il forte volontariato del popolo italiano, la forte vocazione al volontariato. È un tesoro: custoditelo! È un tesoro culturale vostro, custoditelo bene!» (Discorso ai volontari della Protezione civile, maggio 2022). E ancor più recentemente «Il volontariato è una delle tre cose che ho trovato in Italia come una caratteristica vostra, non l’ho trovato così altrove. Le altre cose sono gli oratori parrocchiali, al nord soprattutto, e poi le associazioni di aiuto economico, bancario, perché la gente prenda lì il mutuo e vada avanti, un aiuto di tipo economico. Tre cose tipicamente italiane». (Discorso ai rappresentanti della Focsiv il 14 novembre 2022). Un “tesoro culturale”, sottolinea il Papa, ovvero qualcosa di cui essere coscienti, da salvaguardare, da nutrire. A delineare contorni e contenuti di questo tesoro scoperto strada facendo da Francesco è stata poi l’intenzione di preghiera per il mese di dicembre 2022, diffusa attraverso un video alla Rete mondiale di preghiera del Papa, così intitolata: Per le organizzazioni di volontariato. Un testo breve quanto un’intenzione di preghiera ma in cui c’è molto, forse tutto il pensiero del Papa sul tema. Vediamolo punto per punto perché questi sono i cardini della catechesi del Papa sul volontariato svolta in questi anni.
1. Impegno per il bene comune. L’intenzione si apre con un invito perentorio: “Il mondo ha bisogno di volontari e di organizzazioni che vogliano impegnarsi per il bene comune. Sì, è la parola che oggi molti vogliono cancellare: “impegno”. E il mondo ha bisogno di volontari che si impegnino per il bene comune”. Il mondo ha bisogno di volontari ovvero di persone, uomini e donne, che non abbiamo paura dell’impegno, idea e parola che molti vorrebbero cancellare, e di un impegno, che sempre implica anche un minimo di sacrificio, non per la carriera, i soldi o il potere ma per la costruzione del bene comune, di una casa comune in cui tutti possano essere accolti con dignità.
2. Essere volontari è una scelta che rende liberi. “Essere volontari solidali è una scelta che ci rende liberi; ci rende aperti alle necessità dell’altro, alle richieste di giustizia, alla difesa dei poveri, alla cura del creato“. Essere volontari, sottolinea il Papa, non è un volontarismo ma una scelta ovvero un esercizio proprio della libertà, una scelta che apre all’altro, che apre al mondo impedendo di restare autocentrati su di sé in un circolo egoistico