TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ - ANNO 2023 N.1 - WWW.UNEM.IT
ENERGIE E TECNOLOGIE PER IL FUTURO

TRIMESTRALE DI UNIONE ENERGIE PER LA MOBILITÀ - ANNO 2023 N.1 - WWW.UNEM.IT
ENERGIE E TECNOLOGIE PER IL FUTURO
CUI PRODEST
La percezione dell’opinione pubblica, spinta dalla tempesta mediatica, è stata quella di trovarsi davanti ad aumenti indiscriminati. I fatti hanno però dimostrato che gli aumenti erano esclusivamente legati all’eliminazione dello sconto prima applicato sulle accise. Il commento del Presidente unem Spinaci, che sottolinea anche come a fronte di un sistema industriale virtuoso il nostro tallone d’Achille resta la tassazione più alta d’Europa.


L’EUROPA E LE NUOVE SFIDE DEL 2023

Il 2022 si è concluso in un clima di incertezza: l’anno che doveva consolidare la ripresa post-pandemica è stato caratterizzato da eventi drammatici e da tensioni che hanno coinvolto il settore energetico. Con la crisi tra Russia e Ucraina, l’Europa ha dovuto affrontare due problemi: le ridotte importazioni di petrolio russo e quello ben più grave dei mancati arrivi di prodotti dalle raffinerie russe. La riflessione di Vittorio D’Ermo.
“PRICE CAP GAS”: UNA BATTAGLIA SENZA VINCITORI MA UN SOLO SCONFITTO, L’EUROPA di Benedettini e Stagnaro >>

MATERIALI CRITICI: LE RISORSE NON RINNOVABILI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA di Giacomo Rispoli
CRESCE LA MOBILITÀ PRIVATA CHE PUNTA SULL’IBRIDO di Carlo Carminucci


RINNOVABILI: MOLTE ASPETTATIVE MA ANCHE MOLTI LIMITI di Jacopo Giliberto


SPIEGATA di


Nel giro di dodici mesi il mondo è cambiato come mai nel recente passato e siamo stati costretti a riflettere su molte delle scelte fatte, non sempre lungimiranti. I Governi nazionali hanno dovuto barcamenarsi tra l’insoddisfazione dei cittadini e le difficoltà oggettive di rispondere con i fatti ad un’emergenza energetica che ha riguardato tutti.
Solo recentemente le cose si sono un po’ calmate visto il calo dei prezzi del gas sui mercati internazionali, non certo per merito di misure come il price cap su cui l’Europa si è divisa, di cui ci parlano Simona Benedettini e Carlo Stagnaro nel loro commento. È stato soprattutto perché i mercati si sono riequilibrati con il venire meno di una domanda dovuta agli acquisti “folli” fatti per riempire gli stoccaggi e per temperature tutto sommato miti.
Anche sui mercati petroliferi i prezzi sia del greggio che dei prodotti si sono molto ridimensionati, tornando vicini ai livelli di inizio 2022, tanto che il nuovo Governo ha colto l’occasione per eliminare lo sconto di 30 centesimi su benzina e gasolio introdotto il 23 marzo 2022 dal Governo Draghi quando si erano superati i 2 euro al litro. E lo ha fatto in due riprese: la prima, dal 1° dicembre con l’eliminazione dei primi 12 centesimi; la seconda, dal 1° gennaio per i restanti 18. Si è dunque tornati agli stessi prezzi di quando era in vigore lo sconto senza lo sconto, ma sui giornali si è parlato di prezzi fuori controllo e di speculazione, quando era invece vero il contrario, come spiega il Presidente Spinaci nel suo commento di apertura. In entrambi i casi, emerge la distanza che c’è tra i fatti e la rappresentazione che se ne dà.
Uno degli obiettivi di Muoversi, in questi primi tre anni e mezzo di pubblicazioni, è stato proprio quello di guadare ai fatti per provare a fornire elementi che, in ogni uscita, potessero aiutare a qualificare il dibattito, mettendo da parte estremizzazioni e ideologismi.
In un momento di snodo come quello attuale, con l’inizio di un anno che si annuncia come quello del riassetto globale dopo la pandemia e la guerra che in qualche modo ci coinvolge, l’entrata nel vivo dell’azione del nuovo Governo italiano dopo un avvio fortemente condizionato dall’emergenza, l’ultimo anno pieno di una legislatura europea con poche luci e molte ombre, ci è parso utile dedicare la prima uscita del 2023 ad approfondire quale è la situazione sui mercati dell’energia e delle materie prime e a che punto siamo con la ricerca e l’innovazione sulla via della transizione. Parleremo anche di cybersicurezza, di fusione nucleare e di energia dallo spazio sulla scia degli ultimi successi della ricerca.
Con questo numero prende il via anche una nuova rubrica, “L’energia spiegata”, curata da Salvatore Carollo, che inizia con un focus sul funzionamento dei mercati petroliferi e della raffinazione, prendendo spunto da quanto accaduto in questo avvio di 2023, per porre l’attenzione sui problemi strutturali del mercato petrolifero internazionale e sulle ricadute sul sistema di approvvigionamento italiano e lasciando da parte i tanti luoghi comuni.
Spazio anche alla nuova edizione del campionato internazionale “Motostudent 2023” che vedrà la tappa finale ad ottobre sul circuito spagnolo di Aragon, al quale partecipa il Sapienza Gladiators Racing Team che ancora una volta sarà sostenuto da unem.

Benzina: nuovi rincari”, “Benzina, prezzi impazziti”, “Volano i prezzi di benzina e gasolio”, “Speculazioni su benzina e diesel, interviene la Guardia di Finanza”, “Prezzi benzina, la denuncia: listini record, costi fuori controllo". Questi alcuni dei tanti titoli dei principali quotidiani nazionali all’indomani della fine dello sconto sulle accise introdotto a marzo 2022 quando la benzina era arrivata a costare ben oltre 2 al litro. La percezione dell’opinione pubblica, spinta da questa tempesta mediatica, è stata quella di trovarsi davanti ad aumenti indiscriminati e su tutta la rete,
soprattutto quella autostradale. I fatti, di contro, hanno dimostrato che gli aumenti erano esclusivamente legati all’eliminazione dal 1° gennaio dello sconto precedentemente applicato sulle accise, i famosi 18 centesimi che, peraltro, alla pompa sono risultati più contenuti di 1-2 centesimi al litro grazie a lievi riduzioni dei prezzi industriali, come risulta dai dati del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Dati che hanno confermato quanto andavamo dicendo da giorni sulla base delle nostre evidenze.


Una percezione falsata da allarmi e
accuse totalmente ingiustificate che non hanno fatto altro che esacerbare gli animi e alimentare contrapposizioni ideologiche, poi trasformatesi in battaglie identitarie.

Una vicenda che ha confermato, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, quanto poco contino i fatti e quanto pesi invece la percezione che se ne ha o, peggio, che si preferisce avere a seconda degli interessi del momento. Da un lato, un Governo che ha ritenuto fosse giunto il momento di mettere fine ad una misura ritenuta regressiva e troppo onerosa per il bilancio dello Stato, ma che ha al suo interno alcuni partiti che in passato avevano spesso invocato una riduzione delle accise; dall’altro, un’opposizione che ha subito gridato allo scandalo sperando di mettere in difficoltà il Governo e recuperare parte del consenso perduto. Opposizione dimentica che in un passato, neanche troppo remoto, alcune delle forze politiche che la compon-
La percezione dell’opinione pubblica, spinta da questa tempesta mediatica, è stata quella di trovarsi davanti ad aumenti indiscriminati.
I fatti hanno dimostrato che gli aumenti erano esclusivamente legati all’eliminazione dello sconto prima applicato sulle accise
Benzina: prezzo industriale nei Paesi UE (euro/litro)
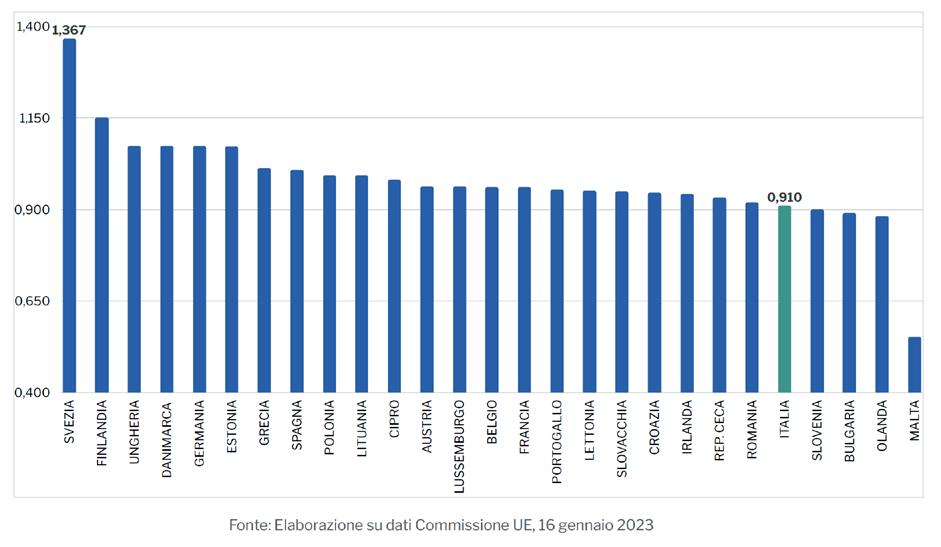

gono avevano sostenuto la necessità di aumentare le accise sul gasolio, in quanto ritenute un sussidio ambientalmente dannoso.
Nel mezzo compagnie e gestori che alla fine sono stati “incriminati” e destinatari di nuove misure che, alla luce dei fatti, non solo sono inutili (se i prezzi sono stato gestiti correttamente dalla filiera perché invocare la mancanza di trasparenza?), ma potenzialmente controproducenti (sin dal 1999
l’Antitrust aveva contestato la pubblicizzazione sugli impianti carburanti di “prezzi consigliati” prevista da un Decreto Ministeriale del 1994, ritenendo che favorisse fenomeni di allineamento dei prezzi). Misure che peraltro richiederebbero ingenti investimenti, nell’ordine di molte decine di milioni di euro, e lunghi tempi di realizzazione (anche oltre 12 mesi) certamente non congruenti con l’urgenza manifestata dal Governo (mentre oggi
si parla di 15 giorni per 21.700 punti vendita), pena multe salatissime. Con il nuovo Decreto-legge n. 5/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” il Governo sembra, quindi, aver dato più peso alla narrazione che ai fatti, invece di spiegare ai cittadini quanto
Gasolio: prezzo industriale nei Paesi UE (euro/litro)
A fronte di un sistema industriale virtuoso, più che competitivo anche rispetto ai principali Paesi UE, il nostro tallone d’Achille resta la tassazione che è invece complessivamente la più alta d’Europa. Una questione del genere non può essere affrontata in termini emergenziali ma in termini strutturali, con una riforma complessiva del fisco
stava succedendo e cioè che a lungo andare lo sconto sarebbe stato insostenibile economicamente, a meno di introdurre nuove tasse in altri ambiti o ridurre la spesa per i servizi. D’altra parte, tenuto conto dell’andamento dei mercati dei prodotti petroliferi, era forse il momento più adatto per farlo in quanto i prezzi sono tornati al livello del 23 marzo quando venne introdotto lo sconto, ma senza lo sconto di 30 centesimi.
Certo, la fiscalità sui carburanti nel nostro Paese è tra le più alte se non la più alta d’Europa (sul gasolio siamo i primi, mentre sulla benzina ci precedono solo a Grecia e Finlandia), ma non è un fatto contingente, è strutturale. Sempre i fatti, ci dicono che a livello in-

dustriale abbiamo i prezzi tra i più bassi d’Europa, in media di 3-4 centesimi. Più bassi di quelli della Germania, dove un litro di gasolio al netto delle tasse costa 15 centesimi in più ma al consumo 5 in meno, o anche della Francia, dove ci sono 6 centesimi in più a livello industriale ma 3 in meno alla pompa. Eclatante è il caso della Spagna, molto vicina a noi per volumi consumati, dove il prezzo industriale è più alto di 8 centesimi ma alla pompa è più basso addirittura di 20.
Quindi a fronte di un sistema industriale virtuoso, più che competitivo anche rispetto ai principali Paesi UE, il nostro tallone d’Achille resta la tassazione che è invece complessivamente la più alta d’Europa.
Una questione del genere non può essere affrontata in termini emergenziali (sconto temporaneo che va rifinanziato per un miliardo al mese di volta in volta), ma va affrontato in termini strutturali, con una riforma complessiva del fisco che, obiettivamente, per la sua complessità non si poteva pretendere fosse affrontata in così poco tempo da questo Governo (è notizia di questi giorni che una proposta in tal senso dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri entro la metà di marzo). Dunque, se si volesse intervenire in modo efficace e non estemporaneo, lo si dovrebbe fare in maniera organica sull’intero sistema fiscale, accise comprese, allineando i livelli di
tassazione dei carburanti alla media europea e detassando la componente rinnovabile dei carburanti, promuovendone così il loro sviluppo.
Stando così le cose, non mi spiego il perché di questa continua opera di criminalizzazione di un settore che è molto più virtuoso di quello degli altri Paesi europei nonostante una serie di problemi cronici, mai affrontati dai Governi passati, che hanno impedito una evoluzione efficiente ed ordinata della rete. Oggi abbiamo ancora un numero di impianti stradali quasi doppio rispetto a Germania e Francia ed un erogato medio che è un terzo. Forse sarebbe il caso di ricominciare a ragionare seriamente su cosa fare per avvicinare il nostro sistema distributivo agli standard europei piuttosto che scatenare campagne diffamatorie che non servono certo a migliorare il sistema nel suo complesso né a portare reali benefici ai consumatori. Non è la prima volta, e temo non sarà l’ultima, che i temi legati all’energia sono divisivi per le forze politiche e più volte, anche da queste pagine, ho richiamato l’attenzione sui rischi legati al “populismo energetico” perché i problemi non si risolvono attraverso la ricerca di un facile consenso, ma solo attraverso investimenti e sviluppi coerenti di lungo termine, con il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della filiera e delle Istituzioni centrali e regionali.


Nella tabella sono evidenziate le diverse componenti - e il relativo peso - che determinano il prezzo finale dei carburanti per i consumatori
16 Gennaio 2023
Margine Lordo: differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima (Platts Cif Med) Tale margine, pari per entrambi i prodotti al 9% del prezzo alla pompa, serve a coprire i costi derivanti da numerosi obblighi di legge (miscelazione biocarburanti; scorte strategiche; tasse locali; tasse portuali, etc ) nonché a remunerare i vari passaggi della filiera (costi distribuzione primaria e secondaria, margine del gestore, oneri finanziari, costi di investimento p v e di struttura, costi di commercializzazione, etc )

L’approccio dominante sul clima e sulla decarbonizzazione delle economie mondiali non ha considerato la necessità di accompagnare la transizione verso fonti a minor impatto ambientale anche supportando l’industria energetica esistente che, invece, vuole e può fornire un contributo determinante

Nella seconda decade del ventunesimo secolo, l’economia globale ha beneficiato quasi costantemente di capitali a prezzi convenienti e di abbondante offerta di energia. Le misure monetarie espansionistiche adottate pressoché universalmente a seguito della crisi del 2008, unite al breakthrough tecnologico del petrolio e gas di scisto (shale), hanno inaugurato una stagione di bonanza nei mercati energetici globali. Parallelamente, la questione climatica ha assunto sempre più peso, uscendo dalla nicchia scientifica, diffondendosi nelle agende politiche internazionali, così come nelle strategie e nei bilanci d’impresa, fino a penetrare le coscienze. Progressivamente, sempre più denaro è stato indirizzato a favore di investimenti che, oltre a rispondere ai classici indicatori finanziari, fossero anche ESG-friendly ossia allineati ai tre criteri centrali per le analisi di sostenibilità.
In questo quadro apparentemente corretto e lineare, si mescolano però
poche luci e tante ombre. Una su tutte: la posizione dominante sul clima e sulla collegata decarbonizzazione delle economie mondiali non ha considerato la necessità di accompagnare la transizione verso fonti a minor impatto ambientale anche supportando l’industria energetica esistente che, invece, nella sua evoluzione verso forme di energia più sostenibili sotto il profilo emissivo, può fornire un contributo determinante.
L’idea che si possa realizzare un taglio netto e veloce rispetto al passato presenta quindi un grave vizio di origine, ignorando una molteplicità di questioni tutt’altro che marginali: i tempi necessari per la sostituzione tra fonti; l’adattamento della domanda; il principio della neutralità tecnologica; il tema centrale della sicurezza energetica in tutte le sue dimensioni; la piena consapevolezza del significato di sostenibilità, che concilia l’attenzione verso l’ambiente con lo sviluppo sociale ed economico delle comunità. A livello europeo, questa narrazione climatica sbilanciata si è riflessa nella definizione di una normativa incardinata di fatto sull’estromissione delle fonti fossili, corroborando l’errato assunto secondo cui lo sviluppo di queste ultime vada giocoforza a detrimento delle fonti rinnovabili. L’industria fossile, ormai da tempo, sta cambiando pelle: evolvendo verso un modello di business più diversificato e proiettato ad una forte riduzione dell’impronta carbonica dei suoi prodotti finali.
Al contempo, poggia su conoscenze, competenze, infrastrutture e tecnologie indispensabili per supportarne l’evoluzione e accompagnare l’ineludibile processo di transizione. Da questa premessa, parte lo studio realizzato dal Rie di Bologna in collaborazione con unem, presentato lo scorso 30 novembre in una conferenza stampa, che propone un punto di vista più ampio sulle potenzialità dei LCF, lo stato dell’arte delle tecnologie, le principali caratteristiche tecniche, logistiche ed economiche, i fattori abilitanti, la disponibilità di materie prime per la loro produzione ai fini di una reale decarbonizzazione del trasporto stradale.
I prodotti analizzati dallo studio vanno anzitutto classificati in funzione della materia prima utilizzata per la loro produzione nonché delle tecnologie produttive. Ci sono i biocarburanti avanzati di origine biogenica e da Forsu, che possono essere utilizzati in miscela con il prodotto fossile o in purezza, che sono i candidati più idonei alla decarbonizzazione dei trasporti in quanto consentono un significativo abbattimento delle emissioni di CO2 rispetto al prodotto fossile, benché funzione del feedstock e del processo produttivo impiegato, arrivando a percentuali di riduzione delle emissioni prossime al 100% nel caso di impiego di rifiuti e sottoprodotti: il bioetanolo che si ottiene da biomasse derivanti da residui agricoli/forestali o da colture energetiche non alimentari, quindi

I progressi scientifico-tecnologici e i grandi sforzi delle imprese energetiche hanno messo a disposizione un’ampia gamma di prodotti bio o di sintesi che si possono utilizzare, dal bioetanolo al biodiesel, dal bio GNL, ai diesel paraffinici sintetici ai carburanti ottenuti riciclando rifiuti di origine non riciclabile
non soggette agli impatti indiretti derivanti dal cambiamento nell’uso del suolo (rappresentati dalle cosiddette emissioni ILUC). I processi di produzione vanno dall’utilizzo di specifici microrganismi, impiegati per estrarre zuccheri sottoprodotti dalle biomasse iniziali, a processi biochimici utilizzati per trasformare i residui in liquidi e successivamente in gas. Attualmente è disponibile su scala industriale la tecnologia per convertire biomasse lignocellulosiche in bioetanolo avanzato utilizzabile in miscela con la benzina, elevandone notevolmente il numero di ottano e in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 90% rispetto al carburante fossile. Il bioetanolo è ancora poco impiegato in Italia, essendo l’obbligo sui biocarburanti quasi interamente assolto con il biodiesel. Tuttavia, in prospettiva, il suo uso in miscela nelle benzine sarà inevitabile. Il PNIEC prevede l’introduzione graduale a partire dal 2023 di obblighi specifici di miscelazione di biocomponenti anche per le benzine. Abbiamo poi il biodiesel che è otte-
nibile a partire da biomasse derivanti da residui agricoli o da colture energetiche non alimentari. Riproduce le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali del gasolio minerale, con il quale viene miscelato ed utilizzato nei moderni motori diesel. A parte una densità energetica leggermente inferiore a quella dei carburanti tradizionali, non si rilevano variazioni in termini di prestazioni e libertà di impiego rispetto a benzina e gasolio fossili. Vi sono poi diesel paraffinici sintetici, indicati con la sigla “XTL/HVO”, dove XTL è un termine che descrive genericamente un combustibile liquido ottenuto mediante processo Fischer-Tropsch a partire da gas naturale (GTL - Gas to Liquid), biomassa (BTL - Biomass to Liquid) o carbone (CTL - Coal to Liquid), mentre con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) si intende il processo di idrogenazione di oli vegetali. La produzione di LCF liquidi da Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano - FORSU deriva invece da processi waste-to-fuel da cui si può ricavare un bio-olio destinabile al trasporto marittimo, visto il basso contenuto di zolfo, o raffinabile per ottenere biocarburanti avanzati. I volumi complessivi di FORSU oggi utilizzati soprattutto per produrre biogas/biometano e compost per l’agricoltura dovrebbero aumentare grazie ad un miglioramento dei processi di raccolta.

Altri prodotti che rientrano nella categoria LCF sono il biometano e il bio-GNL. Il primo è il risultato della raffinazione e purificazione del biogas (upgrading) tramite rimozione di ac-
qua, CO2, contaminanti come silossani, anidride solforosa e ammoniaca, al fine di renderlo impiegabile nella rete e dalle utenze del gas naturale senza la necessità di apportare modifiche agli impianti. Presenta una percentuale di metano superiore al 95% e può essere potenzialmente impiegato sia nell’autotrazione che per soddisfare gli usi domestici e industriali. È un prodotto quindi perfettamente in linea con il metano fossile per quanto riguarda le caratteristiche qualitative e prestazionali. Nella sua forma liquefatta di “BioGNL” può inserirsi nella stessa categoria del Gas Naturale Liquefatto (GNL) di origine fossile ed essere utilizzato come biocarburante per i mezzi pesanti e navali. Le materie prime principalmente impiegate per la produzione di biogas sono colture agricole, rifiuti e sottoprodotti agricoli, agro-industriali, zootecnici, FORSU e altri rifiuti e sottoprodotti (es. fanghi di depurazione). La CO2 rimossa con l’upgrading, di natura biogenica, costituisce inoltre componente utile per successivi processi di metanazione e può concorrere alla produzione di metano sintetico.
Per quanto riguarda prodotti non derivati da biomassa, ci sono i Recycled Carbon Fuels (RCF) che sono carburanti liquidi e gassosi prodotti da flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o dal gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile (ad esempio da plastica). In sintesi, sono ottenuti a partire da rifiuti indifferenziati e rifiuti plastici (plasmix) non
utilizzabili per il riciclo chimico della plastica. I gas di scarico associati ad alcune produzioni industriali, ad esempio quelli delle acciaierie, contengono monossido di carbonio come sottoprodotto. La parte di questo non impiegata nel processo produttivo, viene convertita attraverso un procedimento di fermentazione batterica in etanolo, direttamente utilizzabile come carburante per autotrazione, oppure oggetto di ulteriore conversione per ottenere un fuel di tipo drop-in impiegabile nell’aviazione. I RCF ottenuti in questo modo presentano una caratteristica interessante: da un vettore energetico di basso valore, quale appunto il monossido di carbonio, si ottiene un prodotto energetico di valore elevato e flessibile negli usi come, ad esempio, i carburanti liquidi. L'idea di convertire i rifiuti plastici in combustibili ha invece radici antiche: la grande maggioranza delle materie plastiche è ancora prodotta a partire da materie prime fossili, soprattutto petrolio e gas. I materiali plastici conservano gran parte dell’energia chimica ricavata dagli idrocarburi che, pertanto, può essere convertita in carburante tramite opportuni processi termochimici.
Per gli RCF a base di plasmix, la caratteristica più interessante è l'opportu-
nità di generare fuels e al contempo benefici per la gestione dei rifiuti, dal momento che i rifiuti plastici che alimentano gli impianti di produzione di RCF sono le frazioni di scarto non destinate al riciclaggio di materia ma ad incenerimento oppure smaltimento in discarica (il processo di conversione chimica dei rifiuti plastici potrebbe persino attingere ai rifiuti già conferiti in discarica con un progressivo svuotamento delle stesse).
Infine, abbiamo i carburanti rinnovabili di origine non biologica, in cui rientrano gli e-fuels che sono ottenuti dalla sintesi tra idrogeno (“verde” e “blu”), a sua volta prodotto (alias isolato) tramite elettrolisi dell’acqua utilizzando elettricità da fonti rinnovabili, ed anidride carbonica catturata direttamente dall’aria o, molto più convenientemente, da sorgenti concentrate (ad esempio settori industriali ad alta intensità energetica quali raffinerie, cementerie, acciaierie, ecc.). I prodotti finali sono idrocarburi sintetici di natura gassosa o liquida formulati in modo del tutto simile ai corrispondenti prodotti convenzionali (benzina, diesel, GNC, GNL, ecc.). Avendo caratteristiche merceologiche e prestazionali analoghe a quelle dei combustibili tradizionali, gli e-fuels - classificati
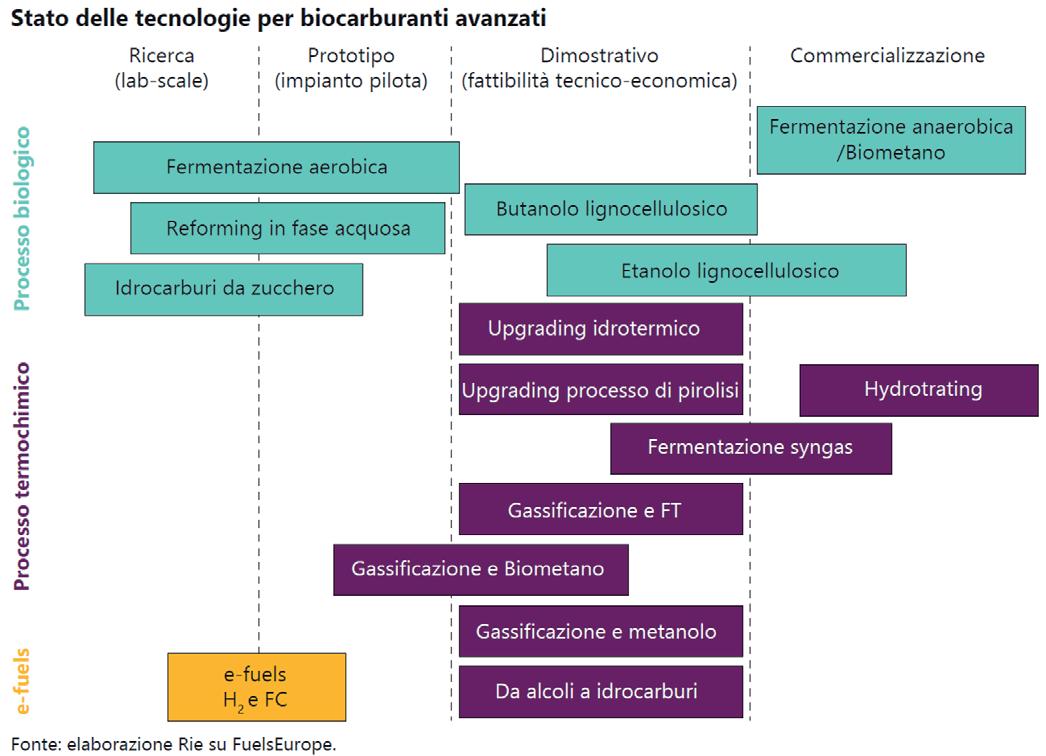
come combustibili drop-in - possono essere immediatamente impiegati su tutto il parco veicolare circolante esistente, sia passeggeri che merci per il trasporto stradale, sino al 100% e senza alcun adattamento tecnico e naturalmente su tutti i veicoli con MCI di nuova immatricolazione. La produzione degli e-fuels è oggi ancora sperimentale e la transizione dalla fase pilota-dimostrativa attuale ad impianti in grado di attivare una produzione su scala commerciale richiede realisticamente più di un decennio. Serve inoltre un aumento molto forte della capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, in considerazione dell’intrinseca inefficienza di conversione che caratterizza questo genere di produzioni.
1 ESG: Environment, Social e corporate Governance.
Un ultimo capitolo riguarda i carburanti rinnovabili di origine non biologica, in cui rientrano gli e-fuels che sono ottenuti dalla sintesi tra idrogeno (“verde” e“blu”), a sua volta prodotto tramite elettrolisi dell’acqua utilizzando elettricità da fonti rinnovabili ed anidride carbonica catturata
A sette anni dal 2030, data entro la quale le emissioni mondiali si vorrebbero dimezzate e l’innalzamento della temperatura contenuto entro il +1,5°C rispetto al periodo preindustriale, la distanza da percorrere è lunga

La COP27 è stata l’occasione per constatare che gli impegni internazionali in materia di riduzione delle emissioni sono stati disattesi. A soli sette anni dal 2030, data entro la quale le emis-

sioni mondiali si vorrebbero dimezzate e l’innalzamento della temperatura globale contenuto entro il +1,5°C rispetto al periodo preindustriale, la distanza da percorrere è lunga. Nonostante la temperatura globale sia già aumentata di 1,2°C, gli obiettivi di riduzione delle emissioni presi dagli stati (NDCs, nationally determined contributions) sono stati per lo più violati, cosicché ci si trova oggi in disavanzo per 23 GtCO2 rispetto al target fissato alla Conferenza di Parigi¹. Al contrario, le traiettorie attuali, ridefinite alla luce della crisi corrente, porterebbero a un aumento di quasi l'11% delle emissioni
globali di gas serra entro il 2030, rispetto al 2010². Si prevede che, qualora le politiche in vigore non vengano accompagnate da ulteriori azioni, l’aumento di temperatura raggiungerebbe i 2,8°C entro il 2100; l’attuazione degli scenari NDC ridurrebbe questo valore a 2,4°C³. Si tratta, ad ogni modo, di un incremento di gran lunga superiore a quanto si registrerebbe se gli Stati riuscissero ad eliminare del tutto le emissioni di CO2 al 2050 (+1,8°C)⁴, un obiettivo che è già stato sottoscritto da più di 70 Paesi, ma che sembra lontano da un’effettiva messa in pratica.

Vista la scarsa efficacia del coordinamento internazionale, diventa decisiva la volontà dei maggiori emettitori mondiali di farsi protagonisti, anche attraverso decisioni unilaterali. La Cina, che è responsabile del 31,5% delle emissioni di gas serra mondiali, è un attore irrinunciabile della transizione a uno sviluppo a basso impatto. Stati Uniti, Unione europea e India, che producono insieme il 26,4% delle emissioni mondiali, giocano a loro volta un ruolo determinante⁵.

L’abbassamento delle emissioni di UE e USA, tuttavia, viene contrastato dalle tendenze di Cina ed India, dove le preoccupazioni ambientali non sempre sono in armonia con i piani di sviluppo economico. Per questa ragione, le scelte delle potenze in via di sviluppo si faranno sempre più cruciali.
In Cina, la dipendenza dai combustibili fossili è destinata a permanere per garantire la sicurezza energetica. L’India ha già raggiunto gli obiettivi annunciati alla COP26, ma è rimasta vaga
quanto alla strategia Zero emissioni per il 2070. Preoccupa anche il Brasile. Benché gli NDC siano migliorati nel 2022 rispetto al 2021, continuano a mancare un piano serio a contrasto della deforestazione illegale dell’Amazzonia e una strategia di emancipazione dalle fonti fossili. D’altro lato, nemmeno le potenze occidentali si mostrano sempre virtuose. L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti avanza ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030, ma prevede anche di accrescere l’esportazione di gas naturale liquefatto di un terzo entro il 2026. La stessa Unione europea fatica ad assumere un ruolo di leadership nella transizione mondiale: nonostante il piano REpowerEU abbia il potenziale di ridurre le emissioni del 57% entro il 2030, la crisi russo-ucraina ha portato a una rinnovata dipendenza nei confronti delle fonti fossili⁶. In tale contesto, ci si domanda se il Carbon Border Adjustment Mechanism sarà
L’abbassamento delle emissioni di UE e USA, tuttavia, viene contrastato dalle tendenze di Cina ed India, dove le preoccupazioni ambientali non sempre sono in armonia con i piani di sviluppo economico. Per questa ragione, le scelte delle potenze in via di sviluppo saranno sempre più cruciali
uno strumento adatto a garantire che le politiche di riduzione delle emissioni portate avanti dall’UE non nascondano uno spostamento delle attività inquinanti al di fuori dei confini dell’Unione. L’intesa tra Stati membri è stata raggiunta lo scorso 13 dicembre nel quadro della revisione del sistema di scambio di emissioni (ETS): l’accordo provvisorio prevede la soppressione delle quote gratuite di emissione per i settori interessati dallo CBAM e la progressiva introduzione dello strumento, dapprima sotto forma di un obbligo di comunicazione, infine come una vera e propria tariffa, da applicare a partire da ottobre 2023⁷. Alla luce di questo stato delle cose, prende sempre più corpo la possibilità di overshooting, ovvero di superare in un primo momento la soglia dei +1,5°C, per rientrarvi nei decenni successivi. La scelta della strategia da seguire –se sottostare agli impegni di Parigi o se contemplare l’overshooting - determina la direzione della scommessa sulle tecnologie più appropriate alla transizione sostenibile: se un processo di rapida elettrificazione sostenuto dalle fonti rinnovabili è la strada che

molti vedono come preferibile, lo scenario che ipotizza l’impiego di bioenergie con sistemi di cattura e sequestro della CO2 a fronte del mantenimento dei pattern attuali di inquinamento è quello che dà speranze di una più drastica riduzione delle emissioni di qui al 2100⁸.
Si impone, dunque, un’adeguata ridefinizione dell’energy mix, che risponda al contempo alle necessità di stabilità energetica e ai vincoli ambientali. Secondo IEA, le fonti fossili bruciate per la produzione elettrica sono le maggiori responsabili delle emissioni di gas serra associate all’impiego
Note: per i dettagli sugli scenari: https://data.ece.iiasa.ac.at/ar6/#/docs
di combustibili (40%). Il solo carbone ha causato il 29% delle emissioni nel 2021, nonostante sia stato appurato che il suo abbandono è possibile, senza comportare un aumento dei costi al consumo, sia nelle economie avanzate che in quelle emergenti⁹. Seguono le emissioni dell’industria (23%), dei trasporti (23%) e in ultima quelle legate ai consumi degli edifici (10%)¹⁰.
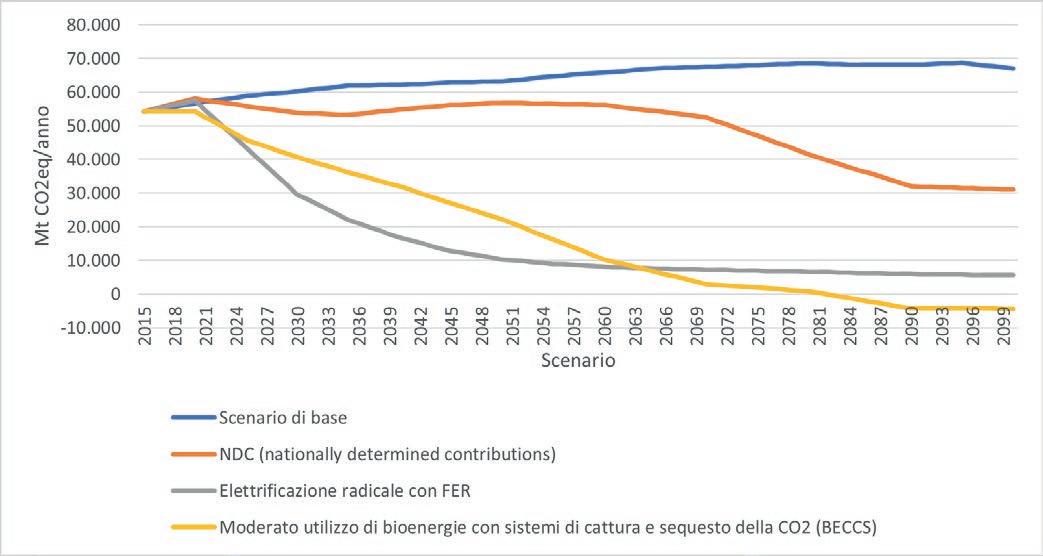
1 https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022
2 https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition#:~:text=To%20keep%20global%20 warming%20to,reach%20net%20zero%20 by%202050
3 https://www.unep.org/resources/adapta-
tion-gap-report-2022
4 https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
5 https://www.iea.org/data-and-statistics/ data-product/global-energy-review-co2-emissions-in-2021
6 https://climateactiontracker.org/documents/1094/ CAT_2022-11-10_GlobalUpdate_COP27.pdf
7 https://www.consilium.europa.eu/it/ press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
8 https://data.ece.iiasa.ac.at/ar6/#/workspaces/20 9 https://iea.blob.core.windows.net/assets/4192696b-6518-4cfc-bb34-acc9312bf4b2/ CoalinNetZeroTransitions.pdf
10 https://iea.blob.core.windows.net/assets/ ccdcb6b3-f6dd-4f9a-98c3-8366f4671427/ The_role_of_CCUS_in_low-carbon_power_systems.pdf
Carbone per uso energe-co Industria
TrasporEdifici
Gas per uso energe-co Altro
Petrolio per uso energe-co

L’Europa aveva chiuso il 2022 con una tabella di marcia precisa: dal 2035 stop all’immissione sul mercato europeo di auto e furgoni nuovi a benzina e diesel. L’intrecciarsi della crisi energetica e della rivoluzione produttiva verde hanno alimentato forti preoccupazioni economiche e sociali, ma questo non fa apparire alle viste ripensamenti su impegni e scadenze per assicurare emissioni zero di CO2 allo scarico. È evidente, però, l’accelerazione delle idee e delle proposte per potenziare l’azione pubblica - degli stati e della UE – a sostegno della transizione ecologica del modo di produzione e consumo. Nelle capitali come a Bruxelles ci si rende ben conto del rischio di spiazza-
mento dell’industria europea sotto una doppia sferzata: da un lato, il Buy American, con il sostegno fiscale agli acquisti di auto made in Usa che discrimina l’Europa; dall’altro lato, il rischio di plasmare un futuro di nuove dipendenze dell’industria europea con il passaggio alla nuova generazione di veicoli elettrici. I produttori europei, infatti, non hanno accesso diretto alle materie di base per realizzare la rivoluzione tecnologica del secolo in particolare per quanto concerne le batterie: la Cina controlla oltre il 60% della produzione mondiale; altri paesi asiatici tra i quali spicca la Corea del Sud ne forniscono il 21%; gli Stati Uniti il 10%. Un effettivo svantaggio concorrenziale.
A Bruxelles ci si rende conto del rischio di spiazzamento dell’industria europea sotto una doppia sferzata: da un lato, il Buy American, con il sostegno fiscale agli acquisti di auto made in Usa che discrimina l’Europa; dall’altro, il rischio di plasmare un futuro di nuove dipendenze dell’industria europea con il passaggio alla nuova generazione di veicoli elettrici
La risposta dell’Unione europea è multipla e attualmente è concentrata sulla moltiplicazione delle “alleanze industriali” per potenziare la base produttiva continentale e sul sostegno finanziario pubblico alla transizione ecologica. L’European Battery Alliance e la Renewable and Low Carbon Fuels Value chain industrial alliance hanno l’obiettivo di facilitare la cooperazione pubblico-privato sui progetti produttivi. L’Alleanza sulle batterie ha attratto finora 440 soggetti e circa cento miliardi di impegni di investimento; l’Alleanza nella catena del valore dei combustibili si concentra sull'aumento della produzione e della fornitura di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio mirata soprattutto ai settori dell'aviazione e delle navi. Per quanto concerne il sostegno finanziario alla transizione verde, di cui la mobilità è solo un aspetto (il trasporto su strada pesa per circa un quinto delle emissioni di CO2 nella UE), si stanno


seguendo due strade: un’accresciuta flessibilità per gli aiuti di stato alle imprese, finanziamenti comuni per progetti di interesse comune. La prima pista è più semplice, ma se tutto si esaurisse lì si approfondirebbero le divergenze tra i paesi UE: chi ha più margini di bilancio avrà più risorse per difendere “campioni” industriali nazionali e sostenere i consumatori a fronteggiare i costi attuali e futuri della transizione (compreso l’acquisto sovvenzionato di un’auto elettrica). La Commissione europea ha quindi delineato la prospettiva di creare un fondo sovrano europeo per la transizione energetica: è la pista parallela ritenuta da molti una necessità inderogabile. Tuttavia, ancora alla fine del 2022 non esistevano le condizioni politiche per operazioni finanziate con obbligazioni UE: l’opposizione tedesca, olandese e degli altri paesi “frugali” permane a raddoppiare il modello Next Generation EU usato per la ripresa e la resilienza delle economie post pandemia. L’accordo preliminare emerso dal trilogo tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione UE di fine ottobre sullo stop ad auto e furgoni nuovi con motore endotermico fra tredici anni deve essere votato in via definitiva dagli eurodeputati a febbraio/marzo, poi passerà al Consiglio UE che deciderà a maggioranza qualificata: non sono prevedibili al momento intoppi sostanziali. I malumori delle rappresentanze dell’industria UE a Bruxelles persistono. Per tutti vale la posizione di BusinessEurope, che rappresenta le “Confindustrie” nazionali, secondo cui il 100% di riduzione delle emissioni allo scarico (tail-pipe only target) al 2035 “non è in linea con il principio della neutralità tecnologica; non prende in considerazione lo sviluppo di condizioni abilitanti fondamentali come le infrastrutture di ricarica e rifornimento; disincentiva gli investimenti in tecnologie cruciali come i carburanti
liquidi a basse emissioni di carbonio e rinnovabili”. Certamente l’esito delle politiche collaterali che garantiscono la congruità dell’obiettivo al 2035 – e costituiscono una sfida enorme – è una scommessa aperta: ciò riguarda la produzione sostenibile di batterie nella UE in quantità e a costi competitivi; la produzione di modelli con un’autonomia che permetta di superare 600 km di viaggio; sufficienti infrastrutture di carica lungo le strade (l’ostacolo più grande per l’accettazione della mobilità elettrica da parte dei consumatori). I critici ricordano che i tempi del passaggio della nuova produzione all’elettrico sono troppo stretti, temendo che il primato europeo ottenuto nel mondo producendo motori a benzina e diesel non si ripeterà con il motore elettrico. I più critici parlano di harakiri industriale. Tuttavia, vista da Bruxelles, si tratta di una partita inevitabile per non perdere competitività rispetto a Cina e Stati Uniti almeno quanto per cercare di imporre uno standard tecnologico e produttivo della transizione ecologica. Anche se questo, inizialmente, comporterà dei costi sociali e non solo finanziari. L’associazione europea dei fornitori auto Clepa stima che in Italia nel solo settore motori, l’occupazione potrebbe passare dai 74 mila lavoratori nel 2020 ai 14 mila nel 2035; in Germania da 151 mila a 68 mila; in Spagna da 72 mila a 44 mila. In Francia si prevede un incremento da 28 mila a 29 mila per effetto della decisione di Renault e Stellantis di riportare eventualmente “a casa” diverse produzioni. Questo a bocce ferme, cioè senza interventi di sostegno. L’accordo UE è il risultato di un difficile compromesso come dimostrano vari elementi. Intanto c’è la deroga per chi produce fra mille e diecimila veicoli all’anno (non dovrà rispettare i passaggi intermedi ma dovrà attenersi solo all’obiettivo del 2035). Chi non raggiunge mille unità potrà conti-

Nel 2026 la Commissione valuterà i progressi verso i target e la necessità di rivederli tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dell'importanza di una transizione sostenibile, socialmente equa. In teoria la UE potrebbe decidere di rinviare lo stop al motore a combustione che utilizza e-fuel o biocarburanti
nuare a produrre motori endotermici (vale per Lamborghini o Ferrari, anche se quest’ultima ha superato tale soglia). Poi c’è la clausola di revisione: nel 2026 la Commissione valuterà i progressi verso i target e la necessità di rivederli tenendo conto degli sviluppi tecnologici — anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in — e dell'importanza di una transizione sostenibile, socialmente equa verso l'azzeramento delle emissioni. In teoria la UE potrebbe decidere di rinviare lo stop al motore a combustione che utilizza e-fuel o biocarburanti. Che questa scadenza possa costituire la leva per modificare l’impianto del regolamento europeo e non sia una mera concessione tattica per difendere l’idea della “neutralità tecnologica” è da vedere. Non a caso, ora si preferisce realisticamente puntare l’attenzione sulle politiche “corollario” del passaggio all’elettrico. Bruxelles ha frenato le sovrainterpretazioni: “nel 2026, valuteremo i progressi compiuti verso l’obiettivo di emissioni zero del 2035. Le clausole di revisione fanno parte di ogni legge europea. Posso assicurare che questa revisione riguarderà solo il modo in cui raggiungeremo l’impegno del 2035, non se vogliamo raggiungerlo”, ha dichiarato il primo vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. Infine, nell’accordo UE è incluso un riferimento ai combustibili «neutri» in termini di emissioni di CO2: previa consultazione, la Commissione presenterebbe una proposta sull'immatricolazione di veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili «neutri» in termini di impatto ambientale dopo il 2035 al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme relative al parco veicoli e in conformità con l'obiettivo della neutralità climatica. Anche se si tratta di una indicazione collocata nei “considerando”, parte non vincolante della normativa, la porta non è chiusa.
Le politiche europee volte al “net zero emissions” hanno l’obiettivo di non aumentare la concentrazione di CO2 in atmosfera e dunque hanno bisogno di soluzioni che siano climaticamente neutre a livello globale dal momento che la CO2 prescinde dal luogo in cui viene emessa.
Nei trasporti ciò che dovrebbe contare è pertanto l'impronta carbonica complessiva delle vetture e dei fuel perché solo in questo modo si può valutare il reale beneficio ambientale delle diverse opzioni tecnologiche. In tale contesto, assume rilievo misurare tali emissioni sull’intero ciclo di vita (LCA) e non solo allo scarico, come al momento prevede la normativa europea, in quanto il controllo esclusivo in questa fase, oltre a trascurare un gran numero di altre emissioni climalteranti generate durante la vita del veicolo, è parziale perché assimila la CO2 riciclata (quella che cioè non genera alcun aumento delle concentrazioni in atmosfera e
dunque è climaticamente neutra), a quella fossile alterando i risultati in termini di effettiva decarbonizzazione dei trasporti.
A tal fine, il Concawe, in collaborazione con Ifpen, ha messo a punto una nuova piattaforma digitale interattiva, denominata “Car CO2 Comparator” in grado di misurare e confrontare le emissioni di gas serra nel ciclo di vita (LCA) delle autovetture e dei combustibili, in base a diversi parametri: powertrains, fuels utilizzati, profilo di guida, intensità carbonica nella produzione di elettricità o di fuels, condizioni ambientali. Ognuno di questi parametri è poi modulabile in funzione del confronto che si vuole fare ed è basato sui dati derivati da analisi specifiche, tra cui gli studi realizzati da Ippc, JRC - Joint Research Center, International Council Clean Transport (ICCT) e Gecoair, nonché le evidenze emerse dalla letteratura prevalente in materia.
Per consultare il comparatore: https://www.carsco2comparator.eu
Le configurazioni possibili sono molte. Qualche esempio mettendo a confronto, nel segmento C, un’auto elettrica (BEV), una ibrida non ricaricabile (HEV) e una Plugin ricaricabile (PHEV) con diversi tipi di alimentazione per le HEV e PHEV.
1) gasolio B7 (cioè quello che troviamo oggi sui punti vendita con il 7% di componente bio)
2) biocarburante avanzato derivato da materiali di scarto di origine organica, utilizzabile in purezza (HVO)
3) carburante sintetico derivato dalla combinazione di idrogeno rinnovabile e CO2 (e-fuel)
4) efuel e zero intensità carbonica per produzione di energia elettrica.
I risultati mostrano come, di fatto, è il metodo di calcolo che indirizza le scelte tecnologiche e non gli obiettivi ambientali. Emerge infatti come con un approccio LCA all’aumentare della quota di componente bio/rinnovabile nei LCF cresce il vantaggio delle HEV e delle PHEV rispetto alle BEV.
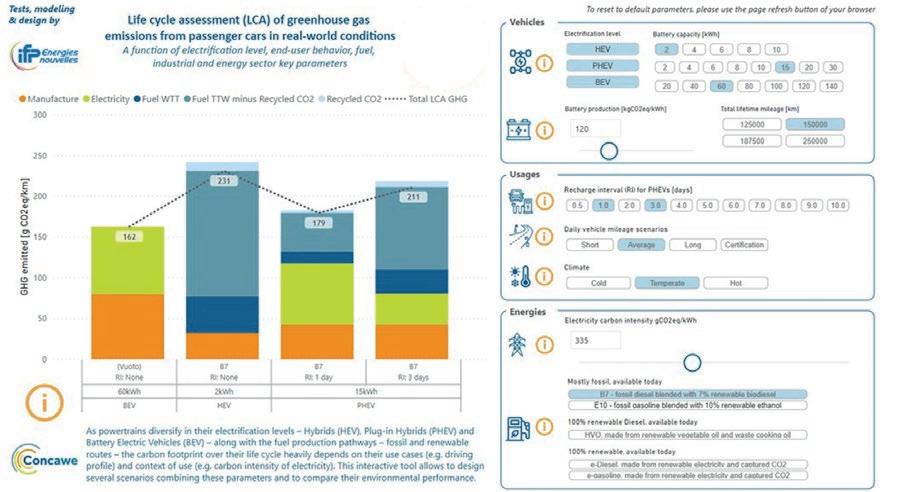
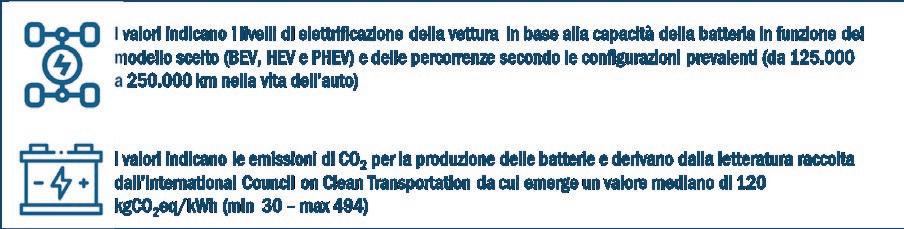
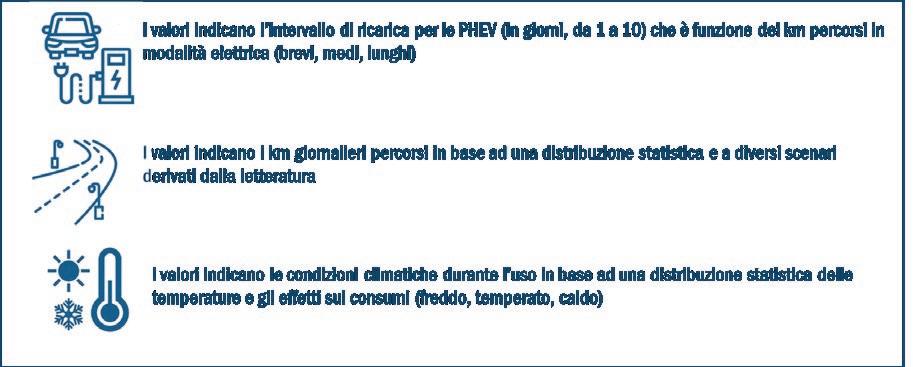

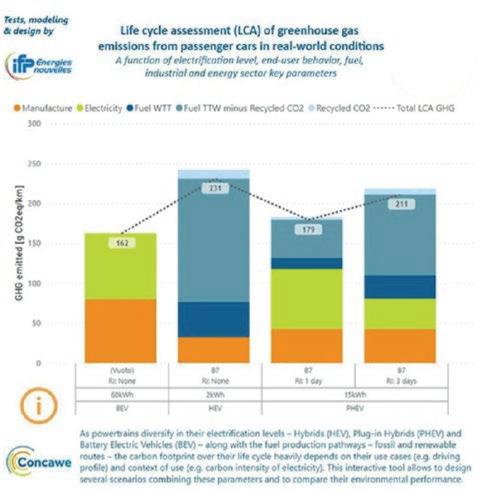
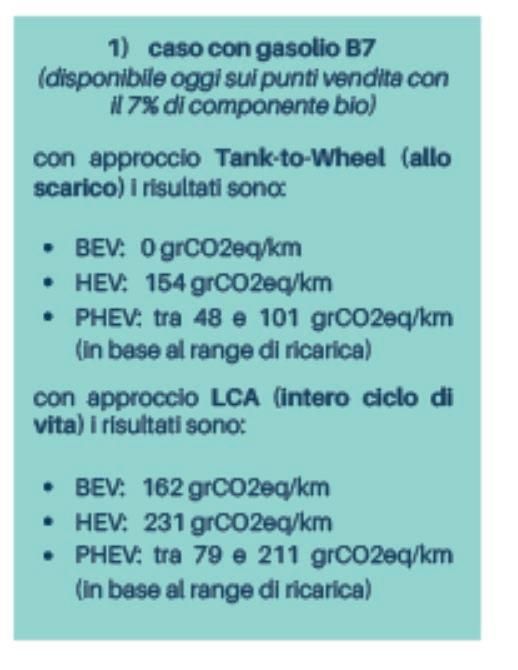

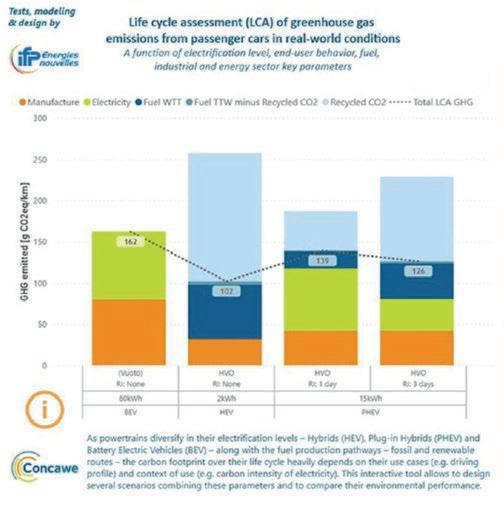





La nuova legge di bilancio sembra aver consolidato il modus operandi affermatosi negli anni precedenti: ritardi nella presentazione del disegno di legge al Parlamento, tempi stretti per la discussione, risorse limitate e una compagine governativa composta da una pluralità di partiti con intenti e priorità a volte divergenti.
Eppure, il percorso di formazione della legge di bilancio 2023 è stato caratterizzato da una novità assoluta. Per la prima volta nella storia del Paese, infatti, le elezioni politiche si sono svolte nel mese di settembre, la XIX legislatura ha preso avvio il 13 ottobre 2022 e il Governo è entrato ufficialmente in carica il 22 ottobre.

L’iter di formazione, pertanto, si è svolto a cavallo tra due governi: il Governo Draghi e il Governo Meloni. Il primo, infatti, ha approvato la NADEF il 28 set-
tembre e il Documento programmatico di bilancio il 10 ottobre, sebbene poi entrambi i documenti siano stati aggiornati dal nuovo Governo. Dunque, complici anche le elezioni tenutesi a settembre, il disegno di legge di bilancio 2023 è stato trasmesso al Parlamento con più di un mese di ritardo rispetto alla data prevista del 20 ottobre, segnando in tal senso un record negativo. D’altronde, è opportuno precisare che tale previsione, da quando è entrata in vigore nel 2016, è sempre stata puntualmente disattesa da ogni Governo.

La principale conseguenza imputabile a tale ritardo è stata senz’altro lo scarso margine di manovra lasciato al Parlamento, dettato dalla necessità di rispettare la scadenza del 31 dicembre e di lavorare a ritmi serrati per scongiurare l’esercizio provvisorio.
Nonostante l’urgenza imposta dalla situazione, i lavori sono proceduti non senza difficoltà di vario tipo, a partire dai ritardi e dagli slittamenti nella consegna degli emendamenti governativi, fino all’abbandono e all’occupazione della Commissione bilancio da parte dell’opposizione in segno di protesta.
L’elemento di anomalia e di novità è rappresentato dal fatto che l’iter di formazione della legge si è svolto a cavallo tra due governi: il Governo Draghi e quello Meloni. Il primo ha approvato la NADEF il 28 settembre e il Documento programmatico di bilancio il 10 ottobre, sebbene poi i documenti siano stati aggiornati dal nuovo Governo
Non sono mancate poi divergenze e frizioni in seno alla maggioranza in merito ai contenuti da inserire nelle misure, tese a soddisfare i rispettivi bacini elettorali. È il caso, ad esempio, degli attriti venutisi a formare tra il Presidente del Consiglio e alcuni esponenti di punta di Forza Italia, che invocavano, tra le altre cose, l’inserimento di uno scudo sui reati fiscali e un intervento più deciso sulla decontribuzione per i giovani assunti. Un maggiore successo è stato invece riscontrato da altre proposte, poi inserite, quali ad esempio la cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro richiesta dalla Lega e una modifica al congedo parentale voluta da Noi Moderati. Il Governo è stato inoltre costretto a non dare seguito ad una serie di disposizioni inizialmente contemplate, passando al vaglio le diverse criticità
In definitiva, sebbene in un contesto politico mutato e per alcuni aspetti con dinamiche differenti, al netto delle inevitabili difficoltà conseguenti al cambio di legislatura di governo in autunno, anche quest’anno la legge di bilancio sembra aver seguito un copione già visto
e modificandole ripetutamente, anche in considerazione del parere formulato dalla Commissione europea sulla manovra, giudicata complessivamente positiva ma con alcuni rilievi critici. Tra questi, in particolare, quelli sui pagamenti elettronici, sul contante e sulle pensioni. E mentre la norma sull’innalzamento al tetto del contante, fortemente caldeggiata dalla Lega, è stata infine approvata, sebbene a seguito di un ridimensionamento dall’iniziale cifra prevista di 10.000 euro a 5.000, l’esenzione dall’obbligo di accettare pagamenti digitali per esercenti e professionisti ha seguito un iter decisamente più travagliato. La soglia, inizialmente fissata a 30 euro, è stata poi innalzata a 60, per essere infine abbandonata a seguito delle perplessità manifestate in sede europea e sostituita con la previsione di istituire un tavolo permanente per valutare soluzioni atte a mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro per i soggetti con ricavi inferiori a 400.000 euro.
Per finanziare tutte le misure inserite nella manovra, che ha un valore complessivo di circa 35 miliardi, il Governo ha introdotto una serie di disposizioni volte a recuperare ulteriori fondi, come ad esempio la normativa sugli extraprofitti a valere sul 2023 e la modifica apportata in corso d’opera all’assegno per il reddito di cittadinanza, passato

da 8 a 7 mensilità per il 2023. Così, come ogni anno, la Commissione bilancio è diventata il teatro principale della manovra, e nella Sala del Mappamondo, per i deputati si sono susseguite notti insonni all’insegna di caffè e di riposi alternati, anche a causa di errori tecnici, come l’approvazione di un emendamento dell’opposizione senza copertura da 450 milioni, affrontando una sorta di maratona contro il tempo.
Nonostante i chiarimenti del viceministro del MEF, Maurizio Leo, sulla mancanza di fondi per approvare gli emendamenti, i gruppi parlamentari ne hanno presentati migliaia, poi ridotti numericamente grazie al sistema degli emendamenti segnalati e supersegnalati. La complessità di approcciarsi alla manovra in tempi così stretti, ad ogni modo, ha infine determinato l’approvazione del testo, in entrambi i rami del Parlamento, con voto di fiducia, dando così vita alla legge n. 197/2022, poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.
In definitiva, sebbene in un contesto politico mutato e per alcuni aspetti con dinamiche differenti, al netto delle inevitabili difficoltà conseguenti al cambio di legislatura di governo in autunno, anche quest’anno la legge di bilancio sembra aver seguito un copione già visto.
Il 2022 si è concluso in un clima di incertezza e preoccupazione: l’anno che doveva consolidare la ripresa post-pandemica è stato invece caratterizzato da una serie di eventi drammatici e da tensioni che hanno coinvolto il settore energetico, che ha reagito con aumenti che, a loro volta, hanno portato a forti spinte inflazionistiche che si sono aggiunte a quelle dei mercati delle materie prime e di molti prodotti di base. L’aggressione della Russia all’Ucraina, con l’invasione di una parte rilevante del territorio di questa repubblica, ha visto il ritorno alle contrapposizioni tra Russia ed Occidente, che sembravano superate con il crollo del muro di Berlino, e la rimessa in discussione degli equilibri geopolitici mondiali con la Cina pronta ad approfittare del conflitto per allargare la sua influenza nel

Il 2022 si è concluso in un clima di incertezza e preoccupazione: l’anno che doveva consolidare la ripresa post-pandemica è stato caratterizzato da una serie di eventi drammatici e da tensioni che hanno coinvolto il settore energetico, che ha reagito con aumenti che, a loro volta, hanno portato a forti spinte inflazionistiche che si sono aggiunte a quelle dei mercati delle materie prime e di molti prodotti di base
mondo a partire dall’Asia, dal Medio Oriente e dall’Africa.
Le conseguenze della crisi sui mercati energetici mondiali, ed in particolare su quelli europei, sono state drammatiche anche se con connotati profondamente diversi da quelle degli anni ’70, nate dalla volontà dei paesi produttori ed esportatori di petrolio di acquisire il pieno controllo delle loro risorse.

La crisi del 2022 è stata invece determinata dalla volontà del presidente russo volta a riacquistare il peso economico e politico perso con il crollo del muro di Berlino.
Tutti i mercati energetici sono stati coinvolti ma in modo differenziato, sia per l’entità degli aumenti, sia per l’impatto a livello geografico, con l’Europa occidentale che ha pagato un prezzo molto elevato.
Il sistema petrolifero nel suo complesso è riuscito a far fronte, con il suo elevato grado di flessibilità, alle nuove sfide geopolitiche e ad una domanda comunque in aumento. Nonostante il contesto molto difficile e le previsioni di un ormai prossimo declino a causa dell’atteso avvento delle rinnovabili, la domanda mondiale ha segnato un aumento di circa 2 milioni b/g rispetto all’anno precedente, toccando circa quota 100 milioni b/g a non grande distanza dal 2019 e confermando il suo ruolo centrale sullo scenario energetico mondiale.
La domanda dei paesi non OCSE, con in primo piano quelli dell’Asia, ha raggiun-
to i 53,8 milioni b/g, con un aumento di un milione b/g rispetto all’anno precedente, nonostante la persistenza di focolai Covid in Cina che hanno portato ad una riduzione della domanda di quel paese da 15,4 a 15 milioni b/g compensata da sensibili aumenti in altre aree a partire dall’India.
Nei paesi OCSE, nonostante le vicende belliche in Europa, la richiesta di petrolio ha continuato a recuperare terreno portandosi a 46,1 milioni b/g rispetto ai 44,6 dell’anno precedente, in netto contrasto con le previsioni di rapida marginalizzazione di questa fonte. Per poter soddisfare i nuovi livelli di domanda, il sistema logistico mondiale ha dovuto affrontare una serie di problemi a causa del progressivo blocco alle esportazioni di petrolio e prodotti russi verso i mercati dei paesi occidentali. Il soddisfacimento della domanda ha richiesto sostanziali modifiche dei flussi di esportazione condizionati dal conflitto con la Russia; questo difficile processo ha fornito un notevole supporto alla lievitazione dei prezzi in un contesto dominato dal progressivo disinteresse a nuovi investimenti in vista della transizione energetica.
In ambito OCSE è stato decisivo l’aumento dell’apporto degli Stati Uniti che ha consentito di raggiungere a tutto l’aggregato il traguardo dei 29,5 milioni b/g nonostante il nuovo calo della produzione europea.
L’OPEC, esclusa la Russia, ha contribuito al bilancio petrolifero mondiale con
circa 35 milioni b/g, in netto aumento rispetto all’anno precedente, evitando che le tensioni sul piano politico e le difficoltà della Russia innescassero una crisi petrolifera mondiale. Anche se sul piano fisico il petrolio non è mai venuto a mancare, le aspettative sull’andamento della domanda, sullo stato delle scorte e sull’atteggiamento dell’OPEC hanno determinato forti oscillazioni, con il Brent che ha raggiunto i massimi dell’anno al momento dell’invasione dell’Ucraina e poi all’inizio della stagione estiva, con oltre 120 dollari/barile in media mensile ; successivamente le quotazioni si sono incamminate su un contrastato trend discendente.
L’Unione europea, che negli ultimi decenni aveva sempre più puntato sulla decarbonizzazione del sistema sino ad assumere il ruolo di portabandiera in questo processo, si è trovata in grandissima difficoltà ad affrontare le conseguenze del conflitto sul mercato del petrolio e su quello del gas naturale. Nel corso degli ultimi anni l’Europa è stata interessata da due fenomeniche ne hanno pesantemente ridotto la sicurezza energetica: da un lato, la progressiva riduzione della produzione interna di idrocarburi, dall’altro, il fortissimo aumento delle importazioni. Nel caso del petrolio, il fenomeno dell’aumento delle importazioni di prodotti si è accompagnato ad una drastica riduzione della capacità di raffinazio-
Nel caso del petrolio, l’aumento delle importazioni di prodotti si è accompagnata a una secca riduzione della capacità di raffinazione. Con la crisi tra Russia ed Ucraina, l’Europa ha dovuto affrontare così due problemi: quello delle ridotte importazioni di petrolio russo relativamente più facile da affrontare; quello ben più grave dei mancati arrivi di prodotti dalle raffinerie russe
ne. Con lo scoppio della crisi tra Russia ed Ucraina, l’Europa ha dovuto affrontare così due problemi: quello delle ridotte importazioni di petrolio russo relativamente più facile da affrontare; quello ben più grave dei mancati arrivi di prodotti e semilavorati dalle raffinerie russe più difficili da sostituire. Le conseguenze di questi squilibri si sono fatte sentire pesantemente con i prezzi delle frazioni medie ed in particolare del diesel, che sono salite ben al di sopra di quelle leggere rendendo così il costo dell’energia per gli utenti europei ancor più pesante. Sul mercato del gas le conseguenze di un sistema poco flessibile imperniato su gasdotti provenienti dalla Russia, che ha progressivamente ridotto i flussi anche come ritorsione alle sanzioni adottate dai paesi occidentali sul piano economico e finanziario, ed anche dell’embargo su una serie di
materiali ed attrezzature di carattere strategico, sono state molto pesanti. I prezzi all’hub Olandese TTF hanno raggiunto, nel momento di massima richiesta per il riempimento degli stoccaggi, il livello record di 344 dollari/ barile rompendo ogni relazione storica con il petrolio.
Nell’ultima parte dell’anno la dinamica dei prezzi degli idrocarburi ha subito un ridimensionamento che ha evitato che il sistema economico andasse del tutto fuori controllo. Le prospettive per il 2023 appaiono dominate dall’incertezza ed in particolare dall’evoluzione di tre variabili: la soluzione, o il proseguimento, del conflitto tra Russia ed Ucraina, per quanto gli ultimi sviluppi purtroppo non siano molto incoraggianti a fronte di bilancio umano e materiale che si fa sempre più pesante; l’altro elemento decisivo è costituito dalla consolidamento della ripresa economica avviata nel 2022, messa a dura a prova dalle misure di contenimento dell’inflazione adottate dalle banche centrali per contenere l’inflazione; il terzo fattore chiave è costituito dalla crescita dell’economia cinese, soggetta a due incognite: quelle sul piano finanziario e quelle legate alla resilienza della pandemia con elevati rischi sul piano interno e internazionale. In questo scenario difficilmente il 2023 potrà essere un anno di svolta per l’economia mondiale, che comunque dovrebbe muoversi su un sentiero di
I ritardi nella transizione
assicureranno al petrolio il mantenimento di un ruolo essenziale nel soddisfacimento della domanda di energia, con una richiesta che secondo i vari centri di ricerca dovrebbe avvicinarsi ai 102 milioni b/g contro i circa 100,5 del 2019, spostando così in avanti l’avvio del declino annunciato per l’inizio del decennio

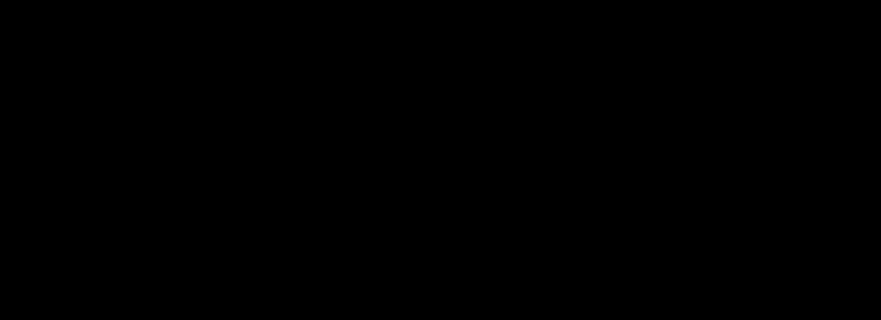
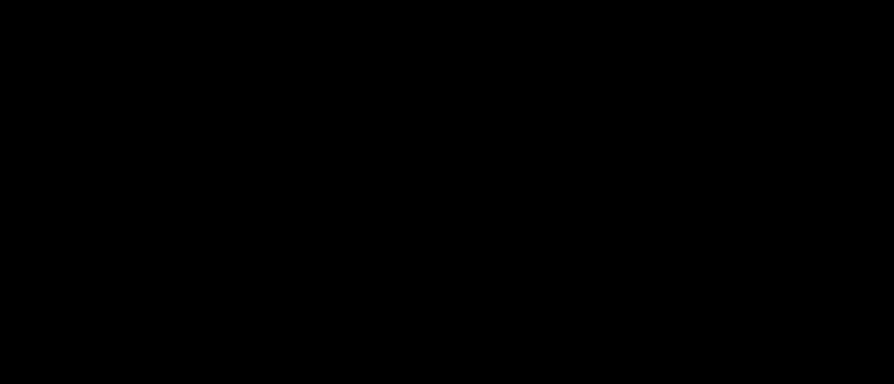
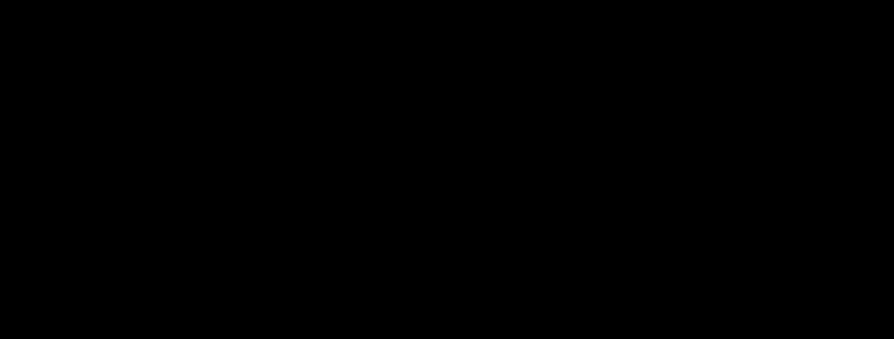
modesta crescita con il supporto delle aree meno esposte alle conseguenze della crisi tra Russia e Ucraina.
I ritardi nella transizione energetica assicureranno al petrolio il mantenimento di un ruolo essenziale nel soddisfacimento della domanda di energia, con una richiesta che secondo i vari centri di ricerca dovrebbe avvicinarsi ai 102 milioni b/g contro i circa 100,5 del 2019, spostando così in avanti l’avvio del declino annunciato per l’inizio del decennio.
Il modo con il quale questa richiesta sarà soddisfatta, ed anche il profilo temporale, avranno un peso determinante nell’evoluzione di prezzi che risentiranno anche dell’atteggiamento dell’OPEC, che vedrà aumentare la richiesta del proprio greggio per la co-
pertura del bilancio globale, e dell’impatto della progressiva riduzione degli investimenti. Le prime battute del 2023 appaiono piuttosto incoraggianti per i consumatori, con il Brent che si sta muovendo intorno agli 80 dollari/ barile rispetto agli oltre 90 del mese di dicembre, ma pur sempre molto lontano dalla media del 2019 pari circa 57 dollari/barile. Anche dal mercato dei prodotti vengono segnali postivi con il ritorno alle quotazioni di inizio 2022, ma il forte differenziale tra benzina e diesel continua a segnalare una situazione di particolare difficoltà per l’Europa, peraltro a poca distanza dall’inizio dell’embargo dei paesi UE nei confronti dei prodotti e semilavorati russi. Nella prima settimana di gennaio anche la quotazione media del gas all’hub TTF,
scesa a quota 65,7 euro/MWh, risulta fortemente ridimensionata e al di sotto dei valori dello stesso periodo di un anno fa. Un segnale certamente incoraggiante per gli utenti finali ma che non può essere interpretato come l’indicazione della fine di una crisi ancora lontana da una stabile soluzione in mancanza di interventi strutturali.
Anche le notizie sul piano dell’inflazione lasciano spazio per un’evoluzione economica meno frenata, percepita anche dai segnali di recupero che si sono manifestati sulle principali borse mondiali. Con un conflitto ancora in atto e con tanti problemi irrisolti sul piano delle politiche energetiche, l’abbandonarsi all’ottimismo sarebbe peraltro il miglior incentivo per il ritorno alle difficoltà drammaticamente sperimentate pochi mesi fa.
energetica
Il nuovo anno inizia con un banco di prova importante per l’Europa dell’energia. Dal 15 febbraio entrerà in vigore il famigerato tetto al prezzo del gas e ci sarà quindi modo di capire se effettivamente il meccanismo produrrà gli effetti promessi o se, più probabilmente, sarà stato solo un contentino dato agli Stati Membri che ne invocavano l’adozione.


Il tetto al prezzo del gas è stato oggetto di una travagliata negoziazione tra Stati che ha visto contrapposti quanti - come l’Italia e la Spagna - ne volevano l’attuazione per limitare la speculazione e altri - come Germania, Olanda e Austria - che si opponevano nel timore che la misura potesse causare rischi per la sicurezza energetica. La Commissione europea, incaricata dal Consiglio di elaborare una proposta in merito, è stata da subito scettica e, nelle diverse versioni della proposta elaborate, ha sempre messo in evidenza i potenziali pericoli della misura.
Dal
L’accordo politico sull’intervento è giunto al Consiglio UE dei Ministri dell’Energia del 19 dicembre. Che cosa prevede la misura approvata? Il meccanismo correttivo ai prezzi del gas, questo il suo nome formale, partirà dal 15 febbraio e sarà attivato al verificarsi simultaneo di due condizioni:
1. quotazione dei prodotti month ahead al TTF superiore a 180 euro/MWh per 3 giorni lavorativi consecutivi;
2. differenza tra quotazione dei prodotti month ahead al TTF e prezzo spot dell’LNG sui mercati globali (calcolato come media di diversi benchmark di prezzo internazionali) superiore a 35 euro/MWh per 3 giorni lavorativi consecutivi In tal caso, il “cap” sarà applicato ai
contratti relativi a prodotti derivati con scadenza a due mesi, tre mesi e un anno. Una volta attivato, al verificarsi delle due condizioni di cui sopra, il meccanismo correttivo rimarrà efficace per almeno venti giorni lavorativi.

Tuttavia, esso non opera come un vero e proprio tetto ai prezzi. Diversamente, le quotazioni sulle varie piattaforme potranno assumere valori superiori a 180 euro/MWh purché si continui a mantenere un differenziale con le quotazioni globali di LNG non superiore a 35 euro/MWh. Detto in altri termini, se l’aumento dei prezzi dipende dagli andamenti dei mercati internazionali, non succederà nulla (come è inevitabile che sia).
Inoltre, potrà essere sospeso in modo automatico al verificarsi di moltepli-

ci condizioni, tra cui le più importanti: quotazioni dell’LNG al lordo del premio di 35 euro/MWh inferiori al valore di 180 euro/MWh; la dichiarazione dello stato di emergenza a livello europeo; qualora, per effetto del meccanismo correttivo, dovessero aumentare i consumi di gas; il verificarsi di una riduzione degli scambi di gas tra Stati Membri o delle importazioni di LNG; pericoli per la sicurezza energetica. L’aspetto “dinamico” del meccanismo e le numerose cause di sospensione fanno comprendere come il compromesso sia andato maggiormente incontro ai Paesi che non volevano il tetto per il timore dei possibili (e plausibili) rischi che avrebbe prodotto sulla sicurezza energetica. Lascia perplessi che si sia diffusa una narrazione fuorviante che attribuirebbe al meccanismo gli effetti degli attuali abbassamenti dei prezzi al TTF che invece sono dovuti esclusivamente a condizioni altre, quali: la riduzione dei consumi delle famiglie per effetto di un autunno e un inverno più miti e quella dei consumi industriali conseguente, soprattutto, agli elevati prezzi del gas dei mesi scorsi. Fenomeni che hanno inoltre limitato l’utilizzo degli stoccaggi. D’altronde, sarebbe davvero sorprendente se un meccanismo
Ancora una volta, la vicenda europea sul tetto al prezzo del gas illustra una UE spaccata. Unita nel definire obiettivi tanto sfidanti, quanto lontani, di decarbonizzazione ma divisa nell’adottare una posizione comune su questione immediate e più problematiche
che entrerà in vigore a febbraio e che ha come trigger la soglia di 180 euro/ MWh avesse spinto al di sotto dei 90 euro le quotazioni del gas a dicembre. La difficoltà a trovare un compromesso ha però rischiato di fare saltare anche l’approvazione degli altri interventi contenuti nella proposta di Regolamento UE nella quale è incluso anche il meccanismo correttivo al TTF. Alla vigilia del Consiglio dei Ministri UE dell’Energia precedente a quello del 19 dicembre, il blocco dei Paesi favorevoli al cap aveva infatti minacciato che, nel caso di mancate revisioni al medesimo rispetto alla proposta originaria (che prevedeva l’attivazione del meccanismo nel caso le quotazioni TTF dei prodotti month ahead fossero state superiori a 250 euro/MWh), sarebbe mancato il voto favorevole
su tutti gli altri interventi proposti. Tra questi: la realizzazione di una piattaforma sugli acquisti comuni di gas a livello UE – la quale è tuttavia obbligatoria solo per il 15% dei volumi necessari a riempire gli stoccaggi degli Stati Membri e non prevede l’obbligatorietà per i medesimi di coordinarsi sulle condizioni economiche di acquisto; la definizione di un nuovo benchmark di prezzo dell’LNG; meccanismi correttivi alla volatilità dei prezzi delle piattaforme nazionali per la negoziazione di gas naturale.
Ancora una volta, la vicenda europea sul tetto al prezzo del gas illustra una UE spaccata. Unita nel definire obiettivi tanto sfidanti, quanto lontani, di decarbonizzazione ma divisa nell’adottare una posizione comune su questioni immediate e più problematiche. Tra chi voleva il cap al prezzo del gas e chi non lo voleva, chi ha perso davvero è l’Unione europea. A quasi dieci anni dal lancio della Comunicazione della Commissione “Unione dell’Energia”, che avrebbe dovuto perseguire la sicurezza energetica dell’Europa, la lotta al cambiamento climatico e la disponibilità di energia a prezzi accessibili per famiglie e imprese, sembra proprio che l’obiettivo sia stato mancato.

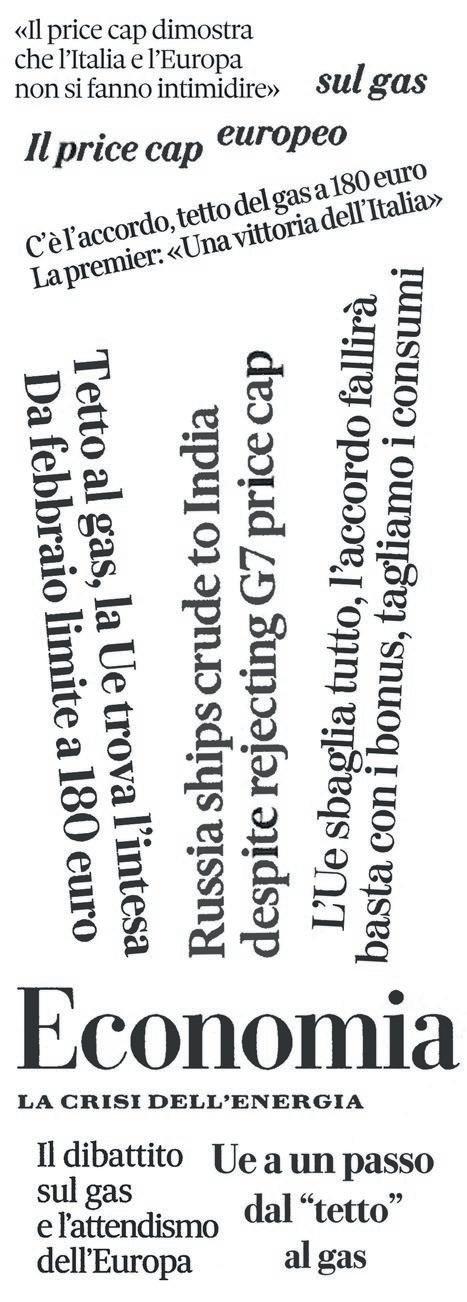
È stato il tormentone degli ultimi sei mesi: l’invocazione di un tetto al prezzo del gas, il famoso price cap, come lo strumento per bloccare la corsa innescata da tempo ma divenuta evidente e allarmante con l’inizio della guerra d’invasione da parte della Russia all’Ucraina. Una misura economica sulla cui realizzazione a lungo si è discusso con grandi titoli sulla stampa italiana e internazionale. Con quali toni l’argomento è stato affrontato dai media? E le reazioni italiane e internazionali sono state uguali? L’approccio ai temi energetici nel linguaggio giornalistico, nell’allarme che si esprime nei titoli è diverso in ogni paese e l’Italia in questo senso sembra il paese che più di tutti ha fatto del price cap un feticcio mediatico.
Così quando il 20 dicembre è stato raggiunto l’accordo che fissava il tetto a 180 euro i titoli sui giornali erano tutti in prima pagina e a caratteri grandi. La vicenda ha assunto subito da noi una curvatura politica perché l’Italia si è intestata l’accordo promuovendolo come uno strumento definitivo per combattere la corsa del prezzo del gas. La proposta era partita nei mesi scorsi, già col governo Draghi, ma l’accordo è arrivato con la nuova legislatura e Il Messaggero lo ha accolto registrando il commento della Meloni: “Vittoria italiana”. Dello stesso tenore le interviste concesse a molti quotidiani dal ministro Pichetto Fratin. Altri, come Libero hanno titolato “L’Europa si piega” in prima pagina e nelle pagine interne “Berlino cede”.
E sulla stampa internazionale? I grandi giornali economici hanno registrato l’accordo sul price cap in maniera molto meno evidente. Il Financial Times del 20 gennaio ne dava notizia aggiungendo che “Gli operatori economici hanno messo sull’avviso perché il price cap potrebbe accrescere la volatilità dei prezzo” visto che i trader avrebbero cercato di aggirare l’accordo. Insomma, l’accordo veniva visto come un possibile elemento di destabilizzazione dei prezzi, piuttosto che un calmieratore.
Già nei giorni successivi sui giornali italiani diventavano più cauti. Si parlava di un buon accordo politico i cui benefici però non si sarebbero riflessi rapidamente sulle bollette. In qualche intervista, come quella di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, su La Stampa intitolata: “Perché l’accordo è un fallimento”, si sottolineava come il price cap avrebbe potuto evitare nuove fiammate ma non alleggerirà il carico sulle famiglie. Tino Oldani avanzava l’ipotesi che i molti paletti contenuti nell’accordo avrebbero rischiato di renderlo inapplicabile. Ma ancora nei giorni successivi, registrando l’abbassamento dei prezzi del gas sul mercato TFT, il Messaggero descriveva questa caduta come un primo effetto del price cap.
Poi il 28 dicembre, è arrivata la risposta di Putin che minacciava di chiudere i rubinetti a tutti quelli che avessero applicato il price cap. Stavolta, con la sua solita flemma, il Financial Times, oltre alla cronaca dell’annuncio russo, fornisce una sua lettura. “La mossa del Cremlino è meno severa dell'opzione di ritorsione più dura lanciata dai media russi”.

Il recente periodo storico ha mostrato con chiarezza come la tecnologia non sia un ambito a sé stante: essa è influenzata e sua volta influenza l’ambiente e la società. Le passate scelte tecnologiche, basate sull’utilizzo principale di fonti energetiche di origine fossile, hanno con evidenza portato all’incremento della CO2 presente in atmosfera – 420 ppm al novembre 2022, e più in generale agli effetti sul nostro ecosistema classificati con il concetto di cambiamento climatico. Non solo, la guerra russo-ucraina ha evidenziato quanto rischioso sia la dipendenza energetica da una principale fonte di approvvigionamento. Nel quadro brevemente descritto, nasce l’esigenza di sviluppare un nuovo
sistema tecnologico ed economico basato sull’utilizzo di fonti rinnovabili (quali fonti energetiche) che sia lungimirante in termini di garanzia di autosufficienza e stabilità geopolitica. Un sistema energetico alimentato da fonti rinnovabili è significativamente diverso da quello alimentato da fonte fossile. Infatti, tale conversione comporta una variazione contestuale anche delle infrastrutture e sistemi produttivi connessi. In particolare, la realizzazione di impianti solari fotovoltaici (PV), parchi eolici, veicoli elettrici (EV) richiede generalmente più minerali rispetto ai loro equivalenti convenzionali (vedi figura – Report IEA). Una tipica auto elettrica richiede sei volte l’input di minerali di un'auto con

Un sistema energetico alimentato da fonti rinnovabili è moltodiverso da quello alimentato da fonte fossile. Infatti, tale conversione comporta una variazione contestuale anche delle infrastrutture e sistemi produttivi connessi. Impianti solari fotovoltaici, parchi eolici, veicoli elettrici richiede più minerali dei loro equivalenti convenzionali
motore termico e un impianto eolico a terra richiede nove volte più risorse minerarie di una centrale elettrica

Quote dei principali paesi produttori di minerali e fossili - 2019

Indonesia
Congo
Filippine
Cina
USA
Arabia Saudita
Russia
Iran
Australia
Cile
Giappone
Myanmar
Perù
Finlandia
Belgio
Argentina
Malesia
Estonia
equivalente a gas. Anche l’economia dell’idrogeno come vettore energetico si basa sull’impiego di minerali, sia per la produzione tramite elettrolizzatori che per il suo utilizzo tramite celle a combustibile.
Poiché le risorse minerarie, al pari delle fossili, non sono rinnovabili, diventa estremamente importante valutare l’andamento tendenziale dei loro consumi, così come la possibilità del loro riciclo e la eventuale disponibilità di nuove risorse non ancora esplorate. Ultimo punto, ma non meno importante, è che lo sfruttamento delle risorse minerarie sta già creando problemi sociopolitici in diverse aree del pianeta, tali questioni vanno quindi considerate attentamente per evitare di inasprire condizioni sociali in particolar modo relative a paesi in via di sviluppo. Chiaro quindi come lo sviluppo di un sistema rinnovabile sia estremamente dipendente da minerali la disponibilità cui è finita ed inegualmente geo distribuita, essi prendono il nome di materiali critici, perché è critico il loro approvvigionamento. In Europa, le materie prime critiche (CRM) – come il litio, il cobalto e gli elementi delle terre rare (REE) – sono materie prime essenziali per l'economia dell'UE. Per la produzione di minerali esistono due fasi principali: 1) estrazione (mining) in genere sotto forma di ossidi; 2) trattamento (refining/processing).
Come si vede dalla tabella seguente (Report IEA), per ciascun minerale esiste un paese principalmente forte nella sua estrazione, questo proprio perché le miniere si trovano concen-
trate in determinate siti geografici. Esempio, vale per la Repubblica Democratica del Congo sul cobalto, e per la Cina che produce circa l’86% della fornitura mondiale di terre rare. Lo stadio di trattamento non è detto avvenga nello stesso luogo di estrazione, il trattamento di tutti i principali minerali critici è concentrato in Cina. Per allineare la richiesta futura di minerali bisogna tenere inoltre in considerazione il tempo di latenza necessario per questo tipo di produzione. In particolare, i tempi dalla scoperta di un nuovo giacimento alla messa in produzione possono avere durate che vanno da pochi anni a decine di anni. In Europa, vista la scarsa padronanza di entrambe le fasi produttive, si è iniziato ad investire molto anche sullo sviluppo di tecnologie e di filiere di riciclo di materiali critici. È stata infatti costituta la «European Battery Alliance» con lo scopo di sviluppare una catena del valore per le batterie, innovativa, competitiva e sostenibile. Per
La UE dovrebbe puntare al mantenimento di tecnologie esistenti non dipendenti dai materiali critici spingendo il loro allineamento agli obiettivi di riduzione emissioni (fuel da produzione sostenibili ed e-fuels) e allo sviluppo di una nuova filiera basata sul riciclo dei materiali critici pronta per quando lo scarto sarà disponibile
alcuni minerali il riciclo è già una soluzione perché tecnologicamente fattibile e perché già ampiamente diffuso nel mercato. Per altri minerali invece bisogna in primis lavorare sullo sviluppo di tecnologie di riciclo efficienti, considerate le basse concentrazioni di minerali nei singoli prodotti. Inoltre, per i materiali relativi a tecnologie il cui sviluppo è previsto in notevole crescita, come il litio per le batterie di auto elettriche, un contributo rilevante dal riciclo potrà arrivare solo dopo il periodo di latenza equivalente alla vita utile del prodotto che permetterà di generare lo scarto, da cui recuperare la materia prima seconda. In conclusione, la transizione energetica necessita l’applicazione di materiali minerali critici. La comunità europea ha un accesso limitato a miniere e siti produttivi di tali materiali. Considerati gli obietti di decarbonizzazione che l’UE si è posta al 2050, il riciclo di tali materie diventa essenziale per assicurare l’approvvigionamento limitando la dipendenza estera. Tuttavia, questo processo non è così semplice e comporta una serie di sfide. In particolare, per quanto riguarda il settore trasporto, la catena del valore delle batterie è dominata dalla Cina. Quindi l’UE dovrebbe puntare al mantenimento di tecnologie esistenti non dipendente dai materiali critici spingendo il loro allineamento agli obiettivi di riduzione emissioni (fuel da produzione sostenibili ed e-fuels) e allo sviluppo di una nuova filiera basata sul riciclo dei materiali critici pronta per quando lo scarto sarà disponibile.
La decarbonizzazione dei combustibili nel settore dei trasporti consente di conseguire una immediata riduzione delle emissioni di gas climalteranti, poiché incide sull’intero parco circolante a livello mondiale a differenza dell’elettrificazione del settore, che necessita invece della riconversione della flotta e della realizzazione delle infrastrutture di distribuzione e ricarica.
La riconversione delle raffinerie, finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2 proprie degli impianti ed alla produzione di combustibili di origine rinnovabile, è certamente un’operazione complessa ma, probabilmente, meno complessa e costosa rispetto alla riconversione dell’industria automobilistica, aeronautica e navale, da condursi in parallelo ad un sostanziale adeguamento del comparto della produzione, dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica. La riconversione del
La UE dovrebbe puntare al mantenimento di tecnologie esistenti non dipendenti dai materiali critici spingendo il loro allineamento agli obiettivi di riduzione emissioni (fuel da produzione sostenibili ed e-fuels) e allo sviluppo di una nuova filiera basata sul riciclo dei materiali critici pronta per quando lo scarto sarà disponibile
settore della raffinazione potrebbe risultare inoltre più rapida e controllabile in quanto localizzata in un numero limitato di grandi siti produttivi, già abituati per la loro natura e per la loro storia pregressa ad un costante adattamento all’evolversi del quadro tecnologico e normativo. La trasformazione di raffinerie in bio-raffinerie si è già dimostrata una via percorribile e profittevole, ma il raggiungimento di più ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione richiede necessariamente di guardare a nuove tecnologie e nuovi combustibili.
Le possibili soluzioni da adottarsi rientrano principalmente nelle seguenti tre categorie:
• Elettrificazione, mediante utilizzo di energia elettrica rinnovabile, delle forniture a bassa, media e alta temperatura tramite utilizzo di pompe di calore o riscaldatori elettrici, finalizzata ad evitare le emissioni di CO2 generate all’interno degli impianti di raffinazione dall’utilizzo di combustibili o stream di processo di origine fossile per sopperire alle esigenze termiche degli impianti stessi
• Carbon Capture and Storage (CCS) della CO2 generata dagli impianti di raffinazione
Carbon Capture and Utilisation (CCU) della CO2 generata dagli impianti di raffinazione per la produzione di e-fuel mediante l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile

Esse possono essere adottate alternativamente, in funzione delle ca-
ratteristiche dell’impianto e del sito dove questo opera, per ridurre l’impronta carbonica della produzione di combustibili fossili, che rimangono comunque il principale prodotto della raffineria. Per una più sostanziale decarbonizzazione della produzione è necessario considerare invece la produzione di e-fuel a partire da CO2 catturata da sorgenti emissive non evitabili (ad esempio dalla produzione della calce), da sorgenti biogeniche (ad esempio dalla produzione di biometano) o direttamente dall’atmosfera.
La disponibilità di idrogeno verde e di un impianto per la produzione di combustibili sintetici rappresentano in ogni caso gli elementi chiave per la potenziale riconversione di una raffineria. Per questa ragione il Progetto E-fuels, coordinato da Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria e tecnicamente sviluppato dai gruppi GECOS e Energy & Strategy, afferenti entrambi al Politecnico di Milano, ha avuto come principale obiettivo lo studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto pilota per la produzione di e-fuel liquidi, in grado di rappresentare una alternativa diretta a benzina, gasolio e jet fuel di origine fossile, tramite il processo Fisher Tropsch (FT). Due diverse alternative impiantistiche sono state valutate e confrontate:
• Nella soluzione e-fuel, il fuel gas di raffineria, viene bruciato per produrre calore utile e successivamente ne viene catturata la CO2. Questa viene
poi miscelata con idrogeno verde; la miscela viene alimentata alla sezione di sintesi, dove viene prodotto un generico combustibile e-fuel. È inoltre possibile sfruttare della CO2 addizionale derivante dai processi di raffineria, in modo da regolare la composizione del gas entrante la sintesi e/o aumentare la produttività del combustibile e-fuel.
• Nella soluzione er-fuel (dove “er” si riferisce a “electrified reforming”), il fuel gas viene alimentato ad una sezione di reforming elettrificato con lo scopo di produrre un syngas ricco di H2 e CO. Il syngas può essere poi miscelato con CO2 addizionale derivante dai processi di raffineria. Il syngas viene infine inviato alla sezione di sintesi per la produzione del generico combustibile er-fuel. In questa casistica non è presente la caldaia convenzionale ed è dunque necessario introdurre un boiler elettrico in modo da compensare il mancato calore prodotto in origine dalla combustione del fuel gas.
La sezione di sintesi differisce in parte a seconda della configurazione adottata, in particolare:
• Nell’ipotesi e-FT, la CO2 catturata a valle della combustione del fuel gas è inviata ad un reattore insieme all’idrogeno verde per convertirla in CO. Nella sintesi FT l’idrogeno e il monossido di carbonio reagiscono per produrre idrocarburi di varia lunghezza, che prendono il nome di syncrude. Gli idrocarburi pesanti e in fase liquida alle condizioni operative di sintesi possono essere estratti dal fondo del reattore, mentre la frazione rimanente del syncrude deve essere raffreddata e frazionata ulteriormente per produrre idrocarburi di media lunghezza, idrocarburi leggeri e separare l’acqua generata nella sintesi dagli altri composti. In questo
modo è possibile ottenere efficienze del carbonio (carbon efficiency CE) prossime all’unità. Il calore necessario a sostenere il reattore deriva da riscaldamento elettrico.
• Nell’ipotesi er-FT, il fuel gas viene compresso e inviato ad un reattore di pre-reforming insieme a vapore acqueo e CO2 addizionale derivante da processi di raffineria, per convertire in metano tutti gli idrocarburi presenti; quindi il syngas viene inviato ad un reattore di Steam Methane Reforming (SMR) elettrificato, per convertire il metano in H2 e CO. A seguito del raffreddamento e della rimozione dell’acqua condensata, il syngas entra in una sezione di lavaggio in modo da rimuoverne la CO2 non convertita, che viene separata e ricircolata al reformer. Il syngas entra poi nel reattore FT da cui viene prodotto il syncrude, che viene quindi frazionato come nell’impianto e-FT.
Dai bilanci energetici condotti risulta che gli impianti er-fuel sono sempre caratterizzati da rendimenti energetici superiori rispetto alle controparti e-fuel, in quanto questi ultimi sono penalizzati dall’elevato consumo elettrico dell’elettrolizzatore e dalle sue perdite. La carbon efficiency (CE) risulta elevata e di circa il 90% in tutti gli impianti. Gli impianti er-fuel ottengono CE leggermente inferiori a causa del metano non convertito nel processo di reforming, che si comporta da inerte nell’unità di sintesi. Su queste basi è possibile immaginare il percorso che una raffineria potrebbe intraprendere verso una progressiva decarbonizzazione:
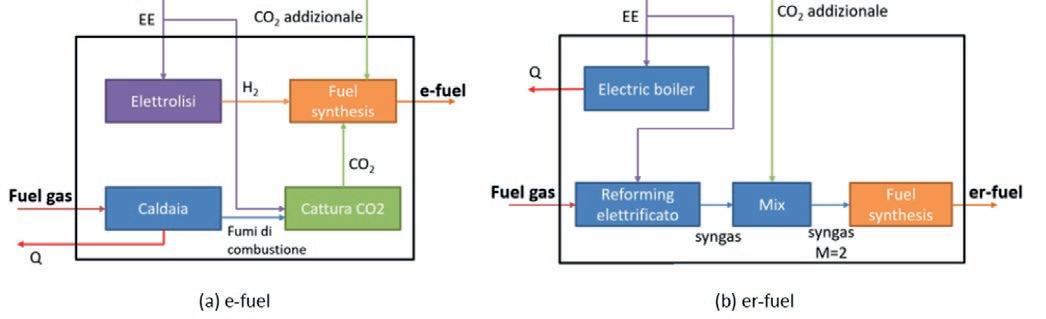
1. Realizzazione di un impianto per la produzione di er-fuel mediante FT, così da ridurre immediatamente le proprie emissioni di CO2 incrementando al contempo la produzione e riducendo la propria impronta
carbonica nel caso di utilizzo di energia rinnovabile, non necessariamente prodotta sul posto
2. Realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde mediante l’adozione di elettrolizzatori di nuova generazione ad alta efficienza e inizio della transizione alla produzione parziale di e-fuel
3. Progressivo incremento della produzione di e-fuel mediante l’acquisizione di CO2 di diversa provenienza (altri impianti industriali, atmosfera)
Un simile percorso può ovviamente risultare più o meno fattibile e costoso in funzione di una innumerevole serie di fattori che incidono in misura variabile sul bilancio finale. D’altro canto, molte sono anche le possibili soluzioni tecnologiche, processistiche e impiantistiche adottabili, che possono rendere percorribili strade alternative, ma tutte finalizzate al medesimo obiettivo di decarbonizzazione del settore della raffinazione e, con esso, fornire un significativo contributo alla decarbonizzazione dell’intero comparto trasporti a livello globale.
Autori:
Simone Casadei, Davide Faedo, Angelo Lunghi e Gabriele Migliavacca (Innovhub Stazioni Sperimentali Per L'industria) Federico D’amore, Matteo Carmelo Romano (Dipartimento Di Energia, Politecnico Di Milano)
Davide Perego (Energy & Strategy, Politecnico Di Milano)
A tre anni dall’inizio della crisi sanitaria, il percorso di “ritorno alla normalità” per la mobilità dei cittadini è ormai concluso e la domanda ha ripreso a correre soprattutto nel 2022. Allo stesso tempo, si è affacciata una seconda grande crisi pervasiva in tutti i settori dell’economia e dei consumi, innestata dal conflitto russo-ucraino


A tre anni dall’inizio della crisi sanitaria, il percorso di “ritorno alla normalità” per la mobilità dei cittadini è ormai concluso e la domanda ha ripreso a correre con una formidabile progressione soprattutto nel 2022. Allo stesso tempo, nell’ultimo anno si è affacciata una seconda grande crisi pervasiva in tutti i settori dell’economia e dei consumi, innestata dal conflitto russo-ucraino, che sta provocando un forte innalzamento dei costi energetici e più in generale dell’inflazione. Lo scenario che si prospetta per il breve e per il medio periodo contiene dunque, come già nell’ultimo biennio, elementi di forte incertezza. Nel quadro confu-
so e caotico a cui si è accennato, il 19° Rapporto sulla mobilità degli italiani di Isfort prova a raccontare come sta cambiando il modello di mobilità degli italiani, tra derive di lungo periodo e pressioni della congiuntura, tra crisi (sanitaria) ormai alle spalle e una nuova emergenza (energetica) in pieno svolgimento.
Guardando i dati sulla domanda di mobilità dei cittadini si può affermare che la grande crisi pandemica prodotta dal Coronavirus è alle spalle. Secondo le stime dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort, in particolare nel primo semestre del 2022, la ripresa della domanda ha sperimentato una

Nel 2019 le «quattro ruote» hanno assorbito il 62,5% degli spostamenti e il 70% dei passeggeri*km; sono percentuali non lontane da quelle registrate nel 2010. Il trasporto pubblico si è fermato in tutti questi anni attorno alla soglia del 10% di share per gli spostamenti e del 20% per i passeggeri*km.
È la prova che le politiche del «riequilibrio modale» nelle ultime due decadi sono state troppo timide e quindi poco efficaci
significativa accelerazione: quasi 100 milioni di spostamenti giornalieri (solo giorni feriali), un volume molto vicino alla soglia pre-pandemica (-6% rispetto al 2019) (grafico. 1). In termini di passeggeri*km (distanze percorse) il rimbalzo della domanda nel 2021 e nel primo semestre 2022 è stato anche più robusto, ma poiché nel 2020 si era registrato un vero e proprio crollo dei passeggeri*km il livello pre-Covid resta più distante (-15%).
Al poderoso rimbalzo della domanda di mobilità ha senza dubbio contribuito la componente della media e lunga percorrenza. La lunghezza media degli spostamenti è infatti cresciuta, nel suo complesso, del +17,2% tra il 2020 e la prima parte del 2022, attestandosi a 10,2 km, valore quasi in linea con quello del 2019. Allo stesso
tempo, la quota delle percorrenze di medio raggio (10-50 km) è passata dal 16,6% del 2020 al 20,2% del primo semestre 2022, a un paio di punti sotto la soglia pre-Covid, e i viaggi di lunga distanza, superiori a 50 km, sono passati dall’1,8% al 2,2%. Va comunque sottolineato che la scala locale di prossimità resta dominante nel modello di mobilità degli italiani. Infatti, gli spostamenti più brevi (fino a 2 km) pesano per quasi il 30% del totale e quelli di scala urbana (2-10 km) quasi per il 50%. Le politiche di settore, prevalentemente guidate dal paradigma delle connessioni di lungo raggio, dovrebbero guardare con più attenzione alla scala urbana e locale dove si concentra al gran parte della domanda di mobilità dei cittadini Passando al dato cruciale sulla scelta dei mezzi di trasporto da parte dei cittadini, i dati sulla ripartizione modale evidenziano uno storico e strutturale orientamento verso l’auto e, simmetricamente, una costante debolezza del mercato del trasporto pubblico. Nel 2019 le «quattro ruote» hanno assorbito il 62,5% di tutti gli spostamenti e il 70% dei passeggeri*km; sono percentuali non lontane da quelle registrate nel 2010 (e anche ad inizio millennio). Il trasporto pubblico si è invece fermato in tutti questi anni attorno alla soglia del 10% di share per gli spostamenti e del 20% per i passeggeri*km. È la plastica dimostrazione che le politiche del cosiddetto «riequilibrio modale» nelle ultime due decadi sono state
troppo timide e quindi poco efficaci. La pandemia ha poi inevitabilmente stravolto i modelli d’uso dei mezzi di trasporto; e tuttavia all’uscita dall’emergenza sanitaria la posizione dominante dell’auto non solo non si è incrinata, ma anzi sembra in fase di ulteriore consolidamento (grafico 2), raggiungendo il 65% degli spostamenti soddisfatti, un punto e mezzo in più del livello pre-Covid. All’opposto la quota di mercato del trasporto pubblico (7,6% nel 2022) è ancora lontana dal già basso livello del 2019 (10,8%). Sintetizzando i dati di ripartizione modale nell’ottica della sostenibilità del trasporto passeggeri (dal lato della domanda), si deve sottolineare con preoccupazione che il tasso di mobilità sostenibile, strutturalmente inferiore al 40% in tutta la serie storica da inizio millennio, si è pericolosamente abbassato sia nel 2021, sia nel primo semestre del 2022 scendendo ben sotto il livello pre-Covid (31,4% nel 2022 contro il 35% del 2019) (grafico 3).
D’altra parte, anche la propensione al cambio modale dei cittadini, intesa come desiderio di utilizzare di meno l’auto a beneficio dei mezzi pubblici e della bicicletta, che normalmente si attesta su livelli alti, nell’ultimo scorcio mostra tuttavia un trend discendente. Ad esempio, per i mezzi pubblici il saldo tra quanti vorrebbero usarli di più e quanti vorrebbero usarli di meno è sceso dal +27,3% del 2019 al +11,4% del 2022, ad ulteriore conferma che
Distribuzione % degli spostamenti per modo di trasporto utilizzato¹
1 Nei mezzi privati sono compresi l’auto privata con e senza passeggeri, i mezzi agricoli, l’auto a noleggio e altri mezzi privati. Nei mezzi pubblici sono compresi tutti i mezzi di trasporto collettivi, urbani (autobus urbano, metro, tram ecc.) ed extraurbani (autobus di lunga percorrenza, treno locale e di lunga percorrenza, aereo, traghetto/nave ecc.), nonché altri mezzi, anche individuali, ma a disponibilità pubblica (taxi, NCC, car sharing, piattaforme car pooling). Gli spostamenti si riferiscono sia al trasporto a compensazione economica (Tpl in generale), sia a quello interamente sul mercato (es. treni AV, segmenti del trasporto pubblico su gomma di lunga percorrenza). Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

la vicenda Covid ha inciso sull’appeal della mobilità collettiva. E su tale dinamica, che porta in superficie chiari risvolti psicologici, ha influito e continua ad influire la percezione di insicurezza da contagio Covid sui mezzi pubblici. Nel 2021 il divario nella percezione di sicurezza tra mezzi individuali e mezzi collettivi è stato molto più elevato di quanto ci si sarebbe potuto attendere, considerando la massiccia campagna di vaccinazione e la riduzione della lesività del virus. Solo nel primo semestre del 2022 gli indici molto bassi registrati dai vettori pubblici hanno iniziato una lenta risalita, ma il gap dai mezzi individuali è tuttavia ancora enorme e costituisce quindi ancora oggi, nonostante l’uscita dall’emergenza sanitaria, uno dei fattori-chiave nella scelta dei mezzi di trasporto. Infine, uno sguardo al mercato dell’auto. Il parco autovetture è continuato a crescere durante la pandemia, nonostante la crisi del settore (circa 1,5 milioni di auto vendute in meno nel triennio 2020-2022 rispetto ai livelli
di mercato del 2019): le auto circolanti sono appena sotto i 40 milioni, circa 100.000 in più rispetto al 2019, con un tasso di motorizzazione salito nel 2021 a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti, il più alto tra i grandi Paesi europei (circa 10 punti in Francia, 15 in Spagna e 9 punti in Germania). Di conseguenza, l’età media delle auto è aumentata nel 2021 a 12,2 anni dagli 11,8 anni del 2020. E nel parco circolante risultano ancora presenti oltre 11 milioni di auto che non superano lo standard emissivo Euro 3 (poco meno del 30% del totale, quota che sale al 40% al Sud). Le alimentazioni “tradizionali” (benzina e gasolio) riguardano circa 35 milioni di auto (l’87,7% del totale), mentre le auto ibride sono circa 1 milione a e quelle elettriche quasi 120mila. Questi numeri, ancorché di scarso peso nel totale, tuttavia sono raddoppiati nel 2021. E guardando alle immatricolazioni la quota della filiera elettrica-ibrida nel 2021 ha sfiorato il terzo del totale, più del doppio rispetto al 2020. Nei primi 11 mesi del 2022 questa per-
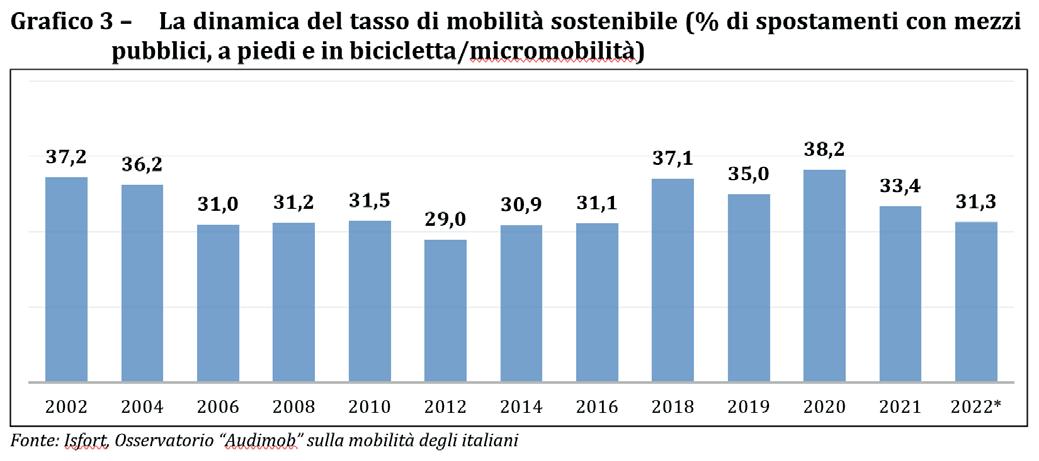
centuale è salita ancora al 42,8% del totale. L’ibrido diventa la motorizzazione più venduta in assoluto nel Paese, ma la componente del full electric vede scendere il venduto di circa un quarto rispetto ai primi 11 mesi del 2021, un rallentamento che non trova riscontro negli altri Paesi europei e che è dovuto presumibilmente alla riduzione degli incentivi normativi.
Guardando alle immatricolazioni la quota della filiera elettrica-ibrida nel 2021 ha sfiorato il terzo del totale, più del doppio rispetto al 2020. Nei primi 11 mesi del 2022 questa percentuale è salita ancora al 42,8% del totale. L’ibrido diventa la motorizzazione più venduta ma la componente del full electric vede scendere il venduto di circa un quarto rispetto ai primi 11 mesi del 2021


La prima cosa da fare è, con due passate di ramazza, spazzare via ipocrisie, sottintesi, luoghi comuni e il vizio di assecondare la corrente perché così fan tutti.
Ecco il primo colpo di ramazza: le grandi fonti rinnovabili d’energia – soprattutto eolico e fotovoltaico – non sono la soluzione; mille problemi e limiti ne vincolano l’adozione; impongono costi economici e impatti ambientali molto alti in genere sottaciuti; in un gran numero di fabbisogni non riescono a sostituire le altre tecnologie energetiche; sono oggetto di speculazione aggressiva e di meccanismi politici di populismo feroce; per il loro ingombro ad alta visibilità, insieme con il loro diffondersi cresce anche l’intolleranza sociale contro di esse.

Ecco il secondo colpo di ramazza per spazzare ipocrisie e sottintesi taciuti: non sono fonti perfette di energia e - almeno nel medio periodo - le sole

Le grandi fonti rinnovabili d’energia – eolico e fotovoltaico – non sono la soluzione: mille problemi e limiti ne vincolano l’adozione; impongono costi economici e impatti ambientali molto alti. Non sono fonti perfette di energia e - almeno nel medio periodo – le sole rinnovabili non basteranno a garantire energia diffusa, economica e sicura. Però le tecnologie rinnovabili sono tra le migliori oggi disponibili
rinnovabili non basteranno a garantire energia diffusa, economica e sicura, però le tecnologie rinnovabili sono tra le migliori oggi disponibili e per questo motivo per anni saranno quelle che cresceranno in modo più vivace. Sicuramente le rinnovabili cresceranno in modo più vivace dei combustibili fossili molti dei quali, ovviamente insostituibili per molte applicazioni ma sostituibilissimi in molte altre applicazioni, sembrano destinati a un graduale ridimensionamento, come dicono
gli scenari dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) diramati in gennaio. In altre parole, i bastian contrari, i pierini e tutti coloro che non amano le rinnovabili se ne facciano una ragione. Grazie alle politiche di promozione dei Governi e al consenso sociale spinto da influencer e trend setter, assecondati dal rating assegnato agli investimenti, le tecnologie fotovoltaiche ed eoliche sono destinate a dettar legge ancora per anni, e con esse anche le tecnologie loro correlate come reti,
accumulatori e così via. Ci sono anche altri fattori di spinta verso le rinnovabili, fattori che non vengono dal mainstream sociale. Sono fattori più congiunturali legati al periodo come – i lettori scusino l’ovvietà ripetitiva - lo shock sui mercati energetici indotto dall’invasione russa dell’Ucraina, il forte aumento dell'inflazione sotto la pressione dei prezzi di energia, le condizioni finanziarie più aspre e la forte dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Questi fattori inducono a rivolgersi verso fonti non fossili, verso tecnologie con un fabbisogno contenuto di capitale, verso energie indipendenti da materie prime energetiche volatili. Qualche confronto. EY (la società di consulenza che una volta si chiamava Ernst&Young) nel dicembre 2022 ha divulgato la nuova edizione del rapporto semestrale Renewable energy country attractiveness index (Recai) in cui vengono allineati i 40 maggiori diversi Paesi secondo la capacità di attrarre investimenti rinnovabili. Sul podio oggi sono Usa, Cina e Germania e l’Italia che rispetto all’estate scorsa ha guadagnato tre posizioni ed è salita dal quindicesimo al dodicesimo posto.
Tra le sfide più significative, il rapporto Recai sottolinea la necessità di rafforzare la cosiddetta resilienza energetica: consolidare la produzione di energie rinnovabili, accelerare la diversificazione delle fonti di produzione di energia e aumentare lo stoccaggio.
Alle spalle di Stati Uniti, Cina e Germania, per appetibilità fra gli investitori seguono Inghilterra, Francia, Australia, India, Spagna, Giappone e Paesi Bassi.
Che cosa spinge gli investitori verso questi Paesi? Gli Stati Uniti richiamano investimenti grazie all'Inflation Reduction Act approvato in agosto e inteso come un punto di svolta green, in particolare nell’ambito dell'idrogeno verde.
La Cina vanta una particolare rapidità di transizione verso le energie rinnovabili nelle politiche per raggiungere una difficile carbon neutrali-

Lente d’ingrandimento sull’Italia: l'eolico registra 11.300 MW di capacità istallata e il fotovoltaico arriva a 23.900 MW e una lista d’attesa di 17.000 MW. Per misurare la “temperatura” rinnovabile può essere utile un dettaglio sul fotovoltaico: alla fine del 2022 erano censiti 1.139.967 impianti solari, in gran parte piccoli e piccolissimi posati sulle falde dei tetti
ty entro il 2060. La Germania afferma di guardare a eolico e fotovoltaico, mentre il Regno Unito vede completarsi e rallentare la grande ondata di investimenti nell’eolico offshore. Va osservato che Paesi come Cina, Germania, e in misura minore Inghilterra, esibiscono potenti muscoli rinnovabili ma sottacciono gli ancora più ingenti investimenti nelle fossili più grevi, come la lignite tedesca che sta sostituendo il nucleare. I Paesi Bassi hanno un programma che include un
obiettivo di 70.000 MW di energia eolica offshore entro il 2050. Interessante anche la Grecia, guidata da nuovi obiettivi di 15.000 MW verdi entro il 2030, di cui 2.000 MW di eolico offshore. Lente d’ingrandimento sull’Italia: l'eolico registra 11.300 MW di capacità istallata e il fotovoltaico arriva a 23.900 MW e una lista d’attesa di 17.000 MW. Per misurare la “temperatura” rinnovabile può essere utile un dettaglio sul fotovoltaico tratto da un rapporto diramato dalla Elmec Solar: alla fine del 2022 erano censiti 1.139.967 impianti solari, in gran parte piccoli e piccolissimi impianti posati sulle falde dei tetti. Lo studio osserva che sono disponibili per accogliere modulo fotovoltaici altri 15 milioni di tetti liberi. Gli uffici commerciali osservino con attenzione il fatto che il Veneto è di gran lunga in testa: chi nel 2022 aveva istallato più moduli solari erano Roma (+43.302); Brescia (+36.455); Treviso (+34.654); Padova (+33.621) e Vicenza (+28.819).
L’energia elettrica è un vettore energetico che viene accumulato con difficoltà, specialmente quando il tempo che intercorre tra l’accumulo e l’uso dell’energia è lungo. La capacità di accumulo è però fondamentale, anche come contributo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Sono diverse le tecnologie usate a questo scopo.
Tecnologie che garantiscono qualità e continuità del servizio elettrico
L’obiettivo è la fornitura di potenza adeguata in tempi brevi (intervallo 1-100 kW, con soluzioni modulari). I tempi di rilascio dell’energia nel sistema sono inferiori al secondo, mentre quelli massimi di fornitura del servizio sono in genere dell’ordine di minuti o decine di minuti.
1) Accumuli elettrochimici, come le batterie nickel-metallo idruro e le batterie al piombo-acido.
2) Accumuli elettrici, come i supercondensatori (energia accumulata sotto forma di energia elettrostatica) e gli accumuli magnetici a superconduttori (energia accumulata nel campo magnetico prodotto da una bobina attraversata dalla corrente).
3) Accumuli meccanici, composti da volani che accumulano l’energia sotto forma di energia cinetica.
Tecnologie per la regolazione di frequenza
L’obiettivo è conservare la frequenza ad un valore constante, anche a fronte di variazioni impreviste.
· Tecnologie “veloci”: accumuli elettrochimici, in particolare batterie litio-ioni e batterie al solfuro di sodio; per contribuire alla “regolazione primaria di frequenza” devono essere in grado di fornire la propria potenza entro 30 secondi dal ricevimento della richiesta e garantirne la fornitura per almeno 15 minuti.
· Tecnologie “lente”: accumuli elettrochimici, quali batterie a flusso (tipicamente vanadio/ vanadio) e allo zinco-bromo, oppure accumuli pneumatici, in particolare accumuli ad aria compressa, o accumuli termici, che permettono di mitigare le fluttuazioni dovute alla potenza prodotta da sistemi alimentati con fonti rinnovabili.
L’obiettivo è superare i limiti delle forme di accumulo tradizionali, grazie ad un nuovo approccio che cambiando il vettore energetico permette l’accumulo a lungo termine. Si tratta di tecnologie ancora allo studio.
• Trasformazione dell’energia elettrica in gas (Power-to-Gas - PtG): un processo che può dare come prodotto finale idrogeno o gas naturale sintetico (GNS), con conseguente necessità di specifiche tecniche adeguate. Ad oggi la modalità prevalente per produrre idrogeno è il reforming del gas metano, che ha come conseguenza l’emissione di notevoli quantità di CO2. La possibilità di usare elettricità (prodotta da fonti rinnovabili) per alimentare elettrolizzatori che producano idrogeno tramite la rottura del legame chimico dell’acqua apre importanti prospettive di decarbonizzazione del settore. Per l’elettrolisi si può parlare di rendimenti compresi tra il 65% e l’80% (secondo la tecnologia utilizzata), mentre il processo di metanazione può arrivare al 78%.
• Trasformazione dell’energia elettrica in liquido (Power-to-Liquid - PtL): grazie all’idrogeno, usato come elemento base nei processi di sintesi successiva di idrocarburi (essenzialmente la reazione di spostamento del gas d'acqua inversa e la sintesi di Fischer-Tropsch), è possibile ottenere catene di idrocarburi come nafta, kerosene, gas petrolio liquido, metanolo ecc. Le efficienze dipendono dalle tecnologie usate e sono comprese tra 55% e 70%, quindi la fornitura di idrogeno prodotto dallo sfruttamento di energia rinnovabile è fondamentale.
Lo stoccaggio di energia coinvolge dispositivi e metodi che assorbono l'energia quando viene generata e la conservano per quando è necessaria. La capacità di immagazzinare grandi quantità di energia in modo economico e per lunghi periodi di tempo serve a migliorare il funzionamento della rete, integrare le energie rinnovabili e aumentare l'a idabilità.
I 4 metodi di stoccaggio più usati
Batteria “grid-scale”
Stoccaggio cinetico; più comuni: volano e aria compressa
Custodia Sottovuoto
Rotore cilindrico
Motore
Volano
Stoccaggio con batterie; più comuni: ioni di litio e piombo
Porta batterie Controllo del fuoco
Celle
Cuscinetto magnetico superiore
Cuscinetto magnetico inferiore
Controllo temperatura
Ventole di raffreddamento
Serbatoio superiore
Pompaggio
Serbatoio inferiore
Scalda-acqua abilitato alla rete
Impianto di stoccaggio a pompa
Energia immagazzinata sotto forma di calore o freddo; più comuni: scalda-acqua controllabili
Pannello di controllo
Accensione e spegnimento del riscaldatore
Regolazione e spostamento del carico
Metodo dell’immagazinamento dell’energia più economico
Generatore
Turbina
Stoccaggio con massa movimentata; più comune: energia idroelettrica pompata
Cosa accadrà nei prossimi anni al settore della produzione di energia dall’atomo? La domanda è rimbalzata su quasi tutti i media mondiali dopo che il 13 dicembre scorso il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti ha dato con una certa enfasi l’annuncio di un risultato sperimentale: per la prima volta da una reazione di fusione nucleare controllata è stata ottenuta più energia di quella che era servita per farla partire.
La fusione nucleare è il processo inverso rispetto alla fissione nucleare. Quest’ultima avviene quando un nucleo atomico di un elemento pesante (come l’uranio) si rompe e viene diviso in due nuclei di atomi più leggeri, le cui masse sommate non raggiungono la massa originaria. La perdita di massa dà origine all’emissione di una grande quantità di energia, secondo la nota
L'energia nucleare costituisce oggi circa il 10% della produzione di energia elettrica mondiale. È diffusa in 32 Stati che ospitano 422 reattori nucleari a fissione per una capacità installata di 378,3 GW. Ci sono inoltre 57 reattori in costruzione, la maggior parte dei quali in Cina, India, Turchia e Russia, con una capacità complessiva di circa 60 GW, mentre 17 reattori hanno sospeso l’attività, quasi tutti in Giappone. Quasi un centinaio sono in programmazione, specie in Asia
equazione di Einstein E = mc2. La fusione consiste invece nell’unione dei nuclei di due atomi leggeri (in particolare deuterio e trizio, due isotopi dell’idrogeno) che danno vita al nucleo di un nuovo elemento (l’Elio) più pesante dei singoli elementi da cui si genera, ma il cui nucleo ha comunque una massa leggermente inferiore rispetto alla somma delle masse dei nuclei di partenza. Dato che “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, anche in questo caso la massa persa si trasforma in energia liberata. Tutta l’energia nucleare prodotta oggi al mondo viene ottenuta con la fissione nucleare, la cui storia è piuttosto recente. Comincia a Roma in un giorno del 1934, quando i ragazzi di via Panisperna guidati da Enrico Fermi bombardano l’uranio con neutroni rallentati grazie a un blocco di paraffina, ottenendo la prima fissione nucleare sperimentale. Da allora passarono 17 anni prima che, grazie a un reattore nucleare, venisse prodotta per la prima volta elettricità per scopi puramente civili. Il 20 dicembre del 1951, infatti, la stazione sperimentale EBR-I, collocata vicino alla cittadina di Arco nello stato dell’Idaho (Stati Uniti), produsse tanta energia da illuminare 4 lampade da 200 Watt. Non era molta, ma era l’inizio di una nuova era. O almeno così si pensava. Da allora molte cose sono cambiate e la fortuna dell’energia nucleare ha conosciuto alti e bassi. In seguito alla crisi petrolifera del 1973, ad esempio, ha avuto una grande espansione, ma dopo i due gravi incidenti di Three Mile


Island (Stati Uniti) nel 1979 e di Chernobyl (ex URSS) nel 1986, il movimento antinucleare è cresciuto portando a una marcia indietro un po’ ovunque e in Italia al referendum che ha chiuso le centrali e bloccato la produzione. All’inizio degli anni Duemila, anche in conseguenza della preoccupazione per le emissioni di gas serra, si ventilava una rinascita del settore con la realizzazione di nuovi impianti, ma l’incidente alla centrale giapponese di Fukushima avvenuto nel 2011 bloccò di nuovo la spinta in avanti.
I dati più aggiornati della IAEA (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica), rilasciati a gennaio 2023, dicono che l'energia nucleare costituisce oggi circa il 10% della produzione di energia elettrica mondiale. È diffusa in 32 Stati che ospitano 422 reattori nucleari a fissione per una capacità installata di 378,3 GW. Ci sono inoltre 57 reattori in costruzione, la maggior parte dei quali in Cina, India, Turchia e Russia, con una capacità complessiva di circa 60 GW, mentre 17 reattori hanno sospeso l’attività, quasi tutti in Giappone. Quasi un centinaio sono gli impianti in programmazione, principalmente in Asia, mentre ad oggi sono gli Stati Uniti d'America ad ospitare la maggior quantità di reattori. In Europa gli impianti nucleari, presenti in 13 Paesi, hanno generato circa il 25,2% di tutta l’energia ottenuta nel 2021. Un dato che è diminuito del 20% dal 2006 ad oggi a causa soprattutto del crollo della produzione tedesca. Questo è lo stato dell’arte sulla produzione di energia elettrica da fissione,
altro capitolo è la ricerca che da anni si concentra sul processo di fusione nucleare.
La fusione nucleare è quella che avviene sul Sole e sulle stelle, ma già dagli anni Cinquanta del secolo scorso si è cominciato a pensare di copiare quello che avviene in cielo per la produzione di energia sulla Terra. In teoria sappiamo che questo processo può produrre un'enorme quantità di energia, e che, come la fissione, non produce inquinanti come l’anidride carbonica in grado di alterare il clima. Inoltre, può presentare dei vantaggi: innanzitutto, mentre i prodotti della fissione sono fortemente radioattivi, il prodotto della fusione è un gas, l’elio, innocuo per gli esseri umani. È vero che i materiali che compongono la parte interna della camera in cui è contenuto il plasma acquistano radioattività e devono essere adeguatamente trattati, ma si tratta di scarti radioattivi di livello medio-basso e quindi richiederebbero solo depositi di superficie. In secondo luogo, la reazione di fusione è intrinsecamente sicura in quanto è sufficiente una variazione rispetto al valore ottimale di densità del gas, temperatura ed efficacia del confinamento del gas stesso affinché la reazione si spenga. Quindi non possono verificarsi incidenti dovuti alla mancanza di controllo della reazione, come invece può avvenire (ed è avvenuto più volte) nel processo di fissione nucleare.

Tuttavia, il processo di fusione in un reattore è cosa complessa, tanto che, dopo tanti anni, siamo ancora in fase sperimentale. Innanzitutto, ottenere una fusione controllata richiede temperature altissime (100-150 milioni di gradi), ovvero quasi 10 volte la temperatura presente al centro del Sole. In anni di tentativi il risultato di ottenere un guadagno netto di energia, ovvero far sì che l’energia in uscita fosse di più di quella utilizzata per innescare la reazione nucleare, non è mai stato raggiunto. Almeno fino ad oggi. Nell’esperimento americano di cui parlavamo all’inizio dell’articolo, infatti, gli scienziati avrebbero centrato questo obiettivo utilizzando un’energia di 2,05 megajoules sul bersaglio per ottenere
3,15 megajoules, con un guadagno di 1,1 megajoules.
L’esperimento è stato eseguito al laboratorio Lawrence Livermore in California. Il laboratorio ha come principale obiettivo lo sviluppo di armi nucleari per il Governo degli Stati Uniti. Tra le numerose strutture contenute al suo interno c’è Il National Ignition Facility (NIF), un’installazione per la ricerca sulla fusione nucleare. La struttura, la cui costruzione è terminata nel 2009 ed è costata 3,5 miliardi di dollari, ha un ruolo importante nella ricerca sugli armamenti atomici perché riesce a mimare un’esplosione nucleare senza bisogno di test come quelli svolti a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale fino all’inizio degli anni Novanta in varie zone del pianeta. Il laboratorio si è ritagliato un ruolo anche nella ricerca sulla fusione da utilizzare per la produzione di energia civile. Il metodo utilizzato al NIF è diverso da quello sperimentato in altri progetti attualmente in corso. È chiamato “a confinamento inerziale” e utilizza 192 giganteschi fasci di laser ad altissima energia per innescare reazioni di fusione dentro al reattore. L’altra tecnologia utilizzata è quella detta “a confinamento magnetico”. In questo caso vengono utilizzati reattori a forma di ciambella chiamati tokamaks entro i quali il gas di deuterio e trizio viene scaldato a temperature così elevate che gli elettroni vengono strappati via dai nuclei creando quello che si chiama “plasma”, una miscela di ioni ed elettroni all’interno della quale i nuclei, scontrandosi ad altissima velocità, si fondono rilasciando energia in forma di neutroni. Il problema di mantenere il plasma all’interno del reattore viene risolto utilizzando campi magnetici potentissimi, il cosiddetto confinamento magnetico.
Questa tecnologia è utilizzata da diversi reattori sperimentali, tra cui ITER, un progetto internazionale che vede la cooperazione tra Unione europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti d'America, Corea del Sud e India. ITER è il progetto più avanzato al momento, in costruzione nel sud della Francia, però non è ancora il prototipo di cen-
Il risultato conseguito nei laboratori Usa per la fusione nucleare è senz’altro interessante dal punto di vista scientifico, ma davvero siamo vicini a risolvere i nostri problemi energetici? Sembrerebbe di no.
Kim Budil, direttore dei laboratori Lawrence Livermorelo ha detto chiaramente: avere elettricità in abbondanza dalla fusione nucleare è un obiettivo per il quale ci vorranno decenni
trale di produzione di energia elettrica ma solo una macchina sperimentale destinata a dimostrare di poter ottenere le condizioni di guadagno energetico necessarie. L’Italia è coinvolta nella progettazione e costruzione del sistema di sospensione magnetica, del sistema di riscaldamento e del condotto di scarico dell’elio. Il primo plasma doveva essere generato da ITER entro il 2025, ma alcuni problemi tecnici ne ritarderanno probabilmente la partenza, secondo quanto affermato da Pietro Barabaschi, direttore del progetto, in un’intervista rilasciata al quotidiano inglese The Guardian il 6 gennaio scorso.
Il risultato americano, quindi, è senz’altro interessante dal punto di vista scientifico, ma davvero siamo vicini a risolvere i nostri problemi energetici? Sembrerebbe di no. Kim Budil, direttore dei laboratori Lawrence Livermore lo ha detto chiaramente: avere elettricità in abbondanza dalla fusione nucleare è un obiettivo per il quale ci vorranno decenni. I problemi da risolvere sono ancora molti. Per quanto riguarda il confinamento magnetico risiedono nel raggiungere le altissime temperature e nel mantenere il plasma stabile e isolato dalle infrastrutture. Per il confinamento inerziale, serviranno laser in grado di fare non uno sparo alla volta, ma diversi al secondo, con energie molto più alte dell’attuale. Infatti, come ha sottolineato un editoriale sul New York Times, è vero che nell’esperimento c’è stato un guadagno energetico, ma l'energia applicata direttamente dai laser è solo una parte dell'energia totale richiesta dall'intero sistema. Il prossimo passo - ottenere così tanta energia dalla fusione da superare l'energia totale prelevata dalla rete - è ancora molto lontano. C’è poi il problema dei costi che al momento, per entrambe le tecnologie, si presentano troppo alti per pensare ad una produzione commerciale.
Il grande fisico Niels Bohr diceva “È difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro”. Mai come in questo caso sembra un’affermazione calzante.
La legge di bilancio è stata appena approvata. Alcuni, con toni più o meno accesi, hanno detto che non era quello che serviva. Cosa si poteva fare di più o diversamente?
C’è sempre qualcuno scontento di qualcosa, soprattutto quando si tratta di un provvedimento così importante e difficile. Siamo arrivati in corsa e abbiamo fatto tutto ciò che ritenevamo importante fare, in tempi brevi, dando priorità nell’ aiutare cittadini e imprese a pagare le bollette e a combattere la povertà energetica.
Sicuramente si poteva fare di più, ma con un pizzico di presunzione, mi permetto di dire, che non avremmo potuto fare meglio di così.
Il nostro impegno è costante e il Governo Meloni sta lavorando giorno e notte per dare al Paese una politica nazionale e internazionale concreta lavorando non solo sulle emergenze,


ma anche con una prospettiva di lungo periodo.
La tassazione degli extra profitti è stata riscritta in linea con quanto previsto a livello europeo. La ritiene una utile misura redistributiva o solo uno strumento per fare cassa?
Per il 2023 le regole cambiano e si allineano al regolamento comunitario del 6 ottobre 2022 che consente agli Stati membri di introdurre un contributo straordinario per far fronte all'emergenza dei costi dell'energia. La nuova tassa che varrà soltanto per il 2023, sarà pari al 50% dell'incremento di reddito complessivo Ires superiore di almeno il 10% rispetto alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti al 2023. Le imprese che saranno chiamate a versare il contributo sono circa 7.000. Sono esclusi tutti colo che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese
che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Si tratta assolutamente di una misura straordinaria, utile e che comporta una ridistribuzione dei costi per far fronte all’emergenza energetica.
Recentemente si è parlato della possibilità di intervenire con modifiche sul PNRR. Ci sono spazi, secondo lei, per correggere alcune forzature in particolare sulle automotive?
L’obbiettivo del Governo è quello di riconvertire e consolidare la filiera nazionale delle automotive per garantire la sostenibilità ambientale. Noi abbiamo 8,7 miliardi fino al 2030 come fondo automotive e ci sono ancora 14 miliardi tra risorse nazionali, Pnrr e IPCEI fino al 2030. Dobbiamo dunque investire verso forme produttive innovative e sostenibili.
In un’Europa scossa dal Qatargate in diversi hanno cominciato ad avanzare il dubbio che le scelte politiche anche in materia di automotive siano state frutto di pressioni esterne. Che
Con il Qatargate sono molti i settori che ne hanno risentito, se non altro in termini di credibilità. Detto ciò non credo che sia opportuno mettere in dubbio le scelte politiche messe in campo nel settore dell’automotive. Credo piuttosto che per la filiera siano stati previsti nel Pnrr fondi che potrebbero non essere sufficienti, visti i cambiamenti che viviamo di mese in mese. Ma in questo faremo di tutto per rendere le procedure più rapide e snellire ove possibile.

Si è anche tornati a parlare di nucleare. Cosa ne pensa?
Che si dovrebbe investire sull’energia nucleare di nuova generazione, come la fusione nucleare. Voglio ricordare la notizia dell’opportunità di un “gua-
dagno netto di energia” (ottenere più energia di quella impiegata per provocare la reazione) nel processo della fusione nucleare a fini energetici, per far fronte al cambiamento climatico con energia pulita riportata ultimamente dal Financial Times che dal Washington Post. Riportano un esperimento effettuato a dicembre 2022 dai ricercatori del National Ignition Facility presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California in cui si utilizza la fusione nucleare in quanto tecnologia molto più sicura della fissione nucleare, poiché la prima non può creare reazioni fuori controllo. La produzione di scorie derivanti dalla fusione sarebbe di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante dalle radiazioni provocate dalla fissione dove
permane la questione dell’utilizzo dei detriti che vengono accumulati in profondità interagendo negativamente con l’ambiente. Non dobbiamo quindi domandarci tra quanto tempo la fusione potrebbe effettivamente alimentare le nostre case, ma pensare che, se i Governi e i privati finanziassero la fusione efficacemente, si potrebbe produrre un prototipo di centrale elettrica a fusione a breve termine. L’Ue ha dichiarato che l’energia nucleare è una delle produzioni meno impattanti quindi noi non possiamo stare fermi a guardare. Non possiamo formare i migliori ingegneri nucleari per poi lasciare che vadano all’estero a fare importanti scoperte. Dobbiamo sfruttare le nostre eccellenze scientifiche per investire nella ricerca.
La legge di bilancio è stata appena approvata. Che giudizio ne dà?
Dal punto di vista del metodo, è stato uno spettacolo indecente. Un livello di approssimazione, superficialità e dilettantismo che non si era mai visto nelle aule parlamentari.
Dal punto di vista del merito, è una manovra sfilacciata che non interviene sui veri problemi del paese (dagli investimenti privati al fisco, dal welfare al supporto alla competitività) ma si limita ad essere un insieme di piccoli favori. Che nella migliore delle ipotesi sono inutili, più spesso sono dannosi.
Lei ha seguito da vicino la vicenda degli extraprofitti. La ritiene una utile misura redistributiva o solo un modo per fare cassa?
Ero contrario – e lo dissi anche a suo tempo – alla versione del governo Draghi, perché la creazione di una base imponibile ad-hoc comporta innumerevoli distorsioni e iniquità. La nuova versione è tecnicamente migliore, ma avrebbe almeno dovuto prevedere la deducibilità della vecchia imposta, ove pagata.
Nel 2023 il Governo ha detto che rivedrà il PNRR. Ci sono spazi secondo lei per correggere alcune forza -
ture in particolare sull’automotive?
Quando si dice “rivedere il PNRR” bisogna intendersi bene su cosa vuol dire. Significa adeguare gli importi nominali all’inflazione, in modo che non sia diminuito il valore reale dell’investimento? O significa ricontrattare le condizionalità in termini di riforme strutturali che sono indigeste all’attuale maggioranza (da quelle sulla concorrenza a quelle sulla lotta all’evasione o la digitalizzazione dei pagamenti)? Perché nel primo caso si troverebbe il nostro sostegno, nel secondo sicuramente no. Se invece si tratta di rivedere parte degli impieghi, allora la risposta ovvia è “dipende da quali”.
In un’Europa scossa dal Qatargate in diversi hanno cominciato ad avanzare il dubbio che le scelte politiche anche in materia di automotive siano state frutto di pressioni esterne. Che idea si è fatto in proposito? Ovviamente non ho nessun elemento che possa farmi propendere in tal senso. Influenzare le decisioni politiche con mezzi illeciti è un’attività antica quanto l’uomo, e in ultima analisi la vera linea di difesa è solo recuperare una religione civile di tutela dell’interesse collettivo da parte di chi assolve funzioni pubbliche. Fino a quando questo processo non sarà completato (ed è compito soprattutto delle nuove generazioni che di volta in volta si affacciano alla vita pubblica),
di Qatar-gate ne vedremo ahimè ancora tanti. Sull’automotive poi è mancato un corretto bilanciamento tra gli interessi dell’industria e quelli, sacrosanti, di tutela dell’ambiente.
Dopo il price cap sul petrolio è arrivato anche quello sul gas. Sono strumenti utili o nascondono le debolezze di un’Europa che sul tema della sicurezza energetica negli anni non ha saputo dare risposte concrete?
La competenza della UE sulle tematiche energetiche è solamente concorrente, e nel tempo si è esercitata quasi esclusivamente nella promozione di una liberalizzazione del settore. Ma le scelte di fondo relative al soddisfacimento del fabbisogno energetico sono saldamente nelle mani degli stati nazionali. I quali in questi decenni sono andati in ordine sparso: dall’investimento in fonti rinnovabili dei paesi del nord, al nucleare francese, passando dalla forte dipendenza di Germania e Italia da petrolio e gas russi.
Per il futuro, mi auguro che la politica abbia la lungimiranza di fare ora le scelte inerenti al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei prossimi decenni, contemperando anche in questo caso l’esigenza di abbattere le emissioni di CO 2 con quelle di assicurare alle nostre comunità la produzione di energia elettrica di cui hanno e avranno sempre bisogno.

novembre
Mentre l’Europa si accinge ad affrontare l’inverno più difficile dalla Seconda guerra mondiale, un coro sempre più nutrito di voci si domanda se il percorso di trasformazione intrapreso dall’automotive – e di conseguenza imposto ai consumatori – abbia davvero un senso, perlomeno come è stato progettato da Bruxelles. Gli ultimi a chiederselo sono quelli di Jato Dynamics. In un recente studio Jato si concentra su due istanze che ritiene dirimenti. Da un lato individua nei costi elevati il limite delle Bev: “Una parte significativa della popolazione è esclusa dalla mobilità elettrica a causa dei problemi legati all’accessibilità economica dei veicoli. Ma ciò comporta un problema di altra natura: “Senza un’adozione di massa delle EV – prosegue Jato – gli obiettivi di riduzione delle emissioni diventano irraggiungibili. (…) Grazie alla forza del mercato interno, al progresso tecnologico, e al persistente sostegno governativo – sostiene ancora Jato - le case cinesi sono in una posizione privilegiata per accelerare i loro piani di espansione globale. Il futuro di Europa e Stati Uniti sembra meno promettente. Nel primo semestre 2022 il prezzo medio di un’auto a batteria si è attestato sui 55mila euro in Europa e sui 63mila dollari negli stati Uniti. La Cina invece è passata da un prezzo medio di 66mila euro ad appena 31mila. I costruttori occidentali stanno spostando il baricentro operativo sempre più in alto, cercando una maggiore marginalità; quando i cinesi si concentreranno sul mass market lo sfondamento della linea sarà drammatico. (…) È paradossale che si stia regalando sovranità ad una economia che dell’ambiante se ne frega e che oggi va all’incasso di una pianificazione partita da lontanissimo
Speculare sui prezzi dei carburanti? È un’accusa senza fondamento, perché tra l'ultima settimana di dicembre e i primi giorni di gennaio il prezzo industriale dei carburanti, stante la sostanziale stabilità dei mercati internazionali, non è variato e la differenza che vediamo oggi è dovuta al solo aumento delle accise», puntualizza l'ingegner Claudio Spinaci, presidente dell'Unem.
“Al momento spiega il capo dei petrolieri italiani-secondo i dati dell'osservatorio ministeriale, in modalità self siamo, come media nazionale, intorno a 1,82 euro/litro per la benzina e a 1,88 per il gasolio, cioè circa 18-19 centesimi in più rispetto a quelli di fine anno. Non vedo dove sarebbe la speculazione se la differenza è pari all'aumento delle accise Iva compresa».


I prezzi salgono nonostante da novembre il Brent costi il 25% in meno...
«Nel serbatoio della nostra auto non mettiamo petrolio ma prodotti derivati dal processo di raffinazione. Quindi, il benchmark per i carburanti non sono le quotazioni del greggio ma le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, il cosiddetto Platts Cif Med. Se guardiamo a questi indicatori e li confrontiamo con i prezzi industriali (cioè al netto delle tasse) dei carburanti, vediamo che da fine novembre ad oggi il Platts per la benzina è diminuito di circa 6 centesimi euro/litro, discesa più che riflessa nei prezzi industriali ridottisi di circa 12 centesimi; il gasolio è invece sceso, rispettivamente, di 4 e 14 centesimi».
Come è possibile risparmiare sul pieno?

«Risparmiare è possibile e spetta al consumatore sapere scegliere l'impianto e la modalità di rifornimento più conveniente. Basta un telefonino.
Per calmierare i prezzi bisogna ripristinare gli sconti?
«Tornare indietro sarebbe insostenibile economicamente visto che il taglio è costato circa un miliardo di euro al mese ed è il motivo per cui è stato eliminato. Occorre quindi un intervento strutturale del sistema fiscale che, tra l'altro, riavvicini le accise del nostro Paese a quelle europee, magari passando anche per la defiscalizzazione della componente bio che favorirebbe un maggiore sviluppo dei carburanti a basse emissioni di carbonio, essenziali per raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione dei trasporti».
"Speculazione? È un'accusa infondata, forse frutto di una percezione errata. Gli allarmi sono a mio avviso ingiustificati". Al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e a quanti nel govemo agitano l'ipotesi della speculazione dietro ai rincari della benzina, compresa la premier Giorgia Meloni, risponde così Claudio Spinaci, presidente dell'Unem, l'associazione che rappresenta le imprese della rafïïnazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi. Dal primo gennaio le accise sui carburanti sono aumentate di 30,5 centesimi di euro per litro considerando anche l'Iva, una decisione del governo Meloni per risparmiare circa 700 milioni di euro al mese. "Tra l'ultima settimana di dicembre e i primi giorni di gennaio il prezzo industriale dei carburanti, stante la sostanziale stabilità dei mercati internazionali, non è variato - spiega Spinaci - e la differenza che vediamo oggi è dovuta all'aumento delle accise. Chi parla di rincari indicando i prezzi di un singolo distributore sbaglia metodo; è la media che conta", spiega Spinaci. È inutile puntare il dito contro un distributore che in autostrada sul servito applica un prezzo di 2,30 euro, anche perché in un mercato frammentato come questo è la concorrenza che tutela i consumatori; "I distributori sono oltre 21.700, la competizione è altissima".
È vero che petrolieri e reti di distribuzione stanno speculando sul prezzo dei carburanti?
«La variazione dei prezzi al consumo riflettono esclusivamente l’aumento delle accise scattato da gennaio - replica Claudio Spinaci, presidente di Unem (ex Unione petrolifera). Anzi, il dato ufficiale emerso dall'ultima rilevazione del Mase ieri dimostra che i prezzi medi italiani dell'ultima settimana sono cresciuti 1-2 centesimi ¡n meno dell'aumento di accise (18,3) e come l'accusa di speculazione sia totalmente infondata e frutto di una percezione errata della situazione».
In Italia perché benzina e gasolio costano di più in Europa?
«Perché abbiamo il peso fiscale più alto ¡n Europa. I prezzi industriali italiani, cioè quelli al netto delle tasse, in media sono più bassi di 3-4 centesimi euro/litro rispetto alla media dell'area euro. Per fare un esempio, in Germania il prezzo industriale del gasolio è più alto di 15 centesimi, ma al consumo è più basso di 3. Un altro esempio è la Spagna che ha un prezzo industriale superiore di 8 centesimi rispetto al nostro ma inferiore di 20 al consumo». Quanto incidono le accise e come andrebbero ridotte? «Sul gasolio accise e Iva pesano per circa il 51% contro una media europea del 45%, mentre sulla benzina si supera il 58% rispetto a una media del 54%. Dobbiamo ricordarci che nel 2021 il gettito delle accise ha contribuito con 25 miliardi (35 Iva compresa) al bilancio dello Stato e quindi sono soldi che andrebbero recuperati in altro modo se venissero meno. Occorre quindi un intervento strutturale sul sistema fiscale, nell'ambito del quale riallineare le accise ai livelli europei, che peraltro renderebbe il nostro Paese anche più competitivo.
II Governo ha sbagliato a tagliare gli sconti?
«Il taglio è costato circa un miliardo al mese ed è il motivo per cui è stato eliminato. Alla lunga è una misura che diventa insostenibile per il bilancio dello Stato».
13
Luca Squeri, deputato, responsabile energia di Forza Italia, cosa sta succedendo sulla benzina?
«È una tempesta in un bicchier d'acqua. A gennaio è venuto meno lo sconto sulle accise e si è riscontato un aumento alla pompa, ma di 16 centesimi quando in realtà il taglio alle accise era di 18. Cito dati del ministero
Che significa questo margine?
“È cominciata una narrazione per cui l’aumento è stato additato come speculazione della distribuzione, si è alzato un polverone che ha portato ad annunciare il decreto
Come giudica la linea del governo?
La scelta di non reiterare il taglio delle accise la condivido. I prezzi di fine dicembre erano inferiori a marzo, quando è stato introdotto. La situazione non è normale ma neanche emergenziale. E lo sconto sulle accise vale un miliardo al mese… Sul decreto dico che è venuto fuori per un presupposto errato. Faccio un esempio: ora c’è un obbligo di comunicare la variazione dei prezzi con sanzioni fino a mille euro. Ora si rende obbligatorio ogni giorno l’invio della comunicazione. Perché? Mi sembrano provvedimenti fatti in fretta”

Sono le ragioni dello sciopero dei distributori?
“Non lo so, ma certo la categoria è già in difficoltà e viene investita da questo pubblico ludibrio… Ai miei tempi si scioperava anche per meno”
La speculazione ad altri livelli c’è?
"Non ce n’è traccia in questo fragente. Lo prova l’aumento inferiore al valore del taglio delle accise. Facendo questa tara in realtà il prezzo è diminuito”.
16 gennaio 2023, Celestina Dominelli
«In Italia prezzi industriali tra i più bassi d'Europa. Ora riordino strutturale»
«In Europa abbiamo i prezzi industriali. cioè quelli al netto delle tasse, tra i più bassi, anche più bassi di quelli della Germania, dove un litro di gasolio, al netto delle tasse costa 15 centesimi in più ma al consumo 5 in meno, o anche della Francia, dove d sono 6 centesimi in più a livello industriale ma 3 in meno alla pompa. Il nostro vero problema è la tassazione che, invece, è la più alta d'Europa: sul gasolio siamo i primi, mentre sulla benzina siamo dietro solo a Grecia e Finlandia. Tassazione che in futuro andrà rivista complessivamente in modo strutturale e non emergenziale».
Claudio Spinaci, numero uno dell'Unione Energie per la Mobilità, va dritto al punto e preferisce far parlare i numeri per respingere le accuse durissime che, in questi giorni, hanno investito il comparto, accusato di aver indebitamente aumentato i prezzi praticati alla pompa. Prezzi che, fa notare l'ingegnere romano, al vertice dell'associazione dal 2015 e che ieri ha preso parte all'incontro convocato dal governo a Palazzo Chigi. «Quello che proprio non riesco a capire è perché, nonostante ciò, si continui a criminalizzare comportamenti che invece sono i più virtuosi che in altri paesi, anche tenendo conto delle tante inefficienze legate a una rete che ha quasi il doppio di quelli di Germania e Francia ed erogati che invece sono un terzo». I numeri sono eloquenti: 21.700 distributori di carburanti con 1.050 metri cubi di erogato medio, a fronte degli 14.439 della Germania (che, però, ha un livello di erogato pari 3.534 metri cubi) e della Francia con 11.160 stazioni di servizio e 3.135 metri cubi di erogato medio. Certo, la realtà italiana, ragiona Spinaci, «è sicuramente diversa da quella tedesca o francese dal punto di vista orografico, del tasso di urbanizzazione e del modello di distribuzione commerciale, ma con una reale riduzione delle aree oil ne guadagnerebbe l'efficienza e ci si avvicinerebbe maggiormente agli standard europei». Ma di quanto dovrebbe essere il taglio. Tenendo conto delle caratteristiche della penisola e della necessità di garantire comunque un servizio capillare. l'asticella potrebbe essere intorno ai 13-15.000. Insomma, il settore ha bisogno di interventi strutturali che, sperano le compagnie, saranno l'approdo finale del tavolo permanente l via da martedì prossimo. Ma, intanto. sulle nuove misure appena assunte dall'esecutivo resta un forte scetticismo. «Si tratta di iniziative che, a mio avviso, sono inutili e controproducenti" chiarisce il presidente dell'Unem. Si rischia di ridurre gli spazi di concorrenza perché potrebbe esserci un livellamento verso il prezzo medio del giorno, inoltre saranno solo nuovi oneri per gli operatori visto che l'adeguamento degli impianti con queste nuove informazioni comporterà costi per decine di milioni».
La mania della bolletta gratuita e eguale per tutti, come un punto di scala mobile pagato dallo Stato. Prima c'è stata la campagna sulle bollette del gas e elettriche, famiglie e imprese strozzate da aumenti da paura. (…) Ci sarà anche un po' di speculazione, come sempre sono sospettati i borsisti di Amsterdam, il gioco dei tulipani che dura dal Seicento, Ma il fenomeno diventa subito da noi romanzo, racconto nero, incubo. Immani risorse vengono dirottate a coprire i costi impossibili dell'energia. La gara del consenso non prevede eccezioni. Si dà la caccia in modo maniacale al riscontro d'opinione, ti pago la bolletta, ti metto in grado di fronteggiare a spese della fiscalità generale l'inazione e la guerra, l'informazione non parla d'altro. Finché si scopre, ma con un poco di buona volontà era chiaro da subito, che l'energia non può essere gratuita e compensata dallo Stato per tutti, che i bilanci delle imprese e delle famiglie, salvo casi davvero eccezionali, sono compatibili con il costo del gas e dell'elettricità, tanto più che in valori relativi questi costi così come sono aumentati in modo abnorme, ecco che decrescono in modo altrettanto rapido e significativo. Però si procede per inerzia. E viene il momento in cui il carburante per auto e autotrasporto sembra essere schizzato a livelli fantastilionici, e invece non è vero, la media del prezzo, fatta salva la fine dello sconto su alcune accise, questione di centesimi al litro, derubricato il differenziale con certe stazioni di pompaggio e rifornimento sulle autostrade, è più o meno quello di prima. (...) Chi vive una vita normale sa che non c'è alcun incubo nell'animo degli italiani, dei consumatori, di chi con il carburante ci lavora, non nella misura indicata dai servizi dei telegiornali e dai notiziari vari dell'apocalisse economica. C'è preoccupazione, sì, con toni e ragionamenti normali. Ci permettiamo anche il lusso di lamentarci di un inverno relativamente mite, chiave di volta insieme alle decisioni dell'Unione europea del calo dei prezzi che ci avevano incantato come una favola, come un fantasy assassino, terroristico. Ci prendiamo in giro da soli, ci esponiamo al ridicolo, e per tanti che gemono sotto il peso di un'economia scarsamente produttiva, di salari ridicolmente troppo bassi, di sindacati che da decenni non fanno il loro mestiere, di imprenditori miopi e taccagni, tanti altri fanno i giocolieri d'opinione con bollette, gas, fonti energetiche varie.
Oil and Energy
Con questo articolo prende il via la nuova rubrica “L’energia spiegata”, curata da Salvatore Carollo, Oil and Energy Analyst and Trader con una lunga esperienza nel settore dell’energia. Iniziamo con un focus sul funzionamento dei mercati petroliferi e della raffinazione, prendendo spunto da quanto accaduto in questo avvio di 2023


Il prezzo dei combustibili per il trasporto in Italia non è sostanzialmente diverso da quello europeo. Siamo vicini alla media dei vari paesi, anche più bassi in molti casi. Le distorsioni che gravano sul nostro sistema nazionale di approvvigionamento fanno parte di una crisi strutturale che grava su tutto il sistema petrolifero del Bacino Atlantico quindi anche su di noi
I recenti rialzi alla pompa dei prodotti petroliferi, benzina e gasolio, ha scatenato un nuovo dibattito tutto incentrato sulla fiscalità che grava su questi prodotti e sulle eventuali “speculazioni” nel settore della distribuzione. A dar forza e supporto a dubbi e sospetti è stata l’osservazione che talvolta al trend in discesa del prezzo del petrolio è corrisposto quello di benzina e gasolio in salita. Purtroppo, la vivacità della polemica politica su temi che hanno una ricaduta
immediata sulle tasche dei consumatori finisce per concentrarsi su tanti luoghi comuni ed aspetti marginali, dando molto meno attenzione ai problemi strutturali del mercato petrolifero internazionale e delle sue ricadute sul sistema di approvvigionamento italiano. Un’analisi approfondita dei dati mette in evidenza una serie di elementi su cui riflettere.
Dal petrolio ai prodotti
Il prezzo dei combustibili per il trasporto in Italia non è sostanzialmente diverso da quello europeo. Siamo abbastanza vicini alla media dei vari paesi, anche più bassi in molti casi. Le distorsioni che gravano sul nostro sistema nazionale di approvvigionamento fanno parte di una crisi strutturale che grava su tutto il sistema petrolifero del Bacino Atlantico e quindi anche su di noi. Ci sono delle particolarità che ci riguardano e che danno una misura della fragilità del nostro sistema di approvvigionamento.
Nelle nostre macchine e nei nostri aerei non mettiamo petrolio, ma benzina, gasolio e jet fuel. Nessuno di noi consuma direttamente petrolio: il petrolio è una materia prima e non un prodotto finito. Questa materia prima va quindi trasformata in prodotti attraverso un complesso processo chimico-fisico su impianti industriali tecnologicamente complessi e costosi, che costituiscono l’industria della raffinazione. L’equivalenza fra offerta di greggio e quella dei prodotti finiti può esistere solo se si dispone di una capacità di raffinazione in grado di trasformare, ogni giorno, il petrolio greggio che esce dai pozzi petroliferi nei prodotti finiti richiesti dai mercati al consumo. Finché avremo bisogno di approvvigionarci di benzina, gasolio e jet fuel dovremo essere sicuri che ci sia abbastanza capacità di raffinazione. Non solo, bisogna che la tecnologia degli impianti sia abbastanza complessa e sofisticata da ottenere, a partire da ogni tipo di petrolio greggio che la natura ci mette a disposizione, la qua-
lità di benzina e gasolio che è richiesta dalle norme ambientali. Più severe sono le norme ambientali, più evoluta deve essere la raffinazione. Quella che chiamiamo “domanda mondiale di petrolio” è in realtà una sommatoria della domanda dei vari prodotti petroliferi, (benzina, gasolio, jet fuel, ecc.). Perché ci sia un equilibrio nel sistema dei prezzi occorre che non solo l’offerta di petrolio greggio ma anche, e soprattutto, quella di prodotti finiti sia allineata alla domanda di questi prodotti sui vari mercati mondiali. Le tensioni che vediamo oggi sul sistema dei prezzi nel mercato internazionale ci dicono che l’offerta di prodotti a valle del sistema di raffinazione non è più in grado di incontrare pienamente la domanda finale sui mercati al consumo, né in termini di volumi né in termini di qualità dei singoli prodotti offerti. Questo problema si è sviluppato in modo preoccupante negli ultimi tre decenni, soprattutto negli Stati Uniti ed in Europa, dove sono state chiuse complessivamente circa 240 raffinerie. Oltre il 50% degli impianti esistenti sono vicini all’obsolescenza e, a meno di investimenti importanti di revisione e potenziamento, si avviano ad essere progressivamente chiusi. Facciamo un esempio per capire meglio di cosa parliamo. Le raffinerie degli Stati Uniti producono circa 10 milioni di barili/giorno di benzine, ma, a causa della inadeguatezza tecnologica, soltanto 3-4 milioni di benzine prodotte hanno una qualità accettabile per essere vendute sul mercato americano. Per poter alimentare il mercato i raffinatori americani sono costretti ad importare dei componenti di alta qualità dal Sud America, dall’India e dall’Europa e mescolarli (in gergo si chiamano operazione di blending) alle benzine da loro prodotte. Senza l’importazione di questi componenti, il mercato americano resterebbe senza benzine oppure dovrebbe rinunciare agli standard di qualità ambientale introdotti nel 2000. Nello stesso tempo, tutte le benzine che non riescono ad essere mescolate con altre di qualità superiore non possono essere vendute sul mercato interno e devono essere esportate verso paesi che ne consumano di qualità inferiore (Africa, Medio Oriente, Asia). Una lettura errata delle statistiche potrebbe far pensare che l’esportazione di prodotti dagli USA sia un segno di eccesso di disponibilità di prodotti. Al contrario è la misura della grave crisi del sistema produttivo.
La domanda di prodotti petroliferi negli USA è di circa 21 milioni di barili/giorno. La capacità di raffinazione realmente utilizzabile è di circa 16 milioni di barili/ giorno. Ne deriva che gli USA dovrebbero importare almeno 5 milioni di barili/giorno di prodotti finiti per coprire la domanda interna. Invece, a causa dei problemi appena descritti, gli USA sono obbligati ad importare prodotti fra 9 e 13 milioni di barili/giorno ed esportano prodotti per 4 e 8 milioni di barili/giorno. Se ci limitassimo ad una lettura dei nudi dati statistici non potremmo capire la reale dinamica del mercato e la fragilità del sistema petrolifero americano. Si tratta di un meccanismo che va in tilt ogni volta che c’è una crisi sui flussi internazionali o quando gli uragani obbligano le raffinerie più sofisticate del Texas e della Louisiana a fermarsi.
Il filetto e la costata
È la conseguenza di alcuni atti legislativi importanti introdotti negli Stati Uniti (Clean Air Act) ed in Europa (2001), che hanno imposto una radicale modifica della qualità dei combustili per il trasporto, intervenendo sulla composizione molecolare dei vari idrocarburi.Perché questi provvedimenti potessero funzionare, ci sarebbero
Immaginiamo, per assurdo, che la UE decida che, dal prossimo mese di luglio, in Europa, l’unico tipo di carne che si possa vendere sia il filetto e la costata di manzo. Quale sarebbe l’effetto sul mercato? A partire da luglio, il prezzo del filetto e della costata schizzerebbe alle stelle, perché non ci sarebbe sufficiente offerta per coprire la domanda complessiva di carne
voluti massicci investimenti nell’industria di raffinazione per adeguare gli impianti e metterli in grado di produrre le nuove qualità di benzina e gasolio. È successo esattamente il contrario.
Le grandi compagnie hanno abbandonato il settore della raffinazione, o chiudendo gli impianti più obsoleti o vendendoli ad operatori minori che si sono limitati a gestire l’esistente. Oggi, il sistema va in crisi costantemente. Per questa ragione Biden, di recente, ha rivolto un appello alle compagnie petrolifere perché investano nel settore della raffinazione. L’appello di Biden è destinato a cadere nel vuoto, a causa
del clima creato dal “verdismo” ideologico. Da decenni ormai è prevalsa una visione della transizione energetica che spinge l’opinione pubblica, la politica ed i governi a ritenere che la fine dell’uso delle fonti fossili per i trasporti avverrà domattina e che quindi da oggi pomeriggio possiamo evitare di occuparci dei problemi strutturali del settore petrolifero e della raffinazione. La recente risoluzione presa ad ampia maggioranza dal Parlamento europeo circa lo stop alla costruzione di veicoli a combustione interna entro il 2035 ne è una dimostrazione clamorosa. Il mercato petrolifero ha reagito a tutti questi provvedimenti con la dinamica dei prezzi tipica dei sistemi caratterizzati da presenza di numerose produzioni associate. Immaginiamo, per assurdo, che la UE decida che, dal prossimo mese di luglio, in Europa, l’unico tipo di carne che si possa vendere sia il filetto e la costata di manzo. Quale sarebbe l’effetto sul mercato?
A partire da luglio, il prezzo del filetto e della costata schizzerebbe alle stelle, perché non ci sarebbe sufficiente offerta per coprire la domanda complessiva di carne. Ma anche il prezzo della mucca salirebbe vertiginosamente, nel tentativo di aumentare in ogni modo l’offerta di filetto e costata. E cosa succederebbe agli altri tagli di carne che non possono essere più vendute? Bisognerà cercare di esportarli verso paesi che non hanno adottato misure simili e che si possono ancora permettere hamburger e salsiccia. E se, progressivamente, tutti i paesi dovessero adottare la stessa legge? Ci sarebbero due risposte. Nel breve si aprirebbe lo spazio del mercato nero. Nel lungo periodo bisognerebbe provare a creare una mucca geneticamente modificata la cui carne sia equivalente a filetto e costata. È un esempio immaginario ma dà una precisa immagine di cosa è successo nel mondo petrolifero. Sotto la spinta del “verdismo” sono state adottate leggi che hanno scassato un settore industriale obbligandolo ad una progressiva scomparsa. La protezione dell’ambiente richiede investimenti e sviluppo tecnologico. Non basta dipingere di verde i muri delle raffinerie o fare indossare magliette verdi agli operatori. La politica si è lasciata trascinare senza alcun senso critico. Altro che correggere le accise. In questo clima, nessun operatore è stato ed è disponibile ad investire
decine di miliardi in un settore la cui sopravvivenza potrebbe essere di così breve periodo da non consentire il recupero degli investimenti. Si naviga a vista sperando che l’esistente rimanga in vita fino al giorno della “mitica” transizione. In caso contrario, arriveremo alla meta a dorso di mulo. Oppure, come succede già negli USA, ad ogni crisi dovremo sospendere le norme ambientali ed ammettere al consumo prodotti più inquinanti.
Il caso italiano si colloca perfettamente all’interno di questo quadro internazionale. Negli anni ’60 e ’70 l’Italia e l’Olanda erano le raffinerie d’Europa che non solo rifornivano gli altri paesi europei, ma esportavano benzine verso gli USA. A partire dagli anni ’80, dopo le grandi crisi petrolifere e dopo l’introduzione di leggi ambientali severissime sulla qualità dei combustibili, la capacità di raffinazione si è più che dimezzata ed oggi non riesce più a coprire interamente i segmenti della domanda del continente, garantendone la qualità voluta. I numeri globali
che appaiono nelle statistiche ufficiali non mettono in evidenza gli elementi critici presenti nel sistema industriale. Apparentemente, a fronte di una domanda di prodotti petroliferi di circa 450 milioni di tonnellate/anno, l’Europa dispone di una capacità di raffinazione di 620 milioni, ovvero di un eccesso di capacità di circa 170 milioni. Non ci dovrebbe essere alcun problema né presente né futuro. Leggendo criticamente i dati viene fuori, però, che gli impianti esistenti sono stati utilizzati al 78%. Ovvero, il 22% della capacità esistente sarebbe rimasta ferma. Nell’ultimo anno, tutti i dati mostrano che i margini di raffinazione sono stati molto buoni. E sappiamo pure che sui mercati c’è stata una mancanza significativa di prodotti finiti. Ne sono prova i prezzi alti registrati da benzina e gasolio. Come mai i raffinatori che disponevano di queste capacità aggiuntive avrebbero rinunciato a questi potenziali enormi guadagni? Evidentemente, la realtà è diversa da quella della statistica. Infatti, siamo di fronte alla mancanza di dati aggiornati

A partire dagli anni ’80, dopo le grandi crisi petrolifere e dopo l’introduzione di leggi ambientali severissime sulla qualità dei combustibili, la capacità di raffinazione si è più che dimezzata ed oggi non riesce più a coprire interamente i segmenti della domanda del continente, garantendone la qualità voluta. I numeri delle nelle statistiche ufficiali non mettono in evidenza gli elementi critici presenti nel sistema industriale
sulla capacità “nominale” di raffinazione, all’interno dei quali risultano ancora impianti che ormai esistono solo sulla carta o che non sono in grado di produrre secondo gli standard europei. La seconda considerazione sui dati statistici riguarda i flussi di acquisto e vendita dei prodotti che sembra ripetere il meccanismo già osservato nel mercato americano. Per coprire una domanda del mercato interno europeo di 450 milioni di tonnellate/anno, il sistema di raffinazione ha avuto bisogno di produrre 490 milioni di prodotti, ma nello stesso tempo di acquistarne sul mercato internazionale circa 300 milioni e di esportarne più o meno lo stesso quantitativo. Se si considera che i prezzi sul mercato interno e quelli del mercato internazionale sono perfettamente allineati, non sembra che questi movimenti siano avvenuti per ottimizzazioni di natura economica. Viene da pensare piuttosto ad una dinamica simile a quella già vista per il mercato americano, ovvero, molte raffinerie non sono più in grado di produrre prodotti finiti con le specifiche ambientali e di qualità richieste dalle norme europee. Solo attraverso l’acquisto di componenti di alta qualità che vengono mescolati a quelli da loro prodotti, riescono a disporre di prodotti finiti da inviare al mercato interno. Nello stesso tempo sono costretti a liberarsi delle produzioni sotto qualità (hamburger e salsiccia) inviandole ai mercati dei paesi con standard inferiori. Il caso italiano sembra la perfetta fotografia su scala più ridotta del problema americano ed europeo. L’utilizzo della capacità di raffinazione è stato del 73%, in linea col dato europeo. Purtroppo, non disponiamo di dati informativi sulla destinazione finale di queste esportazioni per poter qualificare meglio la natura del fenomeno. C’è un altro dato molto preoccupante che non appare immediata-
mente visibile dai dati sulla capacità di raffinazione: l’età degli impianti. Se prendessimo la lista degli impianti esistenti ed accanto ad ognuno di essi scrivessimo la data di costruzione, verrebbe fuori un quadro assolutamente drammatico. La maggior parte degli impianti è stata costruita negli anni ’60 e ’70. L’ultima raffineria costruita in Italia è stata la ISAB di Priolo nel 1976. Proprio la raffineria che sta per essere venduta ad un fondo alle cui spalle sembra esserci una società di trading internazionale che, quasi certamente, sarà più interessata ad operare sui mercati internazionali, più redditizi, piuttosto che sul mercato interno. Per allungare la vita delle raffinerie,
che comunque sono periodicamente soggette a fermate per manutenzione, per il prossimo decennio servirebbero investimenti massicci che, nel contesto culturale e politico attuale, nessuno prenderà mai in considerazione. È tuttavia evidente che senza un upgrading tecnologico tali impianti saranno destinati a chiudere. Dal primo clamoroso episodio del Clean Air Act del 1992, fino al voto del Parlamento europeo del giugno 2022, è stato un susseguirsi di adozione di modelli di gestione della transizione energetica sviluppato senza rispetto della neutralità tecnologica e senza considerazione alcuna per la realtà delle imprese e degli investimenti necessari.
A fronte delle conseguenze dirompenti che già si vanno delineando sul sistema di approvvigionamento dei paesi del Bacino Atlantico, si può continuare a far finta di nulla e scalmanarsi con futili polemiche sulle accise. I problemi rimangono nella loro crudezza e drammaticità e resteranno alla ribalta nei prossimi anni, facendo pagare un costo altissimo specialmente ai ceti più poveri. Forse, la consapevolezza di questa fragilità strutturale avrebbe suggerito più prudenza da parte europea nell’inclusione dei prodotti petroliferi fra le sanzioni alla Russia. Nei prossimi anni vedremo scatenarsi una guerra commerciale fra le due sponde del Bacino Atlantico per accaparrarsi le quote marginali di prodotti petroliferi di alta qualità. La conquista di Priolo, avvenuta nell’indifferenza generale, potrebbe rientrare in questo scenario. La indiscussa vittoria del “verdismo” ideologico non potrà che avere conseguenze gravi verso il nostro paese e verso gli abitanti dei paesi meno sviluppati.


In un mondo profondamente digitalizzato, il tema della cybersicurezza è di vitale importanza per ogni realtà industriale. Però non basta conoscere a fondo i sistemi informatici, ma serve anche stare sempre al passo con le nuove tecnologie e soprattutto nuovi metodi per sfruttarle. Ne abbiamo parlato con Camilla Salini, analista del team di Cyber Security Intelligence inserito nella funzione security centrale di Eni.
Quale è stato il suo percorso formativo?
Il mio percorso formativo inizia con gli anni del liceo. Ho scelto di frequentare il liceo classico Tito Lucrezio Caro di Roma e successivamente a 19 anni ho lasciato l’Italia per studiare in Inghilterra. Ho frequentato un corso triennale in Criminologia alla University of the West of England, grazie al quale ho potuto apprendere e appassionarmi al mondo del crimine, alla scienza che cerca di spiegare perché gli esseri umani commettono crimini e come comprendere e controllare al meglio questo fenomeno. Inoltre, ho appreso tutti quei meccanismi e dinamiche che riguardano il sistema giudiziario e penale di un paese. Tuttavia, è grazie al master in Counter Organised Crime and Counter Terrorism alla University College London che ho potuto farmi strada nel mondo dell’Intelligence, l’analisi delle minacce nel cyberspazio e del contrasto al crimine informatico.
Come è arrivata in questo settore? Il settore ha trovato me. Ed è stata una gran fortuna, visto che proteggere gasdotti e infrastrutture critiche in questo momento storico è, seppur
molto complesso, sicuramente entusiasmante. A maggior ragione, avere a che fare con una azienda che rappresenta una grossa fetta del settore energetico italiano significa in un certo senso occuparsi di sicurezza nazionale. Prima di entrare in azienda avevo già passato due anni come consulente di sicurezza informatica in diverse grandi realtà italiane, per conto una grande multinazionale di matrice giapponese. Mentre ero ancora impegnata come consulente a Torino, sono stata contattata via Linkedin da un recruiter di Eni e successivamente ho affrontato i vari step della fase di assunzione, durante i quali ho cercato non solo di capire se fossi la persona adatta per il ruolo, ma anche se l’azienda fosse un ambiente adeguato alle mie esigenze.
Quale è il suo ambito di attività? Eni ha creato nel 2016 il Cyber Threat Intelligence Center, noto come ETIC, dove i due team di Cyber Intelligence di SECurity (CISEC) svolgono attività di studio e analisi delle minacce cyber. Lo scopo di questa disciplina è non solo analizzare ed attribuire gli attacchi informatici, ma prevenire che accadano operando in maniera proattiva, analiz-

zando dati e informazioni che possono provenire sia dall’esterno tramite risorse e report ufficiali o del settore, sia dall’interno tramite dati raccolti dai nostri asset aziendali o segnalazioni interne. Per poter fare ciò, è necessario non solo conoscere il perimetro e gli asset aziendali, ma anche stare al passo con dinamiche esterne che possono impattare non solo l’azienda, ma anche il settore energetico più in generale, come ad esempio cambiamenti a livello geopolitico. Eni ha messo insieme un team multidisciplinare, dove le competenze di ogni membro, molto specifiche e diverse tra loro, possono arricchirsi a vicenda e fornire prospettive diverse rispetto a un quesito o problematica.
È soddisfatta di questa esperienza? Si sentirebbe di consigliarla ai giovani? Sono estremamente soddisfatta di questa esperienza. Tra i lati sicuramente positivi, insieme a quello di lavorare insieme a dei colleghi che sono dei professionisti di altissimo livello che quotidianamente mi trasmettono le loro conoscenze, c’è quello di rappresentare un’azienda leader del settore energetico in un ambito internazionale. Inoltre, visto che questo mestiere prevede non solo di conoscere a fondo i sistemi informatici ma anche di stare sempre al passo con le nuove tecnologie e soprattutto con i nuovi metodi per sfruttarle. L’azienda ha preso in carico la mia formazione, prevedendo un budget annuale che mi ha già permesso di frequentare corsi di altissimo livello e altamente specializzati. Quindi, per me questo è un ambiente di crescita, rispetto e obbiettivi reciproci dove trovo soddisfatti i miei bisogni di giovane e appassionata lavoratrice. Per questo motivo mi sento di consigliarla ai giovani che stanno approcciando il mondo del lavoro.
Anche per il 2023 unem sosterrà il Sapienza Gladiators Racing Team, la squadra di cui fanno parte studenti e studentesse della facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, che sta lavorando alla nuova moto che parteciperà al concorso internazionale Motostudent che vedrà la tappa finale ad ottobre sul circuito spagnolo di Aragon. Ecco a che punto sono.


Per la progettazione della moto 2023 il team ha seguito il principio di semplicità e funzionalità, con l’obiettivo di creare un base ottimale da perfezionare nelle edizioni successive, che useranno lo stesso motore di quest’anno. Le differenze rispetto alla precedente moto riguardano l’aerodinamica, che è stata studiata più accuratamente e sarà prodotta con standard qualitativi maggiori, tale da raggiungere un’efficienza simile alle moto usate nelle competizioni ufficiali. Quest’anno, poi, il nuovo motore fornito dagli organizzatori è più leggero, più potente e meno ingombrante, ed è stato così possibile realizzare una moto più prestante. Inoltre, il Sapienza Gladiators Racing Team ha deciso di prestare ancora più attenzione all’ergonomia, in modo tale che il pilota possa controllare la moto ancora meglio e con maggiore sicurezza. Il team sta lavorando in sotto-gruppi, ciascuno dedicato ad uno specifico ambito. Il lavoro fatto dal reparto ciclistica è partito dalla moto del 2021. Il cambio di motore di quest’anno, però, ha reso necessaria la riprogettazione di ogni componente praticamente da zero. La sfida più grande è stata dunque fare tutto in soli sei mesi, per fornire gli ingombri il
prima possibile agli altri reparti. La fase di progettazione ciclistica è terminata così ad ottobre e si è entrati in produzione a fine novembre. La progettazione ha riguardato le tre parti della moto - anteriore, centrale e posteriore - ed è inoltre stata divisa in due fasi: la prima relativa alle parti di maggiore complessità produttiva, in modo da massimizzare i tempi per la produzione dei componenti da parte delle aziende del settore; la seconda, completata in un secondo momento, ha riguardato invece i componenti meno complessi che possono essere prodotti nei laboratori dell’università. Il reparto aerodinamica si è dato come obiettivo migliorare il lavoro fatto nell’edizione precedente ed eliminare le criticità che si erano presentate. In particolare, il reparto si è impegnato per riuscire a veicolare quanta più aria possibile al radiatore, mantenendo sempre basso il coefficiente di attrito aerodinamico, per permettere al motore di operare sempre nel range di temperatura ideale. Inoltre, il gruppo si è concentrato nello sviluppo di una presa dinamica quanto più efficiente possibile, per poter sovralimentare il motore tramite l’airbox. Ad oggi, il reparto ha completato la progettazione di massima di tutti i componenti e si sta accingendo ad effettuare la progettazione finale.Il reparto elettronica si è occupato della progettazione del cablaggio, per avere un riferimento nel momento in cui si assemblerà la moto e lo si installerà. Successivamente, si occuperà dell’acquisizione dati, per ve-
rificare che la moto rispetti i parametri di progettazione ed eventualmente capire come ottimizzare le prestazioni. Infine, si occuperà della mappatura del motore, variando i parametri di aria e benzina per ottenere una erogazione della potenza pienamente sfruttabile dal pilota. Il reparto motore lavora sul motore fornito dall’organizzazione, che per questa edizione è un motore KTM 250 SX-F, di derivazione cross e di caratteristiche pari ai motori utilizzati in premoto-3. Il reparto sta terminando la progettazione dei sistemi di aspirazione e scarico. Inoltre, si sta occupando insieme al reparto di aerodinamica della progettazione del sistema di raffreddamento e della presa dinamica, per ottenere il miglior compromesso tra le necessità di fornire quanta più aria possibile al motore e quella di ridurre al minimo il coefficiente di attrito aerodinamico. Il tutto anche per superare le criticità sulle temperature riscontrate nell’edizione precedente. Al reparto di marketing il compito di curare l’immagine del team, sia verso il pubblico che nei confronti degli sponsor. Il reparto operations, infine, ha il compito di coordinare il lavoro di tutto il team, facilitando la comunicazione e l’interconnessione tra i reparti. Si occupa inoltre del business plan, della gestione delle risorse e delle relazioni da fornire all’organizzazione del Motostudent. Il lavoro è attualmente in corso per terminare la progettazione e la produzione e passare poi alle prove su strada, fino alla gara sul circuito di Aragon in Spagna.
• Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, “Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 22 novembre 2022)

Fornisce indicazioni per l’uniforme indicazione dei contenuti dell’etichettatura ambientale degli imballaggi con riferimento al materiale del contenitore su cui è apposta sia riguardo alle modalità di corretto smaltimento da parte del consumatore finale.
• Legge n. 175/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR” (G.U. n. 269 del 17 novembre 2022)
In sede di conversione del cd. “Aiuti-ter” non sono state apportate modifiche sostanziali sui temi indicati su muoversi n. 4/2021.
• Decreto-legge n. 176/2022 recante “Misure urgenti di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica” (G.U. n. 270 del 18 novembre 2022)
Il cosiddetto decreto-legge “Aiuti-quater” prevede, tra l’altro:
• Art. 1 – Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022, utilizzabile fino al 30 settembre 2023
• Art. 2-bis – L’articolo, inserito dalla Commissione Bilancio in Senato, proroga i termini relativi al credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
• Art. 4 – Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
• Art. 8 – Misure in materia di mezzi di pagamento (credito di imposta per adeguare il registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla lotteria degli scontrini).

Al momento, il disegno di legge di conversione del provvedimento è all’esame del Parlamento. In particolare, il Senato ha approvato due emendamenti:
• Art. 4-bis – L’articolo, aggiunto con un emendamento dalla Commissione Bilancio del Senato, prevede una serie di disposizioni per l’impiego di combustibili diversi dal gas per gli impianti industriali e, in particolare, stabilisce che la sostituzione e le modifiche tecnico-impiantistiche debbano essere qualificate come modifiche non sostanziali
• Art. 6-bis – L’articolo, inserito dalla Commissione Bilancio al Senato, disciplina la promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza, prevedendo che l’immissione in consumo dai soggetti obbligati sia pari almeno a 300.000 tonnellate per il 2023, con un incremento di 100.000 tonnellate all’anno fino a 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.
• Decreto-legge n. 187/2022 recante “Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici” (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2022)
Il decreto prevede:
• Art. 1 – Le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi devono garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti
• Art. 2 – Misure economiche connesse all’esercizio del golden power (misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa o accesso a interventi erogati dal patrimonio destinato).
• Decreto ministeriale (ex MISE) del 21 ottobre 2022 recante “Criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale” (G.U. n. 297 del 21 dicembre 2022)
• Legge n. 197/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43)
Si evidenziano, in particolare, i seguenti commi della “Legge di bilancio”:
• Commi 2-9 – Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta pari al 35% o 45% a seconda delle casistiche, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
• Commi 11-12 – Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 kW per il primo trimestre 2023
• Commi 13-14 e 16 – Riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri generali per il primo trimestre 2023 nel settore del gas, per l’energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia e per le forniture di servizi di teleriscaldamento
• Commi 30-38 – Applicazione di un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023
• Commi 39-40 – Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi
• Commi 45-51 – Estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il primo trimestre 2023
• Comma 64 – Differimento dei termini al 1° gennaio 2024 per la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla sugar tax e alla plastic tax
• Commi 115-119 – Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, per taluni soggetti inclusi quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, determinato applicando un’aliquota del 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai
fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede almeno del 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022
• Commi 120-121 – Modifiche al contributo di solidarietà temporaneo per il 2022 prevedendo, in particolare, che il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume di affari dell’anno 2021 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione o estrazione di gas metano, di rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi
• Commi 148-150 – Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA
• Commi 174-178 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
• Commi 179-185 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
• Commi 186-205 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
• Commi 206-212 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
• Commi 213-218 – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
• Commi 265-269 – Crediti di imposta per il Mezzogiorno e ZES
• Comma 272 – Certificazione per la qualificazione degli investimenti
• Comma 306 – Lavoro agile per i soggetti fragili
• Commi 384-388 – Disposizioni in materia di mezzi di pagamento
• Commi 471-472 – Buono portuale pari all’80% della spesa sostenuta dalle imprese titolari di autorizzazione e concessione portuale per la qualificazione del lavoro portuale
• Commi 503-504 – Disposizioni per il sostegno del settore dell’autotrasporto.
• Decreto-legge n. 198/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022)
Si evidenziano, in particolare, i seguenti articoli del cosiddetto “Milleproroghe”:
• Art. 10 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (TPL, concessioni autostradali, trasporti in condizione di eccezionalità, procedura negoziata per le aree di crisi industriale)
• Art. 11 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, piani di azione, sospensione modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)
• Art. 13 – Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (operazioni di patrimonializzazione per soggetti che esportavano verso Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia, finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici).
• Decreto-legge n. 2/2023 recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2023)
Capo II – Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale.
Eni ha annunciato la creazione di Eni Sustainable Mobility, la nuova società dedicata alla mobilità sostenibile, con l’obiettivo di fornire servizi e prodotti progressivamente decarbonizzati per la transizione energetica, accelerando il percorso verso l’azzeramento delle emissioni lungo il loro intero ciclo di vita. Nella società, informa una nota, sono confluiti gli asset della bioraffinazione e del biometano, che includono le bioraffinerie di Venezia e di Gela e lo sviluppo di nuovi progetti quali Livorno e Pengerang, in Malesia, oggi in corso di valutazione; il marketing e la commercializzazione, attraverso una rete di oltre 5.000 punti vendita in Europa, di tutti i vettori energetici tra cui l’idrogeno e l’elettrico, i carburanti anche di natura biologica come l’HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) e il biometano, nonché gli altri prodotti per la mobilità come i bitumi, i lubrificanti e i combustibili e tutti i servizi connessi alla mobilità, come il car sharing Enjoy, la ristorazione e i negozi di prossimità nei punti vendita sul territorio.
Accordo Eni- DHL per sperimantazione biojet a Linate e Malpensa
Accordo tra Eni e DHL Express Italy, che gestisce l’aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate, per la sperimentazione, su 28 voli in partenza da Malpensa, di Eni Biojet, il SAF (Sustainable Aviation Fuel) miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti nella raffineria di Livorno in sinergia con la bioraffineria Eni di Gela.
Itelyum lancia l’iniziativa “1.000 x 1.000”
Itelyum ha lanciato l’operazione “1.000 per 1.000” che prevede l’erogazione di un bonus straordinario di 1.000 euro per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici per far fronte al caro energia e all'inflazione, nel segno della vicinanza e dell’inclusione. La cifra, spiega un comunicato, sarà erogata sotto forma di fringe benefit nella busta paga di dicembre, come rimborso per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, oltre che delle spese di trasporto personale.
Accordo Neste e Brussels Airlines
Brussels Airlines, la compagnia di bandiera del Belgio e parte del Gruppo Lufthansa, è la prima compagnia aerea a ricevere una consegna di Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ all'aeroporto di Bruxelles per la prima volta, utilizzando il NATO Central European Pipeline System (CEPS). Il carburante per l'aviazione è fornito da CEPS agli aeroporti commerciali in Europa e dal 1° gennaio 2023 questi aeroporti possono anche ricevere carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) attraverso questo sistema di condotte.
Neste rafforza i progetti di idrogeno verde della raffineria di Porvoo
Neste ha ricevuto un finanziamento pubblico di 27,7 milioni di euro per progetti di idrogeno verde presso la raffineria di Neste a Porvoo, in Finlandia, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni per la produzione di idrogeno rinnovabile. L'obiettivo di Neste è rafforzare la catena del valore dell'idrogeno europeo ed essere in prima linea nella produzione e nello sviluppo di soluzioni di idrogeno rinnovabile.
Memorandum d’intesa NextChem e Suez International Italian Branch
Maire Tecnimont ha annunciato che NextChem, attraverso la controllata MyRechemical, ha firmato un Memorandum d’intesa con SUEZ International Italian Branch volto a sviluppare ulteriormente la collaborazione esistente sui progetti Waste-to-Chemicals in Italia. NextChem e SUEZ stanno già collaborando con successo su diversi progetti e studi di fattibilità in Italia, tra cui il progetto Waste-to-Methanol & Hydrogen a Empoli, che si basa sulla tecnologia Waste-to-Chemicals di NextChem.
Q8: sottoscritto nuovo accordo collettivo con i gestori
Q8 Italia e le associazioni dei gestori (Faib, Fegica e Figisc) hanno annunciato la sottoscrizione di un nuovo pacchetto di accordi collettivi aziendali che comprende, oltre al rinnovo degli accordi valevoli per i gestori di rete ordinaria che operano con contratto di fornitura, l’istituzione del primo esempio di organismo bilaterale, pariteticamente rappresentato, nel settore della distribuzione carburanti. A questo Organismo sono state assegnate, tra l’altro, funzioni conciliative delle vertenze individuali, non sostitutive della tutela legale prevista; la redazione delle linee guida per la formazione professionale dei gestori; l'attività di studio funzionale alla negoziazione collettiva, la ricerca di strumenti di finanza agevolata volta all'avvio, al sostegno ed al completamento delle attività svolte dal gestore.
Saras: lancia 6 programmi formativi per gli studenti sardi
Sono riprese le iniziative di istruzione e formazione promosse dal Gruppo Saras rivolte agli studenti: per l’anno scolastico 2022-2023, nel quadro del programma ministeriale “Competenze Trasversali e Orientamento” (PCTO), il Gruppo ha pianificato 6 programmi formativi specifici insieme ad altrettanti istituti superiori della provincia di Cagliari e dell’Ogliastra. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Giua” sono stati i primi ad essere coinvolti e hanno partecipato ad un intenso programma di conferenze e visite guidate agli impianti. Sono stati approfonditi gli aspetti di sostenibilità dei processi produttivi del sito Sarlux nelle buone pratiche di produzione che migliorano sempre di più l’impronta ecologica di tutti i processi.
Il Gruppo TAL ha annunciato un piano di investimenti per oltre 100 milioni di euro entro il 2024 con l'obiettivo di mantenere il massimo livello di integrità ed efficienza dell'infrastruttura. Il general manager del gruppo, Alessio Lilli, ha specificato che circa 58 milioni del budget complessivo verranno dedicati alla parte italiana dell'Oleodotto Transalpino gestito dalla Siot, e di questi oltre il 50% saranno destinati alle infrastrutture presenti a Trieste, tra Terminale Marino e Parco Serbatoi. Tale potenziamento, spiega un comunicato, punta innanzitutto al "mantenimento della ottimale efficienza”.
Air Liquide e TotalEnergies hanno stretto un accordo per produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio attraverso il biogas residuo della raffineria di Grandpuits, in Francia. Nell'ambito di un contratto a lungo termine che impegna TotalEnergies ad acquistare l'idrogeno prodotto per le esigenze della sua piattaforma, Air Liquide investirà oltre 130 milioni di euro nella costruzione e nella gestione di una nuova unità di produzione di idrogeno. Questa unità utilizzerà in parte il biogas proveniente dalla bioraffineria costruita da TotalEnergies e sarà dotata fin dall'inizio della tecnologia di cattura della CO2 Cryocap. Un comunicato, spiega che ciò consentirà di catturare, per il riutilizzo in applicazioni agroalimentari e industriali, oltre 110.000 tonnellate di CO2 all'anno al fine di contribuire a ridurre l'impronta di carbonio della piattaforma. La maggior parte dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio così prodotto sarà utilizzato dalla bioraffineria per la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione.
Lo spazio, si sa, è fatto di pura energia. Il punto è come sfruttarla. Lo scorso 3 gennaio SpaceX ha lanciato in orbita lo “Space Solar Power Demonstrator” (SSPD), un prototipo realizzato dal California Institute of Technology (Caltech) con l’obiettivo di capire se è possibile produrre energia solare
È ormai da qualche decennio che si studia la possibilità di produrre energia solare direttamente nello spazio, con progetti e ipotesi di centrali solari orbitali che siano in grado, attraverso pannelli fotovoltaici, di convertire la luce del sole in energia, per poi veicolarla sulla terra attraverso un’antenna e trasmissioni in forma di microonde o laser. Il vantaggio di un simile sistema sarebbe enorme, permettendo continuità di illuminazione e assenza di condizioni atmosferiche negative, potendo così ottimizzare la produzione, seppur a fronte di costi certamente elevati. Il trasporto, l’installazione e la manutenzione di infrastrutture nello spazio sono infatti processi estremamente complessi e richiedono attenzioni e procedure diverse da quelle necessarie sulla terra (ad esempio i tempi di vita di un pannello solare sono molto più brevi in orbita che sulla superficie terrestre).
Un fattore poi di particolare e ulteriore complessità sono i sistemi di invio e trasmissione dell’energia prodotta verso la terra, che funzionano con onde elettromagnetiche ad alta efficienza di trasferimento e richiedono antenne riceventi molto grandi. Una novità in questo percorso di ricerca e sperimen-
tazione è arrivata all’inizio di quest’anno, con il decollo dello “Space Solar Power Demonstrator” (SSPD), un prototipo realizzato dal progetto di energia solare spaziale del California Institute of Technology (Caltech) e ospitato nella missione Transporter-6 lanciata lo scorso 3 gennaio da SpaceX. A bordo di SSPD ci sono tre componenti che serviranno da test per capire se e come costruire dei reali pannelli fotovoltaici orbitanti: il primo (chiamato Dolce - Deployable on-Orbit ultraLight Composite Experiment) è una struttura modulare su cui installare i pannelli fotovoltaici, fino a creare una stazione energetica lunga fino a un chilometro; il secondo (Alba) è una raccolta di 32 diversi tipi di pannelli fotovoltaici, pensata per facilitare la valutazione della misurazione dell'efficacia dell'energia solare raccolta da ogni tipologia; il terzo (Maple - Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment) prevede una serie di trasmettitori di potenza a microonde, dispositivi dotati di controllo di potenza e mirati a dimostrare la possibilità e l’efficienza della trasmissione a distanza wireless.
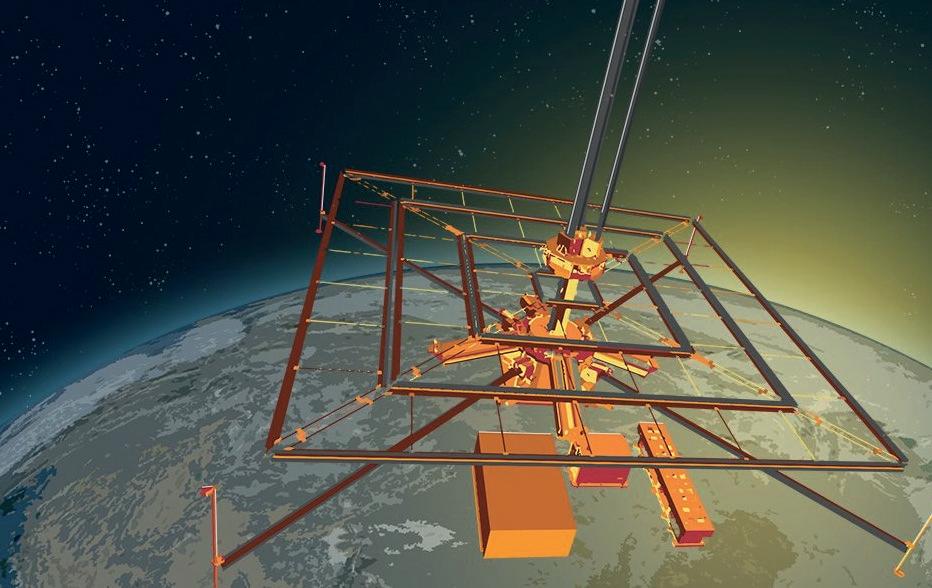
I risultati sono attesi - a quanto dichiarato dai ricercatori dell’Istituto universitario - in tempi ragionevolmente
brevi. E le aspettative sono molto alte: se si riuscisse a far funzionare queste infrastrutture in modo efficiente (raggiungendo ad esempio un’efficienza di trasmissione tramite onde elettromagnetiche del 50-60%), si potrebbe produrre una quantità di energia doppia o tripla per ogni pannello installato rispetto a quanto avviene sulla superficie terrestre, contribuendo in modo sostanzioso ai fabbisogni energetici del pianeta.
Come accennato progetti di sfruttamento dell’energia solare direttamente nello spazio non sono nuovi.
I primi tentativi e studi si devono al ceco-americano Peter Glaser, già project manager dei primi esperimenti scientifici eseguiti sulla Luna. Glaser nel 1974 ha brevettato - nell’ambito di una iniziativa della NASA che aveva assegnato a 4 società lo studio delle infrastrutture spaziali - un metodo per trasmettere energia dallo spazio verso la Terra utilizzando microonde e una particolare antenna chiamata rectenna.
Evidentemente quei primi progetti hanno aperto la strada a nuovi tentativi senza superare tutti le difficoltà, a partire dai costi e dalla complessità di gestione. Successivamente sono stati direttamente i governi ad interessarsi alla possibilità di produrre energia nello spazio, con progetti lanciati di Unione europea, Cina, Russia, Giappone (che ha anche deciso nel 2008 di inserire nella Legge base sullo spazio l’obiettivo della cattura di energia solare in orbita e che ha annunciato risultati concreti per il 2025), Regno Unito (che si prefigura risultati entro il 2040).
Insomma, ancora servirà del tempo, e si dovranno ancora ottimizzare i costi, ma la notizia positiva è che dal punto di vista fisico e tecnologico le conoscenze finora maturate dalla comunità internazionale di studiosi, governi e imprese sono vicine a poter rendere realtà questi progetti, che rappresenterebbero certamente un acceleratore della transizione energetica.
Pensare il futuro è un compito decisivo per tutti, per il quale è utile farsi ispirare da studiosi, esperti, narratori: per immaginare come sarà il pianeta nel quale vivranno le prossime generazioni, saper prevedere come cambieranno le abitudini delle persone e individuare modelli di crescita pienamente sostenibili e rispettosi dell’ambiente.
L’anno che verrà ci deve raccontare se avremo la forza di imporre un’idea e non subire soltanto l’inerzia del passato. Dopo la pandemia, dopo la guerra, dopo il ritorno furente dell’inflazione, il 2023 rischia di essere soprattutto un anno di passaggio. La pandemia sembra superata, ma la guerra non è finita e l’equilibrio per una pace credibile è il principale obiettivo di qualsiasi decisore ragionevole su scala globale. [...] Prima il Covid e poi la guerra in Ucraina hanno imposto cambiamenti che sapevamo di dover fare ma che avevamo rinviato per comodità e ignavia. Organizzare il lavoro in modo nuovo è complicato, ma è anche meglio. Non dipendere da un regime per fare la doccia calda è complicato, ma è anche meglio. Dovremo dunque capire se nell’anno che si apre i sistemi democratici – gli unici a cui è possibile chiedere conto delle proprie scelte – ma anche le aziende, dopo tutto, sapranno privilegiare il cambiamento necessario.
[introduzione a “Duemilaventitre. L’anno che verrà”, Good Morning Italia]
Hanno contribuito a questo numero
Simona Benedettini, Arianna Cappelli, Carlo Carminucci, Salvatore Carollo, Marco D’Aloisi, Vittorio D’Ermo, Jacopo Giliberto, Innovhub, Lisa Orlandi, Antonio Pollio Salimbeni, Cristiana Pulcinelli, Giacomo Rispoli, Claudio Spinaci, Carlo Stagnaro, Angela Zanoni
Hanno contributo alla rivista
Alessandro Aresu, Luca Aterini, Marco Baldi, Alessandro
Bartelloni, Simona Benedettini, Carlo Bonomi, Giogio Carlevaro, Arianna Cappelli, Carlo Carminucci, Salvatore Carollo, Nadia Cerone, Giorgio Chiantella, Stefano Cingolani, Paolo Cintia, Francesco Clementi, Alessandro Clerici, Alberto Clô, Emanuela Colombo e Diana Shendrikova, Marco D’Aloisi, Stefano Da Empoli, Giuseppe D’Arrigo, Vittorio D’Ermo, Bruno Dalla Chiara, Franco Del Manso, Pier Luigi Del Viscovo, Paola De Micheli, Pierroberto Folgiero, Alessandro Fontana, Benedetto Forlani,
Marco Frittella, Giuseppina Fusco, Vannia Gava, Massimiliano Giannocco, Romano Giglioli, Jacopo Giliberto, Gianni Girotto, Maria Cecilia Guerra, Icao, Innovhub, Pietro Lanzini, Stefano Laporta, Antonio Lazzarinetti, Marco Mannocchi, Marco Marcatili, Enrico Mariutti, Benedetta Marmiroli, Michele Masulli, Paolo Mellone, Marco Mocchetti, Enrico Morando, Martina Nardi, Lisa Orlandi, Azzurra Pacces, Gilberto Pichetto Fratin, Linda Piedimonte, Marilena Pisani, Politecnico di Milano, Antonio Pollio Salimbeni, Cristiana Pulcinelli, Ilaria Querci, Paolo Raimondi, Francesco Ramella, Filippo Redaelli, Aurelio Regina, Francesco Ricotta, Giacomo Rispoli, Piero Salatino, Tommaso Santarelli, Francesco Sassi, Francesco Ciro Scotto, Antonio Sileo, Guido Silvestri, Claudio Spinaci, Carlo Stagnaro, Angelo Sticchi Damiani, Davide Tabarelli, Luca Tabasso, Antonio Tajani, Giuseppe Tannoia, Chicco Testa, Antonio Tintori, Stefania Tomasini, Roberto Ulivieri, Maria Rita Valentinetti, Claudio Velardi, Angela Zanoni, Giovanni Battista Zorzoli
Unione Energie per la Mobilità
Piazzale Luigi Sturzo, 31 00144 Roma info@unem.it www.unem.it
tw: @unem_it in: /company/unem
Per proporre contributi o per richieste pubblicitarie: muoversi@unem.it
Le opinioni espresse impegnano unicamente gli autori e sono indipendenti da opinioni e politiche dell’Editore. Registrazione Tribunale di Roma n. 121 del 19 settembre 2019
Tecnologia, esperienza e innovazione per la rigenerazione degli oli lubrificanti, la purificazione dei solventi e i servizi ambientali per l’industria.
27 siti operativi e 900 persone: soluzioni sostenibili per oltre 35.000 clienti in più di 60 Paesi.
