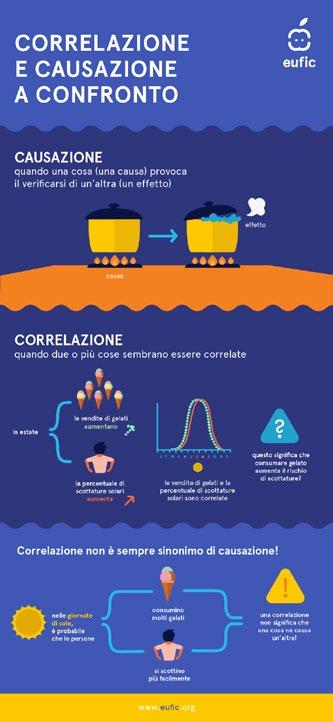10 minute read
STORIA DEL PETROLIO: Il petrolio alla prova della crisi di Giorgio Carlevaro
IL PETROLIO ALLA PROVA DELLA CRISI di Giorgio Carlevaro
L’industria petrolifera ha già dovuto affrontare la sfida della ripartenza sebbene in contesti ben diversi da quelli attuali. In particolare dopo la prima e seconda guerra mondiale quando si posero le basi per lo sviluppo industriale dei decenni successivi. In questa puntata ripercorGiorgio Carlevaro riamo le fasi salienti di quegli anni: gli anni d'oro dell'industria petrolifera italiana.
Direttore emerito della Staffetta
Quotidiana
Tra le domande frontare, in tempi e contesti peraltro rivò a quell’evento con una incerta e le risposte che si sono intrecciate molto differenti, dopo la prima e la see ancora scarsa attività mineraria, in questi mesi e che ancora si intrecconda guerra mondiale e dopo la crisi con la produzione di petrolio greggio ciano in relazione all’emergenza Codegli anni ’70 innestata da una serie che nel 1914 aveva toccato le 5.500 ronavirus, su quando finirà, su come di avvenimenti che si sono succeduti tonnellate, e con una trascurabile atci lascerà, su cosa cambierà rispetto in Medio Oriente (guerra del Kippur e tività di lavorazione che faceva capo a come eravamo e a come ci comcrisi iraniana in primis). Un altro capia tre impianti con una capacità gloportavano prima che cominciasse, tolo della storia che abbiamo iniziato bale di 10.000 tonnellate: le raffineprima delle chiusure di molte attività, a raccontare in questa rubrica in due rie di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), del distaccamento fisico, del blocco precedenti puntate, la prima dedicadella Società Francese del Petrolio, degli spostamenti inter-regionali e ta all’evoluzione della distribuzione e di Fornovo Taro (Parma) della Spi transfrontalieri, una domanda che ci dei carburanti, dai primi distributori (Società petrolifera italiana), che lariguarda da vicino è la tempistica e le automatici alle vere e proprie staziovoravano greggi estratti localmente, modalità di ripartenza dell’industria ni di servizio che si sono moltiplicate e la raffineria di Trieste che lavorava petrolifera. Una dinamica ancora tutta a partire dagli anni ‘50, la seconda ai greggi della Galizia e che con la guerra da apprezzare per tener conto delle primi passi o, meglio, ai primi voli del dovette interrompere le lavorazioni. nuove variabili e dei nuovi parametri calabrone tra la fine dell’800 e i primi Con il fabbisogno di benzina e di pedi comportamento indotti da questo anni del ‘900. Per poi raggiungere i trolio, i prodotti petroliferi che allora periodo di emergenza e che non vertraguardi del tutto inimmaginabili tocandavano per la maggiore, coperto in ranno meno anche con il ritorno alla cati alla fine del secolo scorso. gran parte da importazioni: con quelle normalità. Per citarne alcune, lo smart Due eventi dai contorni e dalle consedi benzina che dalle 41.000 tonnelworking, la scuola e l’università a diguenze molto diverse: con un fronte late del 1914 salirono alle 206.000 stanza, le videoconferenze e i webinar, bellico molto limitato la prima, tutto circa del 1918 e quelle di petrolio lamche grazie al computer e alla digitalizinterno ad una parte del territorio napante scese nello stesso periodo da zazione delle comunicazioni, con cui zionale, che ha coinvolto invece molti 116.000 a 72.000 tonnellate. Con la tra l’altro le giovani generazioni hanno ed estesi scacchieri la seconda. Preproduzione interna di greggio rimasta grande dimestichezza, hanno ridotto ceduta la prima dalla conquista della più o meno intorno alle 5.000 tonnella necessità degli spostamenti ed eviLibia nel 1912, la seconda da guerre late, con un picco di 7.400 tonnellate denziato da una parte comportamenti e conflitti che hanno interessato la nel 1916. Il contributo maggiore alla superflui e inutili e dall’altra situazioni seconda metà degli anni ‘30. Con il copertura del fabbisogno energetico e sistemazioni abitative insufficienti. fabbisogno di petrolio cresciuto nel venendo allora dal carbone e dagli
Una sfida, quella della ripartenza, che frattempo sensibilmente. Una risorsa impianti idroelettrici che nel primo l’industria petrolifera ha già dovuto aftutto sommato marginale nella priscorcio di secolo si erano andati molma, ma divenuta tiplicando a partire dall’arco alpino. importante nella Finita la guerra l’importazione di benseconda quando zina calò rapidamente (allora anche gli la sua disponibiliautocarri andavano a benzina), pertà fece alla fine la ché era venuto meno il fabbisogno differenza tra vineccezionale. Ma poi lentamente si citori e vinti. inserisce anche la produzione interna essendo state acquisite le raffinerie IL PETROLIO di Trieste e di Fiume. Così la capacità NELLA PRIMA interna di lavorazione raggiunge già GUERRA MONnel 1924 le 80.000 tonnellate con DIALE ‘15-‘18 Per quel che riguarda la prima guerra mondiale, l’industria petrolifera italiana arquattro raffinerie. Il periodo bellico, tutto sommato, ci portò fortuna e dagli anni ‘20 inizia la moltiplicazione degli impianti di raffinazione ad opera sia delle filiali italiane di gruppi internazionali (Esso, Shell, Mobil e Petrofina in primis) sia di aziende italiane (Erg,
Api, Permolio). Che troverà poi base giuridica prima nel decreto-legge del 25 novembre 1926, che dà il via agli impianti di cracking per la lavorazione dei residui, e poi nel decreto-legge 2 novembre 1933, il cosiddetto «codice del petrolio» che aprirà la strada alle licenze di importazione. Senza dimenticare che nel 1926, con un decreto legislativo del 3 aprile, era stata costituita l’Agip (Azienda generale italiana petroli) per svolgere per conto dello Stato ogni attività relativa all’industria e al commercio dei prodotti petroliferi, a partire dalla ricerca degli idrocarburi. Il peso del petrolio nei consumi di energia che nel 1910 non superava il 2%, arriverà nel 1920 al 3,7%, nel 1930 al 5% e nel 1938 al 7,4%.
ENERGIA, LE AMBIZIONI E GLI SPRECHI DI MUSSOLINI Nell’ottobre 1922 in Italia era arrivato al potere il partito fascista fondato da Benito Mussolini che, con l’avallo della monarchia, aveva prima pressoché distrutto lo Stato liberale e parlamentare e poi, a partire dall’ottobre 1935, aveva impegnato il Paese in una serie di sciagurate avventure belliche. Una politica di potenza in cui Mussolini impegnò fra l’altro ingenti risorse di energia sotto forma di combustibili solidi e liquidi, nonostante il Paese fosse povero di materie prime e non possedesse cospicue fonti di carbone e di petrolio. Un problema che emerse in tutta la sua crudezza dopo la firma del Patto d’Acciaio con la Germania (22 maggio 1939) quando, a Hitler che chiedeva di cosa avesse bisogno nell’ipotesi di affrontare il blocco franco-tedesco, Mussolini mandò una lista in cui figuravano anche 6 milioni di tonnellate di carbone e 7 milioni di tonnellate di oli minerali che era più o meno il volume delle importazioni in tempo di pace. Una situazione di “povertà energetica” a cui Mussolini, sull’esempio di altri Paesi, cercò di porre riparo a partire dal 1934, dopo la crisi economica del 1929, con la politica dell’autarchia, puntando su tre obiettivi: autonomia, indipendenza e autosufficienza. Facendone uno dei suoi cavalli di battaglia, rafforzando il protezionismo del mercato interno in particolare per quanto riguardava le commesse. Nonostante le materie prime sintetiche e autarchiche risultassero più costose e di qualità inferiore rispetto a quelle importate: caso classico quello delle ligniti, il cui potere calorico era più basso rispetto al carbone tedesco e inglese.

IL TRAUMA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE La seconda guerra mondiale fu un disastro per tutta l’industria petrolifera italiana, come del resto per tutto il Paese. Un vero e proprio trauma, anche perché dal 1924 al 1939 si era lavorato molto per creare impianti ed attrezzature, con un notevole apporto anche di capitali stranieri. In base ad un riepilogo pubblicato nel 1972 sulla Rivista Italiana del Petrolio, alla vigilia della guerra il Paese disponeva di una capacità di raffinazione di 1,9 milioni di tonnellate ripartita tra 18 impianti, di una capacità di stoccaggio di 2,5 milioni di metri cubi, di 2.100 stazioni di servizio e chioschi. E alla fine si ritrovò a causa delle distruzioni belliche solo con 2.000 tonnellate di capacità di raffinazione, tutte le raffinerie praticamente distrutte, 900.000 metri cubi di capacità di stoccaggio (ben 1.600.000 metri cubi in meno), 900 stazioni di servizio (1.200 in meno) e 10.000 distributori stradali (12.000 in meno). Ma già cinque anni dopo, nel 1950, la capacità di raffinazione non solo era stata ripristinata, ma era salita a 4 milioni di tonnellate, idem per la capacità di stoccaggio salita a 2,7 milioni di metri cubi, con le stazioni di servizio salite a 2.400 (300 in più) e i distributori stradali a 16.000 (ancora 6.000 in meno). Con un impegno finanziario di circa 40 miliardi di lire, per circa 18 miliardi a carico del Comitato Italiano Petroli (Cip) e per circa 22 miliardi a carico delle società petrolifere. Praticamente, nel 1951 i danni della guerra si potevano considerare riparati, ma in qualche caso, come per le raffinerie di Napoli (Mobil) e La Spezia (Shell) il recupero era stato largamente superato. Da ricordare che le nostre attività distrutte dalla guerra subirono un diverso trattamento agli effetti dei risarci-
menti e delle ricostruzioni. Le raffinerie a capitale straniero, già sequestrate, presentarono i progetti di ricostruzione ed il Comitato italiano petroli (CIP) ne controllò la consistenza. Poi, attraverso un fondo di riserva ottenuto con una maggiorazione sui prezzi di vendita dei prodotti dei quali aveva la totale disponibilità, pagò subito, a termini del Trattato di Pace, i due terzi della spesa. Le società straniere ebbero così 3,6 miliardi in lire. Più complicata la situazione delle imprese nazionali, i cui danni seguirono la sorte prevista dalla nostra legislazione, con le sue complicazioni e ritardi di anni. Questo senza tener conto le conseguenze del mancato esercizio. Il criterio della ricostruzione tenne conto dell’urgenza

di avere quanto prima gli impianti in efficienza, e perciò si cominciò dove il danno era minore, ma soprattutto dai depositi per poter utilizzarli e andare incontro alle necessità del mercato. Il CIP svolse un lavoro serio e imponente. Strutturato con la partecipazione diretta degli stessi interessati, riuscì in pochi anni a far rivivere tutto il settore che nella ricostruzione aveva trovato anche il modo di introdurre processi più moderni. Anche l’aiuto americano, attraverso il piano Marshall, contribuì in modo determinante alla ricostruzione di alcuni impianti appartenenti a società nazionali e cioè l’Aquila di Trieste, I’IROM di Venezia, i due impianti di Genova e Roma della Permolio, successivamente acquistati dalla Purfina. E così si arrivò agli anni ’50, con una espansione senza precedenti dei consumi totali netti di energia, i quali risultano aumentati del 150%. Fu proprio il settore petrolifero a sostenere l’ondata dei maggiori fabbisogni per tutte le esigenze: dal riscaldamento ai trasporti, dall’industria agli usi domestici. La spinta veniva anche dall’aumen

to medio del reddito nazionale che fu nel decennio del 5,6%. Un periodo in cui si sono avute rilevanti diversificazioni dei consumi di energia. Nel 1950 il carbone e la lignite rappresentavano ancora il 39% dei consumi e la legna da ardere il 14%. Nel 1960 il carbone e la lignite erano scesi al 16% e la legna al 6%. Invece il gas naturale aumentò dal 3 al 16% e i prodotti petroliferi dal 26 al 45% (con i consumi petroliferi saliti da 4,2 a 18,1 milioni di tonnellate). Con un’espansione notevole delle nostre esportazioni di prodotti petroliferi, che si moltiplicarono per 10 volte in volume, contribuendo ad alleggerire notevolmente l’onere valutario della importazione di greggio per il consumo interno.
CONCLUSIONE Appunti di una storia e di una vitalità miracolosa, che segnarono e caratterizzarono gli anni d’oro dell’industria petrolifera italiana. Quale insegnamento trarne? Che ogni sfida trova sempre alla fine la sua risposta. E che ogni problema ne genera un altro, con una concatenazione che non permette mai che si ponga la parola fine. Anche oggi che l’industria petrolifera, più che con la ripartenza, deve cimentarsi con la sfida ben più difficile e complessa di come sopravvivere in questa particolare fase della transizione energetica: una sfida che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria mutazione genetica. Con le incognite che ciò comporta per chi la deve interpretare ed affrontare.