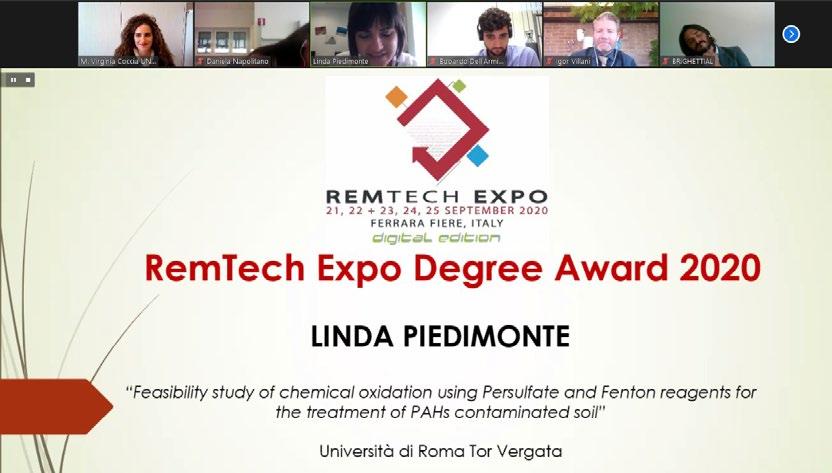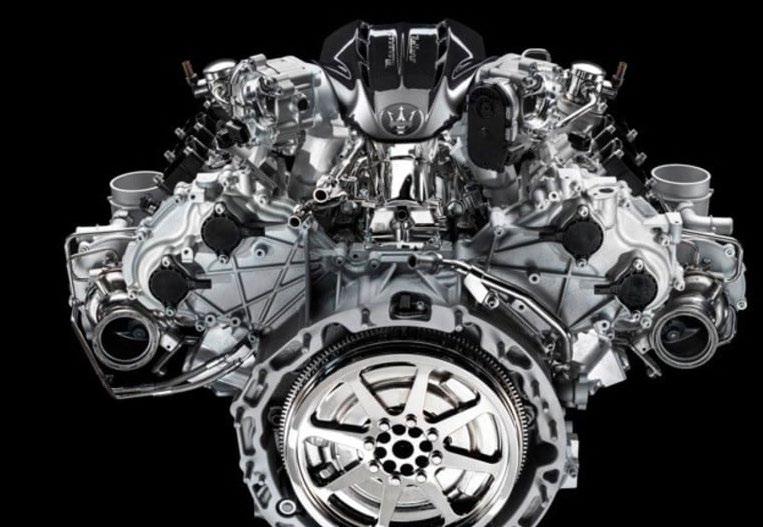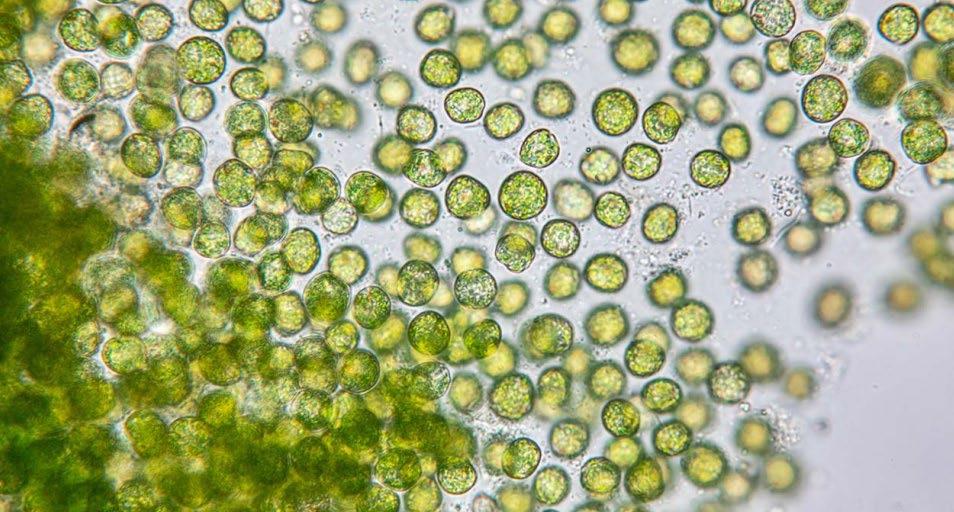13 minute read
STORIA DEL PETROLIO: I protagonisti degli anni d’oro del petrolio in Italia
I PROTAGONISTI DEGLI “ANNI D’ORO” DEL PETROLIO IN ITALIA di Giorgio Carlevaro
Giorgio Carlevaro
Direttore emerito
L’industria petrolifera italiana ha vissuto fasi storiche diverse, che hanno accompagnato il percorso di sviluppo e crescita economica del Paese sapendo sempre garantire un apporto fondamentale per soddisfare i fabbisogni energetici. In questa lunga storia sono tante le figu-
della Staffetta
Quotidiana
re che hanno giocato ruoli decisivi, e Giorgio Carlevaro ci aiuta a scoprire perché sono diventati veri protagonisti di intere stagioni di vita italiana.
Se è vero che in Italia gli affioramenti di petrolio, frequenti sull’Appennino tosco-emiliano e su quello abruzzese, venivano conosciuti e sfruttati da secoli, l’inizio vero e proprio della storia del petrolio risale più o meno intorno al 1870, quando ebbero avvio i primi sfruttamenti speculativi sull’onda di notizie che arrivavano dall’America su imprese che evocavano una sorta di nuova “corsa all’oro”. Per cui non si è distanti dal vero se parliamo di una storia che dura ormai grosso modo da 150 anni, con alti e bassi, crisi e ripartenze, sviluppi record e ridimensionamenti, sfide e passaggi difficili, come è il caso anche del 2020. Una storia che si può raccontare in molti modi e con molte interpretazioni, condensata in libri, cronologie, rievocazioni, manuali, biografie, romanzi, parte a sua volta della storia dell’energia e della storia dell’Italia (che ha appena celebrato i 150 anni dell’Unità), dell’Europa e del mondo, come si sono venute evolvendo in questo lungo periodo. Con il petrolio che a poco a poco è diventato anche in Italia una linfa importante, a volte determinante, dello sviluppo economico e sociale. E tale è ancora oggi. Storia fatta, come tutte le storie, di uo-
pionieri, poi di protagonisti, figure che in ogni caso hanno avuto modo di lasciare la loro impronta. Quanti sono? Tanti. Alla fine dei primi 100 anni, nel 1970, ne erano stati già contati, in un numero speciale della Rivista Italiana del Petrolio del 31 dicembre 1972, più di una settantina, oggi superano certamente il centinaio. Impossibile ricordarli tutti. Fissando, come un sorta di spartiacque tra il periodo pionieristico e quello pienamente industriale e commerciale, il 1945. Quando, finita la guerra, l’Agip, istituita nel 1926 dal governo Mussolini come azienda dello Stato, non venne liquidata ma, grazie a Enrico Mattei, venne rilanciata nell’ambito di un progetto più vasto che coinvolse anche la Snam (nata a sua volta nel 1941), un progetto che nel febbraio 1953 portò alla nascita dell’Eni. A loro volta le filiali di società internazionali, di cui alcune (Siap Esso, Nafta Shell, Vacuum Oil, Petroli d’Italia, Petrocaltex, Petrofina) attive dall’inizio del secolo e sequestrate nel 1941, vennero dissequestrate e riconsegnate ai rispettivi proprietari (giugno 1948) e alcune aziende tipicamente italiane (Api, Erg, Pir, Liquigas e Saras) ebbero modo di sopravvivere e svilupparsi salvaguardando la loro indipendenza. Il tutto in concomitanza con la fine lifera verso la normalizzazione. Favorita anche dall’istituzione dell’Unione Petrolifera (giugno 1948) a cui fanno capo le aziende che importano e raffinano greggio e prodotti semilavorati e distribuiscono prodotti petroliferi e dell’Assopetroli (dicembre 1949) a cui a loro volta fanno capo commercianti, grossisti e rivenditori di prodotti petroliferi. Antefatti importanti perché è da qui, dal 1945 appunto, che è partito e si è consolidato, insieme al miracolo economico italiano, anche il boom petrolifero italiano che toccò il picco nel 1973. Con un rapido sviluppo della capacità di raffinazione e della rete di distribuzione stradale già negli anni a cavallo del 1960. Con la prima che ancora nel 1955 non superava i 28 milioni di tonnellate e che nel 1965 era salita già oltre i 100 milioni e nel 1970 i 160 milioni. Con risvolti positivi sugli investimenti, sull’attività delle imprese di progettazione e di costruzione, sull’occupazione diretta e indotta, specie nel Sud. Non a caso chiamati “gli anni d’oro delle raffinerie”. Aspetti di un unico processo di sviluppo che coinvolse tutto il Paese. E che ebbe uno stop nel 1973 quando, già prima della guerra del Kippur, i prezzi del petrolio cominciano a salire e sui mercati si creò il panico. L’impressione di assistere alla fine di un’era: quella del petrolio facile e dello sviluppo economico senza limiti, quasi il preannuncio della fine dell’Occidente industrializzato. Per l’Italia l’inizio allora delle domeniche a piedi. E non per motivi ambientali.
mini o, meglio, di generazioni di uomini che si sono avvicendate sulla scena e hanno svolto e interpretato ruoli più o meno importanti. Parliamo all’inizio di del Comitato Italiano Petroli, istituito dal Comando Militare Interalleato a Napoli nel 1943 che aveva avuto il merito di traghettare l’attività petroChi furono gli artefici di questo processo? Alcuni che avevano cominciato a farsi le ossa negli anni ’30 sia a livello nazionale che internazionale, altri che ne seguirono le orme a partire dagli anni ’50. Tra i primi Ulisse Guido Ringler (classe 1886), il primo presi-
dente dell’UP, che iniziò a lavorare a vent’anni nel 1906 con il gruppo Esso nella Siap, come figlio dell’agente di Venezia della società costituita nel 1891 (quasi 130 anni fa), consigliere di amministrazione nel 1925, presidente nel 1946 subito dopo il dissequestro, seguendone passo passo lo sviluppo fino alla morte avvenuta nel 1951. Quando viene sostituito da Vincenzo Cazzaniga (classe 1907), che era entrato nel 1926 nella Lubrificanti Bedford, controllata anch’essa dal gruppo Esso, e nel 1948 era entrato nella Siap come direttore vendite e via via direttore generale commerciale, consigliere di amministrazione, presidente e infine, nel 1954, presidente e amministratore delegato della Esso Italiana. Carica che mantenne fino al 1972 quando venne sostituito da Aldo Sala. Dando un impulso decisivo all’integrazione della società in tutte le fasi del ciclo petrolifero. Per due volte presidente dell’UP. Scomparso nel 2000. Una delle figure più note, per più di un motivo, della storia del “petrolio Italia”. Oltre a Ringler, importante negli anni ‘30 anche il ruolo di Ettore Carafa d’Andria (classe 1895), secondo presidente dell’UP, un elemento di continuità nella dirigenza dell’Agip dove, già nel 1926, era entrato per volere del ministro delle Finanze Giuseppe Volpi nei ranghi dell’organizzazione. Nel gennaio 1931 è già direttore generale, nel febbraio del 1932 è segretario del Consiglio e nel marzo del 1935 segretario del comitato esecutivo di cui diventa membro nel 1936. In un periodo in cui si avvicendano al vertice della società ben sei presidenti da Ettore Conti a Giuseppe Gerla. E che dopo la guerra, nel giugno 1948, è nominato amministratore delegato e vice presidente con Enrico Mattei all’epoca della presidenza di Marcello Boldrini. Fino al maggio 1952 quando lascia la società. Da ricordare anche Bernardo Marchese (classe 1884), terzo presidente dell’UP, che dopo aver fondato a Genova la Compagnia Nazionale Prodotti Petroli nel 1925 era entrato nella Nafta (Shell) come amministratore delegato sotto la presidenza di Attilio Pozzo. Rientrato nella società nel 1946 dopo il dissequestro, ne gestì la ricostruzione fino al 1950 sotto la presidenza di Albert De Graan (chiamato nel 1944 a presiedere fino al 1948 il Comitato Italiano Petroli) per poi passare la mano, quando la società cambiò nome in Shell Italiana, a Pierre Paul Escoffier e nel 1957 a Diego Guicciardi (settimo presidente UP). E figure non minori furono Ugo Cantini (classe 1896) per lo sviluppo della Mobil Oil Italiana, Teodolo Theodoli (classe 1882) per lo sviluppo della Petrolcaltex, della Sarpom e della Chevron, padre di Giovanni Theodoli, presidente UP dal 1974 al 1981, e Nicolò Pignatelli (classe 1923), presidente della Gulf italiana, la società che nel 1953 scoprì il petrolio a Ragusa in Sicilia, venduta nel 1984 alla Kuwait Petroleum Italia (Kupit) che nel 1990, presidente Cristiano Raminella, acquistò le attività della Mobil, diventando una delle prime società distributrici di carburanti. Tornando all’Agip, non si può dimenticare la figura di Ernesto Santoro (classe 1888), quarto presidente dell’UP, che ebbe tra l’altro un ruolo importante nella costituzione nel 1949 della Stanic a cui facevano capo, in compar-
Guido Ringler - Primo presidente UP

tecipazione con la Esso, le raffinerie di Livorno e di Bari, la prima distrutta e la seconda solo danneggiata durante la guerra. E con lui non si possono dimenticare Lorenzo Roasio, amministratore delegato dal 1972 al 1977, Angelo Pileri, che fu tra l’altro il primo presidente di Agip Petroli, la società costituita nel 1977 a seguito della ristrutturazione dell’Agip. Per arrivare infine a Pasquale De Vita (classe 1929), entrato nella società nel 1954, presidente Mattei, con incarichi sempre più importanti nel settore commerciale fino a quello di direttore generale della Divisione Italia. Nel 1978 è amministratore delegato di Agip Petroli di cui poi nel 1984 diventa presidente, carica che detiene fino al 1993. “Una lunga e bellissima galoppata”, come la definì lui stesso, riuscendo a mantenere coesa una compagnia composta da realtà diverse e a volte contrapposte. Presidente UP dal 1997 al 2013. Promotore di Confindustria Energia nel 2006. Scomparso nel 2014.
Le grandi famiglie italiane del petrolio Tra le figure più rilevanti ai fini dello sviluppo dell’industria petrolifera italiana non si possono dimenticare quelle che fanno capo a quattro grandi famiglie che hanno iniziato la loro attività nel secolo scorso e sono tuttora presenti sulla scena. Dagli Ottolenghi, che hanno appena festeggiato i 100 anni, ai Brachetti Peretti, che nel 2013 hanno tagliato il traguardo degli ’80, ai Garrone, che questo traguardo lo hanno tagliato nel 2018, e ai Moratti che, sempre nel 2018, hanno tagliato quello dei 70. Famiglie che nel periodo di maggior sviluppo dell’industria petrolifera italiana hanno svolto un compito importante nel tenere alta e nel contendersi, a fianco dell’Agip e delle filiali delle multinazionali e, più recentemente, delle emanazioni dei paesi produttori, la fiamma della componente privata italiana e del loro DNA. Nel solco tracciato da quella lunga schiera di “pionieri” che a partire dalla fine dell’800 diedero un contributo determinante all’avvio di questa industria nel nostro Paese. Nel caso degli Ottolenghi tutto inizia nel 1920 con la costituzione della Petrolifera Italo Rumena (PIR) da parte dell’allora capo famiglia Cesare Ottolenghi e che dal 1921 al 1940 venne guidata da Giuseppe Ottolenghi (classe 1893) e negli anni difficili dal 1940 al 1958 da Guido Ottolenghi sr (classe 1902) e da Carlo Alberto Ottolenghi (classe 1898) che posero le basi della sua futura prosperità . Avendo come partner fin dal 1929 la Nafta Shell di Attilio Pozzo, accordo poi rinnovato dopo la guerra con la Shell Italiana e nel 1974 con l’Agip. Una società, di cui oggi è presidente Emilio Cesare Ottolenghi (classe 1932) e a.d. Guido Ottolenghi jr (classe 1966), e che ha sede a Ravenna, dove gestisce lo stoccaggio e la movimentazione non solo di prodotti petroliferi, ma anche di prodotti chimici, fertilizzanti e aromatici. Con gli ultimi sviluppi legati allo stoccaggio del biodiesel e al GNL. Puntando fin dagli anni ’80 a investire anche in altri terminali, tra cui Genova. Nel caso dei Brachetti Peretti parliamo dell’Api (anonima petroli italiana)
fondata nel 1933 da Ferdinando Peretti (classe 1896) già attivo da dieci anni nella distribuzione di prodotti petroliferi tra Piacenza e Parma, prima di rilevare a pochi chilometri da Ancona un grande deposito costiero di benzina gestito da un gruppo di marchigiani. Che dopo la guerra iniziò la costruzione di una raffineria di oli minerali a Falconara Marittima, inaugurata il 28 dicembre 1950, gettando le basi altresì di una rete di punti vendita stradali diffusa su tutto il territorio nazionale. Scomparso nel 1977, l’attività venne sviluppata ed estesa da Aldo Brachetti Peretti (classe 1932) che ha sposato la figlia Mila, tuttora azionista di riferimento del gruppo. Nominato subito presidente e a.d. ha riqualificato e potenziato la raffineria e la rete allargandone gli orizzonti operativi. Fino al 2007, quando ha deciso di passare la mano ai figli Ferdinando e Ugo. Non senza due anni prima aver comprato la rete IP. Che, con l’acquisto alla fine del 2017 della rete TotalErg, oggi in Italia è diventata la più grande per numero di punti vendita. Nel caso dei Garrone tutto inizia invece nel giugno 1938 quando Edoardo Garrone (classe 1906), dopo la partecipazione ad una serie di iniziative nel settore degli oli minerali risalenti al maggio 1931, si mette in proprio e avvia a San Quirico sulla sponda del torrente Polcevera l’attività di una omonima ditta individuale per il commercio e la manipolazione di derivati del petrolio e del catrame. La prima impresa di totale proprietà personale che, da allora, viene considerata a tutti gli effetti il momento fondativo della Erg. Attività che sfocerà dopo la guerra nella costruzione di una vera e propria raffineria inaugurata nel maggio del 1950. La cui gestione ricadrà nel luglio 1963, a causa della sua immatura scomparsa, sulle spalle del figlio Riccardo (classe 1936), giovane di 27 anni, fresco di laurea in chimica industriale. Che per 40 anni portò avanti l’impresa fino a quando nel 2003 decise di passare il bastone del comando ai figli Edoardo e Alessandro e al nipote Giovanni Mondini. Dopo aver promosso negli anni ‘70 la realizzazione a Priolo Gargallo in Sicilia della raffineria Isab, il riscatto nel 1984 della rete Elf e nel 1986 del 100% della Chevron, fino ad arrivare a detenere il 14% della capacità di raffinazione italiana e il 7% della distribuzione di prodotti petroliferi. Un passaggio di consegne avvenuto dieci anni prima della sua scomparsa nel gennaio 2013, quando ormai la strada dell’addio al petrolio della Erg era imboccata anche se bisognerà aspettare il 2016 per certificare che i Garrone “non sono più petrolieri”. Nel caso infine dei Moratti tutto ha inizio con Angelo Moratti (classe 1909) che, dopo aver debuttato anche lui nel commercio dei combustibili, nel 1948, con una tempestiva scelta di tempo, decide di ricostruire ad Augusta una raffineria demolita in Texas, intuendo prima di altri, su input mai smentito di Vincenzo Cazzaniga, l’importanza strategica dell’Italia e della Sicilia lungo le nuove rotte di approvvigionamento del petrolio dal Medio Oriente all’Europa. Costituendo la Rasiom (Raffineria Siciliana degli Oli Minerali) venduta poi nel 1961 alla Esso Italiana, e con il ricavato dando

vita alla Saras che tra il 1962 e il 1965 realizza la raffineria di Sarroch in Sardegna, che iniziò a lavorare nel gennaio 1965 e che oggi, con 15 milioni di tonnellate di capacità, è una delle più grandi del Mediterraneo. Un progetto che Moratti fece in tempo ad illustrare a Mattei sentendosi dare del pazzo. Scomparso nell’estate 1981, quando tra l’altro era vice presidente dell’UP, la guida della Saras passa ai figli Gian Marco (classe 1936) e Massimo (classe 1945). Con Gian Marco che assume da subito la carica di presidente tenuta per 37 anni fino alla sua scomparsa avvenuta nel febbraio 2018. Presidente UP dal 1988 al 1997, nel giugno 1990 mise fine con Pasquale De Vita a quello che lui definì il “muro di Berlino”, la frattura che alla fine del 1957 si era creata tra la componente pubblica e privata dell’industria petrolifera italiana. In coerenza con il ruolo di aggregatore che ha sempre svolto nel corso della sua carriera. Oggi il testimone è passato a Massimo Moratti che da capo famiglia non nasconde la volontà di passarlo alla terza generazione “nonostante negli anni non siano mancate, dice, le tentazioni per uscire invece dal settore, con gruppi stranieri che si sono fatti avanti per rilevare la raffineria”. Mantenendo all’interno della famiglia l’eredità tramandata dal padre Angelo. Non a caso nel piano industriale 2019-2022 sono previsti 800 milioni di euro di investimenti per restare leader operativi e tecnologici nel settore. Che utilità si può trarre da questa carrellata, o sbirciata data dall’esterno, su un mondo che ormai è quasi tutto scomparso e che molti preconizzano essere in via di estinzione? Una carrellata che non può avere neppure le sembianze di una ricostruzione storica data la mole di materiali che è stata in grado solo di sfiorare. Forse quella di favorire un bagno di umiltà per chi oggi, a differenza dei suoi antenati, pensa di sapere già cosa avverrà tra dieci, venti, trent’anni. E potrebbe sbagliarsi di grosso. I protagonisti di questa carrellata e oggetto della nostra sbirciata non sapevano dove stavano andando, sapevano solo da dove venivano: anni bui e tragici. Non erano in grado di fare previsioni. Non avevano bussole per quella che appariva a tutti gli effetti una traversata nel deserto. Ma avevano delle intuizioni e ad esse si affidarono. E gli “anni duri” si tramutarono in “anni d’oro”.