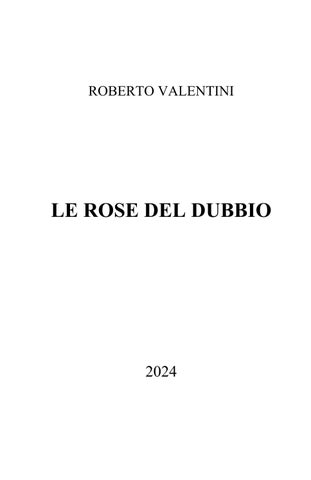LE ROSE DEL DUBBIO
Introduzione
Il volume Le rose del dubbio raccoglieun insieme di prose lirico-filosofiche diverse per genere e argomento, oltre che epoca di stesura, ma comunque accomunate da un discorso imperniato nella fascinazione del dubbio, reiterato in una serie di rimandi annodati sulla collana d’un’unica interrogazione; gli estremi della memoria e dell’effimero offrono cioè uno spazio in cui rintracciare la fragilità della parola e l’ombra del divino, la reinvenzione del tempo e la possibilità dello sguardo, lo specchio della morte e la seduzione dell’eternità.
“Stimare le idee religiose o filosofiche per il loro valore estetico e anche per quel che racchiudono di singolare e meraviglioso. Questo è, forse, indizio di uno scetticismo essenziale”, scrisse Jorge Luis Borges. Praticando una letteratura filosofica che trovi in queste celebri parole un irrinunciabile punto di riferimento (non tanto stilistico o strettamente tematico, quanto metodologico), il filo che si tenta di sdipanare è in definitiva quello avvoltolato nell’avverbio della frase citata, il tentativo di delineare un “pensiero del forse”, un discorso che, al di là di una scepsi puramente negativa, resti in sospeso nella felice aporia e contiguità fra letteratura e filosofia.
Volendo dunque riassumere il contenuto di tali note (alcune svolte nelle maglie di arcani dilemmi metafisici, altre in quelle della pronuncia lirica intorno a una questione o al farsi immagine della domanda), mi limiterò a segnalare che:
“I fiori” aspira a rinvenirne il segreto del nome e della caducità nell’ambivalenza della loro natura, in quella prigione per gli occhi divenuta al contempo un destino da condannati; rassomigliandoli agli ergastolani di Jean Genet,
se ne cercherà in ultimo la cella e lo sguardo cui essi offrono la propria verità.
Ripercorrendone il ruolo fondante lungo la storia del pensiero, dallo scetticismo a Cartesio, da Lao Tse alla tradizione del misticismo, “Il dubbio” propugna il recupero della sua forza illuminante quale soluzione allo stesso interrogativo leibniziano “perché l’essere e non il nulla?”; volgendone la domanda in risposta, la si ritroverà fra i vepri d’un rosaio sul dorso di un’inusitata creatura (da qui il titolo del volume).
“Il corpo della santità” si interroga intorno a tale stato dello spirito, ricercandone il rapporto con la materia; ne contorna perciò la natura con un serto intrecciato di tre ramoscelli: il miracolo, il martirio e la reliquia. Grazie a una peculiare dossografia si propone di esibire il nesso che avvicina la prodigiosa costanza del santo alla carnale vulnerabilitàdei fiori, lafedeltàdel sacrificio allatraboccante voluttà della Vita.
“Il tempo”, intesa quale replica alla celebre confutazione di Borges in Altre Inquisizioni, esamina il paradosso della temporalità per prospettarne un’elisione, un’interruzione che non postuli tuttavia l’identità dei suoi istanti. Accostandosi alle considerazioni di Bergson, Pirandello e Proust azzarda il tentativo di sciogliere la catena cronologica giusto in forza delle sue estasi extratemporali; lasciate con lo stilo dell’effimero in una prossimità o lontananza senza ora, nell’acciotolìo dei passi o nell’ombra di una meridiana.
Nonsenzaunavenaumoristica, “Il linguaggio”ripercorre le rinomate teorie intorno alla sua genesi (dall’antichità sino all’epistemologia novecentesca), risolvendo con piglio eretico l’aporia sommersa sotto la torre di Babele nel brago delle sue lingue; consegnandoci all’augurio di solcarne il mare riottoso e spumeggiante grazie al vaglio d’una parola non detta, lungo il suo andirivieni tra cielo e anima.
“Il labirinto, lo specchio e la rosa. Al centro della Biblioteca” rielabora la metafora coniata da Borges nel celebre racconto La biblioteca di Babele e ne discute il senso delle diverse apparizioni (dalla Sostanza di Spinoza alla monadologia di Leibniz, dallo sviluppo dello Spirito hegeliano all’odierna memoria dell’intelligenza artificiale). Mostrando cosadavverosialaBiblioteca/Universo agli occhi del lettore che ne attraversi la soglia antica e temibile, conclude rispondendo all’interrogativo “perché scrivere”?
“Iconfinidell’occhio” rivisita il millenario predominio dell’organo della visione – l’occhio del sapere –, la fondazione di quella separazione fra luce e ombra, sonno e veglia, conscio e inconscio, soggetto e oggetto in cui si costituisce l’orizzonte del mondo e della filosofia. Soffermandosi sull’impossibilità che l’occhio veda se stesso (regresso che deflagra nell’insituabile infondatezza d’ogni “saperedi sapere”),sovvertendonetaleruolod’artefice lungo i sentieri del mito e della letteratura, descrive infine l’orizzonte di quello sguardo immersivo e accogliente che ci introduce nell’intimità d’una conversione; uno sguardo verticale e ubiquo in cui compiere la trasmutazione del visibile in invisibile e attraversare, ad occhi aperti, lo specchio della morte.
“L’iniqua scommessa della felicità” , formulando un’obiezione “stocastica” alla celeberrima scommessa che Pascal legò all’esistenza di Dio, offre una digressione sulla posta di quella puntata, sulla promessa della felicità rapportata sia all’eterno che al transeunte. Passando dai cirenaici a Kant, da Dostoevskij a Rilke, da Adorno ad Heidegger, da Proust a Chuang-Tzu, tenta di circoscriverne la natura proprio a partire dal suo opposto, dalla prospettiva della perdita della scommessa (costitutivamente iniqua), vale a dire dall’in-felicità come il modo forse più autentico, di abitarne l’evento.
“La tela incompiuta” indugia sul mito di Aracne per esaminare lo scandalo più increscioso del suicidio: l’impossibilità di darsi davvero la morte.
“La delizia dell’inferno”, traendo spunto dalla spaventosa descrizione di padre Arnall nel romanzo Dedalus di Joyce, svolge una riflessione intorno al più torvo attributo degli inferi, all’eternità che ne costituisce l’autentica cifra d’orrore. Considerando come tale sigillo possa rendere ripugnante qualunque stato vi si voglia ammettere, si sofferma sulle conseguenze che essa produrrebbe anche in una interminabile beatitudine, “nella vigilia infinita d’un erebo incruento ma crudele, solennemente affrescato soltanto del suo azzurro letargo”. A illustrazione di tali argomenti si palesa l’emblematico risvolto d’uno dei più celebri dipinti della storia dell’arte.
“La serie di Dio”, principiando da una singolare definizione contenuta in Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico di Alfred Jarry, compie un’escursione attraverso le mutevoli apparizioni dell’infinito attuale nel cielo della filosofia, della matematica e della teologia. Da Aristotele a Galileo, dall’algebra seicentista a Cantor, da Anselmo d’Aosta a Bruno si sdipana, nello stesso labirinto che esso istituisce, il filo d’una concettualità ricorrente e minacciosa,forsenonpertrovarnel’impensabileviad’uscita, ma per perdersi ancor più nel suo mirabile sgomento, per stringerne ulteriormente il fuso del pensiero.
“Mille e una lune” consta di una commemorazione eretica dello sbarco dell’uomo sul nostro satellite. Se per millenni esso ispirò l’immaginario comune e quello di letterati e artisti, l’oltrepassamento di quella frontiera determinòuncambiodiparadigma:l’astronomiadivenneuna fucina di speranze, destini e creazioni, la nuova regola della poesia. Indagando il contrasto fra quella del mondo antico e l’orizzonte del futuro, la nota si interroga sul lascito della sua conquista, sullo spazio impresso fra un’orma abbandonata in
un deserto di cieli e il vessillo d’addio per sempre issato al suo fianco.
“I colori” raccoglie un’estesa riflessione intorno al loro gergo spirituale; nel calco d’una memoria screziata proprio dalle tinte che, contro il detto di Marco Aurelio, il tempo vi rimescola a piacimento e mai egualmente, se ne delinea una sorta di inventario emotivo: il bianco abbacinante dell’infanzia, il blu sapido ed inquieto dell’amore, il rosaceo disfacimento dei tramonti nel lutto della luce, il verde dei rimpianti sui muri dei casolari. In una densa prosa lirica, alternata ad alcuni componimenti in versi, si declina un’autobiografia più che trentennale (in parte debitrice d’un’euforia giovanile) scandita dai luoghi della loro epifania: le cime alpine, le insenature degli arcipelaghi, i crinali delle Cinque Terre, i tramonti greci, i riverberi sui canali veneziani.
Descrivendone la qualità non tanto come frutto accessorio della riflessione – “le realtà sono specchi, non della luce bianca, bensì d’uno spirito insoluto” –, intuendoli come un velario disteso sul mondo, tali estasi del colore/ricordo s’aprono a una teatro speculativo, il solo in cui indovinare l’unica tinta che, seppur posseduta, mai la nostra anima riuscirà davvero a vedere.
Roberto Valentini
I FIORI
Quale segreto nasconde l’urna del fiore se esso da sempre sequestra i sensi con una bellezza sacrilega, con reliquie di profumi, ricordi forse dell’Eden ripudiato e perduto?
Da quella notte l’umanità si ingegna a un incantesimo di tinte per ogni suo rito, per adornare l’ombra della dimora o la tregua del cuore, per far santa la carne o coronare il dolore, per benedire le nozze o il piacere, per avvolgere i defunti in un addio di petali o confinarvi il rigore del cielo. Ecco la castità dei gigli baciata dalle labbra del mattino, la stola dei biancospini arricciarsi sulle braccia della primavera, le filastrocche delle margherite bisbigliate dal vento, l’umore dei gelsomini allattare il puledro del giorno, i forzieri dei girasoli colmarsi dell’avorio di nubi, il tinnito del buio smarrirsi nel viola delle campanule.
Ecosasarebbero unpoetasenzala rosabianca comelasua pena, i sonetti di Shakespeare senza boccioli d’amore, il paradiso di Dante privo della sua mistica rosa o l’irruente tristezza di Lorca dell’amaro riso dei nardi?
Qual è dunque il mistero di questo minuscolo tempio eretto dal sole, con le sue navate di petali e le arcuate colonne d’antere, rigonfi capitelli del polline, con il suo pistillo consacrato al dio come un occulto obelisco?
Là sotto, nella cella dove scrigni di clorofilla proteggono diamanti di radici, sta infine il suo prodigio, il suo impetuoso vigore, il suo inesausto volere. Perché il fiore non è solo l’intimo sesso, il gineceo celato dai veli della prosperosa camelia; esso al contempo è già il ventre rigonfio del frutto, il suo futuro di rigogliose foreste. Se il seme è la sostanza della pianta, l’entelecheia dell’intero sviluppo, la forma originaria raccolta nel suo utero ovale, il fiore non è che l’idea di tutto questo. Sì, ecco ciò che meraviglia i nostri
sguardi: quei piccoli cuori pulsanti sui rami al ritmo degli astri, non sono che l’emblema, l’invenzione, il discorso della metamorfosi. Non quest’ultima, con le sue sterminate propaggini fra le pieghe del creato, nei recessi della materia o nell’incessante ripullulio della vita, ma la sua ragione in sé, invisibile quanto un aroma, custodita da una forma androgina, dalla mistura dei contrari, dal polline d’un pensiero sparso nel mondo solo grazie alla vespa del conflitto.
Il fiore, questo crocefisso di luce sui rami, si dona per riscattare l’effimero, per sostenerne la colpa, per mostrarci come egli pure sbocci sapendo già di spandere gli stami dell’immortalità, e ciò solo per nascere ancora, per tornare ad aprirsi ogni primavera, i candidi bocci trasmutati nella mela della nostalgia. Quanti fiori portano il nome d’un amante perduto. Giacinto ucciso dal disco d’Apollo o Medone cangiato da Demetra nel sogno del papavero. Per questo la rima con l’amore è forse la più antica; perché anche l’amore principia dall’ultimo giorno, perché non esisterebbe senza un accidente o una congiura che vi ponga termine, che ne ostenti l’inganno dell’inconsistenza e dell’inappagato rimando; poiché soltanto sulla margherita della morte s’incontrano e si spiccano, uno dopo l’altro, i volti e le preghiere di Romeo e Giulietta. Anche i fiori amano quando è troppo tardi, quando volere essere altri è già la metamorfosi di Narciso, la nascita nel solco d’uno specchio, morendo del proprio languido aroma, di un’eternità appena intravista. Quanto agognerebbe divenire altro anche la rosa innamorata di sé; forse vorrebbe essere nuvola, uccello o fanciulla, ma non può invece che obbedire alla sua terribile idea, al compito della legge che annunzia “tutto cambia” (tutto tranne la legge), alla sua sorte infinitamente sparpagliata sul recinto degli astri. Fiori partoriti dal pianto, rose di sangue sullo spino della bellezza d’Afrodite o garofani della pietà dal volto della Madonna nati sull’ombra della croce. Così i loro lembi
IL DUBBIO
“La felicità/ sarebbe assaporare l’inesistenza/ pur essendo viventi neppure colti dal dubbio/ di una fine possibile”, scriveva Eugenio Montale in Altri Versi, riassumendo in tale paradosso quel nesso fra esistenza e dubbio che ne segna il percorso lungo i secoli dell’Occidente. Poiché se la sua assenza potrebbe persino lasciarci gustare il sapore friabile dell’inesistenza – “non esisto dunque sono”, declamava Carmelo Bene ne La voce di Narciso –, è proprio nellanebbia del suo quesito a ritrovarsi invece la prova suprema, dalla pietra miliare di Agostino in poi, del nostro essere: nam qui non est, utique nec falli potest, ac per hoc sum, si fallor (“non si può ingannare chi non esiste, se m’inganno per ciò stesso io sono”; La città di Dio, XI, 26). Quel che già Aristotele contestòaldubbiodelloscettico,checioèglibasti aprirbocca per contraddirsi da sé, non necessita di prove per decidere di una cosa almeno: che di tutto si possa diffidare tranne dell’esistenza del dubbio e del dubitante. L’argomento, che nella Metaphysica di Campanella si tinse di rinascimentali coloriture sensistiche – anche lo scettico dovrà ammettere che per dubium l’anima senta se stessa (notitia sui ispius innata) –, sarà in seguito tradotto dalle caravelle di Cartesio, stipato nelle loro argute meditationes, sul mare speculativo del celeberrimo cogito. Venne cioè eretto sulle fondamenta di una certezza, veridicità e realtà (fulcro, al di là della precedente natura della dimostrazione, d’un intero sistema) la cui genitura, occorre non dimenticarlo, fu e resta comunque la requisitoria del dubbio. Altrimenti detto per l’artefice del metodo l’insigne “cogito ergo sum” non scaturì da una autoevidenza immediata del pensiero, ma da una generalizzazione del “dubito ergo sum”: je doute, donc je
suis, ou bien ce qui est la même chose: je pense donc je suis” (da La Recherche de la Vérité par la Lumière naturelle).
Che non sia tuttavia la medesima cosa non è solo l’obiezione di Nietzsche a suggerirlo – da esso si sarebbe potuto derivare non tanto l’Io-sono quanto semmai che “cogitationes sunt” (cfr. Der Wille zur Macht III, n. 484) –, ma proprio l’idea, ammissibile in forza di quella stessa affermazione (“penso dunque dubito”), che non si possa escludere di pensare senza essere; un Dio siffatto, cui il mondo, riconoscendolo, restituiscaunriflessod’esistenzanel cristallo della fede, non è infatti estraneo a tanta parte della tradizione mistico-teologica (un dio che dona l’esistenza poichénon lapossiede), così comenon ènecessario attendere il padre dei Discorsi alla nazione tedesca per rinvenire l’idea di un esse sequitur operari/cogitari, di un agire che preceda l’agente (così Scoto Eriugena tratteggiò il santo teologo Giovanni come plus quam homo, colui che solo immergendosi nel carattere super-essenziale del divino poté coglierne il mistero generativo e annunciare: “in principio erat Verbum”).
Se dunque non fu l’evidenza del nuovo metodo introspettivo a fondare quella dell’Io-sono, ma viceversa proprio l’incertezza posta a suo abbrivo, perché rifuggirla o estirparla dal giardino della metafisica? Non la verità ma il dubbio si profila come baluardo del nostro sapere. Il timore di un dieu trompeur non incrinerebbe la nostra vita più di quanto la vaghezza dell’inganno la possa abbandonare innanzi allo spettro del nulla; quale volere si prenderebbe infatti gioco di noi se il genio maligno alligna forse giusto nel Grund dell’animo o nella spelonca della mente? Nel giardino dei “sentieri che si biforcano”, narrato da Borges quale possibile, crescente coalescenza di temporalità divergenti e convergenti, tale minaccia si riscatterebbe infatti nella traccia del piacere, nella consolazione che, proprio grazie alla
Il CORPO DELLA SANTITÀ
Che cos’è la santità? Se essa indica la complicità dell’uomoallaperfezione celeste,lavocazioneche si realizza imprimendo il sigillo dell’amore al dovere religioso, la mano che plasma l’esistenza modellandola nell’argilla di Cristo, occorrerà forse tracciarne il contorno come l’aureola sul capo delle icone. Non si può forse pensarla senza apporvi un serto intrecciato di tre ramoscelli: il miracolo, il martirio, la reliquia. È proprio nelle spine di questa corona che si palesa allora il suo legame col corpo.
Non v’è santità senza che esso non venga sottoposto a una serie di astinenze e di stenti, ad un ferreo volere che col suo peso vorrebbe assottigliarlo al punto da sfiorarvi l’anima, da farvela uscire per le ferite della carne umiliata. San Giovanni Battista non ne è che l’emblema: percorre il deserto vestito solo di una pelle di cammello, nutrendosi di miele selvatico come un orso, cibandosi di cavallette rimaste imprigionate nella coppa rovente dell’aria. È il modello dell’asceta, dell’anima scheggiata dallo scalpello della solitudine, del diamante serrato nella preghiera e cavato dalla grotta del cuore a forza di rinunce e silenzio; il corpo e i suoi sensi non potranno più offuscarne la trasparenza: “che il vostro sì sia sì e il vostro no sia no”. Il suo insegnamento si prolunga così nelle moltitudini di anacoreti, dal romitaggio di San Girolamo nella Calcide a quello di Santa Rosalia sul monte Pellegrino, dalle lande dell’Oriente alle spelonche dell’Occidente.
Il miracolo non è che il gergo della sua disciplina. Ha sempre un rapporto con la scrittura del corpo: in tutte le guarigioni è l’abbondanza sottratta alle loro membra smunte e nervose a riversarsi su quelle dei malati per sanarne il morbo, l’insania della febbre o la consunzione della morte.
Le stimmate fioriscono sulle mani come gemme sui rami potati, il ruscello delle visioni fluisce dal sensorio, acuito e liberato della materia; quelle di cui, per loro tramite, beneficano gli altri, paiono infine un’emanazione del loro spirito, il volo d’una rondine scesa sugli scrimoli degli occhi attraverso un corpo più terso e sottile del mattino. Così San Francesco predica agli uccelli, si libra con loro sino ad essere avvolto dal fresco tepore dell’alito divino; San Giuseppe da Copertino ealtri ancora levitanosopra questaterra comenubi sollevate dalle dita del sole. Non è un capriccio della fede che li porta a digiuni e mortificazioni, ma l’intransigenza di approssimarsi, in un’altera letizia, all’insondabile sostanza divina.
Sì, il santo chiede un corpo di luce, un corpo che possa raggiungere ovunque, con la sua esangue delicatezza, il desiderio dei credenti; anela risolversi in un’essenza, un riflesso sul cristallo dello Spirito cui corrisponda un fremito nella realtà circostante. Così, durante la pestilenza del ’600, nella grotta di Santa Rosalia un’ammorbata guarì bevendo l’acqua che vi gocciolava come il pianto dalle ciglia della santa. Quando poi le apparì in una bianca veste indicandole il luogo dei suoi resti, le reliquie vennero condotte in processione tra i vicoli madidi e insalubri, fra le case incrostate di bellezza e di morte; soltanto al cospetto delle cupole il suo teschio sarebbe potuto divenire un aspersorio di grazia.
La carne del santo finisce per trasfigurarsi e compenetrarsi in una natura totalmente spiritualizzata, facendola partecipe della propria fine o chiedendole di risparmiare all’uomo i suoi incolpevoli mali: le serpi negli anfratti dei sentieri, i corbasci dei venti, i rovinosi singulti della terra (solamente l’addolorato terremoto che seguì all’introduzione di Sant’Agata nella fornace, conferì al suo rosso velo il potere di contenerne il respiro di lava). È un corpo espansivo e glorioso, per la lunga siccità del suo sforzo talmente rigonfio
IL LINGUAGGIO
“Forse che quella che chiamiamo rosa cesserebbe d’avere il suo profumo se la chiamassimo con altro nome?” (Romeo e Giulietta; Atto II, Scena II); il quesito di Giulietta, quasi offerto all’altare del convenzionalismo anziché al tributo assolutorio dell’amato, sembra trascurare che i suoi petali somiglino più a voci nel vento che non alla semplice lamina variopinta incoronata dal nettario. Sì, petali che ricordano l’alito che li scuote come il male dei fiori, refolo inane della parola: “un non dico niente che, così risuona. Non dico niente. Soffio di vento, divento soffio. Importa solamente come suono questo non dico niente” (Carmelo Bene, Quattro momenti su tutto il nulla).
Eppure, grazie ad esso, anche le cose che ci chiedono asilo trovano la pace d’essere state (dette) almeno una volta. E dove potrebbe aversi tale riposo se non nella pronuncia che al contempo le uccide,imponendovi il nome?Certo,tenerem verba sequentur, recita l’adagio, ma una rosa non è affatto un semplice confuso assieme di macchie o di odori, bensì, come scrive la poetessa, lo specchio del (suo) nome: “una rosa è una rosa è una rosa” … Ormai soltanto la parola ne custodisce la vita. Per questo ci parla, forse, d’uno strazio incompiuto; inesauribile arrestarsi dell’assassinio sulla soglia del suo gesto tardivo. Recitando ancora Bene: “lo so, mi sa che il nostro delirare in voce è un differire la morte, ché noi si muore appena abbiamo smesso di parlare, appena abbiamo smesso l’illusione d’essere nel discorso” (Ibid.). Chi uccide col nome perisce dunque di silenzio; il crimine tocca tanto lo sguardo che la cosa, il soggetto che l’oggetto; il linguaggio rimescola sempre a piacimento, e in seconda battuta, la scena del misfatto, al punto che soltanto per sua intercessione ci possiamo felicemente ingannare nella lusinga di un fiore e
dai profumi saliti ai presagi del cuore riudirne il grido trionfale: “l’uomo dà prova di riflessione […] quando emergendo dall’interno aleggiante sogno di immagini che gli trascorre innanzi è in grado di raccogliersi in un momento di veglia, di indugiare volontariamente [N.B.] su un’unica immagine, sottoporla ad un’osservazione chiara più tranquilla, distinguerne i caratteri […] Benissimo! Gridiamo con lui eureka! Questo primo contrassegno dell’intenzione è la parola dell’anima! Con ciò è stato inventato il linguaggio umano!” (J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache) Ahinoi! La fanfara della coscienza intona così la lode dell’intenzione e della conseguente convenzione, ignorando tuttavia che essa non preesiste al linguaggio e al suo ordine simbolico, che mai potrebbe forgiarlo né folgorarlo, nemmeno nella più herderiana delle notti assopite di grida. Cos’è infatti quella “osservazione in grado di distinguere i caratteri” se non già l’usura d’una semiosi? Il pensiero accade solo quale articolazione del linguaggio, dentro quest’ultimo; immaginare che la nostra intenzione possa averlo volontariamente creato equivarrebbe ad affermare l’atavico paradosso d’un pensiero prima del pensiero. Varrà forse ritenere che sia piuttosto il linguaggio ad essersi imposto all’umanità, ad averne fecondata la curiosità partorendovi l’anima; che le ancestrali testimonianze d’un segno nelle pitture rupestri, quelle tinte ocra e manganese assieme ai loro contorni anneriti, fossero già convenuti, prima dei loro artefici, nella selce degli scalpelli e nelle pareti delle grotte. Sì, il linguaggio è un sogno del possibile miracolosamente apparso in una mente illogica e caotica, una generosa virtualità del mondo, un fiore sbocciato sul suo ramo quando questo si offrì in un tessuto di grafi, pronto ad essere tratto dalla conceria del Caso e gettato dalle laboriose dita d’un lemure, al pari d’una pelle di montone, sulle gracili spalle dell’uomo.
Né d’altro canto gioverebbe stare con Cratilo ed Antistene contro eleati, megarici e la sofistica Giulietta (ritenere cioè che esso non sia frutto dell’arbitrio, ma che siano state le suppellettili e gli esseri dell’Eden a suggerire i nomi all’ascolto di Adamo); basti pensare a tempi assai meno remoti e a teorie realistiche basate su una semantica dei “designatori rigidi” per ritrovarsi, nello stesso roveto ardente dell’episteme, in un cafarnao di dilemmi, primo fra tutti l’ammettere un’inaudita necessità a posteriori che leghi il linguaggio all’essenza, metafisica, delle cose; ma si sa la scienza in fondo lo è… Perché, fosse pur vero quanto si diceva in precedenza, altrettanto lo è che il linguaggio, come un crivello passato tra le acque eraclitee, setaccia il mondo separandone le pagliuzze in base alle intensioni, o ai concetti, che di volta in volta si associno ai nomi. Proprio la scienza contemporanea offre una chiara ostensione delle loro reliquie quando ribadisce come al variare di tali proprietà cambi il riferimento ritagliato nella realtà: se ad esempio l’oro, descritto ed individuato grazie a precise caratteristiche chimico-fisiche, fosse concepito in base ad un diverso peso atomico, ciò che prima lo era non sarebbe più oro, mentre ciò che prima non lo era lo diverrebbe. Sono allora i nomi, taglienti lame del tempo, a sgretolare il granito del creato cavandonei calchidelle cose,nonquest’ultimeadeterminare i primi.
In un approccio naturalistico di questo tipo come si potrebbe poi distinguere fra la dignità di quello “XYZ” dell’acqua sulla “Terra gemella” d’un celebre esempio (il quale, ammesso e non concesso che tale ne sia l’ousia, continuerebbe a designare la molecola H2O, anche supponendo un pianeta analogo al nostro ma con un linguaggio ignoto e imperscrutabile) e i nomi “flogisto”, “drago” o “sirena” che, contraddittoriamente, non dovrebbero invece avere (e perché poi?) più nessuna realtà corrispondente? Se fosse il silenzio del mondo a dettarceli,
L’AZZARDOPOSSIBILE
Cosa significa “azzardo”? L’etimologia, dall’arabo azzhar, ne suggella il senso nell’atto di lanciare i dadi, come se essi rovesciassero sopra un’asse consumata dagli occhi un essere computabile, il compito di contarsi forse, d’appartenere segretamente a un’accolita, di condividere una perdita o un guadagno (di largire così anche un modello sociale).“Quandosi parte il giocodelazara,/ Coluicheperde si riman dolente,/ Ripetendo le volte, e tristo impara” (Dante, Purgatorio, VI, 1-3). La zara, tanto diffusa nel medioevo in tutti i paesi d’Europa, chiedeva appunto di dichiarare preventivamente, ad alta voce, il totale dei punti che si sarebbero realizzati con tre dadi. Quasi che l’azzardo volesse farsi predizione, astuzia del calcolo, docile imprevisto soffiato sul pugno del giocatore, sulla superficie del dado per scostarne una sottile polvere d’eventi. Un filo invisibile sembra invece tenerli legati, stretti assieme, alle galassie, agli stormi d’uccelli o alle geometrie dei cristalli; farli rotolare comelestellesull’orizzonte,isassinel silenziod’unapietraia o le conchiglie nelle spume della risacca. Qualcosa li congiunge, non possono allontanarsi, sfuggire l’uno all’altro, così come noi non possiamo sottrarci al loro accadere, a ciò che essi designano rimbalzando sulla sponda d’un addio. Anche il tavolo da gioco non viene prima della loro risposta, ma sembra sorreggerla sul piedistallo d’una domanda incrinata. Cosa descrivono dunque nella loro caduta, cosa ritraggono dalla bisca del cielo se non la linea di quel destino da cui non ci si potrà esimere: “Un coup de dés jamais n'abolira le Hasard”…! Non è appunto l’Azzardo l’incalcolabilecheliscagliaeriprendealparidellenostrevite (questo ci mostra la vicenda del protagonista nel film “Vivere!” di Zhang Yimou)? Esso ha dunque poco da
condividere con le permutazioni delle probabilità e con la calibrazione stocastica, viceversa inscena quanto la cancella efadel gioco,di qualsiasi gioco,l’arenadi un combattimento impari, quello fra l’uomo e il toro del Caso, fra l’intelligenza e la mostruosità dell’Essere, fra l’eroe e il labirinto in cui rinvenire la propria essenza bifronte e impensabile (connubio di ragione e follia, minotauro di volontà ed istinti). L’azzardo ci dice appunto che tutto è gioco: l’amore, la guerra, l’economia, l’arte, la matematica e la scienza di Basilio o di Prospero; che l’essenza del gioco è l’abisso “in cui cade la prima ritmica attesa del disastro”, in cui sprofonda il marinaio coi dadi stretti tra le mani, in cui naufraga la scommessa di Pascal e l’incalcolabile si fa beffe della mathesis universalis, sino a che, forse con un efferato gioco da nulla, un ultimo lancio celebri pure l’assenza degli dei, poiché “ogni pensiero emette un tiro di dadi” (Mallarmé)
Come si potrebbe allora liberare la sua possibilità dalla ferrea Moira della necessità, non avere più bisogno di impastarlo con la sua calce, di erigerlo sulla volontà di Dio o sull’invariabile prodigalità dell’essere? Non occorrerebbe forse una purezza della contingenza? Avventurarsi in un azzardo, ritenere cioè che l’intero possibile (ciò la cui negazione, aristotelicamente, non è necessariamente falsa; ciò che potrebbe persino svelare la menzogna del mondo), come un numero mai comparso sulle facce dei dadi, possa davvero non essere, precipitare nel vuoto con la rondine fuggita dal nido, inverare improvvisamente il prodigio dei versi montaliani: “forse un mattino andando in un’aria di vetro,/ arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:/ il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro/ di me, con un terrore di ubriaco” (Montale, Ossi di seppia). Ma è impossibile che nulla sia possibile – replica l’“unico argomento” leibnizianokantiano –, ealloragiustotalesupposizione ci costringerebbe ancora ad ammettere, e contingentia mundi, l’Essere necessario, ancorando infine nella sua mente il computo di
L’INIQUA SCOMMESSA DELLA FELICITÀ
Una delle più celebri sfide che la storia del pensiero abbia conosciutoècertamentequellaformulatadaBlaisePascal nei Pensieri, la sua avveduta scommessa sull’esistenza di Dio. Poiché la ragione non è in grado di spingerci a puntarvi “testa o croce” (non potendo escludere nessuna delle due), occorrerebbe, secondo il filosofo portorealista, spostare la considerazione dalla posta, rispetto a cui ci separa un “caos infinito”, alla natura di tale azzardo. Come egli osserva:
Siccome c’è eguale probabilità di vincita e di perdita, se aveste da guadagnare solamente due vite contro una, vi converrebbe già scommettere. Ma, se ce ne fossero da guadagnare tre, dovreste giocare (poiché vi trovate nella necessità di farlo); e, dacché siete obbligato a giocare, sareste imprudente a non rischiare la vostra vita per guadagnarne tre in un giuoco nel quale c’è eguale probabilità di vincere e di perdere. Ma qui c’è un’eternità di vita e di beatitudine. Stando così le cose, quand’anche ci fosse un’infinità di casi, di cui uno solo in vostro favore, avreste pure sempre ragione di scommettere uno per avere due; e agireste senza criterio, se, essendo obbligato a giocare, rifiutaste di arrischiare una vita contro tre in un giuoco in cui, su un’infinità di probabilità, ce ne fosse per voi una sola, quando ci fosse da guadagnare un’infinità di vita infinitamente beata (B. Pascal, Pensieri, 233).
L’argomento, per quanto avvincente risulti la metafora della moneta della fede gettata nella bisca della nostra incredulità,lasciatuttavia spazio apiù di qualchedubbio, non soltanto per il suo tiepido accoglimento teologico, ma per le stesse implicazioni probabilistiche che esso invoca. Restando dunque sul tavolo dell’eternità, nell’alea degli innumeri eoni che vi rotolano come dadi lanciati da una Moira inflessibile
(mentre Dio medesimo trattiene forse il sospiro con noi: l’esito favorevole sarebbe una vittoria anche per lui), occorre valutare anzitutto se il detto di Pascal, così formulato, possa dare luogo ad una puntata non solo allettante, ma anche equanime. Come noto, finché una scommessa lo sia, l’aspettativa di vincita del giocatore – ricavata dalla somma dei prodotti fra il guadagno e le probabilità favorevoli e fra la perdita e la probabilità avverse – dovrebbe essere pari a zero (se negativa sarebbe iniqua mentre se positiva financo favorevole).
Appare allora singolare che si sostenga che “quand’anche ci fosse un’infinità di casi, di cui uno solo in vostro favore, avreste pure sempre ragione di scommettere uno per avere due”; che venga cioè risolta in modo abbastanza istintivo e incongruente la trattazione d’un oggetto vertiginoso come l’infinità; che ci si limiti cioè a riconoscere il solo svantaggio di un’“infinità di probabilità di perdere” (“questo tronca ogni incertezza: dovunque ci sia l’infinito, e non ci sia un’infinità di probabilità di perdere contro quella di vincere, non c’è da esitare:bisognadartutto”).Siconsiderianzituttotaleenfatica accentuazione del ragionamento. Se volessimo scrivere i suoi elementi su due righe (sulla prima sia posto il guadagno e sulla seconda la corrispettiva probabilità) si avrebbe, dove x sia la perdita: + ∞ x 1/∞ 1 – 1/∞
Da cui un’aspettativa aleatoria = (+ ∞ ∙ 0) + x che in quanto tale non può avere significato essendo la formula “+ ∞ ∙ 0” indeterminata; più immediatamente basterebbe osservare che già il fatto di ritenere una possibilità concreta quella d’una probabilità su infinite non può che urtare contro la ragione se, mathematice loquendo, il rapporto 1/∞ = 0; in
tal caso si sarebbe dunque proclamata la sicurezza di non poter vincere e la certezza (pari a 1) di perdere.
Ovviamente non si vuole ridurre la portata dell’argomento a tale iperbole persuasiva. Si consideri invece quanto nel testo viene poco prima asserito, ovvero che le probabilità di vincita e perdita si eguaglino (“in un giuoco nel quale c’è eguale probabilità di vincere e di perdere”) come si suppone nellanciodi unamonetaconcuisiscommetta“testaocroce”, assumendole cioè entrambe pari a ½.
È del tutto evidente che in questa situazione l’aspettativa sarebbe addirittura infinitamente favorevole! Occorre pertanto che non ci si limiti alla scontata conseguenza di una possibile vincita infinita, ciò che farebbe saltare il banco rendendo ininfluente qualsivoglia obiezione, ma che ci soffermi invece sui presupposti della giocata, sull’indebita e sorprendentemente sbrigativa attribuzione delle probabilità di successo. Ricondurla a due eventi equiprobabili, come nel lancio di una moneta, sconta in massimo grado tutte le perplessità di un assunto probabilistico classico; al di là della sua circolarità definitoria tale approccio finisce infatti per apparire assurdo rispetto a una realtà di cui non si abbia alcuna conoscenza: se ha poco senso domandarsi quali siano le possibilità d’essere o meno vivi domani ed equipararle artificiosamente a ½, ciò si rivela ancor più irragionevole in rapporto all’esistere di Dio. Se assumere d’altro canto un approccio frequentista sarebbe semplicemente paradossale, non resta che ammettere che la probabilità dell’esistenza divina vada intesa secondo un’impostazione “soggettivista” (nella più stretta accezione stocastica del termine), quella per cui la probabilità è cioè “il grado di fiducia di un osservatore al verificarsi di un evento”.
Contro l’apoftegma di Pascal lo scommettitore ateo potrebbe dunque ben ritenere, del tutto ragionevolmente dal suo punto di vista, di non volere rischiare la vita e i suoi beni in una scommessa che egli trovi semplicemente iniqua –
LA SERIE DI DIO
“Dio è il punto tangente di zero e dell’infinito”, così scriveva Alfred Jarry nel suo Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico, sorta di negromante moderno, mistura di uomo e marionetta, mito e caricatura, pronto a viaggiare attraverso la membrana elastica di un liquido sull’altrettanto capillare superficie del pensiero; in nome della patafisica, “scienza delle soluzioni immaginarie”, nel XLI paragrafo dell’opera si ritrova una sorprendente deduzione dell’estensione divina che, sussunta dalla rappresentazione simbolica del triangolo, ne ricava la conclusione ricordata.
L’associazione di Dio a concetti geometrici e soluzioni matematiche è d’altronde un artificio ricorrente dell’ingegno filosofico; il rapsodo Senofane da Colofone per primo lo assimilò alla sfera eterna poi ripresa da Parmenide e tramandata dal Corpus Hermeticum sino all’ultimo capitolo dell’ultimo librodi Pantagruel16; il pitagoricoLiside affermò di pensarlo come un numero irrazionale, Nicola Cusano ne rinvenne i “segni” nella retta quale misura dell’infinità delle linee curve e simbolo del rapporto che intercorre fra l’universo e Dio; Vincenzo Gioberti ritenne il continuo la più fulgida immagine dello stato di metessi (la partecipazione alla sua perfezione), del passaggio fra l’Ente e l’esistente operato dal Verbo come diastema fra punctua spaziali o instantes temporali. Se D’altra parte già Dante narrò la prima visione di Dio come punto che indivisibile e incommensurabile ne figura unità e infinita semplicità e come principio della linea l’infinita potenza, l’audacia del
16 Su tale argomento si veda l’interessante ricognizione di Borges nella nota “La sfera di Pascal” (J. Borges, Altre inquisizioni, in: Tutte le opere, Mondadori, 1984, vol. I, p. 911).
sacerdote piemontese colse la piega della creazione proprio nell’impulso impresso da Dio nel continuo, nel conato che questo ne riceverebbe parimenti a quello che, nella prospettiva aristotelico-dantesca, dall’amore divino irradia il movimento infinitamente veloce del primo cerchio angelico: “distante intorno al punto un cerchio d’igne/ si girava sì ratto, ch’avria vinto/ quel moto che più tosto il mondo cigne” (Dante, Divina Commedia, Par. XXVIII, 25-27).
Non occorre dunque sorprendersi per la dimostrazione desunta dal triangolo equilatero che ritrae le infinite Persone della Trinità; scrutando piuttosto la costellazione immaginaria del dottor Faustroll (cachinno del connubio tra Faust e troll, “folletto”), proprio tali congetture suggeriscono ulteriori esercizi di patafisica che – come si tenterà di dimostrare – singolarmente approdano all’universo di Bruno e al transfinito cantoriano, a loro volta fondandosi sulla più suggestiva, controversa e in fondo inappuntabile (nell’immanenza autosufficiente del pensiero) delle prove dell’esistenza divina: il dibattuto argomento ontologico di Sant’Anselmo d’Aosta. Ricordando come per questi il concetto di Dio che avremmo nell’intelletto – “aliquid quo nihil maius cogitari possit” – è propriamente quello d’un’infinitàin atto, non saràinopportuno, primadi vagliarne la consumata occorrenza nel cosmo della metafisica, ripercorrere i fragorosi bagliori che la sua (ab-surda) natura ha lungo i secoli tracciato nel cielo delle idee.
Dopo l’ostracismo greco sentenziato dalla solenne ripulsa aristotelica, l’infinito attuale ebbe infatti un corso sotterraneo che lentamente lo portò a riemergere dai carsici ipogei della speculazione. Nella prospettiva matematica, affinché se ne sperimentasse un’apparizione più significativa dei sophysmata physicalia dei calculatores scolastici (con le loro opposizioni fra naturaliter e mathematice loquendo), aggirato il “rasoio di Ockham” si dovette attendere sino alla ribelle affermazione degli indivisibili di Cavalieri e Torricelli,
ove Dio sia inteso “in tutto il mondo ed in ciascuna sua parte totalmente et infinitamente” e U sia l’universo, assieme alla dialettica fra Tutto e parti (il primo è in ognuna di esse proprio perché non si riduce a nessuna), si abbia anche:
Dio = ǀUǀ < ǀ 2U ǀ< ǀ22Uǀ< …..
Per tale relazione (in base al noto teorema per cui l’insieme delle parti risulta avere potenza superiore all’insiemedato)econsiderandol’infinitàd’ogniporziuncola del cosmo sotto la tutela della metessi divina, si dovrà allora ammettere che Dio non sia altro che il comparteciparsi di tutte quante; con la più grande meraviglia la classe aperta degli insiemi infiniti (non potendosi ovviamente evocare l’antinomia dell’“insieme di tutti gli insiemi”) finirebbe inconcepibilmente per risultare già in ognuno dei suoi termini21: la classe dei transfiniti che si perde come la scala di Giobbe nella sommità dei cieli, alla maniera di un dipinto di Escher estrofletterebbe da ogni suo piolo la stessa volta cui si proietta. Volendo quindi scrivere la formula dell’Onnipotente, con la spregiudicata finzione di una sommatoria sovvertitrice d’ogni nostra regola matematica, avremo che:
Dio
Dio
21 Portando alle estreme conseguenze la definizione di Dedekind – un insieme è infinito quando è equipotente a un suo sottoinsieme proprio – si dovrà allora affermare che l’“insieme-Dio” lo sia di tutti i suoi sottoinsiemi infiniti.
MILLE E UNA LUNE
(Commemorazione eretica del primo sbarco sulla Luna)
Mezzo secolo fa l’allunaggio… Mai visto, troppo visto, veduto per sempre. Se quel piccolo passo fu grande per l’umanità, lo fu più ancora per l’avallo dell’astro. Sì la luna, la luna che per millenni annodò il filo dei sospiri, che colmò la sete nelle grotte degli eremiti e, lasciando brucare l’erba della sua luce, rischiarò gli altipiani sul bastone dei pastori, la luna che beccheggiò sulle vele delle navi e fuse il suo argento nei calchi delle cupole, che mescolò il suo candore al volto della Sulamita e si fece ramo all’allodola o preghiera ai fiori, sì, la luna dei poeti e dei santi lasciò cadere il velo del suo incanto, troppo, troppo esiguo mistero per noi, e permise che un’orma, come quella d’un abbraccio su un corpo, restasse per sempre sul suolo, sul suo nudo fulgore di spazio. La divinità fuggì e da quel momento si consegnò come un qualunque ammasso di roccia celeste, si prostrò al glorioso trionfo della scienza, al nuovo disegno di Faust, ad altro “folle volo” che purtuttavia non si concluse con la prora schiantata e precipitata nel gorgo del buio. Già, nonostante lo si lambì trattenendovi il fiato – la famigerata incognita “Houston, abbiamo avuto un problema” non fece, come nell’odissea di 2001, scoprire al tenero computer di bordo l’errore della verità –, nonostante tanto timore la luna non si rivelò la montagna del Purgatorio. L’uomo oltrepassò ancora le colonne d’Ercole, ma Dio non volle punirlo; forse assente o forse distratto, lasciò che la sorella d’Aurora concedesse non solo di scendere sul suo grembo incontaminato, ma anche di fuggirsene dopo avervi imposto il tremulo bacio, l’imperioso sigillo della nostra debolezza. La luna chiuse per sempre le palpebre del sogno, trafitta dal modulo Eagle come dal razzo di Le voyage dans la lune di Georges Méliès
(l’invenzione dei Lumière non è in fondo che una replica del grande cinema dell’Universo). Addio dunque alle visioni dell’Ariosto, al paladino Astolfo portato sul carro d’Elia in cerca del senno d’Orlando: “Altri fiumi, altri laghi, altre campagne/ sono là su, che non son qui tra noi; / altri piani, altre valli, altre montagne,/ c'han le cittadi, hanno i castelli suoi,/ […] e vi sono ample e solitarie selve, /ove le ninfe ognor cacciano belve” (Ariosto, Orlando furioso, XXXIV, 72). Addio a Caino rifugiato in un pianto di crateri e cosparso daunfasciodispine(quellechelacredenzapopolareriteneva fossero le sue macchie); addio a quel cielo che consentì di orientarsi persino nella fosca gravità dell’Inferno dantesco –“e già iernotte fu la luna tonda:/ ben ten de' ricordar, ché non ti nocque/ alcuna volta per la selva fonda. (Dante, Divina Commedia, Inf. XX 127-129).
Sì, addio ancheal suo volto, al lumetremolanteenebuloso tra i rami della selva e i cigli della giovinezza, quella di Leopardiediogninostro,cosìdiverso,cosìegualerimpianto. Quelle fantasie, quelle immagini, quel lirismo furono soppiantati da altri. Per la prima volta l’umanità coltivò il miraggio di rendere tangibile ciò che nel pensiero v’è di impensabile, di mettere piede sul terreno degli astri, sull’esteriorità, sul fuori, sul bordo siderale che contorna la nostra esistenza. Così la sabbia delle sue lande ci lasciò nelle mani i granelli dell’immensità sognata da Bruno. Il desiderio prese alla gola e divorò persino la paura residua; il satellite divenne ponte immaginifico: non avremmo più smesso di cercavi il monolite sepolto, la sua voce aliena rinviata dall’origine perduta sin “oltre l’infinito”. L’astronomia diventò una fucina di speranze, destini, creazioni, la nuova regola della poesia (a cosa corrispose tale sovraesposizione selenica ben ce lo espresse la luna di Kubrick, destinataria di una riflessione senza via d’uscita, specchio dell’abbaglio solare, di un interrogativo preso in un gioco di fuochi, urente intrattenimento del fuoco/pensiero).
Certo posso soltanto immaginarmi quale delicato e irresistibile stupore abbia accompagnato l’attesa di quell’Evento, forse il più imponente e ancestrale nell’epifania del nuovo volere, in questo pienamente religioso(comeognigrandeeventoesso era un’attesad’oblii, la sua augurale impossibilità di compiersi del tutto). O forse non posso nemmeno immaginarlo provando per chi lo consumò sui miseri schermi in bianco e nero d’allora, la stessa invidia che avrei potuto nutrire per gli abitanti della Galilea sconvolti dall’incontro di Cristo. Forse quel frammento d’emozione intatta, opaca ma precisa che tuttavia riesco ad avvertirvi deve allora essermi giunto da ciò che colmò, con milioni di altri, gli occhi di mia madre e che lei, nella placenta del cosmo, già si apprestava a mostrarmi con la sua virtù generatrice, compulsando dolci riverberi sul cordone che ci avrebbe uniti, di lì a poco, nel suo grembo di luna.
Oggi nessuno scriverebbe più versi alla nostra languida compagna, né la fisserebbe tra promontori selvaggi e marine comeinundipintodiFriedrichodialtripaesaggidellapittura romantica. Abbiamo ucciso il chiaro di luna; ciò che non riuscì alla macchina a vapore fu più semplice per il calcolatore. Niente più lune assopite come rane d’oro nello stagno di Esenin, lune d’occhi increduli perse nell’azzurro dei quadri di Mirò, rosse come dorsi di tori nell’arena dei promontori dove si spezzano i muggiti del mare, lune di zafferanoscheggiatesui muriditufo,bianchedipolveresugli sterridove veglianoi giochidei fanciulli,salmastred’argento sugli aloni dei pontili, corrugate tra le fronde di limoni o tonde come un monile rotolato sulle tegole dei borghi; niente più lune a cui ordinare le maree e la follia, a cui appendere sui canali veneziani palagi di cartapesta, a cui invocare ripari d’ululati e asilo per i viandanti. Niente più, o forse no…
Non è infatti proprio la letteratura a restituirci il segreto, a darci la ragione del suo compassionevole gesto, a sussurrarci
nei profetici versi dell’Ariosto perché essa si sia ritratta da sé, lasciando violare il sogno e scrutare il mondo coi suoi occhi? Oh non è forse proprio perché da lassù “ebbe Astolfo doppia meraviglia:/ che quel paese appresso era sì grande,/ il quale a un picciol tondo rassimiglia/ a noi che lo miriam da queste bande;/ e ch'aguzzar conviengli ambe le ciglia,/s'indi la terra e'l mar ch'intornospande,/ discernervuol” (Ariosto, Orlando furioso, XXXIV, 71).
Non lo fece proprio per questo? Perché potessimo scorgere all’unisono che il nostro orbe terracqueo, la nostra così trascurata dimora, potesse tenersi in un solo sguardo e poggiarsi su una mano simile a una sfera di cristallo o un frutto del paradiso? Che perciò dovesse essere dell’intera Umanità, di tutti e di nessuno, festa di popoli, pace e fede racchiusa nell’iride d’un solo uomo, coperto dalla pesante tuta spaziale, dalla stola d’un annuncio.
Passata la sbornia che fu tuttavia di quella primizia del cosmo? Ci restò certo il nostro incrollabile piacere di valicare un confine, di usurpare il mistero, di calpestare altri terreni. Sì, calpestare e conquistare, ecco l’antico e infelice tripudio, abbandonato anche lì, sul suolo lunare, inciso su una lapide con lo stilo del potere e lo scandalo del suo nome, conficcato dall’asta d’una bandiera come una picca nel corpo del nemico. Già, perché presto derubricammo la luna come una spoglia sull’ara del nostro progresso, un corpo morto appunto, un satellite esanime su cui non sarebbe valso più nemmeno la pena tornare, dacché la scienza s’era riconfermata scenario di guerra e sulla Terra nulla era cambiato (anzi!). Vi eravamo giunti una, più volte, ma forse fu davvero come non vi fossimo mai arrivati… Continuammo a pungerla con gli aghi delle sonde quasi a cercare di rianimarla, di ritrovarvi sete sotto le rocce, ma ormai noi, noi soli ne avevamo preteso l’addio. Avevamo osato più di quanto avremmo potuto e meno di quanto avremmo dovuto. In fondo, improvvisati nomadi dello
spazio, ci limitammo a compiere una fugace scorreria senza nemmeno parlarci nel tepore d’una tenda; sì, avevamo provato l’ebrezza di lasciare un’impronta, eterna inezia sul deserto del cielo, senza nemmeno imparare da un piccolo principe, a coltivarvi una rosa….
I COLORI
Ho conosciuto i colori, i colori della terra, degli autunni trapunti di nebbia e ginepri, delle primavere giunte dai turiboli dei giacinti, dell’afa tremula fra i miti leandri, delle cascine serrate nel muggito del gelo; quante volte me ne giunsero le tinte dalle epoche più lontane. Conservare l’impressione d’un colore è suscitarne un prodigio di miscugli, diluirvi con l’acqua del pensiero i grumi dell’esistenza, ritrovarsi nel malleabile flusso d’un ricordo per cavarne il sapore dal favo dell’inconsistenza.
Così vidi dalle finestre la mia infanzia, la soffice apparenza della neve, la stola posata sulle braccia dei pini; la stessachem’abbacinò di spettrisugli orli dei ghiacciai,creste in cui affondano i nostri destini ed anche la clemenza della roccia soccombe alle profondità dei seracchi.
Oh, lande di chiarore, distese dell’aria più tersa, lume recluso fra i biocchi per resistere alla ferita dei chiodi, biancore d’acciaio e neve di muli... Là, sulle vette, il tuo riflesso mordeva le labbra impedendo di proferire parola; ovunque, nel volto impervio del primo mattino, una biacca d’avorio sfarinava quel trucco, la scarna cipria del giorno su un’accondiscendente chiostra di rupi. Quell’aria di gelo intirizziva le mani sopra al precipizio degli occhi, ostinatamente rivolti a un’aureola di croci sui monti. Eppure lassù tutto appariva protetto da quel bianco refrattario, impenetrabile al tempo; quale cruccio m’avrebbe svelato che quel manto senza peso non fu che la simmetria del vuoto, un’evanescente muraglia di fiocchi; che quella coscienza fu solo il resto d’un cristallo di dubbio fra la grandezza delle cime, fra i bivacchi dei nostri silenzi...
“Dove sono le nevi d’un tempo che l’aprile ha disciolto?” Quelle che vide Villon furono poi così diverse? Forse lo
furono molto più quelle delle montagne dove la fanciullezza trascorse, ignara di sé come i boschi circostanti e le loro inesorabili estati. Bianco accecante della nascita, bianco d’addii sulla corteccia delle betulle, niente ci è più estraneo del suo accrescersi: vello di pudoresottoil rasoio d’unultimo sguardo, tela immacolata che sempre ci accompagna finché esso vi rimuova, anziché accoglierlo, il nostro ritratto.
Perché sì, la talpa del ricordo scompagina il proprio terreno quasi scavasse cunicoli, facendo crollare i giorni vissuti solo cercando di raggiungerne uno. Ma se il ricordo rimuove quei grani dalla rena del nulla, non può che esserne una adulterazione costante, una forma trafugata d’oblio, una venerabile reliquia d’assenza.
Le orme lasciate sulla sabbia e rapite da una mareggiata, i ciottoli smossi dall’onda come nomi cancellati in un risucchio sono allora tracce impresse dal nostro domani, non più segni del passato. L’anima stessa non è forse un’altra memoria, un’ombra di quel che saremo lasciata sulla soglia del tempo come le alghe fra le onde?
Così ne rivedo le brune propaggini addensarsi alla riva, anime che tentavano di risalire dal mare; distese viscose di erbe allagate, appigliate alle scogliere sugli ultimi confini della terra, giusto prima che si concedano, loro soltanto, ad un lutto d’abissi.
Oh, il colore degli abissi! Lo stesso che intuii fra la vertigine delle altezze, tra i banchi dei ghiacci sulle frane del cielo… Poche volte lo intravidi scendendo dagli scogli o nell’approdo delle barche.
A Salina lo scorsi dall’orlo della prua, fra le screziature dell’acqua, in una conca di zaffiri. Le sabbie rovesciate là sotto da una vecchia cava effondevano una luce di pomice lungo le sue pareti impalpabili; nel suo rarefarsi si percepiva un mattino sommerso, un corpo trafitto di raggi che s’estingueva, simile a uno sfolgorio nel crepuscolo, scivolando sui suoi contorni turchesi, quasi ci si vedesse
INDICE
5 Introduzione
13 I fiori
17 Il dubbio
23 Il corpo della santità
33 Il tempo
45 Il linguaggio
51 Il labirinto, lo specchio, la rosa
69 L’azzardo possibile
73 I confini dell’occhio
81 L’iniqua scommessa della felicità
91 La tela incompiuta
95 La delizia dell’inferno
101 La lettera infinita
107 La serie di Dio
117 Mille e una lune
123 L’ultima isola
127 I colori
139 Indice