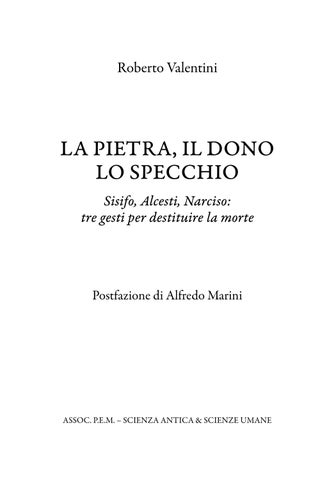LA PIETRA, IL DONO
LO SPECCHIO
Sisifo, Alcesti, Narciso: tre gesti per destituire la morte
Postfazione di Alfredo Marini
ASSOC. P.E.M. – SCIENZA ANTICA & SCIENZE
UMANE
L’ossessione di Sisifo
Figurandosi il mito di Sisifo si è indubbiamente catturati da un fosco scenario: un corpo estenuato, proteso nello sforzo di trascinare un macigno sino alla sommità d’una china, di precipitarlo nelle profondità degli inferi ripetendo tale gesto nel buio dell’eternità. Ne Il mito di Sisifo Albert Camus, immaginandone la discesa scrisse:
È durante questo ritorno, questa pausa, che Sisifo mi interessa. Un volto che patisce tanto vicino alla pietra è già pietra esso stesso! Vedo quell’uomo ridiscendere con passo pesante, ma uguale, verso il tormento, del quale non conoscerà la fine. Quest’ora, che è come un respiro, e che ricorre con la stessa sicurezza della sua sciagura, quest’ora è quella della coscienza. In ciascun istante, durante il quale egli lascia la cima e si immerge a poco a poco nelle spelonche degli dei, egli è superiore al proprio destino. È più forte del suo macigno1 .
Secondo lo scrittore franco-algerino Sisifo può dunque assurgere a emblema dell’eroe tragico, colui che di fronte al divorzio fra lo spirito e l’infondatezza del mondo, fra la nostalgia dell’assoluto e il silenzio del reale, sa accettare anche la contraddizione dell’assurdo, la sua “evidenza che l’uomo prova senza acconsentirvi”. Senza mai elidere la lotta e l’opposizione che lo costituiscono, l’uomo capace di sopportarle si porrebbe così di fronte a un’insensatezza eguale a quella della condanna di Sisifo (tali appaiono ogni nostro progetto e pensiero se rischiarati dallo sconvolgimento della morte, dal compito di trascinarne la pietra sul confine dei giorni); accettandone lo scacco senza rifiutarla alla ragione, proprio nella coscienza riuscirebbe tuttavia a trovare la leva per sollevare il peso dell’esistenza. Grazie alla sua “insoddisfazione cosciente” (da non confondersi con una forma di disperazione, nota Camus), riscoprirebbe quella consapevolezza che gli consente di contemplare la propria delusione, facendo, al pari del protagonista del mito, tacere tutti gli dei. Se “le verità schiaccianti soccombono quando vengono conosciute”2, proprio la perspicacia che avrebbe dovuto incrementare la pena di Sisifo, “afferma nello stesso istante la sua vittoria. Non esiste destino che non
1 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris 1942, in: A. Camus, Opere, c/di R. Grenier, Bompiani, 2000, p. 316-317.
2 Ibid., p. 317.
/ La pietra, il dono, lo specchio
possa essere superato dal disprezzo”3 . Poiché infine la felicità e l’assurdo risultano, secondo Camus, inseparabili e “figli della stessa terra”, si dovrà concludere, che “anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo” e che dunque “bisogna immaginare Sisifo felice”4 .
Con un ideale contrappunto al suo “Sisyphe heureux”, la materia di questo poemetto ne rovescia invece proprio il presupposto emancipatorio della coscienza, cerca di retro-illuminarne l’equivoco sforzo che la eleverebbe al di sopra del supplizio e del suo tragico destino. Non si dovrebbe cioè, al contrario, fare della condanna la stessa coscienza di Sisifo? Renderla il luogo e il tempo, l’atmosfera e il paesaggio, la sola cornice per una possibile comprensione di sé, come se il precipizio di angoscia al di sotto della salita fosse scavato giusto a ogni suo passo?
A tal fine risulterà opportuno rammentare alcuni determinanti passaggi del mito. Sisifo, considerato figlio d’Eolo e fondatore di Corinto, ha altresì nomea d’essere il più scaltro fra i mortali (secondo talune versioni Ulisse ne sarebbe appunto il figlio); prodigo di tanta astuzia da confrontarsi più di una volta con le stesse passioni divine. In un episodio, dopo avere scorto Zeus nell’atto di ghermire Egina, figlia del fiume Asopo, finché questi lasciasse sgorgare una fonte sopra la cittadella rivela al padre il nome del supremo rapitore. Anche il motivo dell’acqua donata, frutto della denuncia d’un dio, si intreccerebbe così al motivo della sua punizione, egualmente scatenata dalla collera di Zeus (l’interdizione stessa delimita la rada profondità d’ una sorgente cui attinge un pozzo simbolico). Se l’invio di Thanatos si situa nella risposta d’un dio, irritato per l’offesa subita, l’azione di Sisifo, la scaltrezza con cui incatena il genio della morte tanto saldamente da far sì che gli uomini ne vengano graziati, aggravando la delazione diventa allora portatrice d’una trasgressione irredimibile, dell’oltrepassamento d’una soglia invalicabile.
Avendo restituito al mondo l’innaturale beneficio (o il dilemma della noia) sgorgato dall’immortalità, l’intervento di Zeus non si compie cioè, solo per liberare Thanatos o concretizzare la sorte del figlio d’Eolo; pare piuttosto tracciare un confine e una deriva per la stessa astuzia dell’eroe, innescare la tagliola d’un meccanismo autoimposto, produrre l’istituzione d’una regola che venga sancita giusto dalla violazione d’un interdetto. Prima di morire Sisifo opera appunto con l’espediente dell’oltraggio: ingiunge alla moglie di non tributargli gli onori funebri, poi, una volta disceso nell’Ade, ne accusa l’empietà ottenendo
3 Ivi.
4 Ibid., p. 319.
Sisifo9 I
Quale voce così riluttante e fedele lentamente indurisce dentro il dubbio crudele del macigno che qui si protende a un mio abbraccio?
Scrigno del suolo e d’erte cui inesausto soggiaccio, esule nel pudore che una lacrima eterna scandisce riecheggiando di nuovo la caverna del cuore... Ah dalle palpebre d’un dio incombe la goccia che ogni giorno ne germina in segreto la roccia, e già quest’ecatombe del tempo si dipinge dell’umore di rene cui la mano costringe.
Così innanzi alla vista ridiventa il crinale ogni volta più ripido... Lì, avanzi casuale il mio passo. In quali occhi sta lucido l’incanto che m’odia, abbandonandomi all’altare d’un vanto?
Quali, se non i miei… È forse quel dio afflitto da sempre, ancora gravido d’un animo proscritto?
Percorrere il pendio madido d’una notte talmente inesorabile, fra le voci corrotte, tremule fatalmente su uno stagno di luna…
E che universo emulo ovunque di fortuna, dall’ozio delle stelle m’è offerto alla coscienza nel giogo frammentario della sua indifferenza!
Costanza che ormai il cielo vi riconsuma appena, osservanza vicaria che lega la catena dei pensieri, più amara, alla pietra caduta.
Potrà mai una notizia, felicità perduta, restituire qualcosa d’umano a quest’abisso?
Opponendo un residuo di scelta al gesto scisso dalla sua innammissibile ingiunzione: tornare,
9 Il poemetto, secondo il modello valeriano, adotta il metro alessandrino (due settenari accoppiati), quale modulazione melodico-espressiva funzionale all’ordine concettuale.
/ La pietra, il dono, lo specchio
sempre e ancora tornare a scendere e scalare la cima che la tenebra vela con la sua noia, assidua pantomima senza più scappatoia, né fine… Sola gioia d’un identico astante che qui mi consegnò l’obolo del suo istante. Ma se neanche la legge che decise il supplizio estingue questo stallo, lungo il suo precipizio potrà mai la fatica trovare conclusione, convertirsi in rifiuto del cuore? Ah devozione che dallo sforzo greve – io soltanto qua l’oso –, non la riappropriazione d’un compito infruttuoso, ma del riposo almeno, da questo assolvimento meriterebbe avere! Ed è invece il momento in cui portato il masso con dovere alla vetta, sopra un torrido antro il corpo lo rigetta, solo a vederlo, sùbito col suo orrido ricatto. Oh attimo di cui dubito, indiviso nell’atto della mia corsa, vibri sulla lama d’un dopo il mio perso intervallo, tregua alla brama, scopo del rito cui deciso, chinandomi, lavoro, – mai niente altro ne segua – che al suo durare imploro…
Eccolo rimbombare sulle frane dell’aria il macigno veloce assieme alla precaria vittoria di quest’anima; pervicace manfrina che sulla breccia scheggia i miei sogni e trascina il sapere che evade. Cosa potrei altrimenti meditare dai sensi, dal cerchio di frangenti nel cui epilogo abdica il silenzio alla soglia del vero, mentre qua si ràdica la voglia che in fondo al suo setaccio depone quest’attesa nel petto. Qua è lo spirito, ghiaccio che la palesa sciolto al trepido sole di quest’idee inflessibili, volti d’esili baratri, e perciò incorruttibili… Ma un dominio soltanto mio quale consistenza gli porterebbe adesso, se non quell’esistenza proveniente dal masso? Se lungamente erose con questi empi granelli, loro gemme incresciose,
concesse di sottrarsi alla morte furtiva?
Così egli ha saputo ciò che altrimenti starebbe sepolto nell’inquietudine della vecchiaia.
Non scelsi forse l’abitudine
d’accogliere le tenebre di questa verità, d’offrirgli la notizia dell’ultima ora che sopra il letto funebre
le sue palpebre avrebbero celato?
Sì, ho manifestato ciò che non è più il giusto, ma un sapere che brucia il pensiero e che nel suo cratere mi incenerisce con la malizia e il fulmine della morte.
Non soffro la perdita precoce della vita, non ho cruccio né rimorso della scelta - ma fu poi mia?, e nemmeno il dolore per i lineamenti dei figli, quelli che l’indugio della mano più non sfiorerà sul giaciglio del sonno, può spingermi al sotterfugio di qualche rammarico.
Ciò di cui la mia convinzione s’è fatta carico appartiene solo al gioco della necessità; racchiusa nella devozione non sarei resistita alla sua legge ostinata, al suo incontrastabile rogo; mai avrei potuto in città prendermi altro sposo ed abitare nuove fastose dimore.
Perché questa sopravvivenza è il mio rifugio, questa la mia fatalità e il mio compito: rivelare, morendo in vece di Admeto, dal pulpito del volto la forza che induce a estinguere ogni respiro, sempre, sino all’ultimo. Un impeto che solo quello – oh, non è poi lo stesso? –, capace di sperdere il favore d’altri sospiri, avrebbe potuto incatenare.
Perché di un’inarrestabile forza si tratta e non di un evento.
Perché se a nessun uomo è concesso di intravedere l’attimo in cui perire, così è un insindacabile corso quello che ci avvolge come la più intima pelle, carnagione del tempo su cui si misura il verso dell’anima.
e sfiora senza offuscarlo l'orizzonte del tuo scopo. Spiegami madre, te ne prego…
ALCESTI
Ah figlia, i tuoi lineamenti sono ancora gracili e così ignari del fuoco troppo ardente del pensiero, delle ceneri che esso sparge corrugando le fronti quanto la scorza d’una pergamena. Proverò a smuovere fra le sue braci un responso che ti riscaldi e sciolga il gelo dello sgomento. Non v’è genere di rapporto fra pensare e morire se non il velo che cela il secondo al primo togliendovi ogni volontà e direzione. Figlia mia, non v’è modo o ventura d’avvicinarsi alla morte, se non obliando ogni senso55, cadendo fuori dalle sue mura invalicabili in un luogo che non è né terraferma né il tragitto d’una chiglia governata dalla stella che la carezza per tenerla saldamente alle onde. Solo uno sterminato mare senz’isole né approdi è questo volere, cui altro nome si presta o si prefigge se non quello sotto cui raccogliamo i momenti più rari come le radici dal vischio della parola.
Amare è quel nome, è un rischio che impone di rinunciare a ogni meta, ad ogni possesso, e in ultimo anche a questa stessa rinuncia. So che le mie espressioni riescono fosche
55 Cfr.: “Morire senza scopo: così (con questo movimento di immobilità), il pensiero cadrebbe al di fuori di ogni teleologia e, forse, al di fuori del proprio sito. Pensare senza scopo, proprio come si muore; ecco ciò che sembra imporre la pazienza nella sua innocente perseveranza; in termini di gratuità, non di responsabilità – di qui il ristagnare dell’ignoto senza linguaggio, lì, alla nostra porta sulla soglia. […] Pensare come morire esclude il ‘come’ del pensiero, di modo che, anche se lo sopprimiamo con una semplificazione paratattica, scrivendo pensare: morire, esso costituisce un enigma persino nella sua essenza, spazio quasi invalicabile; la non relazione tra pensare e morire è anche la forma del loro rapporto, non che il pensare proceda verso il morire, procedendo verso il suo altro, ma non procede neppure verso il suo stesso. Ecco da dove il ‘come’ prende slancio: né altro né stesso” (Ibid., p. 54).
come le fronde che disperdono i sistri di strigi, so che accecano più dei coltelli del sole la credenza che si ripara sulle acque del senso…
FIGLIA
Madre, ma nella pena che avverto come potrò avvicinarmi a questo verdetto farne l’acume, il cardine della mia giovinezza renderla carne che possa la sua accortezza plasmare? La tua sofferenza mi sembra ora una requisitoria, un ordine di leggerezza così lontano da me, dal mio cuore esposto invece all’intemperia più d’una liscia pietra sul letto d’un fiume
ALCESTI
Figlia mia ascoltami ancora ma non rimproverarti per questo; avrai modo di capire e ora voglio solo che tu possa rammentare il privilegio che esercito e quel che nutro per te; dovrai penetrarne il destino, l’ostinata perseveranza di chi ama, la convinzione nel buio degli occhi, in cui tuttavia si risolve ogni distanza e nasconde ogni risposta…
Figlia, ma come potrebbe una voce intonare il sentire che ha forma nel vento, che piano smuove le fronde, l’aria increspando poi fra le mani?
Come potresti anche solo accettare d’esser così somigliante agli uccelli, mentre migrando da quello costretti sono a una nuova imminenza di luce? Per noi già si disseminano le ore abbreviate sopra il velo dei borri, già una soglia di chiaro vi abbacina
la vista e azzurre contorna le tenebre. Dal crepuscolo si spiccano gli alberi scossi come i ricordi, e sugli stagni del respiro riaddensa il suo pulviscolo l’ampia conca del cielo. Lo perscruti toccandone il fondo nei palmi uniti, quasi per berne il mistero, e poi credi che là, nell’alto sia specchio a un’immagine nostra, quando nei crocicchi degli astri il cammino trovi, l’anima e l’odore delle zolle in autunno. Eppure cosa stringe in quel punto il dolore dei labbri congiunti, arsi di silenzi, o l’affanno nei precordi turbati d’altri ascolti, dal sussurro levato nell’infedeltà del nitore? Perché non è voce, se in esso una preghiera v’è impressa, senza traccia del suono che l’ha abbandonata. Perché la voce non esala come il pensiero, torna in seno al cuore prima d’uscirne nell’eco, disfatta... Eccolo il criterio che nel suo viaggio ci fa essere simili agli esodi, alle rondini sfuggite alla caccia. Oh ma come potrebbero gli amanti sapere, essi che nutriti nelle braccia del mutamento, grappoli divenuti appena, poco prima di cadere a terra, quando sono ancora non sono... Ah, vivere senza essere del tutto! Per questo essi offrono resistenza all’istante? Per questo, ignorandolo, ce lo rivelano più certo, terminato e immutabile? Così, nel suo artificio, sotterfugi per riaverne poi corpo, presenza speranza… Oh ma ciò è troppo per loro che vorrebbero trovare rifugio