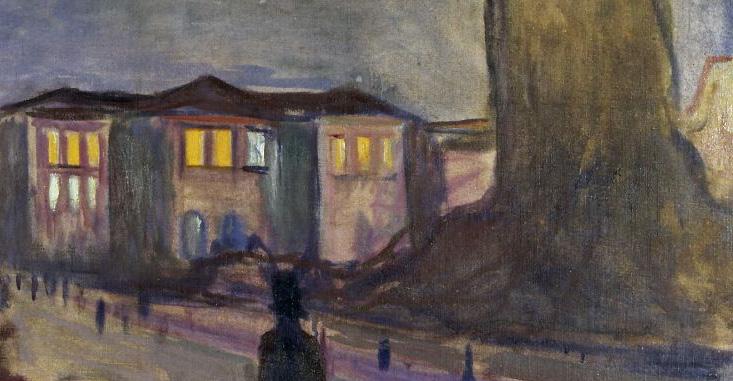8 minute read
Immobilismo sociale
Sembra quasi incredibile che chi governa il Paese non si renda conto che i motivi principali per cui l’Italia non cresce sono:
1. un livello di istruzione e formazione della nostra forza lavoro che, nonostante alcuni miglioramenti, è il più basso della UE e tra i più bassi dell’Occidente
Advertisement
2. un tasso di innovazione e riorganizzazione del sistema economico enormemente ritardato, penalizzato anche da servizi pubblici e sociali costosi, inefficienti o superati
3. un conseguente livello di produttività del sistema economico italiano che non è all’altezza delle sue potenzialità e di ciò che impone la competizione globale.
Questa non-crescita ha generato non solo una contrazione del PIL, bensì l’evaporazione delle opportunità e delle prospettive nonché un blocco all’accesso verso tutte le fasce occupazionali. Ciò significa che oggi ci sono molte meno opportunità per i giovani di diventare ricercatori, manager, professionisti, imprenditori. Manca il futuro, ecco il vero male del nostro Paese, ecco cosa deprime le nostre migliori energie.
Da alcuni anni l’Italia ha perso quello slancio che per decenni ne ha sostenuto la crescita. Si è diffusa nella Società la sensazione di un Paese che in qualche modo si è fermato, che non è più in grado di dare ai propri cittadini quelle opportunità di crescita e di realizzazione a cui aspirano. Una sensazione che demoralizza e demotiva soprattutto le generazioni più giovani, alle quali non si è ancora riusciti a dare una risposta plausibile sul loro futuro.
La vera ingiustizia sociale, per milioni di giovani, non è nell’esistenza di persone che guadagnano di più e altre che guadagnano di meno, ma l’assenza di opportunità, il fatto che i guadagni debbano essere ereditari o legati all’anzianità o protetti da corporazioni e sindacati anziché essere legati al riconoscimento del merito, alle capacità, all’impegno, alla professionalità.
“Ciò che conta non è quanto sai bensì chi conosci”. detto popolare italiano
Per affrontare questi problemi non servono né protezionismi né tutele né sussidi. Anzi, il rischio è che politiche di questo genere aumentino l’immobilismo sociale, innescando un circolo vizioso in cui la mancanza di opportunità di crescita alimenta ulteriormente la domanda di protezione economica e sociale, rallentando riconversioni industriali, inibendo concorrenza e innovazione e aumentando ulteriormente il debito dello Stato, cioè il nostro debito.
Un circolo vizioso che rischia di farci ripiombare nella situazione di insostenibilità economica degli anni scorsi e nel rischio di default sfiorato dall’Italia alla fine del 2011.
Viviamo da anni un netto peggioramento delle opportunità di riuscita sociale e occupazionale dei giovani, accompagnato da una persistente mancanza di equità dei processi di recruitment e di impiego delle persone nelle varie posizioni di lavoro.
Quali sono state le modifiche strutturali che hanno caratterizzato il nostro mercato del lavoro in questi ultimi anni?
La pressoché totale assenza di mobilità porta al risultato che quattro quinti degli occupati hanno un contratto a tempo indeterminato, mentre, per i nuovi contratti che si stipulano il rapporto si inverte: quattro quinti sono a termine. Per aumentare la mobilità dei lavoratori occorre far sì che il contratto a tempo indeterminato torni ad essere la normale forma di assunzione. E per ottenere questo è indispensabile lavorare tutti nel rendere l’assunzione a tempo indeterminato economicamente più conveniente e burocraticamente più agevole, efficace e veloce per le imprese.
Perché la nostra disoccupazione resta così alta? Fondamentalmente perché il nostro mercato del lavoro è chiuso ed ingessato: nessuno ne esce e nessuno ci entra. La rigidità dei vincoli, delle protezioni, dei meccanismi di garanzia e tutela impediscono che il mercato obbedisca liberamente alle regole della domanda e dell’ offerta.
Da una recente ricerca del Censis il 40,8% degli occupati nell’industria è risultato immobile, ossia si è collocato nella stessa classe occupazionale del padre; la quota più consistente di questo segmento è rappresentata dal 20,6% degli occupati che sono rimasti fermi nella classe operaia.
In Italia si trasmettono di generazione in generazione non solo i beni e i redditi, ma anche le professioni. Il 44% degli architetti è figlio di architetti, il 42% dei laureati in giurisprudenza è figlio di laureati in giurisprudenza, il 40% dei farmacisti è figlio di farmacisti e così via, innescando una spirale negativa che non fa che aumentare l’immobilismo sociale del nostro Paese e aumentare la sensazione di impotenza delle generazioni più giovani e, quindi, più vulnerabili.
Da noi la maggior parte delle persone trascorre l’intera esistenza nella città in cui è nata, che spesso è la città in cui sono nati i genitori. E’ evidente come gli italiani siano disposti ad accantonare opportunità di carriera e stipendi più consistenti pur di rimanere vicini a genitori ed amici. A livello di Paese questa immobilità appesantisce le difficoltà sul fronte occupazionale e limita le potenzialità economiche della collettività. D’altronde è assodato che più una persona è istruita e più ha mercato e, quindi, mobilità potenziale.
L’ISTAT ci riporta che quasi un terzo dei nati nel periodo 1970-1984 si sono trovati, al loro primo impiego, in una classe sociale più bassa di quella del loro padre e che meno

di un sesto di essi è riuscito a migliorare la propria posizione rispetto a quella di origine. Nelle fasce anagrafiche più anziane, invece, la situazione è pressoché invertita. I tassi di mobilità sociale ascendente presentano, cioè, valori doppi rispetto a quelli di mobilità discendente.
L’Italia si trova, dunque, di fronte a una radicale discontinuità storica. Le persone che oggi hanno un’età compresa tra i 25 e i 40 anni rappresentano la prima delle generazioni nate nel corso del Novecento a rivelarsi impossibilitata a migliorare la propria posizione sociale rispetto a quella dei propri genitori.
ISTAT ribadisce che le difficoltà incontrate dai giovani italiani nel raggiungere le classi medie e superiori riguarda anche i figli di queste stesse classi e non solo i discendenti delle classi inferiori. Insomma: i posti oggi disponibili nelle posizioni intermedie ed apicali della stratificazione occupazionale sono tutti occupati da adulti e anziani, cosicché molti giovani sono costretti ad accontentarsi, quando riescono a trovare un lavoro, di essere collocati in posizioni economicamente e socialmente poco appetibili.
Vi è quindi il problema del sottoutilizzo delle capacità e competenze. Sia negli uffici pubblici che nelle aziende sono ormai frequenti i casi di persone, in particolare giovani, a cui vengono richieste prestazioni ben al di sotto della loro qualificazione professionale. Infatti, rispetto ai lavori che vengono loro proposti, questi individui sono portatori di un elevato bagaglio di conoscenze, molto superiore a quello del passato: conoscenze operative, padronanza di lingue e di tecniche di comunicazione, competenze informatiche e tecnologiche in genere, esperienze formative e culturali di ampio spettro.
Tornando al Censis ci viene confermato che la pressoché unica mobilità acquisita negli ultimi anni è consistita di fatto in quella che è stata definita la “cetomedizzazione”; si tratta dunque di una mobilità sospinta in gran parte da quella trasformazione strutturale che ha visto dirottare una quota importante delle energie produttive dall’industria al terziario, con il progressivo avanzamento dell’economia post industriale.
Negli USA più di 3,5 occupati su cento ogni mese sperimentano la disoccupazione, ma dalla disoccupazione si esce con grande facilità: ogni mese, 6 occupati su cento trovano un nuovo lavoro. Questo spiega come mai la durata media del periodo di disoccupazione sia una delle più brevi in tutto l’Occidente.
Eppure in Italia ci si lamenta spesso dell’elevata spesa sociale. Dove finisce tutta questa spesa? Per l’80% in pensioni. Una percentuale enorme: in tutti gli altri Paesi della vecchia Europa le pensioni coprono circa il 50% della spesa sociale.
Una società mobile alimenta la fiducia nel domani, dà il senso della possibilità, e motiva gli individui ad investire in tutto quello che aiuta a crescere: lo studio, il lavoro, il sacrificio, la collaborazione. In poche parole: stimola ad investire nella costruzione del proprio futuro.
Se le persone non percepiscono la possibilità di avere accesso a determinate opportunità di crescita e realizzazione, il loro impegno nel perseguirle sarà inferiore a quello che impiegherebbero se le vedessero più raggiungibili.
Quando un Paese offre opportunità di affermazione legate fondamentalmente al merito e alla competenza effettivamente conseguiti si mette in moto un potente meccanismo di mobilità sociale. In questo modo infatti si creano forti incentivi a perseguire percorsi di studio, di carriera, di soddisfazione e di ambizione per il proprio lavoro.
Ricordiamo la regola saggia: se non si cresce non c’è niente da (re)distribuire. Se ci si avvia al declino non ci sarà niente da preservare e tramandare.
Cosa serve allora, prima di tutto? Serve un cambiamento culturale della concezione del posto di lavoro: da noi domina una concezione proprietaria del posto, per la quale il posto si può perdere/cambiare soltanto a seguito di colpa grave o a causa del fallimento dell’impresa. Finché questa sarà la cultura dominante, sarà ben difficile conquistarsi nel nostro Paese un lavoro non precario.
Serve soprattutto una diffusa moralità, un senso di responsabilità e l’attualizzazione di alcuni valori fondanti che molti anni fa ci hanno permesso di diventare un Paese moderno: la giustizia sociale va garantita creando il più possibile pari opportunità per tutti.
Premiare il merito, punire le rendite di posizione, scardinare i privilegi, rendere il mercato più equo e libero, aprire alla concorrenza, colpire l’evasione fiscale.
Occorre introdurre maggiore semplicità, chiarezza e immediatezza nel modo in cui si aiutano le persone. Le parole d’ordine dovrebbero essere semplicità e fiducia nel cittadino, per garantire la massima diffusione e l’effettivo utilizzo delle misure introdotte, e non solo il loro “effetto annuncio”. Troppo spesso infatti si elaborano aiuti e incentivi proposti come innovazioni epocali, ma che poi sembrano strutturati apposta per scoraggiarne l’utilizzo, quasi a volerne massimizzare l’impatto mediatico minimizzando i costi. L’Italia non può più permettersi politiche mirate solo alla propaganda elettorale; occorre iniziare a fare politiche finalizzate ad aiutare davvero la gente e a risolvere nel concreto i problemi del Paese.

Fabrizio Favini