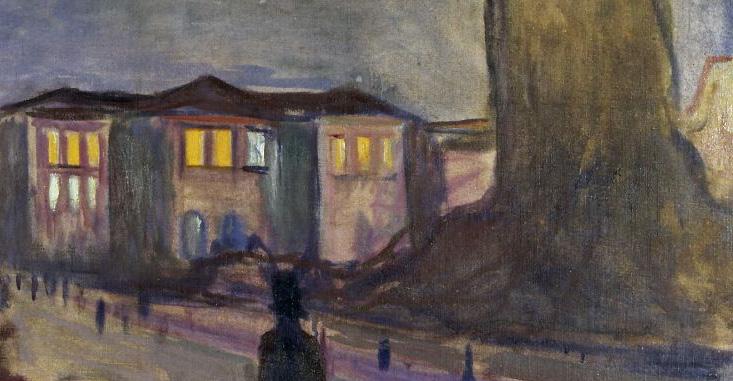5 minute read
Lo sviluppo sostenibile come risposta alla crisi e preparazione
Come ricorda l’inventore del termine “cigno nero”, Nassim Nicholas Taleb, l’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo non ha la caratteristica tipica proprio di un cigno nero: l’imprevedibilità. Questo perché la comunità scientifica ci aveva avvertito nel corso degli ultimi anni sullo spillover, il fenomeno che indentifica il salto di specie animale-uomo compiuto da un virus, il quale diventa sempre più frequente anche per via della distruzione degli ecosistemi. Ma è chiaro che non abbiamo dato ascolto alla scienza ed è un errore che rischiamo di commettere ancora, passato il picco della pandemia da Covid-17.
Per salvare quante più vite possibili, mettendo in sicurezza la tenuta del sistema sanitario, i governi di (quasi) tutto il mondo hanno dovuto imporre la misura del lockdown a oltre tre miliardi di persone. Un fatto eccezionale, che da una parte dimostra la nostra impreparazione nel fronteggiare shock di queste proporzioni, e dall’altra fa emergere la necessità di intraprendere un nuovo percorso di sviluppo. Una crisi che produce effetti così devastanti deve infatti portare a un ripensamento del nostro modello di sviluppo e a un necessario cambio di paradigma, in grado di farci fare un “balzo in avanti” nella ripresa post Covid-19.
Advertisement
Non avrebbe senso, infatti, correre il rischio di ripartire semplicemente per tornare al punto di partenza che, ricordo, significherebbe ritornare in un’Italia dove persistevano forti diseguaglianze, anche territoriali, dove l’evasione fiscale era pari a circa 110 miliardi di euro ogni anno e l’inquinamento determinava 80.000 morti precoci all’anno, tanto per fare tre esempi.
Il rischio di commettere gli stessi errori del 2008 va dunque scongiurato, ma vanno messi in campo nuovi strumenti per accrescere il benessere collettivo e misure in grado di prepararci a shock futuri. Perché la pandemia in atto non sarà l’ultimo degli eventi estremi che il mondo e il nostro Paese saranno costretti ad affrontare: basti pensare agli enormi rischi derivanti dal cambiamento climatico che, sempre gli scienziati, ci ricordano essere un fenomeno assai più devastante del Covid-19.
In questa prospettiva l’Agenda 2030, e i suoi 17 Obiettivi (SDGs, acronimo inglese di Sustainable Develompment Goals) deve essere il punto di riferimento per l’Italia, l’Europa e il mondo intero. Ma gli ultimi lavori dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), alla cui preparazione hanno preso parte oltre 600 esperti di tutti i settori, dimostrano che siamo ancora in ritardo sull’attuazione dell’Agenda 2030 firmata nel 2015 da tutti i Paesi del mondo compreso il nostro, e che la crisi rischia di allontanarci da quegli Obiettivi.
Secondo il Rapporto ASviS, infatti, tra il 2017 e il 2018 la situazione era migliorata in modo significativo su povertà, alimentazione e agricoltura sostenibile, sistema energetico, innovazione, modelli di produzione e consumo, qualità della governance. Piccoli passi in avanti si registravano poi su salute, disuguaglianze, condizioni delle città (ma va ricordato che in Italia si respira ancora la peggior aria d’Europa, responsabile di oltre 80mila morti premature ogni anno), lotta al cambiamento climatico e tutela dell’ecosistema marino. I dati segnalavano invece una flessione per il settore dell’istruzione e per il comparto economico e occupazionale del Paese, mentre significativi peggioramenti si osservavano per l’uguaglianza di genere (dove è anche forte la disparità di trattamento salariale tra uomo e donna), per acqua e strutture igienico sanitarie, per la condizione degli ecosistemi terrestri (non si placa il fenomeno del consumo di suolo) e per la cooperazione internazionale.
La sostenibilità non è una questione prettamente ambientale, come in molti ancora erroneamente credono, ma riguarda ogni aspetto della nostra vita e della nostra società.
E la pandemia sta chiarendo una volta per tutte questo concetto. La crisi è infatti un male per lo sviluppo sostenibile, come dimostra un altro lavoro dell’ASviS. Lo studio “Politiche per fronteggiare la crisi da COVID-19 e realizzare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” descrive gli effetti della crisi sui diversi Obiettivi e come essa impatti negativamente sul capitale economico, per esempio attraverso la drastica riduzione della capacità produttiva, sul capitale umano, disoccupazione e sottoccupazione riducono infatti le conoscenze degli individui, e sul capitale sociale, basti pensare a tutto ciò che comporta la riduzione delle interazioni.
Anche gli effetti sul capitale naturale non devono essere sottovalutati, sebbene la fase di blocco delle attività socio-economiche abbia portato a qualche dato positivo, come la riduzione delle emissioni di CO2, ma non va dimenticato che la ripartenza potrebbe riportare tutto ai livelli pre-crisi con il rischio che vengano abbandonati i programmi di transizione ecologica e di decarbonizzazione.
Altro problema è dato dalla gestione corretta dello smaltimento di mascherine e guanti che potrebbero finire nell’ambiente. Si stima che circa un miliardo e mezzo di questi dispositivi per la protezione individuale verranno utilizzati ogni mese nel nostro Paese, una quantità notevole, che dà il senso della sfida.
La nota positiva è che gli italiani sono ormai consapevoli delle fragilità dell’attuale sistema economico e sociale, e di come le pressioni dell’uomo sull’ambiente siano in grado di incidere sul benessere collettivo. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos il 72% degli intervistati ritiene che la crisi climatica sia una minaccia pari a quella del Covid-19 e che la ripresa economica debba essere focalizzata sulle azioni di contrasto al riscaldamento globale (per il 63% degli intervistati). Dello stesso avviso è la Commissione europea che, anche con il Recovery Fund ribattezzato “Next Generation Eu”, ha stabilito che il Green new deal sia la chiave per la ripartenza.
L’Italia non deve farsi trovare impreparata, deve capire già da ora come investire le risorse europee ma anche quelle nazionali per trasformare la crisi in un’opportunità che difficilmente potrà ricapitarci. Serve dunque una visione di futuro a medio e lungo termine, per avviare il Paese sulla strada dello sviluppo sostenibile. La classica articolazione delle politiche economiche, sociali e ambientali va sostituita da una nuova strategia orientata alla “resilienza trasformativa”, basata su misure in grado di proteggere, promuovere, preparare, prevenire e trasformare. Ma per farlo bisogna alimentare il dibattito sui possibili futuri. Perché se è vero che il futuro è sempre uno solo, è anche vero che risente delle scelte del presente.
Per questo motivo come ASviS abbiamo lanciato il 21 maggio il sito FUTURAnetwork. eu, un luogo dove vengono raccolti studi, articoli, interviste e materiali focalizzati sulla necessità, a partire dalla cronaca, di esplorare i possibili scenari e di decidere oggi quale futuro vogliamo scegliere tra i tanti possibili.
Perché per “rimbalzare in avanti”, per non lasciare nessuno indietro e per “fare pace” con il pianeta serve l’impegno di tutti.