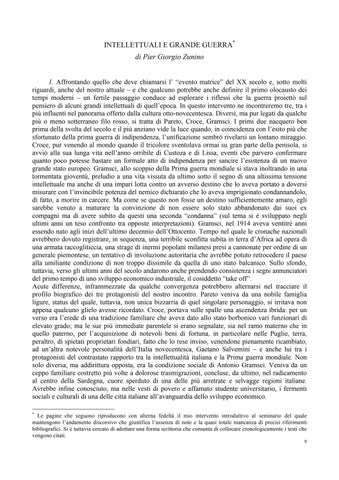INTELLETTUALI E GRANDE GUERRA* di Pier Giorgio Zunino
1. Affrontando quello che deve chiamarsi l’ “evento matrice” del XX secolo e, sotto molti riguardi, anche del nostro attuale – e che qualcuno potrebbe anche definire il primo olocausto dei tempi moderni – un fertile passaggio conduce ad esplorare i riflessi che la guerra proiettò sul pensiero di alcuni grandi intellettuali di quell’epoca. In questo intervento ne incontreremo tre, tra i più influenti nel panorama offerto dalla cultura otto-novecentesca. Diversi, ma pur legati da qualche più o meno sotterraneo filo rosso, si tratta di Pareto, Croce, Gramsci. I primi due nacquero ben prima della svolta del secolo e il più anziano vide la luce quando, in coincidenza con l’esito più che sfortunato della prima guerra di indipendenza, l’unificazione sembrò rivelarsi un lontano miraggio. Croce, pur venendo al mondo quando il tricolore sventolava ormai su gran parte della penisola, si avviò alla sua lunga vita nell’anno orribile di Custoza e di Lissa, eventi che parvero confermare quanto poco potesse bastare un formale atto di indipendenza per sancire l’esistenza di un nuovo grande stato europeo. Gramsci, allo scoppio della Prima guerra mondiale si stava inoltrando in una tormentata gioventù, preludio a una vita vissuta da ultimo sotto il segno di una altissima tensione intellettuale ma anche di una impari lotta contro un avverso destino che lo aveva portato a doversi misurare con l’invincibile potenza del nemico dichiarato che lo aveva imprigionato condannandolo, di fatto, a morire in carcere. Ma come se questo non fosse un destino sufficientemente amaro, egli sarebbe venuto a maturare la convinzione di non essere solo stato abbandonato dai suoi ex compagni ma di avere subìto da questi una seconda “condanna” (sul tema si è sviluppato negli ultimi anni un teso confronto tra opposte interpretazioni). Gramsci, nel 1914 aveva ventitré anni essendo nato agli inizi dell’ultimo decennio dell’Ottocento. Tempo nel quale le cronache nazionali avrebbero dovuto registrare, in sequenza, una terribile sconfitta subita in terra d’Africa ad opera di una armata raccogliticcia, una strage di inermi popolani milanesi presi a cannonate per ordine di un generale piemontese, un tentativo di involuzione autoritaria che avrebbe potuto retrocedere il paese alla umiliante condizione di non troppo dissimile da quella di uno stato balcanico. Sullo sfondo, tuttavia, verso gli ultimi anni del secolo andarono anche prendendo consistenza i segni annunciatori del primo tempo di uno sviluppo economico industriale, il cosiddetto “take off”. Acute differenze, inframmezzate da qualche convergenza potrebbero alternarsi nel tracciare il profilo biografico dei tre protagonisti del nostro incontro. Pareto veniva da una nobile famiglia ligure, status del quale, tuttavia, non unica bizzarria di quel singolare personaggio, si irritava non appena qualcuno glielo avesse ricordato. Croce, portava sulle spalle una ascendenza ibrida: per un verso era l’erede di una tradizione familiare che aveva dato allo stato borbonico vari funzionari di elevato grado; ma le sue più immediate parentele si erano segnalate, sia nel ramo materno che in quello paterno, per l’acquisizione di notevoli beni di fortuna, in particolare nelle Puglie, terra, peraltro, di spietati proprietari fondiari, fatto che lo rese inviso, venendone pienamente ricambiato, ad un’altra notevole personalità dell’Italia novecentesca, Gaetano Salvemini – e anche lui tra i protagonisti del contrastato rapporto tra la intellettualità italiana e la Prima guerra mondiale. Non solo diversa, ma addirittura opposta, era la condizione sociale di Antonio Gramsci. Veniva da un ceppo familiare costretto più volte a dolorose trasmigrazioni, concluse, da ultimo, nel radicamento al centro della Sardegna, cuore sperduto di una delle più arretrate e selvagge regioni italiane. Avrebbe infine conosciuto, ma nelle vesti di povero e affamato studente universitario, i fermenti sociali e culturali di una delle città italiane all’avanguardia dello sviluppo economico. *
Le pagine che seguono riproducono con alterna fedeltà il mio intervento introduttivo al seminario del quale mantengono l’andamento discorsivo che giustifica l’assenza di note e la quasi totale mancanza di precisi riferimenti bibliografici. Si è tuttavia cercato di adottare una forma scrittoria che consenta di collocare cronologicamente i testi che vengono citati. 9