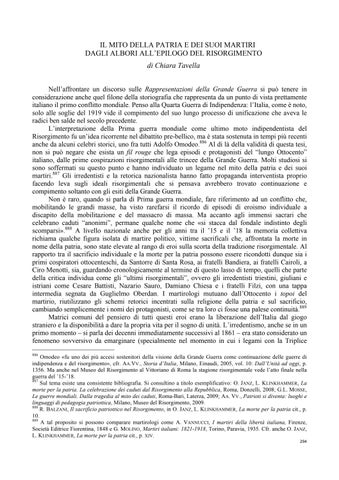IL MITO DELLA PATRIA E DEI SUOI MARTIRI DAGLI ALBORI ALL’EPILOGO DEL RISORGIMENTO di Chiara Tavella Nell’affrontare un discorso sulle Rappresentazioni della Grande Guerra si può tenere in considerazione anche quel filone della storiografia che rappresenta da un punto di vista prettamente italiano il primo conflitto mondiale. Penso alla Quarta Guerra di Indipendenza: l’Italia, come è noto, solo alle soglie del 1919 vide il compimento del suo lungo processo di unificazione che aveva le radici ben salde nel secolo precedente. L’interpretazione della Prima guerra mondiale come ultimo moto indipendentista del Risorgimento fu un’idea ricorrente nel dibattito pre-bellico, ma è stata sostenuta in tempi più recenti anche da alcuni celebri storici, uno fra tutti Adolfo Omodeo.886 Al di là della validità di questa tesi, non si può negare che esista un fil rouge che lega episodi e protagonisti del “lungo Ottocento” italiano, dalle prime cospirazioni risorgimentali alle trincee della Grande Guerra. Molti studiosi si sono soffermati su questo punto e hanno individuato un legame nel mito della patria e dei suoi martiri.887 Gli irredentisti e la retorica nazionalista hanno fatto propaganda interventista proprio facendo leva sugli ideali risorgimentali che si pensava avrebbero trovato continuazione e compimento soltanto con gli esiti della Grande Guerra. Non è raro, quando si parla di Prima guerra mondiale, fare riferimento ad un conflitto che, mobilitando le grandi masse, ha visto rarefarsi il ricordo di episodi di eroismo individuale a discapito della mobilitazione e del massacro di massa. Ma accanto agli immensi sacrari che celebrano caduti “anonimi”, permane qualche nome che «si stacca dal fondale indistinto degli scomparsi».888 A livello nazionale anche per gli anni tra il ’15 e il ’18 la memoria collettiva richiama qualche figura isolata di martire politico, vittime sacrificali che, affrontata la morte in nome della patria, sono state elevate al rango di eroi sulla scorta della tradizione risorgimentale. Al rapporto tra il sacrificio individuale e la morte per la patria possono essere ricondotti dunque sia i primi cospiratori ottocenteschi, da Santorre di Santa Rosa, ai fratelli Bandiera, ai fratelli Cairoli, a Ciro Menotti, sia, guardando cronologicamente al termine di questo lasso di tempo, quelli che parte della critica individua come gli “ultimi risorgimentali”, ovvero gli irredentisti triestini, giuliani e istriani come Cesare Battisti, Nazario Sauro, Damiano Chiesa e i fratelli Filzi, con una tappa intermedia segnata da Guglielmo Oberdan. I martirologi mutuano dall’Ottocento i topoi del martirio, riutilizzano gli schemi retorici incentrati sulla religione della patria e sul sacrificio, cambiando semplicemente i nomi dei protagonisti, come se tra loro ci fosse una palese continuità.889 Matrici comuni del pensiero di tutti questi eroi erano la liberazione dell’Italia dal giogo straniero e la disponibilità a dare la propria vita per il sogno di unità. L’irredentismo, anche se in un primo momento – si parla dei decenni immediatamente successivi al 1861 – era stato considerato un fenomeno sovversivo da emarginare (specialmente nel momento in cui i legami con la Triplice 886
Omodeo «fu uno dei più accesi sostenitori della visione della Grande Guerra come continuazione delle guerre di indipendenza e del risorgimento», cfr. AA.VV., Storia d’Italia, Milano, Einaudi, 2005, vol. 10: Dall’Unità ad oggi, p. 1356. Ma anche nel Museo del Risorgimento al Vittoriano di Roma la stagione risorgimentale vede l’atto finale nella guerra del ’15-’18. 887 Sul tema esiste una consistente bibliografia. Si consultino a titolo esemplificativo: O. JANZ, L. KLINKHAMMER, La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, Roma, Donzelli, 2008; G.L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma-Bari, Laterza, 2009; AA. VV., Patrioti si diventa: luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica, Milano, Museo del Risorgimento, 2009. 888 R. BALZANI, Il sacrificio patriottico nel Risorgimento, in O. JANZ, L. KLINKHAMMER, La morte per la patria cit., p. 10. 889 A tal proposito si possono comparare martirologi come A. VANNUCCI, I martiri della libertà italiana, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1848 e G. MOLINO, Martiri italiani: 1821-1918, Torino, Paravia, 1935. Cfr. anche O. JANZ, L. KLINKHAMMER, La morte per la patria cit., p. XIV. 294