IL MONDO SOSTENIBILE DI



Continua il nostro viaggio tra le fotografie d’autore che ci accompagnano in ogni numero della rivista.
Le immagini questa volta sono di Stefano Torrione, fotografo di Aosta, professionista dal 1992. Vive tra Milano e Saint Pierre in Valle d’Aosta. Ha collaborato alla prestigiosa rivista Epoca che lo ha portato al Panorama European Kodak Award nel 1994 ad Arles, in Francia.
un doppio punto di vista, con due tempi sensibili: quello del fotografo che registra la commedia tragica dei protagonisti (gli “stati d’animo” da consegnare alla nostra storia), e quello di noi osservatori che cerchiamo ingenuamente di comprendere il senso di quella strenua lotta per resistere, interpretando metaforicamente il significato della relazione con la Natura.

Si è specializzato in reportage geografico ed etnografico lavorando in molti paesi del mondo per Geo e National Geographic Italia, Panorama Travel, Gente Viaggi, Traveller, In Viaggio, Rutas del Mundo, Tuttoturismo


Da appassionato di montagna e di boschi, dal 2009 al 2019 ha lavorato a progetti fotografici sulle Alpi valorizzando la cultura popolare (AlpiMagia e Spiriti d’inverno) e tornando sulle tracce della prima guerra mondiale in alta quota (Grande guerra bianca). Il racconto fotografico di Stefano Torrione propone
3 Accanto alle imprese per il futuro del legno di NICOLA SEMERARO
4 L’Europa sostenibile
6 Norme Esg, l’impresa diventa più sociale intervista a MARA CHILOSI
8 Dall’Europa nuove opportunità da cogliere intervista a ANTONIO MASSARUTTO
10 Troppa Italia a Bruxelles intervista a LARA PONTI
12 Addio greenwashing intervista a ROBERTA IOVINO
13 Pmi: perché abbracciare la transizione
Rilegno
Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi di legno
Cesenatico (FC) Via
Milano Via Pompeo Litta 5
Presidente Nicola Semeraro
Direttore Marco Gasperoni
Consiglio di amministrazione
Daniela Frattoloni Vicepresidente
Emanuele Barigazzi
Milena De Rossi
Cosimo Messina
Giovanni Napodano
Stefan Thomas Rubner
Paolo Somenzi
Le fotografie di Torrione rappresentano un momento metafisico in cui gli alberi si presentano come vere e proprie entità intellettuali, esistenze parlanti che sollevano – solidali tra loro – i pensieri e le contraddizioni del nostro tempo. Presenze che sfidano la nostra: restano miti anche quando sono forti e travolgenti, e rilasciano dichiarazioni stupefacenti semplicemente mostrandosi.
Meriterebbero la nostra gratitudine e una specie di intelligente, smisurata, eterna (e anche conveniente) ammirazione.
14 L’emergenza clima ci sfugge dalle mani intervista a GIOVANNI STORTI
16 Il mondo non è mai stato così caldo intervista a CARLO BUONTEMPO
18 I giovani sanno ciò che i sapiens negano intervista a MARIO TOZZI
20 Il riflusso della sostenibilità intervista a MARIO CALDERINI
22 L’artificiale in dialogo con la natura intervista a CARLO RATTI
24 Intelligenza eco-artificiale di EMANUELE FRONTONI
26 L’algoritmo della vita intervista a MONSIGNOR VINCENZO PAGLIA
Ivana Tagliaboschi
Roberto Valdinoci
Andrea Vezzani
Sindaci
Marcello Del Prete
Presidente del Collegio
Cecilia Andreoli
Michele Mantovani
Gianluigi Lapietra (Sindaco supplente)
Amministrazione Anna Antaridi
Area tecnica Antonella Baldacci
Comunicazione e sostenibilità Elena Lippi
Contatti info@rilegno.org www.rilegno.org
Anno sesto - 2024 Registrazione al Tribunale di Milano n. 203 del 23/12/2022
Direttore responsabile
Michele Riva
Hanno collaborato
Valentina Barbieri Riccardo Venturi
Progetto grafico e realizzazione
Margherita La Noce
Art Consultant Franco Achilli
28 Basta con la retorica dell’apocalisse di ANTONIO PASCALE
30 L’Italia del riuso intervista a FILIPPO BRANDOLINI
31 Bere senza sprechi intervista a SILVIA RICCI
32 Riciclo degli imballaggi: numeri da record per l’Italia intervista a IGNAZIO CAPUANO
33 Il legno alleato dell’ambiente intervista a ANGELO LUIGI MARCHETTI
34 Per la tutela di boschi e foreste intervista a MASSIMILIANO BEDOGNA
35 Il sistema Rilegno
Periodicità annuale
Copyright © 2024 Rilegno
Foto pagina 14: Matteo Inzani
Foto pagina 22: Andrea Avezzù
Foto pagina 26: Siciliani/Pontificia Accademia per la Vita
Foto pagina 32: Riccardo Torri
Abbiamo fatto gli sforzi necessari per contattare tutti i detentori dei copyright delle immagini pubblicate. In caso di involontarie omissioni siamo a disposizione
Stampa Pazzini Stampatore Editore srl
Via Statale Marecchia, 67 47826 Villa Verucchio (RN)

L’edizione 2024 di Walden, la rivista annuale di Rilegno dedicata alla cultura e alla pratica della sostenibilità e dell’economia circolare, si apre con un focus sulle nuove normative europee, in materia di sostenibilità che investono un numero sempre maggiore di imprese. Un carico di lavoro aggiuntivo importante, specie per le piccole imprese che hanno meno risorse e strutture a disposizione, e al contempo un’opportunità da cogliere per migliorare il proprio posizionamento sul mercato, oltre che per non rischiare di esserne esclusi. Vale anche per le aziende nostre consorziate, che includono grandi realtà ma anche tante Pmi. Per questo Rilegno ha deciso di essere al loro fianco, lanciando il progetto “Il ruolo della sostenibilità per lo sviluppo dell’impresa” che sarà articolato su diversi incontri, con l’obiettivo di costruire una consapevolezza e una cultura della sostenibilità per le imprese. In questa nuova veste, che mi sta molto a cuore, intendiamo stare come sempre accanto alle aziende del legno, mettendo a disposizione la nostra conoscenza e i nostri esperti per accompagnarle sulla necessaria strada della sostenibilità nei suoi diversi processi.
Rilegno da sempre si occupa della raccolta, del riutilizzo e del riciclo del legno in tutta Italia, mentre l’attuale normativa regola il fine vita solo dell’imballaggio. Oggi l’impegno del Consorzio insieme al Ministero dell’Ambiente è quello di creare un modello normato per tutto il materiale legno diverso dagli imballaggi. Esiste quindi l’opportunità per le aziende di partecipare in forma volontaria a un test della durata di un anno.
Si tratta di indirizzare le aziende del mondo del legno al trattamento del fine vita dei loro prodotti. Rilegno da ventisei anni si occupa di raccolta, riutilizzo e riciclo ed è oggi in grado di dare equilibrio a tutto il sistema circolare del legno in Italia.
E tornando alla rivista Walden in tema di novità, su questo numero abbiamo chiesto a chi è stato intervistato – o ha dato direttamente il suo contributo – un suggerimento ai lettori su un libro, un film o un podcast che valga la pena vedere, leggere o ascoltare per saperne di più in tema di sostenibilità, climate change, boschi, greenwashing e così via. Ne è scaturita un’interessante e variegata galleria, che va da Se niente importa. Perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer, consigliato dal comico
Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, molto attivo nella divulgazione dei temi della sostenibilità, a Shitthropocene, consigliato dal professor Antonio Massarutto.
Sono come sempre numerosi i contributi che vale la pena leggere con attenzione. Da Monsignor Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, che racconta come l’allora presidente di Microsoft Brad Smith sia andato al Vaticano a chiedere di essere “accompagnato, avvertito, messo sull’avviso” sulle enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale, a Carlo Buontempo, fisico esperto di clima, direttore del servizio cambiamento climatico dei satelliti europei Copernicus (C3S), che sottolinea come solo tra il 2022 e il 2023 si sia perso il 10% della massa glaciale delle Alpi. Dal vicepresidente di Confindustria per la transizione ambientale e gli obiettivi Esg Lara Ponti, che teme che la sovrabbondanza di normative europee sulla sostenibilità faccia perdere di vista alle imprese il senso, le ragioni per cui sono nate, e chiede che la portata della loro applicazione sia rapportata alla dimensione delle imprese, allo stesso professor Mario Calderini che ci informa del pericolo che l’impegno delle aziende verso la sostenibilità subisca una pesante battuta d’arresto. E il professor Antonio Massarutto mette in evidenza come da sempre le aziende che sanno trasformare le nuove norme in opportunità, anziché cercare di sfuggire, ne traggono beneficio. Il geologo, saggista e divulgatore scientifico Mario Tozzi chiede di non dare più un euro di sussidio pubblico ai petro-carbonieri, invece di dargliene sette trilioni di dollari l’anno, mentre il giornalista e scrittore Antonio Pascale bolla come controproducente la retorica dell’apocalisse sul climate change, invocando una comunicazione più sobria e obiettivi raggiungibili. E ancora Giovanni Storti, Roberta Iovino, Mara Chilosi, Carlo Ratti, Ignazio Capuano, Silvia Ricci, Emanuele Frontoni, Angelo Marchetti, Massimiliano Bedogna. Per chiudere in bellezza con We are Walden, la community di Rilegno nata nel 2021, luogo di incontro digitale e fisico dedicato ai giovani che condividono i valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.
Con le nuove direttive Esg arrivano obblighi e opportunità per grandi imprese e Pmi: ecco la sintesi del quadro normativo e i commenti degli esperti nelle pagine seguenti
Non solo incombenze burocratiche ma anche opportunità di crescita, a patto di avere un’adeguata assistenza per l’implementazione: è l’impatto delle nuove normative europee in materia di sostenibilità. Leggi che si applicano non solo alle imprese di grandi dimensioni, ma anche, in modo diretto o indiretto, alle medie e piccole – cioè all’ossatura del nostro sistema economico, filiera del legno inclusa.
L’ultima arrivata è la Corporate sustainability due diligence directive (CS3D), ovvero la normativa sulla sostenibilità delle filiere detta anche Supply chain
Le nuove direttive europee per la sostenibilità
act, pubblicata in Gazzetta ufficiale europea il 5 luglio scorso e quindi legge dal 25 dello stesso mese. Gli Stati membri avranno due anni di tempo per implementare i regolamenti e le procedure amministrative conformemente al testo giuridico Ue, ma per le imprese non c’è tempo da perdere.
La CS3D, da un lato, affida alle grandi imprese gravosi compiti di controllo della propria filiera, necessari per limitare il rischio di incorrere in pesanti sanzioni e, dall’altro lato, apre opportunità importanti per le nostre Pmi in grado di rispondere alle richieste di informativa e di fornire adeguate certificazioni.
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), 2024/1760/UE
L’obbligo di controllo della propria filiera coinvolge:
le aziende “di grandi dimensioni”, cioè con oltre mille dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro; le società madre di un gruppo che ha raggiunto la soglia finanziaria indicata per le aziende di “grandi dimensioni” su base consolidata nell’ultimo anno finanziario; le aziende che hanno stipulato o sono società madre di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’UE con royalties che ammontano a più di 22,5 milioni di euro e con un fatturato netto superiore a 80 milioni di euro.
La normativa sarà applicata con un approccio graduale in base alla dimensione e al fatturato:
dal 2027 per le aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato;
dal 2028 per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato;
dal 2029 per tutte le altre aziende che rientrano nell’ambito della direttiva, ovvero più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), 2022/2464/UE
La normativa coinvolgerà gradualmente:
Dal 2025 (anno fiscale 2024) le imprese quotate con un numero medio di dipendenti occupati pari a 500; con totale dello stato patrimoniale di 25 milioni di euro e ricavi netti di 50 milioni di euro.
Dal 2026 (anno fiscale 2025) le grandi imprese con un numero medio di dipendenti occupati pari a 250; con totale dello stato patrimoniale di 25 milioni di euro e ricavi netti di 50 milioni di euro.
Dal 2027 (anno fiscale 2026) le Pmi quotate con un numero medio di dipendenti occupati non inferiore a 11 e non superiore a 250; con totale dello stato patrimoniale superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro e ricavi netti superiori a 900 mila euro e inferiori a 50 milioni euro.
Dal 2029 (anno fiscale 2028) le società figlie e succursali di società madri extra-europee con ricavi netti superiori a 150 milioni di euro, un’impresa figlia con i requisiti dimensionali della CSRD e una succursale con ricavi netti superiori a 40 milioni di euro.
Pmi che hanno dunque la chance di prendere il posto di fornitori esteri non compliant o di microimprese italiane che, pur di abbattere i costi, hanno ignorato regole ora più che mai cogenti in materia ambientale e o sociale, e hanno quindi un profilo di rischio più alto. L’obbligo di controllo della propria filiera sarà esteso progressivamente da qui al 2029 alle grandi imprese con oltre mille dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro.
La CS3D è solo l’ultima di una serie di normative con le quali l’Europa persegue il piano Net Zero che prevede la riduzione dei gas serra del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi così ambiziosi l’Unione sta convogliando massicce risorse verso gli investimenti sostenibili, a partire dai fondi del Next Generation EU, nel quale rientra il Pnrr. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha già annunciato un nuovo fondo sovrano europeo. Per supportare gli investimenti della transizione sono necessari investimenti per centinaia di miliardi di euro: rendere sostenibili l’industria, i trasporti, le costruzioni, richiede uno sforzo titanico.
Altra nuova direttiva europea di fondamentale importanza è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sulla rendicontazione di sostenibilità entrata in vigore in Italia il 25 settembre 2024 con il D. Lgs. 2024/125. La norma introduce importanti novità in merito alle informazioni da inserire nel Bilancio di esercizio riguardanti gli impatti, i rischi e le opportunità legate ai temi Esg. Le imprese soggette alla normativa dovranno fornire un’apposita attestazione di conformità del bilancio di sostenibilità rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Sono circa quattromila, secondo la Consob, le imprese in Italia ad essere soggette alla nuova regolamentazione, la cui applicazione sarà estesa progressivamente da qui al 2026. Come la CS3D, anche la CSRD impone un approccio di filiera: l’impresa deve dar conto di quello che succede in tutta la catena di fornitura, a monte e a valle. Ancora una volta vanno evidenziati, accanto alle opportunità, i rischi per le nostre Pmi: fornire dati certificati sulla sostenibilità diventerà sempre più necessario per non essere estromessi dalla supply chain.
I nuovi standard di rendicontazione (ESRS)
L’ESRS adotta una prospettiva di “doppia materialità”: le imprese sono obbligate non solo a riportare i loro impatti sulle persone e sull’ambiente, ma devono riferire nello stesso tempo come le questioni sociali e ambientali creano rischi o opportunità finanziarie per l’azienda stessa. Sono previsti due standard generali (ESRS1/ ESRS2) e dieci temi Esg, divisi in tre categorie (Ambientale, Sociale e Governance).
ESRS1 Requisiti generali
ESRS2 Requisiti generali di rendicontazione
ESRS E1 Clima
ESRS E2 Inquinamento
ESRS E3 Acqua e risorse marine
ESRS E4 Biodiversità e ecosistemi
ESRS E5 Utilizzo delle risorse ed economia circolare
ESRS S1 Propria forza lavoro
ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3 Comunità coinvolte
ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali
ESRS G1 Condotta aziendale
Le aziende soggette alla CSRD dovranno adottare l’European Sustainability Reporting Standard (ESRS), introdotto dall’Efrag – ente di natura tecnica che svolge funzione di advisory per la Commissione europea in materia di reporting – per imporre criteri di rendicontazione comuni alle aziende, riducendo così i costi nel medio e lungo termine ed evitando il ricorso a standard volontari di altro tipo che rischiano di rendere difficile la comparazione delle informazioni. Secondo una dichiarazione congiunta di Efrag e Global Reporting Initiative (Gri), d’ora in poi gli standard saranno interoperabili: i soggetti che rendicontano ai sensi dell’ESRS potranno già disporre di una buona parte delle analisi implementate per l’applicazione dei Gri. Questo è anche un modo per premiare le aziende virtuose: quelle che hanno utilizzato gli standard Gri sono di fatto quasi pronte all’introduzione della rendicontazione secondo l’ESRS.
1.
Integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione
2.
Identificazione e valutazione degli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani e sull’ambiente
3.
Prevenzione e mitigazione dei potenziali impatti negativi ed eliminazione (o riduzione al minimo dell’entità) degli impatti negativi effettivi
4.
Istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo
5.
Monitoraggio dell’efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi
6.
Comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale

Le nuove direttive europee creano valore e rilanciano la competitività lungo la filiera intervista a MARA CHILOSI
Ci può illustrare brevemente le novità normative in tema di Esg?
Nel corso del 2024 l’Unione Europea ha emanato diversi atti normativi riguardanti l’impatto delle attività produttive sull’ambiente e sui diritti sociali, al fine di attuare i principi e i criteri direttivi codificati nel Green Deal Europeo e di supportare così la “transizione verde” del sistema economico europeo. Fra questi, si annoverano due interventi particolarmente rilevanti: la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), recentemente attuata in Italia con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125; la Direttiva (UE) 2024/1760, nota come Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).
Per comprenderne l’impatto, le direttive vanno calate in un contesto più generale, nel quale l’Unione europea sta intervenendo con un pacchetto di misure a tutto campo, riformando la regolamentazione inerente a svariate filiere produttive particolarmente rilevanti in termini di impatto (tra cui il settore degli imballaggi, delle batterie, dell’automotive, della moda, per ricordarne alcuni), introducendo nuovi strumenti di tracciabilità e informazione riguardanti i prodotti, e ancora più a monte incentivando l’ecodesign e fissando requisiti di prodotto sempre più stringenti in termini ambientali e di sicurezza per la salute umana. Ulteriori direttrici riguardano la comunicazione al pubblico (pensiamo alla Direttiva sul greenwashing,
la 2024/825) e l’inasprimento delle sanzioni relative agli illeciti ambientali (oggetto di un’ulteriore direttiva adottata nel 2024, la 2024/1203). Una sfida davvero complessa per le imprese, soprattutto per quelle italiane che, come sappiamo, sono in larga parte di piccole e medie dimensioni.
La Direttiva CSRD disciplina la rendicontazione societaria di sostenibilità; la Direttiva CS3D, invece, riguarda la due diligence della supply chain da parte delle imprese committenti di elevate dimensioni. La prima prevede la progressiva estensione dell’obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, comprese le Pmi quotate, escluse soltanto le microimprese quotate. L’obbligo si estende anche alle imprese non europee che operino nell’Unione attraverso società “figlie” o succursali. La seconda, invece, obbliga le imprese e i gruppi di grandi dimensioni a mettere in atto strumenti di controllo della propria filiera a livello globale, al fine di verificarne i requisiti ambientali, sociali e di governance e di ridurne gli impatti negativi. È evidente che, di riflesso, questi obblighi, seppur incombenti sul committente, abbiano inevitabilmente effetto sulle imprese a valle, che dovranno adeguarsi se vogliono restare sul mercato. Una grande opportunità per le imprese europee che, attraverso questa nuova normazione, potranno recuperare competitività rispetto ai competitor extraeuropei.
Quali sono i vantaggi per le imprese che possono derivare dall’adesione alle nuove direttive Esg?
Le imprese europee, indipendentemente dalle proprie dimensioni, hanno da tempo percepito l’esigenza di dotarsi di strumenti di governance e organizzativi integrati in grado, oltre che di produrre il bene o il servizio generando profitto, di gestire al meglio i rischi e di creare valore, non solo per gli azionisti, ma per la società nel suo complesso. Se ci pensiamo, questo cambiamento in atto va verso la realizzazione di quella “impresa sociale” di cui già parla l’art. 41 della nostra Costituzione. Le direttive Esg sono funzionali alla creazione di valore sotto il profilo ambientale, sociale e della stabilità finanziaria, organizzativa e operativa dell’impresa.
Le imprese sono chiamate a un rilevante sforzo in termini di visione, dotazione di risorse, investimento economico, rinnovamento dei propri processi produttivi e commerciali e della relazione con tutti gli stakeholder (dipendenti, clienti, fornitori, pubbliche amministrazioni, cittadinanza e altri ancora), ma la promessa in termini di risultato utile è altrettanto significativa: maggiore competitività a lungo termine, capacità di soddisfare le aspettative del mercato e dei portatori di interesse, accesso agevolato al credito.
Quale può essere l’impatto sulle piccole imprese italiane? In positivo e in negativo. Certamente non è un percorso facile, la complessità della normativa è elevata, l’insidia è dietro l’angolo (pensiamo al rischio di greenwashing e a quelli con-
nessi a rendicontazioni non veritiere), servono competenze specialistiche che difficilmente le Pmi possono internalizzare e un grande sforzo anche in termini di digitalizzazione e di innovazione. Il tutto in un Paese, come il nostro, dove la burocrazia è un problema oggettivo e dove la pubblica amministrazione purtroppo non agevola i cambiamenti, a causa di problemi strutturali che non si riescono a risolvere. Alcune piccole e medie imprese che hanno già affrontato questo percorso e hanno accettato la sfida di accreditarsi presso grossi committenti che da tempo richiedono alla propria filiera di soddisfare requisiti e standard più elevati di quelli minimi di legge riferiscono però di averne tratto enormi vantaggi, aumentando il numero delle commesse e la loro remuneratività. Ne è prova anche la proliferazione di imprese benefit certificate.
Come la normativa sulla sostenibilità delle filiere influirà sulle aziende del comparto legno?
Il comparto del legno è sicuramente interessato da queste normative, come tutti gli altri comparti industriali del Paese, nel senso che diverse imprese dovranno fronteggiare i nuovi adempimenti essendovi tenute per legge. Ma questa considerazione non esaurisce la risposta. Si tratta infatti di un settore che, più di altri, può effettivamente sfruttare il vento e in cui gli investimenti in termini ambientali, sociali e di governance possono essere significativi. Pensiamo alle iniziative volte alla riduzione degli impatti ambientali della produzione (attraverso l’efficientamento energetico, l’innovazione impiantistica e tecnologica, la prevenzione dei rifiuti e la simbiosi industriale, l’utilizzo di materiali secondari nella produzione al posto di materia prima vergine, per fare degli esempi), all’adozione di nuovi modelli di consumo (come quello del “prodotto come servizio”), ma anche a quelle che riguardano l’implementazione della tracciabilità e del monitoraggio della filiera lungo tutta la catena del valore, a partire dalle materie prime fino al rifiuto costituito dal prodotto a fine vita. L’adesione a sistemi di responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, come prevede la Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98), può agevolare queste iniziative e alcuni comparti, come quello delle costruzioni in legno, hanno già manifestato interesse al riguardo.
Quale potrebbe essere il ruolo delle associazioni che rappresentano le aziende? Il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale. Monitorano l’attuazione delle normative europee a livello nazionale onde garantire che le soluzioni prescelte dal nostro legislatore siano coerenti con le caratteristiche del tessuto produttivo italiano. Supportano le imprese nella comprensione degli adempimenti. Erogano formazione. Possono favorire le relazioni tra imprese per progettualità comuni e condivise. Possono sviluppare strumenti digitali e piattaforme da mettere a disposizione delle imprese, pensiamo, ad esempio, agli strumenti di supporto per la rendicontazione di sostenibilità. Questa normativa è in grado di rilanciare così anche il ruolo delle associazioni.

e situazioni di inquinamento.

Adeguarsi alle direttive europee può comportare costi e burocrazia ma apre prospettive interessanti, anche nel settore mobile legno-arredo intervista a ANTONIO MASSARUTTO
Le normative europee sulla sostenibilità comporteranno per l’Italia più fardelli burocratici o opportunità per le imprese?
Dagli anni Settanta ad oggi l’Unione Europea ha avuto un ruolo sempre più pervasivo nella politica ambientale: Paesi come l’Italia sono sempre stati trascinati dalla spinta dell’Europa. Ogni volta che è entrata in vigore una nuova serie di norme, nel breve termine si è riscontrato un impatto per l’adeguamento in termini di costi e burocrazia. Le reazioni sono state diverse. Alcuni hanno saputo trasformare le norme in opportunità e con adeguati investimenti ne hanno
beneficiato. Mentre altri sono rimasti vittime dei fardelli burocratici. Storicamente le aziende italiane hanno più spesso seguito, solo raramente anticipato, gli sviluppi normativi. Troppo spesso in Italia le imprese e le loro associazioni hanno preferito restare sulla difensiva nei confronti di leggi percepite come un aggravio di oneri non bilanciati da benefici. Invece, mi sento di affermare che il saldo benefici-costi complessivo è probabilmente in attivo per il made in Italy. Si pensi solo al fatto che è grazie anche alle politiche europee che l’Italia ha affermato e consolidato una leadership mondiale sui settori del riciclo. O si guardino i nume-
ri pubblicati annualmente negli Stati Generali della Green Economy. Vent’anni fa avevo seguito da vicino l’adeguamento del settore mobile legno-arredo alla direttiva solventi che riguardava, in particolare, la verniciatura. In quel caso c’è stato chi ha colto la normativa come un’opportunità per innovare sensibilmente il prodotto andando a collocarlo dove la qualità si misurava anche in termini di eco-friendliness. Altri, invece, hanno preferito esternalizzare i cicli di verniciatura a micro-aziende per non rientrare nelle soglie della normativa. Questa si è rivelata una soluzione perdente. Prima o poi la necessità di fare i conti con una normativa più stringente arriva per tutti. Rinviare di pochi anni o mesi pensando di salvarsi nel breve termine è, a parer mio, una strategia di corto respiro. Va però riconosciuto che non sempre le innovazioni normative in campo ambientale hanno effetti positivi, né rappresentano per forza una soluzione win-win. Spesso l’Europa impone norme più per dogmatismo ideologico che per documentabili benefici – ne è un esempio il nuovo Regolamento sugli imballaggi. Bisognerà capire se e in che misura il mercato saprà dare una risposta positiva accogliendo chi si fa anticipatore o portatore di queste innovazioni rispetto a chi le frena.
Quindi, in altre parole, arriveranno dall’Europa delle opportunità che l’Italia dovrà saper cogliere? Dipenderà dal modo con cui l’Italia attuerà le norme agevolando le imprese che si muovono in questa
Bisognerebbe implementare un sistema di servizi che permetta alle piccole e medie imprese di esternalizzare senza troppi timori e senza costi eccessivi questo tipo di adempimenti. Se la pubblica amministrazione riuscirà a gestire queste incombenze a favore delle aziende, allora gli investimenti potranno essere portati a termine. Altrimenti sarà un fallimento come lo è stato con altri sistemi di rendicontazione che si sono rivelati micidiali macchine mangiasoldi e mangiatempo.
Le normative sulla sostenibilità possono indurre le imprese a un aumento dimensionale? Non credo che siano sufficienti le normative. Le imprese italiane sono piccole per svariati motivi, tra cui il fatto che la maggior parte di esse rimangono ancora rette dalle famiglie fondatrici. Potrebbe però capitare quel che si è verificato in tanti distretti industriali. Alcuni soggetti aggregatori potrebbero presidiare un punto della filiera e dare sostegno alle piccole medie imprese fornitrici. Questo è accaduto anche nei distretti dei mobili dove sono emerse imprese medie che con il loro marchio e la loro propensione a internazionalizzarsi hanno acquisito una posizione dominante all’interno della filiera. Inevitabilmente tutte le imprese che svolgono lavorazioni più semplici o verso le quali le medie imprese esternalizzano determinate funzioni dovranno però sottostare al modo in cui le aziende leader andranno a organizzare la filiera. In passato questo
direzione e semplificando la burocrazia. Nel settore mobile legno-arredo, in particolare, credo siano più le opportunità che i costi. Pensiamo alla direttiva sulla supply chain che obbliga le grandi imprese ad attestare che tutta la catena di fornitura e subfornitura risponde a determinati requisiti. Mi sembra che per le imprese italiane si aprano prospettive molto interessanti per differenziarsi rispetto a chi finora è stato portato a esternalizzare certe produzioni in Asia perché costavano meno. Attenzione, però. Può darsi che gli stessi asiatici si muovano più veloci di noi e siano in grado di qualificare le loro produzioni in modo più efficace. Si tratta di battere sul tempo la concorrenza e arrivare a posizionarsi il prima possibile rimanendo competitivi a livello globale. Certo, rimane un problema.
Quale?
Adeguarsi a questi criteri può comportare investimenti elevati per le aziende. Decarbonizzare la produzione, al di là degli investimenti per adeguare i macchinari, richiede una serie di costi fissi di tipo amministrativo che penalizzano le piccole realtà.
fenomeno ha già trasformato radicalmente la struttura dei distretti industriali in Italia.
Che ruolo assumerà la normativa nella transizione ambientale?
La normativa sarà inefficace se andrà in direzione contraria al mercato. Potrà assumere, invece, un ruolo di primo piano soprattutto se permetterà alle imprese di impostare un orizzonte strategico più prevedibile in sinergia con la domanda e gli stimoli culturali. Pensiamo alla bioedilizia. In passato è stata costellata da false partenze: in Italia resta ancora un settore di nicchia e tutta la produzione è concentrata in sole due province autonome. Ho conosciuto imprese partite con i migliori auspici che credevano in un aumento della domanda in questo settore e poi si sono tristemente ricredute. Una direttiva come quella sulle case green potrebbe creare uno spazio di mercato per le imprese leader del settore. Se la normativa accompagnerà in modo intelligente le imprese, con scadenze appropriate e incentivi giusti, questo faciliterà anche la transizione ambientale.

Antonio Massarutto è professore al Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine.
PER APPROFONDIRE suggeriti da Antonio Massarutto
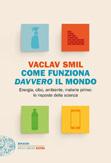
Vaclav Smil, Come funziona davvero il mondo. Energia, cibo, ambiente, materie prime, Einaudi, 2023
Alberto Clò, Energia e clima. L’altra faccia della medaglia, Il Mulino, 2017
FILM
Koyaanisqatsi di Godfrey Reggio, 1982 Wall-e di Andrew Stanton, 2008
DOCUMENTARIO
Shitthropocene di Patagonia, 2024
ARTICOLI
Antonio Massarutto, Attacca l’asino dove vuole il padrone, “l’Astrolabio”, 2 maggio 2023, https://astrolabio. amicidellaterra.it/ node/2951
L’eccesso di regolamentazione può far perdere di vista gli obiettivi: servono semplificazione e sostegno alle Pmi per risultati concreti intervista a LARA

Lara Ponti è vicepresidente per la transizione ambientale e gli obiettivi Esg di Confindustria. È anche vicepresidente di Ponti spa società Benefit.
Le nuove normative europee in materia di sostenibilità per le aziende comportano più opportunità o incombenze?
Come tutti i cambiamenti, presentano certamente opportunità di sviluppo. Le imprese italiane in particolare sono sempre molto innovative, capaci di trovare strategie alternative velocemente. Siamo molto più avanti degli altri paesi, ad esempio, nel riciclo e siamo tra i primi paesi nell’utilizzo di materie prime seconde nella componentistica per il fotovoltaico. Il vero problema è che la regolamentazione sta diventando pantagruelica, enorme, oggettivamente molto complessa e, soprattutto, non tarata sulla dimensione delle aziende.
Per fare un esempio concreto, la normativa della CSRD per la rendicontazione è molto complessa: se l’azienda è strutturata può affrontarla, ma per quelle più piccole diventa davvero onerosa. Quel che sta succedendo è che anche le aziende che dal punto di vista formale non sono tenute ad adeguarsi, nei fatti devono produrre gli stessi dati perché sono fornitrici di aziende che invece sono sottoposte alla normativa.
Si tratta di un compito molto impegnativo che non è tarato sulle possibilità reali delle piccole aziende per ragioni di costi, tempo, competenze. Al tema della complessità si aggiunge il tema delle normative confliggenti. E poi c’è un’altra questione altrettanto grave.
Quale?
Questo eccesso di regolamentazione fa perdere di vista l’obiettivo iniziale che era la trasparenza. La stessa CSRD nasce con l’intento molto positivo di rendicontare la sostenibilità e anche di rendere comparabili le imprese, così che il consumatore o il cliente potessero davvero verificare quale azienda fosse più avanti su questo tema. Invece, con una

procedura così complessa, le imprese si concentrano sulla dimensione operativa e perdono il senso del valore evolutivo, di trasparenza, di maggior tutela del consumatore. Tutto questo è negativo perché sviluppa nelle aziende un’insofferenza verso i regolatori dell’Unione europea e anche verso il tema della sostenibilità, con la percezione che sia tutto “carta” e burocrazia.
L’Ue sta affrontando questo problema?
Sembra che nelle linee strategiche della Von der Leyen sia previsto: la semplificazione è uno dei primi obiettivi. Come lo è nel rapporto Letta e in quello Draghi.
Bisognerà vedere se ci saranno azioni concrete e se le norme emanate potranno essere ancora modificate nell’ambito dei numerosi decreti attuativi.
In Italia, il problema è che spesso aggiungiamo complicazione a complicazione… dico sempre che

c’è troppa Italia a Bruxelles, hanno assunto i nostri peggiori difetti.
E Confindustria come si muove?
Stiamo lavorando intensamente a tutti i livelli, sia con i ministeri che a livello europeo con la nostra delegazione a Bruxelles. Lavoriamo per fare comprendere quali sono le conseguenze sulle imprese di norme ideali sulla carta ma complesse da gestire quando si prova ad attuarle. Inoltre, stiamo lavorando anche a livello dei territori e con le categorie. Abbiamo cominciato da tempo a supportare le aziende, fornendo strumenti, linee guida e formazione.
Lavoriamo sempre su due livelli, quello delle istituzioni sulla dimensione regolatoria e normativa e quello degli strumenti concreti per le imprese. La sfida dei prossimi anni è quella di aiutare tutte le imprese a cogliere le opportunità della transizione.
Qual è il livello di implementazione delle nuove logiche sostenibili?
Ci sono imprese che sono molto avanti, che hanno colto il paradigma dello sviluppo sostenibile come opportunità, portando avanti un’offerta di servizi e prodotti innovativi e un necessario cambio strategico organizzativo.
Altre invece sono più indietro; perché hanno sottovalutato il cambiamento, o spesso per problemi di tempo, di concentrazione sull’ordinario. La nostra grande convinzione è che la transizione sarà efficace e di successo se coinvolgerà le aziende di tutte le dimensioni e tipologie e in tutte le filiere: l’Italia ha tante interconnessioni nelle filiere del territorio, se tutti crescono, il Sistema Paese cresce. Lavoreremo tanto per raggiungere questo risultato.
Ci riescono anche le piccole?
Sì, e ce ne sono che nascono già con questo approccio, come diverse startup. Nelle piccole e medie imprese tutto è maggiormente basato sulla capacità e sulla visionarietà degli imprenditori e delle imprenditrici. Tuttavia non c’è un rapporto causa-effetto lineare. Sebbene le grandi imprese abbiano spinte più oggettive per accelerare il cambiamento e lo stiano facendo, non tutte hanno intrapreso questa strada. Le transizioni verso la sostenibilità e la digitalizzazione vanno abbastanza di pari passo: in particolare, la digitalizzazione è un grande strumento, da utilizzare per la transizione sostenibile. Facilita la raccolta, l’elaborazione e la comprensione dei dati che bisogna rendicontare e insieme agli strumenti di intelligenza artificiale è di grande supporto per il risparmio energetico e l’efficientamento. Nella transizione digitale le aziende medio-piccole sono più indietro perché hanno meno risorse e competenze specialistiche a disposizione. La transizione sostenibile è invece più trasversale perché dipende dalla sensibilità, dalla capacità di leggere il futuro delle imprese, oltre che dall’età media del Cda e dalle competenze.
PER APPROFONDIRE suggeriti da Lara Ponti

Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo , Una buona economia per tempi difficili, Laterza, 2020
intervista a ROBERTA IOVINO

Roberta Iovino è ricercatrice presso l’Istituto di management della Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa all’interno del SuM (Sustainability management laboratory).
PER APPROFONDIRE
suggeriti da Roberta

Fabio Iraldo, Michela Melis, Oltre il greenwashing, Edizioni Ambiente, 2020
DOCUMENTARI
Cowspiracy: the sustainability secret di Kip Andersen, 2014
Seaspiracy di Ali Tabrizi, 2021
Sei ciò che mangi di Louie Psihoyos, 2024
PODCAST
Sostenibilità for beginners, Gli Ascoltabili
Come nasce la normativa sui green claim?
La direttiva n. 825 del 2024 ha modificato la n. 29 del 2005 che è la normativa di riferimento sulle pratiche commerciali sleali. Qualsiasi messaggio, logo, comunicazione anche audiovisiva che faccia pensare al consumatore che un prodotto, un servizio, un’attività possa essere benefica o avere un ridotto impatto sull’ambiente è definito green claim, cioè asserzione che rivendica una caratteristica ambientale del prodotto, del servizio o del trader. Per esempio, “green shampoo”, “confezione sostenibile”, “siamo responsabili verso l’ambiente”, o una gamma di prodotti con un marchio come “greencare” o simili.
Quali sono state le evoluzioni che hanno portato alla modifica della normativa?
Il Green Deal europeo ha affermato che per evitare il greenwashing, cioè evitare di ingannare i consumatori, bisogna spingere le aziende a basarsi su una metodologia condivisa per calcolare gli impatti ambientali, e quindi formulare affermazioni più corrette e sostanziate in questo ambito. Un’intenzione ripresa dal Circular economy action plan che propone la PEF (Product Environmental Footprint) europea, una metodologia standard per calcolare in modo scientifico e condiviso l’impatto ambientale nell’intero ciclo di vita di prodotti e servizi. L’obiettivo è quello di evitare l’utilizzo di termini come green, eco, riciclato, riciclabile, sostenibile, biodegradabile, senza una metodologia condivisa. Successivamente, sono state formulate due proposte di direttive: una è quella confluita nella n. 825 del 2024, l’altra è contenuta nella comunicazione n. 166 del 2023 il cui iter di approvazione è ancora in corso.
Quali le novità introdotte dalla direttiva n. 825?
Non potranno più essere usati claim generici di tipo ecologico, se non si ha una prova concreta dell’eccellenza delle prestazioni ambientali. È il caso, per esempio, di un’etichettatura di tipo 1 come l’ecolabel, o di una certificazione dell’eccellenza che si basa sulle logiche di ciclo di vita o equivalenti, come Iso 14024 o altra norma applicabile dell’Unione. Così in presenza di un prodotto realizzato con materiale riciclato, si potrà dire che è green o ecologico solo con una prova dell’eccel-
lenza. Un altro divieto molto importante che è stato inserito riguarda i claim sulla neutralità climatica: spesso si legge carbon neutral oppure “a emissioni zero”. Ma la direttiva 825 vieta questi tipi di claim del prodotto se sono basati su offsetting, cioè su compensazioni attuate dall’azienda tramite l’acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni del prodotto al di fuori della propria catena del valore. Anche l’esibizione da parte dell’impresa di qualsiasi marchio/logo di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione indipendente rientra tra i nuovi importanti divieti. Altre novità introdotte dalla direttiva 825 riguardano previsioni ambientali sul futuro, come per esempio “utilizzeremo solo materiali riciclati entro il 2030”. Non si potranno più fare questi claim senza avere a disposizione dati “pubblicamente disponibili e verificabili in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise” .
Quali i tempi di applicazione e le sanzioni previste?
La direttiva è entrata in vigore nel marzo del 2024 e sono previsti due anni per il recepimento. Le previsioni saranno vincolanti per tutte le aziende da fine settembre 2026. Il singolo Stato membro dovrà individuare l’autorità di riferimento – in Italia al momento è l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) – per il controllo del rispetto dei requisiti. Per le sanzioni non ci sono state modifiche all’ultima versione del 2005 e dunque il massimo erogabile è di 10 milioni di euro. Per le aziende insorgono ulteriori rischi reputazionali: con una sentenza di greenwashing l’autorità può condannare l’impresa non solo a ritirare il messaggio pubblicitario ingannevole dal mercato, ma anche a pubblicare la sentenza sui propri canali per informare i clienti.
La proposta di direttiva inserita nella comunicazione 166 del 2023 cosa contiene?
Definisce l’explicit green claim come asserzione ambientale testuale o verbale o inclusa in un logo di sostenibilità e istituisce un meccanismo di verifica ex ante del claim, prima che l’azienda lo possa utilizzare sul mercato. Oggi ci sono casi di aziende che producono claim ingannevoli, ma non vengono denunciate perché esso passa inosservato. Se la proposta di direttiva n. 166 diventerà legge, l’azienda dovrà produrre un fascicolo tecnico per dimostrare che il claim ambientale che intende utilizzare sul mercato soddisfa una serie di requisiti minimi. Dovrà inoltre provare di utilizzare evidenze scientifiche ampiamente riconosciute e comunicare informazioni rilevanti in una logica di ciclo di vita. Dal vantaggio ambientale che si pubblicizza non devono derivare peggioramenti significativi in altri indicatori ambientali rilevanti: per esempio, si potrebbe avere meno impatto sul cambiamento climatico ma più sull’impronta idrica. A quel punto, una parte terza verificherà che effettivamente questi criteri siano rispettati e rilascerà un certificato di conformità. L’obiettivo è quello di lasciare sul mercato solo claim sostanziati e trasparenti, basati su metodologie riconosciute.
Il primo motivo per il quale le aziende devono abbracciare le nuove normative europee sulla sostenibilità è la necessità di dare il proprio contributo alla decarbonizzazione. Ma non è il solo: esse sono tenute a seguire la chiara direzione intrapresa dalla domanda, pena la perdita di quote di mercato. Secondo uno studio di McKinsey e NielsenIQ, negli ultimi cinque anni i prodotti con dichiarazioni Esg hanno avuto una crescita complessiva del 28% rispetto a quelli non sostenibili.
Inoltre un’adeguata rendicontazione delle proprie attività sostenibili è un requisito sempre più necessario per accedere al mercato creditizio. Nel sistema bancario c’è ormai una forte attenzione ai temi della sostenibilità e ai rischi climatici e ambientali, con una crescente domanda di informazioni Esg cui dovrebbe rispondere la direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive. Dal classico binomio rischio-rendimento si sta così passando allo schema rischio-rendimento-impatto.
Nel documento di consultazione del Tavolo per la Finanza sostenibile, composto dai ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Imprese e del Made in Italy, oltre che da Banca d’Italia e Consob, dello scorso mese di giugno dal titolo “Il dialogo di sostenibilità tra Pmi e banche”, si legge: “In particolare, le imprese di dimensione piccola o media (Pmi), che hanno
una presenza predominante nel tessuto produttivo italiano, potranno svolgere un ruolo centrale nella transizione. Ad esse viene richiesto gradualmente di comunicare al mercato (banche, investitori e grandi imprese) informazioni sulle loro performance di sostenibilità, intese come le informazioni che attengono agli impatti, ai rischi e alle opportunità legati alle ricadute ambientali, sociali e di governance (Esg) delle loro attività. Il contesto normativo europeo, profondamente rinnovato nell’ultimo decennio, richiede infatti che le imprese di maggiori dimensioni e le istituzioni finanziarie dispongano di informazioni di sostenibilità relative alla loro catena del valore; informazioni per le quali sarà necessaria la cooperazione da parte anche delle Pmi”. Non si tratta di uno sforzo vano, come si legge ancora nello stesso documento: “A fronte di questo sforzo, le Pmi potranno ottenere significativi benefici. Grazie alla disponibilità di queste informazioni esse potranno misurare più accuratamente i rischi e pianificare meglio gli investimenti; avere un miglior accesso a finanziamenti, con minor costo e maggiori agevolazioni; rafforzare la capacità di resistere a shock energetici e ambientali; offrire prodotti e servizi più sostenibili, rafforzando il posizionamento competitivo”.
Per le piccole imprese che iniziano ad approcciarsi alle normative, il primo passo da compiere è un’analisi dei propri punti di forza e di debolezza: azione fondamentale per una prima
Come sottolinea la Commissione europea, tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10% del totale del pianeta. L’espansione agricola è responsabile di quasi il 90% della deforestazione a livello globale.
Nasce da queste premesse quel che è stato definito Regolamento deforestazione, ma che in realtà non riguarda solo l’industria del legno. Il suo nome completo è infatti Regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. Si tratta di sette materie prime
misurazione dei Kpi tramite una valutazione del rischio di impatto. Proprio allo scopo di supportare le Pmi nella produzione di informazioni di sostenibilità, la Commissione europea ha invitato l’Efrag a predisporre uno standard volontario rivolto alle piccole e medie imprese non quotate. Ad oggi, l’Efrag ha sottoposto alla consultazione l’Exposure Draft for the voluntary reporting standard for non-listed SMEs (VSME ED): questo standard non è oggetto di un atto legislativo della Commissione europea in quanto i suoi destinatari non rientrano nel perimetro degli obblighi di rendicontazione della CSRD. Lo standard intende offrire un modello europeo di identificazione e rappresentazione delle informazioni sulla sostenibilità delle Pmi che risponda alle esigenze dei principali utilizzatori (investitori, banche e partner commerciali). Nella sua predisposizione Efrag ha tenuto conto, secondo un criterio di proporzionalità, delle caratteristiche dimensionali e organizzative delle micro, piccole e medie imprese. In particolare, le microimprese sono invitate a utilizzare solo alcune parti dei principi di rendicontazione per semplificare la redazione del report. Il documento di consultazione del Tavolo per la Finanza sostenibile si pone su un piano di complementarità rispetto a tale iniziativa dell’Efrag. Da un lato, mira a concentrarsi sullo specifico rapporto tra le Pmi e le banche e, dall’altro, intende facilitare la standardizzazione delle prassi in via di adozione nel contesto italiano.
(bovini, cacao, caffè, gomma, palma da olio, soia e appunto legno) e alcuni prodotti finiti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime in questione (dalla carne bovina al cioccolato, dai mobili alla carta stampata).
Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e impone un obbligo di due diligence affinché le aziende verifichino che determinate materie prime non siano state prodotte su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.
L’obbligo per le grandi e medie imprese scatta il 31 dicembre di quest’anno mentre le piccole e micro imprese avranno tempo fino al 30 giugno dell’anno prossimo.
Il comico di Tre uomini e una gamba è diventato un portavoce di sostenibilità con un milione di follower
intervista a GIOVANNI STORTI
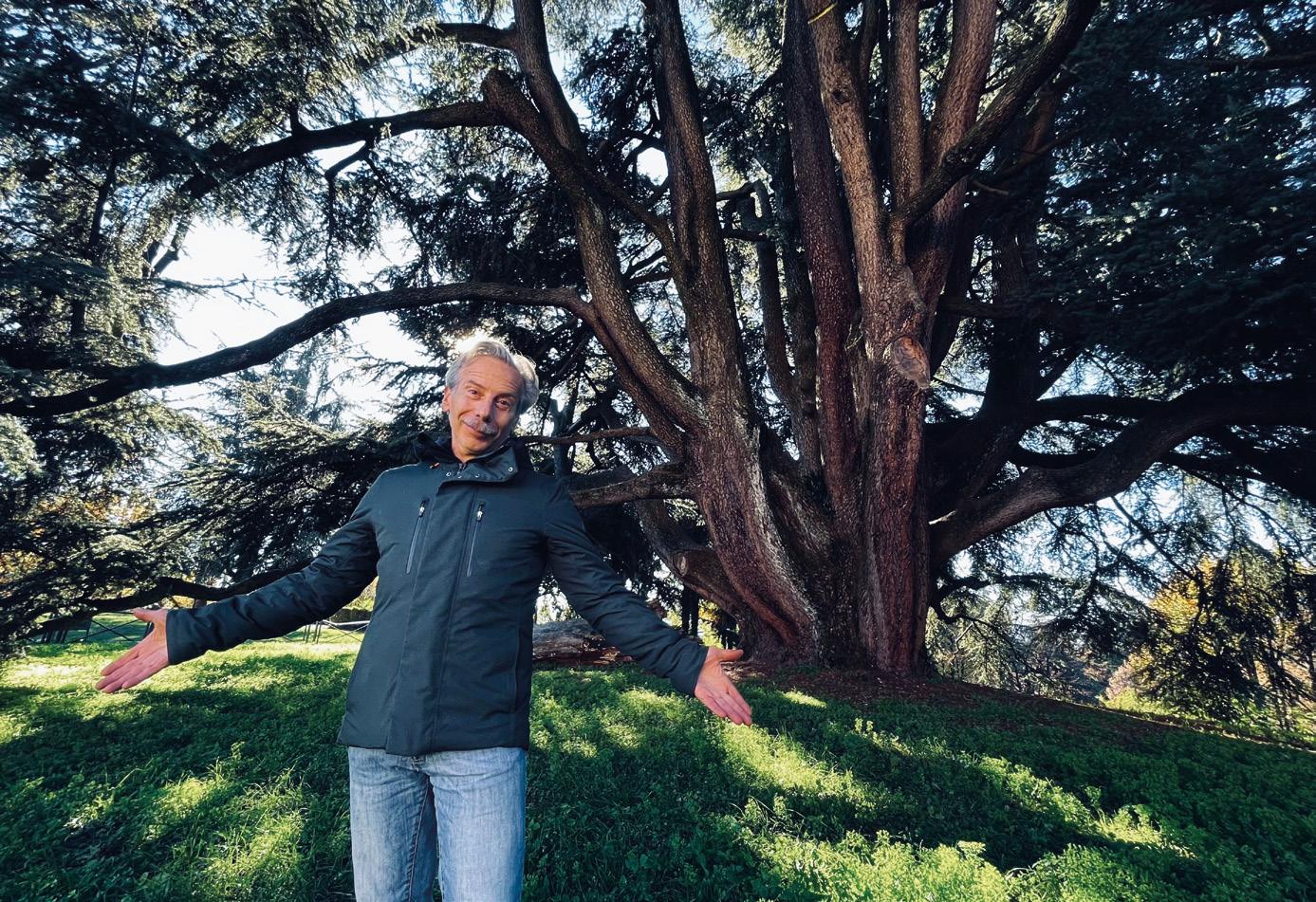
Giovanni Storti è attivista, attore e comico
Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha fondato Immedia, piattaforma social dedicata alla sostenibilità.
Nel film Tre uomini e una gamba lei è protagonista di una scena iconica e forse anche involontariamente metaforica. Raggiunge la riva di un torrente con la scultura di legno della gamba, vuole lavarla perché un cane ci ha fatto la pipì sopra. Le suona il cellulare che le scappa di mano, per recuperarlo al volo perde la gamba che finisce in acqua e se ne va con la corrente. Mentre rispondevamo all’ennesima chiamata ci è scappata la situazione climatica di
mano e ora ci troviamo a inseguirla senza sapere se riusciremo a recuperarla?
(Ride) Bella metafora. È proprio così: ci siamo distratti e continuiamo ad essere distratti. A causa della nostra distrazione continuiamo ad inseguire i veri scopi, le cose belle della vita. Siamo troppo presi dalle cose materiali e dalla tecnologia. In questo modo la situazione ambientale e climatica ci è scappata di mano.
Come è nata la sua attività a favore della sostenibilità?
Sin da bambino ho sempre vissuto per la natura. La sostenibilità è insita in me. Quando non c’era la scuola, passavo l’estate in montagna, sulle Alpi lombarde sopra Lecco. Siccome non avevamo la macchina, prendevamo il treno, poi la corriera, e infine facevamo qualche chilometro a piedi per arrivare in questo posto che oggi si raggiunge in auto in meno di un’ora. Sono cresciuto con la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità, ma questo non deve rimanere solo un pensiero: deve incarnarsi, lo devi sentire col corpo. Se lo pensi e basta rimani troppo distaccato. Azzardo: è come una conversione, a questo cambiamento deve partecipare tutto l’essere.
Quando ha avviato il suo tentativo di comunicare i temi della sostenibilità in modo diverso?
Durante il lockdown. Io e mia moglie siamo rimasti in campagna da soli, era una bellissima primavera nonostante il Covid, attorno a me c’era questa esplosione di natura. Ho voluto raccontarla attraverso la mia pagina Instagram, rendere partecipi anche gli altri di quel che stava succedendo. Poi col tempo l’ho codificata, ho aperto un canale, e la pagina è diventata quel che è oggi.
Quest’anno è andato oltre: ha lanciato Immedia, una piattaforma social dedicata alla sostenibilità. Negli anni la mia attività mi ha portato a conoscere scienziati come Stefano Mancuso, persona eccezionale, Mario Tozzi, Luca Mercalli che conoscevo da “Che tempo che fa”, Telmo Pievani, una persona squisita. E quindi ho lanciato l’idea: “Perché non uniamo le forze? Voi siete scienziati, quindi avete autorità, io invece sono un giullare. Insieme possiamo potenziare la nostra comunicazione in materia di sostenibilità”. Abbiamo incluso anche una biologa, cerchiamo di allargare il campo per comunicare in modo più scientifico il cambiamento in atto. Ora cerchiamo aziende che si approcciano all’attività in modo consapevole e circolare. Uno dei nostri progetti riguarda, ad esempio, il ripopolamento ittico contro la pesca intensiva.
Chi lo porta avanti?
Paolo Fanciulli detto “il pescatore” di Talamone, davanti all’Argentario. Un personaggio conosciuto in tutto il mondo per la sua lotta alla pesca a strascico, che è un vero disastro: crea morte e distruzione sui fondali. Siccome i controlli erano troppo blandi, Paolo ha iniziato a difendere il fondale tagliando le reti dei pescatori di frodo. Così facendo, è riuscito a coinvolgere le istituzioni. E ha avuto un paio di idee geniali: affondare blocchi di cemento in mare con dei ganci di metallo per bucare le reti e impedire ai pescatori illegali di usare quella tecnica distruttiva. Ha ricevuto in regalo da Carrara cento blocchi di marmo che lui ha fatto scolpire da artisti di tutta Europa: ha creato un vero e proprio museo sottomarino. In questo modo è riuscito ad unire l’arte all’attivismo. Più di recente ha lanciato la campagna “Diamo una
casa al polpo” con l’obiettivo di posizionare in fondo al mare delle anfore per ospitare i polpi che vengono pescati (anch’essi) in modo distruttivo e che stanno rischiando di estinguersi nel Mediterraneo. Questo avviene perché vediamo gli animali solo come cibo e non come nostri coinquilini di questo mondo... Per raccontare la storia di Paolo sono venute troupe dal Giappone, si è mossa anche la Bbc e persino Di Caprio si è interessato a lui. È un attivista incredibile: nonostante mille difficoltà, ha trovato soluzioni e ha inventato un meccanismo che si potrebbe esportare dappertutto.
Secondo lei, il cambiamento climatico viene comunicato male?
Si fatica a far capire che le nostre più piccole azioni possono veramente determinare l’economia. Se, per esempio, non comprassimo carne da allevamenti intensivi, ne mangiassimo di meno, sostituissimo un po’ alla volta le proteine animali con quelle vegetali, che costano meno e consumano meno acqua, potremmo avere un impatto importante. È un’assurdità che il 70% delle aree coltivabili siano destinate a dare cibo agli animali da allevamento. Poi ci dicono che bisogna aumentare la quantità di concimi chimici per produrre di più. No, bisogna solo essere più accorti. Ancora oggi l’80% degli aiuti economici dell’Unione europea va alle grandi aziende che si occupano di allevamenti e colture intensive.
Lei ha cambiato alimentazione?
Sì, io e mia moglie non siamo vegani o vegetariani, ma mangiamo poca carne, una volta alla settimana, acquistandola dove siamo sicuri della provenienza. Per quanto riguarda il pesce, pochi sanno che il povero Mediterraneo non riesce a rigenerare la sua popolazione ittica. E che il mangime del pesce allevato è lo stesso che danno ai polli e alle mucche. Come diceva Gramsci, “pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”: il mio intelletto è pessimista, però il mio cuore è ottimista. Siamo alla frutta, veramente. Abbiamo una casa nel Monferrato e ogni tre temporali ce ne sono due devastanti che distruggono diverse piante. In Emilia in quindici mesi ci sono state tre alluvioni: non è mai esistita una cosa del genere. Il cambiamento è sotto gli occhi di tutti.
Con Stefano Mancuso ha lanciato il progetto “Le vie degli alberi” e un appello a sindaci e assessori: “Togliete l’asfalto dalle strade e sostituitelo con le piante!”. Qualcuno ha risposto?
Nessuna risposta, ma andremo noi a parlare con gli assessori, specialmente a Milano, dove ci sono 1700 chilometri di strade! Secondo me troveremo qualcuno che ci ascolta, anche se la burocrazia è impressionante, veramente faticosa. Il problema è che la gente vuole andare in macchina anche in città. Io l’auto ce l’ho, ma la uso solo per andare in campagna. È incredibile voler utilizzare per forza l’auto, in città è un vero vizio e non una libertà. Per che cosa, poi? La velocità media è di diciassette chilometri all’ora, si va più veloci in bicicletta!
PER APPROFONDIRE suggeriti da

Jonathan Safran Foer
Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? Guanda, 2010
FILM
E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif, 2021

Ridurre le emissioni di gas serra rimane la strada maestra per combattere il cambiamento climatico intervista a CARLO BUONTEMPO

Carlo Buontempo, fisico esperto di clima, è direttore del servizio cambiamento climatico dei satelliti europei Copernicus (C3S).
Cambiamento climatico. Qual è la situazione attuale?
Con il programma Copernicus monitoriamo costantemente lo stato del clima, trasformando i dati provenienti dai satelliti e da terra in informazioni più facilmente fruibili e digeribili dal pubblico e dai decisori politici. Quel che è successo negli ultimi mesi è stato abbastanza straordinario dal punto di vista della temperatura sia degli oceani (con quindici mesi consecutivi che sono stati i più caldi della storia) sia dell’aria che ha raggiunto delle quote record per tredici mesi consecutivi: ogni mese è stato il più caldo mai registrato a partire da giugno dell’anno scorso.
Non ha mai fatto così caldo sulla terra?
I dati climatici sui quali abbiamo un controllo diret-
to iniziano dal 1940 anche se esistono alcune serie storiche precedenti. Esiste una letteratura scientifica abbastanza ampia a riguardo. Le temperature registrate negli ultimi dodici mesi sono inusuali rispetto a quelle delle ultime migliaia di anni. È verosimile dunque che gli ultimi dodici mesi (anche forse gli ultimi anni) siano stati i più caldi degli ultimi centomila anni. Nella storia della nostra civiltà non abbiamo mai dovuto confrontarci con un mondo così caldo e ciò vale anche per la temperatura del mare. Secondo me questo è un buon punto di partenza per riflettere su un cambio di paradigma. Spesso si parla del cambiamento climatico come qualcosa che avverrà in futuro, ma in realtà il cambiamento climatico è già qui. Le temperature e tutta una serie di altre variabili marcano una differenza fondamentale
rispetto a quello che è stato il clima nel passato, dalla fine dell’ultima glaciazione in poi.
Rispetto agli obiettivi fissati come stiamo andando? Sono dodici mesi che la temperatura globale è al di sopra di un grado e mezzo rispetto al periodo pre-industriale, contrariamente a quanto previsto dagli Accordi di Parigi. Questa è un’indicazione di ciò che ci aspetta, le conseguenze sono già ampiamente visibili in montagna, nei fiumi. Uno degli aspetti trattati nel rapporto climatico dello scorso aprile congiuntamente con l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite è l’analisi delle conseguenze per vari settori specifici. Un evento di grande impatto tra il 2022 e il 2023 è stato la perdita del 10% della massa glaciale delle Alpi, un volume mostruoso. Ancora più significativo è il fatto che, guardando indietro dagli anni Ottanta ad oggi, si è perso un volume di centinaia di migliaia di metri cubi all’anno: questo dovrebbe bastare per descrivere la gravità del problema. Non sono solo i ghiacciai a doverci preoccupare. Quella della banchisa polare artica è una delle storie più impattanti in termini di perdita di habitat. Negli ultimi due anni, stiamo assistendo alla perdita di ghiaccio marino in Antartide, finora rimasto abbastanza stabile, con una perdita del 30% della superficie. L’ultima variabile che vale la pena menzionare è il livello del mare.
Quali sono i dati in merito?
Negli ultimi trent’anni il grafico del livello del mare è in crescita continua, con un’accelerazione di circa tre millimetri all’anno. Si tratta di una decina di centimetri da quando frequentavo l’università: è un dato piuttosto spaventoso. Da ora in poi, non esiste uno scenario realistico in cui questa tendenza all’aumento del livello del mare possa cambiare nei prossimi due o tre secoli. Le nostre scelte attuali avranno un impatto su molte generazioni future: un aumento di due o tre metri continuerà a essere importante. Mentre per alcune variabili esiste la possibilità di tornare indietro con tempi lunghi, ma quasi umani, per altre l’impatto è di carattere quasi geologico.
Cosa si può fare per contrastare questa preoccupante situazione?
È una domanda complessa. Da fisico di formazione, mi piace semplificare i problemi. Dal punto di vista puramente climatico, sappiamo cosa sta generando il riscaldamento globale: in larga misura
è l’aumento dei gas serra nell’atmosfera insieme a una serie di altri feedback. Se vogliamo limitare il riscaldamento sotto i due gradi come previsto dagli accordi di Parigi, e possibilmente sotto 1,5 gradi, dobbiamo raggiungere le emissioni zero nel più breve tempo possibile. Arrivare a emissioni zero è un passo fondamentale per cercare di contrastare il problema. Esistono altri aspetti che influenzano il clima: si può pensare, ad esempio, di intervenire sulla geoingegneria, sulla riduzione delle radiazioni solari attraverso l’immissione di particelle in stratosfera. Queste sono opzioni che sono state formulate e vengono discusse dai politici. Anche nella dichiarazione finale del congresso del World Climate Research Programme che si è tenuto nel 2023 a Kigali viene citata la necessità di studiare le possibilità della geoingegneria, anche se la maggior parte della comunità non ritiene che questa sia la soluzione più ragionevole al problema dei cambiamenti climatici. Ridurre le emissioni di gas serra rimane il meccanismo principale attraverso il quale possiamo intervenire. Anche perché questi approcci di bioingegneria non toccano alcuni aspetti del problema: per esempio, l’aumento della CO 2 nell’atmosfera aumenta l’acidità degli oceani. Le conseguenze possono minare le basi della catena trofica e la disponibilità di ossigeno generato dal fitoplancton. Il sistema climatico è complesso e gli impatti non sono ovvi.
Ha senso affrontare il problema su una scala che non sia globale?
Non ci sono dubbi che l’adattamento climatico si possa fare su piccola scala, ma ci dobbiamo comunque confrontare con un clima già profondamente diverso da quello che ha sostenuto le nostre pratiche agricole su scala locale. D’altro canto, la mitigazione locale non ha senso: quello del cambiamento climatico è un problema globale che richiede una soluzione globale. Ci siamo già confrontati con un problema globale come il buco dell’ozono e abbiamo trovato una convergenza globale. Questa è la strada da percorrere per un problema incredibilmente più complesso come quello del cambiamento climatico che riguarda la combustione e l’esigenza di ripensare il nostro modello di sviluppo. Non si può risolvere localmente, ma solo con un accordo multilaterale e coordinato. Nonostante il fatto che le COP (Conferenze delle parti) siano diventate nel tempo grandi kermesse e non abbiano portato a risultati eclatanti, rimangono comunque l’occasione più importante per raggiungere un accordo globale. Non ci rendiamo conto di quanto velocemente stia cambiando il mondo. Se da una parte del globo la deforestazione e le azioni distruttive proseguono, dall’altra parte vi sono anche segnali positivi. La Cina è diventata in pochi anni il più grande produttore e installatore di energie rinnovabili. Recentemente la potenza installata dai cinesi ha superato quella del resto del mondo, segnando un cambiamento epocale.
PER APPROFONDIRE suggeriti da Carlo Buontempo
LIBRI

George Monbiot, Il futuro è sottoterra. Un’indagine per sfamare il mondo senza divorare il pianeta (titolo originale Regenesis), Mondadori, 2022
FILM
Don’t look up! di Adam McKay, 2021
PODCAST
The Space Café Podcast #69: Carlo Buontempo con Markus Mooslechner

Il cambiamento climatico non si combatte solo con l’intelligenza artificiale, ma con una rivoluzione culturale intervista a MARIO
TOZZI


Mario Tozzi, geologo, saggista e divulgatore scientifico, è primo ricercatore presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Cnr e membro del consiglio scientifico del Wwf.
Come vede l’atteggiamento dei giovani verso il cambiamento climatico?
Le giovani generazioni si sono date molto da fare, a partire dai Fridays for future che da diversi anni sanno catturare l’attenzione molto meglio di quel che, anni fa, sapevamo fare noi. Le nostre manifestazioni più che altro si occupavano di scuola. Oggi si parla, invece, di questioni cruciali per il futuro, per il benessere delle prossime generazioni: ci hanno prestato il mondo e dobbiamo restituirlo in condizioni adeguate. Poi vi sono i ragazzi di Extinction Rebellion che non mi sento affatto di condannare finché non fanno danni. Vedo bene i giovani d’oggi, mi sembrano coerenti e informati, hanno i loro simboli, Greta Thunberg ma anche il Papa. Mi sembra che questo sia positivo.
E nelle piccole azioni quotidiane?
Ci sono anche quelle: i giovani vanno in giro con le biciclette, hanno le borracce riciclabili, cercano di essere un po’ più coerenti di quanto non siamo noi. E poi danno importanza alla scienza e alle sue conclusioni: sulla crisi climatica gli scienziati hanno una sola voce e i giovani sono gli unici ad averlo capito. Gli adulti come noi pensano che gli scienziati abbiano voci diverse, che litighino sul clima, sulle cause del cambiamento climatico: non è vero, pensano tutti che si tratti di un cambiamento globale anomalo e accelerato rispetto al passato che dipende dagli uomini stessi. Loro, i giovani, l’hanno capito benissimo.
Perché chi ha la le leve, la possibilità reale di incidere, non ha la capacità di ascoltarli?
Perché sono in crisi di malafede da ideologia del liberismo. Non vogliono regole al libero mercato, quindi non ascoltano i ragazzi che chiedono invece che sia regolamentato per legge. Non risolvono nulla, sono anzi parte del problema.
L’atteggiamento dei giovani ci autorizza a essere ottimisti sull’evoluzione della situazione?
No, perché a un certo punto i giovani diventano vecchi, e nati incendiari finiscono per morire pompieri. E comunque nessuno ha intenzione di ascoltarli, vengono addirittura repressi: sono state fatte leggi repressive apposta per non fare manifestazioni eclatanti, per non bloccare le strade. Sono stati impauriti e vengono ancora impauriti. Tutto ciò non va affatto nel senso della mitigazione della crisi, ma la aggrava. Non sono ottimista per niente.
Cosa deve succedere perché le azioni di protesta dei giovani possano innescare un cambiamento reale?
Più disastri idrogeologici, più povertà, più migrazioni per ragioni climatiche. Che si aggravi la situazione fino al punto in cui il sapiens non si tiri indietro. Fino ad ora abbiamo minimizzato, fatto finta di niente, pensato che il problema arrivasse domani, che ci sarebbero state soluzioni tecnologiche. I sa-
piens cominciano a muoversi bene solo sull’orlo del baratro: ci sono già, ma non se ne sono accorti.
La tecnologia può avere un ruolo decisivo? No, il problema non si risolve con le tecnologie. Domani ci sarà forse la possibilità di avere qualche strumento tecnologico che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare; può darsi, non lo so. Però quello che conta è l’oggi, e nell’oggi la tecnologia non ci aiuta, anzi. Si raschiano ancora di più i combustibili fossili e si bruciano, si continuano a predisporre pozzi, a fare ricerca che invece dovrebbe essere abbandonata. Per stare al di sotto di un grado e mezzo di aumento della temperatura media dell’atmosfera (sappiamo già che non ci arriveremo) dovremmo lasciare sotto terra il 90% del carbone e il 60% del gas e del petrolio, ma nessuno lo fa. Non dovremmo dare più un euro di sussidio pubblico ai petro-carbonieri, invece gliene diamo sette trilioni di dollari l’anno, negli ultimi quattro anni solo in Italia quattro o cinque miliardi. Non dovremmo cercare più giacimenti né dare sussidi pubblici: queste sono le prime due mosse che uno Stato serio dovrebbe imporre per andare verso la riduzione delle emissioni. Niente più soldi pubblici e niente più trivellazioni.
L’intelligenza artificiale può aiutare oppure peggiora le cose perché consuma molta energia? Sono vere tutte e due le cose: grazie all’AI potremmo fare una simulazione corretta di dove arriverà la prossima inondazione casa per casa, potremmo prevedere meglio l’utilizzo delle risorse. L’intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo, ma non risolutivo: la questione è culturale, non tecnologica, e l’intelligenza artificiale di fatto è ancora tecnologia pura. È dal punto di vista culturale che non abbiamo capito la gravità della situazione. Ci sono addirittura quelli che negano che sia in atto un cambiamento climatico, figuriamoci.
PER APPROFONDIRE suggeriti da Mario Tozzi
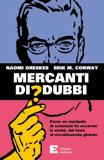
LIBRI
Naomi Oreskes, Erik M. Conway, Mercanti di dubbi: Come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale, Edizioni Ambiente, 2020
FILM
Don’t look up di Adam McKay, 2021
intervista a MARIO CALDERINI
Multinazionali in ritardo nel raggiungimento dei target di decarbonizzazione, calo degli investimenti in fondi Esg: invece di accelerare sul percorso della sostenibilità, così come sarebbe necessario, siamo entrati in una fase di riflusso?
La mia risposta è sì. La regressione c’è ed è anche provata. Basta mettere insieme un po’ di aneddotica. Per esempio: Harley Davidson e Jack Daniels non solo smettono di praticare politiche di diversity & inclusion, ma addirittura ostentano il fatto di non farlo. Nel loro caso potrebbe essere anche un po’ comprensibile, perché sono marchi un po’ legati al “machismo”, ma adesso si sono messi a fare lo stesso Ford e John Deere, grandi manifatturieri americani. E anche in Europa ci sono una serie di segnali tangibili di questa regressione, anche se il fenomeno è ancora molto strisciante.
Quali sono le ragioni di questo riflusso?
Direi fondamentalmente tre. La prima riguarda il fatto che è cambiato l’atteggiamento anche dei consumatori: assistiamo a una coevoluzione tra problema delle imprese e sentiment dei consumatori. Premettendo che io sono totalmente pro azioni anti-climate change, il problema consiste nel racconto che la Commissione europea ha fatto sui temi della sostenibilità. Ha schiacciato tutto su temi verdi, dimenticandosi la transizione sociale e produttiva. Così facendo, ha creato una lacerazione, provocando rabbia e perdita di consenso, e ha regalato al populismo conservatore una tale base elettorale che è ovvio che adesso i consumatori stanno completamente cambiando orientamento. Finora è stata raccontata una sostenibilità prevalentemente verde, spesso molto costosa, spesso dolorosa dal punto di vista di alcune scelte produttive e occupazionali. E i consumatori si sono messi di traverso: hanno ragione loro perché c’è stato un errore di narrazione molto grave.
E le altre due ragioni quali sono?
La seconda fa parte del ciclo di vita di un tema come la sostenibilità: c’è stato il grande innamoramento, la fase facile in cui tutti si compiacevano e abbracciavano la causa. Finché, appunto, nessuno ha presentato il conto. Tanto è vero che la sostenibilità è diventata una commodity, cioè non c’è un’impresa oggi che non si racconti sostenibile. E quindi, da un lato, le imprese hanno cominciato a capire che la sostenibilità, quella facile, quella gratis, non era una fonte di distinzione competitiva e quindi che non era poi così fondamentale. Dall’altro, le aziende si sono rese conto che la sostenibilità vera, soprattutto quella sociale oltre che ambientale, era una faccenda molto complicata e che richiedeva dei rischi aggiuntivi. Richiedeva di prendere in considerazione il fatto che profitto e impatto non sono così sempre perfettamente allineati. È finita un po’ la favoletta che con la sostenibilità si guadagna anche: è vero certe volte, falso molte altre volte. La terza motivazione è che la over regulation della Commissione europea, con la compliance imposta alle imprese, ha fatto un po’ passare la voglia. Oppure, siccome era obbligatoria, tutto si è schiacciato su degli esercizi di compliance e si è perso completamente il senso vero di fare sostenibilità.
E la finanza? Qual è la sua importanza nella transizione?
Questa storia è cominciata molto prima in finanza che nelle corporation. La finanza non è solo un ingranaggio fondamentale della storia, ma è anche quello che può cambiare gli equilibri. Oggi abbiamo 43mila miliardi di dollari investiti in criteri di Esg. Se gli Esg funzionassero forse la finanza sarebbe stata in grado di cambiare il mondo. Ma gli Esg sono criteri molto deboli, e quindi non è detto che così stia succedendo, perché se 43mila miliardi di dollari fossero investiti nella direzione giusta forse molti dei problemi di cui


parliamo sarebbero già risolti. La finanza è fondamentale nella trasformazione perché attraverso le quote di controllo e i consigli di amministrazione impone realmente un certo tipo di scelte alle imprese. Tuttavia, anche la finanza sta facendo i conti con una fase difficile, una regressione segnalata dal calo degli investimenti. La finanza è all’avanguardia, si è data regolamentazioni molto stringenti e ha l’opportunità di cambiare il mondo. Ma purtroppo le metriche sono ancora molto deboli.
A proposito di Stati Uniti e di tema politico, non le pare che Kamala Harris abbia fatto dietrofront su molti dei suoi impegni green?
Sì, almeno dichiaratamente in campagna elettorale, quindi secondo me bisogna darle il beneficio del dubbio. Nell’unico dibattito che c’è stato tra i due candidati, Harris ha fatto delle aperture molto importanti verso l’oil and gas e non ha certamente calcato su temi tipicamente legati al mondo woke. Negli Stati Uniti, molto più che in Europa, c’è questo terrore di sembrare woke (dogmatici e sprezzanti ndr), quindi i politici se ne stanno tenendo molto lontani, anche quelli democratici. Un’altra delle grandi questioni del riflusso è che alcuni Stati americani di matrice conservatrice trumpiana repubblicani stanno denunciando le banche perché sostengono che utilizzino gli Esg come criterio di valutazione per i loro finanziamenti. Anche in questo caso siamo in pienissima fase di riflusso.
Quindi secondo lei che negli Stati Uniti vinca il candidato democratico o che vinca quello repubblicano farà veramente tanta differenza in merito ai temi di cui stiamo parlando oppure no? Continuo a vivere un po’ nell’illusione che la Harris abbia preso certe posizioni in campagna elettorale, ma che poi la sua base di consenso e lei stessa abbiano delle idee leggermente più aperte di quelle di Trump. Quindi penso che farebbe ancora una differenza se vincesse la candidata democratica.
E l’Italia come si pone in questa ondata di riflusso? Abbiamo una grande massa di piccole imprese e tra di loro vedo germi di insoddisfazione e di riflusso molto forti. Le Pmi hanno, a mio parere, soprattutto un grande problema: tra le metriche che regolano oggi la sostenibilità si trovano male, vedono nello specchio un’immagine distorta di sé che non rende giustizia al loro valore. Quindi, oltre a tutto quello che abbiamo detto, c’è anche il fatto che le Pmi, secondo me, nutrono un malcontento nascente rispetto alle metriche con cui vengono misurate. Metriche che, appunto, sono completamente strabiche verso la dimensione ambientale e quasi zero rispetto alla dimensione sociale. Una piccola impresa di una valle del cuneese che in termini di emissioni di CO2 può contribuire in valori assoluti in un modo risibile rispetto a una grande multinazionale e che però lega gran parte del proprio valore al fatto che è la sola presenza economica all’interno di un’intera comunità, non riesce a riflettersi nelle metriche Esg e quindi si sente sottovalutata.

Mario Calderini è professore di Impact and sustainability management presso la School of management del Politecnico di Milano ed è direttore di Tiresia, il centro di ricerca sulla finanza e l’innovazione a impatto sociale della School of management del Politecnico di Milano.
PER APPROFONDIRE suggeriti da

Rebecca Henderson , Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta , Luiss University Press, 2020

Così l’architettura risponde alle sfide del futuro e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico
intervista a CARLO RATTI


Ratti è architetto, urbanista e teorico dell’architettura. Ha fondato e dirige il MIT Senseable City Lab presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), un laboratorio di ricerca che si occupa dell’interazione tra le città, la tecnologia e la società.
Hot Heart, progetto vincitore
della Helsinki Energy Challenge
Un arcipelago di isole-bacini di accumulo del calore, con la duplice funzione di accumulare energia termica e di fungere da centro per le attività ricreative. È il progetto Hot Heart di CRA-Carlo Ratti Associati, vincitore della Helsinki Energy Challenge che mira a decarbonizzare il sistema di riscaldamento della capitale finlandese entro il 2030. Le isole ospiteranno anche foreste tropicali ed ecosistemi provenienti da tutto il mondo. Il sistema funziona come una gigantesca batteria termica: l’energia rinnovabile a basso costo viene convertita in calore, immagazzinata nei serbatoi e prelevata nei canali di distribuzione del calore della città durante l’inverno.
Ci sono città che hanno già investito in architetture o infrastrutture amiche dell’ambiente? Quali esempi virtuosi possiamo citare? Tantissime città stanno lavorando su diversi aspetti per contrastare le emissioni e adattarsi al cambiamento climatico. In Europa, sempre più metropoli stanno adottando le cosiddette “Zone 30”. Le stiamo studiando in merito alla città di Milano grazie a una ricerca per UnipolTech condotta dal nostro laboratorio al MIT di Boston, il Senseable City Lab. Tendenzialmente le emissioni calano, aumenta la sicurezza e i quartieri rivivono tornando in mano alle persone. Grazie alla spinta simbolica del Bosco Verticale di Stefano Boeri, Milano sta lavorando per portare il verde sempre di più nello spazio urbano. Una politica, questa, cui abbiamo contribuito anche noi con lo studio CRA-Carlo Ratti Associati, con il progetto di Porta Romana, dove abbiamo immaginato un nuovo parco pubblico che connette quartieri un tempo divisi dalle ferrovie.
Per contribuire alla lotta al cambiamento climatico come devono cambiare le città?
Non devono cambiare nell’aspetto esteriore, ma nella loro infrastruttura. Con le sfide per il cambiamento globale alle porte, le parole d’ordine per il futuro delle città sono due: rispondere e mitigare. Abbiamo bisogno di interventi di ristrutturazione là dove i nostri edifici sono in grado di rispondere ai cambiamenti climatici e di mitigarne gli effetti. Faccio riferimento a due esempi entrambi realizzati dal mio studio CRA-Carlo Ratti Associati. Il primo è l’architettura cinetica immaginata per gli spazi lungo il Po, a Torino, che si alza e si abbassa assecondando il livello dell’acqua del fiume. Il secondo è l’utilizzo dei materiali, anche non nuovi, in ottica circolare per ottenere nuove soluzioni: per il padiglione Italia a Expo Dubai 2020, abbiamo realizzato una serie di corde in plastica riciclata che climatizzavano l’ambiente senza l’uso di aria condizionata.
C’è compatibilità tra la direzione obbligata dall’urgenza climatica e l’evoluzione già in corso dell’urbanistica?
Questo è il tema cruciale che affronteremo con la Biennale Architettura 2025 (di cui Ratti è curatore, ndr). Una mostra che sarà dedicata all’ambiente costruito e alle numerose discipline che gli danno forma. L’architettura è al centro di esse, ma non è la sola. Essa fa parte di una compagine estesa che deve integrare arte, ingegneria, biologia, scienza dei dati, scienze sociali e politiche, scienze planetarie e altre discipline, collegando ciascuna di esse alla materialità dello spazio urbano. Il titolo che abbiamo individuato, Intelligens, vuole mettere in dialogo i tre grandi filoni dell’architettura contemporanea – quello dedicato al rapporto con la natura, quello dedicato al rapporto con le nuove tecnologie e quello dedicato alla comunità – integrandoli, facendo sintesi e cercando soluzioni alle sfide che stiamo affrontando. Partendo, ovviamente, da quella climatica.
Ci sono progetti in fase di realizzazione che costituiscono un punto di riferimento, inclusi quelli realizzati dal suo studio?
I progetti che realizziamo con CRA si muovono tutti nell’idea di unire l’artificiale con il naturale. La nostra volontà è trovare sempre soluzioni innovative per rispondere ai problemi del mondo attuale. Ad esempio, crediamo sia fondamentale riflettere sulla decarbonizzazione delle città. È nostra l’idea di Hot Heart, il più grande progetto di superamento di questa fonte energetica altamente inquinante su scala europea. Il progetto consta di isole artificiali ancorate al largo del bacino di Helsinki in cui verrà immagazzinata acqua calda per la rete di teleriscaldamento. L’acqua che rimane nelle isole geotermiche, inoltre, permetterà la creazione di nuovi spazi pubblici. Ideando la torre Jian Mu per la megalopoli cinese di Shenzhen, abbiamo puntato, invece, sulle colture idroponiche che, se sviluppate in verticale sulle facciate dei grattacieli, possono garantire il fabbisogno dei propri abitanti.
Per quanto riguarda i materiali, invece, e so di trovare qui un terreno fertile, stiamo lavorando molto sul legno. Con la nostra nuova start-up, Maestro Technologies, cerchiamo di integrare le innovazioni della progettazione insieme alle intelligenze artificiali per ridurre al minimo gli scarti del legno, ottimizzando risorse in ottica circolare.
PER APPROFONDIRE
suggeriti da Carlo Ratti

2014
A Life on Our Planet di David Attenborough, 2020

Emanuele Frontoni professore ordinario di informatica all’Università di Macerata e co-direttore del VRAI (Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab) del Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università politecnica delle Marche
Definiamo intelligenza eco-artificiale tutto quel che possiamo fare in una visione di collaborazione tra essere umano e AI per affrontare le complesse sfide che la sostenibilità ambientale ci pone davanti. Tra i nostri studenti questo è un settore in primissimo piano per percezione e per urgenza di intervento, con grandi squilibri territoriali su scala globale. È anche il settore dove abbiamo tutti l’impressione di poter fare molto meglio: pensiamo soprattutto agli sprechi causati dalle manutenzioni delle reti idriche e a quelli legati ai nostri comportamenti come utenti.
Abbiamo di recente lavorato a due progetti digitali proprio nell’ambito dell’acqua. Il primo è un progetto europeo che coinvolge numerose scuole in Italia, Francia e Spagna. Per l’occasione abbiamo utilizzato veri e propri giochi, detti serious games, che stimolano i nostri giovani a un consumo più consapevole di questa importante risorsa naturale. Il secondo è, invece, un progetto che fa uso di metodi di intelligenza artificiale e ha lo scopo di supportare l’uomo nell’analisi automatica di anomalie nei consumi. In questo caso, lavoriamo su grandi quantità di dati geolocalizzati che ci permettono, ad esempio, di individuare acquedotti che necessitano di una manutenzione e inconsistenze di dati che potrebbero significare perdite.
L’altro ambito su cui stiamo lavorando intensamente è quello della sostenibilità dell’agricoltura, campo di applicazione per tante tecnologie della robotica e della visione artificiale. Da anni ci capita di vedere droni sorvolare i nostri campi o di conoscere agricoltori sempre più abituati a utilizzare immagini satellitari. Le immagini raccolte hanno sempre più spesso un contenuto detto iperspettrale. Sono cioè capaci di vedere oltre il visibile e di catturare molte più informazioni rispetto all’occhio umano. Con questi preziosi dati e con tante competenze interdisciplinari possiamo addestrare algoritmi di AI capaci di misurare il bisogno d’acqua del suolo con eccellente accuratezza. In gergo tecnico viene chiamato water stress: è la base con cui si ottimizzano i sistemi di

irrigazione automatica. Possiamo risparmiare fino al 30% dell’acqua usata in agricoltura, rendendo sostenibili molte coltivazioni che con l’innalzamento delle temperature faticano ad esserlo.
Le applicazioni italiane di intelligenza eco-artificiale, su scala nazionale e internazionale, sono numerosissime. È possibile, per esempio, prevedere il fabbisogno di acqua di un territorio e regolare la portata di sorgenti e reti idriche. Questo metodo predittivo basato sull’AI permette di ottimizzare il modo con cui attingiamo ai singoli pozzi di quelle sorgenti, capire e modellare meglio le relazioni tra pioggia e neve caduti in inverno e quantità di acqua che potremo utilizzare nei periodi di siccità, per avviare tutte le misure preventive che scongiurino blocchi di fornitura.
Ancora, a difesa delle popolazioni colpite da dissesto idrogeologico, l’intelligenza artificiale può agevolare gli allarmi preventivi quando un torrente sale di livello troppo velocemente, grazie all’installazione di reti di sensori di portata e pluviometri.
L’ultimo settore di interesse è quello dell’influenza dei comportamenti di noi utenti. I comportamenti collettivi sono preziose fonti per i nostri big data. Essendo umani siamo, per fortuna, influenzabili. L’intelligenza artificiale applicata alle reti sociali da una parte ci aiuterà a comprendere e conoscere opinioni, problemi e risultati di campagne di sensibilizzazione con una grande accuratezza. D’altro canto, l’utilizzo non etico di questi dati inerenti a comportamenti collettivi potrebbe influenzare in maniera non de-

mocratica scelte e opinioni. Sta a noi continuare ad educare i nostri giovani verso una consapevolezza rispetto all’AI e all’importanza di mantenere un pensiero critico. Ne va della sostenibilità ambientale e, in ultima analisi, del futuro del nostro pianeta.
L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente anche l’intera filiera dell’industria dell’arredamento, comportando delle innovazioni rivoluzionarie che vanno dalla gestione delle foreste fino al riciclo dei mobili a fine vita e ai sistemi di supporto al design di prodotto, con un particolare interesse per le cosiddette collezioni digital native Questo cambiamento epocale promette di rendere il settore più efficiente, sostenibile e orientato al cliente. Il viaggio di un mobile inizia nelle foreste, dove l’AI sta già lasciando il suo segno. Sofisticati algoritmi analizzano immagini satellitari e dati raccolti dai droni per monitorare la salute degli ecosistemi boschivi e ottimizzare la gestione sostenibile delle risorse. I modelli di AI possono prevedere con precisione la crescita degli alberi e la resa del legname, permettendo di pianificare tagli sostenibili con anni di anticipo.
Nella fase di raccolta e lavorazione del legno, l’AI gioca un ruolo cruciale nell’ottimizzazione. Sistemi di visione artificiale esaminano ogni tronco, determinando il miglior schema di taglio per massimizzare l’utilizzo e minimizzare gli scarti. Le tecnologie
AI hanno dimostrato di poter ridurre gli sprechi di legno in modo significativo, con percentuali che in alcuni casi superano il 20%.
Il design e la progettazione dei mobili sono forse gli ambiti dove l’impatto dell’AI è più evidente. La AI generativa sta rivoluzionando il processo creativo, creando infinite varianti di design che ottimizzano forma, funzione e sostenibilità. Le piattaforme di GenAI possono supportare i designer nel creare interi cataloghi di mobili in poche ore, tutti adattati alle ultime tendenze di mercato e ai principi di eco-design. Gli algoritmi di machine learning e i modelli di GenAI analizzano enormi quantità di dati su materiali ecologici, processi produttivi efficienti, tendenze di mercato e preferenze dei consumatori per generare concept innovativi che sarebbero difficilmente realizzabili con i metodi tradizionali. Alcune aziende del settore stanno iniziando ad esplorare le potenzialità della GenAI per creare collezioni innovative, esteticamente accattivanti e a basso impatto ambientale, note come digital native. L’obiettivo è di ridurre al minimo la necessità di campionature ed esposizioni fisiche, prediligendo i percorsi espositivi completamente digitali. Queste collezioni rappresentano un nuovo paradigma nel design sostenibile. L’uso dell’AI in queste fasi di progettazione arriva fino al cosiddetto design generativo. Creativi e sistemi di GenAI – ricordiamo sempre che questi sistemi non sono creativi: questo prezioso compito resta una peculiarità dell’essere umano! – collaborano tra loro nelle fasi di ideazione e di creazione di tutti i modelli digitali, rendendo più efficienti la modellazione 3D e le renderizzazioni e personalizzazioni. Tutto finisce in canali online e app alla ricerca della conferma dell’apprezzamento del mercato. Solo dopo aver raccolto dei dati significativi si passa alla produzione.
Nella produzione, robot guidati dall’AI eseguono compiti complessi di assemblaggio con precisione millimetrica, mentre algoritmi di ottimizzazione analizzano costantemente i dati di fabbrica per migliorare l’efficienza. In molte aziende, l’implementazione dell’AI ha portato ad aumenti di produttività superiori al 30% e ad una riduzione significativa degli errori di produzione. La rivoluzione dell’AI si estende anche alla logistica e alla distribuzione. Sistemi intelligenti pianificano le rotte di consegna più efficienti, riducendo le emissioni di CO2, mentre modelli predittivi anticipano le tendenze di mercato, permettendo una gestione ottimale delle scorte. Nel retail, app di realtà aumentata basate su AI consentono ai clienti di visualizzare i mobili nel proprio spazio prima dell’acquisto, rivoluzionando l’esperienza d’acquisto.
L’AI sta trasformando anche la fase di fine vita dei mobili. Algoritmi avanzati analizzano la composizione dei prodotti per determinare il miglior metodo di riciclo, mentre la GenAI viene utilizzata per creare design che facilitano lo smontaggio e il recupero dei materiali.

FILM
Her di Spike Jonze, 2013
PODCAST
2024 – Speciale
Intelligenza Artificiale di Enrico Pagliarini
Monsignor Paglia, ci racconta come ha avuto origine il documento Rome Call for A.I. Ethics con cui la Pontificia Accademia per la Vita che lei guida, insieme a FAO, IBM, Microsoft e al Ministero dell’Innovazione, vuole promuovere un approccio etico all’utilizzo dell’intelligenza artificiale?
Tutto nasce da un incontro con il nuovo presidente della Microsoft Brad Smith dopo che Bill Gates aveva lasciato. Ricevo una telefonata nel settembre del 2019 con la quale mi chiede se ho un po’ di tempo per parlare con lui visto che veniva in Europa, prima in Germania e poi a Roma. Risposi: “Volentieri”. Ero incuriosito in verità dall’insistenza – ci furono due o tre telefonate – del presidente di un’azienda che già allora aveva un nome particolarmente significativo. Rimasi sorpreso anche dalla richiesta che mi venne a fare. Esordì così: “Sono venuto da Lei non per chiederle di fare un convegno, un’iniziativa pubblica, ma per chiedere se Lei è disposto a coinvolgerci nei temi profondi che riguardano l’intelligenza artificiale”.
Come spiegò questa richiesta?
Mi disse: “Nel nostro centro a Seattle siamo cinquantamila ingegneri, tutti e solo ingegneri. Ogni settimana per restare sul mercato siamo costretti a creare qualcosa di nuovo, altrimenti veniamo spazzati via. Possiamo fare cose straordinarie: ad esempio, ideare delle strumentazioni per far sentire i sordi e vedere i ciechi. Così, per divertimento. Allo stesso tempo, possiamo creare dei mostri. Il problema che io sento e che mi angoscia è che noi, tutti ingegneri e solo ingegneri, non riusciamo a capire il limite tra l’uomo e la macchina. Per questo vengo da lei: tutto questo richiede la presenza di un’istituzione etica autorevolissima come la chiesa cattolica che ci accompagni, ci avverta, ci metta sull’avviso”.
Lei come reagì?
Rimasi non poco sorpreso della richiesta: man mano che andava avanti il suo ragionamento sentivo sempre più la valenza, la gravità del problema. Erano i mesi in cui c’erano le manifestazioni a Hong Kong. Mi disse: “Tutti i manifestanti con il riconoscimento facciale vengono schedati, chi possiede i dati può fare di loro quel che vuole. Qual è il problema? Microsoft è un ente privato. A noi Trump ha chiesto dei dati della gente, ma noi non glieli abbiamo concessi, perché

siamo noi i detentori, i proprietari. Huawei, invece, è di proprietà del governo cinese. Se volesse bloccarli basterebbe bloccare le loro carte di credito e sono finiti. Ecco perché è urgente un impegno internazionale che permetta uno sviluppo regolato, altrimenti i conflitti tra queste grandi agenzie possono essere analoghi a quelli dei conflitti nucleari”. Gli risposi: “Resto sorpreso, più che preoccupato, da quel che mi sta dicendo, intuisco che se non si va, per fare un parallelo climatico, verso una simil Parigi, cioè una Roma delle nuove tecnologie, il rischio di conflitti seri indubbiamente è possibile”.
Così vi metteste in moto? Proprio così. Da lì partì questa nostra collaborazione che produsse dopo mesi di lavoro un manifesto che coglieva l’aspetto etico, educativo e giuridico relativo alle nuove tecnologie, in particolare l’AI. Lo concordammo con altri perché l’AI può dare un aiuto notevole per prevedere e prevenire i problemi. Coinvolgemmo l’IBM, la FAO con cui eravamo in contatto per le questioni del clima e quelle alimentari.

Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo cattolico italiano, è presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II.
Quando firmammo il manifesto il 28 febbraio, l’ultimo giorno prima del Covid, c’era ancora il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Poi fummo travolti dalla pandemia, ma continuammo. Dopo la pandemia abbiamo pensato che il testo dovesse essere ampliato con l’appoggio di Papa Francesco e che dovesse provocare un movimento etico mondiale come reazione a queste recenti tecnologie che sono diventate una specie di nuova religione della modernità.
In che direzione vi siete mossi?
Abbiamo sollecitato altre agenzie come Cisco, Amazon che l’ha richiesto, le università e anche le religioni: lo scorso luglio tutte le religioni del mondo – cattolici, ebrei, musulmani, buddisti, scintoisti – hanno firmato la Rome Call. Poi Papa Francesco durante il G7, con un’intuizione come al solito lungimirante, ne ha parlato finalmente anche alla politica, che non dico sia la più interessata ma senz’altro tra le più interessate, perché la sua assenza significa dare potere alle agenzie tecnologiche. Finalmente la politica ha preso consapevolezza dell’importanza di questo nuovo orizzonte tecnologico. Mi auguro si continui nei diversi ambiti a far crescere questa consapevolezza morale e si arrivi anche a regole giuridiche. Debbo dire che questa volta la Chiesa, non per merito mio ma degli stessi responsabili, è tra le prime che in qualche modo si è interessata e ha cercato di proporre una regola a questo nuovo strumento. Che deve restare uno strumento: questo è il punto.
Quali sono i rischi che corriamo, di cui parla anche nel suo libro da poco pubblicato L’algoritmo della vita?
Già il termine intelligenza è ambiguo: l’intelligenza suppone il cervello, il corpo, le emozioni, una gradazione infinita che uno strumento non può avere. Ecco perché allora la prima grande lezione da trarre dev’essere universale: non possiamo affidare l’esistenza umana solo alla tecnologia. Anche perché questa tecnica è invasiva e pervasiva e ha una potenzialità enorme. Guai all’abdicazione del potere da parte dell’uomo. In questo risiede la grande sfida che abbiamo davanti e che coinvolge, come ho scritto nel libro, tutti gli ambiti della vita. Quello educativo, quello sanitario, il lavoro, la democrazia, la comunicazione e non per ultimo il tema dello spazio che oggi è quello che un tempo fu la Cina per Marco Polo e gli Stati Uniti per Colombo. Fa riflettere la notizia che oggi un privato, Elon Musk, possa lanciare missili e astronauti. Di chi è lo spazio? Sappiamo quanto sia delicata l’occupazione dello spazio. Vi è il rischio che termini la romantica logistica spaziale dove vediamo americani, cinesi, russi e italiani insieme. Rischiamo che lo spazio diventi un possesso delle singole nazioni, con un potere sulla Terra ben più largo e profondo di quel che abbiamo oggi con i soli missili e con i droni, e vediamo quel che già succede.
Come affrontare una simile sfida? Devono crescere la consapevolezza, la strumentazione
educativa, giuridica, etica. Il problema che vedo è che di fronte alla velocità della tecnologia – neppure immaginiamo quello che saremo fra cinque anni – purtroppo non è altrettanto veloce la consapevolezza e lo sviluppo umanistico, giuridico, gestionale. La tecnica corre troppo rispetto alla nostra capacità di gestione: questo è un problema enorme che va affrontato anche perché i benefici sono enormi. Pensi a quei giovani scienziati che per divertimento lavorano a strumenti per far vedere i ciechi: per un non vedente altro che divertimento, gli cambierebbe la vita. Per questo ribadisco che abbiamo urgenza di un arricchimento di patrimonio etico. Tre anni fa Brad Smith mi disse che stavano lavorando su una nuova tecnologia che avrebbe ulteriormente rivoluzionato questa strumentazione. L’anno scorso mi confessa: “Ci siamo arrivati sette anni prima, era Chat Gpt. Abbiamo Chat Gpt ma non abbiamo la strumentazione per combattere le fake news”. Ecco perché il tema è particolarmente urgente, il mio libro vuole essere un piccolo contributo. Ma vorrei evitare un equivoco: la tecnica è una creatura dell’uomo e fa parte delle sue potenzialità. Per me è benvenuta, guai ad averne paura. Il problema vero è governarla, avere la saggezza di poterla mettere al servizio dell’uomo e non, al contrario, che l’uomo ne sia asservito.
L’intelligenza artificiale può aiutare nella lotta ai cambiamenti climatici oppure peggiorare la situazione visto che è molto energivora?
I suoi consumi energetici in effetti sono enormi. Torno al discorso generale che facevo a proposito dello sviluppo e quindi della capacità di governo delle realtà. Riguarda anche il clima, ma non solo: scendiamo un po’ più in basso e prendiamo le guerre. Non riusciamo a terminarle, dipendono solo da noi, non c’è chissà quale altro spirito o forza in gioco. Secondo me c’è un indebolimento pericoloso del pensiero umanista e politico, per parte mia anche spirituale: c’è troppo individualismo ed egocentrismo. Ci manca una visione, quella che Papa Francesco a mio avviso ci ha in qualche modo delineato con la Laudato sì e Fratelli tutti. Detta in termini semplificati: abbiamo una sola casa, questa, e tutti ne siamo abitanti, tutti i popoli che la abitano. Dobbiamo vivere in pace tra diversi custodendola. Questa è l’abilità della politica, l’abilità della creatività, l’abilità dell’etica, imparare a convivere tra diversi rispettandosi e rispettando. Questo richiede un nuovo Umanesimo che chiamerei planetario. Siamo tutti responsabili della nostra convivenza e del nostro rapporto con la natura – forse questa seconda parte non è stata così presente. Questo è un riequilibrio da promuovere. Non è semplice ovviamente, però è la sfida da affrontare. Io ero ragazzo quando nel 1968 Marshall McLuhan diceva che il mondo è un villaggio globale, un villaggio che è nelle nostre mani non chissà dove... Per questo, secondo me, una coscienza più universale è indispensabile, il peccato originale è l’individualismo. Se lo dovessi dire in termini psichiatrico-religiosi, purtroppo l’unico santo oggi venerato è San Narciso.
PER APPROFONDIRE suggeriti

Vincenzo Paglia, L’algoritmo della vita, Piemme, 2024
Luciano Floridi, Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide, Raffaello Cortina Editore, 2022
chiari di ANTONIO PASCALE

Antonio Pascale, giornalista e scrittore, vive a Roma, scrive per il teatro e la radio, collabora con Il Mattino, Il Post, Lo straniero e Limes
Se la domanda è: visto il cambiamento climatico di origine antropica, causato dalla continua emissione di CO2 e derivati, sostanze altrimenti dette climalteranti e che ad oggi hanno toccato la punta di 400 ppm (in epoca preindustriale la quantità era pari a 287 ppm); considerato che l’aumento della temperatura (a quanto pare diffusa ma non esponenziale) causerà problemi di ogni sorta al pianeta, vuoi tu lottare per abbassare le suddette emissioni, impegnandoti con un’efficace logistica a portare avanti il programma?
A questa domanda (che come quelle di alcuni referendum non è scevra di complessità), la maggior parte di noi per fortuna risponde: sì, certamente! Nella sostanza la maggior parte di noi concorda con gli obiettivi, i problemi nascono quando ci confrontiamo con gli strumenti da usare per raggiungere l’obiettivo. È in questa fase che cominciano le discussioni, le litigate. Siamo tutti amici e fratelli e compagni di lotta quando parliamo di obiettivi, siamo quasi nemici quando ci confrontiamo sull’utilità o meno di alcuni strumenti per raggiungere l’obiettivo: viviamo in un paradosso. Le litigate più feroci, insensate, sfiancate sono quelle che quotidianamente si portano avanti con gli ecologisti – per non generalizzare, qui rubrichiamoli sotto la voce eco conservatori. Il movimento ecologista che da anni concentra giustamente la sua attenzione sulla qualità dell’ambiente, convinto che se miglioriamo l’ambiente miglioriamo anche noi (tesi su cui si può concordare) presenta tuttavia imbarazzanti punte di scetticismo verso la logica. Ci sono gli scettici del cambiamento climatico e gli scettici della razionalità, questi ultimi sono gli ecologisti conservatori. Gli ecologisti con-


servatori da decenni portano avanti le proprie campagne sotto la bandiera della retorica dell’apocalisse, ossia la convinzione che mancano (simbolicamente) poche ore alla fine del mondo, è già troppo tardi e che soprattutto il problema siamo noi, noi sapiens, ecc. Campagne siffatte ripetute da decenni agitano gli animi di tutti e in genere ottengono tre effetti, diversi ma uguali.
Il primo, a forza di metterci paura smettiamo di ragionare. Del resto, è un noto meccanismo di difesa, quando avvertiamo un pericolo, alcuni di noi si immobilizzano, così è per la retorica dell’apocalisse: se è imminente la fine del mondo, se non c’è niente che posso fare, allora non posso fare altro (scusate il bisticcio) che star fermo e sperare che il pericolo passi. Secondo effetto correlato al primo: visto che domani muoio, oggi me la godo, mi vado a divertire, spendo e spando. Terzo effetto: a forza di blocchi stradali, monumenti imbrattati, annunci clamorosi di apocalisse per l’indomani, a forza di stress (per i blocchi stradali), di nervosismo e di ansia, a forza di ripetere che il problema siamo noi, manifestando così facendo una totale sfiducia nell’essere umano, molti di noi diventano scettici, cioè pensano che se si grida al lupo al lupo, ma il lupo non arriva allora il problema non esiste. Se fate la somma dei tre effetti e tracciate la mediana potrete osservare il suddetto scetticismo verso la razionalità: chi ha paura ed è vittima di emozioni forti e correlate con l’ansia, poi ha più difficoltà a ragionare caso per caso, elencare le priorità, accettare l’inevitabile, studiare tanto e prepararsi razionalmente per evitare il peggio. A sua volta, chi si va a divertire si concentra sul qui e ora e non ha tempo di pensare al domani. Infine chi si dichiara scettico sottovaluta il range di problemi che abbiamo davanti.
Insomma, sotto stress non abbiamo desiderio di valutare l’efficacia o meno di uno strumento e tendiamo a offrire soluzioni lampo a suon di slogan. Giusto per fare un esempio, Net Zero 2050 con rinnovabili a tutto spiano. È chiaro che un programma simile, zero emissioni, necessita di un discorso serio: abbiamo la logistica, gli investimenti, la competenza, le persone, riusciamo a far parlare discipline diverse per mettere in comune le esperienze? Qual è la risposta? Facciamoci un bagno di realtà, cioè nei dati: nel 1997 la quota di energia totale derivata dai fossili si attestava all’86% e nel 2022 si è fermata a un sorprendente 82% (il rimanente è il risultato dell’idroelettrico, del nucleare e una minima parte del solare ed eolico). Questa è purtroppo la risposta. A parte che di fronte a questi dati viene da sottolineare la contraddizione che dobbiamo saper affrontare: la nostra ricchezza, il nostro benessere, la qualità della vita sono tutte basati su carbone, petrolio e gas (sono economici e con poco volume producono molta energia). Ovvio che non possiamo continuare a usare i fossili, a parte il cambiamento climatico, è insensato scavare miniere e consumare risorse (ogni anno estraiamo dieci miliardi di tonnellate di carbone), risorse che poi vanno lavorate con costosi processi industriali (pensate
PER APPROFONDIRE suggeriti da Antonio Pascale
LIBRI
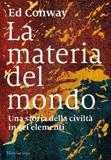
Ed Conqay, La materia del mondo, una storia del mondo in sei elementi, Marsilio, 2023
Vaclav Smil, I numeri non mentono, Einaudi, 2021
FILM
Stalker di Andrey Tarkosvkij, 1979
solo a che significa raffinare il petrolio). Tuttavia, se dopo venticinque anni di slogan, campagne elettorali, blocchi stradali, opere d’arte insudiciate, rabbie e frustrazioni, ansie da fine del mondo, soldi spesi per incentivare fonti alternative, se insomma dopo venticinque anni la quota di energia ricavata dai fossili è scesa di un misero 4%, allora viene il dubbio che le percentuali da raggiungere siano state estratte col lotto. Voglio dire, se ci si avventura nel dichiarare che tra ventiquattro anni, ovvero nel 2050 dobbiamo arrivare a zero emissioni, allora abbiamo un doppio problema: stiamo andando avanti per slogan, senza fare seriamente i conti sullo stato dell’arte, senza analizzare con serietà il funzionamento del mondo, ovvero come (con che materia) otteniamo la necessaria energia per vivere, contestare, fare blocchi stradali ecc. E abbiamo un problema soprattutto perché in un’ottica emotiva, e non razionale, proponiamo di utilizzare solo quegli strumenti che, diciamo così, fanno simpatia e apparentemente sembrano gratis, e ne disprezziamo altri che sono meno emotivi ma tuttavia potrebbero (logicamente) aiutarci ad abbassare le emissioni. La sensazione insomma è questa: stiamo abbassando l’asticella così ci sembra facile superarla e se i dati ci dicono il contrario allora peggio per i dati. Forse sarebbe meglio porci obiettivi realistici, sarebbe meglio usare la logica e la razionalità, integrare gli strumenti e studiare tantissimo. L’incompetenza è il peggior inquinante, non solo in campo ambientale. Diciamo che è il combustibile fossile che accende retorica dell’apocalisse, quella che promuove ansia, nervosismo, emotività e allontana la razionalità e l’analisi e insomma promuove quel circolo vizioso in cui siamo caduti.
Il mercato dei rifiuti fa i conti con nuove responsabilità per le multiutility e necessità di investire sugli impianti per il riciclo
intervista a FILIPPO BRANDOLINI

Filippo Brandolini è presidente di Utilitalia, la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas in Italia. Dal 2009 è presidente di Herambiente Spa.
Come vede il mercato dei rifiuti nei prossimi anni alla luce delle nuove normative?
Abbiamo una serie di indirizzi normativi a livello europeo molto chiari e netti. L’accento è posto sul riuso più di quanto non sia stato fatto in passato, e solo successivamente sul riciclo. Il mercato cambierà perché l’impianto normativo prevede un forte ruolo dei sistemi EPR (Extended Producer Responsibility) chiamati ad assumersi sempre maggiori responsabilità anche riguardo al fine vita dei materiali. Vi sarà un maggiore impulso verso l’ecodesign con un’attenzione particolare per riuso e riciclo. Nel mercato dei rifiuti vediamo la necessità di potenziare il sistema impiantistico per il riciclo, anche per tipologie di rifiuti che hanno volumi meno importanti e che finora non sono stati intercettati perché meno significativi. È importante sottolineare che, mentre per il riciclo si è lavorato molto sugli imballaggi, è evidente che bisogna ampliare la visione ai materiali. Questo è necessario per rispettare normative che hanno scadenze e target entro poco più di dieci anni e più in generale per affermare l’approccio circolare.
crescenti investimenti proprio sugli impianti. C’è stata una forte crescita nel riciclo dei rifiuti organici, anche per effetto delle normative che impongono la raccolta differenziata. Questo sviluppo non riguarda solo le utility, ma anche altri soggetti che operano in altre filiere di rifiuti come vetro, plastica e metalli.
Quali sono gli scenari futuri del mercato italiano dei rifiuti tra urbani e speciali-industriali?
Sarà importante per le utility instaurare partnership e collaborazioni commerciali con il mondo dei produttori. Inoltre, nell’ottica dell’economia circolare, è presumibile che non si gestiranno solo i rifiuti urbani, ma anche i servizi per le imprese, con la prospettiva di supportarle per ridurre i loro impatti, valorizzando i rifiuti per riciclarne la materia e trarne valore. Ci sono ampi margini di manovra per le utility, che devono andare oltre la semplice presenza territoriale. Questo approccio è particolarmente importante per quelle aziende che vogliono svilupparsi e non limitarsi alla mera raccolta, che è un’attività labour-intensive. Negli ultimi anni, molte aziende sono cresciute acquisendo impianti da soggetti privati, confermando la necessità e l’opportunità di industrializzare il settore dei rifiuti, andando oltre la distinzione tra rifiuti urbani e speciali che spesso hanno caratteristiche fisico-chimiche simili.
Qual è l’importanza della gestione dei rifiuti?

Come evolverà il ruolo delle multiutility? Il ruolo delle multiutility, così come delle monoutility, resta innanzitutto quello di gestire il ciclo dei rifiuti, governando i cambiamenti. Le imprese che rappresentiamo hanno una presenza storicamente consolidata e articolata nel mondo della raccolta che negli ultimi vent’anni si è evoluto molto, dal punto di vista sia organizzativo che tecnologico. Un ruolo fondamentale sarà svolto dalle tecnologie digitali, sia per ottimizzare i sistemi di raccolta sia per rendere il sistema più efficiente. Questo nella prospettiva di misurare la quantità di rifiuti prodotti da ogni singolo cittadino o impresa. Già ora abbiamo numerose esperienze positive in questo senso e riteniamo che ce ne saranno altre, considerando che le innovazioni sono utili anche a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. È evidente che nel nostro mondo, presente nell’impiantistica di termovalorizzatori, discariche, riciclo ci saranno necessità e opportunità con
È un comparto strategico per il sistema Paese, non al pari dell’energia in termini di sicurezza, ma comunque importante per favorire la competitività dell’Italia nel mercato europeo e mondiale. È parte integrante del sistema produttivo: garantire servizi di qualità che minimizzano i costi significa favorire la competitività. È quindi importante che il settore si sviluppi garantendo l’autosufficienza per non dipendere dall’estero, come accade ora per molti tipi di rifiuti. Riciclare significa ottenere materie prime seconde, indispensabili per la manifattura. L’Italia è un paese povero di materie prime, che ha tratto beneficio dal riciclo e che è importatore di rifiuti, specialmente metalli, plastica e legno. Questa riflessione è particolarmente strategica, come dimostrato dal PNRR che ha sottolineato la necessità e l’opportunità di potenziare il riciclo, specialmente dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per disporre di materie prime seconde, anche critiche.
La campagna per l’introduzione del deposito cauzionale per gli imballaggi monouso intervista a SILVIA RICCI

Silvia Ricci è coordinatrice della campagna “A Buon Rendere”. Collabora con l’Associazione comuni virtuosi nella realizzazione di iniziative e progetti ambientali attinenti alla prevenzione dei rifiuti. www.buonrendere.it
PER APPROFONDIRE suggeriti da Silvia Ricci

Pietro Lacasella, Luigi Torreggiani, Sottocorteccia. Un viaggio tra i boschi che cambiano, People Storie, 2024
Danilo Selvaggi, Rachel dei pettirossi, Pandion Edizioni, 2022
FILM
Kiss the ground
di Joshua Tickell
e Rebecca Harrell, 2020
Una campagna nazionale per l’introduzione di un sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso per bevande. Si chiama A Buon Rendere – molto più di un vuoto ed è stata lanciata dall’Associazione comuni virtuosi insieme alle organizzazioni partner. “Ogni anno in Italia oltre sette miliardi di contenitori per bevande sfuggono al riciclo per venire dispersi nell’ambiente o smaltiti con i rifiuti indifferenziati” dice Silvia Ricci, coordinatrice della campagna. “I mari, le spiagge, i sentieri di montagna, i parchi delle città, i siti archeologici italiani sono deturpati da bottiglie e lattine abbandonate incautamente. Questo non rappresenta solo un ingente danno ambientale, bensì un rischio concreto per la nostra salute, per l’incolumità degli animali e un danno per le comunità e l’industria del turismo”.
“Abbiamo bisogno di un sistema di deposito cauzionale in primis per raggiungere gli obiettivi della direttiva SUP (Single use plastic): raccogliere nove bottiglie su dieci. Attualmente una parte dei rifiuti finisce nell’ambiente, una parte finisce nei cestini stradali. Molte persone credono che dai cestini avvenga una cernita, ma non è così: i rifiuti finiscono nei termovalorizzatori. Oppure vengono spediti all’estero.
Il deposito cauzionale è un sistema che funziona: lo abbiamo visto coi nostri occhi in Slovacchia dove in due anni hanno raggiunto il 92% e andranno a salire. Avessimo un sistema del genere, andremmo a risparmiare ogni anno circa 110 milioni di euro di Plastic tax (riferite alle sole bottiglie in PET) degli oltre 800 milioni che l’ltalia paga all’Europa per metà circa degli imballaggi in plastica che non ricicla”. Il deposito cauzionale permette di recuperare le bottiglie per un riciclo di qualità bottle to bottle adatto al contatto alimentare. “Solamente il riciclo bottle to bottle permette di ridurre il consumo di PET vergine nel settore delle bevande. Oggi è residuale in quanto il PET raccolto insieme ad altri imballaggi che possono avere contenuto sostanze chimiche tossiche non può essere utilizzato per imballaggi ad uso alimentare. Le bottiglie raccolte finiscono quindi per alimentare il settore
tessile e dell’automotive in un processo chiamato di downcycling. Non esiste un esempio al mondo in cui si sia raggiunto l’obiettivo del 90% di intercettazione senza l’adozione di un sistema di deposito cauzionale: paesi come Germania e Norvegia sono riusciti a raggiungere il 98% di raccolta per gli imballaggi che vi sono soggetti. Anche se viene spesso citata la Svizzera da coloro che si oppongono al sistema di deposito cauzionale, il tasso di raccolta raggiunto nel 2023 per le bottiglie in PET è arrivato all’ 83% e lì si ferma. Pensare però che gli italiani possano di colpo comportarsi come gli svizzeri la trovo una possibilità piuttosto remota”.
La previsione di un sistema cauzionale è contenuta nell’articolo 44 della proposta di “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (Packaging and packaging waste regulation, PPWR) che ne stabilisce l’introduzione obbligatoria entro il 2029 (per bottiglie in plastica e contenitori in metallo per liquidi alimentari fino a tre litri con l’esclusione di contenitori per latte e derivati, vino ed alcolici) per i paesi membri che non avranno raggiunto il 90% di raccolta, non solo per le bottiglie di plastica ma anche per le lattine.
Tutti i sistemi cauzionali in Europa, oggi presenti in sedici Paesi e presto in diciotto, funzionano in questo modo: i produttori di bevande si associano ai rivenditori e formano un ente senza scopo di lucro, incaricato della gestione del sistema. Questo ente gestisce tutto il processo, con il supporto della grande distribuzione organizzata (GDO), che si occupa della raccolta degli imballaggi presso i rivenditori. Il sistema più efficace in Europa è quello in cui i consumatori riportano gli imballaggi direttamente al supermercato, utilizzando macchine automatiche (reverse vending machines). In pochi secondi, la macchina calcola l’importo del deposito da restituire al consumatore che può scegliere se ricevere il rimborso o donarlo a un’associazione no-profit. “Il deposito cauzionale deve essere di almeno 15-20 centesimi per ogni imballaggio. Se l’ente che amministra il sistema di deposito cauzionale e ha accesso a tutti i dati di raccolta in tempo reale rileva che la raccolta rallenta e non progredisce come previsto, ha la facoltà di aumentare il deposito per incentivare ulteriormente la restituzione degli imballaggi” spiega Ricci.
I produttori pagano un contributo ambientale per ogni imballaggio che immettono sul mercato e aggiungono il deposito al prezzo di vendita. I rivenditori poi applicano il deposito ai clienti che acquistano bevande e i consumatori ottengono il rimborso quando restituiscono gli imballaggi vuoti nei punti di raccolta. Ai rivenditori viene restituito il deposito e riconosciuta una commissione per ogni imballaggio gestito. L’intero sistema è finanziato da tre fonti principali: il contributo ambientale versato dai produttori di bevande, le entrate derivanti dalla vendita dei materiali raccolti e i depositi non restituiti che vengono utilizzati per finanziare ulteriori miglioramenti.

Ignazio Capuano è presidente di CONAI e amministratore delegato di Burgo Group.
Qual è il ruolo di CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) e dei Consorzi nel panorama attuale?
Il sistema consortile è garante per l’Italia del raggiungimento degli obiettivi di riciclo degli imballaggi imposti dall’Unione Europea. Un sistema che ha segnato il passaggio a una gestione dei rifiuti integrata che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Anche per questo CONAI oggi, deve farsi portavoce di una cultura della sostenibilità che vuole tutelare le risorse del pianeta partendo dalla prevenzione, e dalla consapevolezza che gli imballaggi giunti a fine vita sono vere e proprie risorse. Il paradigma deve cambiare: non siamo di fronte a rifiuti, ma a nuova materia che deve innescare nuovi cicli produttivi. In questo l’Italia si conferma un paese virtuoso che nel 2023 ha riciclato il 75,3% dei suoi rifiuti di imballaggio, ossia 10 milioni e 470mila tonnellate su un totale di 13 milioni e 899mila tonnellate immesse al consumo. Numeri incoraggianti che confermano il settore del riciclo degli imballaggi come strategico per l’economia circolare nazionale: del resto, i risultati 2023 superano i target UE previsti al 2030 nonostante un contesto generale difficile per le imprese italiane.
Come impatta il nuovo regolamento europeo sul sistema?
con imballaggi sempre più rigenerabili e riciclabili, e a valle, con tecnologie di riciclo in grado di recuperare materiale dalle frazioni difficili da riciclare. Spero che sempre più materiali possano rientrare in modo efficiente in un flusso sostenibile e circolare. Non solo i materiali da imballaggio, che a livello europeo rappresentano il 4% dei rifiuti totali.
Come vede il futuro del CONAI nel panorama italiano della raccolta differenziata?
PER APPROFONDIRE

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia è leader per riciclo pro-capite di imballaggi in un testa a testa con la Germania. Tant’è che lo scorso anno la Commissione Europea ha inserito l’Italia fra i nove Stati non a rischio per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo, nella Relazione di segnalazione preventiva sull’attuazione delle Direttive sui rifiuti. Sappiamo, però, che non è il momento di fermarsi. Anzi. Il nuovo Regolamento europeo ci chiederà tassi di intercettazione dei pack sempre più alti: ecco perché nei prossimi anni dovremo continuare a lavorare per aumentare sia la qualità sia la quantità delle raccolte differenziate, usando anche lo strumento delle raccolte selettive, ove opportune. E per migliorare ancora saranno importanti le innovazioni a monte,
Il nostro ultimo Rapporto di sostenibilità mostra come nel 2022 il valore economico generato per il Paese dal riutilizzo, dal riciclo e dal recupero degli imballaggi abbia superato i 3 miliardi di euro. In questa cifra, il solo valore della materia recuperata grazie al riciclo è di 2 miliardi e 43 milioni di euro. CONAI contribuisce a questo risultato per circa il 50%. Credo che il sistema consortile debba consolidare questi risultati, rendendo sempre più il riutilizzo e il riciclo degli imballaggi uno strumento di aiuto nel percorso verso la decarbonizzazione. Il settore del riutilizzo e quello del riciclo svolgono un ruolo importante nelle strategie di riduzione delle emissioni di CO2, perché mettono a disposizione lo stesso imballaggio per più utilizzi e perché generano materie prime seconde in grado di ridurre l’intensità di CO2 nelle produzioni nazionali. Il nostro Rapporto di sostenibilità evidenzia che il valore economico calcolato sui risparmi delle emissioni di gas serra grazie al riutilizzo, al riciclo e al recupero energetico è di 609 milioni. Dobbiamo tutelare l’ambiente con uno sguardo basato sui fatti e sui dati scientifici, non sull’ideologia: per parlare di conversione sostenibile in modo pragmatico, dobbiamo quindi guardare anche alla competitività del Sistema Paese. Stiamo inoltre attraversando una fase importante: il modello della responsabilità estesa del produttore, alla base del lavoro di CONAI, si sta rivelando sempre più efficace e si sta estendendo ad altri comparti. Penso che in questo il sistema consortile possa rivelarsi un interlocutore di riferimento per mettere a disposizione know-how e competenze.
intervista a ANGELO

Angelo Luigi Marchetti è presidente dell’Associazione nazionale delle industrie del legno (Filiera Legno). Ingegnere civile, è anche amministratore delegato di Marlegno.
Qual è il ruolo del legno nell’edilizia sostenibile per ridurre le emissioni?
Prima di tutto, le imprese del legno devono stare attente a non cadere nella trappola del greenwashing. Non basta che sia legno per avere un basso impatto sull’ambiente. Nel breve termine dovremo andare a dimostrare con i fatti che grazie alle costruzioni in legno si riesce effettivamente a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il valore raccolto non è mai assoluto. Per risultare rilevante esso deve essere sempre messo in relazione con quello delle costruzioni tradizionali non in legno per ricavarne un metro di giudizio, un benchmark. Negli ultimi anni alcune società hanno cominciato a fare le analisi LCA (Life Cycle Assessment) facendo un confronto con prodotti analoghi. Il forte impatto viene registrato in fase di costruzione perché in fase di utilizzo e manutenzione dipende dai requisiti e dalle prestazioni con cui è stata progettata la casa. Per avere buoni risultati le costruzioni devono essere concepite fin dal principio a basso impatto ambientale.
Cosa dicono i LCA?
Abbiamo verificato che sia in fase di costruzione che in fase di fine vita, e quindi di demolizione, le costruzioni in legno hanno un minor impatto sull’ambiente. Sul fine vita lo si può comprendere bene perché portare in discarica il legno non è come portare altre tipologie di materiali.
con cui certifichiamo le tonnellate di anidride carbonica che stocchiamo all’interno delle nostre abitazioni in una logica di blockchain, individuando con esattezza tutti i parametri affinché non vengano fatti conteggi errati. Questo è il primo passo per valorizzare un’edilizia di qualità dove non solo vengono evidenziate le qualità delle abitazioni in termini di prestazioni energetiche, ma venga incentivato sempre di più l’utilizzo di materiali che abbiano parametri di valore in termini di impatto ambientale: con il legno partiamo favoriti.
Questo è un trend in pieno sviluppo che ci posiziona come protagonisti della transizione e che ci offre margini di crescita. Un trend che nei prossimi anni porterà ad un utilizzo del legno non solo nell’edilizia residenziale, ma in edifici multipiano concepiti per uffici o per altre destinazioni.
Oggi è obbligatoria la certificazione energetica Ape. Perché non affiancarle una valutazione della qualità dei materiali utilizzati che concorrono all’impatto ambientale di un’abitazione?
Si sta discutendo a livello europeo della possibilità di rendere obbligatoria la redazione di una lista di tutti i materiali utilizzati per le nuove costruzioni. Oggi quando si compra una nuova costruzione si sa quanto si consumerà in termini energetici, ma non si sa fino in fondo con quali materiali è stata costruita.
PER APPROFONDIRE
suggeriti da Angelo Luigi Marchetti
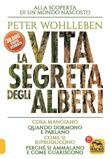
Nella fase iniziale invece viviamo del vantaggio dell’utilizzo di questo materiale come decarbonizzante per le nuove costruzioni: il legno ha infatti la capacità di assorbire anidride carbonica. In cantiere la presenza del legno incide tra gli altri materiali tendenzialmente per circa il 25%. La sua presenza permette di decarbonizzare, immagazzinando l’anidride carbonica nella parte strutturale per tutta la vita dell’edificio stesso.
Come verificate di non cadere nel greenwashing? Attraverso le certificazioni. È recente la collaborazione con una startup italiana che si chiama Carbon Planet
A parer mio, le istituzioni dovrebbero proprio implementare questa norma per incentivare ancora di più costruzioni a basso impatto ambientale. Introdurre l’obbligo di produrre e rendere pubblica la lista dei materiali sarebbe una leva importante per dare valore al costruito.
Sarebbe oltretutto molto semplice redigerla perché basterebbe indicare i materiali usati con relativo Epd, un attestato che indica il loro impatto sull’ambiente. Questo da parte dei costruttori e delle imprese sarebbe anche un atto di trasparenza nei confronti dei clienti compratori che potrebbero valutare l’impatto ambientale del materiale utilizzato per le loro costruzioni.
L’Italia è seconda in Europa per numero di piante ma non sfrutta al meglio le proprie risorse di legno
intervista a MASSIMILIANO BEDOGNA

Massimiliano Bedogna è presidente di Conlegno, consorzio dei servizi legno e sughero che da oltre vent’anni promuove la biodiversità e il patrimonio forestale, ed è a capo di un’azienda che si occupa di produzione pallet e imballaggi nel mantovano.
PER APPROFONDIRE suggeriti da

Stefano Mancuso, Fitopolis, la città vivente, Edizioni Laterza, 2023
Danilo Selvaggi, Rachel dei pettirossi, Pandion Edizioni, 2022
FILM
Avatar di James Cameron, 2009
Quali gli ostacoli, le opportunità, le prospettive per le imprese del legno?
Un paio d’anni fa, grazie all’università di Padova, abbiamo capito che se il mercato del legno rimane alle condizioni invariate di oggi, con l’aumento del consumo di legno per nuovi prodotti emergenti, nel 2050 non ci sarà più legno disponibile a sufficienza: questo è un dato di fatto. Le foreste e i boschi italiani sono secondi per popolazione di piante in Europa con circa duecento piante pro-capite.
Ma i consumi sono molto inferiori rispetto ad altri stati come la Germania o l’Austria. Mettendo in relazione questi due elementi risulta evidente che bisognerebbe investire nel cercare di utilizzare meglio i nostri boschi e le nostre foreste, affinché si mantenga un ritmo di crescita delle piante positivo per l’ambiente.
È importante fare manutenzione perché il terreno sia controllato per prevenire i dissesti idrogeologici e anche gli incendi. Inoltre, se le piante venissero utilizzate correttamente si creerebbe lavoro per coltivare, gestire, manutenere, tagliare e infine utilizzare il legno. C’è poi un altro elemento importante.
Quale?
Dal nostro punto di vista, bisognerebbe accordarsi con tutti gli attori del mercato affinché le piante che dovranno essere utilizzate per re-imboscare siano piante che in prospettiva abbiano una ricaduta positiva sull’economia. Se si utilizzassero al meglio le risorse delle nostre foreste e dei nostri boschi e se si avesse una visione a lungo termine sulle evoluzioni dell’economia entro i prossimi cinquant’anni, allora sarebbe tutto diverso. Allora coltivare piante, pulire i terreni e poi utilizzare il materiale piantato giocherebbe a favore di tutti, dall’ambiente al sociale all’economia: sappiamo bene che alla fine tutto il nostro sistema di vita è integrato.
Stiamo cercando di creare un movimento che possa coinvolgere la politica, gli operatori del settore, chi si occupa dell’ambiente, le università, le imprese affinché si possano creare delle vere e proprie filiere di
gestione del legno che diano un beneficio completo e integrato al nostro territorio.
Qual è il motivo di fondo per il quale boschi e foreste sono così poco utilizzati rispetto ad altri paesi?
Non sono uno scienziato né un economista delle foreste, ma ipotizzo questa idea: la foresta ha una vita di medio-lungo termine e una ricaduta sul territorio di lunga gittata, con tempi che non si accordano a quelli della politica a breve termine. Inoltre finché c’è stata materia prima a basso costo da altri paesi esteri non c’è stato interesse a cercare di spingere questo tipo di attività. Il nostro territorio è più difficile da coltivare rispetto a quello di altri paesi come Austria e Germania, ma è vero anche che la tecnologia oggi ci facilita nella piantumazione e nella raccolta delle piante senza mettere a rischio le persone che ci lavorano.
Da dove si parte per innescare un circolo virtuoso che faccia crescere la filiera?
A Trento abbiamo tentato una prima operazione e abbiamo messo insieme tutta la filiera: proprietari dei boschi e foreste, boscaioli, utilizzatori. Si sono seduti allo stesso tavolo coloro che determinano la piantumazione (per Trento la forestale) e coloro che si occupano di ambiente come, ad esempio, la rivista Sherwood
La nostra volontà è quella di creare un piano di azione condiviso in modo tale che tutti gli attori possano indicare problemi e soluzioni per intraprendere una strada comune. La sintesi dovrebbe farla la buona politica con l’obiettivo che tutti i segmenti possano essere guidati da un unico intento, quello di fare funzionare bene il nostro settore della foresta e dei boschi. Non è un percorso semplice, è molto complesso e dispendioso, però è inevitabile. L’interesse generale c’è, bisogna intercettare le persone e coinvolgere più attori possibili del cambiamento. L’opinione pubblica è matura per questo genere di tematiche, quando ne parliamo riscontriamo sempre un interesse molto alto.
Nel 2023 abbiamo raccolto e riciclato 1,6 milioni di tonnellate di legno
Il risparmio di consumo di pari a 1,8 milioni di tonnellate ottenuto grazie al sistema Rilegno equivale a compensare 1 milione di veicoli che circolano ogni anno*
3.330.784
Grazie a Rilegno l’Italia ricicla già oggi il 64,92 per cento degli imballaggi in legno, più del doppio di quanto sarà obbligatorio nel 2030 secondo gli obiettivi fissati dall’Unione Europea.

909.210
* Ricerca Politecnico di Milano, Il riutilizzo degli imballaggi in legno, maggio 2023


I 26 anni di attività di Rilegno

10.000
ANALISI CHIMICHE PER GARANTIRE STANDARD DI QUALITÀ
milioni
DI TONNELLATE
DI IMBALLAGGI IMMESSI
milioni
DI TONNELLATE
DI IMBALLAGGI RIUTILIZZATI PARI A CIRCA
870 milioni
DI PALLET
485 milioni
DI EURO GARANTITI DA RILEGNO A SOSTEGNO DEL SISTEMA
36 milioni
DI TONNELLATE DI LEGNO AVVIATE A RICICLO DI CUI
11 milioni
PROVENIENTI DAL CENTRO – SUD
2 milioni
DI VIAGGI PER TRASPORTARE IL LEGNO VERSO I CENTRI DI RICICLO
La filiera nazionale di Rilegno
è basata su 1.957 consorziati, 384 piattaforme convenzionate, 13 aziende del riciclo, 16 stabilimenti produttivi.
Le sedi delle aziende che trasformano il legno in risorsa
BIPAN S.p.A.
Pannellificio
Bicinicco (Udine)
Ecobloks S.r.l.
Pallet block
Finale Emilia (Modena)
Fantoni S.p.A.
Pannellificio
Osoppo (Udine)
Frati Luigi S.p.A.
Pannellificio
Borgo Virgilio (Mantova)
Pomponesco (Mantova)
I-PAN S.p.A.
Pannellificio
Coniolo (Alessandria)
Gruppo Mauro
Saviola S.r.l.
Pannellificio
Mortara (Pavia)
Sustinente (Mantova)
Viadana (Mantova)
Isotex S.r.l.
Blocchi legno cemento
Poviglio (Reggio Emilia)
Sicem-Saga S.p.A.
Cartiera
Canossa (Reggio Emilia)
S.A.I.B.
Società Agglomerati
Industriali Bosi S.p.A.
Pannellificio
Caorso (Piacenza)
Xilopan S.p.A.
Pannellificio
Cigognola (Pavia)
Kastamonu S.r.l.
Pannellificio
Codigoro (Ferrara)
Eco-Resolution S.r.l.
Biofiltri
Solofra (Avellino)
ASM Vercelli S.p.A.
Pallet pressati e pallet block
Vercelli
Valle d’Aosta
Enval
Piemonte
Amiat
Ballarini
Borgotti Teresa
Bra Servizi
Cerrirottami
Clerico Primino
Consorzio Area Vasta Basso
Novarese
Cooperativa Sociale Risorse
Cortini Michele
Eco Green
Ecolegno Airasca
Fer-Nova
Ferro e Metalli
Haiki Recycling
M.M.G.
Relife Recycling
Rosso Commercio
S.K.M.
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti
Wood Recycling
Liguria
A.O.C.
Anselmo
Baseco
Comet Recycling
Di Casale Pietro
F.lli Adriano e Giuseppe Bonavita
e Figli
Giuseppe Santoro
Iren Ambiente
Re.Vetro
Relife Recycling
Riviera Recuperi
RTR
Specchia Services
Verde Liguria Riciclaggi
Lombardia
A2A Ambiente
Caris Servizi
Caronni Group
Cascina Pulita
Cauto Cantiere Autolimitazione
Cereda Ambrogio
Convertini
De Andreis - Recuperi e Servizi
Ambientali
Del Curto
Divisiongreen
Ecolegno Brianza
Ecolegno Milanoest
Ecologica Servizio Ambientale
2000
Ecosan
Estri
Focacity Pallets
G.L.M.
Galli
Geo Risorse
GGM Ambiente
Haiki Recycling
Il Truciolo
Isacco
Koster
L.D.R. Logistica Di Ritorno
Laini Alberto
Legno Pallets Servizi
Mantica Rottami
Mauri Emilio
ME.S.ECO.
Nuova Clean
Polirecuperi
Rebucart
Rodella Pallets
SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca
SE.GE. Ecologia
Selpower Ambiente
Seval Casei
Sima
Tramonto Antonio Tre Emme
Trentino Alto Adige All Metals
Chiocchetti Luigi CR3
Ecorott
Energie Ag Suedtirol Umwelt Service
F.I.R.
Galaservice Recycling Lamafer
Masserdoni Pietro Santini Servizi Sativa
Zampoli
Veneto
Ambiente e Servizi
Arca
Autotrasporti Gruppo Frati
Casagrande Daniele
Destro Roberto Eredi
Ecolegno Verona
Ecoricicli Metalli
Eco-Trans
ETRA
Filippi Ecologia
Futura Recuperi
Intercommercio di Coccarielli Guerrino & C.
Intercommercio
Mondo Ecology New Ecology Nuova Ecologica 2000 Ranzato Diego Relicyc
Relife Recycling
S.E.S.A. - Società Estense Servizi
Ambientali
SE.FI. Ambiente
SO.LA.RI.
Società Gestioni Ambientali
T.M. Truciolo
Vallortigara Servizi Ambientali
Vidori Servizi Ambientali
Zanette Gianni & C.
Friuli Venezia Giulia
Autotrasporti Gruppo Frati
Eco Sinergie
Logica Metfer PR Ecology
Emilia Romagna
B. Group
Belloni Giuseppe
BO-Link
Casadei Pallets
Cupola
Ecolegno Forlì Eurolegno BO Garc Ambiente
Garnero Armando
General Forest
Ghirardi
Il Solco Coop. Sociale
Inerti Cavozza
Iren Ambiente
L.C.M.
La Cart
La Città Verde
Longagnani Ecologia
Maccagnani Rottami
Marchesini
Monti Amato
S.E.A.R. Recuperi
Salvioli
Sandei
Sogliano Ambiente
T.R.S. Ecology
Tras-Press Ambiente
Toscana
Autotrasporti Gruppo Frati
Bogi Vinicio
Casini
Cerroni Dino & Figli
Dife
Ecolegno Firenze
Ecorecuperi Versilia
Galeotti
GCE
Herambiente Servizi Industriali
Marinelli
Pianigiani Rottami
Real
Relife Recycling
Rugi
Marche
Autotrasporti Gruppo Frati
Cartfer
Cartfer Urbania
Cartonificio Biondi
Cavallari
Cosmari
Costruzioni e Ambiente
Demolizioni Metauro
Dur. Eco
Ecocentro
Eredi Covi Renzo
Ferri & Oliva
Gualdesi
Immi
L.S.L. Lavorazione Scarti Legno
P.E.
Sampogna Leonardo & C.
TSB
Umbria
Bio Smaltimenti
Biondi Recuperi Ecologia
F.lli Baldini
Ferrocart
GESENU Gestione Servizi
Nettezza Urbana
Spalloni Ecosistema
Terenzi
Lazio
Ambienti e Recuperi
Baldacci Recuperi
Bracci Emma
C.E.S.PE.
Centro Servizi Ambientali
Cerchio Chiuso
D.M.
Del Prete Waste Recycling
Ecolegno Roma
Ecoprat
Ecosystem
Ecotuscia
F.A.T. – Futuro, Ambiente e
Territorio
Fatone
Ferone
Fitals
Geco Ambiente
Gerica
GSV Ambiente
Idealservice
Innocenti
Intercarta
Intereco Servizi
M.G.M.
Marteco
Mediaservice Recycling
Mia Lazio
Pellicano Green
Porcarelli Gino & Co.
Refecta
RIME 1
Romana Maceri
Sabellico
Sieco
Tecnogarden Service
Tecnoservizi
Trash
Abruzzo
A.C.I.A.M.
Cip Adriatica
Eco.Lan.
Ecoaspa Servizi Ecologici
Ecotec
L.E.A.
Mantini
Panone
Paterlegno
Pavind
Se.Lecta
Molise
R.E.S - Recupero Etico
Sostenibile
Campania
Ambiente Italia
Ambiente
Biomasse e Scarti Vergini
Di Gennaro
Eco-Service Sannita
Eco Centro Salerno
Eco Legnami
Eco Sistem S. Felice
Ecocart
Ecologia Italiana
Ecosistem
Edil Cava Santa Maria La Bruna
Fer. Ant. Ambiente Sud Green Energy Revolution
Irpinia Recuperi
Langella Mario Nappi Sud Pannelli Italia
Ravitex
S.EN.EC.A.
S.R.I.
Servizi Gestioni Ambientali
Tony costruzioni
Basilicata Decom
Metaplas
Paterlegno
Puglia
Asia Ecologia
Bri. Ecologica
C.G.F. Recycle
C.M. Recuperi
Cave Marra Ecologia
Cooperativa Solidarietà e Integrazione Sociale
Daniele Ambiente
Direnzo
Eco. Ambiente Sud Ecologistic Ecosveva
Fer. Metal. Sud
La Puglia Recupero
La Recupero Macero
Patruno Group
Recuperi Pugliesi
S.E.T.A.
Spagnuolo Ecologia
Calabria
BNT Ambiente e Servizi
Calabra Maceri e Servizi
Circular Factory
D.N. Service
Eco Piana
Eco Sor.Mi.
Ecologia Oggi
Ecology Green
Ecomediterranea
Ecoross
Ecoshark - Igiene Ambientale
Ecosistem
Lauritano
Logam – Logistica per l’Ambiente
M.I.A. – Multiservizi Igiene
Ambientale
Muraca
Poly2Oil
Recuperi Costa
Rocca
S.E. Servizi Ecologici
Sicilia
Balistreri
Bellinvia Carmela
Caruter
Con.Te.A.
D’Angelo Vincenzo
Di Paola Group Ecocentro
Polivalente
Dimalò
Eco Ambiente
Eco XXI
Ecodep
Ecogestioni
Ecoimpianti
Ecomac Smaltimenti
Ecoplastik
Ecorecuperi
Ecorek
Etna Global Service
F.M.G.
FG
Gestam
L.C.R.
La Sangiorgio
Lemac
Ma.Eco.
Morgan’s
Niem
Palermo Recuperi
Pi. Eco
Puccia Giorgio
Rekogest
Riolo Metalli
Riu
Rubbino
Rubino
S.AM. - Sistemi Ambientali
S.E.A.P.
Sarco
SB Ricicla
Sicula Trasporti
Sidermetal
Trinacria Scavi
W.E.M. Waste Engineering
Management
Sardegna
Eco Silam
Ecopramal
Pro.Mi.S.A.
R.G.M. Recuperi Generali
Mediterranei
Tecnologie Ambientali
Dati al 01/10/2024
We are Walden è un progetto di Rilegno rivolto ai giovani interessati al mondo della sostenibilità: un team di lavoro che, insieme alla sua community, progetta con il design circolare per il bene comune.
Il progetto coinvolge appassionati, creativi, designer e architetti con l’obiettivo di avvicinarsi concretamente alla materia legno e diffonderne il valore.
Essere artigiani di un futuro migliore significa sensibilizzare, educare e fornire gli strumenti per diventare sempre più consapevoli.
Seguici su Instagram!



Nel corso del 2024, il team e la community di We Are Walden si sono dedicati alla progettazione e prototipazione di una falegnameria mobile: un’officina itinerante pensata per diffondere i valori del Consorzio Rilegno. Attraverso il saper fare manuale, legato al ricco patrimonio dell’artigianato, la falegnameria diventa uno strumento per affrontare il futuro con un approccio creativo e sostenibile.
La falegnameria mobile sarà composta da moduli attrezzati per diverse funzioni, capaci di eseguire lavorazioni artigianali in modo pratico ed efficiente.
Sarà caratterizzata da agilità e praticità, ideale per essere facilmente spostata e utilizzata in vari contesti e diventare risorsa per il bene comune.
Conclusa la fase progettuale, si entrerà presto nella fase di costruzione, dando vita a un progetto innovativo che unisce tradizione e sostenibilità.
La Milano Green Week è stata un’occasione ideale per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza del legno e del suo riciclo. In collaborazione con l’Off Campus Nolo del Politecnico di Milano, l’iniziativa ha coinvolto la community nella costruzione di fioriere in legno di pallet, trasformando via Martiri Oscuri in uno spazio pubblico più accessibile e protetto dal traffico. Grazie agli strumenti della futura falegnameria mobile, le fioriere hanno ridefinito una nuova area pedonale, diventata teatro di attività dedicate al valore del legno e del suo riuso, trasformando la città in un vero laboratorio a cielo aperto.



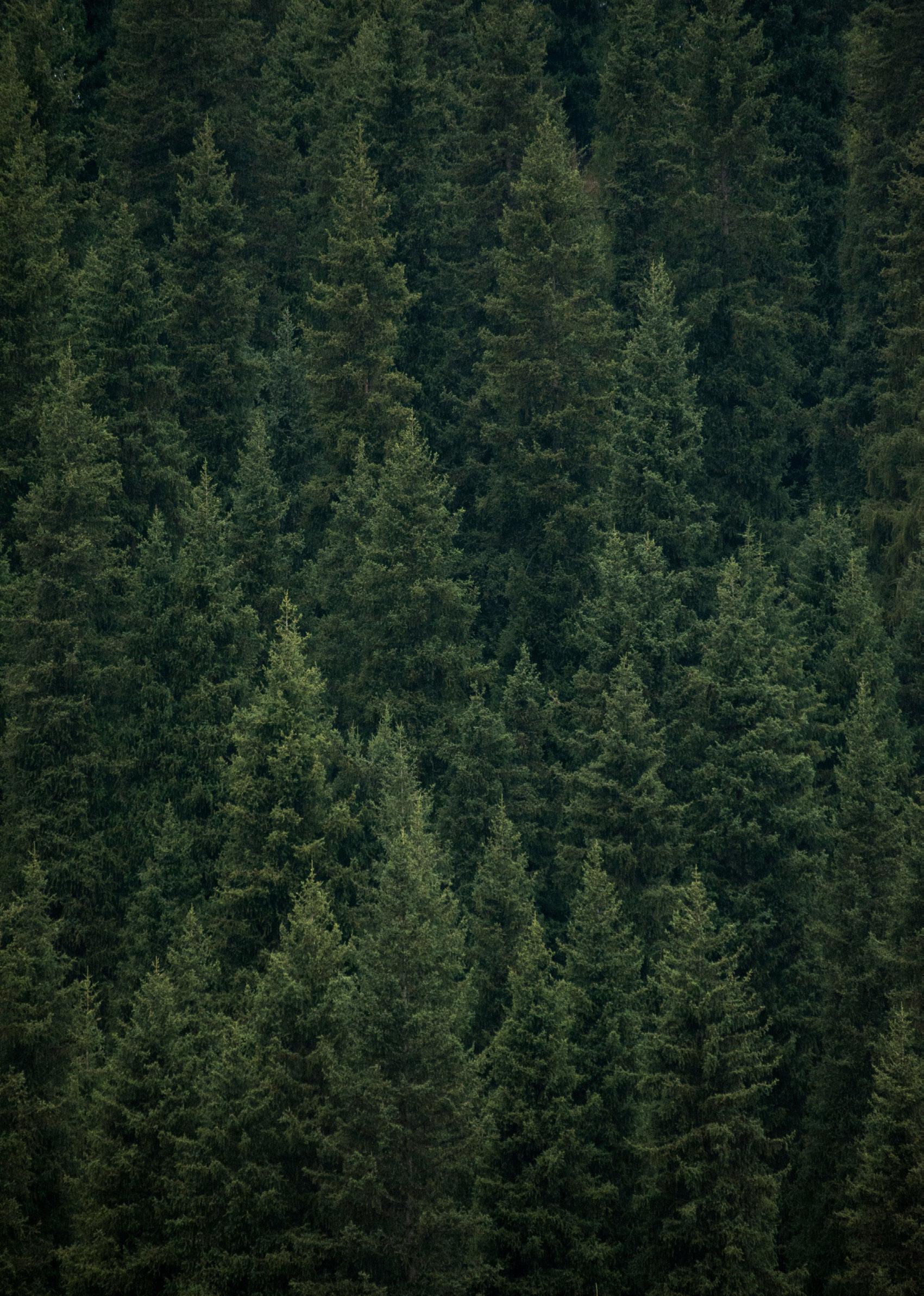
l l e t s, New Pack 02, Meschini & Grassi, RainoldiMac, PontinaLegnami,SpigolonImballaggi,
A lg P
& C , Ro Ga legno, I
Forest Ag r iDalBosco, FocacityPalletsdiDimasiRoberto, Varesco Legno , SchiedaFilippo&Antonio , LD.R . Logistica Di Ritorno , Scal i gera Pal l
, Firlu Pla l te , S u hg e r i f c i o G a nau, Lamp recht, Imballagg iBazzani,Legnonova,UmbraPallets,TecnoImballi, Moving Service Pallets, ImballaggiMancini , FalangaPallets , FIMImballaggieLogi
Pallets di Rizzato Claudio, Fravega, DiamSugheri , ImballaggiRe , Imballaggi Alto Mil anese , M w o o d , I m ab l l ,ateneV lS goL,ehcitsi ,stellapocE oidualCitnazzaMiDxeraM & C , oisiraC ,ecivreS FiedittobongeLC&ottedeneBeDill. , emme2 , fnaSileic , P e j o Pla l
CostruzioneeCommercio
g n o form, Banf Assemblagg ieServizi,Packings Nord Est, Rosa Group, Enwrap Logistic&Packaging , Pallet
D i D a p r à Ro do l fo & C., Pallets Dolomiti, I.C , airehgeS nosirF ocnarF id nosirF erottE & ,C etaroproCenoihccO , iggallabmIatsoC , ilopuL &
rtai ggeR anai ggallabmI,.IR.Ii oratotortsaMilL.F & oC ,efellE nocsecnarF iggallabmI , M u r e d du Sug her i di Fabio Mureddu, Europal,MaicaPallet,Gava Cav Giuseppe Imballaggi , Petrin , Positello , NewBlu , VenetaService , A n gel o N i c o t r a & ,.C ,otartnocnI plA,ongeLi ,amaC ireihcsA .F,irteiPeD- ,nihcaoiG ,imangeloruE stellaPinoiruB , ocnarFittanoB , dooWlatI L,do i, P i la e ong , .G.S .M ,stellaP ,ollevoN imocoS,stellaPoirevaD,xoBdooW àteicoS oicremmoC itrenIilairetaM , iggallabmIiVoM , ozneroLosolleP biR, o Pla l te s, G b S e r v i c e s, Go l in Pa l lets, FalegnameriaRescaldese,Allwood,RomaPallet,Pbw,
C , Cefap Service, Lc Imballaggi, Ligna - LetteraAntoniodiLetteraUmberto&C . , Galvan Imballaggi, VT L Flexo Fibra, La Bottega dell’artigiano , Poly-Pack , NapodanoGiovanni
legnamidiDebortoliFabrizio,Palm
Iannucci, TrefnosItalia, onaibruD , iggemraP ina
dustria ImballaggieLogistica,Euro.Imballi, Silcam GlobalPallets,Pamm, Fabbrica Generale ImballaggiAcanfora , Imballaggi Trenti
A
E
, BP. . dnIiggallabmItsu
s , S a c c h i Pallets, Gierreti,Bof, Diefegi , P iero, DellaValentina&C ,Nord Legno, Orlandi , B.Group,Italsugh e r o ed i .F l ggerroCil,illabmilatIavouN,i imangeLattaG , enozzoM F r ta e l l i ImballaggiValtanaro , Silvestri Pal l e t s , aP l stel ,initreB P.D.M , enoizarovaL ,imangeL kcaponceT , lapeR , Litse P a l l e t s, Leg nopack, EmilianaImballaggi, Imbal-LegnodiScalf
Alfo Forelli Italpacking, Naturalpallet , S.I . Tecnimballo , NigelliImballaggi ,S e gheri a B i
A m ro mi kroC ,ailatI obleB S u g heri, Casadei Pallets , Monari Pallets , Efegi ,BCub ,e .A .F àteicoStellaP avitarepooCS,tra o r i l e gno, Essegi, Chimar , I.M .Servi z ,i oM lsani ,ilgiF&onippeP oloaP odlarA , kolbocE
Adri an o E C , zaorG ,imangeL ,stellapixaM,stellaPanacsoT angodeB illF , stellaPonroC , lleDlava l
SB Scart Imballaggi , Cork Supply Italia , SegheriaPiovano ,Baril l i Arnal d ,o
r aP l ,tel ,laponceT ,spL ,ihcsobailgaT,allehccaT,itangiV ,gnikcaP xobiloP
oppiliF E C , ocE ,dooW ,agaD laPocEigrenE , stellaPaneiSpooC , idstellaPdroN
,ill.F enheuK,ilgiF&ocinemoDàroC + ,legaN ibessE aciG iggallabmI , idihccarBimangeL Clleana
,iman agaF ggallabmI,i enoizarovaL,kcaPlabolG,tellaPomagreB,kcapsnarT ,ongeL izragS ,gnikcaP ihccoB illF , kcapnaP , iggallabmiongeL , stellaPaporuE , FlleDill. inotna o d i Dle l tna ino o P a lo
derE,i
l ggal i ,ratS ,remI ottegorP ,ongeL ,.oC&elehciMeseroM avitarepooCàteicoS ,oiggallabmI lanoidireM stellaP àteicoS ,avitarepooC ongelicirdnE , fiarGiggallabmI , stellaPinidoB , eD iVov bmI,la l a igg M i itun l l
, mI
,ozneRagabiRidimangeL oniluGiggallabmI,.C&oiligiV
Grazie a Rilegno e ai suoi consorziati esiste la raccolta, il riutilizzo e il riciclo degli imballaggi in legno.
• oltre 3 milioni di tonnellate di imballaggi vengono immessi al consumo
• oltre 70 milioni di pallet vengono raccolti e riutilizzati Ogni anno in Italia (Rapporto Rilegno 2023):
• il 64,92% dell’imballaggio di legno viene raccolto e riciclato rispetto all’immesso al consumo
• oltre 1.600.000 tonnellate di legno vengono raccolte e riciclate