





Conta automatica in un secondo

Scritte ed etichette non rappresentano un’interferenza nella lettura

Tracciabilità dei risultati
Lettura di piastre tonde (55 – 150 mm) e quadrate (120 mm)
salviette pronte per essere imbevute - in busta stand-up

Salviette presaturate IPA ALCOOL ISOPROPILICO

Adatte a tutti gli usi ed economiche Pronte all’uso, per massimizzare i processi
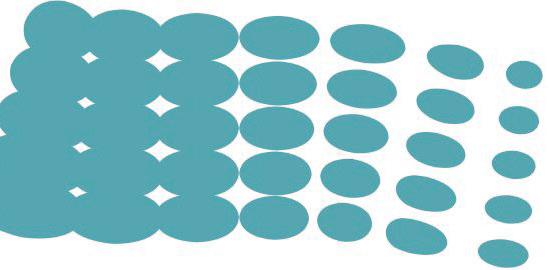
Salviette e Mop per pulizia e disinfezione delle superfici in tutti gli ambiti Visita www.kairosafe.it per vedere l’intera gamma di

Contatta il nostro team 040 299502-2907149
info@kairosafe.it chatta con noi su www.kairosafe.it

BENEDETTA BOTTARI
Professore Associato
Microbiologia degli Alimenti
Università degli Studi di Parma
C’è chi dice che la denominazione d’origine sia un’invenzione, frutto di una brillante operazione di marketing. Questo però non è quello ci dice la scienza, o meglio le scienze degli alimenti, almeno nel caso dei formaggi DOP a latte crudo. Posti sotto la lente di ingrandimento, o ben più potenti strumenti analitici, di microbiologici, chimici ed economisti degli alimenti, 4 formaggi DOP italiani sono stati il focus del progetto PRIN (progetti di ricerca rilevante interesse nazionale, ndr), “Formaggi con Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non: interazioni tra preferenze e consumatori e cheeseomica”. I risultati del progetto, durato 3 anni, sono stati presentati in un evento conclusivo in cui i ricercatori degli atenei coinvolti, Università di Parma come capofila, Università di Torino e Università di Bari, hanno tirato le fila dei complessi esiti delle rispettive ricerche. I 4 formaggi, scelti come rappresentanti delle diverse aree di Italia (Parmigiano Reggiano DOP, Roccaverano DOP, Caciocavallo Silano DOP), o a essa trasversali (Grana Padano DOP) sono stati confrontati con prodotti simili, ma senza marchio, disponibili sul mercato. Il confronto è stato fatto all’assaggio, con analisi sensoriali codificate, fatte da esperti assaggiatori ONAF, e con analisi meta-omiche, in grado di rilevare i metaboliti volatili associati all’aroma e al gusto, e il microbiota e i suoi geni, probabilmente responsabili della loro presenza/quantità. Il tratto comune dei 4 formaggi scelti è la produzione a partire da latte crudo e la scelta dei produttori di attenersi a un disciplinare di produzione. Con tecnologie simili, ma senza l’obbligo di rispettare specifiche indicazioni, si ottengono formaggi cosiddetti “tipo”. I prodotti a
marchio DOP hanno generalmente un prezzo più alto, ma è lo stesso marchio a rappresentare uno dei motivi per il quale il consumatore è disposto a spendere di più. La complessa correlazione statistica tra l’incredibile mole di dati generata dai vari ambiti di ricerca di questo progetto, rivela però che il consumatore non sceglie solo per ragioni di affetto verso una tradizione o un territorio, o perché indottrinato dal marketing dei marchi DOP.
Nella maggioranza dei casi, infatti, la preferenza al palato risulta infatti saldamente connessa a specifici composti che sono il risultato dell’attività di specifici microrganismi, che sono specifici solo dei formaggi DOP. Nei formaggi non DOP, una maggior eterogeneità di scelta delle materie prime e delle tecnologie, si riflette in una maggior variabilità tra i microbioti presenti, che si caratterizzano per una minor ricchezza funzionale: sono meno coinvolti nelle vie metaboliche da cui derivano gli aromi che il consumatore avverte come migliori. E guarda caso, i formaggi non DOP che sono risultati più graditi all’analisi sensoriale, sono quelli con un profilo microbico più simile al corrispettivo formaggio DOP. Sembrano essere quindi i microrganismi i principali responsabili della classificazione dei formaggi analizzati come buoni o meno buoni. Nel caso dei formaggi DOP, tali microrganismi derivano dal latte crudo e/o dell’innesto naturale e rappresentano il legame con il territorio, un legame che il consumatore è in grado di scegliere e apprezzare non solo grazie a un acronimo in etichetta. Produrre secondo DOP è una scelta che deve poter essere valorizzata. Consumare prodotti DOP è un’opportunità che può essere colta con trasparenza e consapevolezza.



INGRANDIMENTI
DOP o non-DOP? Alla cheese-omica l’ardua sentenza!
Benedetta Bottari 2
NEWS DAL MONDO a cura della Redazione 6
TECNOLOGIA APPLICATA
Ricerca scientifica internazionale a cura della Redazione 12
ATTUALITÀ
Crescita solida del settore food a cura della Redazione 16
PACKAGING
Coating a base di biopolimeri
Simona Rispoli, Stefania Volpe, Elena Torrieri 18
ATTUALITÀ
La snack economy da 234 miliardi di euro alimenta il retail europeo a cura della Redazione 22
DIRITTO ALIMENTARE
Regolamento EUDR sulla Deforestazione
Avv. Chiara Marinuzzi 24
MACCHINE E IMPIANTI
Novità e soluzioni dalle Aziende a cura della Redazione 28
SPECIALE CONTROLLO QUALITÀ
Il metodo “Seek and Destroy”
Francesca De Vecchi 32
LABORATORIO
Il ruolo del laboratorio nel controllo qualità
Laura Scafuri 36


FOCUS FOOD WASTE
Lotta allo spreco alimentare: protagonisti i surgelati a cura della Redazione 42
Mense scolastiche: nei rifiuti finisce metà del pasto a cura della Redazione 44
NUTRIZIONE
Nuove abitudini alimentari David Migliori 48
In Italia un bambino su 2 non mangia verdure a cura della Redazione 52
Pasta, da 50 anni protagonista dei menu degli sportivi a cura della Redazione 54
LOGISTICA
Piano Transazione 5.0, un’occasione per migliorare la propria logistica
Marco Barbetti 56

Rilevamento con infrarossi Francesco Nicassio 62
ABBIAMO PARLATO DI ALTOPACK pag. 28 www.altopack.com
BARILLA pag. 60-61 www.barilla.com
BITZER pag. 31 www.bitzer.de
CSB-SYSTEM pag. 64 www.csb.com
EIQ INDUSTRIAL pag. 29 www.eiqindustrial.com
FANUC pag. 28 www.fanuc.eu
IGUS pag. 30 www.igus.it
IFM ELECTRONIC pag. 30 www.ifm.com
LABELYS pag. 31 www.labelys.it
RELICYC pag. 29 www.relicyc.com/it/
SODEXO pag. 46 www.sodexo.it
STESI pag. 59 www.stesi.it
Direttore Responsabile Giorgio Albonetti
Direttore Scientifico
Massimo Artorige Giubilesi
Comitato tecnico scientifico Giancarlo Belluzzi, Vincenzo Bozzetti, Francesco Fiorente, Gaetano Forte, Luciano Negri, Erasmo Neviani, Serena Pironi, Daniele Roseghini
Coordinamento editoriale
Chiara Scelsi c.scelsi@lswr.it Cel. 3490099322
Redazione
Diletta Gaggia d.gaggia@lswr.it redazione.food@quine.it
Impaginazione LSWR
Immagini Shutterstock
Produzione Antonio Iovene a.iovene@lswr.it Cel. 3491811231
Direttore Commerciale Costantino Cialfi c.cialfi@lswr.it tel. 3466705086
Traffico
Ilaria Tandoi i.tandoi@lswr.it
ABBONAMENTI www.quine.it abbonamenti.quine@lswr.it Tel. 02 864105 www.alimentinews.it
Costo copia singola: € 2,80 Abbonamento annuale Italia: € 40
Stampa
New Press Edizioni S.r.l. Lomazzo (CO)
Quine Srl Produzione & Igiene Alimenti - Bimestrale Rivista ufficiale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 510 del 29-10-1983 Iscrizione al ROC n. 23531 dal 6 Maggio 2013
Tutti gli articoli pubblicati su Produzione & Igiene Alimenti sono redatti sotto la responsabilità degli Autori. La pubblicazione o la ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall’Editore. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pubblicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dal GDPR. I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Quine Srl, Via Spadolini 7 - 20141, Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.
Testata Associata

INDICE INSERZIONISTI
AEB III Copertina
ALITEST IV Copertina
BIOAGRO pag. 3
CIBUS TEC FORUM pag. 11
CSB-SYSTEM pag. 9 KAIROSAFE pag. 1 e inserto SACCO II Copertina
Si è svolto il 6 giugno scorso a Loreto l’evento “Il Grano Duro nelle Marche”, organizzato da COMPAG – la Federazione nazionale delle rivendite agrarie – in collaborazione con Confagricoltura Marche e Federchimica-Assofertilizzanti, e con il supporto di BPER Banca, BASF, Newpharm e Mulmix. L’iniziativa, alla sua terza edizione, ha rappresentato un momento di dialogo tra tutti gli attori della filiera del grano duro: agricoltori, tecnici, ricercatori, stoccatori e aziende fornitrici di soluzioni avanzate, che si sono riuniti per discutere di qualità, sostenibilità e competitività in un contesto di profondi cambiamenti climatici, economici e normativi. Il tutto, in un territorio - le Marche - dove la cerealicoltura rappresenta un comparto chiave.
In apertura dei lavori, il Direttore di COMPAG, Edoardo Musarò, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per affrontare le sfide attuali: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di una filiera integrata e consapevole. La competitività si costruisce sul campo, ma anche nelle scelte strategiche e nelle relazioni tra i diversi attori. Questo evento ne è la dimostrazione concreta”.
Carlotta De Pasquale di Areté ha fornito un’ampia panoramica sullo scenario economico e commerciale del frumento duro. Il mercato mondiale è attualmente in surplus, con stock in ripresa ma ancora sotto i livelli storici: nonostante gli incrementi nel 2024/2025 si registra un -25% nel contesto mondiale rispetto al 2018-2022 e, sempre nello stesso periodo, -28% a livello UE. Gli stock sono un importante elemento di volatilità, che deve essere attentamente monitorato perché determinano la capacità di un mercato di far fronte a eventuali shock lato offerta. Il calo produttivo nei Paesi esportatori e il limitato livello mondiale di stock lascia il mercato esposto a ondate di volatilità rialzista nell’eventualità in cui la produzione nei Paesi importatori dovesse rivelarsi al di sotto delle aspettative. Allo stato attuale, la prospettiva di aumento produttivo in UE (+11%) lascia tuttavia spazio per un ulteriore abbassamento delle quotazioni. Nel contesto macroeconomico occorre monitorare l’instabilità geopolitica e le restrizioni com-

merciali USA, che potrebbero limitare la domanda di export di pasta, e quindi incidere negativamente sulla domanda di frumento duro. L’Italia è il primo esportatore di pasta a livello mondiale (40% del totale mondiale in media tra il 2020 e il 2024).
L’export di pasta italiana verso gli Stati Uniti - cresciuto del 16% in volume e del 54% in valore negli ultimi anni - potrebbe ora essere messo alla prova dai nuovi dazi commerciali (elaborazione dati Areté).
“Di fronte a questo scenario”, sottolinea il Vicepresidente di COMPAG Mauro Acciarri, “è imprescindibile rafforzare i rapporti tra gli operatori e ricomprendere nelle relazioni interprofessionali anche la distribuzione organizzata e i consumatori, anelli ultimi di una filiera agroalimentare di eccellenza per la tradizione e l’economia italiana”. Una filiera, secondo Acciarri, che deve essere protetta dalle discontinuità del mercato mondiale e dagli eventi climatici estremi, attraverso strumenti di tutela per gli operatori come la contrattazione pluriennale, una maggiore sinergia nei rapporti di filiera, il miglioramento dell’accesso al credito per la parte agricola e agli strumenti per la gestione del rischio. Particolarmente importante anche la previsione di un monitoraggio delle quantità stoccate a livello nazionale, dati fondamentali per gli operatori del settore. Il registro per il monitoraggio delle produzioni cerealicole non deve pesare sull’operatività quotidiana delle imprese coinvolte, ma deve essere di agile e semplice fruizione. Per COMPAG è inoltre opportuna una divulgazione aggregata e periodica dei dati raccolti.
Alla tavola rotonda, che si è tenuta a conclusione dei lavori sono intervenuti, oltre ad Acciarri, Alessandro Alessandrini (Presidente CAP Ancona), Enrico Villa (FederchimicaAssofertilizzanti) e Marco Lazzari (Responsabile servizio Agri Banking BPER Banca).
È ancora record per l’industria italiana delle macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio, che nel 2024 ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 10 miliardi di euro di fatturato. Il giro d’affari complessivo ha raggiunto i 10,06 miliardi, con una crescita del +9% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati resi noti nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci di Ucima, sulla base della 13^ Indagine Statistica Nazionale condotta dal Centro Studi Mecs. Lo studio ha coinvolto 619 aziende del settore, che danno lavoro a 40.503 addetti (+6% sul 2023).
I mercati internazionali
La vocazione all’export delle aziende italiane del packaging si rafforza ulteriormente nel 2024: le vendite all’estero hanno raggiunto 8 miliardi di euro, pari al 79,4% del fatturato complessivo, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente (+10%). L’incremento delle esportazioni, pari a oltre 700 milioni, consolida la posizione del Made in Italy nei mercati globali, dove le tecnologie italiane continuano a essere apprezzate per affidabilità, flessibilità e innovazione. Il podio delle destinazioni resta invariato: l’Unione europea si conferma la principale area di sbocco delle tecnologie italiane per il packaging, con 2,9 miliardi di euro di fatturato e una quota del 35,8% sull’export totale. L’Asia mantiene il secondo posto con un giro d’affari pari a 1,6 miliardi (20,2%), seguita dal Nord America con 1,3 miliardi (16,6%).
A seguire, Europa extra UE (768 milioni), Sud America (730 milioni), Africa (573 milioni) e Oceania (122 milioni).
Il mercato interno
In crescita anche il mercato domestico, con un incremento del +5,2% che ha portato il fatturato Italia a superare i 2 mi-

liardi di euro (2,07 miliardi il consuntivo 2024). La quota di vendite interne si attesta al 20,6% del totale. Il food rimane il principale settore cliente sul territorio nazionale, con una quota del 36,8%, seguito da beverage e farmaceutico.
Food & beverage ancora protagonisti
Anche nel 2024 il comparto delle macchine per il packaging conferma la propria trasversalità industriale, con una domanda distribuita su più filiere produttive. La maggior parte del fatturato proviene dai settori alimentare e delle bevande, che insieme assorbono il 56,1% delle vendite complessive: il food si attesta al primo posto con 3,12 miliardi di euro (31% del fatturato totale), seguito dal beverage con 2,52 miliardi (25,1%). Al terzo posto si colloca il comparto che comprende tissue, tabacco e altri settori con 1,92 miliardi di euro, pari al 19,1% del totale. In forte crescita anche il settore farmaceutico, che raggiunge quota 1,74 miliardi (17,3%).
Fatturato per tipologia produttiva
Le macchine per il packaging primario si confermano la principale voce di fattura-
to, con una quota pari al 53% del totale, trainata in particolare dalle formatriciriempitrici-chiuditrici (FFS) che, con 2,24 miliardi di euro, rappresentano da sole il 22,3% del fatturato complessivo, in crescita del 10,3%. Al secondo posto si collocano le riempitrici e dosatrici, con 1,90 miliardi (18,9%, +8,6%). Il packaging secondario, che comprende astucciatrici e incartonatrici, si attesta al 19,9% del fatturato, con una crescita del 6,6%.
Le aspettative per il 2025
Guardando all’anno in corso, le aziende del settore si mantengono prudentemente ottimiste.
Secondo l’indagine del Centro Studi Mecs - Ucima, il 37,5% delle imprese prevede una crescita del proprio fatturato nel 2025, mentre il 45,8% si attende una stabilità dei volumi. A pesare sulle prospettive future sono soprattutto i fattori di instabilità internazionale, l’evoluzione dei costi energetici e le politiche industriali a livello europeo. Resta comunque forte la fiducia nella capacità del settore di innovare e consolidare la propria posizione sui mercati globali.
Il bilancio 2024-25 del settore con una campagna olearia definita “complessa”, e conclusa confermando le stime al ribasso già previste: ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’industria olearia aderente a Federalimentare e Confindustria, non nasconde ma al contrario evidenzia i problemi del settore e invita a una riflessione comune. Secondo le statistiche della UE, la produzione di oli d’oliva in Italia nella campagna 2024-25 si è attestata sulle 248 mila tonnellate, registrando un calo di quasi il 25% rispetto alla campagna precedente, in controtendenza rispetto al resto del territorio europeo. “Sapevamo già che sarebbe stata una campagna di scarica”, spiega Anna Cane, presidente del Gruppo olio d’oliva di ASSITOL. “Ad aggravarla, purtroppo, sono state le conseguenze della crisi climatica e le tensioni internazionali, che hanno reso più difficile la programmazione delle aziende”.
Le difficoltà di reperimento di materia pri-

ma e i timori sulle ipotesi di dazi americani hanno pesato sulle quotazioni di mercato, soprattutto in Italia. L’apporto del blending, l’arte di abbinare oli provenienti da cultivar diverse per dare vita a un prodotto dal profilo sensoriale unico, capace di soddisfare le richieste dei consumatori, è stato provvidenziale. “Grazie al know-how delle nostre imprese -– osserva la presidente degli industriali – siamo riusciti a reggere in un momento complesso. Possiamo ben
dire che l’Italia è al primo posto nel mondo nella ‘produzione’ di conoscenza sull’extra vergine d’oliva”. Anche i consumi nel canale retail non hanno subìto variazioni di rilievo, a conferma che l’extra vergine è molto amato dagli italiani.
Le imprese italiane evidenziano con orgoglio di saper vigilare sulla genuinità e l’autenticità dei loro oli, grazie al sistema di monitoraggio del SIAN, che verifica i flussi in entrata e in uscita dal nostro Paese.
I consorzi del settore lattiero-caseario sono stati presenti al Summer Fancy Food di New York, la principale rassegna del settore agroalimentare di tutto il continente americano, dal 29 giugno al 1 luglio con
eventi e iniziative e per presidiare un mercato fondamentale per le nostre esportazioni minacciate anche da nuovi dazi. Continua il tour di promozione internazionale per la Mozzarella di Buafala DOP: dal

Giappone, dove il Consorzio di Tutela ha partecipato alla missione della Commissione UE, con un volo di 10 mila km è ora la volta del Summer Fancy Food di New York.
Per il Consorzio del Parmigiano Reggiano quello del Summer Fancy Food Show è un ritorno “un appuntamento irrinunciabile per sostenere le azioni di promozione della domanda della DOP”, che vede negli USA il principale mercato estero, pari al 22,5% della quota export totale. Nel 2024 sono state esportate oltre 16.000 tonnellate, con un aumento del +13,4% sul 2023. Inoltre, a livello di sell-out, nel primo quadrimestre il Parmigiano Reggiano ha continuato a crescere del +9% in linea con i mesi precedenti.
È stato inaugurato il nuovo impianto per il recupero e la valorizzazione degli scarti salini derivanti dalla produzione. L’impianto, che è stato promosso e realizzato dal Consorzio attraverso la società controllata Promo San Daniele Srl, rappresenta la concreta realizzazione di un progetto di economia circolare e una delle più importanti azioni in chiave di attenzione ambientale avviate dal comparto negli ultimi anni.
Il Prosciutto di San Daniele DOP manifesta con soddisfazione il risultato parlando di una struttura unica nel suo genere a livello europeo. Il dato più importante è che è pensata per trattare e rigenerare due tipologie di rifiuti – il sale solido esausto e la salamoia –trasformandoli in prodotti riutilizzabili nell’ambito del trattamento stradale antighiaccio, della concia delle pelli e dell’industria. Il tutto secondo un modello di economia circolare che riduce sensibilmente i costi di smaltimento, l’impatto ambientale e le emissioni di CO₂. Il nuovo impianto sorge a pochi chilometri dal distretto di San Daniele e garantisce il 100% del fabbisogno di trattamento dei 31 produttori consorziati. È stato concepito su due linee operative: una linea per il sale solido, attiva circa 200 giorni all’anno, e una per la salamoia, operativa 350 giorni l’anno, 24 ore su 24. Il sale esausto viene sottoposto a vagliatura, lavaggio igienizzante, essiccamento e insaccamento, mentre la salamoia è trattata con una sequenza di processi fisico-chimici e biologici che ne consentono la separazione in acqua pulita ed elementi solidi recuperabili.


L’istinto aiuta, ma oggi contano i fatti. Che si tratti di margini di contribuzione, costi delle materie prime o semplicemente dei prezzi giusti. Con il CSB-System gestirete la vostra azienda alimentare sulla base degli indici. In questo modo avrete una visione chiara anche in situazioni non chiare.
Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il settore alimentare: www.csb.com
Una filiera da 21,5 miliardi e un export da primato di fronte a crisi epocali, tra geopolitica in fiamme, allarme dazi e competitività a rischio. Con l’Assemblea Generale Federvini prende il via la nuova presidenza di Giacomo Ponti.
Il contesto internazionale è complicato, con guerre, instabilità geopolitiche, incertezze commerciali e sfide culturali. Tuttavia secondo i dati Nomisma per l’Osservatorio Federvini, nel 2024 l’export italiano complessivo ha raggiunto i 10,5 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo di 8,9 miliardi, rafforzando la leadership italiana sui mercati internazionali. Una filiera da 21,5 miliardi di euro che conta un tessuto produttivo di oltre 40 mila imprese a carattere industriale garantendo l’occupazione di oltre 81 mila addetti diretti.
Gli scenari
Il quadro macroeconomico nazionale resta fragile. Il PIL italiano è cresciuto dello 0,9% nel 2024 e per il 2025 si prevede un andamento analogo. I prezzi delle bevande alcoliche risultano in deflazione, a fronte di una crescita sostenuta nel comparto alimentare e del food service. A maggio 2025 si è registrato un rimbalzo della fiducia di consumatori e imprese, dopo tre mesi consecutivi di calo. Tuttavia, i volumi di vendita al dettaglio restano deboli, con crescita nei canali discount, segno delle difficoltà ancora presenti nei bilanci familiari.
Nel contesto di un’economia interna ancora cauta, il primo trimestre del 2025 mostra un mercato in lieve assestamento, con alcuni segmenti che confermano segnali positivi. Secondo le rilevazioni
Nomisma per l’Osservatorio Federvini, le vendite nella grande distribuzione organizzata hanno registrato un andamento complessivamente stabile, con dinamiche differenziate tra i comparti.

Il vino ha generato un valore pari a 694 milioni di euro, registrando una lieve flessione dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare il segmento sono gli spumanti di qualità, con il Metodo Classico in crescita del 7,1% e lo Charmat dolce in aumento del 2%. Restano in difficoltà i vini generici e frizzanti, mentre i vini a indicazione geografica protetta (IGP) segnano un +1,1% a valore. Anche il comparto degli spirits risente di una certa debolezza con vendite pari a 274 milioni di euro, in calo del 3,2% sul 2024. Tuttavia, si distinguono performance positive per alcuni segmenti, come il Gin (+14,2%), tengono gli aperitivi alcolici, mentre risultano in flessione Grappa, liquori dolci e amari.
Più positivo l’andamento degli aceti, che nel primo trimestre segnano una crescita dell’1,8% a valore. In particolare, spiccano le performance dell’aceto di mele (+6,4%) e dell’aceto di vino (+1,5%).
L’Aceto Balsamico di Modena IGP subisce invece una lieve contrazione dello 0,7%, pur mantenendo una quota di mercato rilevante, pari al 32% del totale venduto in GDO.
Per quanto riguarda i consumi fuori casa, i dati TradeLab indicano un valore complessivo di 81,4 miliardi di euro nel 2024, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Nonostante una flessione delle visite pari all’1,6%, il settore mostra segnali di tenuta, con vino e bollicine che continuano a giocare un ruolo centrale soprattutto nelle occasioni serali, come cene e aperitivi.
Nonostante le esportazioni di vini, spiriti e aceti italiani abbiano registrato un andamento tendenzialmente positivo nell’ultimo quinquennio, non mancano le preoccupazioni legate a uno scenario attuale instabile che continua a produrre ripercussioni sui costi di approvvigionamento delle materie prime e dell’energia, sull’inflazione e sul tasso di occupazione.
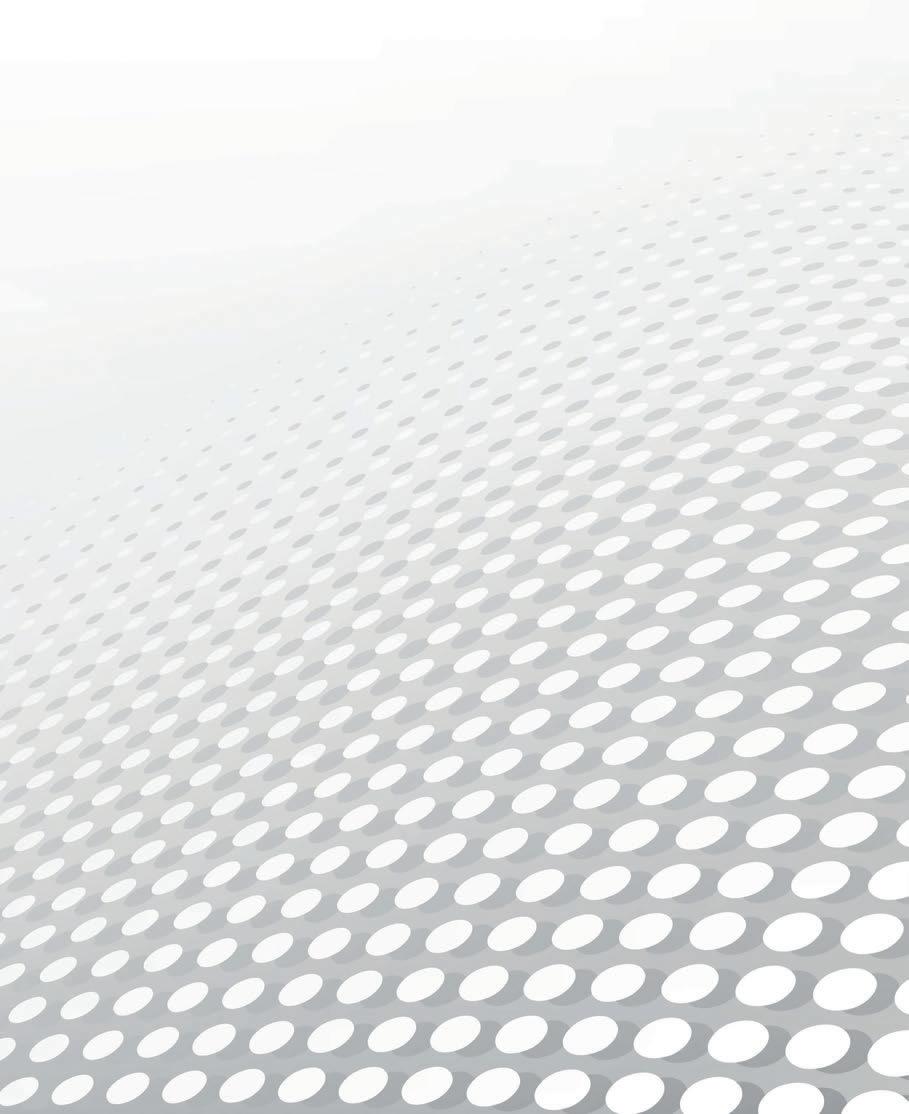




a cura della Redazione
DOI: 10.1016/j.ccr.2024.215689
Gli enzimi artificiali imitano la catalisi a cascata per l’amplificazione e la trasduzione del segnale nella determinazione della qualità degli alimenti: una panoramica dei fondamenti e dei recenti progressi
Artificial enzyme mimics cascade catalysis for signal amplification and transduction in food quality determination: An overview of fundamentals and recent advances. Coordination Chemistry Reviews, Volume 505, 15 aprile 2024
Y. Li, Q. Bao, Z. Wang, Y. Huang, D. Zhang, Y. Shen, J. Cheng, J. Wang
Il rilevamento della qualità alimentare basato su nanozimi svolge un ruolo sempre più importante nel garantire la sicurezza alimentare lungo l’intera catena dell’industria alimentare. Tuttavia, l’insufficiente attività catalitica e la bassa capacità di trasduzione del segnale dei metodi di analisi alimentare basati su nanozimi hanno fortemente limitato la loro ampia applicazione nell’industria alimentare. È incoraggiante che l’enzima artificiale imita la catalisi a cascata ispirata alle attività della vita e ha
mostrato vari vantaggi, come una buona selettività, un’elevata efficienza catalitica attraverso il miglioramento della concentrazione del substrato nel microambiente locale e l’amplificazione e trasduzione del segnale, che possono compensare perfettamente le debolezze di cui sopra e si prevede che migliorerà le applicazioni alimentari del rilevamento basato sui nanozimi. Inoltre, rispetto alla progettazione razionale del nanozima e alle condizioni di reazione esterna, la reazione a cascata è un metodo facile e universale perché il processo non comporta la sintesi del nanozima e il cambiamento dei fattori esterni. Tuttavia, la mancanza di una comprensione sistematica del rilevamento della qualità degli alimenti basato sulla catalisi a cascata degli enzimi che imita, limita la loro applicazione approfondita. I ricercatori hanno discusso in modo esauriente l’amplificazione del segnale e la trasduzione dell’enzima artificiale che imita la catalisi a cascata, i tipi di segnali di uscita, i biosensori sviluppati, i loro recenti progressi nel rilevamento degli alimenti e le prospettive future. Si prevede che questa revisione possa migliorare la praticità delle tecnologie di rilevamento della qualità alimentare basate sui nanozimi nell’industria alimentare.


DOI: 10.1016/j.ifset.2024.103647
Pastorizzazione non termica del latte mediante campo elettrico moderato con elettrodo allungato: analisi chimica e sensoriale durante la conservazione a freddo e determinazione della durata di conservazione
Non-thermal pasteurization of milk by elongated electrode moderate electrical field: Chemical and sensory analysis during cold storage and shelf-life determination. Innovative Food Science & Emerging Technologies, Volume 94, giugno 2024
A. Wali M. Alsaedi, AR. Al-Hilphy, AJ. Al-Mousawi, M. Gavahian
È stato dimostrato che gli elettrodi allungati a campo elettrico moderato (EEMEF), una tecnologia emergente di pastorizzazione del latte, riducono il consumo di energia. Il presente studio mira a studiare gli impatti dell’EEMEF sui parametri sensoriali e chimici e sulla

durata di conservazione del latte. L’EEMEF ha prodotto latte pastorizzato con valore di perossido, pH e acidità simili alla pastorizzazione termica, ma con una durata di conservazione più lunga del 25% e punteggi sensoriali più elevati. La gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) ha rivelato che la pastorizzazione termica alterava significativamente il profilo degli acidi grassi, mentre l’EEMEF colpiva principalmente gli acidi grassi a catena più corta, come l’acido butirrico e caprilico. La spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) rivela che la composizione del latte EEMEF era simile al latte crudo, priva di ampia denaturazione proteica e di prodotti della reazione di Maillard rilevati nel latte pastorizzato. Una durata di conservazione prolungata e una migliore qualità sensoriale e nutrizionale potrebbero motivare le applicazioni industriali dell’EEMEF a raggiungere emissioni nette pari a zero e obiettivi di sviluppo sostenibile.
DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108991
Sopravvivenza di Listeria monocytogenes su verdure congelate durante la conservazione a lungo termine a -18 e -10°C
Survival of Listeria monocytogenes on Frozen Vegetables during Long-term Storage at -18 and -10°C. Journal of Food Protection, Volume 87, numero 3, marzo 2024 ML. Fay, JK. Salazar, DS. Stewart, BA. Khouja, X. Zhou, AR. Datta
Poiché non sono disponibili dati sulla sopravvivenza di L. monocytogenes su verdure IQF durante la conservazione congelata, questo studio ha esaminato la popolazione di sei diversi ceppi (comprendenti i lignaggi 1/2a, 1/2b e 4b) su verdure IQF durante la conservazione a lungo termine.
I ceppi individuali sono stati inoculati su una miscela vegetale IQF a 4 log CFU/g e conservati a -18 o -10°C per 360 giorni. Sebbene siano state osservate fluttuazioni nelle popolazioni di tutti i ceppi sulle verdure durante la conservazione, non sono state osservate differenze significative in base al ceppo, ai lignaggi o alla temperatura. Nel complesso, le popolazioni di L. monocytogenes sono state ridotte solo fino a 0,47 e 0,59 log CFU/g dopo 360 giorni rispettivamente a -18 e -10°C. I risultati di questo studio suggeriscono che L. monocytogenes è in grado di persistere sulle verdure IQF per periodi di tempo prolungati senza una riduzione significativa della popolazione. Studi futuri potrebbero valutare la sopravvivenza e la crescita di L. monocytogenes sulle verdure IQF durante lo scongelamento e la conservazione.

DOI: 10.1016/j.tifs.2024.104486
Biosensore microfluidico abilitato ai nanozimi: uno strumento promettente per l’analisi della sicurezza alimentare in loco
Nanozyme-enabled microfluidic biosensor: A promising tool for on-site food safety analysis. Trends in Food Science & Technology, 10 aprile 2024
X. Zhang, D. Zhu, X. Yang, C. Man, Y. Jiang, Q. Zhao, X. Zhang
La sicurezza alimentare come argomento critico di interesse internazionale ha ottenuto una crescente attenzione in tutto il mondo. Pertanto, è di grande importanza sviluppare metodi di rilevamento sensibili, accurati e rapidi per l’analisi della sicurezza alimentare.
Negli ultimi anni, i nanozimi emergenti sono diventati un’alternativa promettente agli enzimi naturali per lo sviluppo di
biosensori per ottenere analisi sulla sicurezza alimentare, grazie ai loro processi di preparazione più semplici, alla maggiore stabilità, all’efficienza di riciclaggio più elevata e al costo inferiore rispetto a quello dei nanozimi naturali. Per ottenere un rilevamento portatile e in loco, i biosensori basati su nanozimi sono stati integrati con successo con dispositivi microfluidici avanzati (ad esempio, chip microfluidici) per la costruzione di biosensori microfluidici abilitati ai nanozimi, per realizzare il rilevamento rapido di contaminanti alimentari. In questa recensione, sono stati riassunti gli ultimi progressi sui biosensori microfluidici abilitati ai nanozimi e le loro applicazioni nel campo dell’analisi della sicurezza alimentare.
I nanozimi emergenti sono stati combinati con successo con la tecnologia microfluidica, aprendo una nuova strada per l’analisi rapida, sensibile e in loco della sicurezza alimentare.


DOI: 10.1016/j.fufo.2023.100290
Ritorno al futuro: i consumatori sono pronti a mangiare prodotti alimentari a base di pollame nutriti con insetti provenienti da un sistema di agricoltura circolare? Un bilancio per l’Italia
Back to the future: Are consumers ready to eat insect-fed poultry food products from a circular farming system? An assessment for Italy. Future Foods, Volume 9, giugno 2024
G. Tiboldo, L. Arata, S. Coderoni
Lo sfruttamento delle risorse naturali derivanti dall’allevamento del bestiame diminuirebbe se le fonti proteiche convenzionali nelle diete animali fossero parzialmente sostituite con insetti attraverso un approccio di economia circolare. Tuttavia, l’accettazione da parte dei consuma-

tori dei nuovi prodotti animali nutriti con insetti (IF) è fondamentale per il successo finale di tali prodotti. Questo studio analizza la volontà dei consumatori di acquistare carne e uova di pollame IF utilizzando i risultati di un sondaggio online condotto su 780 consumatori italiani.
Nel complesso, i risultati mostrano un atteggiamento positivo dei consumatori italiani intervistati nei confronti dei prodotti animali IF. Inoltre, lo studio dimostra che la neofobia alimentare e l’entomofobia influenzano negativamente l’atteggiamento dei consumatori italiani nei confronti di tali prodotti, mentre la fiducia nel ruolo delle autorità pubbliche nel garantire la sicurezza alimentare ha un impatto positivo su di esso. Inoltre, la propensione dei consumatori verso il cibo sostenibile aumenta la probabilità di acquistare prodotti di origine animale.
DOI: 10.1016/j.foohum.2024.100301
Revisione comparativa delle proprietà nutri-funzionali e sensoriali, dei benefici per la salute e dell’impatto ambientale dei latticini (latte bovino) e del latte vegetale (latte di soia, di mandorle e di avena)
Comparative Review of Nutri-functional and Sensorial Properties, Health Benefits and Environmental Impact of Dairy (Bovine milk) and Plant-Based Milk (Soy, Almond, and Oat milk). Food and Humanity, Volume 2, maggio 2024
P. Vashisht, A. Sharma, N. Awasti, S. Wason, L. Singh, S. Sharma, A. Pradeep Raja Charles, S. Sharma, A. Gill, A. Kaur Khattra
Con le crescenti preoccupazioni circa l’effetto ambientale della produzione di latte lattiero-caseario e i casi elevati di allergie alle proteine del latte e di intolleranza al lattosio, si è verificata una domanda significativa di latte vegetale. Nonostante ciò, il mercato del latte bovino è ancora
stabile grazie alle proprietà funzionali favorevoli e ai nutrienti più biodisponibili. Questa recensione mette a confronto le proprietà nutrizionali, funzionali e sensoriali del latte di mandorle, soia e avena con il latte bovino. Sono stati inoltre discussi i vantaggi intrinseci (benefici per la salute) e i limiti del latte bovino e confrontati con questi latti a base vegetale insieme all’impatto ambientale di ciascun settore. È stato osservato che il latte bovino è intrinsecamente ricco di componenti nutrizionali e presenta caratteristiche funzionali migliori rispetto alle bevande vegetali in esame. Anche i punteggi sensoriali erano più alti. Mentre tra i latti a base vegetale, il mascheramento del sapore era considerato un’opzione praticabile per soddisfare le preferenze dei consumatori. La letteratura ha riportato un minore impatto ambientale dei latti a base vegetale, tuttavia è necessaria un’ampia valutazione della sostenibilità per un migliore confronto con il latte bovino.


a cura della Redazione
L’OSSERVATORIO SULLE PERFORMANCE E SUI MODELLI DI BUSINESS DELLE AZIENDE ITALIANE DEL FOOD REALIZZATO DALL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO E DA CERESIO INVESTORS
Nel 2024, i ricavi del settore sono cresciuti del 5,9% confermando performance superiori rispetto all’economia italiana, con un PIL nazionale fermo sullo 0,7%. Il settore mostra buoni livelli di redditività commerciale con un ROS al 5,7% un ROIC al 6,9%, valori positivi, anche se in lieve calo rispetto agli anni precedenti. La solidità finanziaria resta elevata con un indice di indebitamento pari a 1,19 (mezzi di terzi su mezzi propri).
Per il 2025, il settore food dovrebbe confermare, con un 4,6% il trend positivo, seppure con tassi leggermente inferiori rispetto all’anno precedente. Per il 2026 si prevede una crescita dei ricavi del +4,4%.
Il mercato interno dovrebbe tenere grazie alla positiva dinamica dell’occupazione, che dovrebbe stimolare i consumi e quindi la domanda di prodotti del settore food. La crescita dei salari resta una variabile fondamentale per un salto di qualità dei consumi interni. La positiva evoluzione degli investimenti industriali
conferma come l’industria italiana, in particolare quella del food, stia rispondendo alla sfida della produttività. A livello di comparto, nel 2025 cresceranno significativamente farine (+9,9%), caffè (+6,9%), olio (+6,3%) e surgelati (+5,6%).
Il Food Industry Monitor analizza le performance di un campione di oltre 860 aziende, con un fatturato aggregato di circa 87 miliardi di euro, attive in 15 comparti del settore food. L’osservatorio analizza le performance storiche delle aziende del food dal 2009 al 2024 focalizzandosi sulle seguenti dimensioni: crescita, export, redditività, produttività e struttura finanziaria. Per ogni comparto vengono elaborate previsioni biennali (2025-2026) sulla crescita del fatturato e dell’export e sull’andamento della redditività.
L’export (in valore a prezzi correnti) del settore food, per i comparti analizzati dal FIM (con i relativi codici ATECO), registrerà una crescita del 7,3% nel 2025, leggermente inferiore rispetto al +8,2% del 2024. Le previsioni restano positive anche per il 2026, con un incremento stimato del 7%.
L’export relativo ai comparti mappati dal Food Industry Monitor ha raggiunto i 47 miliardi di euro, di cui circa il 13% destinato agli Stati Uniti. Il vino, da solo, genera esportazioni per oltre 8 miliardi di euro, con circa il 30% del totale diretto verso gli USA. Le esportazioni del comparto food (incluso il vino) sono cresciute del 5,5% nel 2024, in netta ripresa rispetto al -1,6% registrato nel 2023. Tuttavia, è evidente che le politiche dell’amministrazione americana in materia di importazioni potrebbero avere effetti significativi sulle vendite negli USA.
FOCUS SU AZIENDE FAMILIARI, GOVERNANCE E PERFORMANCE
Per la XI edizione del Food Industry Monitor, è stato sviluppato un focus specifico

sugli assetti istituzionali e sui modelli di governance adottati dalle imprese. Il settore food si conferma fortemente caratterizzato da una presenza di imprese familiari, che rappresentano il 67% del campione analizzato (870 aziende). Le analisi sono state condotte anche a livello di comparto. I comparti delle farine (95%), distillati (83%), olio (82%) e caffè (81%) superano l’80% di aziende a proprietà familiare. Anche in comparti caratterizzati dalla presenza di grandi players internazionali, come surgelati, birra e vino, le aziende familiari rimangono prevalenti, seppur con un’incidenza di poco superiore al 50%.
La governance delle imprese varia in base alla natura proprietaria: nelle aziende familiari, il 75,8% è gestito tramite Consiglio di Amministrazione, mentre il 24,2% è guidato da un Amministratore Unico. Nelle aziende non familiari la struttura è più formalizzata, con una netta prevalenza
del CdA (93,6%) e una marginale presenza dell’Amministratore Unico (6,4%). Dal punto di vista della composizione di genere dei CdA si evidenzia come le aziende familiari presentino una quota di donne nei CdA del 24,7%, sensibilmente più alta rispetto al 10,1% rilevato nelle aziende non familiari.
Il settore del food evidenzia una buona longevità delle imprese, infatti il 53,3% delle aziende familiari del campione è guidata da esponenti della terza generazione, mentre un ulteriore 36,8% ha superato la terza, solo il 9,9% delle aziende è guidata dalle prime due generazioni. I comparti con la prevalenza di aziende di prima e seconda generazione sono: farina, pasta distillati e dolci. I comparti con le aziende più longeve, arrivate oltre la terza generazione, sono: birra, olio, farine e acqua. Dal punto di vista delle performance economiche, le aziende familiari si distinguo-
no per risultati mediamente superiori alle non familiari. Il ritorno sul capitale investito (ROI) e il Return on Equity (ROE) sono sensibilmente superiori per le aziende familiari. In generale, per tutte le aziende, i modelli di governance evoluti determinano performance superiori. In particolare la presenza di una leadership collegiale, cioè una distribuzione delle deleghe tra più figure, migliora significativamente le performance, con effetti positivi sui principali indici di redditività. Ancora più rilevante è l’effetto positivo della presenza di amministratori che siano anche parte della compagine proprietaria: la presenza nei CdA di consiglieri-azionisti, infatti, porta a un miglioramento significativo del ROA. Nelle imprese familiari, la presenza di un presidente familiare, che esercita il ruolo di collegamento strategico tra famiglia e impresa, ha un’influenza rilevante sulle performance reddituali.

SimonaRispoli,StefaniaVolpe,ElenaTorrieri
Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare (GSICA)
Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II
STRATEGIE INNOVATIVE DI CONSERVAZIONE DEL POMODORO PREVEDONO L’UTILIZZO DI REGOLATORI
DELLA SINTESI DELL’ETILENE PER RIDURRE LE PERDITE DI PRODOTTO SENZA COMPROMETTERE LE QUALITÀ NUTRIZIONALI E ORGANOLETTICHE DEL FRUTTO
Lo spreco alimentare rappresenta una delle sfide più urgenti a livello globale, con conseguenze significative dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Secondo la FAO, circa un terzo del cibo prodotto per il consumo umano viene perso o sprecato lungo la filiera agroalimentare, corrispondente a circa 1,3 miliardi di tonnellate all’anno con i maggiori contributi provenienti da Stati Uniti, Australia, Europa e Asia Orientale. Una delle possibili soluzioni è il continuo mi -
glioramento delle tecnologie di conservazione e distribuzione al fine di ridurre le perdite dovute al deperimento degli alimenti (FAO, 2011).
Il pomodoro ( Solanum lycopersicum ) è uno degli ortaggi più consumati al mondo e riveste un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana grazie al suo profilo nutrizionale. Nonostante i suoi benefici, il pomodoro presenta sfide significative in termini di conservazione, a causa dell’alto contenuto di acqua e della sua natura climaterica, che lo rende
suscettibile a un rapido deterioramento. L’etilene svolge un ruolo cruciale nella maturazione del pomodoro e nella sua conservazione. Strategie innovative di conservazione del pomodoro prevedono l’utilizzo di regolatori della sintesi dell’etilene per ridurre le perdite di prodotto senza compromettere le qualità nutrizionali e organolettiche del frutto. I coating a base di biopolimeri possono rappresentare una soluzione innovativa e sostenibile grazie alla loro capacità di ridurre gli scambi di umidità e gas e pre -
I coating a base di biopolimeri riducono gli scambi di umidità e gas e preservano le caratteristiche organolettiche del prodotto

Nonostante i suoi benefici, il pomodoro presenta sfide significative in termini di conservazione, a causa dell’alto contenuto di acqua e della sua natura climaterica, che lo rende suscettibile a un rapido deterioramento
servare le caratteristiche organolettiche del prodotto. Questi rivestimenti sono generalmente composti da proteine, polisaccaridi o lipidi, spesso combinati con plastificanti per migliorare la loro resistenza e flessibilità (Valentino et al., 2020). Uno studio condotto sui pomodori ciliegino minimamente processati trattati con acqua attivata al plasma (PAW) e un rivestimento edibile a base di caseinato di sodio ha evidenziato una riduzione della degradazione qualitativa del prodotto, attribuibile sia all’effetto barriera del rivestimento che all’azione degli antiossidanti incorporati (Volpe et al., 2023).
L’obiettivo del presente lavoro è stato valutare l’effetto del coating edibile ottimizzato da Volpe et al. (2023) costituito da caseinato di sodio (SC), gomma guar (GG) e cera d’api (BW) sulla velocità di respirazione e sulla produzione di etilene
di pomodorini ciliegini conservati a diverse temperature. Il lavoro contribuisce a comprendere il ruolo dei coating edibili a base di biopolimeri nel preservare la qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi.
METODOLOGIE
Per la sperimentazione sono stati utilizzati pomodori ciliegino della varietà “Creativo”. Il coating è stato preparato miscelando in acqua caseinato di sodio, glicerolo, gomma guar, e cera d’api. Alla soluzione sono stati aggiunti emulsionanti in rapporto di 4:1 rispetto alla cera. Dopo omogeneizzazione è stato aggiunto il gallato di propile. Il coating è stato applicato sui pomodorini mediante immersione per 2 minuti nella soluzione a base di biopolimeri, e successiva sgrondatura e asciugatura a temperatura ambiente. La velocità di respirazione (mL kg -1 h -1) e di produzione di etilene (μl
kg -1 h -1) è stata misurata in un sistema chiuso a temperature controllate (5°C, 10°C, 15°C, 20°C).
PRINCIPALI RISULTATI
La Figura 1 mostra i risultati relativi alla velocità di respirazione espressa come velocità di consumo dell’ossigeno dei campioni di pomodorino ricoperti con coating e del campione controllo, non coperto con coating. Il coating ha un effetto protettivo riducendo la velocità di respirazione del prodotto di circa il 20% a tutte le temperature a eccezione di 5°C.
La produzione di etilene nei pomodori ciliegino segue un andamento crescente nel tempo fino al raggiungimento del picco massimo e poi segue una decrescita (dati non mostrati). Per valutare l’effetto del coating e della temperatura è stata calcolata la velocità di produzio -

Figura 1. Velocità di respirazione (RRO2) dei campioni di pomodoro controllo (■) e con coating (■) a 5°C, 10°C, 15°C e 20°C, in aria. Lettere differenti corrispondono a valori significativamente differenti (p < 0.05) per l’effetto temperatura. * indica differenze statisticamente significative tra il campione controllo e coating (p < 0.05)
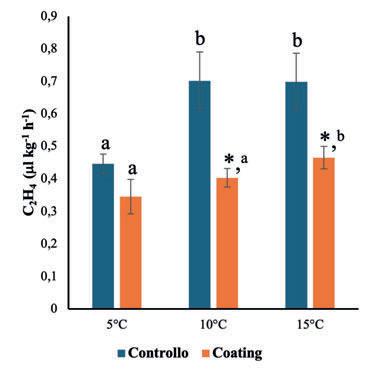
Figura 2. Velocità di produzione di etilene (C2 H4) dei campioni di pomodoro controllo (■) e con coating (■) a 5°C, 10°C e 15°C, in aria. Lettere differenti corrispondono a valori significativamente differenti (p < 0.05) per l’effetto temperatura. * indica differenze statistiche (p < 0.05) tra il campione controllo e coating
ne di etilene (fino al picco di massima produzione) espressa in μl kg -1 h -1. Come si evince dalla Figura 2, la velocità di produzione dell’etilene aumenta all’aumentare della temperatura per entrambi i campioni. Il coating riduce significativamente la produzione di etilene a 10°C e 15°C rispetto al campione controllo. In particolare, a 10°C il coating riduce del 42,6% la produzione di C 2H 4 rispetto al controllo mentre a 15°C la riduce del 33,5%.
Lo studio ha messo in evidenza come il coating edibile a base di caseinato di sodio, gomma guar e cera d’api possa rappresenta una soluzione tecnologica per rallentare i fenomeni di respirazione e la produzione di etilene dei pomodorini, fenomeni critici per la conservazione del prodotto in post raccolta. Ulteriori analisi sono in corso per valutare l’impatto del coating sugli aspetti di sicurezza d’uso del prodotto.
§ FAO. 2011. Global food losses and food waste - Extent, causes and prevention. Rome
§ Valentino, M. et al., 2020. Active Biopolymer Coating Based on Sodium Caseinate: Physical Characterization and Antioxidant Activity. Coating, 10 (8), 1-12. 10.3390/coatings10080706
§ Volpe, S. et al.2023. Effect of Plasma Activated Water and Sodium Caseinate Based Coating on the Quality of Minimally Processed Cherry Tomatoes during Storage. Chemical Engineering Transactions, 102, 205-210
FBCA, ASSOGRAFICI, UTILITALIA, COMIECO, UNIRIMA E ASSOCARTA INSIEME PER OTTIMIZZARNE LA GESTIONE INTEGRATA E RISPONDERE ALLE SFIDE NORMATIVE
FBCA, Assografici, Utilitalia, Comieco, Unirima e Assocarta hanno avviato una collaborazione strategica per potenziare la raccolta e il riciclo dei cartoni per bevande e alimenti, rispondendo alle sfide poste dal nuovo quadro normativo europeo, con un’attenzione particolare al nuovo Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. I cartoni per bevande e alimenti, composti in media da circa il 75% di carta e da una parte di plastica (~21%) e alluminio (~4%), sono progettati per essere riciclabili e valorizzabili in nuovi prodotti.
La collaborazione, che si sviluppa attraverso un tavolo tecnico, mira a rafforzare la sinergia tra tutti gli attori della filiera per ottimizzare la gestione di questi imballaggi e garantire il recupero e riciclo di tutte le sue componenti. In particolare, la filiera si concentra sull’individuazione e la realizzazione di idonee soluzioni operative relative a tutte le fasi della gestione del post-consumo, dalla raccolta differenziata fino ai flussi di recupero e riciclo, per raggiungere obiettivi di circolarità ambiziosi, rispondendo alle aspettative degli stakeholder e del mercato. Strategico è il coinvolgimento degli attori territoriali, quali gli enti locali, i gestori e gli impianti. Garanzia del successo è la capacità di mettere in campo risorse e competenze a tutti i livelli, anche grazie a soluzioni impiantistiche specifiche e a progetti pilota capaci di adattarsi alle specificità dei vari contesti.

“Con un immesso al consumo in Italia di circa 90.000 tonnellate l’anno, i cartoni per bevande e alimenti rappresentano una risorsa preziosa per l’economia circolare. Questa iniziativa condivisa è un passo importante per il sistema: mettiamo a valore la collaborazione tra industria, utility, consorzi e territorio per sviluppare soluzioni operative, condivise e scalabili. Solo così possiamo rispondere in modo concreto e credibile alle nuove sfide
normative e ambientali”, ha affermato Micol Bertoni, Direttore Italia di FBCA. “Come associazione di categoria dell’industria dei cartoni per bevande ci impegniamo a favorire la condivisione di conoscenze e informazioni puntuali, l’individuazione degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi, nonché a garantire la coerenza di intenti degli attori coinvolti”, ha dichiarato il Direttore Generale di Assografici, Maurizio D’Adda.

GLI SNACK TRAINANO UNA CRESCITA DA 7 MILIARDI DI EURO NELLE VENDITE DEI BENI DI LARGO CONSUMO IN EUROPA. REGNO UNITO E GERMANIA GUIDANO LE VENDITE IN VALORE, MENTRE LE ABITUDINI EVOLVONO a cura della Redazione
Il mercato europeo degli snack ha raggiunto un valore di 234 miliardi di euro nel 2024, in crescita del +2,9% su base annua, con un incremento di 7 miliardi di euro, nonostante i volumi venduti siano rimasti stabili a 115 miliardi di unità. È quanto emerge dalla nuova analisi “Snack Unwrap: The Insatiable Craving for Growth” di Circana, consulente globale sulla complessità del comportamento dei consumatori, che evidenzia come oggi gli snack rappresentino il 40% del valore delle vendite di alimentari confezionati in Europa.
Se l’inflazione resta un fattore, la crescita dei volumi è guidata da categorie funzionali e orientate alla salute, come: cereali e barrette per la colazione (83,6 milioni; +6,0%), frutta secca e disidratata (160,2
milioni; +4,9%), formaggi (478,4 milioni; +3,1%) e yogurt (303,2 milioni; +3,5%). Questi prodotti sono sempre più protagonisti nelle occasioni di consumo di snack.
L’analisi di Circana si basa su dati vendita al dettaglio di sei mercati chiave: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e include 628 segmenti tra snack dolci, salati, freschi, surgelati e funzionali, offrendo una panoramica del comportamento dei consumatori, mettendo in evidenza i trend, le innovazioni e i brand che guideranno la crescita futura.
Ananda Roy, SVP Thought Leadership ed Europe CPG Growth Advisor di Circana, ha dichiarato: “La corsia degli snack è diventata lo specchio dello stile di vita moderno, plasmata da nuove tendenze legate a dieta, abitudini e momenti di con-
sumo che vanno oltre quelli tradizionali. Per restare rilevanti, i brand globali devono bilanciare gusti locali con motivazioni di consumo universali come piacere, praticità e benessere. Il successo non si misura solo in quote di mercato, ma in capacità di essere rilevanti. Per vincere, bisogna trattare meno gli snack come una categoria e più come una cultura: fluida, ibrida e in continua evoluzione”.
SNACK SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI
La categoria degli snack sta evolvendo più rapidamente rispetto a qualsiasi altro momento dopo la pandemia, spinta da un’ondata di trend che riflettono priorità salutistiche, stili di vita e bisogni emotivi in cambiamento.
Dalle opzioni ad alto contenuto proteico

Il mercato europeo degli snack ha raggiunto un valore di 234 miliardi di euro nel 2024, in crescita del +2,9% su base annua
o per la salute intestinale, agli snack minimamente processati, i consumatori compiono scelte più intenzionali, alla ricerca di energia, equilibrio o comfort.
Aumentano le proposte con la formula “piacere sì, ma dalle porzioni controllate” e le alternative plant-based, insieme ai trend virali e alle occasioni social a dimostrazione che la crescita odierna non è legata solamente alla mera funzione ma anche all’emozione suscitata.
I supermercati continuano a dominare il mercato europeo degli snack, rappresentando il 50% del valore complessivo delle vendite e una crescita del +2,1% nei volumi. I discount rivestono un ruolo sempre più importante, generando 44 miliardi di euro di vendite e registrando crescita sia in valore che in volume.
Al contrario, i negozi di prossimità mostrano un calo nei volumi, mentre gli iper-
mercati restano stabili. Siti eCommerce e canali specializzati più piccoli, pur con una quota complessiva minore, sono quelli a registrare i tassi di crescita più elevati, evidenziando opportunità emergenti nel digitale e nel retail di nicchia.
I Paesi Bassi (44,6%) e l’Italia (43,2%), tra i sei principali mercati europei, vantano le quote valore più alte per gli snack, confermando il forte orientamento dei consumatori verso questa categoria.
Nel frattempo, la Germania (60 miliardi di euro; +2,5%) e il Regno Unito (53 miliardi di euro; +3,6%) guidano per vendite totali in valore, riflettendo la maturità dei rispettivi mercati e il ruolo centrale degli snack nelle principali economie del ramo beni di largo consumo europeo.
Raccomandazioni per retailer e produttori:
§ Passare dall’impulso all’intenzionalità: costruire strategie di portfolio adatte alle nuove occasioni di consumo, ad
esempio prima dell’allenamento, durante i pasti o per rilassarsi la sera.
§ Accelerare l’innovazione funzionale: valorizzare claim come alto contenuto proteico, benefici per la salute intestinale, energia e prodotti poco processati per attrarre i consumatori più attenti al benessere.
§ Ridefinire i KPI di successo: oltre alle unità vendute, misurare il successo in base alla capacità di entrare in nuove occasioni di consumo, sinergie di merchandising e rilevanza nei diversi momenti della giornata.
§ Ottimizzare l’assortimento in modo dinamico: usare analytics granulari per prevedere la domanda, stabilire promozioni mirate e monitorare la performance della categoria in base alle occasioni di consumo snack.
§ Bilanciare premium e permissività: sostenere sia i formati indulgenti sia quelli più salutari, dalle confezioni piccole e snack “nostalgici” che ricordano il passato, alla frutta fresca e agli snack proteici.

Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Gaetano Forte
AGGIORNAMENTI E SEMPLIFICAZIONI DALLA UE
Le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia sono in fermento per la prossima applicazione del Reg. UE 1115/2023 sulla deforestazione (EUDR European Deforestation Regulation) che, come noto prefigge l’obiettivo di ridurre l’impatto dei consumi europei sulla deforestazione globale, promuovendo un mercato di prodotti pù sostenibili. Tali prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e certificati come “a deforestazione zero” ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. L’applicazione prevista originariamente per fine 2024 è stata prorogata di un anno e quindi è slittata al 31 dicembre 2025, salvo per le piccole e microimprese per le quali la deadline è il 30 giugno 2025. Ad aprile di quest’anno sono intervenuti due importanti aggiornamenti dei seguenti documenti: la Comunicazione della Commissione C/2024/6789 recante “Do-
cumento di orientamento per il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero” nonché le FAQ (versione 4).
Inoltre, il 23 aprile 2025 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, che riporta l’elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a.
GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULL’EUDR
La Comunicazione C/2024/6789
Tale documento si occupa specificamente delle definizioni di «immissione sul mercato», «messa a disposizione sul mercato» ed «esportazione», di «operatore», contiene inoltre uno schema in merito alla data di entrata in vigore e tempistica per l’applicazione definendo i casi relativi al periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore
del 29 giugno 2023 e la data di applicazione del 31 dicembre 2025 e per le piccole e microimprese del 30 giugno 2025.
In essa sono reperibili diversi strumenti comprese una serie di domande per l’accertamento della dovuta diligenza e l’individuazione del «rischio trascurabile».
Viene definito il ruolo dei commercianti PMI e non PMI, i cui obblighi sono più ampiamente dettagliati nelle FAQ.
La comunicazione chiarisce il ruolo di specialità dell’EUDR rispetto alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) la cui applicabilità è stata tuttavia prorogata. Sono inoltre offerti chiarimenti del concetto di «complessità della catena di approvvigionamento» che è strumentale sia alla valutazione del rischio, che alla possibilità di accedere alla due diligence semplificata di cui all’art. 13 EUDR, che consente di non effettuare la valutazione del rischio e di adottare le relative misure di mitigazione, a condizione che l’acquisto avvenga da Paesi considerati a basso rischio.

I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e certificati come “a deforestazione zero” ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020
Si forniscono inoltre chiarimenti sulla legalità e quindi su concetto di conformità alla legislazione dei Paese di produzione, sul sistema di dovuta di diligenza e sulla sua costruzione nonché sui prodotti composti.
Un chiarimento particolare, ripreso poi dalle FAQ, è la tematica degli imballaggi per i quali emerge che sono soggetti al regolamento:
§ materiali da imballaggio commercializzati come prodotti a sé stanti;
§ contenitori che conferiscono carattere essenziale al prodotto, mentre non sono soggetti al Regolamento:
§ materiali da imballaggio presentati con il prodotto e usati solo per proteggerlo, sostenerlo o trasportarlo.
Un punto specifico viene dedicato ai sistemi di certificazione per i quali viene chia-
rito che gli stessi non possono sostituire gli adempimenti dell’EUDR in quanto strumenti che rimangono volontari.
Le FAQ versione 4
Le FAQ di aprile 2025 contengono elementi di particolare significatività a livello interpretativo in quanto consentono una serie di semplificazioni molto importanti per i soggetti interessati. Queste presentano un’ampia disamina della tracciabilità e delle modalità per effettuare la geolocalizzazione (punto 1) e del sistema informativo (punto 7).
Tra gli aspetti più rilevanti si segnalano:
§ Adempimenti degli operatori/commercianti non PMI a valle della catena di approvvigionamento (cc. Downstream operator/traders)
In base all’art. 8 par. 9 dell’EUDR, in caso di prodotti già corredati da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) gli operatori/commercianti non PMI possono fare riferimento a tali dichiarazioni (richiamandole nella dichiarazione di dovuta diligenza che essi sono comunque tenuti a presentare al sistema informativo) purché accertino che gli operatori a monte abbiano esercitato la dovuta diligenza (ossia che abbiano raccolto informazioni, tra cui la geolocalizzazione, abbiano svolto la valutazione del rischio e, nel caso in cui questo non sia nullo o trascurabile, che abbiano adottato le relative misure di mitigazione del rischio).
Nella prima versione delle FAQ tale “accertamento” implicava comunque una serie di verifiche sulla filiera.
In base alle nuove FAQ, è stato chiarito
Il 31 dicembre 2025 costituisce la prima deadline per l’applicazione dell’EUDR per le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio e soia

che tale accertamento può essere svolto attraverso la raccolta e verifica della validità (mediante il sistema informatico) delle dichiarazioni di dovuta diligenza dei propri fornitori. Situazione che indubbiamente rende meno impattanti gli obblighi di tali soggetti.
§ Trasformazione
Le FAQ chiariscono che l’attività di trasformazione è considerata rilevante solo se comporta il cambio del codice doganale. Il che significa che in tal caso il soggetto è qualificabile come commerciante (trader) e non un come operatore (downstream operator). A titolo esemplificativo si riporta il caso di chi effettua la torrefazione del caffè (codice HS 0901) che non cambia nelle prime quattro cifre rispetto alla materia prima originaria.
§ Gruppi di impresa
Interessante il chiarimento fornito in relazione ai Gruppi di ogni impresa, che non rilevano ai fini dell’EUDR, in quanto ogni ente deve presentare la propria DDS. Eventualmente è possibile individuare una delle imprese del Gruppo come mandata-
rio, ossia un soggetto che può presentare la dichiarazione di dovuta diligenza in nome e per conto di un altro soggetto.
§ Esportazione
Semplificazioni anche per l’export: gli operatori che esportano prodotti realizzati con merci o altri prodotti già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza possono avvalersi anche delle pertinenti semplificazioni.
§ Modalità e tempistiche per la DDS
Le FAQ chiariscono che sarà possibile presentare una DDS per diversi lotti o spedizioni e che questa può coprire le quantità di prodotti immesse sul mercato, messe a disposizione o esportate per la durata di 1 anno.
Benchmarking Paesi
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 sono stati definiti i paesi a basso e alto rischio espressamente riportati nell’allegato I. Tutti gli altri Paesi non indicati nell’allegato al regolamento sono a rischio standard. Tale classificazione è strumentale alle
verifiche delle autorità competenti sugli operatori e sui commercianti riguardanti i sistemi di dovuta diligenza e la conformità dei prodotti interessati; all’applicazione della dovuta diligenza semplificata (che consente andare esenti dalla valutazione del rischio e dall’adozione di misure di mitigazione) ex art. 13 del regolamento; alla valutazione del rischio da parte degli operatori e dei commercianti soggetti alla dovuta diligenza completa.
CONCLUSIONI
Il 31 dicembre 2025 costituisce la prima deadline per l’applicazione dell’EUDR per le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia. I recenti documenti emessi dalla Commissione europea e il Regolamento di esecuzione sulla classificazione dei Paesi costituiscono uno strumento molto importante per la definizione degli obblighi in particolare alla luce di diverse semplificazioni che dovrebbero rendere l’adempimento al complesso regolamento meno gravoso.
4° edizione
11-12 NOVEMBRE 2025
Alla luce delle sfide globali che l’industria alimentare è chiamata ad affrontare, AlimentiPiù ha tracciato gli scenari di mercato e di consumo, con un’attenzione ai temi della sostenibilità delle filiere tecnologie della
2 GIORNATE
www.alimentipiu.it
info@alimentipiu.it

10 SESSIONI 35 RELATORI

a
cura della Redazione
ROBOT SCARA DI FANUC
FANUC amplia la sua gamma di robot SCARA con il nuovo SR-12iA/C, una soluzione progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti che richiedono alti standard di pulizia e sicurezza. Grazie alla certificazione ISO Classe 5 per camere bianche, al grado di protezione IP65, al lubrificante food grade e ai bulloni antiruggine, il nuovo SCARA SR-12iA/C è ideale per l’industria alimentare.
Il robot SCARA SR-12iA/C è stato progettato per operazioni di movimentazione, assemblaggio, ispezione e prelievo/imballaggio che richiedono procedure di pulizia rigorose. Il suo design robusto e la resistenza agli agenti corrosivi lo rendono una soluzione affidabile anche negli ambienti più gravosi.
Tra le sue caratteristiche distintive spicca il soffietto protettivo per il mandrino dell’as-
se Z, un elemento unico nel suo genere che lo differenzia dai modelli concorrenti e assicura la massima protezione durante le operazioni di lavaggio.
Dotato di un braccio robusto, lo SCARA SR-12iA/C supporta un carico utile massimo di 12 kg, il doppio rispetto al precedente modello food grade di FANUC, con una portata di 900 mm. Il nuovo SCARA FANUC semplifica l’integrazione grazie a servizi completamente integrati, con I/O, alimentazione a 24V CC, elettrovalvole e circuiti dell’aria tutti interni al corpo del robot. Il design ultracompatto


riduce al minimo le interferenze con dispositivi periferici, consentendo la realizzazione di celle automatizzate più piccole ed efficienti.
www.fanuc.eu
Altopack, azienda toscana specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’automazione industriale lancia sul mercato una nuova versione della macchina AOD.
Presentata in anteprima durante la fiera IPACK-IMA 2025, la nuova AOD Ultra si inserisce all’interno della linea EcoFriendly®, il portafoglio Altopack di macchine progettate per massimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.
Tra le principali innovazioni introdotte, spicca la sostituzione di tutti i corpi riscaldanti con un nuovo sistema di saldatura a freddo che permette di abbattere la potenza assorbita di circa il 70%.
I dispositivi di saldatura longitudinale e trasversale a ultrasuoni consentono di ridurre la fascia della bobina e il passo di taglio alleggerendo i costi di oltre 20 tonnellate di film all’anno. Inoltre,
la precisione del sistema, permette di non avere scarti dopo una sosta ed evita la presenza di frammenti di pasta nella saldatura, escludendo il rischio di confezioni difettose e contribuendo così a una produzione più snella e sostenibile ma anche attenta alla salute e sicurezza dei lavoratori perché si annullano i rischi di scottature accidentali.


La nuova AOD Ultra può essere equipaggiata con il Display EcoFriendly®, un dispositivo pratico ed elegante che misura in tempo reale la carbon foot -
print della macchina durante il ciclo produttivo. Uno strumento concreto per monitorare e comunicare l’impatto ambientale.
ALTOPACK www.altopack.com
EiQ industrial propone una linea completa di quadri elettrici e accessori hygienic design realizzati in acciaio inox, sviluppati per andare incontro ai costruttori di macchine e agli esperti di automazione industriale a rispettare normative igienico-sanitarie sempre più rigide.
Le soluzioni presentano componenti con design igienico certificato e sono testate per garantire elevati gradi di protezione e resistenza agli impatti meccanici. Realizzata in acciaio inox Aisi 304 o Aisi 316, la Cassa HEN Series presenta un’anta sp. 2mm a profilo squadrato, garantisce un’apertura a 180° tramite cerniere esterne e sistema di chiusura brevettati e certificati EHEDG. Il cielo inclinato di 30° copre l’anta e impedisce il deposito di polvere e liqui -
di agevolando lo scolo, mentre la guarnizione siliconica blu, conforme alle normative FDA, assicura i gradi di protezione IP66 e IP69 consentendone il lavaggio con acqua ad alta pressione e a temperature elevate.
La cassa è completa di piastra interna di cablaggio realizzata in FeZn sp. 2,5mm. L’intera carpenteria è certificata 3-A, rendendola idonea all’uso in impianti a contatto con alimenti. Questa configurazione garantisce la completa conformità alle linee guida dettate da EHEDG e alle normative igieniche internazionali.
EIQ INDUSTRIAL www.eiqindustrial.com


DECARBONIZZARE, RISPARMIARE RISORSE NATURALI, RICICLARE E RIUTILIZZARE: I QUATTRO MUST DI RELICYC
Raccolta, selezione, riciclo e riutilizzo dei materiali: sono queste le quattro imprescindibili fasi in cui si articola un processo di produzione dei pallet in plastica orientato alla decarbonizzazione e al recupero come quello di Relicyc, reso possibile dall’impiego di tecnologie di stampaggio efficienti e dalla gestione del materiale a fine vita, con benefici tangibili in termini di riduzione delle emissioni e sostenibilità complessiva del comparto.
La raccolta di plastiche dismesse provenienti da scarti industriali e imballaggi postconsumo è lo starting point necessario per ridurre le emissioni di CO₂, il consumo di risorse vergini e la produzione di rifiuti. Subito dopo, un’accurata selezione per tipologia di polimero è fondamentale per garantire la qualità del pallet riciclato e la resistenza del prodotto finale; più omogeneo è il materiale di partenza, meglio avverrà il riempimento dello stampo, così da ottenere un
risultato omogeneo e privo di punti deboli. Si passa poi alla pulizia e macinazione: le plastiche raccolte vengono selezionate per mezzo di macchinari e verificate da un operatore specializzato, con lo scopo di eliminare qualunque impurità prima che vengano ridotte in piccoli frammenti. Questo step è essenziale per ottenere un materiale pulito e pronto per il riciclo. Nell’eventuale fase di estrusione e pellettizzazione, i frammenti plastici vengono fusi ad alta temperatura e filtrati per rimuovere le ultime impurità. Il materiale fuso viene poi “formato” in granuli che diventano la nuova materia prima per la produzione dei pallet, grazie allo stampaggio a iniezione, che permette di ottenere prodotti robusti, precisi e con scarti minimi, massimizzando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. RELICYC www.relicyc.com/it/


Dalla sensoristica intelligente alla produzione ottimizzata: Omnia Technologies e ifm electronic digitalizzano i processi di EasyBräu-Velo per una nuova frontiera dell’efficienza industriale.
La collaborazione tra Omnia Technologies e ifm dimostra come la digitalizzazione stia contribuendo a plasmare in meglio il futuro dell’industria delle bevande. Uno dei risultati di questa collaborazione è il progetto sviluppato per EasyBräu-Velo dove una sensoristica all’avanguardia garantisce processi trasparenti nella sala di cottura per la produzione di birra. Easybräu-Velo sviluppa e produce sale cottura e macchinari completi per la produzione di birra industriale e artigianale. L’azienda si è posta l’obiettivo di ottimizzare il processo di produzione della birra attraverso soluzioni di automazione innovative.
Nella sala cottura, dove con il malto e l’acqua viene prodotto il mosto della birra, vengono utilizzati diversi sensori ifm per misurare, ad esempio, il livello, il flusso, la pressione o la temperatura. Poiché tutti i sensori sono dotati di tecnologia di comunicazione digitale IO-Link, i dati non vengono trasmessi solo al sistema di controllo, ma anche al livello IT, dove vengono analizzati per ottimizzare il processo di produzione della birra. Il nuovo flussimetro SM Foodmag per applicazioni igieniche è il primo sensore di questo tipo a essere dotato di IO-Link. In questo modo colma la lacuna finora esistente nel processo alimentare digitalizzato e amplia ulteriormente le possibilità di monitoraggio e controllo degli impianti: con un unico sen-


sore, si possono rilevare tre importanti grandezze di misura, come flusso, conducibilità e temperatura. Inoltre, il sensore trasmette anche informazioni sulla direzione del flusso e sulla presenza del fluido, fornendo così una visione completa del processo.
Con il nuovo ReBeL Move, igus dimostra ancora una volta che l’automazione dei processi non deve necessariamente essere costosa o complicata. Il robot mobile sviluppato dall’azienda di Colonia è in grado di spostarsi in modo autonomo nei capannoni, trasportando la merce da un punto a un altro. Questo sistema può essere abbinato al Cobot ReBeL, realizzato in plastica ad alte prestazioni. Per la messa in servizio serve solo un’ora e non sono richieste particolari competenze informatiche.
I robot mobili autonomi (AMR) semplificano le attività quotidiane nelle aziende industriali: gli operatori che lavorano sulle macchine, ad esempio, non devono più andare a piedi a recuperare attrezzi o prendere materiali dal magazzino, ma possono contare sull’aiuto dei veicoli robotizzati. Vantaggi riconosciuti anche da un numero crescente di piccole e medie


imprese che vedono nell’automazione la chiave per aumentare la produttività e ridurre i costi.
IGUS www.igus.it
BITZER prosegue lungo la strada della progettazione ecocompatibile con i suoi innovativi evaporatori ibridi a falling film. Tra i prodotti di punta proposti da BITZER spiccano infatti gli evaporatori ibridi a falling film, conformi ai requisiti di efficienza del regolamento UE Ecodesign e con una potenza frigorifera che va da 300 a 2000 kW. Grazie a questo plus distintivo, offrono flessibilità e una varietà di campi di applicazione, soprattutto nella climatizzazione e nel raffreddamento di processo. Disponibili in cinque diametri mantello e ottimizzati per i refrigeranti R134a, R1234ze e R513A, gli evaporatori a fascio tubiero ottengono efficienze decisamente superiori rispetto a quelli a espansione secca nell’impiego a pieno carico e, in particolare, a carico parziale. Mostrano inoltre un comportamento stabile in tutte le
condizioni di lavoro, grazie alla separazione delle gocce di liquido ottimizzata, a una minore carica di refrigerante e a un migliore recupero d’olio: garantiscono così bassi costi di manutenzione.
Il loro speciale design assicura che il lato del mantello non sia completamente allagato di refrigerante ed è stato studiato per ridurre almeno del 35% l’utilizzo di refrigerante rispetto ai tradizionali evaporatori allagati. Il liquido, nello specifico, viene accuratamente distribuito sulla superficie del tubo, mentre viene allagata solo una piccola parte


del lato mantello. Per questo, gli innovativi evaporatori a falling film ibridi sono considerati l’evoluzione degli evaporatori allagati.
Nel settore del Food & Beverage le etichette in bobina rappresentano una soluzione versatile e di alta qualità per il confezionamento dei prodotti. In questo variegato mondo operano realtà artigianali che necessitano prevalentemente di etichette per l’applicazione manuale in piccole tirature, mentre le grandi aziende dotate di impianti di confezionamento prediligono soluzioni per applicazione automatica in volumi più elevati. Labelys.it, il web-to-print del Gruppo Labelys per il mercato italiano, offre la possibilità di ordinare online etichette in bobina su misura per ogni esigenza. La produzione interamente europea assicura elevati standard qualitativi, massima trasparenza e tempi di lavorazione rapidi, dalle piccole tirature per applicazione manuale (a partire da 25 unità) fino alle grandi produzioni per linee automatizzate ad alta rotazione. La crescente attenzione alla sostenibilità ha reso
fondamentale l’utilizzo di materiali eco-responsabili. L’ampia gamma di supporti per la stampa di etichette in bobina proposti da Labelys.it comprende soluzioni come il PLA trasparente compostabile, ideale per prodotti alimentari freschi e confezionati, come latticini e succhi, che richiedono una visibilità, e la carta in fibra di canna da zucchero, perfetta per prodotti premium come vini e distillati.


LABELYS www.labelys.it
PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI LISTERIA MONOCYTOGENES
NEGLI STABILIMENTI ALIMENTARI
La Listeria monocytogenes continua a essere l’assillo per i produttori di alimenti e una sfida continua per chi si occupa di processi di sanificazione. Adattabile, opportunista, capace di sopravvivere in alcune delle più comuni condizioni di conservazione e persistente nell’ambiente anche per anni e in condizioni avverse.
È il batterio responsabile della listeriosi, una patologia di origine alimentare che secondo i dati ufficiali è continuata a crescere in modo statisticamente significativo nell’Unione europea tra il 2009 e il 2018. Ancora nel 2022 la listeriosi è stata l’infezione di origine alimentare che ha pre-

occupato di più, con i tassi di decesso (insieme a Salmonella) fra i più alti segnalati negli ultimi 10 anni in Europa. L’Italia, nello stesso anno, ha riportato tre focolai epidemici particolarmente gravi in termini di ospedalizzazioni e decessi. Due di questi provenienti da carni di pollo e suino sono stati causati da Listeria monocytogenes e hanno provocato un totale di 140 casi e ospedalizzazioni e 6 decessi.
I PRODOTTI ALIMENTARI SOGGETTI
ALLA LISTERIOSI
Quali sono i prodotti alimentari comunemente associati alla listeriosi e più spesso coinvolti in casi di contaminazione? Per le

Francesca De Vecchi tecnologa alimentare
sue caratteristiche, L. monocytogenes rappresenta un pericolo per i prodotti pronti al consumo (ready-to-eat, RTE) e i prodotti con una lunga vita commerciale (shelf-life) mantenuti a temperature di refrigerazione, perché può crescere nell’alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni tali da causare un’infezione nell’uomo. Gli alimenti principalmente associati alla listeriosi sono quindi in linea generale quelli ricchi di proteine, con una moderata attività dell’acqua e una bassa microflora di fondo. Quindi, pesce affumicato (es. salmone), prodotti a base di carne (paté di carne, hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie), formaggi a pasta molle, for-

La listeriosi continua a essere l’infezione di origine alimentare che preoccupa di più, con tassi di decesso (insieme a Salmonella) fra i più alti segnalati negli ultimi 10 anni in Europa
maggi erborinati, formaggi poco stagionati; vegetali preconfezionati e latte non pastorizzato. I dati indicano che la presenza di L. monocytogenes nei prodotti alimentari varia con un range che va dallo 0,09% per i “formaggi a pasta dura a base di latte pastorizzato” al 3% per la carne bovina RTE. La contaminazione è preoccupante proprio per tutti quei prodotti che non subiscono ulteriori trasformazioni o trattamenti termici di bonifica prima di essere consumati.
ESISTE UN METODO CHE MIRA
ALLA COMPLETA ERADICAZIONE?
Come quindi affrontare il problema della contaminazione da L. monocytogenes? Nell’Unione europea, la garanzia di conformità degli alimenti rispetto ai livelli massimi possibili di contaminazione da L. monocytogenes è un obbligo che spetta all’operatore del settore alimentare (OSA) attraverso l’igiene del processo di produ-
zione e di distribuzione degli alimenti basati sulle buone pratiche di lavorazione e l’applicazione dell’HACCP. Negli anni si è arricchito il panorama normativo relativo ai limiti e ai controlli: il Regolamento CE 2073/2005 e s.m.i prevede per L. monocytogenes, criteri di sicurezza applicabili agli RTE, sia in fase di produzione che di commercializzazione e il 2021/1373 che ha aggiornato la lista degli alimenti a rischio per la Listeria monocytogenes, includendovi i prodotti a base di latte crudo, di carne cruda, di pesce crudo e di verdure crude; ma sono state via via emesse anche linee guida nazionali (Ministero della Salute) ed europee (EFSA) per orientare l’operato di chi ha la responsabilità di garantire e controllare la sicurezza alimentare perché L. monocytogenes è a tutti gli effetti un contaminante di filiera. Si comprende quindi come un’adeguata gestione dei processi e degli ambienti produttivi (temperature, igiene, buone pratiche di fabbricazione), la corretta manipolazione degli alimenti e la necessità di applicare piani di prevenzione specifici e monitorati rappresentino i cardini di una strategia a tutela della salute. Secondo i dati raccolti, infatti, si ritiene che la presenza di L. monocytogenes negli alimenti si verifichi per contaminazione ambientale in post-lavorazione più che in seguito a sopravvivenza durante i trattamenti termici (Gurtler & Kornacki, 2007). Non solo: la persistenza di L. monocytogenes può estendersi per anni, poiché è un batterio che può rimanere - vitale - sulle superfici degli impianti quando persistono particolari condizioni (ad esempio residui organici, biofilm) che lo proteggono dalle operazioni di pulizia e ne favoriscono lo sviluppo. La gestione del rischio di contaminazione di alimenti da parte di questo batterio deve sempre far parte dei piani di autocontrollo con un’analisi e procedure di sanificazione mirate, che tengano conto delle caratteristiche di sopravvivenza

Per le sue caratteristiche, L. monocytogenes rappresenta un pericolo per i prodotti pronti al consumo (ready-to-eat, RTE) e i prodotti con una lunga vita commerciale (shelf-life) mantenuti a temperature di refrigerazione, perché può crescere nell’alimento contaminato fino a raggiungere concentrazioni tali da causare un’infezione nell’uomo
del batterio, delle tipologie di produzione, di ambiente, attrezzature e impianti.
IL METODO “SEEK AND DESTROY”
I punti di proliferazione, per Listeria (come per altri patogeni), sono una sorta di rifugio e comunemente vengono denominati nicchie. Il concetto di nicchia protettiva quale luogo riparato è alla base di un metodo operativo conosciuto come “Seek&Destroy” (S&D) utile per identificare e gestire queste zone di crescita in attrezzature o strutture, eradicarle e creare le condizioni perché non si formino (o riformino), garantendo un’efficace protezione dalla crescita di Listeria negli ambienti di produzione. Il metodo, sviluppato inizialmente negli Stati Uniti, focalizza l’attenzione non solo agli ambienti di produzione alimentare, ma anche ai processi di sanificazione, alla loro adeguatezza per la prevenzione del pericolo di formazione di aree di sviluppo del patogeno. Nelle nicchie, che sono spesso siti
difficili da raggiungere e pulire con le normali procedure igienico-sanitarie, Listeria trova le condizioni adeguate di crescita per colonizzare anche formando biofilm, resistenti alla disinfezione, sulle superfici di attrezzature e impianti di produzione alimentare.
“Il metodo Seek&Destroy è un approccio innovativo per l’eradicazione del pericolo Listeria”, spiega Giuseppe De Lucia, tecnologo alimentare e consulente in sanificazione intervenuto al convegno digitale AlimentiPiù. “La nicchia è il luogo che favorisce una crescita microbica ed è protetto dal contatto con gli agenti di sanificazione. È infatti caratterizzato dall’avere una elevata conta microbica ancora dopo pulizia e disinfezione”.
La presenza di nicchie e residui organici, interferendo con l’attività di detersione e poi di sanificazione, protegge Listeria; trovarle a fine processo indica il fatto che la procedura di sanificazione eseguita non è stata efficace. I fattori predominanti che
influenzano la formazione di nicchie, infatti, rimandano a errori operativi:
§ scorretta applicazione o sbagliata esecuzione delle procedure di sanificazione;
§ procedure non correttamente studiate (perché per esempio non tengono conto del disegno igienico dell’impianto, complesso o non corretto);
§ frequenza di applicazione della procedura non corretta;
§ movimentazione del personale e di attrezzature (per esempio carrelli che da zone sporche vengono portati in zone “pulite” senza aver sanificato le ruote. Per via aerea la Listeria può raggiungere le superfici a diretto contatto con gli alimenti).
S&D è una tecnica investigativa che include un approccio aggressivo e sistematico per identificare i siti di rifugio e localizzare le nicchie in cui i microbi (non solo Listeria monocytogenes ma anche altre specie di Listeria spp) sopravvivono (o persistono) nonostante le misure di pulizia e disinfezione messe in atto nell’ambito dell’applicazione dei piani di autocontrollo.
Si tratta di un approccio innovativo che sovverte metodiche più comunemente impiegate che però non garantiscono gli obiettivi di sicurezza alimentare, commenta De Lucia. “Di solito si cerca il patogeno sulle superfici, nell’ambiente di produzione e nel prodotto”. E in caso di assenza, si valuta il protocollo come conforme. L’approccio S&D, invece, si basa su uno studio preliminare approfondito per evidenziare tutte le potenziali nicchie e quindi rimuoverle. Non solo eliminarle, ma soprattutto capire perché si sono formate e quindi attuare azioni correttive contro le cause che le hanno generate per evitare che si ripresentino. È un lavoro finalizzato a creare un sistema efficace di prevenzione perché si rimuovono tutte le condizioni che facilitano la formazione di luoghi di potenziale annidamento e proliferazione batterica.
Quando si può applicare un piano S&D?
Tendenzialmente un simile processo viene applicato quando le aziende di trasformazione alimentare sono chiamate a:
§ rispondere a un test positivo per Listeria monocytogenes o i suoi organismi indicatori (Listeria spp o organismi simili a Listeria),
§ qualificare un’apparecchiatura o un processo (ad esempio, come parte di una valutazione di una nuova apparecchiatura e quindi non necessariamente in presenza di una nicchia).
§ eseguire la convalida di un processo: normalmente è un processo di verifica che dura circa 90 giorni (con un campionamento al mese).
Semplificando, prosegue De Lucia, le tipologie di applicazione di questo metodo sono principalmente due, a seconda che si voglia verificare se un sistema è protetto (“Non per causa”) o quando è conclamata la presenza del patogeno (“Per causa”).
Nell’ipotesi “Non per causa” si vuole verificare la presenza di nicchie di crescita dei patogeni sulle attrezzature. Il procedimento prevede una serie di controlli via via più
– E. Evans et al. Exploring Listeria monocytogenes perceptions in small and medium sized food manufacturers: Technical leaders’ perceptions of risk, control and responsibility. Food Control 2021.
– G. De Lucia. Nuovo metodo “Seek and Destroy” per la prevenzione ed eliminazione di Listeria monocytogenes e ruolo della sanificazione. Case History in un’industria alimentare. Alimenti più, 28 settembre 2023.
– Malley TJ et al. Seek and destroy process: Listeria monocytogenes process controls in the ready-to-eat meat and poultry industry. J Food Prot. 2015
Listeriosi, l’infezione generata dal batterio Listeria monocytogenes, generalmente è dovuta all’ingestione di cibo contaminato. Nei Paesi occidentali è un problema di sanità pubblica poiché, anche se si presenta meno frequentemente di salmonellosi e campylobacteriosi, può dar luogo a malattia grave, soprattutto in soggetti fragili quali anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti immuno-compromessi, portando al ricovero ospedaliero con tassi di mortalità elevati Listeria monocytogenes è un batterio patogeno Gram-positivo, non sporigeno e mobile. È ampiamente diffuso nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Cresce e si riproduce a temperature molto variabili (da temperature di refrigerazione sino a 45°C), tollera ambienti salati e pH acidi. È quindi molto resistente in particolare alle condizioni che caratterizzano la produzione e la lavorazione degli alimenti.
approfonditi: parte dal verificare la procedura di sanificazione quotidiana (prodotti utilizzati, concentrazione, modalità di impiego); prosegue con un’ispezione mediante test analitici rapidi per vedere se vi sono nicchie (residui proteici, test bioluminometrici, video-ispezioni). Prevede quindi lo smontaggio dell’attrezzatura come da procedura ordinaria per verificare la presenza di siti rifugio e poi, allo stesso scopo, avanza con lo smontare completamente la macchina (operazione che è solitamente prevista, ma a intervalli di tempo maggiori). La presenza o l’assenza di nicchie in punti non raggiunti dalle operazioni di pulizia quotidiane dà la misura della correttezza della procedura di sanificazione ordinaria e quindi della necessità di applicare azioni correttive (compresa l’elaborazione di una nuova procedura di sanificazione). Nel caso di applicazione «Per causa» invece si valutano le modalità di contaminazione in caso di positività: il fine della ricerca in questo caso non è solo identificare le nicchie ma soprattutto trovare le modalità di trasferimento del patogeno all’origine della contaminazione - dai siti di origine al punto in cui è stato ritrovato. L’indagine deve essere sviluppata conducendo più analisi con tecnica S&D oppure identificando i punti di trasferimento che potrebbero aver portato il microrganismo nel luogo dove si è rilevato il campione positivo. Il punto cardine di questo sistema è quindi l’individuazione e la prevenzione delle nicchie. Questo comporta l’attuazione di azioni correttive e poi il rinforzo del protocollo di sanificazione per evitare che le nicchie si formino nuovamente. Date le caratteristiche di resistenza del microrganismo è importante valutare la persistenza, tracciare la contaminazione e caratterizzare il ceppo del microrganismo (eventualmente con opportune tecniche di sequenziamento del genoma tipo Whole Genomic Sequencing), adeguando quindi il piano di campionamento e integrando con le valutazioni di persistenza dei ceppi di Listeria monocytogenes. Significa eventualmente prevedere interventi di manutenzione, di ripristino di un disegno igienico di parte degli impianti di produzione, di movimentazione secondo principi di igiene di attrezzature e personale per generare un protocollo sicuro di prevenzione della contaminazione.

IL MONDO AGROALIMENTARE È AVVIATO SULLA STRADA
DELL’INNOVAZIONE MA SERVONO COMPETENZE SPECIFICHE
E FORMAZIONE, COSE NON SEMPRE FACILI DA REPERIRE.
UNA RICERCA NOMISMA SI È FOCALIZZATA SULLO STATO
DELL’ARTE E I FABBISOGNI IN ITALIA
Nella produzione alimentare, nelle aziende, si identificano generalmente due attività legate alla qualità, l’assicurazione e il controllo. Generalmente, il controllo qualità (CQ) si occupa di ispezionare e verificare che un prodotto soddisfi i parametri quantitativi stabiliti. Ma quali e quante possono essere i parametri, le caratteristiche che compongono e contribuiscono a definire la qualità di un alimento?
Da questa domanda, discendono le tipo -

logie di controllo, le modalità di svolgimento, le funzioni che possono svolgere ispezione e verifica, le registrazioni e le finalità.
IL RUOLO DELL’OSA
Mettiamoci nei panni dell’OSA, del produttore di alimenti: dagli ingredienti all’alimento finito, completo di confezione, attraversa e percorre un processo che all’apparenza può sembrare diretto, lineare e a suo modo semplice, con un obiettivo finale chiaro: il suo prodotto
Laura Scafuri
Tecnologo Alimentare e consulente
con la sua qualità definita. Qualità composta da caratteristiche estrinseche, come l’aspetto, la forma, il colore ma anche il peso, e molte altre intrinseche: contenuto nutrizionale, stabilità, sicurezza igienica, idoneità, etc.
Di fatto, l’OSA deve rispettare alcuni “paletti” normativi che lo guidano nel processo, a partire dal Reg. UE 178/2002 che gli ricorda che il suo alimento non dovrà essere né nocivo né inadatto al consumo umano; avvalendosi dunque di un sistema di autocontrollo, basato sui

principi dell’HACCP, potrà gestire il suo processo perseguendo l’obiettivo della qualità descritto nel Reg. UE 852/2004
Capo II art.3 che così recita: “Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento”. Al successivo art. 5 si parla di punti critici di controllo, con chiara indicazione della necessità di definire limiti e modalità. Facciamo caso che nel Reg. 852 la parola “controllo” si ripete ventisei volte, altre cinque nella sua versione al plurale e leggiamo quattro volte invece la forma verbale, “controllare”. Possiamo dire che il tema è centrale!
Mi piace immaginare questa attività come un viaggio in automobile, un percorso da un punto di partenza a una
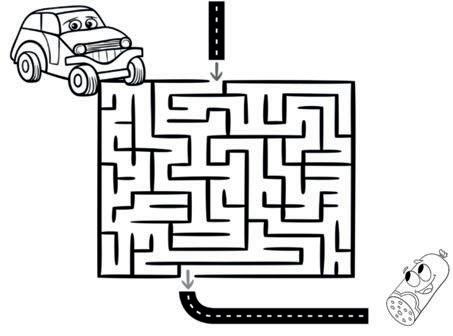
meta finale, durante il quale dobbiamo percorrere un tragitto in cui ci possono essere pericoli, difficoltà, fermate, bivi, rotonde e semafori, magari qualche buca. Lungo il tragitto ci sono i “controlli” che possiamo assimilare ai diversi segnali di precedenza, di stop, agli avvisi di pericolo e soprattutto ai semafori.
Il CQ alimentare è proprio questo: definire nel proprio processo produttivo, nella filiera tutta ove possibile, quali e quanti controlli sono necessari a non uscire dal percorso migliore e corretto per raggiungere il traguardo, per andare spediti all’arrivo e posizionarsi quali vincitori.
Il CQ si presenta oggi come un insieme di attività, ben descritte nei loro limiti, nelle modalità esecutive, ovvero con metodo, criteri di accettabilità e registrazioni rin-
tracciabili.
Delle attività, alcuni controlli possono essere più soggettivi, visivi e discorsivi; molti invece sono riferibili a parametri misurabili, oggettivi, come: grammi, parti per milione e Unità Formanti Colonia/g. Nella sfera dei controlli misurabili entra in gioco il ruolo e il supporto del laboratorio, un servizio alla qualità con competenze specifiche che analizza non solo l’alimento in quanto tale e i suoi ingredienti, ma anche componenti ausiliari del processo per contribuire alla tenuta sotto controllo dell’intero flusso produttivo: superfici, aria, acqua, indumenti, prodotti per la sanificazione, etc.
Tornando alla metafora del viaggio, possiamo assimilare il controllo di laboratorio al semaforo: se rosso, la fermata è obbligatoria e finché non appare il verde non si riparte; il verde è l’esito favorevole
dell’analisi. In caso di giallo, si tratta di fare delle valutazioni, degli approfondimenti, delle ripetizioni.
Ogni piano di autocontrollo prevede un certo numero e tipologia di analisi la cui frequenza e i limiti sono stabiliti da requisiti cogenti, ove presenti e pertinenti, o definiti dall’OSA sulla base della valutazione del rischio. A supporto del CQ, possono delinearsi almeno due tipologie fondamentali di laboratorio con cui l’OSA può interfacciarsi, le quali presentano caratteristiche, ruoli, finalità e potenzialità differenti: il laboratorio interno, aziendale, detto “annesso all’impresa” e il laboratorio esterno, conto terzi.
LABORATORIO INTERNO O LABORATORIO ESTERNO?
Partiamo dal 2009, con il Decreto 22 dicembre 2009 (G.U. Serie Generale, n. 20 del 26 gennaio 2010) che riconosce “Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. Quindi? Come conseguenza, la Conferenza Stato Regione definisce l’Accordo Rep. N. 78 /CSR/2010 che identifica le due tipologie di laboratori all’art.1 – Campo di applicazione in:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
L’accordo ne definisce obblighi e requisiti; in particolare, l’art.2 stabilisce che:
1) i laboratori di cui all’art., lettere a) e b), di seguito indicati come “laboratori”, devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,

per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISOIIEC 17011.
2) i laboratori possono affidare l’esecuzione di determinate prove a un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l’accreditamento secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 e l’iscrizione negli elenchi regionali di cui al presente accordo.
I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori
affidatari e i rapporti di convenzione a tal fine stipulati.
Da questo momento prende il via l’attuale contesto di attività dei laboratori di CQ nel sistema alimentare italiano.
Al di là del contesto normativo, che differenze sostanziali nel ruolo, nelle potenzialità e nelle peculiarità possiamo evidenziare?
Laboratorio “interno” , aziendale: conosce bene l’azienda, i suoi processi e soprattutto gli alimenti, le “matrici alimentari” che vi si producono; questo implica che ha familiarità con i controlli specifici e utili per il contesto, con gli aspetti normativi peculiari, oltre a conoscere pericoli e rischi. Di solito non offre una gamma estesa di parametri analitici, ma si concentra ed è specializzato in quelli significativi per la routine del controllo dei processi della sua azienda. È anche sempre disponibile a collaborare in progetti di ricerca e sviluppo, per indagare su azioni di miglioramento ma anche e soprattutto in caso di scostamenti produttivi; può essere proattivo e tempestivo nel supportare strategie correttive in ottica di sicurezza alimentare, senza tuttavia dover compromettere o blocca-
• N Not a 1: obiettività significa che non esistono conflitti di interesse, o che questi sono risolti in modo da non influenzare negativamente le conseguenti attività del laboratorio (3.6).
• N Not a 2: Altri termini utili per trasmettere il concetto di imparzialità comprendono: «assenza di conflitto di interessi», «assenza di preconcetti», «assenza di pregiudizi», «neutralità», «onestà», «apertura mentale», «equità», «distacco», «equilibrio».
UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018 - Termini e Definizioni
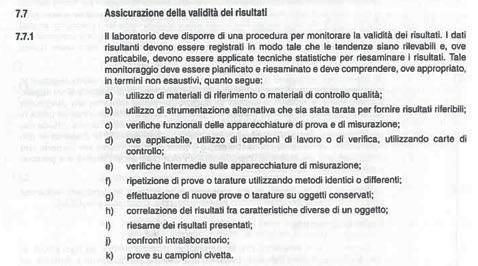
Fonte: UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
re interi processi/lotti di produzione; può interagire attivamente nel limitare errori. Generalmente non esegue analisi complesse, perché di fatto raramente investe in attrezzature sofisticate che richiedono competenze e gestione di alto livello, anche per complessità della tecnica analitica; ad esempio, difficilmente esegue controlli di contaminanti chimici indesiderati di grande impatto quali diossine.
Un ruolo di assistenza continua, di fiducia, che però può risentire del pericolo del conflitto di interessi, deve stare attento all’imparzialità, a non subire ingerenze o interferenze da ruoli aziendali direzionali. Qui entrano in gioco i requisiti dell’accreditamento, dettati soprattutto dalla norma di riferimento per i laboratori di Prova ISO/IEC 17025. L’accreditamento è obbligatorio per i laboratori di auto-
controllo aziendali che possono svolgere il loro servizio per aziende che non sono direttamente annesse, come nel caso di sedi produttive dislocate sul territorio ma afferenti a un unico laboratorio aziendale. Di contro, il laboratorio “esterno”, che esegue analisi conto terzi, per clienti di svariate tipologie e provenienza, ai fini di autocontrollo ma non solo, potrà offrire un servizio più completo e vario, ma forse un po’ meno “vicino” alla peculiarità del singolo produttore. Si tratta di strutture in grado di offrire servizi analitici anche complessi, con necessità di avvalersi di attrezzature performanti e costose, di tecniche sofisticate e di personale competente e qualificato. Spesso sono organizzazioni articolate che offrono servizi con logistica importante, dal servizio di ritiro del campione al campionamento vero e proprio anche accreditato, con supporto informatizzato di accettazione e di visualizzazione/ricezione dei certificati di analisi (i Rapporti di Prova); offrono anche supporto tecnico per la scelta delle analisi, per l’interpretazione dei risultati; propongono momenti formativi e aggiornamento normativo; possono essere in grado di supportare l’azienda in caso di controlli ufficiali, anche di contenziosi. Trovano ragione per studi complessi, quali ad esempio i Challenge test microbiologici con ceppi patogeni.
Esteso per questi laboratori, irrinunciabile l’accreditamento delle prove e quindi, necessariamente, del sistema di gestione. Ma nel ruolo di entrambe le tipologie di laboratori sono presenti aspetti, forse meno evidenti, meno valutati dall’OSA, che sono determinanti per la qualità del servizio che possono offrire, ovvero:
a) Imparzialità.
b) Validità.
Requisiti requisiti imprescindibili per poter garantire esecuzione di analisi valide,
Nella sfera
misurabili entra in gioco il ruolo del laboratorio, che analizza non solo l’alimento in quanto tale e i suoi ingredienti, ma anche componenti ausiliari del processo
robuste, spendibili verso terzi e per autocontrollo.
Non da ultimo, per lo svolgimento di analisi ai fini dell’autocontrollo, entrambe le tipologie di laboratorio devono essere iscritti nel Registro regionale, sempre in base all’ Accordo Rep. N. 78 /CSR/2010, art. 3, 4, 5 e 6. Questo comporta che il laboratorio è soggetto a ulteriore valutazione esterna: se Accredia valuta la competenza, il servizio regionale mira a verificare la credibilità del laboratorio.
Qual è nel CQ il valore aggiunto dell’accreditamento, che valenza ha un’analisi accreditata rispetto alla stessa, stesso metodo, non accreditata?
La parola accreditamento deriva dal verbo latino “accredere”. In inglese si può interpretare come “dare credito a”. Gli accreditamenti vengono rilasciati in vari campi, e di norma, rappresentano una sorta di approvazione, una conferma, che viene rilasciata dall’ente autorizzato a concedere l’accreditamento. Ciò richiede la prova di determinate qualità e capacità, nonché la conformità a standard specifici.
La definizione autorevole di “accreditamento” in questo contesto è contenuta nella norma ISO 17011. Di conseguenza, l’accreditamento è la: “Conferma da parte di un ente terzo che attesta formalmente che un organismo di certificazione ha la competenza per svolgere specifici compiti di valutazione”.
Qui entrano in gioco valori e criteri di responsabilità, di onestà, che possono
essere riassunti nel fatto che Accredia è l’organismo nazionale che assicura che i risultati delle prove elaborati dal laboratorio siano accettati con fiducia sia in Italia sia all’estero e che tali risultati siano realizzati con competenza e imparzialità.
Accredia accredita un laboratorio ai fini dell’esecuzione di specifiche prove, solo dopo aver accertato:
§ L’esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi necessari per garantire il riferimento metrologico.
§ L’affidabilità e la riproducibilità delle procedure impiegate.
§ L’adeguatezza della strumentazione impiegata.
§ La competenza del personale.
§ L’imparzialità del giudizio tecnico.
Accredia segue costantemente l’attività dei laboratori accreditati attraverso periodiche ispezioni, al fine di verificare il mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno consentito l’accreditamento.
L’accreditamento dei laboratori di prova ha l’obiettivo di tutelare l’interesse degli utenti finali dei prodotti sottoposti a prova, garantendo così la competenza tecnica e la serietà professionale degli esecutori delle prove di conformità a specifiche norme o regolamenti tecnici. Tale garanzia si è basata in principio su criteri più o meno codificati di “buona gestione” dell’attività di prova.
Fin dal 1978, con la pubblicazione della guida ISO 25 (Guidelines for assessing the technical competence of testing laboratories) l’attività di accreditamento ha cominciato a fondarsi su criteri univoci, validi in campo internazionale. Oggi, i criteri di accreditamento sono definiti, a livello europeo, dalla norma armonizzata
UNI EN CEI ISO/IEC 17025 standard internazionale che stabilisce i requisiti per la competenza dei laboratori di prova e taratura. Il suo riconoscimento a livello globale è assicurato da accordi di mutuo riconoscimento tra gli organismi di accreditamento, come ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e EA (European co-operation for Accreditation). Questo significa che un laboratorio accreditato secondo la ISO/IEC 17025 in un paese è generalmente riconosciuto come competente anche in altri paesi che partecipano a questi accordi. Questo sistema di mutuo riconoscimento facilita il commercio internazionale, garantendo la qualità e l’affidabilità dei risultati di prova e taratura, e riducendo la necessità di ripetere le prove in diversi paesi.
Controllo qualità e laboratorio dovrebbero essere un binomio degno di fiducia credibile, pronto a dare supporto e ad affiancare l’OSA nel suo ruolo al servizio della sicurezza alimentare; il laboratorio è l’autista di fiducia che ci accompagna nel viaggio del controllo qualità e ci aiuta ad arrivare al traguardo.

a cura della Redazione
GR
In Italia, nonostante la crescente sensibilizzazione dei consumatori in termini di sostenibilità, lo spreco alimentare domestico resta un fenomeno diffuso. Ogni settimana gettiamo, in media, 667,4 grammi di cibo pro capite, con una crescita del +17,9% rispetto allo scorso anno (a gennaio 2024, erano 566,3 gr). Dati che evidenziano le dimensioni sempre più allarmanti del problema, che in soli 5 anni ha visto crescere di quasi 140 gr settimanali il quantitativo di prodotti alimentari gettati via, posizionando l’Italia al pari della maggior parte dei paesi europei, che mostrano una certa omogeneità in termini di spreco domestico, attestandosi su percentuali poco lusinghiere. Esistono, però, alcuni prodotti che possono rappresentare dei veri e propri alleati nella lotta agli sprechi: tra questi, con solo 14,9 gr gettati sul totale pro capite settimanale, ci sono gli alimenti surgelati. Si parla di appena il 2,23% rispetto allo spreco individuale complessivo. A confermarlo sono i dati emersi da uno studio inedito dell’Osserva-
torio internazionale Waste Watcher-Campagna Spreco Zero per IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati, che ha quantificato l’incidenza del comparto frozen sullo spreco alimentare complessivo. I dati, frutto di una indagine condotta su 1000 intervistati dai 18 anni in su [1], hanno ribadito il ruolo centrale dei surgelati nella gestione sostenibile delle risorse alimentari domestiche, grazie alle loro caratteristiche intrinseche: dalla lunga durata di conservazione all’efficiente porzionatura, fino ai minori consumi di acqua ed energia elettrica necessari per la preparazione dei piatti, che ne garantiscono anche una elevata sostenibilità economica. “In un Paese come l’Italia”, dichiara Giorgio Donegani, Presidente IIAS, “in cui il problema del food waste ha assunto dimensioni preoccupanti, con una crescita a doppia cifra nel 2025, il consumo di prodotti surgelati può diventare un importante tassello nella lotta agli sprechi. I prodotti surgelati aiutano nella lotta al food waste perché permettono un utilizzo ottimale delle materie prime che arrivano pronte per l’uso in
cucina, consentono di massimizzare la resa produttiva, di contenere gli sprechi che avvengono durante tutta la filiera e di ridurre le emissioni di inquinanti nell’atmosfera”.
AUMENTANO I CONSUMI DI SURGELATI
Secondo una ricerca del 2024 di AstraRicerche [2], in 5 anni, 4 italiani su 10 hanno notevolmente aumentato i consumi di prodotti surgelati, ma a questa crescita non è corrisposto un aumento del loro spreco che, dal 2021 a oggi, si è mantenuto stabile, su valori percentuali di poco superiori al 2% (si è passati dal 2,37% del 2021 al 2,23 del 2024).
“Dal punto di vista ambientale il loro vantaggio è doppio: meno sprechi alimentari, ma anche minore impatto energetico. I prodotti sono infatti già lavati e questo riduce il consumo domestico di acqua, e i tempi di cottura più brevi consentono un minore dispendio energetico”, afferma Giorgio Donegani. “Grazie alla loro forte valenza antispreco, i surgelati rappresentano una risorsa importante per ridurre e
contrastare gli sprechi alimentari non solo a livello domestico, ma anche di ristorazione. Parlando di ristorazione pubblica, questi dati dovrebbero far riflettere anche sull’opportunità di rivedere i limiti attualmente imposti alle forniture di prodotti surgelati nei contratti di appalto per la ristorazione collettiva (Decreto 10 marzo 2020 sui Criteri Ambientali Minimi)”.
MENO SPRECATI
Frutta e verdura fresche, insalate, pane, cipolla, aglio e tuberi, latte e yogurt occupano i primi posti in classifica tra i cibi più sprecati, con picchi di 26,82 gr e 23,89 gr settimanali rispettivamente per frutta e verdure fresche.

Nella top 10 dei meno sprecati, invece, trovano posto i surgelati, che con soli 14,9 gr gettati via a settimana, registrano uno spreco inferiore del -37,6% rispetto a quello delle verdure fresche e del -17,4% rispetto a verdura e frutta non fresche (in vasetto o in barattolo).
L’indagine WWI ha mostrato, inoltre, differenze molto significative su base geografica. I consumatori del Nord Italia si distinguono per comportamenti più responsabili, con soli 12,5 grammi di surgelati sprecati a settimana, (-16% rispetto alla media nazionale). Le abitudini alimentari variano anche in base alla composizione familiare e al livello socioeconomico. Le famiglie con figli sprecano l’11% in meno di surgelati rispetto alla media e il ceto medio e mediobasso dimostrano maggiore attenzione, con percentuali che oscillano tra -7% e -8% vs. la media nazionale. Analoga sensibilità si riscontra in chi vive in piccoli centri, sprecando un 8% in meno di surgelati rispetto alla media o in chi abita in grandi città (-5%).
SCARSA ORGANIZZAZIONE DOMESTICA E CATTIVA CONSERVAZIONE
Secondo i dati emersi, i surgelati si confermano tra gli alimenti meno soggetti allo spreco domestico, dimostrandosi una scel-
ta strategica per una gestione più efficiente, economica e sostenibile delle risorse alimentari in casa: oltre 1 su 3 (34%) dichiara di non gettare mai via prodotti surgelati. Tra le ragioni per cui, talvolta, anche questi prodotti finiscono in pattumiera ci sono principalmente fattori organizzativi, logistici o imprevedibili: la dimenticanza delle scadenze (22%), la cattiva conservazione (21%) la mancanza di spazio nel freezer/una cattiva organizzazione domestica (20%) e le interruzioni della catena del freddo (16%). Non si tratta, quindi, di motivi legati alla deperibilità del prodotto ma, piuttosto, a una gestione poco efficiente della sua conservazione. Quanto alla frequenza di spreco, circa 1 su 10 (14%) si trova a buttar via surgelati ogni 3-4 mesi, a fronte di un 59% che li spreca molto meno spesso.
Secondo i dati di un’indagine recentemente condotta da AstraRicerche per IIAS [3], inoltre, i prodotti surgelati sono un emblema anti-spreco anche dal punto di vista economico. È stato calcolato, infatti, l’effettivo “value for money” di questi prodotti rispetto agli analoghi freschi, prendendo in esame 5 frozen food rappresentativi delle principali categorie del comparto (fagiolini, patate fritte, fi-
letti di merluzzo, paella). I risultati emersi dimostrano la convenienza dei surgelati, considerata la somma di tempo e cibo risparmiato, nonché i costi per l’acquisto e la preparazione dei prodotti.
I dati mostrano, ad esempio, che i filetti di merluzzo freschi “costano” il 49% in più dei surgelati, percentuale che tocca il 60% se si considera anche il valore dello spreco alimentare. Analogamente, i fagiolini – che nella versione fresca, necessitano di essere puliti e tagliati alle estremità – superano del 53% il “valore economico” del surgelato e per preparazioni più complesse, come la paella di pesce e verdure, la convenienza del surgelato è inequivocabile: il fresco costa il 246% in più del surgelato.
[1] Osservatorio Internazionale Waste Watcher, Indagine su “Surgelati e spreco alimentare”, Aprile 2025, Campione di 1.000 italiani, età 18-70 anni, rappresentativo della popolazione italiana, secondo le variabili ISTAT (genere, età, area geografica)
[2] Aprile 2024, AstraRicerche: Survey “Italiani e surgelati: #losapeteche?”; Blind Taste Test; Analisi sul “Value for money” dei prodotti surgelati
[3] Analisi AstraRicerche sul “Value for money” dei prodotti surgelati, Aprile 2024

a cura della Redazione
MIGLIORA IL PASTO DELLA MENSA MA PEGGIORA L’ATTEGGIAMENTO DEI BAMBINI RISPETTO AL CIBO. SONO SEMPRE DI PIÙ GLI ALUNNI CHE HANNO PAURA DI ASSAGGIARE CIBI NUOVI E CERCANO RIFUGIO NELLA PASTA IN BIANCO E NEL PANE. DIVERSO È INVECE L’ATTEGGIAMENTO DOVE SI FA EDUCAZIONE E DOVE PERSISTONO LE CUCINE INTERNE
Il 9° Report dei menù scolastici ha messo in luce il miglioramento della mensa evidenziando luci e ombre di questo servizio. Rispetto all’anno precedente l’analisi del campione, rappresentativo di circa un terzo delle mense italiane, registra un miglioramento nel 44% dei menù analizzati, mentre il 29,5% rimane stabile e il 20% mostra, per contro, un calo di qualità. Il miglioramento è significativo in quei Comuni che hanno rinnovato le gare d’appalto, come è successo a Trento, Udine, Frosinone, Rieti e Siracusa.
NON MANCANO GLI ASPETTI NEGATIVI
I dati dell’anno scolastico 2023/24 sono messi a confronto con quelli degli ultimi 5 anni, dimostrando come la legge dei Criteri Ambientali Minimi (in vigore dall’ago-
sto del 2020) abbia reso i menù più sani e sostenibili, con maggiore varietà di alimenti, più biologico, più legumi ma anche più prodotti locali e provenienti da cooperative sociali.
L’indagine mette anche in luce aspetti negativi importanti: aumenta il cibo processato e, secondo quanto riferito da numerosi insegnanti, diminuisce la percentuale di pasto effettivamente consumata. I maggiori consumi si rilevano nelle scuole dove si fa educazione alimentare, dove ci sono le cucine interne, dove i bambini hanno a disposizione più tempo per il pranzo, dove i refettori sono meno rumorosi e, infine, dove la frutta è servita a metà mattina anziché a fine pasto. Poche sono le realtà sensibili al problema del ridotto consumo, come dimostra il fatto che sono rare le attività di monitoraggio degli scarti; rile-
vazioni che invece sono indispensabili per comprendere e affrontare il fenomeno. Questa, in sintesi, è la situazione che emerge dal report del 9° Rating dei menù scolastici pubblicato da Foodinsider, l’osservatorio indipendente che ogni anno monitora lo stato della mensa scolastica in Italia, conducendo rilevazioni e questionari di gradimento in molte città d’Italia.
L’ALIMENTAZIONE COME STRUMENTO DI SALUTE
“In cima alla classifica del 9° Rating c’è il menù che meglio ha saputo interpretare l’alimentazione come strumento di salute, di rispetto per l’ambiente e di promozione del territorio. È il Comune di Sesto Fiorentino ad aver fatto il salto più alto, passando dal quintultimo posto del 2017 al primo nella classifica pubblicata in que-

Aumenta il cibo processato e, secondo quanto riferito da numerosi insegnanti, diminuisce la percentuale di pasto effettivamente consumata
Con più di 2 milioni di pasti al giorno
le mense scolastiche possono dare un grande impulso al settore dell’Agrifood”
sto Report”, dichiara Claudia Paltrinieri, Presidente di Foodinsider. “Dall’olio extra vergine d’oliva proveniente dagli uliveti di Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Carmignano, alla trota della Lunigiana, al Cefalo della Laguna di Orbetello, alla pasta fresca del Mugello… questi sono solo alcuni dei prodotti di filiera corta che occupano il 73% degli alimenti offerti nel menù. Nella mensa di Sesto Fiorentino la plastica è bandita, così come lo sono i piatti processati”. Si confermano di alto profilo i menù di Parma e Fano – secondi a pari merito – e di Cremona, che rimane il migliore in termini di abilità gastronomica dei cuochi. Le mense del Sud danno segnali di ripresa, in particolare Bari e Brindisi e soprattutto Siracusa, che conquista 57 punti in più rispetto allo scorso anno. Nell’approfondimento, il Report dedica
un focus speciale al pane, alimento presente a ogni pasto. “Nonostante si trovino ancora panini plastificati singolarmente e fatti con farine raffinate 00, sono emerse realtà che offrono più forme e varietà di pane, anche integrale, o fatto con farina di tipo 2; altre che privilegiano i grani antichi e alcune che per rifornire la mensa ricostruiscono le filiere locali, dal grano fino al mulino e al panificio del territorio”, afferma la vicepresidente di Foodinsider Francesca Rocchi.
Il Report racconta anche le best practice: iniziative di matrice diversa ma che puntano tutte alla transizione verso una mensa sostenibile. Tra queste, i progetti europei Horizon che fanno parte del Programma
Quadro dell’Unione europea per la Ricerca e l’Innovazione; attività delle agenzie regionali per lo sviluppo dell’agricoltura; le proposte sostenute dalle fondazioni bancarie fino alle azioni della società civile che a Roma è rappresentata dal Consiglio del Cibo, da cui è nata la proposta di introdurre, una volta al mese, un pasto completamente vegetale per ridurre le emissioni.
“Con più di 2 milioni di pasti al giorno, le mense scolastiche, oltre a essere un servizio fondamentale che nutre le future generazioni, possono dare un grande impulso al settore dell’Agrifood”, ha affermato il deputato Claudio Mancini, “per questo dobbiamo trovare la strada che consenta ai Comuni di diventare strumento di sviluppo del territorio in chiave sostenibile, attraverso la ristorazione scolastica”.
In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, Sodexo ha aperto simbolicamente le porte delle cucine scolastiche che gestisce nel cuore di Roma, Municipio I, con un’iniziativa pensata per raccontare il lavoro quotidiano, fatto di sfide e diversità. Ogni giorno, vengono garantiti pasti sicuri a circa 7300 bambini tra i quali il 14% è rappresentato dalle diete speciali.
ED ESIGENZE RELIGIOSE
Secondo uno studio EPIFA (Epidemiology of Paediatric Italian Food Allergy), promosso dalla Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP) e coordinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, le allergie alimentari in Italia sono aumentate del 34% in 10 anni, più colpita la fascia d’età 0-3 anni (+120,8%). Proprio per questo, l’attenzione è massima: le diete speciali sono pertanto personalizzate in relazione alle specifiche richieste. A tal proposito, ad esempio, vengono preparate delle preparazioni alimentari prive delle proteine del latte, ma anche delle proteine dell’uovo o della frutta a guscio. Per gli intolleranti al glutine, anche in questo caso, Sodexo si attiene ai prodotti indicati nel Prontuario degli Alimenti Senza Glutine - AiC. La medesima attenzione viene dedicata nella preparazione delle diete etico-religiose.
Partendo dalle diete vegetariane, per le quali vengono escluse le proteine di carne e pesce, fino a quelle che soddisfano i principi della religione ebraica, per le quali vengono introdotti prodotti specifici come il par-


migiano, il pollo e il bovino Kosher, oppure musulmana, escludendo la carne di suino e introducendo la carne di bovino Halal.
PROGETTO OPEN KITCHEN
Sodexo racconta proprio questo, con trasparenza, nel mini-documentario “Open Kitchen - Preparare pasti buoni e sicuri”, videoregistrato presso la scuola Adelaide Cairoli di Roma.
Il progetto “Open Kitchen” ha l’obiettivo di mostrare, con trasparenza, come nasce ogni giorno un pasto scolastico sicuro: un processo regolato da protocolli rigorosi, svolto da personale qualificato e attento alle esigenze alimentari dei bambini. “Vogliamo far conoscere a tutti il nostro lavoro quotidiano”, ha spiegato Piero Pini, Direttore Regionale di Sodexo Italia, “mostrando il percorso di sicurezza e qualità che accompagna ogni piatto, dietro le quinte della ristorazione scolastica”.
I pilastri dell’evento saranno le tematiche economiche, scientifiche, tecnologiche, della sostenibilità, dell’innovazione, con particolare attenzione alle ultime novità del settore Organizzato da
13 - 14 NOVEMBRE 2025
2 GIORNATE
www.lattepiu.it
info@lattepiu.it

9 SESSIONI
30
RELATORI

David Migliori
GLI STUDI CONFERMANO UNA BUONA DISPONIBILITÀ DEGLI ITALIANI RISPETTO AGLI ALTRI EUROPEI A MODIFICARE LE PROPRIE SCELTE PER RAGIONI DI SOSTENIBILITÀ. LE RACCOMANDAZIONI PER LA SALUTE VENGONO SEGUITE CON UNA CERTA ATTENZIONE. NEL CASO DELLA CARNE, LE ALTERNATIVE SONO VISTE ANCORA CON FATICA E LA NORMATIVA È ANCORA LONTANA DALLA CHIAREZZA NECESSARIA
Il settore alimentare è sempre in rapido movimento e muta seguendo i cambiamenti della società, delle abitudini alimentari e della tecnologia.
Oggi è lo stesso modello produttivo, in cui le proteine animali rappresentano il principale contributo alle emissioni, a essere messo in discussione. Nel frattempo, sul lato dei consumatori, sono in atto cambiamenti delle scelte alimentari per ragioni di sostenibilità ambientale e attenzione alla salute. Il punto da cui partire per ogni riflessione su questo tema sono le raccomandazioni del CREA, che non suggerisce di evitare la carne, ma di farne un uso che rispetti le linee guida della salute: ossia un consumo senza eccessi.
Questi temi sono stati al centro di un talk di AlimentiPiù moderato dalla tecnologa alimentare Serena Pironi, durante il quale la dirigente di ricerca del CREA Alimenti e Nutrizione, Laura Rossi, ha illustrato i dati emersi da una recente ricerca sulle fonti proteiche alternative realizzata proprio
dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
Lo studio del CREA, focalizzato sulla sostenibilità alimentare, ha coinvolto 800 persone tra i 18 e i 54 anni, rappresentative della popolazione italiana sia a livello geografico che economico. Tre i focus indagati, diversi fra loro ma consequenziali: lo stato delle conoscenze del consumatore, la sua disponibilità al consumo di proteine alternative alla carne e, ultimo ma non meno importante, la propensione al cambiamento delle proprie abitudini alimentari per ragioni ambientali.
Poco meno di un italiano su due (il 44%) è d’accordo con l’affermazione che si debba fare attenzione alle scelte alimentari perché hanno conseguenze anche sull’ambiente. Tuttavia, una simile percentuale di persone dichiara di non volere imposizioni o indicazioni troppo “stringenti”. A dimostrazione di una forte resistenza rispetto
a sistemi impositivi quando si parla di alimentazione.
La ricerca fa emergere elementi positivi e negativi. Tra questi ultimi emerge, ad esempio, che solo il 17% delle persone dichiara che le proprie abitudini alimentari influenzano negativamente l’ambiente. Questa “auto-presunzione di innocenza” è mitigata da una dichiarata volontà di intervenire attivamente sui propri comportamenti. In primis (per il 79% dei rispondenti), la disponibilità a ridurre lo spreco di cibo in casa, adottando misure anti-spreco. Un dato che conferma come i comportamenti alimentari degli italiani siano migliori e più virtuosi rispetto a quelli di molti altri paesi europei.
C’è poi la disponibilità da parte del 73% di acquistare prodotti di stagione e quella di circa il 63% di mangiare cibi vegetali, nonostante non siano sempre graditi. Un ulteriore elemento positivo è che oltre la metà degli italiani (il 60%) si dichiara disponibile a cambiare le proprie abitudini

alimentari nel momento in cui si accorgesse effettivamente che non fossero rispettose dell’ambiente.
Passando al fulcro dello studio, la ricerca si è concentrata sulla propensione a ridurre il consumo di carne rossa (manzo, agnello, maiale) per ragioni ambientali. Molti lo hanno già fatto. Il 51% ha ridotto i propri consumi personali. Il 27% invece non lo ha fatto: sono quei consumatori che, per le ragioni più diverse, non sono disponibili a cambiare le proprie consolidate abitudini alimentari. Esiste poi un ulteriore 10% di persone dai buoni propositi che non ha ancora ridotto il proprio apporto di carne, ma ritiene che lo farà in futuro. E i vegani/ vegetariani? Dalla ricerca sarebbero il 4% a cui bisogna aggiungere un altro 7% che ha effettivamente smesso di mangiare carne rossa senza essere diventato vegetariano/vegano.
LE ALTERNATIVE E LA RESISTENZA
AL CAMBIAMENTO
Ma quali soluzioni alternative alla carne sono accettate dai consumatori italiani? A specifica domanda, le risposte, come
era facile immaginare, sono le più varie: legumi, uova, pesce, formaggi, frutta secca. Allo stesso modo non può stupire che la ricerca confermi una forte resistenza da parte dei consumatori italiani verso i sostituti della carne, come la carne vegetale senza OGM (rifiutata dal 47%), la carne sintetizzata in laboratorio (dal 61%), e quella derivante da insetti (67%).
D’altronde nella cultura alimentare italiana la carne ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza. Infatti, ben il 53% è convinto che sia necessaria per avere una dieta completa; il 40% considera la carne fondamentale per poter parlare di dieta bilanciata. Altri, il 34%, la considerano insostituibile nella propria alimentazione. Tutto questo nonostante le evidenze confermino che è possibile avere una dieta equilibrata utilizzando in alternativa altri prodotti.
Il BEAU, un istituto europeo che si occupa di educazione all’alimentazione, ha svolto un interessante studio di approfondimento sulla accettazione della carne sintetica e di quelli a base di insetti a livello europeo. L’analisi dei dati fatta dalla dottores-
sa Rossi ha permesso di scoprire che le differenze tra i nostri comportamenti e quelli dei nostri vicini, non sono così marcate come sarebbe stato lecito attendersi.
La differenza maggiore con alcuni Paesi del nord riguarda la differente accettazione degli insetti che noi, così come i greci, tendiamo ancora a rifiutare.
La resistenza al cambiamento, quando si tratta di abitudini alimentari consolidate, è cosa nota e risaputa. I cambiamenti di questo genere di comportamenti richiedono tempi lunghi, necessitano anni, passaggi generazionali e culturali: basti pensare a come gli anziani difficilmente accettino il sushi nella propria alimentazione che è invece diventata una pratica comune per tutti i più giovani.
Ma se c’è un tratto distintivo, che ci distingue dagli altri Paesi, è la maggiore disponibilità a diminuire il consumo di carne. Un dato confermato dall’alto numero di persone che questa scelta l’ha già fatta, nonostante la presenza di quello zoccolo duro che non intende assolutamente modificare il proprio consumo, né per ragioni di salute, né per ragioni ambientali.
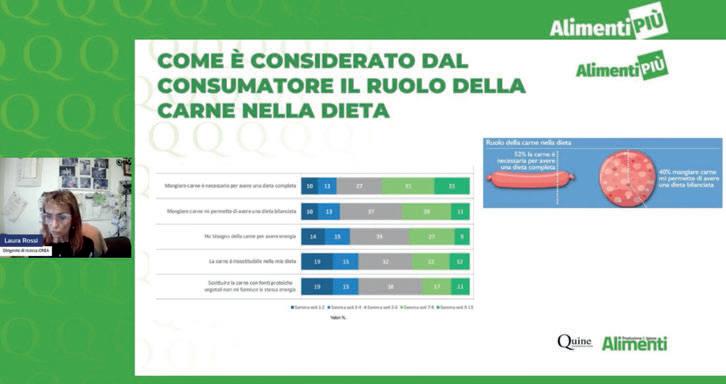
In conclusione, la carne resta un elemento chiave per l’alimentazione degli italiani. Le raccomandazioni per la salute vengono seguite con una certa attenzione. Le alternative sono viste ancora con fatica, con maggiore accettazione quelle a base vegetale, meno quelle innovative anche se naturali come alghe e insetti.
Le scelte alimentari non dipendono solo dalla volontà delle persone o dal contesto culturale, ma anche da quello normativo. Soprattutto quando l’innovazione svolge un ruolo importante come nel caso dei prodotti alternativi alla carne, è importante capire quale sia oggi lo stato dell’arte per quanto riguarda le leggi che regolano questo settore. Sul tema è intervenuta l’avvocato Chiara Marinuzzi dello Studio Forte segnalando la complessa situazione italiana.
Il punto di partenza sottolineato dall’avvocato riguarda un’importante sentenza della Corte di Giustizia che nel 2017 ha messo
un punto fermo nel settore delle denominazioni di prodotti quale latte, crema di latte o panna, burro, formaggio o yogurt disponendo che queste denominazioni fossero prerogativa esclusiva dei prodotti di origine animale. Questo ha garantito ai produttori condizioni di concorrenza leale e ai consumatori la corrispondenza del prodotto nominato in questo modo con prodotti di qualità. Allo stesso modo la Corte di Giustizia ha stabilito che la dominazione latte e quelle relative ai prodotti lattiero-caseari non possono essere impiegate legittimamente per designare prodotti esclusivamente di origine vegetale. È stata prevista una eccezione solo per un elenco di prodotti elencati specificatamente e che godono di una deroga ad hoc perché “la loro natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o quando le denominazioni sono chiaramente utilizzate per descrivere una caratteristica del prodotto”. Alcuni esempi spiegano bene cosa abbia inteso il legislatore: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e così via.
La carne e le pratiche scorrette
Passando invece alla questione “meat sounding”, l’avvocato ha spiegato che questa espressione non riguarda l’utilizzo della denominazione “carne” quando si ha a che fare con prodotti vegetali, come pensano alcuni, ma nei casi di termini che fanno esplicitamente riferimento a caratteristiche tipiche della carne, come ad esempio le parole “bistecca”, “salsiccia, “scaloppina”, e anche lo stessa e assai diffusa “burger”, quando quello che viene reclamizzato è in realtà un prodotto vegetale e che non apporta le proteine della carne.
Data la complessità della materia, nel corso del tempo ci sono state molte proposte e richieste di interventi sulla normativa, sempre respinti. Uno dei più noti è del 2020 e ha riguardato il tentativo di far sì che le denominazioni utilizzate per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne, come quelle elencate poco sopra, fossero riferite “esclusivamente ai prodotti contenenti carne”. Alla base della
proposta c’era la necessità di salvaguardare il settore della carne da pratiche commerciali ingannevoli e scorrette che con facilità utilizzassero ad esempio la parola salsiccia per alimenti senza carne, un tentativo di difesa analogo a quanto fatto in passato con successo per i prodotti lattiero-caseari, come si diceva all’inizio.
Ma perché nel caso della carne tutti gli emendamenti sono stati respinti e non si è raggiunta la chiarezza del mondo del latte?
La spiegazione dell’avvocata Marinuzzi, è che nel caso dei prodotti lattiero-caseari esiste un regolamento che espressamente definisce questi prodotti, cosa che manca invece nel caso della carne, impedendo di raggiungere facili accordi condivisi.
Un pasticcio all’italiana
Ma l’esigenza di salvaguardare e chiarire il settore della carne ha portato inevitabilmente ad alcuni importanti passaggi normativi. Il più significativo è la legge 1° dicembre 2023, numero 173, recante “Disposizioni in materia di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti, a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animai vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.
L’articolo 2 prevede con nettezza il divieto di produrre, esportare, somministrare e distribuire queste fattispecie di alimenti. Per quanto riguarda i termini vietati, l’articolo 3 specifica che il coinvolgimento comprende sia la parola carne, ma anche riferimenti a specie animali, così come le terminologie tipiche della macelleria, della salumeria (e anche della pescheria).
Quello che è ammesso è la possibile aggiunta ai prodotti di origine animale di proteine vegetali, aromi o altri ingredienti. Infatti, una nota importante specifica che i divieti non si applicano nel caso in cui le proteine animali sono prevalenti nel prodotto che contiene anche proteine vegetali e purché non si induca nell’errore il consumatore sui contenuti (anche nel caso di combinazioni di prodotti di origine animale con altri prodotti alimentari che non sostituiscono e non sono alternativi a quelli di origine animale).
Come troppo spesso accade in Italia, alla legge avrebbe dovuto seguire un cosiddetto “decreto attuativo” con l’elenco preciso delle denominazioni vietate che poi non è stato mai emanato.
Tuttavia, la legge ha previsto delle sanzioni che sono quindi operative. E non si tratta di misure “leggere”. In particolare, a seconda della gravità appurata e della du-
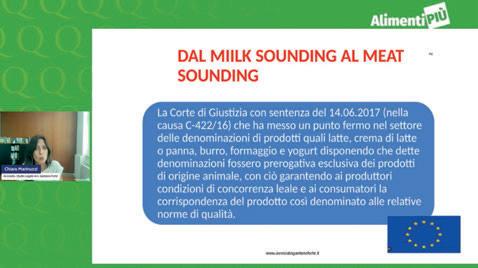
rata dell’attività giudicata illecita, i produttori colpevoli rischiano sanzioni amministrative da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 60 mila (o del 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 60mila, e fino a un massimo di 150 mila euro). È poi ovviamente prevista la confisca dei prodotti giudicati illeciti, il divieto successivo di finanziamenti e supporti di vario genere pubblici e di enti statali da uno a tre anni e anche la stessa chiusura dello stabilimento per lo stesso periodo di tempo.
Tuttavia, come è noto, la Commissione Europea che avrebbe dovuto vagliare il provvedimento l’ha invece archiviato all’inizio del 2024, spiegando che la legge era stata pubblicata anticipatamente rispetto al periodo previsto e creando una situazione molto confusa e interpretazioni molto differenti. Di fatto, come ha ricordato la dottoressa Marinuzzi, la legge così com’è è inapplicabile nonostante il Ministero abbia cercato di darne una interpretazione diversa.
Quindi, cosa può accadere oggi? Allo stato dei fatti, oggi i produttori possono incorrere nell’accusa di pratica commerciale scorretta, con sanzioni che sono quelle tipiche della pubblicità ingannevole, che vanno da poco più di 3 mila a un massimo di 18 mila euro. Cifre molto lontane da quelle previste dalla legge di cui abbiamo parlato.
C’è anche la possibile applicazione del Codice di consumo che prevede le pratiche commerciali sleali con induzione in errore del consumatore. L’Autority garante del mercato può valutare se ci sono questi estremi per prodotti con etichette “ingannevoli”. In questo caso torniamo a sanzioni che in ambito ipotetico possono raggiungere livelli altissimi, milionari in casi ipotetici estremi, oltre a interventi inibitori per bloccare le pratiche giudicate scorrette. Oltre alla “moral suasion”, ossia l’invito all’operatore di eliminare quelle informazioni che possono sviare il consumatore.

a cura della Redazione
SONO SPESSO I PIÙ PICCOLI A CONDIZIONARE ANCHE LA SPESA DEGLI ADULTI E L’ALLONTANAMENTO
DA UN REGIME ALIMENTARE VARIEGATO. UNA MINACCIA CHE, A LUNGO TERMINE, RICADE SUL BENESSERE
DELL’INTERA POPOLAZIONE
Il 17 giugno si celebra l’Eat Your Vegetables Day, una ricorrenza nata negli Stati Uniti che si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mangiare, in una dieta sana ed equilibrata, le verdure. Un problema sempre più urgente e sentito anche in Italia dove, secondo i recenti dati dell’Osservatorio Nestlé, sono addirittura uno su 2 (46,4%) i bambini che non gradiscono mangiare verdure e legumi. Gli esperti lanciano dunque l’allarme su un tema troppo spesso sottovalutato, ma fondamentale per la salute della popolazione, sulle quali abitudini e comportamenti alimentari scorretti, a lungo andare, potrebbero avere un impatto significativo.
Ad avvalorare questa tesi è, tra gli altri, un recente studio sulla longevità pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, che, per un periodo di 30 anni ha monito-
rato le diete e il processo d’invecchiamento di oltre 100 mila persone di mezza età, scoprendo che, raggiunti i 70 anni, solo il 10% dei partecipanti alla ricerca mostrava un “invecchiamento sano”, considerando, oltre a problematiche di tipo fisico (come difficoltà a deambulare, diabete, patologie cardiache, problemi di pressione e patologie croniche di varia natura) anche sofferenze di natura cognitiva come carenze di memoria e stati depressivi. Lo studio ha altresì evidenziato come coloro che, negli anni, hanno seguito un regime alimentare più vario ed equilibrato, includendo i vegetali, sono invecchiati meglio. Otto, in particolare, sono i regimi alimentari che hanno reso i migliori risultati, tra questi vi è anche la dieta mediterranea. In generale a essere premiati sono stati i regimi alimentari che, maggiormente, hanno favorito la varietà. E a trarre beneficio dal maggior consumo di alimenti di origine vegetale è anche l’organo fondamentale: il cuore. Un recente
studio clinico, condotto su 153 soggetti che presentavano congiuntamente ipertensione e malattie renali croniche, pubblicato dall’American Journal of Medicine, ha infatti rilevato come, tra i regimi antiinfiammatori e specifici per il benessere dei reni, solo quelli che includevano una maggior quantità di verdura e frutta (da 2 a 4 porzioni al giorno) contribuivano a migliorare anche la salute cardiovascolare.
I vegetali, insomma, sono un vero e proprio elisir di giovinezza e la disaffezione dei più piccoli verso questi alimenti è una minaccia ad ampio spettro. Ne è convinta la prof.ssa Laura De Gara, presidente della Laurea Magistrale in Nutrizione Umana e prorettore vicario del Campus Bio-Medico di Roma: “Le verdure non sono semplici contorni ma veri e propri alleati per la nostra salute, alimenti ricchi di vitamine e altri micronutrienti anche in grado di

I più piccoli mostrano di avere difficoltà anche con altri alimenti quali pesce (31,4%), cereali (20,3%), carne (19,3%) e frutta (16,9%)
proteggerci da malattie croniche e allungare la nostra vita. Vanno consumate ogni giorno, in varietà e quantità adeguate, per dare gusto e colore alla tavola e, al tempo stesso, prevenire rischi per il futuro. Fare in modo che i nostri figli, e in generale i nostri cari, siano in grado di apprezzare questi cibi è un dovere educativo e una

responsabilità verso la propria famiglia ma anche nei confronti delle nostre comunità. Tollerare abitudini alimentari scorrette o diete poco varie e povere di vegetali espone a maggiori rischi di dover ricorrere a farmacoterapia in futuro, incidendo sui costi dei sistemi sanitari. E questo vale anche per i giovanissimi, tra i quali maggiore, purtroppo, è la propensione a ignorare o a rifiutare i vegetali come componenti essenziali del loro regime alimentare”.
Il fenomeno dell’allontanamento da verdure e legumi, infatti e come illustra l’Osservatorio Nestlé, riguarda tutte le fasce di età, ma è particolarmente rilevante tra i più piccoli. I quali, peraltro, mostrano di avere difficoltà anche con altri alimenti quali pesce (31,4%), cereali (20,3%), carne (19,3%) e frutta (16,9%). Si tratta, purtroppo, di altri ingredienti che contribuiscono a variare e a rendere più salutare l’alimentazione quotidiana. Questo è significativo perché, sempre secondo i dati dell’Osservatorio Nestlé, sono spesso i bambini a determinare il contenuto del carrello della spesa: in 6 famiglie su 10 (58,5%) infatti sono i bambini che accompagnano la fi-
gura di riferimento (nella maggior parte dei nuclei, il 49,2%, si tratta della madre, mentre più raramente, solo in 3 casi su 10, viene coinvolto anche il papà) al supermercato, indirizzandone inevitabilmente anche gli acquisti, mentre sono meno di 4 su 10 (37,2%) le famiglie nelle quali non si evidenziano problemi a gestire l’alimentazione dei figli.
Il dato, secondo la prof.ssa De Gara, è definibile come “allarmante”. “Quello che bisogna capire è che questi comportamenti e abitudini alimentari finiscono per condizionare quelli di tutta la famiglia. Se è il bambino che decide il contenuto dei sacchi della spesa e se il bambino mostra di rifiutare determinati alimenti, quelli non verranno consumati o verranno consumati in quantità minori anche dai familiari: papà, mamme, fratelli e sorelle. Così si impoverisce il regime alimentare di tutta la famiglia, con i rischi conseguenti in termini di tutela della salute e del benessere. Se i vegetali, come confermano gli studi più recenti, contribuiscono a un invecchiamento in salute, viceversa una tendenza a non consumarli produrrà, sul lungo termine, conseguenze negative per la longevità e il benessere della popolazione”.

UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO CONFERMA CHE UNA DIETA MEDITERRANEA CON REGOLARE CONSUMO DI PASTA HA EFFETTI FAVOREVOLI SU FORZA E COMPOSIZIONE CORPOREA IN CHI PRATICA SPORT, SENZA EFFETTI NEGATIVI SUI PARAMETRI CLINICI a cura della Redazione
Sono passati quasi cinquant’anni dai Giochi Olimpici di Montréal 1976, quando la pasta fece il suo ingresso ufficiale nel mondo dell’alimentazione sportiva, spodestando la “dieta del marine” iperproteica fino ad allora dominante nella nutrizione sportiva e rivoluzionando le abitudini alimentari degli atleti. Ormai persino il Comitato Olimpico e Paralimpico USA evidenzia che un basso consumo di carboidrati peggiora la prestazione sportiva. Ma in Italia la pasta e i carboidrati restano ancora vittime di luoghi comuni e mode estreme, che trovano terreno fertile anche tra gli sportivi italiani, meno fedeli al modello alimentare mediterraneo di quanto ci si aspetterebbe.
PASTA&SPORT
Lo dimostra un recente studio italiano effettuato dai nutrizionisti del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente insieme ai fisiologi di scienze motorie dell’Università di Milano. Il gruppo di ricerca ha osservato i comportamenti alimentari di oltre 60 atleti non professionisti, scoprendo un quadro tutt’altro che virtuoso: consumo insufficiente di frutta, verdura, legumi e cereali soprattutto integrali, scarso
uso di olio d’oliva, e un ricorso eccessivo a proteine animali e carni trasformate. E un forte pregiudizio verso l’introduzione di carboidrati in generale, ritenuti spesso (erroneamente) responsabili di peggioramenti nella composizione corporea. Lo studio, pubblicato sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition, ha poi sottoposto alcuni partecipanti a un’alimentazione mediterranea con almeno 5 porzioni di pasta alla settimana, dimostrando che questo modello risultava migliore per effetto su forza muscolare e massa grassa se paragonato a uno con quantità inferiori di carboidrati e pasta. Secondo Patrizia Riso, responsabile dello studio e Professore Ordinario di Nutrizione Umana dell’Università degli Studi di Milano: “Abbiamo verificato che anche chi fa sport abitualmente, come gli studenti in Scienze Motorie che hanno partecipato alla nostra ricerca, tende a sottovalutare il valore degli alimenti fonte di carboidrati in generale e della pasta in particolare come carburante per la performance. Quando abbiamo effettuato l’intervento dietetico per 8 settimane con due diete di tipo mediterraneo: una ricca di carboidrati (55-60% dell’energia, ≥5 porzioni di pasta settimanali) e una più bassa in carboidrati (40-45%, ≤2 porzioni di
pasta a settimana), abbiamo dimostrata che la versione ‘high-carb’ aveva effetti più favorevoli su forza e composizione corporea, senza effetti collaterali o scompensi nei parametri ematici.”
Definisce il valore alimentare della pasta anche l’ultima revisione dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) redatti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, che propone per la prima volta una sezione interamente dedicata alla popolazione attiva e sportiva. Confermando che anche l’alimentazione sportiva deve ispirarsi alle caratteristiche fondamentali della dieta mediterranea che prevede almeno il 45-60% dell’energia totale giornaliera derivante dai carboidrati.
“I carboidrati restano protagonisti dell’alimentazione sportiva, ovviamente con le dovute proporzioni”, afferma Michelangelo Giampietro, specialista in medicina dello sport e scienza dell’alimentazione. “Le indicazioni per la popolazione generale valgono anche per la quasi totalità degli sportivi amatoriali e cioè un apporto giornaliero di carboidrati ben superiore a 2 grammi per
SCELTA PLANT-BASED PER LE NUOVE GENERAZIONI DI ATLETI
La scienza conferma: migliora performance e benessere psicofisico di tutti

La verità sulla
Uno studio dell'Università di Milano ha preso in esame
di carboidrati
Dieta sottoposta per 8 settimane Porzioni di pasta alla settimana
La revisione dei LARN (livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti) propone un’appendice dedicata all’attività fisica e alla pratica sportiva

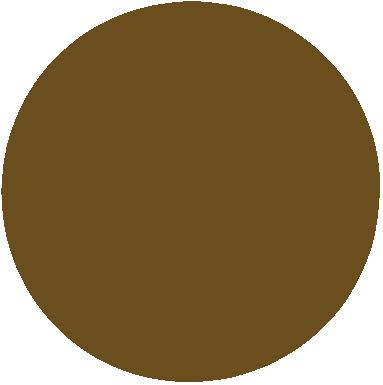
I nuovi LARN confermano: carboidrati sì, ma di qualità (come la pasta) Recuperare senza carboidrati è come costruire senza cemento FABBISOGNO GIORNALIERO DI CARBOIDRATI (in grammi per kilogrammo di peso corporeo desiderabile)
Nell'immaginario collettivo, un piatto di pasta viene visto come un «carico di zuccheri»
100 g di pasta cotta
Anche l’alimentazione per l’attività fisica e lo sport deve ispirarsi alla dieta mediterranea con il 45-60% dell'energia dai carboidrati
175 kcal meno di tanti piatti percepiti come light
MODELLO DELLE «4R» (Rehydrate-Refuel-Repair-Rest)
Dopo 60-90 minuti di esercizio intenso le scorte di glicogeno si riducono fino al 60%. La
fondamentale nel recupero post-allenamento



chilo di peso corporeo desiderabile, preferibilmente complessi (come quelli della pasta), e ben distribuiti durante la giornata”.
Nel caso degli sportivi d’élite, questi valori crescono in proporzione alla durata e all’intensità dello sforzo muscolare, arrivando a 6-10 grammi per chilo al giorno per chi si allena da una a tre ore quotidiane. Fino a toccare addirittura i 12 g/kg per atleti che si preparano per attività estreme come la maratona, il triathlon o il nuoto di fondo.
“Stupisce che nonostante le evidenze scientifiche e nutrizionali molti attacchi alla dieta mediterranea arrivino proprio dal mondo dello sport”, spiega Giampietro, “da chi propone modelli iperproteici come la dieta a zona o iperlipidici come la chetogenica, che invece non sono adatti a sostenere prestazioni atletiche di qualità”. Il nostro organismo, infatti, è in grado di immagazzinare solo limitate quantità di carboidrati sotto forma di glicogeno nei muscoli e nel fegato. Ma se l’apporto è insufficiente – per esempio a causa di regimi low-carb – le scorte non si realizzano pienamente e, quindi, si esauriscono rapidamente. “I risultati? Maggior senso di fatica, calo della prestazione e minore concentrazione e capacità di aumentare la velocità nelle fasi finali delle
corse”, conclude l’esperto. “Una dieta ricca di carboidrati, invece, migliora la qualità dell’esercizio e la capacità di prolungare nel tempo il lavoro muscolare, a tutti i livelli: dall’amatore all’atleta di alto livello”.
ENERGIA PLANT-BASED, RECUPERO E BENESSERE PSICOLOGICO
La pasta ha un profilo nutrizionale ideale per chi pratica sport: apporta carboidrati complessi a lento rilascio, proteine vegetali (in media 12-13%, ma alcune tipologie superano il 20%), vitamine del gruppo B e minerali come il potassio, il tutto con una quota minima di grassi. “Nell’immaginario collettivo, un piatto di pasta viene ancora visto come un ‘carico di zuccheri’ che finisce dritto in grasso”, spiega Elisabetta Bernardi, nutrizionista dell’Università di Bari e divulgatrice scientifica, “ma si dimentica che 100 g di pasta cotta apportano solo 175 kcal, meno di tanti contorni light conditi generosamente”.
Oltre a fornire energia prima dell’attività fisica, la pasta è fondamentale nel recupero post-allenamento riducendo anche l’incidenza di infortuni e danni muscolari da sovraccarico. “Recuperare senza carboidrati”, osserva Bernardi, “è come avere un mura-
tore con una pila di mattoni perfetti (le proteine) ma senza cemento per unirli. Le diete low-carb invece non aiutano chi fa sport: rallentano la sintesi proteica e amplificano la cosiddetta ‘finestra catabolica’”.
Nel modello delle “4R” (Rehydrate, Refuel, Repair, Rest), riconosciuto dal Comitato Olimpico, i carboidrati giocano un ruolo centrale. Dopo 60-90 minuti di esercizio intenso, le scorte di glicogeno si riducono fino al 60%. “È lì che serve una ricarica intelligente”, spiega Bernardi. E un piatto di pasta ben costruito con un condimento mediterraneo è la risposta: fusilli con ricotta e limone offrono proteine assimilabili, pasta e lenticchie è un pasto completo a basso carico glicemico, e anche la classica pasta al ragù, che non si associa nell’immediato allo sport, unisce carboidrati, aminoacidi essenziali e ferro.”
C’è poi l’aspetto psicologico, spesso trascurato. “Il cibo è anche piacere e condivisione”, conclude Bernardi, “e per chi vive sotto pressione, come molti sportivi, mantenere la dimensione gratificante del pasto è fondamentale. Studi mostrano che i pasti condivisi migliorano aderenza alla dieta mediterranea e performance, riducendo anche ansia e depressione del 30-40%”.

Marco Barbetti Logicà
A DIFFERENZA DELL’INDUSTRIA 4.0, CHE PUNTAVA SULL’AUTOMAZIONE, L’INDUSTRIA 5.0 VALORIZZA
IL RUOLO DEGLI ESSERI UMANI ACCANTO ALLE MACCHINE. L’OBIETTIVO È CREARE PROCESSI DI PRODUZIONE PIÙ PERSONALIZZATI, EFFICIENTI E SOSTENIBILI, UNENDO IL MEGLIO DELLE CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE
Il Piano Transizione 5.0 punta a rendere le imprese più competitive e a ridurne l’impatto ambientale grazie a investimenti in tecnologie all’avanguardia e alla formazione del personale. Rientrano nel piano i seguenti beni:
§ strumentali materiali: macchinari e attrezzature avanzate, sistemi di automazione industriale e dispositivi per il controllo e il monitoraggio dei processi basati su tecnologie IoT;
§ immateriali: software avanzati, piattaforme digitali, soluzioni di intelligenza
artificiale e sistemi di analisi dei dati (big data);
§ sostenibilità: tecnologie volte a migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di carbonio e promuovere l’economia circolare.
QUALI I BENEFICI?
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta la cui percentuale varia a seconda del risparmio energetico che gli investimenti agevolabili permettono di ottenere in base a una serie di parametri
riportati in Tabella 1. Il Piano Transizione 5.0 è cumulabile con tutte le agevolazioni, comprese quelle finanziate con fondi europei, e anche con il credito d’imposta ZES (zona economica speciale per il Mezzogiorno).
A differenza del credito d’imposta 4.0, l’agevolazione 5.0 dovrà essere obbligatoriamente prenotata sulla sezione dedicata del portale del GSE tramite una procedura che prevede una certificazione ex ante (prima dell’investimento) che potrà essere redatta solo ed esclusivamente da

Il Piano Transizione 5.0 è un’opportunità se si è definito un progetto di investimento che produce risparmio energetico, con una cospicua introduzione di rinnovabili e un sistema aziendale di misurazione consolidato
certificatori abilitati (Art. 38 - Comma 11 Legge 56 del 29 Aprile 2024).
QUALI OPPORTUNITÀ PER LA LOGISTICA?
L’industria 5.0 è un’opportunità che introdurrà cambiamenti tangibili nel settore logistico, attraverso applicazioni mirate per l’efficienza e la sicurezza, quali, per esempio:
d’imposta 5.0
Importo investimento Risparmio energetico di almeno il 3% dei consumi energetici dell’unità produttiva oppure di almeno il 5% dei consumi energetici dei processi produttivi
a
§ Automazione del trasporto merci: l’adozione di carrelli automatici AGV (Veicoli a Guida Automatica) e di robot automatizzati AMR (Robot Mobili Autonomi) nei magazzini trasforma il trasporto delle merci. Questi mezzi automatizzano il trasporto interno, migliorando l’efficienza e riducendo il rischio di errori.
§ Gestione avanzata delle scorte: i sof-
Risparmio energetico di almeno il 6% dei consumi energetici dell’unità produttiva oppure di almeno il 10% dei consumi energetici dei processi produttivi
Risparmio energetico di almeno il 10% dei consumi energetici dell’unità produttiva oppure di almeno il 15% dei consumi energetici dei processi produttivi
tware WMS di gestione della supply chain, potenziati dall’intelligenza artificiale, permettono un controllo più preciso delle scorte e una pianificazione ottimizzata, riducendo gli sprechi e migliorando la risposta alle fluttuazioni del mercato.
§ Manutenzione predittiva: l’implementazione di sensori e software consente di monitorare lo stato dei macchinari in tempo reale, prevenendo guasti e riducendo i tempi di fermo.
§ Ottimizzazione di picking e imballaggio: l’introduzione di sistemi automatizzati per il picking e l’imballaggio accelera questi processi, aumentando la precisione e alleggerendo il carico di lavoro fisico dei dipendenti.
§ Tracciamento accurato dell’inventario : l’adozione di tecnologie come sistemi di lettura dei barcode , dei QR code o dei tag RFID sui carrelli ele -
vatori migliora notevolmente la tracciabilità e la gestione dell’inventario, offrendo una visione chiara e aggiornata delle scorte.
§ Ottimizzazione della preparazione degli ordini : l’automazione e l’ottimizzazione della preparazione degli ordini, supportata da software intelligenti, migliorano la velocità e l’accuratezza nel soddisfare le richieste dei clienti.
§ Analisi dei dati avanzata : l’uso di strumenti di analisi dei dati e di business intelligence fornisce dati indispensabili per ottimizzare le operazioni, prevedere le tendenze di mercato e prendere decisioni.
Queste applicazioni specifiche dell’industria 5.0 stanno portando il settore logistico verso un futuro più efficiente,
sicuro e sostenibile, sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia avanzata con un focus importante verso la responsabilità e sostenibilità ambientale, attraverso, per esempio, l’utilizzo di forme di energie alternative, quali carrelli elevatori con batterie al litio in sostituzione di quelli termici e la promozione di pratiche sostenibili.
Per accedere alle agevolazione fiscali a tale impostazione va, inoltre, aggiunto un ulteriore elemento riconducibile ai concetti di etica e sicurezza, ponendo un’importante enfasi sul benessere dei lavoratori, ovvero attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro e soddisfacente, ove gli addetti sono valorizzati e sono parte integrante dei processi interni.
NUOVE FIGURA PROFESSIONALI
L’approccio e la gestione nella logica 5.0 richiederà per le aziende più strutturate la creazione di alcune figure professionali specifiche. Tra questi troviamo il manager della sostenibilità , che si occupa di sviluppare e implementare strategie aziendali volte a ridurre l’impatto ambientale e promuovere la sostenibilità.
Il credito d’imposta 5.0 è uno strumento fiscale che permette alle imprese di recuperare parte delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, che siano legati all’innovazione tecnologica. Questo incentivo è stato creato per incoraggiare le aziende italiane a investire in soluzioni tecnologiche avanzate, in grado di migliorare i processi produttivi, aumentare la competitività e affrontare le sfide della sostenibilità ambientale e della transizione digitale.
Se il focus di Industria 4.0 era centrato sull’automazione e la digitalizzazione dei processi attraverso l’utilizzo di tecnologie come, per esempio, l’Internet of Things (IoT), Industria 5.0 punta a integrare la tecnologia non solo per rendere le aziende più efficienti, ma per creare un ambiente di lavoro in cui l’uomo e la macchina interagiscono in modo più armonioso e con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ecologico delle attività.
Oltre a monitorare il rispetto delle normative ambientali, ottimizza l’uso delle risorse e sensibilizza i dipendenti verso pratiche più sostenibili, garantendo un equilibrio tra responsabilità sociale, ambientale e obiettivi economici.
Un’altra figura sarà il manager dell’energia che si occuperà di gestire l’efficienza energetica di un’organizzazione. Il suo ruolo include l’analisi dei consumi energetici, la pianificazione di interventi per ridurre sprechi/costi e la transizione verso l’uso di fonti energetiche rinnovabili. È spesso coinvolto nella definizione di politiche energetiche aziendali e nel rispetto delle normative in materia di energia.
L’attenzione generale sul Piano Transizione 5.0 ha una giustificazione più che valida, rappresentata dal beneficio potenziale significativamente superiore a quello offerto dal piano Transizione 4.0. L’impegno derivante da procedure e oneri burocratici, dalle certificazioni, comunicazioni e rendicontazioni è però decisamente più stringente. Inoltre, i tempi a disposizione sono decisamente minori; infatti tutte le pratiche, comprese quelle dell’interconessione alle quali fa riferimento la 4.0, devo essere terminate entro il 31 dicembre 2025. Detto questo, il Piano Transizione 5.0 è un’opportunità se si è definito un progetto di investimento che produce risparmio energetico, con una cospicua introduzione di rinnovabili e un sistema aziendale di misurazione consolidato. Diversamente, anche per evitare problematiche e sanzioni, Industria 4.0 è ancora una possibilità, seppur minore in termini di benefici fiscali, che può essere di aiuto.
Articolo già pubblicato su Blu&Rosso n°301, qui ripreso
NON
Si è svolto a maggior scorso il webinar organizzato da Stesi Srl e Induvation dedicato alla logistica nelle cantine vinicole e alle strategie per ottimizzarne la gestione delle scorte e dei canali di vendita. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti del settore e il contributo di relatori di grande esperienza: Alessio Pavan, Operations Director di Stesi specializzato nella gestione avanzata del magazzino e nell’ottimizzazione della supply chain integrata, e Marco Brisotto, Management Consultant, responsabile della divisione Integrated Logistics di Induvation, società di consulenza manageriale in ambito organizzazione aziendale e operations. Durante l’incontro sono stati affrontati temi fondamentali come le sfide logistiche del settore, nonché il ruolo fondamentale del WMS come alleato strategico per ottimizzare la logistica e aumentare la redditività. Il 90% del successo commerciale di una cantina non dipende, infatti, dalla qualità del vino ma dall’efficace gestione di magazzino e logistica, il vero fulcro delle attività quotidiane di un’azienda vinicola (gestione degli ordini, pianificazione, acquisti, magazzino, analisi dei dati, processi standard). Le principali sfide logistiche del settore vinicolo sono legate alla multicanalità (GDO, Horeca, e-commerce, enoturismo; personalizzazione degli ordini e aumento della frammentazione; integrazione dei Sistemi Informativi: portali e-commerce, portali clienti, CRM, ERP, etc.) e alla gestione del magazzino e delle scorte (monitoraggio in tempo reale: rotazioni lente e rapide, gestione delle annate, ubicazioni; analisi della domanda: stagionalità, difficoltà di bilanciare le risorse logistiche; tracciabilità (etichettatura, lotti, registro carico/scarico


vino). Per garantire una logistica davvero efficiente, dotarsi di un sistema gestionale non è più sufficiente. Il vero alleato è il WMS, l’unico in grado di trasformare il magazzino in un vero e proprio centro di valore, garantendo tracciabilità in tempo reale, l’automazione dei processi, l’ottimizzazione degli spazi, la preparazione veloce e precisa degli ordini, la riduzione e gestione più efficace delle scorte e l’eliminazione dell’errore umano. Grazie anche all’integrazione dell’intelligenza artificiale e del MotionMining, esso consente
di ridurre i costi operativi fino al 20% e i trasporti del 15%, migliorando la soddisfazione del cliente e la competitività dell’azienda. Gestire la logistica non significa solo movimentare bottiglie, ma creare valore. Un sistema di gestione intelligente, come il WMS, è fondamentale per affrontare con successo le sfide di un mercato sempre più competitivo, multicanale e digitale.
STESI www.stesi.it
Barilla apre le porte della sua “Città della pasta” a Pedrignano (PR), per ospitare una live visit in collaborazione con il partner Transporeonsocietà di Trimble.
A dare il benvenuto agli ospiti, Roberto Magnani, Vice President Logistics di Barilla Group, Gianluigi Mason, Logistic Italy Director Barilla Group e Davide Busato, Logistics Systems and Processes Ass. Manager. La mattinata è poi proseguita con la visita del sito di Pedrignano, il più grande magazzino automatizzato del mondo nel settore alimentare, con una superficie complessiva di 60.000 m².
L’inizio della partnership tra il colosso del settore alimentare e la piattaforma di gestione dei trasporti risale al 2014, quando Barilla ha riorganizzato i propri asset logistici e di conseguenza trasformato l’intera gestione delle operazioni. “Ai trasporti è dedicato il 65% del budget per la logistica e nello specifico il 50% dei nostri carichi viaggia su gomma, per questo è essenziale sostenere il nostro network nazionale e internazionale
scegliendo soluzioni innovative come quelle proposte da Transporeon per gestire al meglio i nostri volumi che toccano le 600 mila tonnellate annue”, afferma Gianluigi Mason. A seguito di una riorganizzazione della propria configurazione logistica, legata all’espansione della multinazionale – che conta ad oggi circa 110.000 spedizioni Full Truck Load all’anno in 100 nazioni – è entrata in scena Transporeon, che ha avuto l’onere di trovare soluzioni in grado di efficientare il processo di assegnazione dei carichi ai vettori. Ad esempio, grazie alla soluzione Time Slot Management, Transporeon ha facilitato l’ottimizzazione dei processi interni armonizzando il flusso tra magazzino e baie di carico e riducendo i tempi di attesa del 20%, tanto che le soluzioni della piattaforma sono ora utilizzate in tutti gli stabilimenti italiani e buona parte di quelli europei del gruppo.
La funzionalità Transport Assignment permette di ovviare alla gestione manuale dell’assegnazione dei trasporti ai vettori, estremamente dispendiosa in termini di tempo ed efficienza operativa. Infatti, proces-

si come l’assegnazione del vettore alla rotta più appropriata, l’analisi della copertura geografica e dei percorsi migliori, la valutazione dell’idoneità dei trasportatori e la verifica dei tempi di consegna garantiti sono solo alcuni dei parametri da verificare per valutare i vettori; valutazioni ora fornite dalla piattaforma. “Dal 2022 utilizziamo anche ‘Rate Management’ che ci consente di ottimizzare il processo di assegnazione delle tratte. In caso di mancata disponibilità del vettore scelto, la piattaforma trova automaticamente una soluzione di backup, dandoci la possibilità di gestire eventuali criticità in tempo reale”, dichiara Davide Busato. Le informazioni arrivano dalla piattaforma Transporeon direttamente alla Logistic Control Tower di Barilla, per poi essere consolidate; a questo punto le tratte saranno assegnate secondo la modalità No Touch Order per quelle già contrattualizzate, oppure Best Carrier per i viaggi spot.
TRANSPOREON www.transporeon.com


Sostenibilità ambientale e innovazione nella logistica: sono questi i cardini della partnership tra Barilla, Nicolosi Trasporti e Vulcan, che da anni collaborano per ridurre l’impatto ambientale della filiera alimentare. Una strategia condivisa che oggi si traduce in numeri concreti, tecnologie all’avanguardia e un modello virtuoso di trasporto a basse emissioni.
Dal 2020, infatti, le spedizioni su gomma verso la Sicilia e parte del Nord Italia firmate Barilla sono affidate a Nicolosi Trasporti, realtà siciliana, che ha scelto di investire in una flotta interamente alimentata a GNL e Bio-GNL, quest’ultimo ottenuto da scarti agricoli. Con circa 5.000 viaggi all’anno, Nicolosi contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni climalteranti, rendendo tangibile l’impegno green di Barilla. Un ruolo chiave lo gioca anche Vulcan, operatore italiano con oltre 50 anni di esperien-

za nella distribuzione di gas naturale liquefatto e pioniere nella creazione di una filiera certificata del Bio-GNL. È grazie alla sua infrastruttura – tra cui spiccano numerose stazioni di rifornimento in Italia e in Europa – e al sistema di tracciabilità Vulcancard, che Barilla può contare su dati trasparenti e certificazioni ufficiali. Il sistema consente infatti di intestare all’azienda i certificati di Garanzia d’Origine emessi dal GSE, documentando con precisione la riduzione dell’impronta carbonica del trasporto.
E TRASPARENZA AL SERVIZIO DELLA
SOSTENIBILITÀ
Nicolosi Trasporti integra il suo impegno ambientale con un modello logistico che comprende la produzione di energia rinnovabile. I depositi, tra cui quello di Catania, sono alimentati da impianti fotovoltaici, mentre il primo impianto privato di LNG in Sicilia, di
proprietà dell’azienda, rappresenta un ulteriore tassello nella transizione ecologica del settore.
Negli ultimi due anni, l’uso di centinaia di tonnellate di Bio-LNG da parte di Nicolosi – anche grazie alla collaborazione con la Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. “Vulcan” – ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti, come le Garanzie d’Origine, che attestano l’utilizzo di fonti rinnovabili e il relativo recupero energetico in termini di MWh. Con questa collaborazione a lungo termine, Barilla, Nicolosi Trasporti e Vulcan dimostrano che la sostenibilità può – e deve – essere integrata nei processi chiave della supply chain, in un modello di sviluppo virtuoso che guarda al futuro dell’ambiente e dell’alimentazione. Una logistica più sostenibile non è più un’opzione: è la strada da seguire.
BARILLA www.barillagroup.com/it/

Francesco Nicassio
Dottore forestale esperto in gestione integrata degli infestanti
UN INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE EFFETTUATO IN UN MOLINO DIMOSTRA COME L’USO DELLA TECNOLOGIA
POSSA ESSERE DI GRANDE AIUTO PER INDIVIDUARE PUNTI DI INGRESSO UTILIZZATI DAI RODITORI ALTRIMENTI DIFFICILMENTE RILEVABILI
Siamo all’interno di un molino a grano duro dei primi del ‘900. La struttura, benché sempre perfettamente manutenuta e periodicamente ammodernata, risente dei problemi tipici degli edifici costruiti all’inizio del secolo scorso: scale strette e anguste, un montacarichi posticcio più utile al trasporto di merce e macchinari che di persone, il pavimento in legno, un piano interrato attraversato da numerosissimi cavidotti e tubazioni ma, soprattutto, un ultimo piano, dove sono presenti i filtri dell’aria, coperto da una tettoia. La struttura – un parallelepipedo con lati di circa 100 x 20 m e sei piani di altezza più quello interrato e, nelle immediate vicinanze, un complesso formato da una decina di silos in acciaio – confina a nord e a ovest con il centro abitato, a sud con la ferrovia e a est con un capannone industriale abbandonato. Agli inizi del mese di novembre 2024, al sesto piano vengono notate impronte ed escrementi di roditori; nei giorni successivi, grazie a un sensibile aumento della vigilanza, si notano tracce anche in altre zone del molino.
Viene immediatamente allertato il disinfestatore che, tempestivamente, implementa il posizionamento di trappole a scatto e colle su tutti i piani, con particolare attenzione alle scale e ai pianerottoli, i quali, assieme alle tubazioni pneumatiche e le canaline, sono l’unico collegamento tra i piani. Contestualmente vengono verificati e chiusi, con materiale non oltrepassabile dai roditori, tutti i cavidotti e gli spazi tra le pareti e i pavimenti attraversati dalle tubazioni pneumatiche.
Il giorno successivo viene rinvenuto un ciuffetto di peli e un’impronta su di una trappola collante, segno evidente che il roditore, benché fosse entrato in contatto con la stessa, sia riuscito poi a liberarsi. Da quel momento in poi, né sulle trappole collanti, né su quelle a scatto, né in altro luogo del molino si rinviene più alcuna evidenza.
Col passare dei giorni, si pensa che il roditore sia uscito dalla struttura ma, a distanza di circa una settimana dall’intervento straordinario di disinfestazione, si rinven-
gono due trappole a scatto disarmate al piano terzo. Il molino viene ispezionato accuratamente, sebbene con esito negativo, alla ricerca di eventuali punti di nidificazione o accesso; tale ispezione consente però di rinvenire tracce: impronte di zampe e di coda, escrementi e rosicchiamenti, segno di una presenza piuttosto continuativa e costante nel tempo.
Nonostante il numero di trappole a scatto, colle e sistemi multicattura posizionati in ogni ambiente i roditori continuano a sfuggire e sembra che abbiano smesso di frequentare il pavimento dei piani e si siano spostati solo sulle parti più alte: canaline elettriche, tubi pneumatici, coclee e parti alte dei macchinari. Come facciano a spostarsi da un piano all’altro resta un mistero; tutti i fori passanti da piano a piano sembrano essere stati chiusi e le scale non sembra vengano visitate.
USO DELLA TECNOLOGIA
A distanza di circa un mese dal primo rinvenimento, si decide di installare una rete di sensori di passaggio con tecnologia PIR (Passive InfraRed). Tale sistema consente

Le innovazioni digitali nel pest management stanno trasformando la gestione dei roditori, portando a sistemi più efficaci, efficienti e sostenibili
il rilevamento grazie a sensori che si attivano al passaggio di animali a sangue caldo che emettono radiazioni infrarosse.
Tali sensori sono collegati tra loro con tecnologia LO.RA (Long Range), un sistema di comunicazione wireless a lungo raggio e a bassa potenza in grado di inviare piccole quantità di dati su grandi distanze, e comunicano con una centralina che invia in tempo reale i dati a un software gestionale in grado di elaborare le informazioni.
Vengono installati venti sensori di cui: cinque al sesto piano, posizionati in modo pe-
rimetrale al piano con attenzione ai punti di ingresso e uscita delle tubazioni e dei cavi; tre al quarto piano, di cui uno vicino la porta, uno nel punto di ingresso delle tubazioni pneumatiche e uno all’uscita; tre al secondo di cui uno vicino la porta, uno nel punto di ingresso delle tubazioni pneumatiche e uno all’uscita; cinque al piano terra posizionati in modo perimetrale al piano, con attenzione ai punti di ingresso e uscita delle tubazioni e dei cavi; quattro al piano interrato, posizionati in modo perimetrale al piano con attenzione ai punti di ingresso
TRAPPOLA: In un molino vengono notate numerose tracce di presenza di roditori. Viene implementato il posizionamento di trappole a scatto e colle e vengono chiuse le possibili vie di ingresso.
DUBBIO: Nonostante le misure adottate i roditori continuano a manifestare la loro presenza. Tutti i fori sembrano essere stati chiusi, e non si capisce come riescano a spostarsi da un piano all’altro.
SENSORI: Si decide di installare una rete di sensori di passaggio a infrarossi. Ricostruendo il percorso dai roditori, si scopre un punto di ingresso del quale non si conosceva l’esistenza.
MONITORAGGIO: Dopo la chiusura del foro di ingresso non prima individuato, non sono più stati riscontrati roditori. La rete di sensori di passaggio è stata mantenuta a scopo di monitoraggio.
e uscita delle tubazioni e dei cavi. Detti sensori, installati in data 2 dicembre 2024, iniziano a raccogliere dati.
A distanza di una settimana esatta, incrociando i dati delle segnalazioni con gli orari, si capisce con buona sicurezza il tragitto percorso dai roditori. A seguito di un sopralluogo mirato nella zona di potenziale ingresso posta al sesto piano, si scopre un foro che collegava l’esterno con l’interno, difficilmente raggiungibile, tra due tubazioni parallele che percorrono tutti i piani del molino. Nello spazio tra un tubo e l’altro si rinvengono numerosi escrementi. I roditori evidentemente entravano dall’esterno a scopo trofico e poi uscivano percorrendo lo stesso percorso. Vengono quindi posizionate due tavolette collanti immediatamente all’ingresso del foro; anche qui viene posizionato un sensore di passaggio che, nella notte successiva, segnala la presenza. La mattina dopo vengono rinvenuti sulle tavolette collanti quattro roditori della specie Rattus rattus e, contestualmente, viene chiuso dall’esterno il foro di ingresso.
Dopo la chiusura di quell’unico foro di ingresso, non prima individuato, non sono più stati riscontrati ingressi. La rete di sensori di passaggio è stata mantenuta a scopo di monitoraggio.
Le innovazioni digitali nel pest management stanno trasformando la gestione dei roditori, portando a sistemi più efficaci, efficienti e sostenibili. L’integrazione delle tecnologie IoT con sensori intelligenti, monitoraggio remoto e analisi dei big data ha migliorato la capacità di rilevare tempestivamente le infestazioni e ottimizzare gli interventi, riducendo i costi operativi e l’impatto ambientale. La gestione intelligente dei parassiti è ormai una realtà che offre alle aziende una soluzione altamente tecnologica per affrontare le problematiche legate ai roditori, portando a risultati migliori per l’ambiente e per l’economia.

Incarlopsa è uno dei più grandi macelli spagnoli con un volume di macellazione di 600 suini all’ora per un totale di 70.000 suini a settimana. Sin dal 2017, l’impiego dell’ERP CSB-System ha consentito di ottimizzare i processi e rafforzare la sicurezza alimentare; successivamente ha dato la spinta verso l’automazione e la digitalizzazione di oggi.
MACELLAZIONE AUTOMATIZZATA
Il flusso di dati nell’intero impianto e la movimentazione delle mezzene è gestito dai tag RFID che dialogano con l’ERP CSB-System. Le soluzioni RFID garantiscono la rintracciabilità e l’automazione dell’impianto e consentono processi intralogistici accelerati nel rispetto, ovviamente, dei regolamenti europei su rintracciabilità ed etichettatura e qualità dei prodotti.
SALA SEZIONAMENTO HIGH TECH
Incarlopsa è stata una delle prime aziende

al mondo a disporre di un sistema di sezionamento supportato da IT. Sulla base del piano di sezionamento, viene eseguito il trasporto delle carcasse dalla cella di stoccaggio delle mezzene al sezionamento. Sulla prima delle tredici postazioni industriali CSB Rack, le mezzene vengono pesate automaticamente e ne viene registrato l’ingresso. Il taglio principale è eseguito in modo completamente automatico e la carne disposta in casse con Tags RFID e assegnate nei singoli I-Point. Questo consente un controllo completo dell’uscita sezionamento in tempo reale, la determinazione della resa di ogni partita e una panoramica dello scostamento tra risultato previsto e risultato effettivo.
Al termine delle linee di sezionamento Incarlopsa utilizza il CSB Eyedentifier, un sistema di riconoscimento automatico delle immagini basato sull’IA. Per mesi il CSB Eyedentifier ha “imparato” a identificare au-
tonomamente i tagli di carne nelle casse e a indirizzarli ai magazzini automatici dell’azienda.
CONTROLLO E GESTIONE DEI MAGAZZINI AUTOMATICI
Oltre alle strategie di riempimento e svuotamento, il modulo Gestione Magazzini Automatici di CSB-System controlla anche il magazzino buffer e il magazzino automatico a casse per la merce sfusa con quattro unità di stoccaggio e recupero. Il prossimo step sarà l’automazione dell’area spedizioni con un magazzino buffer con 14 linee di confezionamento/pesoprezzatura dove CSB-System continuerà a essere il partner informatico di riferimento.
Per saperne di più CSB-SYSTEM www.csb.com



pronte all’uso per le conte microbiologiche per il settore agroalimentare
Conta Aerobica - E.Coli e Coliformi - Lieviti e Muffe - Coliformi,
Enterobacteriaceae - Conta Eterotrofa - Staphylococcus Aureus
Oggi sul mercato esistono prodotti simili con caratteristiche laboriose che implicano diverse problematiche, come ad esempio la preparazione del terreno, la cross-contamination, la di usione dell’aliquota e la necessità di molto spazio per l’esecuzione di numerose piastre. Molti sono i test microbiologici, ma pochi sono stati studiati per risolvere pienamente i numerosi problemi riscontrati durante le analisi.
Le Piastre Microbiologiche Peel Plate Charm presentano le seguenti caratteristiche:
- Pronte all’uso, contenenti un terreno di coltura selettivo per la crescita dei microrganismi.
- Un solo passaggio, basta pipettare il campione da analizzare senza l’utilizzo di tecniche di di usione.
- Progettate e validate per essere sovrapposte.
- Tempi e le temperature di incubazione coincidono con le convenzionali procedure microbiologiche.
-Validate AOAC e NCIMS
- ISO 9001 : 2015




E’ uno strumentino portatile che indica in tempo reale la presenza di sporco organico sulle superfici o in acqua, attraverso la rilevazione di ATP e suoi derivati.
Kairosafe offre il Lumitester Smart abbinato ai tamponi Lucipac A3, con i quali si preleva il campione dalle superfici o dall’acqua. Il test, rapido e preciso, è utilizzabile per il controllo della sanificazione in tutti gli ambiti, alimentare, sanitario, HO.RE.CA, industriale ecc
Per ordinare:
codice 61324: Lumitester Smart
codice 1702671-60361: Lucipac A3 Surface, tamponi
codice 1702672-60365: Lucipac A3 Water, tamponi



Tamponcino per verificare la presenza di residui proteici sulle superfici. Il risultato viene valutato visivamente poiché il viraggio da giallo a verde indica la presenza di proteine. I 2 kit disponibili si differenziano per la sensibilità.
Per ordinare:
codice CC4008.0050: Pro-Check 20 µg
codice PC002.0020: Pro-Check SensiPLus 2 µg
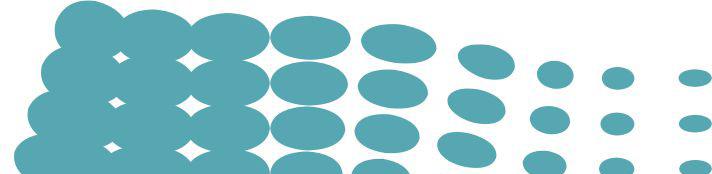
Contatta il nostro team
040 299502-2907149 info@kairosafe.it chatta con noi su www.kairosafe.it
Si tratta di dispositivi adatti a campionare superfici di ogni genere e ampiezza, punti difficilmente raggiungibili, attrezzature, carcasse animali, allevamenti ecc.
Vengono inumiditi con una soluzione sterile, spesso neutralizzante rispetto ai comuni disinfettanti, e poi strisciati sulla superficie delimitata da una cornice sterile di 10x10 cm o 5x5 cm. Infine vengono processati per seminare specifici terreni di coltura e determinare il numero di UFC.
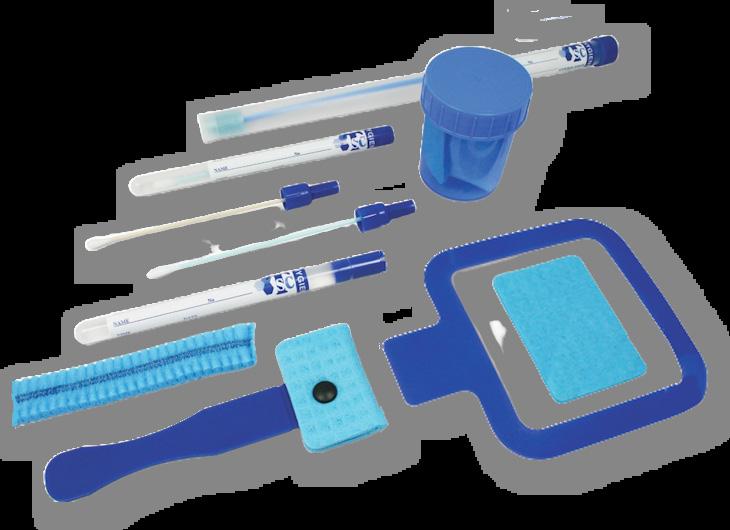
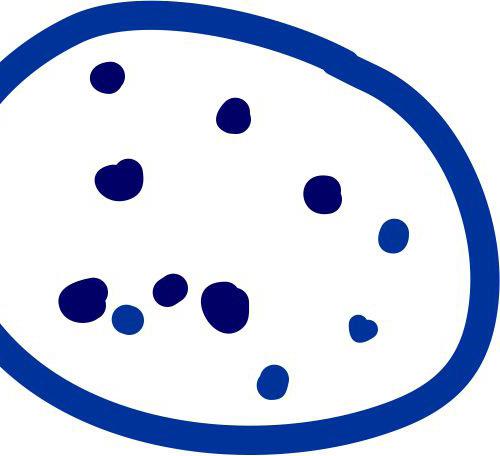

Cerchi precisione e velocità? Un test compatibile con i sistemi qPCR più comuni?
Kit qPCR per la rilevazione di una serie di microrganismi e allergeni in matrici alimentari, in abbinamento a diversi kit di estrazione degli acidi nucleici e reagente cellule vitali, per offrire le migliori performance.

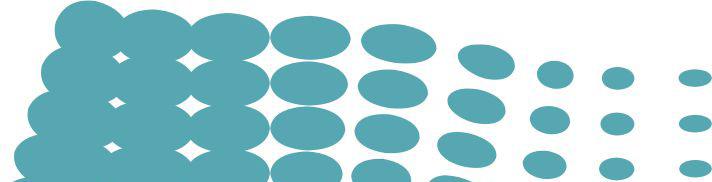
Trovi tutto nella sezione “Monitoraggio ambientale” del nostro sito www.kairosafe.it
Contatta il nostro team
040 299502-2907149
info@kairosafe.it chatta con noi su www.kairosafe.it