

1925-2025
Pàtron Editore
Riflessioni e racconti

Copyright © 2025 by Pàtron editore - Quarto Inferiore - Bologna
In copertina: progetto grafico di StudioNegativo.it
Casa Editrice Prof. Riccardo Pàtron & C. srl - via Badini 12
Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 051.767003
E-mail: info@patroneditore.com
sito: www.patroneditore.com
Stampa: Legodigit, Lavis (TN) per conto della Pàtron editore.

IntroduzIone
Per una Casa editrice, riuscire a festeggiare il proprio centenario è un traguardo importante, per una Casa editrice universitaria lo è ancora di più. Ed eccoci quindi qui a ricordare con orgoglio il momento della costituzione di quella che oggi è la Casa Editrice Prof. Riccardo Pàtron & C. Fondata da Riccardo Pàtron nel 1925 come “Grafolito”, la Casa editrice superò non senza le prevedibili ristrettezze il periodo della guerra, ma la volontà del fondatore di tenerla aperta fu incrollabile e la fine del conflitto vide la Casa editrice ancora in piedi, pronta a riassestarsi e a tornare a essere un importante punto di riferimento per gli accademici della città.
Il boom dell’istruzione universitaria verificatosi tra gli anni Sessanta e Settanta permise alla Casa editrice di espandersi, crescere e rinvigorirsi, tanto da attraversare indenne la liberalizzazione dei piani di studio e la nascita di tutta una serie di cooperative editoriali interne al circuito universitario. Negli anni Ottanta la Casa editrice attraversò un periodo di importante riassestamento: la scomparsa alla fine degli anni Settanta dell’ingegner Adelson Pàtron, uno dei figli del fondatore Riccardo, alla guida della Casa editrice da oltre vent’anni, impose alla famiglia di rimodulare la propria presenza in azienda, che si concretizzò con l’ingresso della terza generazione attraverso Riccardo, nipote
del fondatore e dell’ingegnere, che garantì il proseguimento delle attività.
Oltre ai cambiamenti al vertice, la Casa editrice andò incontro a riorganizzazioni a livello commerciale ed editoriale.
Una scelta sicuramente importante fu quella di proseguire con maggiore impegno nel settore scolastico, proponendo sul mercato nuove edizioni dei titoli più meritevoli, alcuni dei quali ancora oggi richiamano l’attenzione di insegnanti in cerca di testi “fatti come una volta”. Ovviamente la produzione scolastica non poteva prescindere da quella universitaria, tanto che uscirono delle riduzioni adeguate alle esigenze degli istituti tecnici e professionali, in particolare del settore agrario.
La produzione scolastica, supportata in termini commerciali da una rete di rappresentanti plurimandatari, terminò poi verso la fine degli anni Novanta.
Le aree disciplinari della produzione universitaria sono state le più varie fin dalle origini per esplicita volontà del fondatore e ancora oggi la produzione è caratterizzata da un catalogo in grado di rivolgersi a una vastissima gamma di corsi universitari, dall’umanistica alla bioingegneria, passando dalla geografia all’ingegneria fino a espandersi, più recentemente, agli studi comparativi in ambito umanistico e dei media.
L’elasticità aziendale ha permesso al catalogo di adattarsi in base alle sempre nuove esigenze del panorama universitario, rincorrendo pionieristicamente vari settori e dando spazio a molteplici voci.
Sempre negli anni Ottanta l’offerta si arricchì con l’affiancamento di nuove riviste tecniche alle già presenti testate umanistiche, ospitando a partire dagli anni Novanta
anche testate di valore nazionale e organi di associazioni scientifiche.
Questo passaggio fu fondamentale per lo sviluppo di un ramo d’azienda che ancora oggi garantisce pubblicazioni di qualità.
Oltre alla capacità di accogliere nel proprio catalogo le discipline più varie, la Casa editrice ha sempre avuto cura di restare legata al proprio territorio senza tuttavia precludersi collaborazioni anche al di là della realtà bolognese.
Il catalogo ospita grandi nomi del passato, tra cui, per ricordarne alcuni, troviamo Felice Battaglia, Eugenio Duprè Theseider, Carlo Tagliavini, Gina Fasoli, Dario Graffi, Renato Giovannozzi, Ettore Funaioli, Alfonso Traina, Giancarlo Susini, Ovidio Capitani, Luigi Giardini, Franco Lorenzetti e Remigio Baldoni.
Grazie a questi grandi maestri, la Casa editrice ha potuto proporre sul mercato testi didattici di riferimento che ancora oggi formano le nuove generazioni.
Il cuore della produzione era e resta la realizzazione di testi di didattica, alla quale si è affiancata da tempo, anche grazie al rigore metodologico seguito, la pubblicazione dei risultati di ricerca. L’azienda si pone così accanto ad Autrici e Autori, ascoltando le loro esigenze e mettendo a disposizione il proprio lavoro per garantire la diffusione del sapere. Non si tratta solo di una scelta di carattere commerciale, ma lo sviluppo di una visione che, ben radicata nel fondatore dell’azienda, è il faro guida anche nella produzione di oggi.
Negli ultimi vent’anni sono avvenuti molti cambiamenti tecnici e organizzativi: la progressiva delocalizzazione della produzione interna, la chiusura della storica tipografia di Quarto Inferiore, lo spostamento della sede operativa
dalla provincia al centro cittadino, in via Marsala, l’inclusione dell’Editore Clueb e dei suoi marchi Archetipo Libri e Biblioteca Clueb, sono tutti cambiamenti che hanno consentito l’ottimizzazione delle risorse e il potenziamento commerciale dell’azienda.
Infine, considerate le nuove dinamiche ed esigenze di studio, il catalogo Pàtron ha recentemente introdotto anche l’offerta digitale dei propri prodotti, confidando di poter mettere a frutto la soddisfazione di essere qui a festeggiare 100 anni di vita per rinnovarsi e proporre sul mercato volumi aggiornati non solo nei contenuti ma anche nella forma.
Siamo giunti a un traguardo importante: vogliamo volgere gli occhi al passato per ricordare quali sono le nostre radici, ma anche a festeggiare il futuro che ci aspetta, ricco di sfide e di nuove tecnologie attraverso le quali proporremo a chi si affiderà a noi l’uscita di titoli caratterizzati dalla consueta qualità.
E quale miglior modo di festeggiare se non che affidarsi ai ricordi di chi ci cammina accanto?
Non è stato possibile dare voce a tutti, ovviamente, ma siamo lieti di poter condividere il pensiero di alcuni tra i nostri Autori e direttori di Collana, per ricordare insieme momenti – aneddoti, curiosità e collaborazioni – che ci hanno portato fino a qui.
Spesso, nelle parole del ricordo si può ritrovare la gioia necessaria per affrontare le fatiche del presente, e per noi è un po’ la stessa cosa. In questo anno così significativo, l’impegno della storia che ci portiamo sulle spalle diventa rinnovato impegno per il futuro grazie alle parole di questi contributi.
L’Editore
GIan MarIo anselMI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Il mio primo incontro con Pàtron ha un esordio molto netto e difficilmente dimenticabile: ero matricola al primo anno di Lettere Classiche a Bologna e dovevo sostenere il duro esame di Letteratura italiana del severissimo professore Raffaele Spongano (con cui poi mi laureai). La gran parte dei testi, saggi, antologie e strumenti di mano del Professore stesso e con cui dovevamo preparare l’esame erano appunto editi da Pàtron: memorabile, e valga come esempio per tutti, fu l’approccio con l’ormai mitico Nozioni ed esempi di Metrica italiana, che ancora tengo fra i libri a me più cari. Edito da Pàtron in elegante copertina rigida e stampato, secondo le indicazioni di Spongano, con struttura redazionale chiarissima, resta un testo ancora oggi capitale per avvicinarsi allo studio della metrica italiana: un merito di Spongano, grande metricista (come lo era un altro mio maestro di quegli anni, il brillante e famoso grecista Carlo Del Grande), era di rendere chiara e accessibile per matricole che nulla ne sapevano i “fondamentali” della metrica. Tanto che, per molti anni dopo il pensionamento di Spongano, si adottava ancora il suo manuale, molto più chiaro dei manuali ispirati a fumose e narcisistiche analisi formalistiche e strutturalistiche. Noi, allora giovani docenti di Letteratura italiana, indicavamo i nuovi manuali “alla moda” ma alle matricole consigliavamo, per capire davvero le nozioni essenziali di metrica, ancora per lunghi
anni il prezioso testo di Pàtron. Altrettanto importante fu per me, prima da studente e poi da docente e ricercatore, l’incontro con la preziosa Collana di studi classici e latini fondata e diretta dall’indimenticabile Alfonso Traina: lì, su quei testi, imparai con entusiasmo la vera pronuncia del latino, l’esegesi di classici fondamentali, le nozioni di base per studiare il latino medievale.
Negli anni Ottanta, fu varata la prima Collana dipartimentale di italianistica: “L’esperienza critica”. Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna, per la quale uscirono quattro volumi: La “Memoria” dei mercatores di G.M. Anselmi, L. Avellini e F. Pezzarossa; Trame e ragioni dantesche di S. Abbadessa; Il soggetto centrifugo di V. Roda; Il “mistero” retorico della scrittura di A.M. Pasini Cavalli.
Da tutto ciò si evince che per noi qui a Bologna, e non solo, lo studio delle humanities facilmente veniva a coincidere spesso con i preziosi libri, riviste specialistiche e strumenti didattici editi dalla Pàtron. E la mia lunga carriera universitaria a Bologna, come Ordinario di Letteratura italiana e Letteratura italiana medievale, coincise con la frequentazione e con la presenza di quei volumi, anche i più antichi e spesso per mano di celebri studiosi, fra le mie letture e ricerche. La collaborazione attiva di noi italianisti bolognesi con Pàtron si impennò poi negli ultimi anni della mia Direzione del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica, verso il 2013: il fortunato incontro con la bravissima Responsabile Editoriale e cara amica Sandra Simoni portò alla nascita, in collaborazione con Loredana Chines (bravissima studiosa succeduta ai maestri della nostra vecchia generazione alla Cattedra di Letteratura italiana per il Corso di Laurea in Lettere) di vari volumi e di
ben due collane di studi italianistici, una di carattere più spiccatamente saggistico e specialistico e una di didattica innovativa della letteratura italiana (“Cultura umanistica e saperi moderni” e “I sentieri della letteratura”).
Io come Loredana e altri colleghi più o meno giovani avvertivamo l’esigenza di un profondo rinnovamento degli strumenti di didattica e di ricerca del nostro settore disciplinare. Sebbene avessimo già avviato importanti sperimentazioni con Editori di portata nazionale (Carocci, Bur, Franco Angeli e ovviamente, fin dal magistero di Ezio Raimondi, Il Mulino) pure avvertivamo l’esigenza di un importante Editore di fiducia che fosse “di casa” per noi ma con vocazione nazionale: a Bologna tanti piccoli editori avevano chiuso i battenti o erano stati assorbiti dalla stessa Pàtron (vedi Clueb, Archetipo, ecc.), altri navigavano a piccolo cabotaggio.
La Pàtron, appunto grazie alla forte capacità organizzativa della famiglia proprietaria e di Sandra Simoni, aveva ripreso un ruolo importante nell’Editoria specie umanistica (ma non solo), tanto da collocarla come vera e propria Casa editrice nazionale, rinverdendo

i fasti dell’epoca di Spongano, di Del Grande, di Traina. Da qui nacquero quelle Collane e Riviste ancora oggi vivacissime e fra le punte di diamante nel settore letterario della Pàtron. Anzi, mi attribuisco come merito quello di aver voluto fortemente una ripresa piena della collaborazione degli italianisti con Pàtron, tuttora un nostro punto di forza come Dipartimento e un luogo dove sperimentare quelle necessarie innovazioni di cui già parlavo. La storia continua… i rapporti si sono rinsaldati ulteriormente con l’arrivo, al posto di Sandra Simoni in pensione, di Erika Mucignat, nuova responsabile, attentissima ai linguaggi del presente e ai nuovi terreni di sviluppo come alla tradizione.
E questo indovinato volume per il glorioso Centenario della Pàtron lo conferma pienamente. Come dire: la Pàtron rappresenta per me e per tanti un felice ricordo della giovinezza e degli anni da studente cadenzati da volumi Pàtron che poi mi hanno accompagnato per tutta la vita. Non è un caso se Loredana Chines e altri miei allievi abbiano voluto che il volume di studi uscito in mio onore per i miei settant’anni nel 2017, dal titolo molto intrigante e innovativo, Humana feritas. Studi con Gian Mario Anselmi, fosse edito proprio da Pàtron, con la generosa dedizione allora di Sandra Simoni e della stessa famiglia Pàtron con cui mi auguro di poter veder ancora crescere le nostre collaborazioni. È questo del resto il senso dei libri e degli Editori che ci accompagnano: fare da ponte fra un passato ricco di premesse e il futuro che dobbiamo ancora costruire insieme alle nuove generazioni di studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori.
GIuseppe GIlberto bIondI
Università degli studi di Parma
Pàtron, per uno studente che, come chi scrive, dalla Romagna si fosse iscritto all’università di Bologna nella seconda metà degli anni Sessanta (per precisione il ’67-’68: l’ultimo anno in cui si celebrò la festa della matricola e il primo che iniziò, appunto, il… ’68), era un nome che presto diveniva familiare, più che per la sua “impressione” nelle copertine dei non pochi manuali in programma per esami, per la famosa libreria di via Zamboni, angolo Marsala, che già dai primi giorni di lezione (quasi mai prima di metà novembre: eravamo in un altro millennio!) anche noi studenti neobolognesi cominciavamo (con una faccia un po’ così, un’espressione un po’ così) se non a frequentare quanto meno a “individuare”, sotto i portici, attigua a un piccolo bar, quello sì già frequentatissimo da iscritti non solo alla vicina facoltà di Lettere ma alle tante altre facoltà, tutte servite dalla grande libreria universitaria. Col passare degli anni, e degli esami, le sigle Pàtron (quella dei libri e quella della libreria) mi accompagnavano, sempre più familiari e compulsate – fino a divenire, la libreria, meta quotidiana, preceduta dal rito pausa caffè (nel piccolo bar) –, spesso in compagnia dei miei mitici maestri Alfredo Ghiselli e Alfonso Traina, ma l’aggiunta “Editore” rimase puro significante (o significato astratto)
fino al giorno in cui il mio primo maestro, Ghiselli (di Traina, trasferitosi da Padova a Bologna dall’ottobre del ’74, bisognoso di un assistente per esami e esercitazioni, mi sentivo più che assistente un assistito e privilegiato studente), mi invitò a raccogliere alcuni articoli su rivista per un eventuale concorso a un probabile bando per professore incaricato di Grammatica Greca e Latina per l’anno accademico 1978-1979. L’“affettuoso” consiglio del maestro fu di presentare anche un volumetto. Non capivo ma mi adeguai.
E così imparai che la parola “Editore”, giustapposta a “Pàtron”, non rappresentava una estensione tipografica della libreria (magari allocata nella vicina via Marsala) ma rimandava a una “casa” vera e propria, ubicata in una zona periferica della città: Quarto Inferiore.
Ad accompagnarmi fino alla materializzata Casa editrice (non ricordo se alla fine del ’77 o all’inizio del ’78) fu lo stesso Ghiselli, che mi presentò al geometra Bruno Pasquetto, direttore tecnico dell’impresa editoriale fondata, appunto nel 1924, dal prof. Riccardo Pàtron.
Del geometra Pasquetto, oltre alla gentilezza della persona, appena dissonante con la voluminosa corporatura, ricordo, in occasione del primo incontro (propedeutico al volumetto) un suo accenno a una delle dattilografe, efficientissima nel trascrivere i testi, a condizione – disse – di ascoltare musica a tutto volume (immagino nelle cuffie). Eravamo appunto in un altro millennio.
L’avvicinarsi del terzo millennio ebbi modo di intuirlo sempre dal geometra Pasquetto in occasione, l’anno seguente, questa volta non di una “consigliata” raccolta di articoli, ma di una monografia da collocarsi nella famosa
Collana Verde: si era vicini a una possibilità di scrittura – ricordo – non più dattilografica ma da diretta dettatura vocale, salvo l’inconveniente non risolto della riproduzione dei segni diacritici: se dettavi “punto” la macchina scriveva “punto”, “virgola” e la macchina scriveva “virgola”. Il nuovo millennio – anche quello tipografico – era comunque alle porte.
Per alcuni anni i risultati delle mie ricerche ebbero come sbocchi articoli su riviste e comunque non su collane di Pàtron, fino a che, ai primi dell’’84, i tempi furono maturi per un libro, più voluminoso dei precedenti, collocabile sempre nella “amica” Collana Verde.
Chiesto un contatto telefonico con la Direzione, il centralino mi passò un nuovo direttore, l’ing. Aldo Lanza, con cui fissammo un appuntamento. Ad esso era presente anche una giovane gentile e interessante collaboratrice, Sandra Simoni, cui l’ingegnere mi affidò per tutti gli aspetti logistici (ma non solo) dell’operazione.
Da quel momento sono passati quarant’anni e Sandra Simoni, assistita nel frattempo da eccellenti collaboratori, è divenuta mia immagine interiore della stessa Casa editrice Pàtron.
MarIella bonvIcInI
Università degli studi di Parma
Correva l’anno 1987. Già da tempo, dopo il perfezionamento, ero seguita dal prof. Alfredo Ghiselli nella mia attività di ricerca. Più volte mi ero imbattuta nella produzione della Casa editrice Pàtron e in particolar modo nelle collane “Testi e manuali per l’insegnamento universitario del latino” alla base del nostro percorso di studenti, ed “Edizioni e saggi universitari di filologia classica”, di cui Ghiselli era condirettore assieme a Gualtiero Calboli, Italo Mariotti e Alfonso Traina. Di alcuni di questi volumi avevo stilato anche delle recensioni, ma fu solo nel 1987 che entrai in contatto diretto con la Casa editrice. Ghiselli aveva in preparazione il volume Catullo, Guarnerianus 56 Escorialensis ç IV 22. Per lavorare alle ultime bozze, con lui e altri suoi allievi, mi recai nella sede dirigenziale e operativa della Pàtron, nella pianura bolognese, a Quarto Inferiore, in aperta campagna. Facemmo il nostro ingresso in un edificio enorme, spartano, quasi conventuale. Ci fu assegnata una sala anch’essa enorme, immersa in un assoluto silenzio, con grandi tavoli, su cui distribuimmo i vari fogli ed eseguimmo il lavoro di revisione. Ebbi l’opportunità di intravedere l’ingegner Aldo Lanza, allora il direttore, noto per la squisita sensibilità culturale, che ci accolse con grande cordialità; non ebbi però più occasione di rivederlo in seguito, perché poco dopo i contatti furono tenuti da Sandra Simoni.
Da quel momento cominciò la mia collaborazione diretta, intensa, proficua e ininterrotta con la Casa editrice. Dato alle stampe il volume sui codici catulliani, mi occupai subito di altri due volumi: Mnemosynum, a opera di allievi e colleghi, per celebrare i settant’anni del nostro maestro Alfredo Ghiselli, e il mio commento al poemetto latino Agape di Giovanni Pascoli. Uscirono entrambi nel 1989 dopo molto lavoro e qualche imprevisto. Imprevisto relativo al mio commento. Erano ancora i tempi in cui si redigevano i testi a mano, successivamente si copiavano con la macchina da scrivere, si correggevano sempre a mano, poi venivano affidati al proto per la stampa. Mia madre aveva provveduto al lungo lavoro di battitura e su quel mucchio di fogli, ormai pronti per la consegna, avevo fatto diverse modifiche suggerite da Ghiselli. Lasciai il plico per la tipografia nell’auto dentro una elegante borsa di pelle mentre andavo a trovare mia madre ricoverata al Rizzoli. Nel parcheggio un ladro, poco accorto, pensò di infrangere il finestrino e di portarsi via la ‘preziosa’ borsa e così… dovetti tornare alla versione precedente non aggiornata e ricostruire il lavoro perduto. Fortuna volle che l’amico Mauro Lasagna si fosse nel frattempo procurato uno dei primissimi “personal computer” e si offrisse pure, per fare esercizio con il suo nuovo ‘strumento’ (che richiedeva una manualità e una pazienza inimmaginabili rispetto agli attuali PC), di ricopiare il tutto. Così finalmente, con un certo ritardo ma anche con un po’ di compiacimento, andai a portare i floppy disk a Sandra Simoni, che mi accolse molto cordialmente senza nemmeno accennare alla fastidiosa dilazione. Da allora per me Pàtron si identificherà con Sandra Simoni e la collaborazione continuerà ininterrotta per più di trent’anni.
A parte la pubblicazione di molti dei miei studi, non posso dimenticare due richieste rivoltemi direttamente
dalla Casa editrice. Su indicazione di Alfonso Traina, Sandra Simoni mi propose: l’aggiornamento per le ristampe di Cesidio De Meo, Lingue tecniche del latino (III ed. 2005), e La lingua poetica latina, a cura di Aldo Lunelli (IV ed. 2011), due mitici volumi della Collana “Testi e manuali per l’insegnamento universitario del latino”, con cui mi ero già cimentata durante il percorso di studi universitari. In questi casi si procede di solito fornendo una breve segnalazione e analisi della bibliografia successiva all’edizione precedente. Nel corso della mia ricerca emersero però anche vari spunti e filoni nuovi per cui gli aggiornamenti risultarono davvero “giganteschi”. Soprattutto per il primo mi presentai molto timorosa alla consegna, preparata a sentirmi dire che un’appendice di 150 pagine per una riedizione era davvero sproporzionata. In cuor mio ero già pronta anche a ridurre e a sintetizzare, sacrificando in parte i risultati del faticoso lavoro… e invece no. Andò tutto bene: l’insolita proposta fu accettata senza battere ciglio e portata in porto senza alcun problema. Nel caso della Lingua poetica mi sentivo un po’ più tranquilla (vista l’esperienza precedente e anche perché si trattava solo di 75 pagine), ma l’autore-curatore, Aldo Lunelli, espresse il desiderio di leggere il mio testo prima che fosse dato alle stampe. Dopo averglielo inviato, il giorno stabilito partii per Padova, con l’amica e collega Alessandra Minarini (anche lei allieva di Ghiselli e autrice della Pàtron): portavo con me una copia cartacea su cui riportare le sue correzioni. Anche in questo caso andò tutto per il meglio, Lunelli si limitò a qualche breve e rapida osservazione e la “giornata padovana” si trasformò in una visita della città.
Nel medesimo periodo, a rendere ancora più frequenti i contatti con la Casa editrice, si aggiunsero due libri di Ghiselli, Catullo. Il passer di Lesbia e altri scritti catulliani, del
2005, e Commento alla sintassi latina. Ristampa con due saggi complementari, del 2012, che seguii direttamente perché il professore (alle soglie dei novant’anni nel 2005), lucidissimo e quanto mai attivo intellettualmente, era meno propenso agli spostamenti e ai controlli tipografici, comunque di gran lunga semplificati grazie all’uso del computer (e sempre all’aiuto di Mauro Lasagna, divenuto nel tempo anche amico e collaboratore di Ghiselli stesso).
Nel frattempo la sede operativa della Pàtron si era spostata da Quarto Inferiore nel centro di Bologna, dapprima nei locali della storica libreria di piazza Verdi, poi in via Marsala. Data la comodità, diverse volte, quando ero a Bologna, passavo anche solo per un saluto e due chiacchiere con Sandra Simoni, senza impegni particolari. Gli incontri erano sempre gradevolissimi: accolta come un’amica, era l’occasione, oltre che per rievocare qualche piacevole ricordo comune, per un aggiornamento sulle attività della Casa editrice, per uno scambio di opinioni sulle trasformazioni e i diversi problemi nati con le nuove tecnologie, nonché sulle ordinarie, ma sempre nuove difficoltà di gestione. Non sono mancate frequenti conversazioni telefoniche; ho incontrato di persona Sandra Simoni l’ultima volta alla Giornata di studi La lingua dei poeti a Roma in memoria di Alfonso Traina, tenutasi nell’aula Stabat Mater dell’Archiginnasio il 22-23 settembre 2022, un evento che lei caldeggiava da anni. Nell’austero ingresso dell’aula, assieme ad altro personale della Casa editrice, attendeva con un invitante sorriso i partecipanti, dietro un ampio tavolo dove erano in mostra tutte le pubblicazioni di Traina, disponibili per chi non ne fosse già in possesso.
Ho appreso dalla mail relativa alla celebrazione del centenario della Casa editrice che Erika Mucignat è la nuova responsabile: si è chiusa davvero un’epoca!
Non resta che augurare a Erika di raccogliere l’eredità di Sandra Simoni e di proseguirne l’attività con lo stesso zelo ed efficienza, per mantenere inalterato l’altissimo profilo scientifico (e umano) della Casa editrice.
beatrIce borGhI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Ricordo, oramai, venticinque anni fa, quando entrai con emozione nella sede di Quarto Inferiore di Pàtron, ricevuta da Sandra Simoni, coordinatrice e persona di riferimento delle mie pubblicazioni; fin da subito ho intuito l’eccezionalità della persona con cui mi sarei confrontata per tanti anni, professionale, esperta, sincera, dallo sguardo gentile e soprattutto amica.
Pàtron pubblicò il mio primo volume, che diede poi l’avvio ad altri saggi che hanno delineato e caratterizzato il mio percorso di ricerca sul viaggio e pellegrinaggio nel Medioevo, sugli statuti e sulla didattica della storia. Con motivazione e fiducia, abbiamo portato avanti diverse linee editoriali che hanno saputo dare valore alle molteplici esperienze culturali cittadine che durano da oltre vent’anni.
Intuendo l’importanza di creare una Collana che potesse dare merito alle ricerche e alle tante esperienze di didattica della storia e del patrimonio, nacque nel 2008 quella del Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna con l’obiettivo di porsi quale fulcro e luogo di confronto sullo studio e l’insegnamento della storia e del patrimonio culturale e ambientale. In particolare, attraverso la proposta e la condivisione di presupposti, terminologie, metodi, pratiche e strumenti adottati in varie sedi e paesi, il progetto editoriale ha inteso raccogliere e valoriz-
zare l’ampia gamma di esperienze, ricerche, progettazioni e attività condotte negli anni recenti a livello nazionale e internazionale nell’ambito della didattica della storia e dell’educazione al patrimonio, del settore dei beni culturali (archivi, biblioteche, centri documentali, musei, pinacoteche) e dell’articolato sistema associativo. Si trattava di una delle prime esperienze di pubblicazione che dava voce al mondo della scuola, delle realtà museali e associative e rendeva visibile e condivisibile le attività di educazione al patrimonio e alla cittadinanza attiva. Una lungimiranza che ha accompagnato, attraverso altre progettualità, la raccolta di saggi e attività quali convegni, conferenze, progetti educativi relativi alla rievocazione del Passamano per San Luca e della Festa Internazionale della storia, promossi dal Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica (LMRS), un’associazione volontaria, aperta a chiunque intendesse svolgere ricerche storiche, attestando ancora una volta la capacità di Pàtron di cogliere le esigenze dei tempi e di essere attivo promotore di cambiamento.
Un’attenzione alla didattica che aveva le sue radici nell’impegno profuso da Gina Fasoli e da Paolo Prodi che realizzarono nel 1982 una “guida” di metodologia della ricerca storica rivolta agli studenti, il cui obiettivo era di insegnare come si fa a trovare i testi che occorrono, come si debbono usare le fonti, come si lavora con ordine e metodo, e riflettere su quello che si fa.
Su tali premesse, la realizzazione della Collana “Il Medioevo: contesti, comunità, incontri” diretta dal professor Rolando Dondarini, che si propone come strumento di approfondimento e diffusione della conoscenza del Medioevo in tutti i suoi aspetti e in chiave multidisciplinare, accogliendo analisi e dissertazioni sulle questioni connesse alla ricerca storica. Il primo volume (Luce sui secoli
bui) approfondisce proprio l’aspetto dell’insegnamento della storia medievale.

La professionalità che contraddistingue Pàtron è il suo lavoro di artigiano del sapere; con gli attrezzi del mestiere cesella, cura, sistema, aggiusta con le sapienti mani di un gruppo di persone, le parole degli autori – le mie sicuramente –, dando vita ad un’opera unica. Quell’incontro di tanto tempo fa ha dato un senso al mio lavoro, perché in Pàtron mi sono sempre sentita a casa, sicura della correttezza, chiarezza e coerenza stilistica e formale che tutti gli artigiani della Casa editrice avrebbero messo per creare un’opera. Sono certa che percorreremo, ora insieme a Erika Mucignat, ancora tanta strada che ci porterà, riprendendo il titolo dell’ultimo volume, ad “andar per lo mondo”. Grazie per questi primi cento anni.
GIovannI brIzzI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dalla Pàtron Editore — che, dal lontano 1925, anno in cui nacque come Grafolito, sta per toccare ormai, pur avendo cambiato nome più volte, la venerabile soglia del secolo — chi scrive ha ricevuto molto più di quanto abbia dato; e ciò fin dal momento in cui, ormai oltre quarant’anni or sono, ha varcato decisamente intimorito, come giovanissimo assistente universitario, la soglia dei locali allora situati a Quarto Inferiore, facendovi conoscenza con la deliziosa Sandra Simoni. Molto debbo alla Pàtron; e se qualche cosa posso averle restituito, redigendo e pubblicando due trattati universitari (credo di poterli definire in tal modo…) di Storia romana, la creatura (amatissima anche se certo non mia…) cui più a lungo sono rimasto vicino è la «Rivista Storica dell’Antichità» (RSA, secondo la facile sigla che la rende familiare al mondo degli antichisti nel grande repertorio dell’Année Philologique); uno strumento che ha scandito costantemente, accompagnandola fino ad oggi, la vita dell’Istituto, poi Dipartimento di Storia, dell’Università.
Nata nel 1971, la rivista esce puntualmente senza conoscere iato alcuno da ben cinquantaquattro anni. Prodotto dell’ispirazione della compianta Marta Sordi (che l’ha diretta per due anni soltanto, fino al momento in cui si è trasferita all’Università Cattolica di Milano) e soprattutto del mio indimenticato maestro, Giancarlo Susini, il periodico ha conosciuto
per un troppo breve momento anche la direzione congiunta dello stesso Susini e di Gianfranco Tibiletti, scomparso ahimè quattro anni dopo soltanto, nel 1976. Da allora le redini del periodico sono state tenute a lungo con mano sicurissima dallo stesso Susini; che, dal 1991, ha voluto associarmi a lui in qualità di condirettore. Alla sua scomparsa, nell’ottobre dell’anno 2000, ne ho assunto la direzione, condivisa prima con la sola Gabriella Poma (che già tanto aveva contribuito alla gestione della Rivista…), poi, a partire dal 2020, anche con la prestigiosissima firma di Yann Le Bohec, professeur émérite dell’Université Paris IV-Sorbonne. Ora, venute a mancare negli ultimi anni sia l’amica Gabriella Poma, sia colei che, per dottrina e attenzione, è stata lungo alcuni decenni l’accorto, accurato, impeccabile supporto capace di verificare ogni volume ed assicurarne l’uscita, la professoressa Angela Donati, si è aperta un’età nuova, e speriamo ancor degna. Alla direzione è stato associato un giovane e validissimo docente di Storia greca, il prof. Giovanni Parmeggiani, già allievo del Dipartimento di Bologna; e come direttore responsabile la professoressa Beatrice Girotti. Alla curatela dei nuovi numeri provvede ormai la preziosa e caris-

sima collega Daniela Rigato, assistita da una équipe di volenterosi ed efficienti giovani, promessi io spero a preservare in seno all’Ateneo le tradizioni della Storia antica (Erica Filippini, Manuela Mongardi e Mattia Vitelli Casella).
Questa breve scheda non sarebbe, io credo, sufficiente a riportare i nomi di tutti gli insigni studiosi che l’onorano da decenni con i loro contributi: per ricordarne alcuni soltanto, con la speranza di non far torto a nessuno, J. Vogt e G.-C. Picard, I. Calabi Limentani e A. Garzetti, F. Hampl e F. Paschoud, J. Harmand e P. Pédèch, A. Roveri e A.E. Raubitschek, D. Asheri ed E. Gabba, A. Mócsy ed E. Badian, R. Laporte e K.-E. Petzold, J. Seibert e N. Alfieri, J. Sašel e F. Hinard, G.A. Mansuelli e S. Panciera, G. Walser e G. Alföldy, A. Mastino e T. Schmitt, C. Wolff e Y. Le Bohec, E. Dabrowa e G. Zecchini, J. Gomez Pallarès e A. Valvo, M. Mayer y Olivé e M.L. Uberti, M. Bollini e A. Marcone, A. Buonopane e D. Vera, G. Mennella e M. Pucci, J. Remesal Rodriguez e G.A. Cecconi, F. Rohr Vio ed E. Melchior Gil, T. Gnoli, U. Fantasia ed E. Cimarosti, nonché moltissimi altri. Non solo loro, tuttavia. Nel corso dei decenni la Rivista ha ospitato il ricordo di personalità scomparse (ad esempio Gianfranco Tibiletti) e sezioni dedicate a particolari ambiti di ricerca (tra l’altro gli studi annibalici e l’età dell’oro della storiografia greca) e ha costituito una preziosa palestra per alcuni allievi cresciuti nel nostro Dipartimento fino a divenire studiosi di vaglia (tra cui Riccardo Vattuone, Valerio Neri, Francesca Cenerini e Anna Lina Morelli; e i compianti Antonio Baldini e Federicomaria Muccioli); ma ha cercato di non negarsi mai ad ogni giovane ricercatore che meritasse di aver voce nel dibattito degli studi. In multos annos, «Rivista Storica dell’Antichità».
danIele cazzuffI
Direttore responsabile della Rivista Italiana di Geotecnica
Il mio primo contatto con la Casa editrice Pàtron risale all’anno accademico 1978-1979, quindi poco tempo dopo il cinquantesimo anniversario di fondazione. Io ero studente dell’ultimo anno di ingegneria civile al Politecnico di Milano. Il professore Gianfelice Gatti, titolare del corso, aveva adottato proprio il volume Tecnica delle fondazioni pubblicato da Pàtron nel 1977 e scritto dal professore Giuseppe Ricceri, ordinario di Geotecnica all’ Università degli Studi di Padova: neanche a farlo apposta, meno di due anni dopo mi sarei trovato personalmente di fronte il prof. Ricceri come responsabile del Master di Geotecnica della locale università patavina, cui sarei stato ammesso nell’anno accademico 1980-1981.
Gli inizi degli anni Ottanta erano ancora difficili per l’assetto organizzativo dell’università italiana: dopo la “bagarre” del 1968 e il periodo buio degli anni Settanta, non si era infatti proceduto all’introduzione dei dottorati di ricerca, a differenza della maggior parte degli altri stati europei, e questo fatto aveva sicuramente influenzato lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel panorama accademico italiano, prigioniero di un persistente “provincialismo intellettuale” e di una scarsa vocazione a un effettivo confronto e a una reale vocazione interdisciplinare.
Fortunatamente, in quegli stessi anni, eminenti professionisti italiani riscuotevano un grande successo internaziona-
le, anche nei settori dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni in generale: un nome per tutti è quello di Renzo Piano, avviato a divenire una vera “archistar” dopo la realizzazione del Centre Pompidou a Parigi.
Non a caso, proprio a metà degli anni Ottanta, su iniziativa di un “rampante” architetto milanese, Augusto Cagnardi, nacque il progetto di un Comitato Nazionale per le Scienze Ambientali e Territoriali, significativo tentativo di mettere a confronto diverse discipline per iniziare ad affrontare in maniera congiunta e coordinata le tematiche sempre più pressanti ed indifferibili relative alla protezione dell’ambiente e alla tutela del territorio: il caso della diossina all’ICMESA di Seveso aveva infatti lasciato pesanti conseguenze, sanitarie e legali, soprattutto nel densamente popolato hinterland milanese.
Ben 29 diverse associazioni nazionali erano state allora chiamate a far parte del Comitato Nazionale per le Scienze Ambientali e Territoriali: tra queste anche l’Associazione Geotecnica Italiana (AGI), di cui ero un giovane socio. Primo passo per mettersi attorno a un tavolo per discutere tematiche di comune interesse fu quello di creare una rivista: «Terra – Rivista di scienze ambientali e territoriali», assegnata proprio a Pàtron Editore e registrata al Tribunale di Bologna il 10 Febbraio 1987. Con mia grande sorpresa, gli allora presidente e segretario generale AGI, prof. Piero Colombo e ing. Sandro Martinetti, chiamarono il sottoscritto per rappresentare l’Associazione Geotecnica Italiana nel Comitato di Redazione della rivista.
Le riunioni del Comitato di Redazione della rivista «Terra» si svolgevano nell’abitazione dell’architetto Cagnardi, in pieno centro di Milano, e costituivano effettiva-
mente un’ottima occasione di proficuo confronto nell’ambito della preparazione dei numeri monografici della rivista stessa, confronto interdisciplinare accompagnato costantemente dall’arricchimento reciproco, anche in termini di relazioni umane sempre più profonde.
Fu così che agli inizi degli anni Novanta fui chiamato a coordinare il numero 11 della rivista «Terra», numero monografico dedicato in questo caso a Naturalizzazione dei fiumi: protezione e difesa dei corsi d’acqua, assieme ad un manipolo di altri esperti della materia nelle più disparate discipline. Fu così che allora entrai in diretto contatto con lo staff di Pàtron Editore, anche per risolvere al meglio gli aspetti logistici legati alla pubblicazione di una serie di figure, grafici e fotografie, indispensabile corollario dei nostri articoli. In quella occasione cominciai a frequentare con regolarità gli uffici di Quarto Inferiore della Casa editrice, nell’immediata periferia di Bologna, e a conoscere personalmente tutti i componenti dello staff operativo, a cominciare da Sandra Simoni.
Pochi anni dopo, è stata proprio lei a convincermi a preparare le carte indispensabili per essere ammesso come pubblicista all’Ordine Nazionale dei Giornalisti e diventare così il nuovo direttore responsabile della «Rivista Italiana di Geotecnica (RIG)», acquisita nel frattempo da Pàtron, carica che rivesto quindi ininterrottamente dal 1996! Sandra in effetti era a conoscenza che, nel mio (poco) tempo libero, a partire dal 1992 e sotto la direzione del mitico Indro Montanelli, collaboravo con «Il Giornale» come corrispondente sportivo da Ferrara, in particolare per seguire le partite di calcio della SPAL, la mia squadra del cuore, viste anche le mie origini ferraresi.

La direzione responsabile della Rivista Italiana di Geotecnica ha per me costituito sempre un prezioso legame di collaborazione con la Casa editrice Pàtron, anche grazie all’eccellente lavoro dei responsabili scientifici che si sono succeduti in questi decenni, vale a dire i professori Roberto Nova, Augusto Desideri e Renato Lancellotta, coadiuvati dall’instancabile e professionale operato della segretaria di redazione, la dottoressa Anna D’Elia.
Eletto membro del Consiglio di Presidenza di AGI nel 1999 e designato anche come Presidente del Comitato Organizzatore di EuroGeo 2 (Second European Conference on Geosynthetics) svoltasi a Bologna nel mese di Ottobre 2000, divenne così naturale la scelta di fare pubblicare i due volumi degli Atti della conferenza in inglese da Pàtron Editore: ricordo ancora le notti passate negli uffici di Pàtron a Quarto, assieme agli amici Andrea Cancelli e Claudio Soccodato, co-editors assieme a me, per riuscire a consegnare in tempo per la stampa tutti i testi delle keynote lectures e degli altri articoli, dopo il nostro attento lavoro di editing delle oltre mille pagine degli atti!
Sono passati quasi venticinque anni, ma erano veramente altri tempi per la pubblicazione degli atti di un congresso: adesso è tutto relativamente più facile, ma attualmente la maggior parte dei contributi restano virtuali e non so che impatto effettivo possano avere sull’intera comunità scientifica… Nel 2000 eravamo proprio in un anno di transizione, tanto che – per la prima volta in un convegno internazionale nell’ambito dell’ingegneria dei geosintetici – gli atti erano stati resi disponibili sia nei due volumi a stampa sia in due significativi CD: ai giorni nostri ormai solo in una chiavetta USB.
Il mio rapporto personale e professionale con Pàtron Editore è poi ovviamente continuato anche dopo questa esaltante avventura internazionale di Bologna, che aveva – tra l’altro – posto le basi per la mia elezione nel 2002 alla presidenza mondiale dell’International Geosynthetics Society (IGS) per un quadriennio molto costruttivo.
Rapporto consolidato con Pàtron, dicevo: a partire dal 2007 infatti gli atti del tradizionale Convegno Nazionale Geosintetici, sino al 2006 pubblicati a cura dell’Associazione Ingegneri e Architetti della

Provincia di Bologna grazie al carisma del Presidente Giovanni Tasselli, hanno iniziato ad essere editi da Pàtron Editore in copyright con l’Associazione Geotecnica Italiana.
I volumi degli Atti di questo convegno nazionale, giunto nel 2024 alla XXXIII edizione ancora con notevole successo, annoverano come editors – oltre al sottoscritto – gli amici di lunga data Nicola Moraci e Claudio Soccodato e sono resi possibili anche grazie alle inserzioni pubblicitarie delle società presenti nel settore dei geosintetici.
Questa ultima considerazione rappresenta in definitiva la “chiusura di un cerchio” di relazioni professionali e umane maturate in quasi cinquant’anni di mia personale conoscenza e collaborazione con la Casa Editrice Prof. Riccardo Pàtron & C. s.r.l., relazioni che hanno sicuramente contribuito alla mia crescita individuale e anche in definitiva della disciplina che rappresento: l’ingegneria geotecnica.
Gli auguri più sinceri allora per questo centenario da parte mia personale e dell’intera comunità geotecnica.
Ad maiora!
francesca cenerInI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
La prestigiosa collana “Studi di Storia” pubblicata da Pàtron Editore, è stata fondata nel 1982 dall’illustre storico Giancarlo Susini, nonché Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna dal 1970 al 1988.
Gli interessi epigrafici del Professore Susini e dei suoi Allievi, tra i quali un ruolo di primo piano è certamente rivestito dalla Professoressa Angela Donati, infaticabile curatrice di tutte le attività editoriali attribuibili alla storia antica bolognese del tempo, sono evidenti in quanto il primo volume della Collana pubblica gli Atti dell’importante Convegno internazionale di Epigrafia greca e latina, tenutosi a Bologna nel 1981. Tale Convegno aveva visto la partecipazione dei più importanti studiosi di epigrafia, provenienti anche da molti paesi stranieri, impegnati in un vero e proprio confronto interculturale dedicato alla memoria di un grande epigrafista degli inizi del 1800, Bartolomeo Borghesi, i cui interessi culturali erano parimenti aperti sul mondo esterno.
Molteplici sono i filoni di ricerca che hanno animato la redazione dei volumi della Collana: in primis cultuali, in quanto un altro illustre Maestro dell’Ateneo bolognese, il Professore Guido Achille Mansuelli, indaga sulla cosiddetta Ultima Etruria e si occupa nello specifico sugli
aspetti culturali e sacrali della romanizzazione del mondo etrusco. La Collana offre nel tempo ampio spazio a interessi storiografici, che spaziano dalla storiografia greca, ad esempio Timeo di Turomenio oppure Eforo di Cuma, alla storiografia pagana di età tardoantica, ad esempio Jordanes.
Anche in questo caso corre l’obbligo di citare uno Studioso prematuramente scomparso, il Professore Antonio Baldini, che si è occupato nello specifico della difficile ricostruzione della cosiddetta Storia imperiale di Enmann.
Altri temi di indagine presenti nella Collana sono di tipo geografico, ad esempio il viaggio di Pitea; ampio spazio hanno tematiche di carattere sociale, declinate anche sulla base delle più innovative istanze di ricerca, ad esempio il corpo e l’erotica, sia in ambito greco che romano. Anche il tema di indagine molto dibattuto, vale a dire quello della cosiddetta propaganda nel mondo antico, trova un puntuale riscontro nella Collana mediante l’analisi della cultura spartana, mentre il IV secolo d.C. è indagato nelle sue molteplici peculiarità sulla base degli storici, della storia e dei documenti.
Tra gli ultimi volumi si possono segnalare quelli editi da giovani e valenti ricercatori della sezione di Storia Antica del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna: Ariminum. Politica del Welfare, buona amministrazione e rapporti con la domus imperiale tra I e III sec. d.C., di Manuela Mongardi (2020), La Liburnia settentrionale nell’antichità: geografia, istituzioni e società, di Mattia Vitelli Casella (2021), I Collegia e le relazioni clientelari, di Simone Ciambelli (2022), Una società malata?, di Beatrice Girotti (2022).
Accanto alla più corposa Collana, per volontà di Gabriella Poma, che volle generosamente associarmi alla condirezione, è nata una Collana più agile, “Itinerari di Storia antica”, affettuosamente chiamata Collanina. L’intento era quello di interessare alle tematiche della storia antica un pubblico più ampio, ma allo stesso tempo attento e informato. A tale proposito le norme editoriali non prevedono l’uso di note corpose, ma solo semplici rimandi alla fonte storiografica o alla dottrina corrente; anche la bibliografia finale deve essere contenuta, pur presentando il più aggiornato inquadramento degli studi. Il primo volume è stato pubblicato nel 2010 e l’ultimo nel 2023. I temi sono diversi, ma tutti i volumi riflettono alcune delle più recenti tendenze della storiografia sul mondo antico: la vita alla corte imperiale romana, nonché il dissenso a questo potere che si connota sempre più autocraticamente, le reti di spionaggio, la salute, l’insicurezza legata alle sconfitte militari. Particolare attenzione è stata posta al tema del viaggio, anche quello dei mitici Argonauti, oppure ai contatti tra Roma e la Cina. Alcuni volumi, infine, possono essere considerati delle brevi biografie, come quelle su Romolo, Pompeo Magno e Agrippa Postumo.

Come si può intuire già da queste brevi parole di presentazione, queste Collane di Storia antica che Pàtron Editore continua a pubblicare con grande passione hanno il grande merito non soltanto di potere offrire una conoscenza più propriamente scientifica su temi specifici legati alla storia antica, ma anche di offrire a un pubblico più vasto una corretta conoscenza di argomenti particolari che, però, godono di attenzione e, nel caso del volume dedicato ai rapporti tra Roma e Cina, anche di grande successo editoriale. È quindi evidente che queste collane non possono che continuare a intercettare le domande che gli studiosi e il grande pubblico si pongono relativamente alla storia antica, anche in costante dialogo con le domande che ci pone un presente in continua e fluida evoluzione.
claudIo cobellI
(con un pensiero a Emanuele Biondi)
Università degli studi di Padova
Con Pàtron la Collana del Gruppo Nazionale di Bioingegneria ha una storia bella e coraggiosa che parte all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso.
Una collezione di Scuole, esattamente 42, una Collana didattica con pubblicati oltre una ventina di titoli, e, più recenti, gli Atti dei Congressi di Bioingegneria in Italia, raccolgono gli argomenti trattati nelle varie declinazioni.
Ideatori, promotori e sostenitori Emanuele Biondi, del Politecnico di Milano, e Claudio Cobelli, dell’Università di Padova, oltre all’appoggio dei docenti che hanno percorso questi oltre quarant’anni insieme alla Pàtron: la prima generazione di bioingegneri dedicata a ricerche e corsi.
La storia comune inizia a intrecciarsi con il varo degli innovativi corsi di ingegneria biomedica in Italia e della prima Scuola Annuale di Bressanone tenutasi nel 1982.
La Bioingegneria, oltre un decennio prima, muoveva i primi solidi passi, attraverso lo spirito lucido e determinato di alcuni pionieri, tra i quali Emanuele Biondi. Il dibattito all’interno della disciplina, che ancora non aveva linee comuni nazionali, era animato e vivace. Consolidare la ricerca, deciderne le direzioni e definire i punti essenziali, con volumi a cadenza annuale che ne attestassero la presenza stabile nel panorama scientifico nazionale, non
sempre favorevole, era l’obiettivo dei fondatori della serie del Gruppo Nazionale di Bioingegneria.
Nel 1981 ci furono di primi incontri: Aldo Lanza, allora direttore generale della Casa editrice, prese contatto con il giovane Claudio Cobelli a Padova. A fare da tramite fu il prof. Antonio Lepschy dello stesso Ateneo, autore per la Casa editrice, con Umberto Viaro, del fortunato Guida allo studio dei controlli automatici.
La pubblicazione delle Scuole iniziò, e si partì con singolarità. Il primo volume fu Il calcolatore nella pratica clinica di Carlo Berzuini, Scuola del 1983, quasi in contemporanea con il volume della prima Scuola, tenutasi nel 1982, Metodi di Analisi dei Sistemi Neurosensoriali di Roberto Schmid.
I primi volumi furono un vero rodaggio per tutti: tempi stretti, tanti autori (20/25) di diversa provenienza disciplinare per ogni volume: tale mole spesso rischiava di sfuggire di mano.

Ogni Scuola/volume aveva uno o più coordinatori scientifici: il tema della Scuola successiva, sempre innovativo e stimolante, veniva deciso dal Gruppo Nazionale di Bioingegneria nell’assemblea di chiusura della Scuola. Referente per la Pàtron, era il coordina-
tore scientifico a dettare tempi e consegne: tante avventure o, come si dice ora, eventi, perché ogni libro è stato evento e avventura. L’avventura consisteva nel non perdere la data di inizio della Scuola. Appuntamento imprescindibile: settembre di ogni anno. E l’evento era pubblicare, con l’ansia e il timore delle varie insidie dell’ultimo minuto.
Emanuele e Claudio, vigili, sorvegliavano tutti, intervenendo se necessario. E a Bressanone senza avere mai mancato ad un appuntamento si pensava al futuro.
Nel 1996 ci fu il varo della Collana didattica “Collana di ingegneria biomedica”: responsabili scientifici Biondi e Cobelli.
Il primo volume fu Biomateriali per protesi e organi artificiali di Riccardo Pietrabissa: tutto da inventare per la Casa editrice, e ad oggi ancora in vendita con pochi cedimenti.
A seguire progetti e ricollocazioni: nel 1975 Pàtron pubblicò le allora dispense di Strumentazione biomedica di Guido Avanzolini, Università di Bologna. Il volume in seconda edizione passò in Collana: ora è in catalogo la terza edizione (2015) (G. Avanzolini, E. Magosso, Strumentazione Biomedica).
Nel 2001 venne pubblicato il volume Storia della Bioingegneria curato da Biondi e Cobelli, numero 6, della Collana: 450 pagine dedicate alla fondazione ed evoluzione della disciplina, attraverso la riflessione scientifica e il ricordo di oltre quaranta docenti di vari atenei italiani, protagonisti negli ultimi sessant’anni del consolidamento della oramai indispensabile posizione nazionale e internazionale della materia.
I volumi didattici pubblicati in Collana prendevano corpo dai corsi varati. Seguendone caratteristiche e conseguente trattazione, con la supervisione scientifica dei di-
rettori, si giungeva a un volume strutturato destinato agli studenti.
Emanuele Biondi è scomparso qualche anno fa a oltre novant’anni: progettuale e futuristico fino all’ultimo, sempre stimolante e innovativo.
Attualmente con Claudio Cobelli, Beppe Baselli, del Politecnico di Milano, e Arianna Menciassi, della Scuola Superiore di Pisa, condividono la responsabilità scientifica della Collana.
Per Pàtron Sandra Simoni ha seguito collane e serie, di concerto con le figure professionali alternatesi negli anni all’interno della Casa editrice.
Ora Erika Mucignat sta proseguendo il lavoro editoriale sulle linee tracciate, coniugando le attuali esigenze di innovazione informatica con le reali necessità commerciali della Casa editrice.
Ivano dIonIGI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
francesco cIttI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna «Da mezzo secolo ho continui e cordiali rapporti con la Casa Editrice Pàtron»
Riflettere sul connubio tra l’Editore Pàtron e il latino significa in primo luogo riflettere sul lungo e felice sodalizio instaurato con l’editore da Alfonso Traina, che nel gennaio del 2002, nella Prefazione a La lyra e la libra (Tra poeti e filologi), poteva scrivere con schietta soddisfazione: «Da mezzo secolo ho continui e cordiali rapporti con la Casa Editrice Pàtron». Del 1967 è infatti la creazione della Collana “Testi e Manuali per l’insegnamento universitario del latino”, la cosiddetta Collana Bianca, inaugurata con L’alfabeto e la pronunzia del latino (la prima edizione fuori collana risaliva al 1957), che conta a tutt’oggi ben 157 volumi.
Prima degli anni Sessanta il rapporto tra Pàtron e il latino era piuttosto sporadico e limitato per lo più ad edizioncine fuori collana e a dispense per i corsi universitari, con volumi talora esili, costituiti da brevi raccolte di testi (come i Fragmenta Lyricorum Romanorum, o la Ioannis Pascoli Lyrica di Gian Battista Pighi; l’Invectiva in M. Tullium Cicerone e Properzio. Il libro quarto delle elegie di Elio Pasoli) o da veri e propri saggi (come Le epistole letterarie di Orazio e Le Historiae e le opere minori di Sallustio, di Pasoli o ancora le Teorie artistiche e letterarie di L. Anneo Seneca di Aldo
Setaioli): non mancavano manuali, come la Fonetica e morfologia storica del latino di Carlo Tagliavini.
È da questa esperienza embrionale che nasce nel 1966 la “Collana Edizioni e saggi universitari di Filologia Classica”, la cosiddetta Collana Verde (dal colore delle sue copertine), giunta ora al n. 74, e diretta inizialmente dal latinista Virgilio Paladini, cui si sono affiancati in seguito Gualtiero Calboli, Alfredo Ghiselli, Italo Mariotti, Alfonso Traina e Lucia Pasetti, e grecisti come Enzo Degani e Renzo Tosi.
Nella Collana Verde, per quanto riguarda il latino, prevale decisamente la pubblicazione di testi critici, accompagnati da traduzione e commento, con una notevole apertura a testi extracanonici: accanto a Lucrezio (per cui va menzionato un classico: Religio, natura, voluptas di Francesco Giancotti), Cicerone e Sallustio (con volumi di Paladini, Pasoli, Ghiselli), Orazio, Properzio e Seneca (cui è dedicato un classico degli studi sul teatro, Il Nefas argonautico. Mythos e logos nella Medea di Seneca di Gilberto Biondi), compaiono infatti tra gli altri Catone e Varrone, alcuni trattati di retorica (con i commenti alla Rhetorica ad Herennium di Gualtiero Calboli, all’Ars Rhetorica di Consulto Fortunaziano di Lucia Calboli Montefusco), l’Ilias Latina di Bebio Italico, l’Historia Augusta (uno dei campi di indagine preferita di Elio Pasoli), e ancora la poesia tarda (da Claudiano al Versus de Sodoma, all’Alcesti di Barcellona) e neolatina, con ampio spazio dedicato ai Carmina di Giovanni Pascoli.
Non mancano – soprattutto nel formato maggiore – volumi che si sono imposti come un riferimento nel dibattito critico: è il caso dei saggi di taglio tematico dedicati alla
vecchiaia (Senectus, I. Grecia; II. Roma; III. Ebraismo e Cristianesimo, a cura di Umberto Mattioli), alle lingue tecniche (del greco e del latino), ai testi medici latini. E vi trovano inoltre spazio anche Festschriften dedicate a importanti latinisti (Alfredo Ghiselli, Giuseppe Morelli, Ivano Dionigi) e raccolte di Kleine Schriften di studiosi che hanno operato in particolare tra Bologna e Padova (da Giorgio Bernardi Perini, Italo Mariotti ad Alfonso Traina).
Se si parla di latino, tuttavia, il pensiero va in primis alla Collana Bianca (“Testi e manuali per l’insegnamento universitario del latino”): con angolazioni diverse, ma anche spesso complementari rispetto alla Collana Verde, la Collana Bianca offre ormai un riferimento consolidato per la latinistica, e potrebbe fornire il punto di partenza per una riflessione sull’evoluzione degli strumenti, dei metodi e degli obiettivi della ricerca e della didattica nel campo negli ultimi sessanta anni. Ma non è questo il luogo per esplorare il tema, né sarebbe possibile in poche pagine. Ci limitiamo quindi a osservare le caratteristiche di maggiore spicco della Collana.
Variegata la tipologia, dalla manualistica alla saggistica, alle edizioni tradotte e commentate; ampia la gamma cronologica degli autori, dagli arcaici ai cristiani ai moderni (Tommaseo e Pascoli); molteplici gli ambiti, dalla poesia alla prosa, dalla lingua letteraria ai testi epigrafici, dalla grammatica ai linguaggi tecnici.
Per quanto riguarda i manuali, il primato va senza alcun dubbio alla Propedeutica al latino universitario, un testo che, giunto alla sesta edizione (la prima è del 1971), ha formato numerose generazioni di insegnanti, molti dei
quali amano confessare con orgoglio: «Anche noi abbiamo studiato sulla Propedeutica».
Tanto lungimiranti quanto utili alcune traduzioni e curatele di trattati. Su tutte, la Storia della lingua latina di Friedrich Stolz – Albert Debrunner – Wolfgang Schmid, giunta alla quarta edizione, con in Appendice La formazione della lingua letteraria latina di Iosif Moiseevič Tronskij, riveduta e aggiornata da Edoardo Vineis, e soprattutto con Introduzione e note di Traina, dal titolo Riflessioni sulla storia della lingua latina (tradotto in inglese nel 2012 in The Oxford Handbook of Roman Studies): un saggio sull’identità della lingua latina nota a generazioni di studenti di lettere e che ancora oggi conserva tutta la sua attualità.
Non meno meritorie – anche per il respiro internazionale – l’Introduzione al latino volgare di Veikko Väänänen; I caratteri del latino cristiano antico di Joseph Schrijnen; La lingua d’uso latina di Johann Baptist Hofmann; la Stilistica latina di Johann Baptist Hofmann – Anton Szantyr; La lingua poetica a cura di Aldo Lunelli, con saggi di Wilhelm Kroll, Heindrikus H. Janssen e Manu Leumann: la priorità degli interessi linguistici e stilistici di Traina è evidente nelle scelte editoriali. Ma non manca un’apertura anche alle
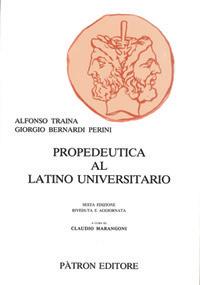
metodologie emergenti in campo linguistico (come mostrano La linguistica moderna e il latino. I casi, di Gualtiero Calboli o I composti nominali latini. Una morfologia generativa di Renato Oniga) e letterario, ad esempio con gli studi sulla pragmatica della comunicazione (legati in particolare a Licinia Ricottilli, autrice di Gesto e parola nell’Eneide e curatrice di Modalità della comunicazione in Roma Antica).

I volumi, prima di superare l’esame delle Commissioni nazionali di concorso, avevano già superato il giudizio ben più probante e selettivo del fondatore della Collana. Tra questi alcuni risaltano in modo particolare: per l’autorità degli studiosi (Introduzione alla metrica di Plauto di Cesare Questa; Nuovi contributi di filologia e storia della lingua latina di Sebastiano Timpanaro; Il Bellum Poenicum e l’arte di Nevio di Scevola Mariotti; Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa di Emilio Pianezzola; la Coniuratio Catilinae a cura di Italo Mariotti; l’Ortensio di Cicerone a cura di Alberto Grilli), per l’impatto sugli studi (Seneca e i Greci di Aldo Setaioli; Tra filosofia e poesia. Studi su Seneca e dintorni di Rita Degl’Innocenti Pierini; Studi oraziani. Tematica e intertestualità di Francesco Citti; Quando le muse parlavano latino. Studi su Plauto di Gianna Petrone), per la fortuna
editoriale (Lucrezio. Le parole le cose di Ivano Dionigi, giunto alla terza edizione), per il carattere innovativo e originale, e l’attenzione a testi meno frequentati (Fer propius tua lumina. Giochi intertestuali nella poesia di Calpurnio Siculo a cura di Luciano Landolfi; Narrare memoriter temporaliter dicere. Racconto e metanarrazione nelle Confessioni di Agostino di Bruna Pieri; Declamazioni minori attribuite a Quintiliano I [244 – 292] a cura di Lucia Pasetti).
Ricorrenti gli studi su Plauto, Virgilio, Catullo, Seneca (per cui non si può non ricordare la ristampa del L. Anneo Seneca di Italo Lana), Ovidio, Orazio, Lucano, Petronio, Floro, Apuleio, sulla filologia in frammenti (con gli importanti saggi di Lorenzo Nosarti, Alessandro Perutelli, e soprattutto con l’Index Morelianus e il Supplementum Morelianum, a cura di Alfonso Traina e Monica Bini).
Ma le vere perle della Collana sono le opere di Traina stesso. Tre su tutte, che hanno aperto prospettive inedite e guadagnato punti d’approdo inarrivabili: Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, giunto alla quarta edizione (rielaborazione della prolusione universitaria del 1964); Forma e suono. Da Plauto a Pascoli (che gli iscritti al Corso di Perfezionamento in Filologia Classica della fine degli Anni Settanta ebbero il privilegio di conoscere nella fase di gestazione); Il latino del Pascoli. Saggio sul bilinguismo poetico: un testo che ci rende consapevoli di «quanto il latino sia ricco del suo futuro, l’italiano del suo passato». Scorrendo i titoli della vecchia e della nuova serie della Collana, ci si accorge quanto magistero di Traina sia stato trasmesso: quello del professore che parlava dal pulpito della cattedra, dopo aver preparato e perfezionato con scrupolo le sue lezioni fino all’ultimo minuto dell’ultimo
giorno; quello dello studioso che si esprimeva nel ritiro della sua cella, il dicti studiosus, appassionato della parola e del suo ‘etimo spirituale’; quello del colloquium con i grandi autori latini, sui quali Traina ha confessato: «Non mi hanno dato solo un’emozione estetica, ma mi hanno aiutato a capirmi e quindi, negli angusti limiti in cui la mia problematica coincideva con la loro, a capirli: è la conflittualità catulliana fra sesso e amore, l’accettazione virgiliana di un destino che si può non amare, l’ansia oraziana del tempo, l’ideale senecano di una saggezza che conti solo sulle sue forze interiori, il nichilismo pascoliano appena temperato dall’appello alla solidarietà nel dolore».
Inoltre i volumi della Collana Bianca non ci restituiscono solo una sintesi degli interessi di ricerca e di didattica che Traina ha coltivato per una vita: sono il frutto della passione per il libro, anche come oggetto materiale (era il direttore stesso, appassionato anche d’arte, che sceglieva le immagini per le copertine, spesso prima ancora che il libro fosse ultimato), e soprattutto di un lavoro attento e caparbio che non solo selezionava le proposte, ma sollecitava gli autori a intraprendere nuovi percorsi di ricerca con stimolo premuroso, accompagnato da «una pazienza dapprima impaziente, poi spazientita, infine rassegnata, ma mai del tutto spenta» (come ha scritto in maniera efficacissima Roberta Strati, nella Premessa alle Ricerche sugli avverbi latini in -tus). Significativo in questo senso lo scambio epistolare con Sebastiano Timpanaro. Già nel giugno del 1973, per la pubblicazione dei Contributi di filologia e di storia della lingua latina – voluta fortemente da Traina per una sua Collana delle Edizioni dell’Ateneo, e giunta a pubblicazione nel 1978, dopo
un quinquennio di tribolazione – Timpanaro confida a Traina le incertezze sui lavori da accogliere nel volume, e dopo un apprezzamento per alcuni articoli dell’amico, soggiunge ironicamente (ma non troppo) «Mi sembra di sentirti rispondere: “Grazie tante, ma dimmi piuttosto se stai lavorando al volume per le edizioni dell’Ateneo o se invece stai battendo la fiacca!”».
La stessa dialettica si instaura per il volume pubblicato nella Collana Bianca, i Nuovi contributi di filologia e storia della lingua latina, usciti a stampa nel 1994, dopo una lunga gestazione: un «progetto provvisorio» è esposto in una lettera del maggio 1989, ma emblematica è la missiva inviata da Firenze nel febbraio del 1994, che combina, assieme ai ringraziamenti per la riuscita del volume, grazie alle «preziose osservazioni» e alla scelta della «copertina, che più bella non poteva essere», il diniego, di fronte alla richiesta di un nuovo volume: «Quanto agli auguri per i Terzi Contributi, li accetto come espressione di amicizia, come quando, ad uno che compie gli anni, si dice: “Cento di questi giorni!”. Ma i Terzi contributi non potranno esserci. […] quanto a nevrosi e a capacità di lavorare e a voglia di vivere, non c’è nemmeno da pensarci».
Uno scavo più ampio nell’epistolario rivelerebbe senz’altro molto altro: ma forse bastano questi pochi tratti per comprendere quanto passione di ricerca, interessi professionali e generosità nelle relazioni personali abbiano contribuito a fare della Collana Bianca un punto di riferimento per la latinistica in Italia.
rolando dondarInI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Per me il marchio Pàtron ha rappresentato fin dai miei primi esami universitari di cinquantacinque anni fa la soglia d’ingresso ad un ambito di studi superiore: quello che fino a pochi anni prima mi sembrava irraggiungibile. Frequentavo Magistero quando a far parte del suo corpo docente c’erano tra le firme più illustri del mondo accademico. Quasi tutti quei personaggi così stimati e a volte temuti pubblicavano manuali e dispense con Pàtron attestando una reciproca stima. Dopo pochi mesi, il marchio della Casa editrice mi era divenuto consueto e familiare quasi fosse garante del contenuto. Ma il passo più importante e significativo lo feci quando qualche anno dopo inopinatamente io stesso entrai nel novero degli autori. Ebbi così modo di conoscere personalmente le anime ispiratrici del lavoro editoriale che non si limitavano a svolgere diligentemente il delicato lavoro di pubblicazione ma che prospettavano, proponevano e programmavamo. Gli incontri con Sandra Simoni duravano spesso più di un’ora e si trasformavano sempre in una fucina di idee. Mi rimane il rammarico di non aver realizzato che una minima parte di quei progetti; ma sono certo che nei prossimi decenni si troverà modo di concretizzarli.
lucIano forMIsano
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
La testimonianza, per sua natura sempre personale, rende difficile qualsiasi tentativo di storicizzazione, e tuttavia, per il tema che qui ci occupa, la storicizzazione non solo è possibile, ma contribuisce all’oggettività del testimone. Volendo, dunque, storicizzare, la collaborazione tra l’editore Pàtron e la Filologia romanza si può dividere in due periodi il cui discrimine è collocabile intorno al 1978. Il primo periodo è quello delle origini, nel caso specifico delle Origini delle lingue neolatine di Carlo Tagliavini, pubblicato nel 1949, ma poi riedito e aggiornato più volte fino alla sesta edizione uscita nel 1972 e tuttora ristampata: introduzione alla Filologia romanza, come recita il sottotitolo, e come tale presente per decenni in quella parte del programma d’esame che solitamente viene dedicata alle “istituzioni”; cionondimeno un manuale di linguistica, se non di filologia in senso stretto, su cui a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso si sono formate almeno tre generazioni di docenti della disciplina e al quale i dottorandi e i giovani ricercatori faranno bene a tornare ogniqualvolta sentiranno la necessità di acquisire delle basi solide e sicure. Se “il Tagliavini” è un “acquisto perenne”, diciamo pure un fiore per l’occhiello di Pàtron, l’Introduzione al latino volgare di Veikko Väänänen offre più di un motivo di soddisfazione: pubblicata per la prima volta
nel 1971, giunta nel 1982 alla sua terza edizione (seconda ediz., 1974), questa Introduzione, curata da Alberto Limentani, dunque da un romanista, ma pubblicata all’interno della Collana di “Testi e manuali per l’insegnamento universitario del latino”, diretta da Alfonso Traina, non solo offre in traduzione italiana un’opera fondamentale della linguistica latina e romanza, ma è anche la versione alloglotta scelta dallo studioso finlandese per le revisioni e gli aggiornamenti di volta in volta apportati alla redazione originale in francese1 .
Si colloca in questo primo periodo una serie di pubblicazioni a scopo principalmente didattico, non a caso quasi tutte firmate dall’allora titolare della cattedra bolognese di Filologia romanza, Marco Boni: antologie di liriche trobadoriche e antico-francesi, non senza una particolare attenzione ai testi gallo-romanzi citati del De vulgari eloquentia, ma anche una selezione di poesie dell’amato Sordello, già oggetto dell’imponente edizione critica del 1954, e una scelta di passi della Chanson d’Aspremont2 . Degna di segnalazione è anche l’informata ed elegante antologia della
1 Introduction au latin vulgaire, Paris, Klincksieck, 19631.
2 Antologia trobadorica, con traduzioni e note a cura di M. Boni, Bologna, vol. I3, 1968, vol. II2, 1966; Liriche francesi dei secoli XII-XIII, traduzioni, con un’appendice contenenti i testi delle canzoni francesi citate da Dante nel «De vulgari eloquentia», a cura di M. Boni, Bologna 1967; Sordello, con una scelta di liriche tradotte e commentate, a cura di M. Boni, Bologna 1970; La «Chanson d’Aspremont». Episodi scelti, con traduzione e note, a cura di M. Boni, Bologna 1977.
lirica d’oīl allestita da Gianluigi Toja nel 1966, quando in Italia la poesia dei trovieri non aveva ancora conosciuto le quotazioni al rialzo registrate a partire dalla fine degli anni Settanta del Novecento, senza dubbio il florilegio più completo dedicato al settore dopo quello di Carla Cremonesi3. Un caso a sé è l’edizione critica di Rambertino Buvalelli uscita nel 19784, ormai a ridosso della data che ho assunto come spartiacque dei nostri due periodi.
Nel secondo periodo, la collaborazione con la Casa editrice diviene parte integrante di un ampio progetto di studi e ricerche. Nel 1979 escono i Quaderni di Filologia Romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, più noti con l’acronimo QFR. Affidata alle cure della Pàtron, che ne pubblica i primi ventisette numeri (ma il terzo5 non è mai uscito), dalla fondazione, credo avvenuta nel 1978 per iniziativa di Ruggero Campagnoli, all’annata 2018-2019, la rivista, che si propone una cadenza annuale6, nasce senza «programmi ambiziosi» quale espressione dell’«attività scientifica e culturale di un Isti-
3 Cfr. G. Toja, Lirica cortese d’oīl. Sec. XII-XIII, Bologna, Pàtron, 1966, senza traduzione dei testi ma accompagnata da un ampio glossario; C. Cremonesi, Lirica francese del Medio Evo, Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1955.
4 Rambertino Buvalelli, Le Poesie, edizione critica, a cura di E. Melli, Bologna, Pàtron, 1978.
5 L. Petroni – R. Trovato, Studi sulla commedia letteraria del Rinascimento in Italia e in Francia (con una commedia inedita).
6 Proposito che non sempre viene realizzato, da cui anche i casi di mancata corrispondenza tra il numero e l’annata, con doppia numerazione di recupero o della seconda o di entrambi.
tuto», appunto quello di Filologia romanza7, anche se poi finirà con l’acquisire una dimensione che sarebbe riduttivo definire “nazionale”, sia pure senza tradire il programma iniziale, quello di offrire una palestra per i giovani studiosi e una testimonianza delle ricerche e degli interessi di studio della filologia romanza bolognese, o almeno di una sua parte. I primi cinque quaderni (1979-1985) sono diretti Marco Boni, i successivi da Elio Melli (nn. 6-11, 1987-1994), da chi scrive i nn. 12-21 (1995-2009); col n. 22/2014 la direzione viene “pubblicamente” assunta da Andrea Fassò8 (dal fascicolo successivo condirettore con Francesco Benozzo); con questo numero ha inizio anche la “nuova serie” intitolata «Rivista di linguistica, letteratura, critica testuale», salvo il mantenimento dell’acronimo storico QFR. Avendo già parlato della rivista in altra sede9, basti qui richiamarne i tratti salienti.
Anzitutto, l’intento monografico, particolarmente evidente nel fascicolo 1/1979, dove, sotto il titolo Forme, maniere, manierismi. Scritti sul Cinquecento francese (con un’appendice quattrocentesca), si raccolgono saggi editi e inediti
7 Così nella seconda di copertina, dove a partire dal n. 6/1987, ormai soppressi gli istituti, non si manca di ricordare il patrocinio (successivamente anche il contributo) del Dipartimento di Lingue e letterature straniere moderne.
8 Di fatto, la nuova direzione è stata nominata nel 2012 dopo un silenzio triennale della rivista.
9 Cfr. La filologia romanza formato quaderno, in Fra Autore e Lettore. La filologia romanza nel XXI secolo fra l’Europa e il mondo, a cura di R. Antonelli, P. Canettieri, A. Punzi, Roma, Viella, 2012 (= «Critica del Testo», XV/3), pp. 189-200.
di Ruggero Campagnoli, fermo restando che nei numeri miscellanei l’intervento di più autori non ha impedito che i loro contributi venissero raggruppati per aree tematiche; limitandomi, per le ragioni che dirò, ai primi 11 numeri:
2/1981. Linguistica e letteratura. Problemi e Studi.
4/1984. Teatro romantico spagnolo. Autori personaggi nuove analisi
5/1985. Avvenimenti e discorsi
6/1987. Lingua, poesia, racconto
7/1990. Trovatori Canzoni di gesta Storia delle idee ed altro
8/1991. Lingua, immagini e storia
9/1992. Ecdotica ed esegesi
10/1993. Epica Romanzo Altra letteratura Storia della civiltà
11/1994. Lirica Drammatica Narrativa
Come appare già evidente dal titolo del quarto fascicolo, la “filologia romanza” dei «Quaderni» va intesa in senso ampio, senza limitazioni cronologiche e tematiche; semmai, come indicazione della preferenza accordata allo studio della testualità in tutti i suoi aspetti, anche ecdotico, quest’ultimo di fatto prevalente nei contributi degli allievi del «Dottorato in Filologia romanza e cultura medievale» fondato da Melli nel 1988.
Dal n. 12-13 (1995-1998) si assiste a un profondo ripensamento della linea editoriale: i «Quaderni» cessano di essere un collettore più o meno organico di contributi indipendenti tra loro per trasformarsi in uno strumento di discussione su alcuni temi centrali della filologia romanza in quanto disciplina essenzialmente medievistica ma che nel Medioevo trova un momento fondativo del-
la modernità. Accade così che QFR si faccia promotore di convegni, giornate di studio e seminari (questi ultimi anche in forma di discussione di libri) i cui atti si incarica di ospitare per sottoporli al giudizio della comunità scientifica. Nascono così i numeri intitolati La rima trivocalica. La rima nell’antica poesia italiana e la lingua della Scuola poetica siciliana (nn. 12-13, 1995-1998), Interpretazioni dei trovatori (n. 14, 1999-2000), Il racconto nel Medioevo romanzo (n. 15, 2001), Il romanzo nel Medioevo (n. 18, 2004-2005), ma anche Medioevo romanzo e medioevo germanico a confronto (n. 16, 2002), Bologna nel Medioevo (n. 17, 2003), «La traduzione è una forma». Trasmissione e sopravvivenza dei testi romanzi medievali (n. 19, 2006), Trattati d’amore cristiani del XII secolo (n. 21, 2009). Dunque, non solo tematiche particolarmente importanti per la formazione dei giovani romanisti, ma anche aperture a un settore disciplinare “affine” quale la filologia germanica, e pertanto anche un modo per ripensare àmbiti e metodi di ricerca; ciò che spiega la deroga alla linea editoriale del fascicolo 20 (2007), interamente dedicato a una silloge di saggi che l’autrice, GianGabriella Buti, ha significativamente raccolto sotto il titolo Studi interdisciplinari di Filologia germanica. Va da sé che la nuova programmazione non ha impedito che si continuassero a pubblicare contributi autonomi, che vengono radunati in un’apposita sezione. Tra questi non mancano gli articoli di carattere ecdotico (edizioni di testi brevi o studi per una nuova edizione di testi d’oc e d’oīl non solo lirici o didattici, ma anche odeporici), cui si aggiungono contributi più eccentrici: dalla poesia romena a tema balcanico di Ion Barbu agli italianismi e americanismi nello spagnolo e nella toponomastica del Cile.
Ricordo, infine, che, come altre riviste di filologia romanza, anche i «Quaderni» hanno potuto contare su una loro “biblioteca”, una Collana di testi e saggi a cui demandare contributi di ampio respiro ed edizioni. Nel caso specifico, la «Biblioteca di Filologia Romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna» («BFR»), fondata nel 1980, viene ufficialmente inaugurata nel 1984 con una Festschrift, che, dedicata al primo direttore dei «Quaderni», Marco Boni, ha il titolo significativo di Critica testuale ed esegesi del testo, etichetta romanistica quant’altre mai, anche se per l’occasione vengono chiamati a raccolta non solo filologi romanzi in senso stretto, ma francesisti e francofonisti, ispanisti, studiosi di teatro. Non a caso, per i suoi primi dieci numeri la Collana è condiretta da un romanista e da un francesista: lo stesso Boni e Liano Petroni fino al n. 3, Elio Melli e ancora Petroni fino al n. 10. Non solo: se autore del secondo volume, mai uscito, avrebbe dovuto essere un francesista10, autore del terzo (un’edizione critica), pubblicato, si noti, nello stesso anno del volume inaugurale, è il romanista che subentrerà a Boni nella condirezione. Resta il fatto che, astraendo dalla Festschrift di apertura, dei restanti dodici volumi (ma di fatto undici) nove sono firmati da filologi romanzi, sette dei quali sono edizioni di testi.
La «Biblioteca» è cessata nel 2009. Come suo ultimo direttore11, credo di poter dire che l’evento non era affatto
10 Autore e titolo sono registrati nella terza di copertina fino al n. 13 e ultimo: R. Campagnoli, Discorsi e finzioni. Scritti di letteraturologia in campo francese.
11 Nel 1996 sono subentrato come direttore unico al tandem
prevedibile e che a causarlo non è certo stato un deficit improvviso di materiali: ne fanno fede i due volumi usciti nello stesso 2009, con i quali «BFR» aveva ripreso a spaziare tra letteratura d’oīl e antica letteratura spagnola. Forse è semplicemente venuta meno, per motivi di cui non mette conto parlare, la “bella stagione” che è stata alla base di tante iniziative corali di cui i «Quaderni» e la stessa «Biblioteca» sono stati protagonisti; forse è venuto a mancare anche il «presupuesto», come direbbero gli spagnoli, per continuare con una cadenza ragionevole.
Diverso è stato, invece, il destino della Collana «Storia e Testi. Dal Medioevo all’Europa Moderna», fondata e diretta dallo scrivente e di fatto priva di legami particolari con questo o quel Dipartimento dell’Alma Mater, il cui primo volume è uscito nel 2011, il quarto nel 2023. Quattro numeri in tredici anni potrebbero sembrare davvero pochi se non si trattasse di volumi con cui vengono colmate delle gravi lacune. Penso, in particolare, all’Antologia delle letterature romanze del Medioevo di Paolo Gresti12, una crestomazia di taglio comparatistico di cui non trovo altri precedenti che le fotocopie di nudi testi romanzi con cui i docenti sono soliti rimediare al monolinguismo dei nostri florilegi; penso soprattutto all’Antologia del francese d’Italia.
Melli-Petroni, anche se il nome dei due condirettori sarà ancora registrato nella seconda di copertina del n. 12, uscito, come il successivo e ultimo, nel 2009, sei anni dopo la scomparsa di Melli, tre dopo quella di Petroni.
12 Primo numero della Collana, sia pure in quanto seconda edizione aggiornata del volume omonimo dello stesso Autore pubblicato, sempre da Pàtron, ma fuori collana, nel 2006.

XIII-XIV secolo (n. 4), con cui i co-curatori Francesca Gambino e Andrea Beretta riprendono ab imis fundamentis la questione del cosiddetto franco-italiano, affidandone l’illustrazione a un’antologia di testi significativi dal punto di vista non solo linguistico, ma storico-culturale. Insieme all’Introduzione alla linguistica romanza, sempre di Gresti (n. 2, 2016), si tratta di opere originali in cui intento didattico e ricerca scientifica si completano vicendevolmente, sia pure nella misura variabile imposta dalla natura dell’oggetto. Non parlo, per ovvie ragioni, del terzo numero (2021), perché mi appartiene in proprio e interessa solo marginalmente i cultori della romanza, se non per sottolineare l’intento metodologico sotteso dal titolo13. Naturalmente, non pretendo che la Collana offra una formula vincente, anche se il titolo «Storia e testi» dirà pur qualcosa ai frequentatori della Letteratura italiana di Ricciardi; credo però fermamente che una didassi alta che ponga il testo al centro della storia, rivolgendosi del pari a studenti e insegnanti, sia quanto ci si debba legittimamente aspettare dai cultori di filologia romanza, disciplina tanto irrinunciabilmente specialistica quanto caparbiamente “dialogica”.
13 Letteratura dei viaggi e delle scoperte.
paola foschI
Socio Emerito della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna
La Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna è un istituto dello Stato che ha come peculiare missione la promozione degli studi storici nel territorio dell’antica Legazione di Bologna dello Stato Pontificio. Scrive Paola Infantino nella sua relazione introduttiva al riordinamento dell’archivio della Deputazione di Storia Patria: «Nel febbraio del 1860, quando mancava appena un mese al plebiscito che avrebbe sancito l’annessione del territorio emiliano al Regno di Sardegna, Luigi Carlo Farini, governatore delle province dell’Emilia, su sollecitazione del ministro dell’istruzione Montanari…, decretava l’istituzione di tre Deputazioni di storia patria, a Bologna, Parma e Modena… Il provvedimento di Farini precedeva di pochi giorni – e di fatto ne vanificava gli effetti futuri – il decreto del 21 febbraio 1860 di re Carlo Alberto, il quale, dopo aver fondato nel 1833 la prima Regia Deputazione per lo Stato sabaudo…, ne estendeva ora la sfera d’azione alle province lombarde già annesse al Regno di Sardegna, con l’esplicito intento di farne una istituzione a carattere nazionale via via che altri territori si fossero aggregati. La decisione di Farini e di Montanari intendeva sicuramente valorizzare al meglio l’ampio patrimonio storico-artistico delle ‘Regie Provincie’…, ma rispondeva in particolare all’esigenza di dar conto delle profonde diversità culturali
che caratterizzavano la regione, riflettendo la disomogeneità storica, politica e istituzionale del territorio emiliano, per secoli suddiviso in tre diversi stati: le Legazioni pontificie, il Ducato di Modena e il ducato di Parma e Piacenza… I nuovi sodalizi ebbero quindi lo scopo principale di promuovere le ricerche di storia patria nei territori emiliani e romagnoli, attraverso il recupero e lo studio delle fonti documentarie, materiali e di tradizione orale».
La Deputazione romagnola ha sempre curato lo sviluppo degli studi storici e letterari nel territorio di propria competenza – Bologna e la Romagna – mai trascurando, d’altro canto, collaborazioni con società storiche delle regioni vicine, per conoscere esperienze parallele o divergenti. Questa attività, di studio e ricerca, si articola nelle diverse discipline storiche, dalla storia dell’arte a quella dell’architettura, dall’archeologia alla storia antica, dalla letteratura alla storia religiosa, sociale ed economica.
Tutte le proposte scientifiche degne di studio e di approfondimento, presentate da studiosi sia accademici sia giovani e promettenti, ma anche da ricercatori liberi, non inquadrati in istituti ufficiali di ricerca, vengono accolte nelle sedute e negli Atti relativi: finalità del-
la Deputazione è, infatti, il confronto fra le diverse esperienze e la possibilità

di offrire spazio a chi svolge i suoi studi anche come attività collaterale alla professione, purché condotti con serietà e competenza.
Allora si comprende come l’incontro con un Editore sensibile alle esigenze culturali, un Editore sperimentato nelle pubblicazioni di ricerca e di studio sia indispensabile per rispondere appieno alle esigenze di serietà e scientificità delle pubblicazioni curate dalla Deputazione.
Molti dei soci della Deputazione hanno avuto occasione, nella loro carriera, di avere rapporti con la Casa editrice Pàtron, da anni impegnata nella pubblicazione di riviste e volumi miscellanei di alto livello scientifico. È stato per questo, per avere sperimentato la competenza e serietà della Casa editrice, che il consiglio direttivo della Deputazione si è risolto, una volta terminata la collaborazione con la Casa editrice Forni per la sua cessazione, a cercare un nuovo editore con cui potesse iniziare un rapporto proficuo per le due parti.
In occasione dell’entrata fra le pubblicazioni della Casa editrice Pàtron, il consiglio direttivo ha anche studiato un rinnovamento grafico della rivista «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna». Assieme alla nuova veste grafica, la Deputazione ha deciso di creare un comitato scientifico che potesse fornire consulenze e consigli e di introdurre la revisione in doppio cieco dei contributi, al fine di dare maggiore rilevanza scientifica alla rivista. Oggi non ci si può più accontentare del prestigio dell’ente che pubblica la sua tradizionale rivista: bisogna mantenere costantemente alto il livello dei contributi, senza divergere da questi severi intenti. Ne guadagna l’istituzione, che onora gli alti principi che hanno presieduto alla sua fondazione, e ne guadagna il prestigio
dei suoi collaboratori, che siano studiosi già sperimentati e apprezzati o giovani che si affacciano agli studi storici. Con la collaborazione con la Casa editrice Pàtron la Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna inizia il suo 156° anno di attività e non possiamo che augurarci che la collaborazione duri ancora a lungo e raggiunga sempre più proficui risultati.
paolo GolInellI
Università degli studi di Verona
Conoscevo la Pàtron attraverso le dispense universitarie che stampava (ricordo quelle di Paleografia del prof. Gianfranco Orlandelli o quelle di Filologia romanza di Marco Boni), e la grande libreria sotto i portici di via Zamboni, che profumava dei libri appena usciti dalle tipografie: c’era la fila per poterli avere e fare l’esame, e quando arrivavano erano pile che toglievano spazio a un pubblico impaziente di averli. Erano gli anni della contestazione, ma anche di centinaia di studentesse e studenti che frequentavano le lezioni nelle grandi aule per i fondamentali. Ricordo la folla alle lezioni, lentissime, di Raffaele Spongano di Italiano, con i tre preesami: antologia, Divina Commedia e metrica, quest’ultimo basato sulla sua antologia, edita dalla Pàtron, con una crestomazia di brani imprevisti e imprevedibili, che ancora mi frullano nella memoria: «Me marì non vol che balla, / che l’è morta la cavalla», o l’attualissimo: «Non mi mandar messaggi che son falsi / non mi mandar messaggi che son rei. / Messaggi siano gli occhi quando li alsi; / messaggi siano gli occhi tuoi ai miei». Cito a memoria, ma non mi sarebbe difficile trovarne la pagina.
Pàtron era allora per me il simbolo di un’editoria alta, e quando avviai col Comune di San Benedetto Po il progetto della grande storia di quel monastero (in dodici volumi dei quali undici editi), mi sembrò naturale rivolgermi a
questa Casa editrice, alla quale mi indirizzò subito il mio maestro, Ovidio Capitani.
Andammo insieme in via Badini 12 a Quarto Inferiore, in un dopopranzo del 1983, in taxi. Una cosa per me nuova. Il mio maestro era molto sicuro di sé, io ero insieme intimorito e curioso. Ci ricevette l’ingegner Aldo Lanza, una persona molto distinta e preparata, che decise di inserire questo progetto come “Fuori sezione”, all’interno della Collana “Il mondo medievale. Studi di storia e storiografia”, iniziata nel 1981 da Ovidio Capitani stesso, con la ristampa dell’antologia La concezione della povertà nel Medioevo, uscita per la prima volta nel 1974 e andata esaurita. Erano anni nei quali andavano di moda i readings, raccolte di saggi prevalentemente stranieri su di un argomento, e Capitani si muoveva tra le due case editrici prevalenti in Bologna in quel decennio: Il Mulino, per il quale aveva già pubblicato L’eresia medievale nel 1971, poco dopo il suo arrivo all’Alma Mater. Nel 1974 la Pàtron aveva un’unica Collana, denominata “Di cultura storico sociale”, entro la quale pubblicava soprattutto dispense per i corsi monografici dei docenti di Lettere, di Magistero (molte di Gina Fasoli), Economia e Commercio (Luigi dal Pane); ma già cominciavano a profilarsi collane più specialistiche. “Il mondo medievale”, fortemente voluto da Adelson Pàtron, si strutturò subito su tre sezioni: Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee, diretta da Ovidio Capitani; Sezione di storia della società, dell’economia e della politica, diretta di Vito Fumagalli; e Sezione di storia bizantina e slava, diretta da Antonio Carile. Un progetto legato a un territorio e a un’abbazia, quale quello della Storia di San Benedetto Polirone, non rientrava strettamente in nessuna di quelle sezioni, ove confluivano volumi di
docenti e di neolaureati che si aprivano al mondo universitario, dal quale erano finanziati. Da ciò la dicitura “Fuori sezione”, nella quale andarono libri da me proposti, che si alimentavano con contributi del territorio, soprattutto enti locali, che vedevano editi in una sede “alta” ricerche e convegni che li coinvolgevano direttamente.
Fu così che dopo la Bibliografia Storica Polironiana, del 1983, che si avvaleva di una importante Introduzione del Capitani stesso, uscirono gli Atti del convegno per i 900 anni della morte di sant’Anselmo, patrono di Mantova (Sant’Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture), nel 1987, e due convegni matildici, organizzati dalla Provincia di Reggio Emilia: I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all’Europa, nel 1994, e Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo Millennio. Dalla storia al mito, nel 1999, intrecciandosi con il primo volume del Codice diplomatico polironiano (961-1125), nel 1993, e col Catalogo dei manoscritti Polironiani. I. Biblioteca Comunale di Mantova (ms. 1-100), nel 1998, anno in cui usciva anche il primo volume della vera e propria storia, Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (9611125), presto andato esaurito e ristampato.
Questa produzione portò nel 2000 a trasformare il Fuori sezione in una vera e propria sezione che intitolammo, Capitani ed io, ricordando un famoso titolo di Vito Fumagalli, prematuramente scomparso nel ’97 (Terra e società nell’Italia padana): “Sezione di Storia medievale dell’Italia Padana”, con gli atti di un convegno del 1997 su Il Millenario di Sant’Adalberto a Verona, n. 9 della Collana, di cui a questo punto fui riconosciuto direttore.
Non so se in questa “promozione” abbia influito il fatto che nel 2000 ero diventato professore associato, ma per un uomo come il mio maestro, persona d’altri tempi (nel bene
e nel male), anche questo contava, tanto che solo dopo che ebbi ottenuto l’ordinariato, nel 2014, passò al tu, pretendendo che anch’io lo usassi con lui (prima ci si dava del Lei, magari facendolo seguire dal nome proprio).
Da allora il lavoro con la Pàtron è diventato una consuetudine, se nel quarto di secolo che seguì credo che non sia mai mancato anno nel quale non uscisse un volume della Collana (giunta al n. 29), o da me scritto, curato o promosso, e dal 2018 ogni anno ha visto la luce la rivista «Matildica», annuale dell’Associazione Matildica Internazionale, tanto che c’è stato un momento in cui in via Badini avevano coniato il neologismo “golinelliamo”, per dire facciamo un libro di Golinelli. Devo dire che anch’io mi trovavo a casa a Quarto Inferiore, pur continuando a pubblicare anche altrove. «Noi siamo un’editoria di nicchia» soleva ripetere Sandra Simoni, con una modestia non falsa, quella che ha consentito alla Casa editrice Pàtron di raggiungere il traguardo del secolo. Naturalmente i momenti di crisi non sono mancati, e anch’io me ne rendevo conto, quando vedevo assottigliarsi il numero delle collaboratrici, o quando chi faceva le copertine e insieme rispondeva al telefono mi mise una miniatura a rovescio nella cover.

Personalmente ho vissuto con la Pàtron tutte le trasformazioni dell’editoria negli ultimi cinquant’anni. Ho incontrato una Casa editrice che faceva tutto al suo interno, quando era bellissimo lavorare nello stabilimento di via Badini 12. Si cominciava nello studio delle riunioni, coi committenti e la signora Simoni, poi col progetto del libro o la consegna dei dattiloscritti con Daniela Serafini, e al momento dell’impaginazione con il proto, che diventava protagonista nella fase della correzione delle bozze. Dal corridoio, dove i miei occhi scorrevano centinaia di titoli di libri accattivanti, che esitavo a chiedere in omaggio, si scendeva nel grande magazzino. Tre o quattro file di scaffali, zeppi di pacchi di libri messi in ordine progressivo, come i filari di una vigna, dove era bello perdersi, mentre un magazziniere cercava il titolo richiesto. In quella zona doveva esserci anche la tipografia, all’inizio. Io non l’ho mai vista, ma quando uscì il volume su sant’Anselmo e dovevamo presentarlo il giorno dopo a Mantova (dicembre 1987), ricordo che il rilegatore non l’aveva ancora mandato. Era sera, ma Sandra e altre due collaboratrici presero tre plichi di fascicoli rimasti in sede e li rilegarono con un apparecchio che avevano, a mano, e prepararono seduta stante tre volumi per la presentazione. Uno lo portai subito a Franco Cardini, che doveva presentarlo e alloggiava al Jolly.
Ricordi di un altro mondo, che posso qui esternare. Come non posso non ricordare l’avventura del catalogo della mostra del Millenario della fondazione del monastero di San Benedetto Polirone nel 2008. Tutta quella ricorrenza fu per me un travaglio, funestata durante l’organizzazione dalla morte del sindaco (Eros Bertazzoni), e dall’accavallarsi di situazioni impreviste: l’affidamento
della parte economica a un Comitato di Scopo, fatto di gente che non aveva esperienza nell’editoria; il moltiplicarsi delle mostre, per cui un Presidente della Provincia di Mantova entusiasta, reduce da una straordinaria esposizione a Paderborn (alla quale io pure avevo collaborato), volle ripeterla a Mantova, affidandone la cura a una persona “in carriera”, che approfittò del mio lavoro (avevo pubblicato con la Federico Motta come strenna alla fine del 2003 il volume illustrato I mille volti di Matilde. Immagini di un mito nei secoli) per anticipare quella che mi era stata affidata per celebrare i mille anni dalla fondazione del monastero (1007) sul quale coordinavo studi da una trentina d’anni. Infine la Provincia di Reggio Emilia, che non volle essere da meno e affidò a uno storico dell’arte, Arturo Calzona, l’organizzazione della terza mostra: Matilde e il tesoro dei Canossa. Quando si trattò di pubblicare il volume di studi per ognuna delle tre mostre, le due province, che potevano contare su un’abbondanza di fondi pubblici, si accordarono per affidarne la stampa a un esperto di cataloghi d’arte, la Silvana editrice di Cinisello Balsamo. Io, sapendo per esperienza come si comportano queste case editrici, che trattando con enti pubblici fanno lievitare i costi oltre le spese effettive, preferii che l’incarico fosse assegnato alla Pàtron, che presentò un preventivo, comprensivo del compenso agli autori, che era meno della metà di quello presentato dalla Casa editrice milanese.
Naturalmente gli altri non chiesero preventivi (forse non era necessario) e procedettero come volevano. La Pàtron cercò in quel momento di affacciarsi anche nel settore delle mostre, anche perché aveva intrapreso la stampa de «Il Carrobbio», una strenna bolognese molto ben illustrata, e solo in alcuni casi riuscì a ottenere incarichi.
Per me fu bello lavorare durante l’estate del 2008 a questo libro, insieme a Sandra e a Gino Bonfiglioli, uno degli ultimi bravi proto, che lavorava con forbici e colla a sistemare le righe, disporre immagini, infilare correzioni. Furono giorni febbrili in quell’agosto, in cui spesso fui alla Pàtron dal mattino alla sera, condividendo con le poche persone in servizio il pranzo in un self-service di Quarto Inferiore. Ne uscì un volume – L’ abbazia di Matilde. Arte e storia in un grande monastero dell’Europa benedettina. San Benedetto Po (1007-2007) – di cui vado ancor oggi orgoglioso, così come di quell’esperienza, che vide, all’apertura della mostra, nel settembre 2008, una grande partecipazione da parte della gente di quel piccolo centro sulle sponde del Po. Anche Sandra fu presente (l’unica volta) e poté rendersi conto di che cosa significa quel centro monastico e quel paese, che sa raccogliersi insieme quando ne vale la pena. Furono oltre trentamila i visitatori di quella mostra e molti lasciarono commenti entusiasti.
Poche furono le volte che la Pàtron, messa a confronto con altre case editrici, non la spuntò. Quella che ricordo meglio fu nel 2012, un anno tragico per chi viveva o aveva affetti
nella Bassa Modenese e

dintorni, coi due terremoti del 20 e 29 maggio. Io allora dovevo curare gli atti di un convegno internazionale svoltosi a Verona due anni prima, con l’Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e dell’Agiografia (AISSCA), di cui ero uno dei due vicepresidenti. La tradizione era di pubblicare con Viella di Roma, con cui peraltro avevo già edito due volumi; in quell’occasione scelsi di avvalermi di un editore bolognese, per poter seguire la lavorazione mentre continuavano le scosse e l’incertezza. Pensavo ovviamente alla Pàtron, ma – come era dovuto, trattandosi di soldi pubblici che mi venivano dalla mia Università –richiesi tre preventivi: al Mulino, alla Pàtron e alla Clueb. Quest’ultima presentò l’offerta migliore, e pubblicai con essa quel volume di 444 pagine, con saggi in italiano e inglese (Agiografia e culture popolari – Hagiography and popular cultures. In ricordo di Pietro Boglioni), La Clueb fu, nell’ultimo ventennio del secolo scorso, la più forte concorrente della Pàtron, anche nel settore della medievistica, con l’avvio di due importanti collane: la Biblioteca di Storia Agraria Medievale (BSAM), diretta da Vito Fumagalli, poi dai suoi allievi Bruno Andreolli (morto nel 2015) e Massimo Montanari, e Biblioteca di Storia Urbana Medievale (BSUM), diretta da Antonio Ivan Pini (morto nel 2003). In quest’ultima serie avevo pubblicato nel 1991 Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, presto andato esaurito, e riedito con significativi ampliamenti nel 1996; mentre nella prima un’allieva di Vito Fumagalli, poi cultrice della materia all’Università di Verona, Elisa Anti, era uscita nel 1998 con Santi e animali nell’Italia padana. Secoli IV-XII. A monte del successo di questa Casa editrice vi era la filosofia del signor Ercoli (un nome che ben rappresentava la sua imponente figura di tipico bolognese), il
quale coinvolgeva gli autori con un’elevata percentuale di royalties sul venduto, in modo che, mettendo i libri in programma e pretendendo che gli studenti e le studentesse li portassero, gli autori potessero avere un riscontro economico personale. Niente di illegale se le pubblicazioni non erano state finanziate con danaro pubblico; se lo erano state, allora bisognava fissare una quota iniziale priva di diritti, oltre la quale questi potevano intervenire. Pàtron, per quanto mi consta, lo fece solo per i manuali che non erano finanziati: la mia Breve storia dell’Europa medievale. Uomini, istituzioni, civiltà, uscita nel 2001 e ristampata più volte, e gli Elementi essenziali di archivistica teorica e pratica, scritto con Emanuela Lanza nel 2003, e anch’essi riediti; non fu finanziato, ma nemmeno coperto da diritti, il manuale di didattica della storia: Leggere, scrivere, insegnare storia, del 2010, poi riedito.
Si affacciava intanto, almeno dagli anni Novanta, il problema delle fotocopie. Prima si usavano fotocopie per parti non essenziali dei programmi; ma a un certo punto le copisterie cominciarono ad aumentare a vista d’occhio, senza che ci fosse una regolamentazione in grado di difendere il copyright. «Copiami stupido» si intitolò un manifesto dell’Associazione Italiana Editori, diffuso dalla Pàtron, e io fui tra i più accaniti sostenitori del diritto d’autore, non solo e non tanto per il danno che mi derivava dalle fotocopie, ma per difendere il principio della legalità, che se ci si abitua da piccoli a non rispettare non lo si rispetterà per tutta la vita, ingrossando la sempre più ampia schiera dei disonesti (stupidamente chiamati “furbetti”: cosa c’è di furbo nell’ingannare il prossimo?) che non rispettano le leggi. Giunsi a non fare l’esame a coloro che si presentavano con fotocopie, con la conse-
guenza che si facevano prestare il libro da altri prima di venirmi davanti. «Una battaglia persa …» mi diceva Sandra Simoni, ma tanto valeva combatterla, e non darsi per vinto prima di affrontarla.
L’ultimo capitolo del mio rapporto con la Pàtron riguarda l’attività editoriale dell’Associazione Matildica Internazionale, un organismo di volontariato che ho potuto fondare con l’aiuto di un centinaio di appassionate e di appassionati della storia e del mito di Matilde di Canossa, e dei suoi territori, nel 2018. Anche per questa iniziativa fondamentale è stata la disponibilità della Pàtron attraverso la figura di Sandra Simoni, con la quale feci una lunga riunione in un affollato bar di piazza Verdi: io sempre attento agli interessi dell’Associazione, lei a quelli della Casa editrice, ma ben disposti ad accordarci in modo che entrambi potessimo ottenere quello che desideravamo (win-win), e da lì la spinta per procedere e continuare una collaborazione iniziata nel 1983. Di questa spinta si è poi fatta carico, una volta che giustamente Sandra ha raggiunto i limiti per potersi ritirare (io già li avevo raggiunti l’anno prima), chi le è succeduta, Erika Mucignat, con i suoi collaboratori Massimo e Matteo.

In cifre i miei primi quarant’anni con la Pàtron hanno significato: 29 libri della Collana “Storia medievale dell’I-
talia Padana”; un catalogo di mostra; tre manuali; una rivista, «Matildica», giunta al n. 6, e due Quaderni della medesima, dei quali uno in inglese: Penelope Nash, The Spirituality of Countess Matilda of Tuscany (2021), e l’altro in Italiano: Simona Bini e Fausto Ghisolfi, La chiesa di San Martino delle Ferrate (CR) nei secoli XII e XIII (2022). C’è di che essere grati a chi ha consentito tutto questo.

franco lorenzettI
Università degli studi di Perugia
danIele rosellInI
Università degli studi di Perugia
fabIo veronesI
Università degli studi di Perugia
In occasione del suo primo centenario, la Casa editrice Pàtron ci ha chiesto un breve scritto sulla nostra esperienza di autori. Abbiamo accettato molto volentieri, dato il lungo rapporto di collaborazione che riguarda essenzialmente il volume Genetica Agraria – Genetica e biotecnologie per l’agricoltura, edito per la prima volta nel 1980.
La genetica e, in particolare la genetica agraria, non ha avuto un percorso facile per essere annoverata tra le materie di studio universitario. Per la genetica, ancora nel 1920 (un ventennio dopo la riscoperta dei principi di Mendel) il naturalista Cesare Artom fu incaricato dalla SIGE (Società Italiana di Genetica e Eugenetica) di presentare all’Accademia le nuove acquisizioni genetiche, in particolare la teoria cromosomica dell’ereditarietà. Situazione ancora peggiore per la Genetica agraria, praticamente assente dagli insegnamenti universitari fino alla seconda metà del XX secolo.
Tuttavia la genetica aveva già dato un importantissimo e non riconosciuto contributo all’agricoltura italiana fin dall’inizio del secolo, grazie a Nazareno Strampelli che, mediante incroci e selezione aveva prodotto varietà innovative di frumento, una delle quali fu da lui battez-
zata “Gregorio Mendel”. Queste varietà resero possibile un grande aumento delle produzioni unitarie di frumento e resero evidente l’importanza della genetica applicata all’agricoltura. È il caso di ricordare che, tra l’ostracismo dei “genetisti puri”, nel 1954 Carlo Jucci fondò la Società Italiana di Genetica Agraria.
Nel corso del Novecento, col progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche, diventò sempre più evidente l’importanza della Genetica non solo nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ma anche nelle Facoltà di Scienze Agrarie. In queste ultime, l’insegnamento del mendelismo classico, delle moderne acquisizioni di biologia molecolare, della genetica dei caratteri poligenici a variabilità continua (genetica quantitativa), della genetica di popolazione e dei metodi di miglioramento genetico si fecero lentamente strada.
Tuttavia è stato necessario attendere il 1982 perché l’insegnamento della Genetica Agraria fosse reso obbligatorio per i corsi di Laurea in Scienze Agrarie. A questo risultato si è giunti per tappe. Nel 1959-1960 furono istituite due cattedre, una di Genetica a Pisa e una di Allevamento Vegetale a Perugia. È interessante che a Perugia non fu possibile denominare la cattedra “Miglioramento Genetico Vegetale” per la contrarietà dei genetisti “puri” a permettere che il termine “genetico” fosse inserito nel titolo di un corso insegnato da Adelmo Panella, un docente proveniente dall’Agronomia! Comunque i tempi evolvono: nel 1964 a Bologna e nel 1967 a Torino furono istituite due cattedre di Miglioramento genetico mentre nel 1967 fu istituita a Bari una cattedra di Miglioramento genetico delle piante agrarie. Nel 1975, il corso complementare di Genetica agraria fu inserito nello Statuto dell’Università di Perugia e impartito da Franco Lo-
renzetti. Nel 1982 la lunga incubazione giunse finalmente al termine con la riforma delle Facoltà di Agraria nella quale la Genetica agraria, materia divenuta ormai fondamentale, ha finalmente avuto uno spazio autonomo.
Disegnato a grandi linee lo sviluppo della Genetica agraria nel nostro Paese, è opportuno sottolineare l’attività editoriale sviluppata dall’editore Pàtron in questo settore. Nei primi quindici anni di sviluppo dell’insegnamento della Genetica agraria in Italia non erano presenti veri e propri testi universitari che sviluppassero compiutamente questa disciplina; questo problema fu quindi affrontato da uno di noi (Franco Lorenzetti) che, con la collaborazione di due suoi allievi (Salvatore Ceccarelli ed Efisio Piano) nel 1974 produsse una dispensa di Genetica agraria per gli studenti universitari. Il successo ottenuto da questa dispensa spinse Lorenzetti e Ceccarelli a pensare alla pubblicazione di un volume per la cui edizione si rivolsero a Pàtron. La risposta della Casa editrice fu positiva per cui nel dicembre 1980 uscì la prima edizione del testo Genetica agraria che fu adottato non solamente a Perugia ma in molti altri Atenei italiani. Il successo editoriale fu notevole per cui già nel 1983 Pàtron pubblicò la seconda edizione. L’inserimento della Genetica agraria come insegnamento fondamentale in tutti i corsi di Scienze agrarie non fece che migliorare ulteriormente la diffusione dell’opera che, nel 1996, giunse alla terza edizione nella quale, per la prima volta, vennero riportati lineamenti di ingegneria genetica e che vide la presenza come coautore di Fabio Veronesi. In questa edizione fu aggiunto un capitolo finale di lineamenti di miglioramento genetico indirizzato agli studenti che non avrebbero poi svolto il corso di Miglioramento genetico nella prosecuzione dei propri studi.
F.
Lorenzetti
- D. Rosellini - F. Veronesi | 77
Dopo un aggiornamento del 2002, la quarta edizione fu stampata nel 2011 con il contributo come coautore di Daniele Rosellini. Dopo le ristampe della quarta edizione avvenute nel 2015 e nel 2018 si è quindi arrivati nel 2023 alla quinta edizione, che ha visto l’inserimento di un altro coautore (Emidio Albertini) e ha richiesto un lavoro non indifferente sia per modernizzare la veste grafica e l’iconografia che per aggiornare il testo dove necessario. In particolare sono stati eliminati alcuni argomenti di genetica classica non più attuali, aggiunte informazioni sui meccanismi delle mutazioni geniche e aggiornato il capitolo sull’ingegneria genetica con informazioni sul genome editing. Questo aggiornamento ha reso possibile l’utilizzazione del testo anche per l’insegnamento di Principi di genetica del Corso di laurea triennale di Biotecnologie di Perugia.
Il libro ha subito, come si è detto, un continuo sviluppo per adeguarsi alle nuove conoscenze, ma la stella polare del nostro lavoro è sempre stata la volontà di fornire un testo introduttivo alla materia, senza eccesso di informazione di dettaglio, volto alla comprensione da parte degli studenti dei concetti chiave della genetica e della genetica applicata all’agricoltura. Come indicato nella prefazione alla quarta edizione, due di noi (Veronesi e Rosellini) hanno iniziato a studiare la Genetica agraria su questo testo che evidentemente ha contribuito a farci piacere la materia al punto tale da scegliere la Genetica agraria come il settore nel quale spendere la propria vita professionale. Il volume è stato utilizzato ininterrottamente per oltre un quarantennio (dal 1980 ad oggi) e ha sempre incontrato il gradimento di studenti e studentesse, anche grazie allo sforzo degli autori volto a rendere agevole l’acquisizione di nozioni che non sono sempre di facile apprendimento.
| 1925-2025

La realizzazione di questo obiettivo è stata possibile anche grazie alla disponibilità della Casa editrice Pàtron che ha sempre dato seguito alle nostre richieste. Il rapporto con la Casa editrice è stato sempre costruttivo e cordiale, cosa non scontata nella relazione autore-editore. Ad esempio, è stato l’Editore, nelle persone di Sandra Simoni, da poco in pensione, e della dott.ssa Erika Mucignat, a stimolare le due ultime edizioni, dimostrando di saper interpretare con lungimiranza le esigenze didattiche della disciplina.
Il risultato di questo lungo lavoro editoriale è evidenziato dalle vendite; abbiamo i dati sulle vendite di un ventennio pari a circa 13.000 copie, con una media di circa 640 copie per anno, per cui pensiamo che, nel complesso, siano state vendute almeno 25.000 copie in 43 anni. Considerando che stiamo parlando di un testo universitario, ci dichiariamo molto soddisfatti di aver contribuito alla formazione di un numero così alto di studenti e studentesse.
Concludendo il nostro rapido excursus sui rapporti fruttuosi con Pàtron, ci piace ricordare anche un altro volume edito nel 2013 dalla stessa Casa editrice che vede come autori Franco Lorenzetti, Silvia Lorenzetti e Daniele Rosellini dal titolo Uomini e semi. Dal seme alimento alla semente biotecnologica. Si tratta di un libro indirizzato agli
F. Lorenzetti - D. Rosellini - F. Veronesi
studenti universitari delle Lauree Magistrali, ai professionisti del settore agricolo e al pubblico generale. Il seme è alla base della produzione agricola e della sicurezza alimentare mondiale ed è un concentrato di conoscenze e tecnologie la cui importanza non è sempre adeguatamente riconosciuta. Il testo ripercorre la storia del seme e del suo legame con l’uomo agricoltore e richiama la necessità di rivedere profondamente l’organizzazione odierna del mercato delle sementi e di rendere più efficiente la filiera sementiera che rimane alla base della produzione agricola nazionale e internazionale.
Auguriamo alla Casa editrice Pàtron, che possiede tutte le caratteristiche per ottenere ancora molti successi editoriali, altri cento anni di attività.
flavIo lucchesI
Università degli studi di Milano
Il libro di Nedim Vlora Città e Territorio: distribuzione e crescita urbana in Italia (1979) è stato il primo volume della “Collana di Geografia e Organizzazione dello Sviluppo Territoriale”, e ha segnato l’inizio del profondo e duraturo legame della Pàtron con la disciplina.
Una disciplina in evoluzione che, forte della solidità dei propri cardini, si prestava in quel periodo ad accogliere nuovi temi con approcci trasversali, al passo con l’evoluzione più recente degli studi e delle ricerche.
Fu questa un’intuizione dell’allora Editore, Adelson Pàtron, concretizzata dopo la sua scomparsa dal direttore generale Aldo Lanza, che nel varo di tale iniziativa aveva visto una possibile svolta di respiro editoriale nazionale: non a caso, infatti, proprio in quegli anni la Casa editrice iniziò una profonda trasformazione commerciale che le avrebbe consentito una presenza certa nelle librerie delle principali sedi universitarie italiane e che sarebbe stata avvalorata dalla necessità di rinforzare il catalogo con titoli non solo di utilizzo locale.
La Collana di Geografia, fondata e diretta per quarant’anni da Roberto Bernardi (Ordinario presso l’Università di Verona) ha fino a oggi accolto oltre 150 titoli, distribuiti nelle due attuali sezioni: una sezione di manualistica universitaria, che da sempre accoglie opere di riferimento per corsi generali, e una sezione di Studi Regionali e Mo-
nografici, sede ideale per lavori inerenti a tematiche e ambiti territoriali specifici.
Per molti anni nella seconda pagina di copertina dei volumi si leggevano le righe qui di seguito riportate, che riassumono con efficacia quanto era nella volontà del prof. Bernardi, spirito vivo, autorevole, tonante e instancabile:
… Va d’altro canto affermato che la Geografia, nonostante le antiche e nuove tematiche inerenti il territorio si siano sempre più caratterizzate come aree di studi interdisciplinari, resta la scienza che, per metodo e finalità, appare privilegiata nello studio dei rapporti tra ambiente fisico e ambiente umano dai quali dipendono gli equilibri socio-economici…
La puntuale presenza alle riunioni mensili nella sede di via Badini, le intense telefonate, il lavoro comune, costantemente motivato dall’obiettivo di arricchire la Collana con idee nuove da trasformare in volumi accattivanti e consoni al mercato, hanno caratterizzato la cifra del direttore; uomo schietto e diretto, dotato di profonde competenze disciplinari, oltre che delle necessarie capacità organizzative e diplomatiche, egli ha sempre valutato studi e progetti con spirito leale e costruttivo, nella convinzione che ogni scritto di valore dovesse venire pubblicato.
La storica copertina, a cui era particolarmente affezionato, è presto stata una nota distintiva della serie, e ha reso l’Editore individuabile con rapidità.
Con l’ingresso di Piero Dagradi (Ordinario presso l’Università di Bologna), entrato alla fine degli anni Ottanta come direttore del Comitato Editoriale, la Casa editrice si è avvicinata con ulteriore vigore alla disciplina.
| 1925-2025
Il severo referaggio degli scritti, la rilettura accurata e critica con annotazioni a penna di Dagradi prima e Bernardi poi, hanno indirizzato gli autori con fermezza e rigore (a prescindere dalla loro collocazione accademica) verso il miglioramento del risultato finale.

La presenza costante ai Congressi Geografici, alle Giornate della Geografia, ai Convegni dei vari sodalizi, ha reso naturale per i geografi delle varie sedi accademiche rivolgersi alla Pàtron per la pubblicazione di Atti di Congressi e Convegni, Scritti in onore, Giornate di Studio, risultati di ricerche di progetti PRIN, al di là della sempre possibile pubblicazione di monografie nella Collana didattica.
All’interno della Casa editrice si è andata così formando una precisa professionalità unita a competenze disciplinari specifiche. E la certezza del risultato finale, anche a fronte di difficoltà a volte non facili da gestire, ha rappresentato il valore aggiunto dell’Editore in questi anni. Una fiducia che all’inizio degli anni Novanta ha coinvolto la Casa editrice nella pubblicazione della rivista «Geotema» organo dell’AGEI, Associazione dei Geografi Italiani. L’allora presidente Alberto Di Blasi (Ordinario presso l’Università di Catania) volle con determinazione e lungimiranza che la
sede editoriale della testata fosse presso un editore legato da tradizione geografica duratura e consolidata.
Egli difese con convinzione questa sua scelta, e il rapporto con lui (nonostante le oggettive distanze fisiche, in tempi tecnologicamente diversi), ripagò gli sforzi suoi e di tutto il gruppo di lavoro, alternatosi nel tempo ma sempre rispettoso di questa volontà: tuttora la Rivista è edita da Pàtron, con le indispensabili variazioni al passo con le attuali necessità del sodalizio.
In questi anni di attività costante (a volte di sperimentazione) sempre segnata dai continui scambi e stimoli con il mondo dei geografi, sono comparse serie e sezioni all’interno delle strade maestre sopra delineate, come per esempio alcuni titoli pubblicati in una sezione di Viaggi e Viaggiatori, e una serie di Geografia Regionale dell’Europa, con agili volumetti destinati agli studenti sui principali stati europei.
Tra i volumi che nel corso del tempo hanno consolidato il catalogo di Geografia non si può non citare il fortunato Manuale di Geografia umana di Piero Dagradi, che ha visto più edizioni in trent’anni, con vendite per oltre 60.000 copie. Pubblicato per la prima volta nel 1979 fuori collana, è stato successivamente inserito in Collana con il nuovo titolo Uomo, ambiente e società. Esso è stato poi

affiancato nel 2003 da Introduzione alla Geografia Umana, di Piero Dagradi e Carlo Cencini, volume che sarebbe stato a sua volta ristampato varie volte.
La Collana è stata seguita coralmente dall’Ufficio editoriale della Casa editrice, sotto la guida precisa, attenta e partecipe di Sandra Simoni, coadiuvata dalla collaborazione di Daniela Serafini.
Ora è seguita da Erika Mucignat, che è succeduta a Sandra Simoni nella direzione editoriale.
La storia recente è segnata dalla mia direzione, iniziata nel 2019, con l’affiancamento di un Comitato Scientifico di riferimento costituito da illustri colleghi di università italiane e straniere.
Il fondatore, scomparso nel 2022, ha seguito anche negli ultimi tempi qualche referaggio, lasciando un’eredità di solido rigore metodologico, assidua curiosità intellettuale e costante tensione innovativa che cercheremo di non disperdere, ma anzi di valorizzare, negli anni a venire.
lucIa rodler
Università di Trento
Buon centenario, Pàtron!
Pensando al centenario dell’editore Pàtron, mi sono subito venute in mente due immagini, legate alla Bologna universitaria che ho cominciato a frequentare nel 1983.
La prima è la copertina di un libro fondamentale, consistente e solido, scritto da Alfonso Traina e Giorgio Bernardi Perini e intitolato Propedeutica al latino universitario. Ricordo bene che, inizialmente, il titolo non mi era chiaro: perché propedeutica se ho già fatto sette anni di latino (tra scuole medie e liceo classico)? Che cosa ha di diverso il latino universitario da quello già studiato? Poi, frequentando con passione crescente le lezioni di Traina (lunedì, martedì e mercoledì, dalle 9 alle 10, da novembre a maggio, in via Zamboni 38), ho capito le ragioni di quel libro serio, denso e chiaro, e ho al tempo stesso scoperto e apprezzato l’editore Pàtron, che collego da allora a scelte durature e di qualità. Ho davanti a me i capitoli di quel volume: La storia del latino, La pronunzia, La quantità e l’accento, Problemi di fonetica, Problemi di morfologia, Problemi di sintassi, Fondamenti di metrica, La critica del testo, Didattica e didassi del latino, Gli strumenti, Gli indici e Supplementi e aggiornamenti. Ancora oggi i titoli incutono un certo timore, lasciando intuire le ore di studio richieste da questo testo che, però, alla fine, mi ha fatto sentire davvero una studentessa universitaria, cioè consapevole delle questioni complesse che stanno dietro a ogni elemento del sapere.
A questo libro è legata anche una seconda immagine che ho ritrovato tale e quale nella mia memoria e nell’edizione del 1977 da me studiata: il bellissimo logo di Pàtron, con le due torri di Bologna (attrattore potente per una fuori sede), un libro aperto e una scritta latina perfettamente coerente con la serietà dell’editore: Labor omnia vicit improbus. E in effetti così è certamente stato sin dal 1925 per Riccardo Pàtron (presente nel logo con le iniziali maiuscole del nome e del cognome), un Editore soprattutto accademico, ma non esclusivamente dedicato all’Ateneo bolognese. La citazione dalle Georgiche di Virgilio dà il senso dell’impegno e della fatica che sostanziano un mestiere sempre sottoposto a nuove, difficili, sfide (basti pensare, prima, alla concorrenza sleale delle fotocopie e, oggi, alla pressione del web e della scienza aperta).
La scritta del logo veicola anche una terza immagine, più recente, che ritrae il volto sorridente di Sandra Simoni, che per decenni ha realizzato nella sua persona le qualità di affidabilità di Pàtron, con l’entusiasmo, la generosità e la simpatia di chi lavora sodo, con autentica passione. Non vivevo già più a Bologna, quando ho conosciuto Sandra. Ma ricordo di avere salito con grande piacere le scale di via Marsala 31 per incontrarla e sento anche l’eco delle nostre telefonate, sempre amabili, positive e propositive. La sua fiducia è stata indispensabile per portare avanti, con l’amico Gino Ruozzi (e ora anche con Elisabetta Menetti e Bruno Capaci), la Collana “Letteraria “che dal 2015 raccoglie saggi di letteratura, destinati all’università ma anche alla diffusione extra accademica della critica letteraria.
Da qualche anno Sandra è in pensione e dunque festeggio il centenario di Pàtron insieme a Erika Mucignat, un’altra donna con cui è bello dialogare perché interpre-
ta molto bene il motto Labor omnia vicit improbus. Grazie dunque a Sandra, a Erika e a tutto il gruppo di lavoro di questo editore coraggioso e determinato, in tempi difficili per la cultura umanistica.
Buon centenario e felice proseguimento.
Marco ruGGerI
Conservatorio di Musica di Darfo-Brescia
La Casa editrice Pàtron è benemerita in Italia anche nel campo degli studi legati all’organo. Dal 1967, infatti, essa pubblica ininterrottamente «L’Organo. Rivista di cultura organaria e organistica», ossia il primo periodico scientifico che si occupa di valorizzare nel nostro Paese questo specifico settore.
Come in tanti altri ambiti artistici, anche in quello degli organi, infatti, la penisola è estremamente ricca di testimonianze storiche. Decine di migliaia sono gli strumenti disseminati in ogni parte e ancor oggi nemmeno del tutto censiti e catalogati. Il patrimonio organario, superficialmente considerato minore o secondario rispetto a quello architettonico o pittorico, ha ricevuto meno attenzioni e controlli, sicché è stato oggetto di manomissioni avvenute in particolare nei primi decenni del Novecento. L’organo antico, di cui appunto restano molti esemplari a partire dalla fine del XV secolo, in molti casi ha pertanto subito alterazioni a causa della mancanza di una specifica tutela da parte dello Stato, al contrario di quanto avveniva in altri settori dell’arte.
La salvaguardia del patrimonio organario ha cominciato a presentarsi come problema concreto soprattutto dopo la celebre legge di tutela 1089 del 1939 inerente, più in generale, ai beni storici e artistici. Da lì in avanti, grazie specialmente all’istituzione di specifiche commissioni
presso le Soprintendenze, si è affrontato in modo sempre più capillare anche il tema della protezione degli organi storici.
Accanto a questo percorso, volto soprattutto a considerare l’organo come bene in sé, si è parallelamente avviato un altro fruttuoso itinerario culturale, ossia quello che risponde a una sempre più incalzante esigenza di conoscere il repertorio organistico antico e dunque di poterlo eseguire sugli organi coevi ancora conservati. La tutela del bene trova quindi sostegno dal desiderio di una migliore conoscenza della letteratura organistica delle epoche passate, dal Rinascimento al Barocco e all’Ottocento, un sostegno che è certamente reciproco.
Tale rilevante fenomeno culturale – che lega la tutela-restauro degli organi antichi (spesso dotati di sontuose e artistiche casse lignee) a una più appropriata esecuzione della letteratura musicale – si è affacciato in Italia verso la metà del Novecento come prosecuzione nostrana dell’analogo movimento che già aveva solide radici nell’Europa settentrionale. È la cosiddetta Orgelbewegung, cioè il “movimento organistico”, espressione con la quale si intende appunto l’articolato àmbito di ricerche, studi, restauri e valorizzazione dell’organo antico. Vari furono in Europa i propugnatori del movimento: uno su tutti può essere qui ricordato, quello di Albert Schweitzer (1875-1965), principalmente noto per la sua attività di medico e missionario.
In Italia, gli ideali dell’Orgelbewegung furono inizialmente portati, in un contesto culturale decisamente avverso, da Renato Lunelli (1895-1967), figura pionieristica in particolare per ciò che concerne la ricerca storico-archivistica.
Questa lunga premessa vuole delineare per sommi capi il quadro di idee e persone nel quale è sorta – nel 1960 – la rivista «L’Organo»: essa ha voluto proseguire e incrementare in Italia i principi dell’Orgelbewegung transalpina e porsi come strumento scientifico di riferimento per gli studi in campo organistico e organario. Nell’editoriale del primo numero si esponevano gli intenti programmatici:
La presente rivista si propone di contribuire ad una rinnovata conoscenza dell’organo nella sua vera natura, nella sua tradizione autentica, nella sua organica architettura sonora. L’organo italiano odierno ha purtroppo sostanzialmente perduto il legame con la preziosa tradizione mantenutasi con straordinaria tenacia nel nostro paese sino agli ultimi decenni del secolo scorso. [...] Si impone un sostanziale rinnovamento del gusto e della concezione sonora e strutturale, che deve fondarsi in primissimo luogo su una meditazione dei valori perenni di una gloriosa tradizione. A questo fine la ricerca storica scientificamente impostata e documentata costituisce il sicuro terreno su cui il nostro periodico intende basarsi.
L’idea di fondare una rivista specifica si deve ai bolognesi Luigi Ferdinando Tagliavini (1929-2017), organista concertista internazionale e musicologo, e Oscar Mischiati (1936-2004), musicologo: i due giovani studiosi cominciarono infatti a parlarne sul finire degli anni Cinquanta. Tra le righe di una lettera a Renato Lunelli (1 giugno 1958), un giovanissimo Oscar Mischiati rivela che «da alcuni giorni – da quando il m.° Tagliavini trova tempo da dedicare alle chiacchierate tra amici – abbiamo approfondito
un po’ la meditazione sull’attuale situazione italiana della cultura ‘organica’» e «tra le cose dette, è venuta fuori l’idea di una rivista», constatandone «l’estrema necessità»14.
In quel periodo Tagliavini si trovava infatti a Bologna, in convalescenza a seguito di un grave incidente automobilistico avvenuto a fine aprile in Danimarca, durante una tournée di concerti nel nord Europa. La pausa forzata consentì di mettere a punto riflessioni e progetti per concretizzare la realizzazione di un movimento organistico italiano, fondato su basi storiche e scientifiche, alla maniera dell’Orgelbewegung tedesca.
Una di poco successiva lettera di Tagliavini a Lunelli (13 giugno 1958) chiarisce aspetti più concreti, quali la struttura direttiva del periodico, gli argomenti dei primi articoli e la disponibilità di un editore. Quest’ultimo era stato individuato nel fiorentino Olschki, la cui produzione libraria comprendeva testi di musicologia. Tutto pareva procedere per il meglio, cioè verso la stampa del primo numero, quando sorsero alcune difficoltà di non poco conto, fra cui l’imprevisto ritiro da parte dell’Editore (lettera del 9 marzo 1959): le motivazioni erano legate a problemi finanziari interni e a una diversità di vedute circa la modalità di uscita della pubblicazione, che l’Editore preferiva come una libera “Collana” piuttosto che come regolare “periodico”.
Lo sbocco fu trovato con una soluzione un po’ macchinosa, ma che comunque garantì l’uscita delle prime quattro
14 Questa e le successive lettere citate sono tratte dal fondamentale studio di Luigi Collarile, «L’Organo. Rivista di cultura organaria e organistica». Intorno alla concezione di un progetto visionario, «L’Organo» LII, 2020, pp. 7-136.
annate. Venne creata infatti una società editoriale a Brescia, con un direttore responsabile (il prof. Giuseppe Scarpat, latinista e biblista, docente all’Università di Parma), due direttori scientifici (Mischiati e Tagliavini) e un comitato di redazione formato da Oscar Mischiati, Sergio Paganelli, Pier Luigi Bossoni ed Ernesto Meli quale segretario. Due erano le sedi: quella amministrativa a Brescia, quella redazionale a Bologna. Il primo numero fu stampato nel giugno 1960. La presenza di Brescia non fu casuale, dal momento che lì, negli anni Cinquanta, si era sviluppato un forte interesse per la musica antica, portato avanti dal Gruppo Musicale “G. Frescobaldi”: questo si faceva promotore di rassegne concertistiche annuali15, ma, soprattutto, fu il propugnatore del restauro dell’organo Antegnati 1581 della locale chiesa di S. Giuseppe, uno dei più prestigiosi e antichi organi europei16. Il restauro del monumentale strumento vide la partecipazione, assieme ai membri del Gruppo “Frescobaldi”, anche di Lunelli e in particolare del giovane Tagliavini, convinto sostenitore di una nuova modalità di restauro, volta a riportare il manufatto, per quanto possibile, nelle condizioni della più completa originalità e coerenza17. Gli
15 Sull’attività artistica del Gruppo “G. Frescobaldi” si veda Mariella Sala, Il Gruppo Musicale ‘Girolamo Frescobaldi’ di Brescia e la rivista «L’Organo», «L’Organo» LII (2020), pp. 137-198.
16 Sulle vicende legate al restauro dell’organo Antegnati di S. Giuseppe in Brescia si veda il saggio di Alberto Chiari, Il restauro dell’organo Antegnati della chiesa di S. Giuseppe a Brescia (19541956): un determinante impulso alla conservazione del patrimonio organario nazionale, «L’Organo» LII (2020), pp. 199-251.
17 Tali principi, in riferimento proprio all’organo di S. Giuseppe,
studiosi bolognesi Tagliavini e Mischiati trovarono dunque a Brescia terreno fertile per far maturare l’idea della rivista che così nacque e si sviluppò per qualche anno sotto l’egida del Gruppo Musicale “G. Frescobaldi”.
Tuttavia, da quanto emerge dal carteggio conservato, apprendiamo che già nel 1959 ci fu un contatto con l’editore Pàtron. Scrivendo a Meli circa la preparazione del primo numero della rivista, Tagliavini dichiarava la disponibilità dell’Editore bolognese per la composizione litografica degli esempi musicali. Non è un caso che vi fosse tale aggancio, dal momento che il padre di Luigi Ferdinando, il glottologo e docente universitario Carlo Tagliavini, sin dagli anni Quaranta aveva pubblicato testi con Riccardo Pàtron e dunque poteva facilmente fare da tramite.
La possibilità – a portata di mano – di collaborare con Pàtron non si attuò subito ma era comunque destinata a concretizzarsi prima o poi, giusto il tempo che gli intricati percorsi bresciani giungessero a termine. I primi anni della rivista, infatti, non furono di facile gestione, caratterizzati da problemi economici, organizzativi, redazionali e anche personali fra i vari membri del comitato direttivo. Dopo l’uscita delle prime quattro annate (tutte semestrali, a eccezione del 1962 che ebbe numero unico), nel 1963 la rivista interruppe le pubblicazioni.
La situazione rimase bloccata sino alla fine del 1966 ma, tra il novembre di quell’anno e il gennaio successivo accaddero alcuni avvenimenti decisivi: le dimissioni dal gruppo direttivo di Giuseppe Scarpat ed Ernesto Meli, sono stati esposti da Tagliavini in Il problema della salvaguardia e del restauro degli organi antichi, «Musica sacra» 2 (1956), pp. 134-142.
da un lato, e, dall’altro, in particolare, la disponibilità di Pàtron ad assumersi l’amministrazione e la stampa della rivista. I rapporti con l’Editore bolognese erano «i più cordiali e amichevoli», come Tagliavini stesso afferma e riferisce a Renato Lunelli in una lettera del 10 gennaio 1967, nella quale illustrava il delicato momento di passaggio. La transizione non fu comunque indolore, soprattutto sul piano finanziario, visto che la gestione precedente della rivista aveva accumulato un debito di oltre 400mila lire con la tipografia bresciana La Nuova Cartografica, cifra che fu generosamente saldata da Tagliavini stesso nel dicembre 1966. Non solo: il 14 gennaio 1967 moriva a Trento, improvvisamente, Renato Lunelli lasciando così Tagliavini e Mischiati nella piena conduzione della rivista, una conduzione a quattro mani, sia nella redazione che nella direzione, che così rimase sino all’annata XXXVI del 2003, cioè sino alla scomparsa di Oscar Mischiati il 14 aprile 2004.
Dall’annata XXXVII del 2004 la direzione venne pertanto assunta da Tagliavini insieme a Paolo Da Col; entrambi, con l’aggiunta di Liuwe Tamminga, si occuparono anche della redazione.
Con la scomparsa di Tagliavini nel 2017 la rivista ha conosciuto un inevitabile rallentamento, se non addirittura un reale rischio di chiusura. La volontà di dare continuità fu chiaramente espressa e sostenuta dall’editore Pàtron con l’auspicio di rinnovare e ampliare il comitato direttivo. E così è stato. La rivista ha proseguito il proprio cammino sotto la direzione di Paolo Da Col, con la collaborazione di Liuwe Tamminga, Antonio Tagliavini e Marco Ruggeri. Nel 2020 si sono aggiunti Luigi Collarile e Maurizio Tarrini, mentre nel 2021 Catalina Vicens (nuova
direttrice del Museo di San Colombano - Collezione Tagliavini di Bologna) ha sostituito Liuwe Tamminga, prematuramente scomparso.
La pubblicazione della rivista, iniziata per i tipi di Pàtron con l’annata V del 1967, non è la sola attività dell’Editore in ambito organistico. Fin dal 1968, infatti, parallelamente al periodico veniva aperta una Collana dedicata a studi di organaria, intitolata “Biblioteca di cultura organaria e organistica”, sotto la supervisione di Oscar Mischiati e giunta sino ad ora a 12 volumi:
vol 1: Oscar Mischiati, L’organo della chiesa del Carmine di Lugo di Romagna, 1968
vol 2: Giuseppe Radole, L’arte organaria in Istria, 1969
vol 3: Giuseppe Radole, L’arte organaria a Trieste, 1975
vol 4: Giuseppe Serassi, Sugli organi. Lettere (1816), a cura di Oscar Mischiati, 1973
vol 5: Catalogo degli organi fabbricati da Serassi di Bergamo (circa 1816) - Giovanni Battista Castelli, Catalogo degli organi da chiesa ostruiti a tutto l’anno 1858 dall’I. R. Fabbrica Nazionale Privilegiata dei Fratelli Serassi in Bergamo (1858), a cura di Oscar Mischiati, 1975
vol 6: Oscar Mischiati, L’organo della cattedrale di Feltre, 1981
vol 7: Mauro Ferrante, L’organo della chiesa di Sant’Agostino in Corinaldo, 1991
vol 8: Oscar Mischiati, Repertorio toponomastico dei cataloghi degli organari italiani (1587-1930), 1995
vol 9: Gli Antegnati. Studi e documenti su una stirpe di organari bresciani del Rinascimento, a cura di Oscar Mischiati, 1995
vol 10: Indice trentennale, I/1960-XXX/1996 della rivista «L’Organo». Rivista di Cultura Organaria e Organistica, a
cura di Oscar Mischiati e Luigi Ferdinando Tagliavini, 1998
vol 11: Bibliografia Organaria Toscana, a cura di Oscar Mischiati, 2002
vol 12: Oscar Mischiati, L’organo della cattedrale di Cremona. Vicende storiche e documenti dal XV al XX secolo, redazione e integrazioni a cura di Marco Ruggeri, 2007
Quest’ultimo, uscito a tre anni di distanza dalla morte del suo autore principale, venne amorevolmente preparato da Mischiati in circa vent’anni di ricerche e completato solo nel marzo 2004, cioè un mese prima della sua scomparsa.
Nel 2013 sono apparse altre due pubblicazioni: il Regesto degli antichi organi di Bologna e del suo territorio (estratto da analogo articolo di Oscar Mischiati già apparso sulla rivista nel 2002) e, soprattutto, il monumentale lavoro, a lungo in gestazione, dello stesso
Mischiati e di Luigi Ferdinando Tagliavini su Gli organi della Basilica di San Petronio in Bologna.
A ciò va aggiunta la ristampa di alcuni dei primi numeri della rivista «L’Organo», già editi dal Gruppo Musicale “G. Frescobaldi” di Brescia e nel frattempo andati esauriti.
Da tutto ciò emerge una costante e determinata attenzione da par-

te dell’Editore Pàtron per la cultura organistica, ossia un settore che può essere considerato minoritario o per specialisti, ma che annovera in realtà un patrimonio artistico di inestimabile qualità e avente una diffusione territoriale così capillare da raggiungere praticamente ogni chiesa italiana! La necessità di studi e ricerche – che si esprime mediante la rivista «L’Organo» e le pubblicazioni annesse – è dunque fondamentale per una continua opera di valorizzazione e promozione culturale.
GIno ruozzI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Il nome della Casa editrice Pàtron è per me in primo luogo associato alla memoria di Fiorenzo Forti e del suo bellissimo libro dantesco Magnanimitade, pubblicato nel 1977. Fu su quel libro appena uscito e di cui Forti era giustamente orgoglioso che approfondii la mia preparazione su Dante per il primo esame di Letteratura italiana. Il volume è aperto dal saggio Il limbo e i megalopsicoi della Nicomachea, inizialmente pubblicato nel «Giornale storico della letteratura italiana» (1961), «splendido esordio del Forti dantista», per Emilio Pasquini «ancora oggi vivo e insuperato»; e il libro, meritoriamente pubblicato da Pàtron, «consacra definitivamente» Forti «come dantista di alto rango».
Da Magnanimitade presi confidenza e consuetudine con la Casa editrice Pàtron, i cui testi hanno poi accompagnato i miei studi da studente a professore. Tra i quali spicca il basilare Nozioni ed esempi di metrica italiana di Raffale Spongano, uscito nel 1966 e di nuovo nel 1974 (è l’edizione che ho studiato), con il simpatico menu della Trattoria – Pizzeria Da “Spongano” posto a sinistra della premessa con le indicazioni delle proposte gastronomiche e dei prezzi: dai piatti meno cari, la “Canzone a ballo” (2.000 lire) e la “Ballata antica (senza mozzarella)” (3.000), ai più costosi, la “Villotta di cavallo (alla diavola)” (8.000) e la “Zingaresca (acciughe, capperi, olive)” (9.000). Ironico quanto gustoso segnale della sua origine salentina, inatteso per
chi ne temeva la severità e il rigore di professore, lo scrupolo lenticolare del filologo, il costante invito del maestro «alla ginnastica dell’attenzione nei giovani» che useranno il manuale di metrica, «ridestandoli dall’abitudine alla distrazione e all’approssimazione, a cui troppe altre cose oggi li invitano e fors’anche li costringono». Libro che risulta tuttora di grande utilità per l’esemplare chiarezza didattica e scientifica.
Un altro passaggio fondamentale della mia prossimità a Pàtron fu quando Emilio Pasquini mi chiese di entrare nella redazione della rivista annuale «il Carrobbio», che nel 1993 passò dall’editore Luigi Parma appunto a Pàtron, con un primo numero che fondeva due annate (XIX-XX: 1993-1994), avviando «una nuova generazione della Rivista». A firmare il sintetico e programmatico editoriale erano i due nuovi direttori Emilio Pasquini e Giancarlo Susini, proponendosi «di continuare la serie in tutti i suoi meriti e di ampliare nei contenuti l’orizzonte degli interessi scientifici». La segreteria di redazione era composta da Daniela Rigato, da Patrizia Tabaroni e dal sottoscritto. L’avventura editoriale del «il Carrobbio» di Pàtron proseguì fino al 2013 e la direzione, dopo la morte di Susini (2000), fu condivisa da Pasquini e da Giuseppe Sassatelli (con l’integrazione in redazione di Antonella Coralini).
Nell’introduzione al numero del 2001, aperto dal pregevole ricordo di Susini di Angela Donati, Pasquini affermava che con la co-direzione dell’etruscologo Giuseppe Sassatelli si ripristinava «l’equilibrio fra l’antico e il moderno, fra la competenza letteraria e quella antiquaria»; in questo modo la rivista «può continuare fiduciosamente il proprio cammino, fedele ai suoi presupposti di fondo: alla
| 1925-2025
dimensione, cioè, di un regionalismo aperto all’orizzonte della storia generale d’Italia e d’Europa».
In tutti questi laboriosi anni, in cui «il Carrobbio» è stato un riferimento della cultura bolognese, la funzione editoriale è stata assolta da Sandra Simoni, con competenza pari alla passione e alla simpatia. Quella della redazione del «il Carrobbio» è stata per me una splendida esperienza di conoscenza della storia e della cultura dell’Emilia Romagna dall’antichità a oggi. Nell’editoriale che apre il numero XXII del 1996, Pasquini e Susini ringraziavano l’impegno del nuovo Editore Pàtron, «così ben radicato a Bologna», auspicando «di allargare ancora di più gli oggetti della raccolta: dai racconti di storia e dei palinsesti monumentali ai temi dell’ambiente ed alla ricognizione vigile del patrimonio culturale». Archeologia, storia, geografia, arte, economia, urbanistica e naturalmente lingua e letteratura, sulle quali mi sono maggiormente concentrato nel lavoro di allestimento e curatela della rivista.
Nel tempo sono usciti saggi rilevanti e illuminanti sull’incisivo contributo di Bologna e dell’Emilia-Romagna allo sviluppo del panorama culturale nazionale e internazionale. Mi limito ad alcuni riferimenti: nel 1997, i saggi Manzoni e la Commissione per i testi di lingua di Ernesto Travi e Fiorenzo Forti tra i suoi libri e la vicenda del sapere di Federica Rossi; nel 2007, Pascoli dantista della compresenza di Alessandra Cetro, La commemorazione carducciana dell’ottavo centenario dell’Università di Bologna di Mario Pazzaglia, Carducci e la forza dell’inattualità di Pasquini, prolusione dell’anno accademico 2006-2007 dell’Università di Bologna. Pasquini chiudeva l’intervento con un avvertimento e un auspicio, urgente allora e forse ancora di più oggi: «La verità è che, se le sorti e la crescita del nostro paese si giocano sulla cultura, o più precisamente
sull’istruzione e sulla ricerca, il paradigma carducciano rischia di diventare di forte attualità».
Nel sistematico ritratto dei protagonisti della città e dell’università, del 2010 è la Commemorazione di Elio Melli all’Accademia delle scienze di Pasquini; del 2012 è il ritratto-ricordo di Giorgio Celli: scienziato geniale, entomologo-etologo, ecologo-naturalista, letterato e saggista di Silviero Sansavini (che presenta infine un’accurata bibliografia dello scienziato, scrittore e poeta noto agli studiosi quanto al vasto pubblico). Due decenni di sodalizio Pàtron-«il Carrobbio» (1993-2013) che hanno documentato e divulgato con appassionata precisione secoli di identità culturale.
Terza significativa esperienza (ancora in corso) è quella della fondazione e della direzione della Collana “Letteraria”, ideata e condivisa con Lucia Rodler, promossa da Sandra Simoni e ora seguita da Erika Mucignat: ad attestare la fertile e sempre fluente vena imprenditoriale dell’Editore Pàtron, sempre interessato ad abbracciare nuove imprese. La Collana è stata aperta nel febbraio 2015 dal libro L’infinito sotto casa di Nora Moll (sottotitolo «Letteratura e transculturalità nell’Italia contemporanea»).
La serie, ora diretta anche da Bruno Capaci e da Elisabetta Menetti, «ospita saggi di critica letteraria caratterizzati da una solida metodologia teorica e storica e da uno stile comunicativo efficace: intrecci tra letterature, convergenze tra letterature e media, riletture originali di generi, forme, temi, autori del passato o del presente, aggiornamenti su teorie e metodi, rinarrazioni di questioni storico-letterarie complesse. Gli ambiti di “Letteraria” sono numerosi perché la Collana intende fornire saggi di riferimento a un tempo essenziali e completi, ordinati e innova-

tivi, che aiutino la letteratura a dialogare con le culture della contemporaneità», rivolgendosi a «lettrici e lettori curiosi di letteratura e del mondo delle idee, a studenti universitari dei corsi di letteratura italiana, letteratura italiana contemporanea, letterature comparate, letterature straniere e scienze umanistiche in genere, a docenti interessati a un’interpretazione critica aggiornata e capace di orientare le ricerche future».
Tra gli ultimi volumi stampati L’atlante di Claudio Magris di Dario Salvadori (2020), Effetto Rodari di Tiziana Piras (2023), Sorelle minori. Figure femminili nella «Commedia» di Sandra Carapezza (2024) e Assenza, più acuta presenza. Manzoni lettore inquieto di Voltaire di Cristina Cappelletti (2024).
La mia familiarità con Pàtron data ormai cinquant’anni. Ha segnato varie fasi della mia esistenza e in tutte è stata una presenza formativa, una collaborazione operosa, una piacevole compagnia.

renzo tosI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Il costante rapporto fra il nostro gruppo di studiosi di Letteratura Greca e la Casa editrice Pàtron ha avuto inizio grazie alla rivista «Eikasmòs», fondata nel 1990 da Enzo Degani: prima, ai tempi in cui insegnava a Bologna Benedetto Marzullo, la rivista di quest’ultimo, «Museum Criticum», aveva avuto vari editori, ma mai Pàtron, e la prima esperienza di direzione da parte di Degani fu col «Giornale Filologico Ferrarese», che era, come dice il nome, stampato e pubblicato a Ferrara; nel Dipartimento di Filologia
Classica la Casa editrice Pàtron rimaneva esclusivo punto di riferimento della sezione di studi latini. Le cose cambiarono quando Degani decise di fondare una nuova rivista, che chiamò «Eikasmós»: con questo termine greco, che può essere tradotto congettura, egli si rifaceva non tanto alla congettura stricto sensu, ma a un’operazione mentale ben più complessa, grazie alla quale, di fronte a un problema, in primo luogo si raccoglievano scrupolosamente tutti gli elementi, poi li si analizzava parametrandoli alla luce di quanto era precedentemente noto e infine su questa base si ipotizzava una soluzione. Degani, insomma, si proponeva di accogliere articoli che non fossero belle esercitazioni letterarie o che ribadissero nozioni note, ma che affrontassero problemi, testuali ed esegetici, e che, procedendo con un metodo autenticamente filologico e scientifico, costituissero un passo in avanti nella ricerca. Dopo i
primi anni di assestamento, in cui la rivista fu pubblicata presso una tipografia, Degani si pose il problema di fornirle una solidità amministrativa e legale, e si rivolse alla Casa editrice Pàtron, che era diretta da una manager dal carattere forte e dalle idee molto chiare, Sandra Simoni. Alla fine di una lunga trattativa «Eikasmòs» divenne una rivista della Pàtron (anzi il suo «fiore all’occhiello», disse varie volte la Simoni) e, parallelamente, furono fondate due collane ad essa collegate, una a impronta scientifica (i Quaderni) e una didattica (i Sussidi). Il nostro gruppo intraprese il lavoro per la rivista con notevole entusiasmo: tutti leggevamo gli articoli proposti e ne discutevamo in lunghe riunioni redazionali, che spesso si trasformavano in veri e propri seminari, ovviamente guidati da Degani. Fin dall’inizio «Eikasmós» si caratterizzò per il suo respiro internazionale: non solo per gli studiosi che facevano parte del comitato scientifico, e per la collaborazione di colleghi di tutto il mondo, ma anche per la scelta di accettare gli articoli scritti in numerose lingue (oltre all’italiano, in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese): eravamo tutti convinti (e io lo sono ancora) che l’autentico discorso scientifico non possa appiattirsi su una sola lingua, italiano o inglese che sia, e che lo studioso debba saper almeno leggere scritti in varie lingue (confesso che provo sempre un certo imbarazzo quando ho fra le mani libri la cui bibliografia presenta solo titoli in inglese).
La rivista aveva due anime, che corrispondevano ai due principali interessi del direttore e fondatore: una sezione era occupata da articoli di tipo critico-testuale, un’altra era dedicata a scritti di storia della filologia o a contributi seri sulla ricezione dei classici. Per quanto riguarda questa seconda parte, nel 1994 si presentò una ghiotta occasione,
che Degani non si lasciò sfuggire: quella di pubblicare una miscellanea di studi sulla storia della filologia dedicati a Ernst Voigt, grande grecista di Monaco di Baviera e direttore di «Gnomon», la più importante rivista di recensioni specialistiche concernenti l’antichistica. Fu così che l’editore Pàtron pubblicò – in Italia caso più unico che raro – un volume di alto livello scientifico quasi completamente in lingua tedesca, un volume che ebbe una grande rinomanza nella comunità filologica internazionale.
La rivista – e insieme a lei tutto il nostro gruppo – subì un duro colpo quando nel 2000 morì Enzo Degani. Ci fu chi fece la funesta previsione che essa sarebbe morta con il suo fondatore, e forse ci fu anche qualcuno che lo sperò, ma la bontà di un’iniziativa si vede se riesce a vivere e a fiorire al di là delle singole persone: in quel drammatico momento noi serrammo le fila, ben decisi a non lasciar perdere questa importante eredità. Di fronte alla necessità di nominare un nuovo direttore, nell’imbarazzo dovuto al fatto che nessuno si sentiva in grado di eguagliare il prestigio che aveva conferito alla pubblicazione il defunto maestro, si decise per una direzione collegiale composta da Francesco Bossi, Gabriele Burzacchini, Ornella Montanari,

Vinicio Tammaro, Renzo Tosi; altri, che lavoravano con non minore impegno, come Alberta Lorenzoni, Maria Grazia Albiani, Giovanna Alvoni, Camillo Neri, facevano parte del comitato scientifico redazionale, mentre la segreteria vera e propria si avvaleva soprattutto dell’impeccabile contributo dell’Alvoni; in altri termini, avevamo scelto una conduzione non verticistica ma autenticamente collegiale. Negli anni a venire, la struttura e l’impostazione sono rimaste invariate, anche se varie vicende hanno portato a cambiamenti nelle persone (in particolare, per quanto riguarda la direzione: nel 2014 purtroppo è morto Francesco Bossi, ed essa fin dal 2011 è stata integrata con Camillo Neri); la rivista, però, non solo ha continuato a esistere, ma è diventata una delle più prestigiose nei ranking internazionali. Dopo trentaquattro anni non si è perso lo spirito collegiale che l’animava all’inizio: anche ora essa si avvale di referees esterni e dell’approfondita lettura di tutti noi (e soprattutto di Gabriele Burzacchini), della sapiente correzione delle bozze di Vinicio Tammaro e di un accuratissimo lavoro redazionale di un gruppo guidato da Camillo Neri e i cui componenti storici sono Valentina Garulli e Marco Ercoles, mentre a chi scrive sono stati per lo più demandati i rapporti con la Casa editrice, anche perché mi lega un’amicizia personale con la solerte e scattante Sandra Simoni (siamo andati in pensione nello stesso anno, forse segno del vecchio che muore e del nuovo che avanza). Abbiamo superato insieme momenti di difficoltà finanziaria, perché ad anni di vacche grasse si sono alternati anni di vacche magre, abbiamo imparato col COVID a fare le riunioni online, non abbiamo permesso che fosse influenzata da dissapori o polemichette di nessun tipo, ma mai, prima d’ora, avevamo avuto a che fare con nor-
me astrattamente valide, ma che nella pratica rischiano di strangolare l’editoria scientifica.
I miei rapporti con Pàtron sono legati anche alla pubblicazione di tre volumi. Il primo nacque sotto l’egida di Alfonso Traina, che aveva uno strettissimo legame con la Casa editrice Pàtron e in particolare con la «signora Simoni», per la quale nutriva una profonda stima. Era su suggerimento di Traina che dagli inizi degli anni Ottanta avevo iniziato a studiare la tradizione proverbiale e nei primi anni Duemila egli mi spronò perché raccogliessi vari studi su questo argomento in un libro, rivedendoli in modo che avessero una facies organica. Traina aveva anche escogitato il titolo (La donna è mobile e altri studi di intertestualità proverbiale), partendo da un mio lavoro sulla tradizione della ”donna è mobile”, che gli interessava e lo divertiva particolarmente, e aveva anche trovato la copertina adatta, in un disegno con un vecchio che, severo, impartiva insegnamenti con il dito alzato (Traina, che aveva una profonda passione per le arti figurative, voleva sempre cercare le copertine per i volumi della Collana che dirigeva, e che denominava comunemente «Collana Bianca», per distinguerla da un’altra, denominata «Verde»). Il volume uscì nel 2011, col solito immancabile ritardo con cui ho sempre presentato agli editori le mie opere, dopo anche un istruttivo seminario a casa di Traina, che aveva letto il dattiloscritto con estrema cura: ricordo in particolare una discussione su una sentenza medievale ametrica e il suo apprezzamento per la mia introduzione, in cui citavo persino Totò.
Il secondo libro, invece, uscì per le insistenze di Sandra Simoni, che voleva pubblicarlo nei “Sussidi di Eikasmós”.
In effetti Capire il greco ha avuto una storia tortuosa:
nacque nel 2002 come appendice a una grammatica greca dalla struttura molto innovativa che era stata concepita per la Casa editrice Cappelli. Sandra Simoni ebbe l’idea, una volta avuta la regolamentare liberatoria, di trasformare Capire il greco in un agile strumento finalizzato all’insegnamento universitario. Se la redazione originale era costituita da sette versioni, in cui spiegavo come si faceva a comprendere il testo come premessa dell’esercizio di traduzione, ora esse erano precedute da un repetitorium di sintassi, la cui stesura fu affidata a una giovane di spiccata intelligenza, Rachele Pierini. Il volume è uscito nel 2014 e ha riscosso un discreto successo, come mi è stato rivelato da vari riscontri di colleghi che l’hanno utilizzato e adottato, e ha avuto poi l’onore di essere stato, in certe parti, scopiazzato da un libro di larga diffusione, presentato in ogni dove con grandi strombazzamenti propagandistici, a Bologna addirittura nella sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio, con elogi sperticati per idee che provenivano dal nostro Capire il greco, al quale invece fu riservata solo una presentazione in un liceo cittadino, in cui, come spesso accade, si vide chiaramente che chi parlava lo conosceva molto poco. Ciò nonostante, potei dire che quel libro mi procurò grande soddisfazione, perché colleghi e studenti mi dissero che l’avevano trovato di grande utilità.
Il terzo libro uscì nel 2011 nella Collana degli studi legati a Eikasmós, ed era la raccolta commentata dei componimenti greci di Clotilde Tambroni, una studiosa e poetessa che insegnò greco a Bologna alla fine del Settecento, in un momento in cui il nostro ateneo si avvaleva di vari insegnanti di sesso femminile, e che ai suoi tempi godette di notevole celebrità a livello europeo, mentre ora a Bologna è ricordata solo perché le sono state intitolate una via
e una scuola. Tale volume era stato preceduto nel 1988 da un primo articolo, comparso in una miscellanea sulle donne che avevano insegnato nell’Università di Bologna, e nel 2005 da un sunto dell’introduzione che la Simoni aveva voluto pubblicare nella rivista locale più importante edita da Pàtron, il «Carrobbio». In effetti, si tratta di un libro che avevo scritto nel 1994, in un momento particolarmente triste della mia vita, quando fu solo l’amicizia di poche persone, Francesco Bossi, Vinicio Tammaro e don Paolo Serrazanetti, a darmi la forza di resistere; proprio per questo, in seguito, l’avevo lasciato nel cassetto, e non mi ricordo per quale ragione decisi allora di pubblicarlo, forse per chiudere definitivamente quella pagina, forse perché avevo smesso di credere all’antico adagio Veritas filia temporis, forse per poter dire di essere il maggior studioso mondiale di qualcosa (credo infatti di essere l’unico che si sia occupato di Clotilde Tambroni).
Questo è il racconto, un po’ serio e un po’ semiserio, dei miei rapporti con la Casa editrice Pàtron. Ho avuto la fortuna di studiare e insegnare in un momento in cui il lavoro culturale era finalizzato a pubblicazioni scritte e non affidate all’etere, in cui si studiava in biblioteche dagli scaffali aperti, ammonticchiando libri sui tavoli, in cui si aveva un rapporto famigliare con certi strumenti fondamentali che venivano consultati, letti e riletti, in rassicuranti ambienti con le pareti ricoperte di libri. È indubbio che la versione digitale di tante opere e la possibilità di facili ricerche via internet abbiano portato grandi vantaggi, ma perché questi siano reali, a mio avviso, non devono scalzare l’esistenza del libro. Verba volant scripta manent.
paola vecchI
Commissione per i testi di lingua di Bologna
Solo da pochi anni – dall’accordo siglato fra le due parti nel 2017 – la Pàtron editore pubblica i libri della Commissione per i testi di lingua, l’istituzione bolognese che dal 2014 ho il privilegio di dirigere: due le collane, la maggiore “Collezione di opere inedite o rare”, che ha raggiunto il n. 173 delle sue pubblicazioni, e la minore “Scelta di curiosità letterarie inedite o rare”, approdata alla dispensa CCCVII. Non è questo il luogo per soffermarsi sulle vicende plurisecolari della Commissione che, in proprio o per il tramite di benemeriti editori bolognesi, da più di centocinquant’anni – dal 16 marzo 1860, giorno della sua fondazione! – onora la cultura nazionale con la pubblicazione di opere inedite o semisconosciute della lingua e della letteratura italiana: e che quest’anno allestirà una mostra sulla sua storia e i suoi volumi presso la sede di Casa Carducci e la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna. Una vicenda che è stata anche di recente ripercorsa, in alcune delle sue tappe più salienti, da uno dei libri pubblicati dalla Pàtron – gli Atti del Convegno di Bologna del 2021 –, che ha sottolineato il carattere nobilmente “artigianale”, cioè non programmatico, libero da convenienze accademiche e alla fin fine commerciali, delle sue pubblicazioni. Via via confidando in esse, il testo di lingua della Commissione ha modificato nel tempo il proprio ambito e le proprie aspirazioni e metodologie, virando verso l’edizione critica,
secondo le prospettive filologiche e critiche più aggiornate, di opere di ogni tempo e area della letteratura italiana. Ricordo quindi soltanto i titoli dei volumi editi in collaborazione con la Pàtron, gli ultimi, a cui altri seguiranno e sono già in lavorazione. Della “Collezione”:
Il mio Carso di Scipio Slataper, a cura di Roberto Norbedo (2019)
Che cos’era e che cos’è un testo di lingua. Atti del Convegno, Bologna 4-5 novembre 2021, a cura del Consiglio della Commissione (2022)
Rime di Battista Guarini, a cura di Luca Piantoni (2023).
Della “Scelta”:
L’Historia di Camallo e l’Historia del pescatore, a cura di Roberto Galbiati (2017)
Corbaccino di Ludovico Bartoli, a cura di Raffaele Cesaro (2021).
Come si noterà, sono libri frutto di lunghe ricerche, ed è perciò merito della Pàtron averli accolti fra le proprie edizioni, facendosi tramite ultimo di una tradizione culturale illustre e peculiare come la nostra. Rispondono infatti alla vocazione specialistica della Commissione, e sono, per forza di cose, “libri di studio”, che percorrono vari ambiti della ricerca scientifica. Rivolti in primo luogo al pubblico universitario e agli addetti ai lavori – filologi e critici della letteratura italiana e storici della lingua –, e minuziosamente curati nella facies editoriale, richiedono curatele speciali anche per la varietà delle sezioni e degli strumenti paratestuali che offrono, da indici
a tabelle sinottiche di raffronto, da apparati critici a glossari di termini rari e antichi. Come esempio fra tutti – ma tutti meriterebbero una segnalazione a parte –, mi basti ricordare Il mio Carso di Scipio Slataper a cura di Roberto Norbedo (2019): un’opera complessa, non solo per l’elaborata stratigrafia testuale, ma anche e di conseguenza, come sanno bene i responsabili della Casa editrice, per l’impaginazione e la stampa di un oggetto-libro articolato, che alterna all’applicazione della più attuale filologia d’autore i dubbi sulla cosiddetta “ultima volontà” del testo; e che fra l’altro ha imposto alla Collana (la “Collezione di opere inedite o rare”) un formato maggiore, se non unico molto raro. Nonostante ciò, il processo editoriale si è svolto senza intoppi, sollecitando un dialogo fertile che ha reso spedito il cammino percorso insieme. Varcato il Rubicone, anche il seguito delle nostre edizioni, compresa quella in corso – di aggiornamento dei quattro volumi di Lettere di Pietro Bembo a suo tempo editi dalla Commissione –, è stato affidato all’opera della Pàtron. Alle valenti editor del passato e del presente, Sandra Simoni e Erika Mucignat, mi è grato quindi esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto insieme, e per la comprensione che hanno manifestato nei confronti di certe mie resistenze progettuali che, lo ammetto, testimoniano più i limiti della mia età che una mia competenza in materia. Penso ad esempio al suggerimento della Casa editrice di mettere in vendita i libri della Commissione, vecchi e nuovi, anche on-line e in formato digitale: ma come, i nostri libri plurisecolari!... Eppure è il tramite obbligato e sensato per una diffusione più efficace delle nostre opere, e bene ha fatto la dottoressa Mucignat a stringermi in un “dolce assedio” per convincermi.
Nonostante la collaborazione con l’editore sia recente, va poi detto che la Pàtron è da sempre parte attiva dell’“immaginario didattico” dell’Alma Mater, e in particolare di quella che un tempo era chiamata Facoltà di Lettere e Filosofia: ne è derivato in certo modo un imprinting – un senso di consuetudine e di appartenenza – che tanti studenti della mia generazione hanno ricevuto dai libri della Pàtron sui quali si sono in buona parte formati. Ripenso così a una porzione significativa di strumenti didattici che ancora conservo e che mi sono stati guida e primo viatico agli studi letterari. Posso per forza di cose ricordarne qui solo alcuni: dei principali, senza dubbio, fu autore Raffaele Spongano, il mio primo e indimenticato maestro di Letteratura Italiana. Spicca nella memoria un’opera “di scuola” in anticipo sui tempi, il manuale di Nozioni ed esempi di metrica italiana (un titolo che come tutti quelli di Spongano va dritto al centro: Bologna, Pàtron, 1966, più volte ristampato e ancora oggi disponibile nel catalogo della Casa editrice), antesignano degli studi metrici e formali sul testo poetico. Non è un caso che Spongano, da “pedagogo” istintivo, abbia chiuso la premessa al volume con questa avvertenza, che penso che si potrebbe estendere anche oggi a ogni libro scolastico:
La riflessione sul senso letterale dei testi non è forse mai troppa, e, per la destinazione che questo libro vuole avere, gioverà – crediamo – col suo esempio, alla ginnastica dell’attenzione nei giovani che lo useranno, ridestandoli dall’abitudine alla distrazione e all’approssimazione, a cui troppe altre cose oggi li invitano e fors’anche li costringono.
Sono parole che testimoniano una costante della “scuola bolognese” di letteratura italiana, memore dell’eredità di Giosuè Carducci: con l’attenzione al testo e alle forme del testo, e con la «ginnastica dell’attenzione» che essa comporta, rispecchiata e di certo agevolata da libri come questi. Mi permetto perciò di ripeterle anche in questa occasione, proponendole quasi come un esergo a una Casa editrice di così precipua e meritevole vocazione didattica. Ma non è finita qui, perché anche altri volumi di Spongano – e di Pàtron – destinati all’Università sono conservati fra i miei libri di scuola: come gli Schemi di Storia della letteratura italiana, composti a «stimolo della riflessione non meno che della memoria» degli allievi (1963); e la Antologia della letteratura italiana, che approdò in tre volumi alla Pàtron nel 1968 e fu più volte ristampata. Senza contare i saggi che, composti da Spongano nei decenni precedenti o frutto degli ultimi lavori dello studioso, furono negli anni affidati alla Pàtron, come Il primo Parini o le Rime dei due Buonaccorso da Montemagno. E spostandomi su altri versanti, trovo i Lirici greci e i Frammenti di Ipponatte oggetto dei miei studi di Letteratura greca con Carlo Del Grande e Enzo Degani; oppure il robusto L’alfabeto e la pronunzia del latino di Alfonso Traina (Bologna, Pàtron, 1957), sussidio fondamentale ai miei primi corsi di Letteratura latina seguiti con Elio Pasoli: anch’egli fra i maestri bolognesi che hanno arricchito con i loro studi il catalogo della Casa editrice (penso ad esempio alle Epistole letterarie di Orazio, alle Historiae di Sallustio e a tanto altro). Come avrebbe detto Croce, alla Pàtron respiro quindi una certa “aria di famiglia”: una consuetudine che affonda nella formazione di tanti di noi e che è stata chiamata dalla Commissione a dare i suoi frutti anche nel presente.
Potrei fermarmi qui, fiduciosa che questa testimonianza valga al riconoscimento del cammino editoriale dalla Pàtron a fianco dell’Università e della città di Bologna. Ma ho un’ultima tessera personale che è anche segno di stima e di vicinanza. In una Collana della Pàtron che, all’interno del mio Dipartimento, il FICLIT dell’Alma Mater, ha visto impegnati colleghi a me carissimi (e “chiarissimi”) come Gian Mario Anselmi e Loredana Chines – “I sentieri della letteratura. Metodi, percorsi e prospettive nella didattica dei testi letterari” –, sono stati pubblicati di recente in volume postumo, a cura di Alberto Di Franco, i saggi su Letteratura e scienza del già vice presidente della Commissione, il professore Andrea Battistini. Nel nome della Pàtron editore mi è grato perciò rievocare con affetto, nel ricordo che non si spegne, l’illustre amico e collega, maestro di tutti noi.
Dopo le parole di quanti hanno dedicato parte del loro tempo per regalarci qualche ricordo e considerazione, spetta alla Casa editrice fare una riflessione.
Cento anni di storia sono stati teatro di vicende tutt’altro che lineari, di successi e imprese perse, di iniziative coraggiose e cambiamenti necessari.
Ci sono però alcune cose che restano invariate.
La prima, la più evidente, è forse anche la più distintiva: l’azienda è rimasta all’interno di uno dei rami della stessa famiglia per generazioni.
Grazie a questo impegno, la Casa editrice è passata attraverso gli ostacoli incontrati lungo il proprio cammino e ne è uscita rafforzata, per merito, innanzitutto, dell’esperienza maturata.
La seconda cosa che resta comune e caratterizzante in questi decenni è la dedizione del personale che si è succeduto, spesso dopo diverse decadi di collaborazione, all’interno della Casa editrice che non è solo un posto di lavoro ma anche un ambiente in cui mettersi alla prova dando il meglio di sé, mantenendo uno stile rigoroso e una dedizione che Autrici e Autori hanno saputo apprezzare.
Non per nulla, in molti contributi c’è un riferimento costante a chi ha guidato l’Ufficio Editoriale della Casa editrice negli ultimi quarant’anni.
Sandra Simoni ha lasciato un segno all’insegna della cordialità e della lealtà dei rapporti con chi ha collaborato nel corso degli anni con la Casa editrice, consentendo a chi le è succeduta, Erika Mucignat, di inserirsi in una realtà animata dalla volontà di impegnarsi in progetti concreti e di proseguire il lavoro comune, nella certezza di ricevere dalla rinnovata e giovane compagine aziendale lo stesso livello di accoglienza e disposizione al confronto indispensabili in una Casa editrice.
Il futuro è lì ad attenderci, e già lancia importanti sfide. Dopo eventi così impattanti come una pandemia, le dinamiche di insegnamento e di studio non possono che cambiare. E la Casa editrice è pronta ad ascoltare, ancora una volta, le esigenze di Autrici e Autori, ma anche le esigenze di una popolazione studentesca che vive in un mondo fatto di tecnologie e strumenti da inglobare nella didattica, senza mai toglierle il ruolo centrale e determinante.
Per questo l’ammissione a cataloghi digitali come jStor e l’implementazione dei titoli presenti su piattaforme come Torrossa e Perlego sono i fisiologici primi passi in un processo di trasformazione necessario e, anzi, ormai più che funzionale a rispettare quella che è la ragione stessa dell’esistenza della Casa editrice: contribuire alla diffusione del sapere.
Vogliamo celebrare così, dunque. Con lo sguardo al futuro e alle innovazioni, sapendo di avere alle spalle un passato importante, ma proprio per questo un passato capace di mettere le ali ai piedi.
L’Editore
